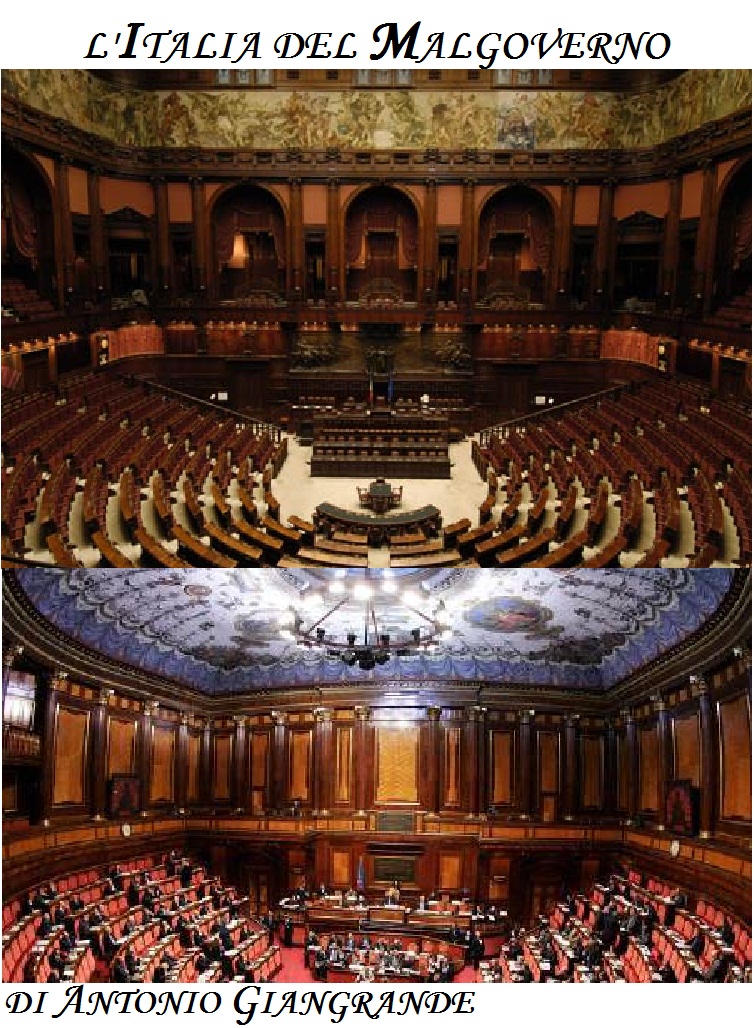Denuncio al mondo ed ai posteri con i miei libri tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del 1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica, discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e censurato. Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per quello che scrivo i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la fonte. Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare per potermi mantenere. Non vivo solo di aria: Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a: ANTONIO GIANGRANDE, VIA MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601 - CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
versamento in bollettino postale sul c.c. n. 92096221. intestato a: ANTONIO GIANGRANDE, VIA MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
![]()
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE: CONTROTUTTELEMAFIE - MALAGIUSTIZIA - TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi) ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE - TELE WEB ITALIA
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine) GIANGRANDE LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
GOVERNOPOLI
PRIMA PARTE
DI ANTONIO GIANGRANDE
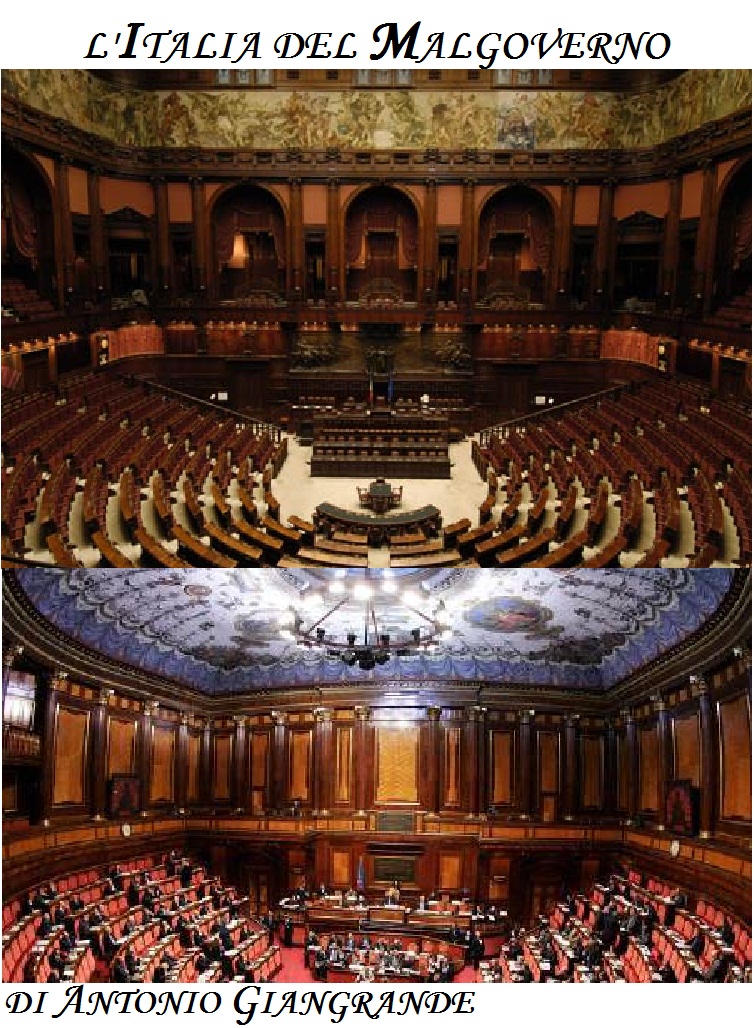
L’ITALIA DEL MALGOVERNO,
OSSIA, LA POLITICA COME ESEMPIO DI MORALITA’
TIRANNIDE indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
"Art. 1 della Costituzione: L’ Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (non sulla libertà e la giustizia). La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. (I limiti stabiliti al potere popolare indicano una sudditanza al sistema di potere. Il potere popolare è delegato ai Parlamentari e agli organi da questi nominati: Presidente della Repubblica, Governo, organi di Garanzia e Controllo. La Magistratura è solo un Ordine Costituzionale: non ha un potere delegato, ma una funzione attribuita per pubblico concorso. In realtà si comporta come Dio in terra: giudica, ingiudicata).
Un'Italia tenuta al guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobby, mafie e massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere. La “Politica” deve essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione.
l'Italia sia una repubblica democratica e federale fondata sulla Libertà e la Giustizia. I cittadini siano tutti uguali e solidali.
I rapporti tra cittadini e tra cittadini e Stato siano regolati da un numero ragionevole di leggi, chiare e coercitive.
Le pene siano mirate al risarcimento ed alla rieducazione, da scontare con la confisca dei beni e con lavori socialmente utili. Ai cittadini sia garantita la libera nomina del difensore o l'autodifesa personale, se capace, ovvero il gratuito patrocinio per i poveri. Sia garantita un'indennità e una protezione alla testimonianza.
Sia garantita la scusa solenne e il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, al cittadino vittima di offesa o violenza di funzionari pubblici, di ingiusta imputazione, di ingiusta detenzione, di ingiusta condanna, di lungo o ingiusto processo.
Sia garantita a tutti ogni garanzia di accesso al credito per meritevoli finalità economiche o bisogni familiari necessari.
Sia libera ogni attività economica, professionale, sociale, culturale e religiosa. Il sistema scolastico o universitario assicuri l'adeguata competenza, senza vincoli professionali di Albi, Ordini, Collegi, ecc. Il libero mercato garantirà il merito. Le scuole o le università siano rappresentate da un preside o un rettore eletti dagli studenti o dai genitori dei minori. Il preside o il rettore nomini i suoi collaboratori, rispondendo delle loro azioni.
Lo Stato assicuri ai cittadini ogni mezzo per una vita dignitosa.
Ai disabili sia garantita l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità dei luoghi di transito o stazionamento.
Il lavoro subordinato pubblico e privato sia remunerato secondo efficienza e competenza.
Lo Stato chieda ai cittadini il pagamento di un unico tributo, secondo il suo fabbisogno, sulla base della contabilità centralizzata desunta dai dati incrociati forniti telematicamente dai contribuenti, con deduzioni proporzionali e detrazioni totali. Agli evasori siano confiscati tutti i beni. Lo Stato assicuri a Regioni e Comuni il sostentamento e lo sviluppo.
Sia libera la parola, con diritto di critica, di cronaca, d'informare e di essere informati, così come sia libero l'esercizio della stampa da vincoli di Albi, Ordini e collegi.
I senatori e i deputati, il capo del governo, i magistrati, i difensori civici siano eletti dai cittadini con vincolo di mandato. Essi rappresentino, amministrino, giudichino e difendano secondo imparzialità, legalità ed efficienza in nome, per conto e nell'interesse dei cittadini. Essi siano responsabili delle loro azioni e giudicati e condannati. Gli amministratori pubblici nominino i loro collaboratori, rispondendone del loro operato.
Il difensore civico difenda i cittadini da abusi od omissioni amministrative, giudiziarie, sanitarie o di altre materie di interesse pubblico.
Il Parlamento voti e promulghi le leggi propositive e abrogative proposte dal Governo, da uno o più parlamentari, da una Regione, da un comitato di cittadini".
di Antonio Giangrande
SOMMARIO I PARTE
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
INTRODUZIONE
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
ITALIA. DEMOCRAZIA COL BROGLIO.
AI MIEI TEMPI...AI MIEI TEMPI...
COS’E’ LA POLITICA OGGI?
LA LUNGA STORIA DEI POPULISMI.
IL POLITICAMENTE CORRETTO. LA NUOVA RELIGIONE DELLA SINISTRA.
PARLIAMO DI LEGALITA'. LA REPUBBLICA DI ZALONE E DI FICARRA E PICONE.
LA MORALITA' DEGLI UOMINI SUPERIORI.
A MIA INSAPUTA. QUELLI CHE NON SANNO.
L’ITALIA E LE RIVOLUZIONI A META’.
C'ERA UNA VOLTA LA SINISTRA. LA SINISTRA E' MORTA.
LA DIFFERENZA TRA LA POLITICA DEI MODERATI E L'INTERESSE PRIVATO DEI COMUNISTI.
IL TRAVESTITISMO.
C'ERA UNA VOLTA LA DESTRA.
C’ERANO UNA VOLTA I LIBERALI.
LA RIVOLUZIONE CULTURALE DA TENCO A PASOLINI, DA TOTO’ A BONCOMPAGNI.
MAI NULLA CAMBIA. 1968: TRAGICA ILLUSIONE.
1977: LA RIVOLUZIONE ANTICOMUNISTA.
FASCISTI-COMUNISTI PER SEMPRE.
L'ITALIA ANTIFASCISTA.
MALEDETTO 25 APRILE.
PRIMO MAGGIO. FESTA DEI LAVORATORI: SOLITA LITURGIA STANTIA ED IPOCRITA.
LA FINE DELLA DEMOCRAZIA.
IL COMUNISMO, IL FASCISMO ED I 5 STELLE: LA POLITICA COL VINCOLO DI MANDATO.
DEMOCRAZIA: LA DITTATURA DELLE MINORANZE.
LE DONNE (DI IERI E DI OGGI) PIÙ IMPORTANTI E BELLE DELLA POLITICA ITALIANA.
GLI ULTIMI 25 ANNI DEGLI ITALIANI.
IL LIMBO LEGISLATIVO. LE LEGGI TEORICHE.
LA REPUBBLICA GIUDIZIARIA, ASPETTANDO LA TERZA REPUBBLICA.
IL PARTITO DELLE MANETTE COL CULO DEGLI ALTRI.
STORIA DELL’AMNISTIA.
I TRADITORI, OSSIA I FRANCHI TIRATORI.
LE FAKE NEWS DEL CONTRO-REGIME.
LA DEMERITOCRAZIA.
IN QUESTO MONDO DI LADRI.
CHI FA LE LEGGI?
I PEONES DEL PARLAMENTO.
"PADRI DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA NOSTRA ROVINA.
MAFIA, PALAZZI E POTERE.
MAFIA DEMOCRATICA.
BUROCRAZIA. LA DITTATURA DEI BUROCRATI.
LO STATO STA CON I LADRI. OVVIO SONO COLLEGHI!
LA LIBERTA'.
LA DEMOCRAZIA E' PASSATA DI MODA?
A PROPOSITO DI TIRANNIDE. COME E QUANDO E' MORTO HITLER?
L'ANTIPOLITICA E L'ASTENSIONISMO.
L’ANTIPOLITICA E LE SUE VITTIME. IL PACIFISMO.
IL PARTITO INVISIBILE. ASTENSIONISMO, VOTO MIGRANTE E VOTO DI PROTESTA: I MOTIVI DI UNA DEMOCRAZIA INESISTENTE.
E’ STATO LA MAFIA!
ITALIA MAFIOSA. IL PAESE DEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA SE AMMINISTRATI DALL’OPPOSIZIONE DI GOVERNO.
LEZIONE DI MAFIA.
DEMOCRAZIA A SINISTRA. VOTI TRUCCATI, ELEZIONI TAROCCATE.
I DEBITI SI PAGANO, ANCHE IN GRECIA !!!
POLITICA E SPETTACOLO: DIETRO LA MASCHERA C'E' IL NULLA.
E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.
IL MONDO SEGRETO DEGLI ITALIOTI.
IL MONDO SEGRETO DELLE CASTE E DELLE LOBBIES.
IL MONDO DEI TRASFORMISTI.
IL MONDO DELLE CRICCHE.
I MEDIA ED I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE, CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
PER UNA LETTURA UTILE E CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
POLITICA, GIUSTIZIA ED INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE VERGINELLE.
LA REPUBBLICA DELLE MANETTE.
TUTTI DENTRO CAZZO!
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI.
ITALIA PAESE DELL’IMMUNITA’ E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
STATO DI DIRITTO?
CHI E’ IL POLITICO?
CHI E’ L’AVVOCATO?
DELINQUENTE A CHI? CHI E’ IL MAGISTRATO?
DUE PAROLE SULLA MAFIA. QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
CARMINE SCHIAVONE. LA VERA MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
2 OTTOBRE 2013. LE GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
ITALIA DA VERGOGNA.
ITALIA BARONALE.
CASA ITALIA.
ITALIA. SOLIDARIETA’ TRUCCATA E DI SINISTRA.
LA GUERRA TRA ASSOCIAZIONI ANTIRACKET.
ITALIA: PAESE ZOPPO.
QUANDO I BUONI TRADISCONO.
DUE COSE SU AMNISTIA, INDULTO ED IPOCRISIA.
FACILE DIRE EVASORE FISCALE A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN E MARADONA.
ANCHE GESU' E' STATO CARCERATO.
ANCHE GLI STUDENTI SONO UNA CASTA.
QUANTO SONO ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME?
LO STATO CON LICENZA DI TORTURARE ED UCCIDERE.
27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.
FIGLI DI QUALCUNO E FIGLI DI NESSUNO.
LA TERRA DEI CACHI, DEI PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
LO SPRECO DI DENARO PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
SONO BRAVI I COMUNISTI. NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
MENTRE PER LE LOBBIES LE PORTE SONO SEMPRE APERTE.
LA LOBBY DEI DENTISTI E LA MAFIA ODONTOIATRICA.
UNIONE EUROPEA: ITALIA 60 MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
FATTI DI CRONACA, DISFATTI DI GIUSTIZIA.
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO ARRIVA LA PREDICA, SE LO STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI NIMBY.
L’ITALIA DEI COLPI DI STATO.
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
NON VI REGGO PIU’.
BELLA ITALIA, SI’. MA ITALIANI DEL CAZZO!!!
FENOMENOLOGIA RANCOROSA DELL’INGRATITUDINE.
SE NASCI IN ITALIA…
DIRITTO E GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
GIUSTIZIA DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
LA CHIAMANO GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI TESTIMONI.
LA VERA MAFIA: LO STATO ESTORTORE E CORROTTO.
LA VERA MAFIA E’ LO STATO. E PURE I GIORNALISTI? DA ALLAM ALLA FALLACI.
MAFIA E TERRORISMO DA QUALE PULPITO VIEN LA PREDICA. L’ITALIA CODARDA ED IL PATTO CON IL DIAVOLO. MEGLIO PAGARE IL PIZZO.
SOMMARIO II PARTE
PROFESSIONE PORTAVOCE E PORTABORSE: CHE DOLORI...
L'AGIT-PROP, OSSIA, "L'AGITAZIONE E LA PROPAGANDA".
GLI SPIN DOCTOR. PERSUASORI DEI GOVERNI.
GLI INFLUENCER.
LE SOLITE FAKE NEWS DEI MEDIA DI REGIME.
LE FAKE NEWS DEL CONTRO-REGIME.
MAGISTRATI: FACCIAMO QUEL CHE VOGLIAMO!
GUERRA DI TOGHE. ANCHE I MAGISTRATI PIANGONO.
ANCHE BORSELLINO ERA INTERCETTATO.
TANGENTI: CORRUZIONE E COLLUSIONI. LA STORIA SCRITTA DAI VINCITORI.
CORRUZIONE A NORMA DI LEGGE.
IL SUD TARTASSATO.
DISSERVIZI A PAGAMENTO.
IL NORD EVADE PIU’ DEL SUD.
LA PATRIA DELLA CORRUZIONE.
LE BUGIE DEI POLITICANTI CHE SCHIAVIZZANO I NOSTRI GIOVANI.
MINISTRI. UNA IMPUNITA' TUTTA PER LORO.
PER GLI ONOREVOLI...NON C'E' FRETTA.
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA.
CITTADINI. MANIFESTARE E DEVASTARE. IMPUNITA’ CERTA.
LA SCUOLA DELL'INDOTTRINAMENTO IDEOLOGICO.
L’ISLAM, LA SINISTRA E LA SOTTOMISSIONE.
LA VERA MAFIA E’ LO STATO. E PURE I GIORNALISTI? DA ALLAM ALLA FALLACI.
INCOSCIENTI DA SALVARE? COME SI FINANZIA IL TERRORISMO ISLAMICO.
IL BUSINESS DEGLI ABITI USATI.
COME SIAMO O COME CI HANNO FATTI DIVENTARE.
MILANO: DA CAPITALE MORALE A CAPITALE DEL CAZO.
IL DUALISMO MILANO ROMA. LA RIVALITA' TRA DUE METROPOLI IN SOSTANZA UGUALI NEL DELINQUERE.
L’INTELLIGENZA E’ DI SINISTRA?
L'UGUAGLIANZA E L’INVIDIA SOCIALE.
GLI INTOCCABILI E LA SOCIETA’ DELLE CASTE.
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO: LITURGIA APPARISCENTE, AUTOREFERENZIALE ED AUTORITARIA.
COME TI GABBO IL POPOLINO. RIFORMA FARLOCCA DELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI MAGISTRATI.
POTENTE UGUALE IMPUNITO.
AMMINISTRATORI SOTTO ATTACCO.
DETENUTO SUICIDA IN CARCERE? UNO DI MENO!!!
BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: FACCIAMO CHIAREZZA! NON E’ COSA LORO!
IL BUSINESS DEI BEI SEQUESTRATI E CONFISCATI.
USURA ED ESTORSIONE: CONVIENE DENUNCIARE? RISPONDONO LORO. ANTONIO GIANGRANDE. PINO MANIACI E MATTEO VIVIANI DE LE IENE PER I FRATELLI CAVALLOTTI E L'ITALGAS. FRANCESCO DIPALO. LUIGI ORSINO. PINO MASCIARI. COSIMO MAGGIORE. LUIGI COPPOLA. LUIGI LEONARDI. TIBERIO BENTIVOGLIO. IGNAZIO CUTRO'.
MAI DIRE MAFIA. FRANCESCO CAVALLARI E LA SFIDUCIA NEI MAGISTRATI.
E POI PARLIAMO DELL'ILVA.
EQUITALIA. STROZZINI DI STATO.
CONCORSI ED ESAMI. LE PROVE. TRUCCO CON I TEST; TRUCCO CON GLI ELABORATI.
SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO.
USURA BANCARIA: I MAGISTRATI STANNO CON LE BANCHE.
CORRUZIONE NEL CUORE DELLO STATO.
COSI' HANNO TRUFFATO DI BELLA.
GIUDICI SENZA CONDIZIONAMENTI?
A PROPOSITO DI RIMESSIONE DEL PROCESSO ILVA. ISTANZA RESPINTA: DOVE STA LA NOTIZIA?
CALABRIA: LUCI ED OMBRE. COME E' E COME VOGLIONO CHE SIA. "NDRANGHETISTI A 14 ANNI E PER SEMPRE.
I TRIBUNALI PROPRIETA' DEI GIUDICI.
LA BANDA DEGLI ONESTI E MAFIA CAPITALE.
QUANTI GUAI CON LA GIUSTIZIA PER GLI EX AN.
IL PARLAMENTO DEI PRIVILEGI E DEI POMPINI AI COMMESSI.
A PROPOSITO DI COMMESSI PARLAMENTARI E DEI LORO STIPENDI.
L’ITALIA COME LA CONCORDIA. LA RESPONSABILITA’ DELLA POLITICA.
ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO BISIO.
LA CASTA VIEN DA LONTANO.
ITALIA. NAZIONE DI LADRI E DI IMBROGLIONI.
PARLAMENTARI SENZA ARTE NE' PARTE. COME DA POVERI SI DIVENTA MILIONARI.
LA POLEMICA SULLA NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO E DEGLI SCRUTATORI.
LA VITTORIA CENSURATA DEL PARTITO DEL NON VOTO.
IL BERLUSCONI INVISO DA TUTTI.
LA DEMOCRAZIA SOTTO TUTELA: ELEZIONI CON ARRESTO.
L’ITALIA DEI PAZZI. UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SULLA BUROCRAZIA. CANCELLATE 10 LEGGI, NE NASCONO 12.
GIUSTIZIA E POLITICA MADE IN SUD.
BUROCRAZIA E DISSERVIZI. IL SUPPLIZIO DEGLI ITALIANI.
LO STATO DELLA CASTA: COME EVADE LE TASSE E COME TRUFFALDINAMENTE SI FINANZIA.
LO SPRECO DELLA CARTA PARLAMENTARE.
IL PAESE DELLE STAZIONI FANTASMA.
IL PARLAMENTO DEI POMPINI E DELLE BOTTE DA ORBI.
MAI DIRE MAFIA: IL CALVARIO DI ANTONIO GIANGRANDE.
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI SONO?
IL SEGRETO DI PULCINELLA. LA MAFIA E’ LO STATO.
TUTTO IL POTERE A TOGA ROSSA.
GIUDICI IMPUNITI.
PERCHE’ I REFERENDUM ABROGATIVI SONO UNA STRONZATA.
C’E’ UN GIUDICE A BERLINO!
IL PAESE DEL GARANTISMO IMMAGINARIO.
I GIOVANI VERGINELLI ATTRATTI DAL GIUSTIZIALISMO.
MAGISTRATI? SI', COL TRUCCO!!
MANETTE FACILI, IDEOLOGIA ED OMICIDI DI STAMPA E DI STATO: I PROCESSI TRAGICOMICI.
LA VERITA’ NON E’ UGUALE PER TUTTI.
PARLIAMO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESCO COSSIGA: TRA GLI ITALIOTI UOMO SOLO CONTRO LO STRAPOTERE DELLA MAGISTRATURA.
MENZOGNE DI STATO. DOVE VANNO A FINIRE I NOSTRI SOLDI?
LA TRUFFA DEI CONCORSI PUBBLICI E DELLA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI.
COSTITUZIONE ITALIANA: COSTITUZIONE MASSONICA.
APOLOGIA DELLA RACCOMANDAZIONE. LA RACCOMANDAZIONE SEMPLIFICA TUTTO.
LA STRATEGIA DELLA TENSIONE: TERRORISTICA E GIUDIZIARIA.
GLI INNI DEI PARTITI ED I PENTITI DEL PENTAGRAMMA.
ED I 5 STELLE...STORIE DI IGNORANZA.
ED I LIBERALI? SOLO A PAROLE.
POPULISTA A CHI?!?
LA CASTA CORROTTA E SFRUTTATRICE.
LA CASTA ASSENTEISTA.
LA CASTA PERSEGUITATA ED INETTA. SE SUCCEDE A LORO…FIGURIAMOCI AI POVERI CRISTI.
CASTA SENZA VERGOGNA.
CASTA ANTICASTA.
BEPPE GRILLO ANTI CASTA ED ANTI LOBBY? MA MI FACCIA IL PIACERE!!!!
PAGARE LE TASSE: SI’, MA PERCHE’?
PARLIAMO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA.
ISTITUZIONI, LEGALITA' E MORALITA'
PARLIAMO DI VOTO DI SCAMBIO IN PARLAMENTO: NATURALMENTE IMPUNITO!
PARLIAMO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO.
LA CASTA DEI TESORIERI DI PARTITO.
IL PARLAMENTO DEGLI INQUISITI.
GLI IMPRESENTABILI, SE LI CONOSCI, LI EVITI: IN TUTTI I PARTITI.
RISSE PARLAMENTARI.
VOTI NOSTRI.
ROBA NOSTRA.
NOMINATI ED ASSENTI. IL PARLAMENTARE NON RISPONDE ALLE E-MAIL.
SCRANNI VUOTI, PIANISTI, RISSE. ECCO L’ESERCITO DEGLI ASSENTEISTI.
CASA NOSTRA.
PAPPONI DI STATO.
PRIVILEGI E BENEFITS.
ENNESIMO RICORSO AL GOVERNO CONTRO I CONCORSI FORENSI TRUCCATI, INVIATO PER CONOSCENZA AI 630 DEPUTATI, AI 320 SENATORI, AI 72 PARLAMENTARI EUROPEI. RISULTATO: LETTERA MORTA.
RICORSO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI.
RICORSO MINISTERIALE CONTRO GLI INSABBIAMENTI.
DENUNCIA PENALE AL CSM CONTRO GLI INSABBIAMENTI.
ESPOSTO ALLE ISTITUZIONI CONTRO GLI INSABBIAMENTI.
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande)
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Tra i nostri avi abbiamo condottieri, poeti, santi, navigatori,
oggi per gli altri siamo solo una massa di ladri e di truffatori.
Hanno ragione, è colpa dei contemporanei e dei loro governanti,
incapaci, incompetenti, mediocri e pure tanto arroganti.
Li si vota non perché sono o sanno, ma solo perché questi danno,
per ciò ci governa chi causa sempre e solo tanto malanno.
Noi lì a lamentarci sempre e ad imprecare,
ma poi siamo lì ogni volta gli stessi a rivotare.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Codardia e collusione sono le vere ragioni,
invece siamo lì a differenziarci tra le regioni.
A litigare sempre tra terroni, po’ lentoni e barbari padani,
ma le invasioni barbariche non sono di tempi lontani?
Vili a guardare la pagliuzza altrui e non la trave nei propri occhi,
a lottar contro i più deboli e non contro i potenti che fanno pastrocchi.
Italiopoli, noi abbiamo tanto da vergognarci e non abbiamo più niente,
glissiamo, censuriamo, omertiamo e da quell’orecchio non ci si sente.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Simulano la lotta a quella che chiamano mafia per diceria,
ma le vere mafie sono le lobbies, le caste e la massoneria.
Nei tribunali vince il più forte e non chi ha la ragione dimostrata,
così come abbiamo l’usura e i fallimenti truccati in una giustizia prostrata.
La polizia a picchiare, gli innocenti in anguste carceri ed i criminali fuori in libertà,
che razza di giustizia è questa se non solo pura viltà.
Abbiamo concorsi pubblici truccati dai legulei con tanta malizia,
così come abbiamo abusi sui più deboli e molta ingiustizia.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Abbiamo l’insicurezza per le strade e la corruzione e l’incompetenza tra le istituzioni
e gli sprechi per accontentare tutti quelli che si vendono alle elezioni.
La costosa Pubblica Amministrazione è una palla ai piedi,
che produce solo disservizi anche se non ci credi.
Nonostante siamo alla fame e non abbiamo più niente,
c’è il fisco e l’erario che ci spreme e sull’evasione mente.
Abbiamo la cultura e l’istruzione in mano ai baroni con i loro figli negli ospedali,
e poi ci ritroviamo ad essere vittime di malasanità, ma solo se senza natali.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Siamo senza lavoro e senza prospettive di futuro,
e le Raccomandazioni ci rendono ogni tentativo duro.
Clientelismi, favoritismi, nepotismi, familismi osteggiano capacità,
ma la nostra classe dirigente è lì tutta intera da buttà.
Abbiamo anche lo sport che è tutto truccato,
non solo, ma spesso si scopre pure dopato.
E’ tutto truccato fin anche l’ambiente, gli animali e le risorse agro alimentari
ed i media e la stampa che fanno? Censurano o pubblicizzano solo i marchettari.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Gli ordini professionali di istituzione fascista ad imperare e l’accesso a limitare,
con la nuova Costituzione catto-comunista la loro abolizione si sta da decenni a divagare.
Ce lo chiede l’Europa e tutti i giovani per poter lavorare,
ma le caste e le lobbies in Parlamento sono lì per sé ed i loro figli a legiferare.
Questa è l’Italia che c’è, ma non la voglio, e con cipiglio,
eppure tutti si lamentano senza batter ciglio.
Che cazzo di Italia è questa con tanta pazienza,
non è la figlia del rinascimento, del risorgimento, della resistenza!!!
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Questa è un’Italia figlia di spot e di soap opera da vedere in una stanza,
un’Italia che produce veline e merita di languire senza speranza.
Un’Italia governata da vetusti e scaltri alchimisti
e raccontata sui giornali e nei tg da veri illusionisti.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma se tanti fossero cazzuti come me, mi piacerebbe tanto.
Non ad usar spranghe ed a chi governa romper la testa,
ma nelle urne con la matita a rovinargli la festa.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Rivoglio l’Italia all’avanguardia con condottieri, santi, poeti e navigatori,
voglio un’Italia governata da liberi, veri ed emancipati sapienti dottori.
Che si possa gridare al mondo: sono un italiano e me ne vanto!!
Ed agli altri dire: per arrivare a noi c’è da pedalare, ma pedalare tanto!!
Antonio Giangrande (scritta l’11 agosto 2012)
PRIMA PARTE
INTRODUZIONE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.
Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi, vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di mitomania, pazzia o calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece parlo di loro, delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di loro stessi e se ne fottono degli altri.
Gattopardismo. Vocabolario on line Treccani. Gattopardismo s. m. (anche, meno comunem., gattopardite s. f.). – Nel linguaggio letterario e giornalistico, l’atteggiamento (tradizionalmente definito come trasformismo) proprio di chi, avendo fatto parte del ceto dominante o agiato in un precedente regime, si adatta a un nuova situazione politica, sociale o economica, simulando d’esserne promotore o fautore, per poter conservare il proprio potere e i privilegi della propria classe. Il termine, così come la concezione e la prassi che con esso vengono espresse, è fondato sull’affermazione paradossale che «tutto deve cambiare perché tutto resti come prima», che è l’adattamento più diffuso con cui viene citato il passo che nel romanzo Il Gattopardo (v. la voce prec.) si legge testualmente in questa forma «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» (chi pronuncia la frase non è però il principe di Salina ma suo nipote Tancredi).
I nostri politici sono solo mediocri amministratori improvvisati assetati di un potere immeritato. Governanti sono coloro che prevedono e governano gli eventi, riformando ogni norma intralciante la modernità ed il progresso, senza ausilio di leggi estemporanee ed improvvisate per dirimere i prevedibili imprevisti.
Cosa vorrei? Vorrei una Costituzione, architrave di poche leggi essenziali, civili e penali, che come fondamento costitutivo avesse il principio assoluto ed imprescindibile della Libertà e come obiettivo per i suoi cittadini avesse il raggiungimento di felicità e contentezza. Vivere come in una favola: liberi, felici e contenti. Insomma, permettere ai propri cittadini di fare quel che cazzo gli pare sulla propria persona e sulla propria proprietà, senza, però, dare fastidio agli altri, di cui si risponderebbe con pene certe. E per il bene comune vorrei da cittadino poter nominare direttamente governanti, amministratori e giudici, i quali, per il loro operato, rispondano per se stessi e per i propri collaboratori, da loro stessi nominati. Niente più concorsi truccati…, insomma, ma merito! E per il bene comune sarei contento di contribuire con prelievo diretto dal mio conto, secondo quanto stabilito in modo proporzionale dal mio reddito conosciuto al Fisco e da questi rendicontatomi il suo impiego.
Invece...
L'influsso (negativo) di chi vuole dominare l'altro. Ci sono persone che sembrano dare energia. Altre, invece, sembra che la tolgano, scrive Francesco Alberoni, Domenica 01/07/2018, su "Il Giornale".
Ci sono persone che sembrano darti energia, che ti arricchiscono.
Altre, invece, sembra che te la prendano, te la succhino come dei vampiri. Dopo un colloquio con loro ti senti svuotato, affaticato, insoddisfatto. Che cosa fanno per produrre su di noi un tale effetto? Alcune ci parlano dei loro malanni, dei loro bisogni e lo fanno in modo tale che tu ti senti ingiustamente privilegiato ed è come se avessi un debito verso di loro.
C'è un secondo tipo di persone che ti sfibra, perché trasforma ogni incontro in un duello. Non appena aprite bocca sostengono la tesi contraria, vi sfidano, vi provocano. Lo fanno perché vogliono mostrare la loro capacità dialettica ma soprattutto per mettersi in evidenza davanti agli altri. Se gli date retta, vi logorano discutendo su cose che non vi interessano.
Ci sono poi quelli che fanno di tutto per farvi sentire ignoranti. Qualunque tesi voi sosteniate, anche l'idea più brillante e ragionevole ecco costoro che arrivano citando una ricerca americana che dice il contrario. Magari qualcosa che hanno letto in un rotocalco, ma tanto basta per rovinare il vostro discorso. Ricordo invece il caso di un mio collega che, per abitudine, nella conversazione, faceva solo domande. All'inizio gli raccontavo le mie ricerche, gli fornivo i dati, gli mostravo i grafici, le tabelle, mi sgolavo e lui, dopo avere ascoltato, faceva subito un'altra domanda su un particolare secondario. E io giù a spiegare di nuovo e lui, alla fine, un'altra domanda...
Abbiamo poi quelli che, quando vi incontrano, vi riferiscono sempre qualche cosa di spiacevole che la gente ha detto su di voi: mai un elogio, mai un apprezzamento, solo critiche, solo pettegolezzi negativi. E, infine, i pessimisti che quando esponete loro un progetto a cui tenete molto, vi mostrano i punti deboli, vi fanno ogni sorta di obiezioni, vi fanno capire che sarà un fallimento. Voi lo difendete ma loro insistono e, alla fine, restate sempre con dei dubbi. Un istante prima eravate pieno di slancio, ottimista, entusiasta e ora siete come un cane bastonato. Cosa hanno in comune tutti questi tipi umani? La volontà di competere, di affermarsi, di dominare, di opprimere.
Le leggi della politica secondo Montanelli. Esce la versione illustrata del classico dell'Indro storico. Dalla fondazione alla caduta dell'Urbe c'è molto da imparare, scrive Alessandro Gnocchi, Domenica 04/11/2018 su "Il Giornale". «Mai città al mondo ebbe più meravigliosa avventura. La sua storia è talmente grande da far sembrare piccolissimi anche i giganteschi delitti di cui è disseminata. Forse uno dei guai dell'Italia è proprio questo: di avere per capitale una città sproporzionata, come nome e passato, alla modestia di un popolo che, quando grida Forza Roma!, allude soltanto a una squadra di calcio». Un giudizio durissimo che potrebbe stare in calce a un articolo scritto ieri. Invece è la frase finale della Storia di Roma (Rizzoli, pagg. 544, euro 26) di Indro Montanelli, che torna in versione illustrata. Un libro geniale, per numerosi motivi. Per la prima volta la Storia diventava grande divulgazione a opera di una delle migliori penne del XX secolo. Era il 1957 e il calcio d'inizio della Storia d'Italia scritta insieme con Roberto Gervaso e Mario Cervi. Un successo colossale e non solo per il taglio felicemente discorsivo. Ad esempio fu la Storia d'Italia a spezzare un tabù e definire, in anticipo rispetto agli (...) (...) accademici, il conflitto tra Repubblica di Salò e partigiani col suo nome: guerra civile. Torniamo a Roma. Il racconto di Montanelli è due volte avvincente. Non c'è solo la «meravigliosa avventura» di un rozzo villaggio divenuto Capitale del mondo. Ci sono anche le leggi eterne della politica che Montanelli individua nel cuore degli avvenimenti. In questo appartiene a una tradizione tutta italiana. Per citare modelli illustri, Machiavelli scelse la Storia di Roma per scrivere il suo capolavoro, i Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio perché nella storia di Roma c'è tutto quello che sarebbe accaduto dopo. L'Urbe fu il laboratorio della Repubblica e dell'Impero. Fu il laboratorio della «lotta di classe» e di una cultura capace di integrare senza farsi sopraffare. Almeno fino a un certo punto. Quali sono dunque le leggi della politica che si possono desumere dalla Storia di Roma? Quando spiega l'aggressività militare della Roma di Tarquinio il Superbo, che si era fatto strada a colpi di pugnale, Montanelli chiosa: «I successi esterni servono molte volte a mascherare la debolezza interna d'un regime». Avete mai pensato che gli eroi esemplari abbondano soprattutto tra i perdenti? Le sconfitte subite a opera dell'etrusco Porsenna furono nascoste da una serie di imprese leggendarie di uomini straordinari come Muzio Scevola e Orazio Coclite: «La loro esaltazione costituisce uno dei primi esempi di propaganda di guerra. Quando un paese subisce una disfatta, inventa o esagera dei gloriosi episodi su cui richiamare l'attenzione dei contemporanei e dei posteri». Dall'alleanza di Roma con la Lega latina, del 493 avanti Cristo, terminata con la distruzione di Veio, si trae invece questa lezione: «Da allora le alleanze fra gli Stati si son continuate a stipulare col proposito di farle durare finché la posizione del cielo e della terra rimanga la stessa». A distanza di pochi anni, uno dei contraenti fa una brutta fine per colpa dell'ex alleato: «Ma, impassibili, i diplomatici insistono a usare quella formula, o altra equivalente, e i popoli a crederci». Quando fu instaurata la Repubblica, cambiarono gli schieramenti interni. Gli aristocratici si schierarono con «quei ricconi che in fondo, come tutti i borghesi di tutti i tempi, non domandavano di meglio che di entrare a far parte dell'aristocrazia, cioè del Senato». L'espansione romana è dovuta alla stabilità politica delle classi alte, conservatrici ma dotate di sale in zucca: «Non si vergognavano di difendere apertamente i propri interessi di casta e non fingevano d'amoreggiare con le sinistre come hanno fatto tanti principi e industriali». Inoltre anteponevano il bene della patria ai propri privilegi. Roma «portò alla più alta espressione il concetto di Stato, di cui fu praticamente l'inventrice, e lo poggiò su cinque pilastri che tuttora lo reggono: il Prefetto, il Giudice, il Gendarme, il Codice e l'Agente delle tasse». Con le Dodici Tavole dei decemviri, i romani separarono «il diritto civile da quello divino» e addio teocrazia. La decadenza è messa in relazione con il boom economico dovuto all'allargamento dei mercati: «Si cominciò a formare una nuova borghesia di trafficanti e di appaltatori. I costumi si addolcirono e ammollirono. Sorse quella che oggi si chiamerebbe una social life con salotti intellettuali e progressisti. La fede negli dei si indebolì come quella nella democrazia». Fu da quei salotti che si prepararono le rivoluzioni che affliggeranno Roma. La rivoluzione «contrariamente a quel che si crede, non nasce mai nelle classi proletarie, che poi le prestano la mano d'opera; ma in quelle alte, aristocratiche e borghesi, che poi ne fanno le spese. Essa è sempre, più o meno, una forma di suicidio». Trattando le vicende dei Gracchi, Montanelli scrive che i «progressisti, di alta estrazione, nobile o borghese che fosse, non sapevano sfuggire, allora come ora, a una contraddizione fra abitudini di vita raffinate e sofisticate e atteggiamenti politici populisti e piazzaioli». Potremmo proseguire. Ma finiremmo col riscrivere il libro e privare il lettore del piacere di scoprire le perle di Indro. Ecco le sue parole sulla caduta di Roma: «L'Urbe fu caput mundi, capitale del mondo, finché i suoi abitanti seppero poche cose e furono abbastanza ingenui da credere in quelle, leggendarie, che avevano loro insegnato i babbi e i magistri; finché furono convinti di essere i discendenti di Enea, di avere nelle loro vene sangue divino e di essere unti del Signore anche se a quei tempi si chiamava Giove. Fu quando cominciarono a dubitarne che il loro Impero andò in frantumi e il caput mundi divenne una colonia». Con una piccola parafrasi questa analisi potrebbe diventare anche l'epitaffio dell'Europa decadente di oggi, in piena crisi d'identità.
Chi sono il deputato leghista e la collega grillina beccati a fare sesso nei bagni di Montecitorio? (Fosca Bincher – il Tempo 6 dicembre 2018) – La bomba era stata tirata qualche giorno fa nella sua rubrica di gossip da Romana Liuzzo, l’affascinante nipote di Guido Carli: “alla toilette si rinsalda il rapporto tra Lega e M5s”. E via a raccontare l’indiscrezione di un momento di passione pizzicato per caso in toilette che vedeva protagonisti un deputato della Lega e una collega dei 5 stelle. Notizia confortante per lo stato di salute del governo gialloverde, anche se un pizzico imbarazzante peri diretti interessati. Poteva finire lì. Invece fra uno sbuffo e l’altro per la snervante attesa della legge di bilancio che tardava ad arrivare (ancora ieri sera durante la seduta notturna che ne inaugurava la discussione generale il testo non c’era), la caccia ai due amanti focosi del palazzo è diventata il principale sport praticato dai loro colleghi. E si è trasformata in una vicenda seria, serissima. Tanto è che il capogruppo del M5s, il giovane siciliano Francesco D’ Uva, ha inviato un sms ai suoi dai toni imperiosi, vietando a chiunque di parlare con i giornalisti della vicenda. Ma ha sbagliato mira, perché non era la stampa ad andare a caccia della notizia che ormai era divenuta pubblica, e non importa chi e come. Ieri all’ora di pranzo sui vari divani di Montecitorio erano i colleghi a non parlare di altro. Tutti conoscevano i nomi della coppia, e ognuno dava giudizi un po’ a casaccio fornendo i particolari dell’incontro: «Due bei ragazzi entrambi, mori, alti. Travolti da una insolita passione, tanto da non potere tergiversare rifugiandosi in un bagno del quarto piano, dove il rischio è altissimo perché c’ è il continuo viavai delle commissioni…». A rivelare l’identità degli innamorati erano soprattutto i parlamentari del Pd che non vedono l’ora di occuparsi di qualcosa di un pizzico più eccitante delle disavventure del partito. «Chiedete ad Alessia Morani», suggerivano i suoi colleghi, «lei sa ogni particolare». Qualcuno mi dice che il primo a cui lei l’ha confidato è stato il collega siciliano Fausto Raciti, che però è timido e assai riservato: «Vi diffido anche solo ad accostare il mio nome a questo gossip», minacciava ieri lui, «mi occupo di cose più serie e non di affari privati di questo genere». Ne sorrideva invece il vicepresidente della Camera dello stesso partito, Ettore Rosato: «Finalmente un buon modo di esponenti della maggioranza per utilizzare il tempo qui dentro. Ce ne fossero tanti così, farebbero meno guai». Cascava dal pero pur sorridendo alle indiscrezioni il grillino atipico Emilio Carelli che almeno come ex giornalista un po’ di curiosità l’aveva: «Sono sempre l’ultimo ad accorgermi di queste cose. Sto ore in commissione a lavorare e non vedo e non sento nulla anche se avviene a pochi metri da me…». C’ è chi rivendica la privacy come è giusto, ma ci si rende conto che il luogo dove la passione ha travolto i due giovani alleati era in qualche modo pubblico. Altri invece vengono fuori da una settimana difficile. Un giovane deputato leghista di primo pelo piuttosto belloccio ed esuberante confida: «Sono venuti in tanti a chiedermi: sei tu? E qualche problema questi sospetti me lo stanno creando. Ho una fidanzata nel collegio dove sono stato eletto. Poi non nego che da quando sono qui qualche occasione è capitata e può essere che non mi sia tirato indietro. Però un po’ di sale in zucca ce l’ho: mica qui dentro è capitato, fuori. Ho un posto dove dormo non lontano da qui, e in ogni caso uno anche non l’avesse ha a disposizione decine di alberghi o bed and breakfast entro poche decine o centinaia di metri da Montecitorio… Si può resistere senza finire in una situazione così imbarazzante. Dicono pure che chi li ha pizzicati in bagno avrebbe girato un filmato con un telefonino nascosto dentro la toilette: i due non l’avevano notato…». Se non è lui, dove puntano i sospetti? «Il nome poi me lo ha fatto una collega di altro gruppo. E in effetti ho notato che l’indiziato da giorni è nervoso, intrattabile. Non si ferma alle riunioni, parla sempre freneticamente al telefonino con qualcuno, e preferisce stare solo come prima non accadeva». Il palazzo vive di questi episodi. Ce ne fu più di uno nella scorsa legislatura nel gruppo Pd, si vede che stare in maggioranza aiuta gli ardori. Ma anche la storia di quelle mura ne è piena. Perfino quella dei bagni non è una novità assoluta, e aveva fatto il giro del palazzo qualche incontro ravvicinato dei deputati con dipendenti della Camera. Tanto che poi è stato inserita nel regolamento una norma che individua nella relazione affettiva di un dipendente con un parlamentare la giusta causa per il licenziamento…
La Camera si occupa di gossip (ma prima dov'erano le grilline?) In aula dibattito surreale sulla rubrica del "Giornale", scrive Paolo Bracalini, Domenica 09/12/2018, su "Il Giornale". Più ancora che a trovare le coperture della manovra, l'aula della Camera in questi giorni è impegnata a scoprire chi siano i due deputati, una grillina e un leghista, beccati a fare sesso nella toilette di Montecitorio. Grande agitazione tra le onorevoli M5s, scosse da una seconda indiscrezione raccontata sempre da Romana Liuzzo sul Giornale: un'altra eletta Cinque stelle colta in tenere effusioni stavolta con un collega di Forza Italia. È noto che i grillini non tollerino neanche le minime critiche dalla stampa, ma che persino gli aggettivi «vivaci» ed «esuberanti» diventino per loro insopportabili insulti sessisti è una novità. Tanto più che per imboscarsi in un bagno o scambiarsi effusioni bisogna essere in due, quindi a rigor di logica il gossip riguarderebbe anche i deputati, non solo le deputate. Ma niente. La grillina Maria Edera Spadoni ha preso la parola per denunciare vivacemente (con rispetto parlando) al Parlamento il vile attacco in corso e chiedere l'intervento urgente del presidente della Camera Roberto Fico, riedizione grillina della Boldrini. I dialoghi che riportiamo sono tratti dallo stenografico della seduta di ieri, a testimonianza che per davvero la Camera dei deputati italiana si è occupata di scappatelle e flirt con la gravità che spetterebbe ad altre questioni. Il fatto, come ha spiegato la Spadoni, è che non si tratta di un innocuo gossip di Palazzo, macché, qui «ci ritroviamo di fronte all'ennesimo commento sessista» e lei non ci sta a farsi «dare della vivace e della esuberante da una giornalista, perché questa non è informazione, questo è semplicemente sessismo», e insomma se vogliamo «tutelare le donne e l'onorabilità di questa istituzione» bisogna darci tutta una regolata, specie i giornalisti, ha tuonato la Spadoni indignata. La Carfagna le ha ricordato, giusto per la cronaca, gli attacchi subiti dalle donne di centrodestra - i più recenti, proprio dai militanti M5s - che però non hanno mai destato allarmi, men che meno dal M5s, sull'onorabilità delle istituzioni minacciate dal sessismo. Ma poi ha chiesto di parlare il deputato Fiano, del Pd, ed eccolo: «Prendo spunto dalle parole della collega Spadoni per unirmi alla solidarietà per le colleghe del M5s raggiunte da offese o da aggettivi o da accuse di tipo sessista», bisogna aggiungere «un sentimento di grande amarezza» perché «evidentemente la cultura del sessismo è penetrata anche qua dentro. Uniamoci tutti, per favore, perché perlomeno in quest'aula sia fatta barriera a questo modo di considerare il giudizio sulle donne in particolare» (applausi dal gruppo Pd). Il tutto, ricordiamolo, solo perchè in una rubrica del Giornale è stato scritto che due deputati si sono dati appuntamento in bagno e altri due si scambiano «dolci effusioni». Un dibattito surreale, chiuso da par suo da Fico con un impegno solenne: «Questi articoli sono chiaramente sessisti e questa Presidenza ed io assolutamente non li tollero e insieme lavoreremo affinché ci sia un modo per uscirne e cercare di creare una cultura molto più avanzata». Applausi.
Il rapporto hot di due deputati nei bagni della Camera, il gossip non si ferma, scrive il 09/12/2018 Giornalettismo. Il gossip in Parlamento non si ferma, dopo le voci su un rapporto hot di due deputati nei bagni della Camera. Le onorevoli chiedono: «Basta pettegolezzi». Ma spunta un'altra storia. Quando il gossip non si ferma intervengono anche le più alte cariche dello Stato. Dopo il susseguirsi di voci su un rapporto sessuale consumato da due deputati nei bagni della Camera, è stato costretto ad intervenire perfino il presidente dell’Assemblea di Montecitorio. Ieri Roberto Fico ha sbottato affermando «Non sopporto gossip sessisti, qui dentro» in risposta alla vicepresidente di turno, Maria Elena Spadoni, che ha denunciato pubblicamente il fatto offrendo ai pettegolezzi, come raramente avviene, una dignità pubblica. Ne parla oggi il Quotidiano Nazionale (articolo di Ettore Maria Colombo) ricostruendo la vicenda e le prevedibili reazioni di questi giorni. La vicenda è partita da una rubrica di gossip del quotidiano Il Giornale e poi esplosa con un articolo pubblicato su Il Tempo. Come spiega Qn, in Transatlantico non si parla d’altro. Ne conoscono qualche dettaglio parlamentari, giornalisti, funzionari e commessi. Ad essere sorpresi sono stati un deputato della Lega e una collega del Movimento 5 Stelle: avrebbero consumato gli ‘atti erotici’ mentre era in corso in Commissione Giustizia l’esame del ddl corruzione, nei bagni poco distanti dall’aula della riunione. I nomi sarebbero sulla bocca di tutti, ma nessuno li pronunzia pubblicamente per evitare ai due protagonisti della vicenda dei guai familiari, o per evitare querele. E da ieri, fa sapere il Quotidiano Nazionale, si aggiunge una nuova storia. Stavolta sarebbero coinvolti un deputato di Forza Italia e una collega della Lega: una storia alla voce "amori impossibili". Poi l’intervento in aula, con Spadoni contro «gli articoli in cui si descrive l’aria frizzante della Camera e si fa riferimento alle nostre parlamentari, una vergogna». «Questo non è giornalismo, ma sessismo», ha tuonato. La replica della forzista Mara Carfagna: «Mi auguro che d’ora in poi voi 5 Stelle condanniate tutte le volgarità, anche le vostre».
Sesso di cittadinanza, scrive il 10 dicembre 2018 Mauro Mellini su La Valle dei Templi. Scandalo a Montecitorio. Scandalo? Fino a un certo punto. La notizia passata anche sui giornali, che una Deputata P.D. ha sorpreso in un gabinetto del quarto piano della Camera un aitante Deputato della Lega “in freganti grimini” (come diceva G.G. Belli) o, come si dice oggi “a fare sesso” con una altrettanto aitante collega del Movimento 5 Stelle, ha suscitato più compiaciuta ilarità che scandalo. Il fatto che i nomi dei due focosi giovani non siano stati fatti è la prova della verità, del doversi escludere che si tratti di un pettegolezzo, di uno sgambetto alla alleanza giallo-verde. Pettegolezzi, insinuazioni, racconti fantasiosi sono costruiti in genere sui nomi delle persone tirate in ballo. Dei due protagonisti, invece, si dice solo che i nomi si conoscono. E che si tratta di due giovani avvenenti. Come se ciò fosse una mezza giustificazione della scelta del luogo per dar sfogo ai loro ardori. Leggendo quanto ne scrivono i giornali mi è tornato alla mente il titolo (e non solo il titolo) del mio libro uscito in questi giorni: “C’era una volta Montecitorio”. Una volta un fatto simile avrebbe scatenato il finimondo. Ai tempi cui si riferisce il mio scritto si “mormorava”, al più era per qualche scappatella attribuita a poco coerenti Onorevoli, consumata chi sa dove. Ora siamo agli amori consumati nelle latrine. Un contributo notevole alla demolizione del mito della vita da nababbi che i Parlamentari avrebbero sempre goduto a spese di Pantalone. Visto che si parla ogni tanto di “rimpasto”, i due rappresentanti emblematici dello stretto legame tra Lega e Cinquestelle dovrebbero essere chiamati a far parte del Governo. E’ sperabile che qualche tanghero togato non venga fuori a trasformare lo sgomento per la mancanza di rispetto per l’Istituzione, il suo Palazzo, le loro stesse funzioni e la mancanza di buon gusto in un capo di imputazione per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante etc. etc. e con chi sa quali argomentazioni per dimostrare, intanto, che i due non hanno, nel caso, agito nella qualità di rappresentanti dell’intera Nazione e che non si tratta di “voti dati ed opinioni espressi nell’esercizio del mandato”. La questione andrebbe invece valutata dai sostenitori di questa fase del “nuovo”, come l’espressione della concezione populista che tende a sostituire il culto delle Istituzioni con l’adeguamento di quanto attiene alla vita dei loro rappresentanti, ai costumi e al comportamento del popolo. Non è da escludere che dal mezzo scandalo delle latrine di Montecitorio nasca una battaglia per assicurare un minimo di sesso ed una opportuna disponibilità di luoghi per praticarlo ad ogni cittadino. Può darsi che se non si placherà subito il chiacchiericcio sui due giovani parlamentari, venga fuori, con tanto di dichiarazione di sostegno via internet, di una “aggiunta al contratto di Governo” di qualcosa come il “sesso di cittadinanza”. Che di “copertura” pare non abbia troppo bisogno. Staremo a vedere. Salti chi può. Mauro Mellini
Vittorio Sgarbi vuota il sacco, roba da censura in Parlamento: "Dove e come lo ho fatto", scrive il 10 Dicembre 2018 "Libero Quotidiano". Prima la grillina con un esponente di spicco della Lega. Poi (ancora) una grillina con un deputato di Forza Italia. Le cronache di gossip politico della scorsa settimana hanno raccontato delle "imprese" a luci rosse tra onorevoli di opposte fazioni. E chi se non un libertino godereccio come Vittorio Sgarbi potrebbe svelare la mappa del sesso di Montecitorio? A chiedergliela è stata la trasmissione L'Italia s'è desta su Radio Cusano Campus. "Dovrò indagare" ha detto il critico d'arte e deputato del gruppo Misto (ma eletto lo scorso 4 marzo con Forza Italia) relativamente ai recenti episodi. "Io e altri ne abbiamo fatte tante alla Camera quando eravamo ragazzi, era tutto un fare sesso, lo facevamo in maniera più abile. Non si può andare in Commissione Giustizia, ti sanzionano pure magari per sco*** con associazione a delinquere. Per stare tranquillo devi andare dove ci sono le commissioni disperate, quelle abbandonate tipo la Commissione Agricoltura o Turismo così non ti becca nessuno”.
"Ex presidente della Camera beccato a fare sesso orale". Il vignettista Vincino: "Fu sorpreso con un commesso nell'ascensore di Montecitorio...". Ma non fa il nome dell'ex presidente della Camera coinvolto, scrive Luisa De Montis, Sabato 26/07/2014, su "Il Giornale". "Mi piace andare nei luoghi dove le cose accadono". Vincino, all’anagrafe Vincenzo Gallo, fa il vignettista. E da sempre racconta i palazzi del potere romano. Eppure, in una intervista di Giancarlo Dotto per Diva e Donna, tira fuori dal cassetto dei ricordi un aneddoto che ai più è sconosciuto. Al centro del pettegolezzo c'è un presidente della Camera. Non si sa il nome. Ma si sa molto bene cosa ha fatto: sesso orale. Presentando a Dotto l'ultimo libro appena pubblicato, La cavalcata di Renzi, il 68enne palermitano racconta un retroscena a luci rosse che si è consumato tra le mura del Palazzo. "A Montecitorio un ex presidente della Camera fu beccato mentre praticava sesso orale con un commesso". Vincino non fa il nome dell'ex presidente, ma la sua rivelazioni è abbastanza forte da gettare un'ombra di scandalo su Montecitorio. Tanto che molti hanno iniziato a interrogarsi su quali e quante pratiche sessuali spinte vengano quotidianamente praticate alla Camera.
Anna Falchi, il raptus dell'onorevole: "Cosa mi ha fatto sotto il tavolo il ministro di sinistra", scrive il 7 Dicembre 2018 Libero Quotidiano. Anna Falchi scatenata a Un giorno da pecora. E' vero che una volta un ministro di sinistra le fece delle avances molto esplicite? “Mi diede quello che io chiamo il morso del cavallo", risponde l'attrice, "un pizzicotto sotto al tavolo, sulla coscia”. Quando accadde? “Una decina di anni fa. Io misi le gambe dalla parte opposta per non dargli la possibilità di nuovi 'pizzicotti'. Poi mi alzai, andai in toilette preoccupata dal dover tornare lì. Quando uscì mi trovai di fronte un giornalista, che era al tavolo con noi, il quale mi rassicurò dicendomi: non ti preoccupare, siediti vicino a me, ci penso io a proteggerti”. Parliamo del suo fidanzato Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa: ha già comprato il suo ultimo libro? “Me lo ha regalato facendo anche una dedica: 'ad Anna e i suoi fornelli', riferendosi alla trasmissione che conduco in tv”. E lo ha letto? “Io leggo molto ma quello è un po' pesante. Come fermaporte è fantastico!”, ha scherzato la Falchi a Radio1.
«Palpeggiate dai politici», scandalo sessuale anche al Parlamento europeo, scrive martedì 24 ottobre 2017 Secolo D’Italia. Dopo il clamore suscitato dal CASO WEINSTEIN e la conseguente ondata di denunce di molestie, l’ombra degli scandali sessuali potrebbe allungarsi, anche alle istituzioni europee. Un’inchiesta pubblicata domenica scorsa dal Sunday Times punta il dito contro il Parlamento europeo accusandolo di essere un “focolaio di molestie sessuali”. Secondo quanto riferito dal giornale, che pubblica le testimonianze di diverse assistenti, più di una dozzina di donne che hanno lavorato all’Europarlamento avrebbero accusato i politici di averle palpeggiate, molestate e trattate come “pezzi di carne”. Il Sunday Times mantiene anonime le vittime dei presunti reati in quanto nessuna di loro ha denunciato gli abusi alla polizia. Al Parlamento europeo, riporta la Bbc, ci sarà mercoledì un dibattito sul tema delle molestie sessuali nelle istituzioni Ue e voterà una mozione a riguardo. Lunedì, commentando le notizie apparse sulla stampa, il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani ha dichiarato: «È con choc e indignazione che ho appreso delle recenti accuse di molestie sessuali al Parlamento europeo. Tuttavia, lo choc non può essere la risposta», anche se sono «già stati intrapresi passi avanti», ora «è necessario aumentare ulteriormente la conoscenza delle soluzioni già disponibili».
DALEMA QUERELA IL GIORNALE...(AGI 25 giugno 2009) - Il presidente della Fondazione Italianieuropei, Massimo D'Alema, ha dato mandato ai propri legali di querelare per diffamazione 'Il Giornale' per quanto pubblicato oggi. E' quanto si legge in una nota.
2 - DIREZIONE "IL GIORNALE" SU QUERELA D'ALEMA... (AGI 25 Giugno 2009) - La direzione de "Il Giornale" replica sulla querela annunciata da Massimo D'Alema contro il quotidiano: "Saremo ben lieti - si afferma in una nota - di discutere in un'aula di tribunale con l'onorevole Massimo D'Alema i contenuti dell'articolo pubblicato oggi dal Giornale, dal momento che tutto ciò che è scritto fa parte di un'inchiesta che noi abbiamo riportato fedelmente. All'onorevole Zanda che parla di 'violenza vuota' consigliamo, se non altro, almeno la lettura dei servizi prima di sbilanciarsi in dichiarazioni. Certo stupisce che i parlamentari più impegnati a difendere la libera stampa in questi giorni diventino all'improvviso così nemici della libera stampa, tanto da ricorrere subito ai giudici e agli insulti volgari nei confronti di un quotidiano colpevole di raccontare alcuni episodi (accertati) e di porre alcune domande".
L'ARTICOLO DE "IL GIORNALE" CHE HA FATTO INFURIARE D'ALEMA, di Gian Marco Chiocci per il Giornale del 25 giugno 2009. C'è un'inchiesta, a Bari, che anziché restare riservata finisce sui giornali perché riguarda indirettamente un premier e/o persone a lui vicine presumibilmente in contatto con alcune prostitute. E c'è un'altra inchiesta, a Roma, che invece resta «sconosciuta» per quasi dieci anni e che riguarda l'entourage di un altro premier in contatto sicuramente con una scuderia di prostitute d'alto bordo. Il doppiopesismo mediatico-giudiziario cui si fa riferimento concerne un'inchiesta avviata nel 1999 dal pm capitolino Felicetta Marinelli e conclusasi il 4 ottobre 2000 con il patteggiamento a un anno della maîtresse R.F. che secondo l'accusa inviava sue «squillo» ai fedelissimi dell'allora presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, per ottenere ritorni economici di vario genere. Sono svariati i nomi eccellenti che tornano nei verbali d'interrogatorio e nelle intercettazioni disposte a seguito dei pedinamenti fin sull'uscio di Montecitorio da parte degli agenti della Squadra mobile: si va da Francesco «Franco» Mariani, un tempo responsabile dei trasporti del Pci-Pds e ora presidente dell'autorità portuale di Bari (revocato dal ministro Matteoli e reinsediato dal Tar) ai due ex soci del leader Massimo nella compravendita della barca Ikarus: innanzitutto, Roberto De Santis, pugliese ed eminenza grigia del leader Ds, già vicepresidente della finanziaria London Court, quindi nel cda della Spa portuale «Marina Blu» e poi in quello della società d'energia «Avelar Energy»; dopodiché Vincenzo Morichini, ex amministratore delegato del consorzio Ina-Assitalia, fondatore dell'Assonautica romana, da sempre vicinissimo a D'Alema. Nei brogliacci delle telefonate sbobinate a piazzale Clodio si fa anche esplicito riferimento ad alcuni episodi dove viene citato l'allora «segretario particolare di D'Alema», ovvero Nicola Latorre, oggi parlamentare del Pd. Nelle informative c'è spazio infine per i ruoli ricoperti dall'ex deputato Ds, Michele Giardiello e da un paio di funzionari ancor oggi nel partito di Franceschini. Le persone di fiducia di D'Alema finite agli atti del procedimento numero 10498/99, a eccezione di Latorre, sono state prese a verbale come persone informate dei fatti direttamente negli uffici della Settima sezione della questura di Roma. Obiettivo degli inquirenti era infatti quello di capire se effettivamente la maîtresse facesse ricorso a ragazze a pagamento per «convincere» persone importanti a dare una mano alla sua agenzia di pubblicità nella gestione di eventi, convegni (la donna ne ha organizzato un paio per la Camera dei deputati) appalti e pubblicazioni per strutture come Alitalia, Banca di Roma, Enel, Eurostar, Ina-Assitalia, Acea, Inpdap, eccetera. Se l'allora dirigente della Mobile, Nicolò D'Angelo, era pressoché convinto dell'andazzo corruttivo («la donna che inequivocabilmente procura ragazze a molte persone organizzando incontri sessuali - scriveva in una informativa - utilizza tale "chiave di accesso" per ottenere dai destinatari di queste "attenzioni" che sembrano essere tutti ai vertici di strutture pubbliche o private, favori e indebite pressioni al fine di ottenere benefici economici nella forma di ghiotti appalti o incarichi ben remunerati») il pm Marinelli rimarcava: «Dalla lettura dei verbali emerge che R.F. utilizza le ragazze per organizzare incontri di carattere chiaramente sessuale con personaggi, di cui alcuni facenti parte del mondo politico, o aventi cariche in enti pubblici». L'indagine, come tante nel sottobosco della prostituzione, nacque un po' per caso. Solita routine: una soffiata, un accertamento, un'arida informativa. Poi arrivarono i pedinamenti, i telefoni sotto controllo, i riscontri su un'organizzazione di via Veneto diretta dall'austriaca Angelica W. e un centro massaggi dell'Eur dove venivano reclutate ragazze per i festini. E quel che sembrava un «normale» giro di squillo della Roma-bene, s'è rivelato presto un «problema» politico per tutti coloro che s'erano ritrovati tra le mani quel materiale scottante. In procura si accavallarono le riunioni. In questura gli accertamenti rallentarono bruscamente. L'ipotesi iniziale della corruzione venne presto derubricata in sfruttamento della prostituzione finalizzata a portare a casa contratti importanti con aziende private e istituzioni pubbliche. I controlli sui telefoni dell'indagata vennero interrotti, la richiesta di rinvio a giudizio fu recapitata all'interessata, si arrivò al processo senza dare alcuna pubblicità all'esito finale. Con la maîtresse condannata, in tanti tirarono un sospiro di sollievo. Nessuno, nemmeno il preveggente D'Alema, poteva immaginare che a dieci anni di distanza potesse arrivare una simile «scossa». I primi sentori di un giro di «escort» intorno ai palazzi del potere romani vengono messi nero su bianco da un ispettore della Squadra mobile romana nel giugno del '99. Nell'appunto si fa riferimento a una maîtresse, R. F., titolare di un'agenzia di pubblicità, che secondo una fonte qualificata starebbe reclutando ragazze per «farle prostituire con facoltosi clienti». La polizia riferisce dell'attività di R. F. che avrebbe assoldato una certa Marina «per un incontro a sfondo sessuale con un personaggio molto importante» retribuito con 800mila lire. «Dopo essersi accordate sulla cifra - prosegue la relazione - uscivano entrambe raggiungendo da una via laterale l'entrata della Camera dei deputati. Dopo aver varcato il portone d'ingresso, si fermavano davanti a un commesso preposto alla consegna dei "pass", il quale, senza alcuna richiesta, con atteggiamento molto confidenziale, consegnava a R. F. due pass senza ricevere in cambio alcun documento. Dopo aver passato il varco d'ingresso si dirigevano nell'ufficio di un personaggio, a dire della ragazza molto importante, che le faceva accomodare entrambe». «Lo stesso, dopo aver visionato la ragazza e averci dialogato, durante la conversazione chiedeva alla stessa se era disponibile a viaggiare in qualità di "accompagnatrice" di personaggi molto influenti, prospettandole in cambio la possibilità di guadagnare molto denaro (...). R. F. diceva alla ragazza che dopo poco sarebbe entrato un uomo e con lui doveva congiungersi carnalmente. Infatti dopo poco giungeva un uomo e all'interno dell'ufficio la ragazza aveva un rapporto sessuale. Al termine quest'ultimo riferiva di essere rimasto molto soddisfatto e che tramite il suo segretario, se lei era disponibile, si sarebbero nuovamente incontrati per seguirlo in uno dei suoi spostamenti all'estero (...). Si rappresenta inoltre che la ragazza, anche se raccontava nei particolari alla fonte l'incontro avuto all'interno della Camera dei deputati, evitava di dire le generalità del personaggio molto influente» per paura di ritorsioni. La successiva nota inviata in procura dall'ex dirigente della Mobile, Nicolò D'Angelo, dava il senso delle indagini fin lì svolte. «Dal tenore delle conversazioni si è avuto modo di constatare che le utenze vengono utilizzate da R. F. e dalla sua segreteria per contattare noti personaggi del mondo politico e di enti pubblici, servendosi della loro conoscenza al fine di ottenere appalti o erogazioni in denaro (...). È emerso in modo palese che la R. F., al fine di mantenere e in seguito sfruttare tali conoscenze, organizza con gli stessi incontri a sfondo sessuale». Francesco Mariani sfila negli uffici della settima sezione della questura il 10 dicembre '99. Le sue prime risposte vertono in merito a un suo presunto interessamento per aiutare R. F. in alcuni progetti con Alitalia: «Ho conosciuto R. F. nel maggio '99 in quanto durante una cena da me organizzata fu portata dal Morichini, presentandola quale sua amica, il quale qualche giorno dopo mi chiamò sapendo della mia conoscenza con Zanichelli (ex relazioni esterne Alitalia, ndr). R. F. mi disse che trovava ostacoli di comunicazione con Alitalia in quanto a suo dire amica di Morichini era vicina all'area di sinistra». Mariani spiega di essere andato da Zanichelli, di avergli chiesto di prendere in considerazione il progetto della donna di rilanciare la rivista Freccia Alata. «Zanichelli mi disse che oltre alla mia, aveva ricevuto diverse segnalazioni per R. F. provenienti da diverse aree politiche (...). Dissi a R. F. che avevo sollecitato Zanichelli, poi la invitai a cena a casa dove, dopo cena, avemmo un rapporto sessuale (...)». «Confermo che nell'arco della mia conoscenza ho avuto diversi incontri a sfondo sessuale con R. F. In queste occasioni più volte la stessa si presentava anche con sue amiche (ne cita tre, di cui una brasiliana, ndr) e in queste occasioni avemmo dei rapporti sessuali. Rappresento comunque che oltre a me vi erano a volte anche Morichini Vincenzo, De Santis Roberto e Lazzarini Franco, con i quali le ragazze si univano carnalmente (...). Per quanto riguarda questi incontri rappresento che si svolgevano sempre presso la mia abitazione (...). Rappresento che se ho avuto qualche dubbio sulla libertà sessuale delle ragazze portate alle mie cene da R. F. non ho mai chiesto nulla in quanto in una occasione R. F. mi disse che lavoravano per lei e le utilizzava quando organizzava convegni (...). Preciso che le segnalazioni effettuate nei confronti di R. F. sono avvenute con lo Zanichelli e basate su nostri lontani rapporti di amicizia, senza che venisse fatta da me alcuna intimidazione né tantomeno venissero fatte alcune pressioni politiche». Preso a verbale il 13 dicembre '99, Morichini conferma la versione fornita da Mariani, confessa d'aver segnalato la donna al responsabile servizio marketing di Ina-Assitalia, dice che la donna le venne presentata dal «mio amico Proietti» e aggiunge: «Venni invitato a una cena da Mariani che mi disse di portare alcune amiche. Nel contesto invitai R. F. che si presentò con tre sue amiche, alla cena c'erano anche De Santis e Lazzarini. Chiesi a Mariani se poteva aiutarla in Alitalia in quanto lui, essendo stato segretario nazionale dei trasporti, aveva conoscenze influenti. Dopo la cena ognuno si appartò con una ragazza in una stanza. So che Mariani si è interessato con Zanichelli per farla lavorare. A casa del Mariani abbiamo organizzato almeno altre due cene che alla fine terminavano con incontri a sfondo sessuale, in queste occasioni le ragazze erano portate da R. F. che durante i nostri rapporti mi chiedeva in continuazione di aiutarla servendomi delle mie conoscenze (...)». «Per quanto riguarda la frase da me detta durante la telefonata da voi intercettata riguardo "Ti ho risolto i problemi con Banca di Roma e Alitalia" tale frase sta a significare che avevo fatto telefonate a tali enti segnalandola». E ancora: «Sì, ho saputo del vostro intervento (della polizia, ndr) nei confronti di R. F. che un giorno mi chiamò dicendomi che mi doveva parlare di persona. Prendemmo appuntamento da Doney in via Veneto e nell'occasione mi disse che era soggetta a indagine di polizia, che erano state fatte foto all'interno del suo ufficio ed erano state registrate telefonate e conversazioni. Quindi mi invitava a servirmi delle mie conoscenze per arrestare tale indagini, sennò, sentendosi persa, avrebbe raccontato dei nostri incontri. Rendendomi conto del velato ricatto a cui ero soggetto, le dissi che non mi interessava nulla e che non volevo avere più rapporti con lei (...). Sì, effettivamente ho fatto delle segnalazioni nei confronti di R. F. con vari enti ma specifico che non sono a conoscenza se ha fruito di tali raccomandazioni con contratti di lavoro». Concludendo: «Sì, effettivamente conosco sia il presidente del Consiglio che il suo segretario particolare da lunga data ma rappresento che tutto quello che ha detto R. F. su questi personaggi è solamente frutto della sua immaginazione, in quanto non sono mai state organizzate cene né tantomeno l'ho segnalata servendomi di tali amicizie influenti (...)». Sul «segretario di D'Alema» (Nicola Latorre) citato il 5 ottobre da R. F. in due telefonate, la polizia si limita a riportare solo la frase: «giovedì saranno a cena con lui e il segretario di D'Alema». Latorre, contattato dal Giornale, esclude categoricamente qualsiasi coinvolgimento nell'inchiesta: «Non sono mai stato interrogato e non so nulla di questa vicenda». Il 16 dicembre '99, tocca a Roberto De Santis rendere la sua versione sui fatti contestati. «Ho conosciuto per la prima volta la signora R. F. in quanto era presente a una cena in cui ero stato invitato da Morichini. Oltre a noi erano presenti tale Checchino e tre amiche di Rita. Dopo la cena ci recammo su invito di R. F. nel suo ufficio dove loro si appartarono con le ragazze e io rimasi con una giovane brasiliana senza consumare alcun rapporto sessuale (...). La seconda volta è stata nell'abitazione di Mariani dove oltre a me erano presenti Morichini, Lazzarini e due ragazze brasiliane. Dopo cena mi appartai con una di loro ed ebbi un rapporto sessuale». De Santis riferisce di altri due incontri, finiti sempre allo stesso modo. «Voglio precisare che non ho mai dato denaro né ho mai fatto regali alle ragazze intervenute, i miei incontri con R. F. sono stati solo di carattere sessuale e mai si è parlato di lavoro (...). L'ultima volta che l'ho vista è stato ai primi di novembre dopo il vostro intervento all'Alitalia, la incontrai casualmente in un bar del centro ed era agitata. Mi disse che dovevo sollecitare un intervento del Mariani e del Morichini affinché l'aiutassero a trovare un nuovo lavoro, poiché a seguito dell'indagine lei aveva avuto dei problemi, sostenendo tra l'altro che l'indagine in corso lei la stava subendo per colpa del Morichini e del Mariani in quanto volevano colpire la sinistra».
Lazzarini, il re delle assicurazioni che ospitava l'ex ministro Burlando...Genovese come Mariani, Franco Lazzarini, 59 anni, è il broker assicurativo (executive chairman di Ital Brokers, che gestisce un portafogli di oltre 750 milioni di euro) che nel 2007 è finito al centro delle cronache per aver condiviso casa, auto e passatempi con il governatore della Liguria, Claudio Burlando, accusato di averlo favorito in appalti pubblici. «Sospetti assurdi. Io, poi, sono socialista» replicò lui. Manager dal passato come calciatore professionista (negli anni Settanta, nelle fila della Sampdoria) e un presente fatto di buone amicizie politiche. Oltre a Burlando, soprattutto l'ex presidente dei Ds Massimo D'Alema. Centocinquanta dipendenti, sede in una splendida villa genovese in uno dei quartieri più eleganti della città, Albaro, uffici sparsi in tutta Italia, la Ital Brokers dall'81 ha via via scalato il vertice del business assicurativo, conquistando clienti come Alitalia, Finmeccanica e anche la Camera dei Deputati.
De Santis, l'azionista delle sale Bingo al timone della barca di Massimo...Leccese, 53 anni. Negli anni '80 ha militato nel Pci leccese, ma balza agli onori delle cronache nel 1997 quando assieme a Vincenzo Morichini risulta tra i comproprietari di Ikarus, il baltic viareggino che sarà acquistato dall'appassionato di vela Massimo D'Alema alla fine di quell'anno. Nel 2000 De Santis ritorna sotto i riflettori come socio della London Court una merchant bank che insieme con la Chance Mode di Luciano Consoli è azionista di Formula Bingo, la società che in quell'anno voleva partecipare alla gara per la gestione delle sale dedicate alla tombola inglese. Dopo le dimissioni di D'Alema da premier di De Santis si perdono un po' le tracce anche se ha fatto parte di vari consigli di amministrazione. Come quello della fallita Festival Crociere, di Marina Blu, società che gestisce la darsena di Rimini, e di Avelar Energy, la società per le fonti alternative del magnate russo Vekselberg, titolare del gruppo Renova che due anni fa ha acquistato Marina Blu.
Mariani, il comunista della Liguria sempre al vertice dei porti «rossi»...Dirigente del Pci ligure negli anni '80, nella seconda metà degli anni '90 è stato responsabile trasporti del Pds-Ds, poi nel 2000 è stato collaboratore del ministro dei Trasporti Pier Luigi Bersani. Ha in seguito assunto la direzione nazionale dell'Ancip, l'associazione delle compagnie portuali. Nella sua casa genovese ha ospitato un ricevimento per i candidati del centrosinistra alle amministrative 2002. È stato presidente di Intempo, società di lavoro interinale al servizio dei principali porti italiani. Alla fine del 2005 è stato nominato commissario dell'Autorità portuale di Bari, dal 2006 ne è presidente. Ha assunto per qualche tempo pure la presidenza di Bari Porto Mediterraneo (Bpm), la società che gestisce il terminal passeggeri. L'apertura di un'inchiesta della procura di Bari sulla natura dei rapporti tra Autorità e Bpm lo ha indotto a rescindere il contratto tra i due enti. Il ministro Matteoli ha commissariato l'Autorità portuale, ma il Tar ha accolto il ricorso di Mariani.
Morichini, agente di professione fondatore dell'Assonautica romana...Folignate. Titolare di un'agenzia assicurativa. Come De Santis balza anche lui alle cronache per la nota cessione di Ikarus. Ma il suo ramo è quello assicurativo: agente, nel 1994 viene nominato dal presidente Ina Lorenzo Pallesi amministratore del consorzio delle agenzie Ina-Assitalia di Roma. In un periodo di sostanziale vuoto di potere politico la gestione del gigante assicurativo vicino alla Dc viene spostata un po' più a sinistra: tra i soci di un'agenzia romana entra anche l'imprenditore di area dalemiana Pino Marzo. Nel 1998 Morichini termina il proprio incarico e diventa titolare di una nuova agenzia Ina-Assitalia, l'Agf di Fiumicino che dirige ancor oggi e che fornisce servizi a buona parte del litorale e della periferia ovest della Capitale. La passione per le barche non è morta. A fine 2007 Morichini con la sua agenzia è tra i fondatori dell'Assonautica romana, associazione per lo sviluppo della nautica collegata alla Camera di Commercio di Roma.
Lucio Barani: "Tanti senatori sniffano cocaina", scrive il 28 Marzo 2015 Barbara Romano su Libero Quotidiano. Lucio Barani da Aulla, classe 1953, senatore iscritto al gruppo delle Grandi autonomie e libertà. Socialista più craxiano di Craxi, come certificano i suoi continui pellegrinaggi ad Hammamet («la terra santa degli orfani di Bettino») e il garofano che ammicca dal taschino. Ha appena messo a segno un record: è il primo parlamentare della Repubblica che prenderebbe a sberle la seconda carica dello Stato. Prova a smussare: «No, io non ho detto questo. Ho detto che sono pronto a dare quattro ceffoni a chiunque cita a sproposito Calamandrei e i padri costituenti che ci hanno dato questa Costituzione garantista». Resoconto stenografico dell’Aula, seduta del 26 marzo. Il senatore Barani rivolto al presidente Grasso: «Credo che anche i suoi genitori le abbiano dato ceffoni, e forse, se gliene avessero dati di più l’avrebbero educata meglio». «Gli ho detto che avremmo dovuto avere un’educazione riformista dai nostri genitori, che avrebbero dovuto darci qualche scappellotto in più. A tutti noi, compreso Grasso. A scopo educativo».
Grasso è maleducato?
«No, ma non è adatto alla politica. Ha fatto il magistrato, quindi è abituato solo a emettere sentenze. E non è in grado di capire quali sono i mali del Paese, la diagnosi e la cura. Il suo ddl anticorruzione aumenta le pene e non risolve niente. È come se dinanzi a un tumore, se non funziona la chemioterapia, il medico dicesse: “Ok, aumentiamo la dose”».
C’è chi lo fa.
«Da medico le assicuro che così il malato muore. Lo stesso vale per la corruzione: l’aumento sic et simpliciter della pena non guarisce il reato, anzi. Portare la prescrizione a 30 anni ammazza il paziente».
Secondo la sua metafora Grasso è un assassino.
«No, però ragiona da pm. Lui e la politica sono agli antipodi. È come se dicesse: “Siccome ho fatto il capo dell’Antimafia, mi metto a pilotare un aereo”. Un disastro».
Da capo dell’Antimafia qualche competenza in materia Grasso l’avrà pure ottenuta.
«Secondo me lo ha fatto con dubbi risultati. La mafia non l’ha sradicata, anzi è più viva che mai. Di sicuro combina disastri ogni volta che presiede l’aula, perché gli mancano le basi politiche. Non ci si improvvisa legislatori da un giorno all’altro. Lui è un magistrato».
È il fatto che sia un magistrato il motivo per cui le sta tanto sulle scatole?
«Ma no, a pelle mi sta pure simpatico. È un bambinone».
E allora perché lo attacca in modo così duro?
«Perché è un dilettante allo sbaraglio, non è in grado di affrontare nessuna questione politica. S’intende solo di pene, giustizia e repressione. E perché è totalmente asservito alla maggioranza. È un militante del Pd, nelle cui file è stato eletto. Se lui continua a fare come gli pare in aula, chiederò d'istituire una commissione d'inchiesta sui presidenti della Repubblica e su quelli del Senato che, come Grasso, hanno svolto il loro ruolo in modo fazioso, non garantendo le minoranze e i regolamenti».
Lei ha presentato emendamento che propone la fucilazione per i rei di corruzione.
«Proprio perché sono un garantista, nel secondo comma ho scritto: “La pena non può comportare la morte del reo”. Ovvio che la mia era una provocazione, una boutade. Io parlo per parabole, come nostro Signore».
Barani come Gesù.
«Se la corruzione è di così grave allarme sociale fuciliamo tutti i corrotti, no? Come si faceva con i briganti, torniamo indietro di 150 anni. La mia era una presa in giro per dire che i processi dobbiamo farli subito, su-bi-to! Non possiamo lasciare uno venti anni a bagnomaria, scherziamo? È anticostituzionale».
Craxi, il suo mentore, fu condannato per corruzione. Lo vuole vendicare?
«Craxi era innocente per davvero. Mentre i magistrati sono gli unici in Italia che non pagano mai per i loro errori. Hanno in mano la vita delle persone, io li sottoporrei a visite psicoattitudinali. Per estirpare la corruzione ci vorrebbero degli statisti, non degli ubriaconi. È come dare l’Avis in gestione a Dracula. Non abbiamo messo Poletti, il capo delle coop rosse, al ministero del Lavoro? Lo stesso vale per Grasso».
Che c’entra adesso Poletti?
«Poletti al Welfare ovviamente farà gli interessi delle coop. E se metti il capo dell’Antimafia alla presidenza del Senato, cosa farà? Vorrà inquisire tutti, no?».
Lei in Senato ha anche detto: «In quest’Aula c’è chi si droga». A chi si riferiva?
«C’è gente che soffre di cretinismo politico, poi tira di coca e viene in Aula a blaterare».
Ci sono senatori che pippano cocaina?
«Certo. Ce ne sono tanti. Io sono medico, ho fatto diagnosi per molti anni. Basta che li guardi negli occhi, so riconoscere le pupille di chi sniffa. Poi chiedono la parola e parlano a sproposito».
In quali partiti sniffano di più?
«In quelli di nuova formazione, dove dilaga il cretinismo politico. La colpa non è solo della impreparazione, ma anche dell’assunzione di sostanze stupefacenti». Di Barbara Romano
Droga in Parlamento: trovate tracce di cocaina nei bagni della Camera. Il test eseguito da un cronista su alcuni residui rinvenuti nei servizi maschili prima di un voto, scrive Sabato 06/05/2017 "Il Giornale". Tracce di cocaina nei bagni di Montecitorio. Il Fatto Quotidiano sceglie uno scoop stupefacente per lanciare il suo nuovo inserto mensile, Millennium, diretto da Peter Gomez, mandando un suo giornalista, Thomas Mackinson, armato di telecamera e salviette impregnate di reagente capace di rilevare tracce di cocaina. Mackinson è entrato nei bagni dell'atrio della Camera dei Deputati (comunque non riservati all'uso esclusivo dei parlamentari) lo scorso 29 marzo, giorno di votazioni, ha controllato un po' di mensole a inizio giornata senza rilevare nulla e poi è tornato qualche ora dopo, immortalando con la telecamera le salviette che si tingevano di blu, ossia reagivano positivamente. Scoop stupefacente, appunto, ma che non deve stupire. L'accostamento tra droghe e Palazzo non è certo una novità. Successe in Gran Bretagna, alla Camera dei Comuni, con il Sunday Times a fare i test che imbarazzarono i parlamentari britannici poco prima del nuovo millennio. Poi arrivò il bis in Germania, al Bundestag, dove i cronisti di una tv trovarono 22 bagni su 28 positivi alla cocaina. In Italia tra i primi a lanciare l'allarme fu Ramon Mantovani nel 2001: l'allora responsabile esteri di Rifondazione denunciò l'uso di spinelli e cocaina da parte dei suoi colleghi. Il botto arrivò un lustro più tardi quando - era il 2006 - le Iene tirarono un brutto scherzo a decine di parlamentari, intervistati e «tamponati» da una truccatrice che, in realtà, prelevava campioni dalla fronte degli ignari onorevoli. Su cinquanta, ben 16 risultarono positivi, dodici alla cannabis e quattro alla cocaina. Il parlamento si divise tra scandalizzati per il risultato (come Alessandra Mussolini che chiese al programma di Italia1 di rivelare i nomi dei positivi) e irritati dal test galeotto, come Luigi Lusi, Pierferdinando Casini e Italo Bocchino, che annunciò querela e chiese il sequestro immediato dei campioni raccolti «illegalmente».
Poi arrivò il test volontario promosso nel novembre 2009 da Carlo Giovanardi, sottosegretario alle politiche antidroga. Lo fecero in 232, molti preferirono restare anonimi. E tra questi, anche il parlamentare che risultò positivo alla cocaina. «Non so chi sia. Non ho la più pallida idea, se è senatore o deputato, se è uomo o donna. Il risultato del test è segreto», sospirò Giovanardi. Per non saper né leggere né scrivere, quando il M5s propose di fare verifiche antidroga sui parlamentari, nell'agosto 2015, i deputati bocciarono l'ordine del giorno. Che prevedeva «controlli ambientali periodici» in diversi luoghi, tra cui i bagni di Montecitorio, ora di nuovo accusati dal Fatto di essere covi di onorevoli fattoni. Ma anche su Palazzo Madama ci sono sospetti. Nel 2015 Lucio Barani di Ala, intervistato da Libero, sui senatori che «pippavano» disse: «Ce ne sono tanti. Riconosco le pupille di chi sniffa».
Cocaina in Parlamento, la Camera precisa e MillenniuM risponde. I politici? Molti si difendono, pochi accusano. Il portavoce della Boldrini scrive una lettera al Direttore del mensile: "In quei bagni accedono anche esterni autorizzati, commessi, la tesi che sia stato un parlamentare è infondata". La replica: "Lo abbiamo scritto e per questo abbiamo concentrato le prove nelle ore di minima presenza di esterni e massima di deputati". Prime reazioni politiche tra difese d'ufficio e accuse, scrive "Il Fatto Quotidiano" il 7 maggio 2017. La Camera precisa, la polemica continua ma i politici si difendono. “Caro Gomez, l’articolo del vostro magazine Millennium intitolato "La Camera se la tira. Tracce di cocaina nel bagno dei deputati" merita una precisazione”. Inizia così la lettera di Stefano Menichini, capo ufficio stampa della Camera dei Deputati, che risponde al servizio di MillenniuM che ha rilevato la presenza di cocaina nei bagni di Montecitorio. “A prescindere dal tono dell’articolo, denigratorio verso l’istituzione, e dalla veridicità e attendibilità dell’analisi effettuata, la cosa che va precisata è che i servizi igienici in questione non sono affatto “dei deputati” e tanto meno “inaccessibili agli esterni”, come scrive il giornalista che evidentemente della Camera conosce poco. All’opposto, chi conosce Montecitorio sa che quei bagni sono frequentati, oltre che dai deputati, dai giornalisti, dai dipendenti, dagli addetti dei servizi esterni e da qualsiasi cittadino sia ammesso, a qualsiasi titolo, all’interno del palazzo. La tesi esposta dall’articolo appare perciò quanto meno infondata”. Poche righe cui l’autore del pezzo Thomas Mackinson risponde: “Caro Stefano, sono molto sicuro di quello che ho visto, scritto e documentato. Proprio perché ai servizi igienici appena fuori dall’aula possono accedere anche commessi e persone esterne autorizzate abbiamo concentrato le verifiche quando il tasso di esterni era prossimo allo zero e quello dei deputati più elevato. L’Italia intera è sollevata di sapere, nonostante i precedenti non depongano a favore, che l’Ufficio Stampa della Camera è poco allarmato della cocaina in Parlamento e molto che si possa pensare che a usarla siano i deputati. In effetti potrebbe farlo anche un ospite-pusher che accede liberamente all’istituzione senza controlli, un commesso che la serve con particolare gaiezza o magari – perché no – un bimbo di una scolaresca in visita, che alle otto di sera non avevano di meglio da fare”.
Le reazioni: dalla M5S Ciprini a Giovanardi. Mentre in rete la notizia, ripresa anche da altri giornali, continua a tenere banco, tra sdegno e ilarità sono arrivate le prime reazioni politiche. “Ora mi spiego perché per due volte l’aula ha bocciato gli ordini del giorno con i quali chiedevo di sottoporre a controlli antidroga i parlamentari, così come viene imposto ad altre categorie di cittadini”, dice Tiziana Ciprini dei Cinque Stelle. “Il ritrovamento di tracce di cocaina nel bagno maschile dei deputati, appena fuori dall’aula di Montecitorio, rivelato dal FQ MillenniuM, è un fatto di una gravità inaudita”, scrive in una nota l’onorevole di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano. “Non solo si potrebbero ravvisare dei comportamenti illeciti da parte del consumatore ma si tratta di una palese violazione di un inderogabile dovere civico e morale dei parlamentari: dare il buon esempio. E comunque, sapere che qualcuno possa legiferare non in piena lucidità fisica e mentale rappresenta un alto fattore di rischio per la qualità legislativa. Quando negli anni scorsi scoppiò una polemica simile mi sottoposi senza indugio all’esame tossicologico, sono disponibile a ripetere la prova e invito tutti i miei colleghi a farlo. È in gioco la dignità dell’Istituzione”. Pippo Civati se la ride. L’estate scorsa, quando la Camera decise di non liberalizzare la cannabis, consegnò a Twitter la frase più corrosiva, che ora il segretario di Possibile non può farsi scappare: “630 cocainomani bocciano la cannabis”. E oggi al Giornale precisa: “Chiedere la legalizzazione della cannabis non significa certo tirare di coca. Io non l’ho mai fatto, a una canna preferisco un boccale di birra. Hanno trovato tracce di cocaina nel bagno della Camera? Non mi sorprende, ma il dato rilevante è che ancora una volta di più questo episodio sottolinea l’ipocrisia di alcuni esponenti politici. Abbiamo sempre sostenuto che al lavoro uno non può andare sballato; ovviamente il discorso vale per chi guida un bus e per chi siede a Montecitorio o Palazzo Madama”. Carlo Giovanardi prende la cosa con uno spirito diverso. Il senatore sempre in prima fila nella lotta contro le droghe attacca: “Ora sto al Senato, va bene, ma sono stato vicepresidente della Camera, conosco bene quell’Aula e anche quei bagni. Forse non è stato scritto che in quei bagni può entrare un po’ chiunque”.
Cinquanta onorevoli sono stati sottoposti, a loro insaputa, al "drug wipe". Quattro positivi alla cocaina, 12 alla cannabis. Dubbi sulla veridicità dei risultati. Le Iene: "Un deputato su 3 usa droghe". Bocchino querela: "Sequestro subito" Capezzone: "Lo dico da sempre...". Casini: "Pessima trovata pubblicitaria". Mussolini: "Adesso dicano se c'è il parlamentare pusher", scrive "La Repubblica" il 9 ottobre 2006. Droga in parlamento? Il test sui deputati effettuato, con uno stratagemma, dalle Iene, innesca una miccia politica. Con il radicale Daniele Capezzone che commenta caustico: "Io l'ho sempre detto...", Alessandra Mussolini che pretende i nomi dei consumatori. E Italo Bocchino, deputato di Alleanza nazionale, che - attraverso un legale - chiede il sequestro immediato del campione raccolto illegalmente e la distruzione dello stesso in sede processuale. In serata arriva lo strale di Pierferdinando Casini (Udc) che liquida lo scoop come una "pessima trovata pubblicitaria". Piero Fassino invece la butta sull'ironia: "Può darsi - dice il segretario Ds - che così si faccia più in fretta a cambiare la legge Fini sulle tossicodipendenze". Il test, eseguito su 50 deputati a loro insaputa e i cui risultati verranno presentati nella prima puntata della nuova serie del programma (domani sera alle 21 su Italia 1), potrebbe creare non poco imbarazzo nei palazzi della politica: un onorevole su tre fa uso di stupefacenti, prevalentemente cannabis, ma anche cocaina. Questo il dato: il 32% degli intervistati è risultato positivo: di questo il 24% (12 persone) alla cannabis, e l'8% (4 persone) alla cocaina. L'esame è il drug wipe, un tampone frontale che, spiega Davide Parenti, capo autore delle Iene, "ha una percentuale di infallibilità del 100%". In realtà il tossicologo Piergiorgio Zuccaro, direttore dell'Osservatorio Fumo, alcol e droga dell'Istituto superiore di sanità, definisce il drug wipe un test "serio e scientificamente valido, ma non sufficiente da solo a confermare la positività all'uso di droghe. Normalmente se il drug-wipe è negativo il risultato è confermato come tale, ma se è invece positivo è necessaria la conferma ulteriore di laboratorio, dal momento che possono verificarsi dei falsi positivi". I deputati sono stati avvicinati con la scusa di un'intervista. Poi, una finta truccatrice, si accorgeva che la fronte dell'intervistato era "troppo lucida" e tamponava. In realtà l'ignaro si era sottoposto, senza saperlo, al test che svela se si è fatto uso di stupefacenti nelle ultime 36 ore. "Il test - spiega sempre Parenti - è infallibile al 100% se si sono assunte sostanze stupefacenti nelle ultime 36 ore. Il che vuole dire che basta averne fatto uso più di due giorni prima per risultare negativi. L'errore, piuttosto, può essere fatto per difetto: può succedere che il test non rilevi chi ha fatto uso di cannabis coca o altro ma non che risulti positivo se qualcuno è pulito". Nel servizio-inchiesta non si riconosceranno i deputati sottoposti al test: "Noi stessi non sappiamo chi, dei 50 testati, sono i 'positivi'. Per noi la parte interessante non è la violazione, ma il dato percentuale". Ed è proprio sull'anonimato che punta il dito la battagliera Mussolini: "Vogliamo sapere chi tra i rappresentanti del popolo usa droga, come e da chi la compra ma soprattutto se la vende: ci manca solo l'onorevole 'pusher'". E tanto per far capire che non scherza la leader di Azione Sociale ha già attivato una petizione online sul sito del partito da presentare ai presidenti delle Camere. Su posizioni totalmente opposte Luigi Lusi, della Margherita, che chiede alla Iene di ripensarci e non mandare in onda "un'inchiesta 'alterata', perchè, stando alle anticipazioni, si baserebbe non solo su metodi da verificare, ma farebbe acqua da tutte le parti sia dal punto di vista dei diritti, sia della privacy e non ultimo dell'attendibilità medica, dando un messaggio distorto e falsato ai giovani che rappresentano proprio il pubblico principale di questa trasmissione". Anche Lusi, come Mussolini, chiede a Bertinotti e Marini un intervento, ma di segno inverso, ovvero a tutela dei parlamentari. Sullo scoop delle Iene interviene anche il ministro per la Solidarietà sociale Paolo Ferrero che non si stupisce di fronte a "quella che è una voce popolare sul consumo delle sostanze da parte di molti parlamentari". Ferrero chiede quindi "al mondo politico di riflettere in modo più laico sulla materia". Ospiti di Porta a Porta Casini e Fassino se la giocano in modo diverso. Durissimo il leader dell'Udc: "Questa cosa mi sembra una pessima trovata pubblicitaria. L'attendibilità di questo specie di esperimento pseudo-scientifico è equivalente allo zero". Fassino invece spiega ironicamente che, magari, la trasmissione aiuterà il Parlamento a fare una nuova legge sulla droga. Tranchant il giudizio del verde Paolo Cento che se la prende con i moralisti: "Non sorprende affatto l'ipocrisia di una parte del mondo politico che vota leggi liberticide, e poi sniffa cocaina". Più scanzonato Capezzone: "Leggo dello stratagemma usato da 'Le Iene', cui vanno i miei complimenti. Dal canto mio, ho sempre detto che, se un cane poliziotto entrasse in alcuni luoghi della 'politica ufficiale', prima gli andrebbe in tilt il naso e poi si arrenderebbe...". E Carlo Giovanardi, l'ex ministro "padre" della recente legge sulla droga, chiede ironicamente che l'esame sia esteso anche al Senato: "Se le Iene vogliono dire che anche in Parlamento c'è chi consuma cocaina - afferma Giovanardi - scoprono l'acqua calda". Per concludere, con una pesante allusione: "Basta andare a vedere tra i senatori a vita...". Intanto Italo Bocchino ha dato mandato all'avvocato Leone Zettieri di adire alle vie legali nei confronti della trasmissione 'Le Iene': "Pur non avendo nulla da nascondere - spiega - ed essendo tra i deputati risultati negativi alla prova tossicologica, ritengo gravissimo dal punto di vista penale l'invadenza di chi pur di fare audience è oggi illegittimamente in possesso del Dna di 50 parlamentari". Anche Tommaso Pellegrino, dei Verdi, ammette di essere "tra i parlamentari che si sono sottoposti al test delle 'Iene'", ma di "non fare uso di droga e quindi di essere disponibile a sottopormi anche ad altri test". Ciò detto spera che "l'inchiesta promossa dal programma possa rappresentare un'occasione di dibattito, anche parlamentare, contro l'ipocrisia del proibizionismo, che ha prodotto solo danni".
Alle Iene droga tra i parlamentari. Il garante blocca il servizio, scrive il 10 ottobre 2006 "La Repubblica". Il garante per la Privacy ferma le Iene. L'Authority blocca il contestato servizio del programma di Italia 1 sul test antidroga a 50 deputati, che sarebbe dovuto andare in onda questa sera. In base alle indiscrezioni fatte trapelare dagli autori della trasmissione, il test, eseguito all'insaputa dei parlamentari, avrebbe dato esiti clamorosi, con ben 16 casi di positività all'uso di stupefacenti. Lo stop del Garante è legato alla "raccolta illecita di dati di natura sensibile in quanto attinenti allo stato di salute" che sarebbe stata effettuata nel servizio. Il provvedimento cautelativo dispone, con effetto immediato, "il blocco dell'ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale raccolto e trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, immagini e risultanze di test". Nel caso poi le Iene non cambiassero la programmazione il Garante partirà con le sanzioni. Di fronte allo stop, le Iene cedono. Il contestato servizio non va in onda. Al suo posto, un altro reportage, che racconta come si svolge il test e cosa avrebbe detto il filmato bloccato. "Tutti i parlamentari sarebbero apparsi irriconoscibili, perfino alle loro famiglie - spiegano i conduttori, Luca e Paolo - da anni realizziamo servizi in cui tuteliamo la privacy di tutti, anche dei ladri di motorino. Avremmo fatto lo stesso per i nostri politici". Diversa l'opinione del Garante. "Non è possibile - spiega Mauro Paissan, componente dell'Authority - travolgere le persone in nome del diritto di cronaca. Il nostro ruolo è quello di trovare il punto di equilibrio fra libertà di stampa, di satira in questo caso, e il diritto del singolo cittadino ad essere tutelato nei suoi valori fondamentali come la propria dignità, la propria riservatezza e la propria identità". Le Iene, comunque, non si arrendono. E a riprova dell'importanza dell'argomento, mandano in onda anche un altro servizio sui test antidroga: compiuti, questa volta, sui frequentatori di una discoteca, con identiche garanzie - rispetto al filmato censurato - per coprire l'identità delle persone sottoposte ad esame. Risultato: il 50 per cemtp dei 40 sottoposti all'analisi è risultato positivo alla cocaina. "La prossima settimana faremo il possibile per farvi vedere anche i nostri parlamentari", dicono subito dopo, da studio, Paolo e Luca. L'annuncio del servizio delle Iene, fatto alla vigilia della prima puntata della nuova serie del programma, aveva subito scatenato polemiche fortissime. L'esame condotto è il cosiddetto drug wipe, un tampone frontale che secondo Davide Parenti, capo autore delle Iene, "ha una percentuale di infallibilità del 100%". I deputati sono stati avvicinati con la scusa di un'intervista. Poi una finta truccatrice si accorgeva che la fronte dell'intervistato era "troppo lucida" e tamponava. In realtà, l'ignaro si sottoponeva, senza saperlo, al test che svela se si è fatto uso di stupefacenti nelle ultime 36 ore. Drastica la reazione del leghista Roberto Calderoli che chiede di sospendere i senatori "che assumono sostanze stupefacenti o abusano dell'alcol". Per il Codacons, invece, "l'indagine viola i più sacri principi della privacy. Chi assicura infatti che le prove, raccolte in modo illegale e con un furbo espediente, siano state distrutte e che quindi sia impossibile risalire ai singoli soggetti risultati positivi al test?". Ironico il ministro per la Famiglia, Rosy Bindi: "Alle Iene sono imbroglioni, ma se i miei colleghi non facessero uso di droghe, non si vedrebbe". Mentre il segretario dei Radicali italiani Daniele Capezzone chiede di "dissequestrare le Iene. La privacy vale, ma la libertà di informazione vale anche di più. Dico no alla censura". Mentre Ignazio La Russa di an lancia una proposta ai colleghi parlamentari: "Invito i 50 'tamponati a firmare la liberatoria per far sapere se è vero che hanno assunto sostanze stupefacenti, Abbiamo il coraggio delle loro azioni".
Droga in Parlamento: le Iene condannate anche in Cassazione, scrive Fabio Mascagna giovedì 12 giugno 2008 su Blogo (Il Messaggero). Alla fine "Le Iene" sono state definitivamente condannate anche in Cassazione per aver danneggiato "l'immagine pubblica e l'onorabilità" di deputati e senatori dato che "tutti i parlamentari potevano essere indiscriminatamente sospettati di assumere stupefacenti". Il che significa: potete tranquillamente denunciare fatti e comportamenti di chiunque, ma non toccate il palazzo. Il famoso servizio, che vi riproponiamo nel video qui sopra, mirava a rendere noto verso i cittadini il comportamento dei nostri parlamentari in tema di droga: su 50 deputati e 16 senatori sottoposti al "test-tampone" ben 16 erano risultati positivi a cannabis e cocaina. La Camera dei deputati è composta di 630 membri, mentre il Senato di 315. Fatevi due conti insomma. Secondo la Cassazione i campioni biologici "sono stati carpiti con un comportamento ingannevole e fraudolento". Come se un deputato cocainomane potesse mai dare un qualche tipo di assenso o autorizzazione. Gli autori de "Le Iene" - Davide Parenti e Matteo Viviani - erano stati condannati il 16 ottobre del 2007 dal gip del Tribunale di Roma per il reato previsto dall'art. 167 d.lvo 196/2003 (Codice della Privacy - Trattamento illecito di dati) a 5 mesi e 10 giorni di reclusione (convertiti poi in pena pecuniaria) nonostante avessero assicurato il totale anonimato sui campioni organici prelevati. Adesso invece arriva la conferma della condanna da parte della Corte Suprema della Cassazione, III sezione penale con la sentenza 23086. L’informazione evidenziata che taluno, entro una circoscritta e determinabile cerchia di persone, faceva indebito uso di droghe [...] in tale situazione, tutti i parlamentari potevano essere indiscriminatamente insospettati di assumere stupefacenti con la conseguenza che ogni membro del Senato o della Camera, nonché l'istituzione parlamentare, ha subito un nocumento alla sua immagine pubblica e onorabilità. Un interessante stralcio della sentenza: secondo questa sentenza è stato il servizio de "Le Iene" a portare nocumento all'immagine pubblica dell'istituzione parlamentare e non invece il fatto che gran parte di loro faccia uso di sostanze stupefacenti.
GLI SPIN DOCTOR. PERSUASORI DEI GOVERNI.
Ma Cambridge Analytica e Facebook non hanno eletto Trump. Le manipolazioni e l'uso dei dati del social non è detto siano così efficaci politicamente. E non dovrebbero diventare un alibi per le difficoltà elettorali del liberalismo e dei difensori delle società aperte, scrive Luigi Gavazzi il 21 marzo 2018 su "Panorama". È il caso di ribadirlo. Donald Trump e la Brexit non dovrebbero essere spiegati solo con la manipolazione dei dati sottratti a Facebookda Cambridge Analytica (CA). L'azione di quest'ultima, sicuramente preoccupante per la democrazia e le libertà individuali, compreso l'incubo per l'abuso dei dati conferiti a Facebook dagli utenti, difficilmente è stata davvero efficace come sostengono sia i dirigenti di CA, sia Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato all'Observer e al New York Times il lavoro fatto per Steve Bannon - stratega della campagna elettorale 2016 di Donald Trump - e per il Leave in Gran Bretagna. Indagare e scoprire violazioni di legge e pericoli politici di questa attività è doveroso. Sarebbe meglio però non venisse usata da partiti, gruppi sociali e culturali sconfitti da Trump e dalla Brexit come alibi per ignorare le proprie debolezze e l'inefficacia degli argomentiusati a favore della società aperta e del liberalismo. Insomma, evitiamo di rispondere alle minacce e alle sfide del populismo parlando solo di social network.
Se Cambridge Analytica fosse inefficiente e avesse venduto fumo. I signori di CA da anni - come ricorda David Graham su The Atlantic - cercavano di piazzare i propri servizi, dicendo che avrebbero fatto cose miracolose. Nel 2015 Sasha Issenberg di Bloomberg scrisse di CA e delle promesse della loro profilazione “psicografica”, oggi alla ribalta, con una certo scetticismo, per esempio perché il profilo ricavato dal test sullo stesso Issenberg era risultato molto diverso da quello prodotto dal Psychometrics Centre dell’Università di Cambridge (il test originale sul quale si basava l'app di usata da Aleksandr Kogan per raccogliere i dati per Ca). Del resto, Cambridge Analytica, era stata ingaggiata nel 2015 sia da Ted Cruz che da Ben Carson, due candidati repubblicani alla nomination per le elezioni presidenziali. Ebbene, il contributo di CA è risultato nullo, e le campagne hanno avuto esiti disastrosi. Le persone che dirigevano quella di Cruz hanno ben presto deciso di lasciar perdere il contributo di CA, perché irrilevante. Nel comunicare la decisione si lamentarono del fatto che stessero pagando un servizio che non esisteva neppure. C’è poi il fatto che dietro CA ci fosse, come investitore, Robert Mercer e la sua famiglia, fra i principali sostenitori e finanziatori dei repubblicani. Per Cruz era importante avere i soldi di Mercer, a costo di ingaggiare la creatura CA che Mercer finanziava.
Mercer, come noto, passò poi a Trump, convinto anche da Bannon e da Breitbart. La cosa interessante è che, d’altra parte, la stessa campagna di Trump, dopo aver abbracciato CA, l’ha successivamente abbandonata. A sostegno della tesi di Cambridge Analytica come un bluff che ha venduto più che altro fumo, ci sarebbe anche il video registrato dai reporter di Channel 4, presentati sotto la falsa identità di politici dello Sri Lanka interessati a comprare i servizi dell'azienda. Ebbene, se questi servizi fossero così efficaci come i manager di CA sostengono, che bisogno ci sarebbe stato, per venderli ai politici interessati, di proporre anche manovre per intrappolare gli avversari di questi ultimi, screditandoli con possibili scandali sessuali, sospetti di corruzione e cose del genere? Più in generale, gli osservatori citati da Graham sono da tempo assai dubbiosi dell’efficacia di queste tecniche “psicometriche”, fino a qualche anno fa chiamate di “microtargeting”.
La democrazia liberale deve comunicare meglio i pregi della società aperta. Detto questo, i democratici negli Stati Uniti, chi voleva che il Regno Unito restasse nell'Unione Europea, i partiti sconfitti dall'onda populista in Italia, chi teme l'autoritarismo sovranista e illiberale di Ungheria e Polonia, dunque, tutti coloro ai quali sta a cuore la democrazia liberale e la società aperta dovrebbero concentrarsi più sugli argomenti politici, i linguaggi, le proposte, la comunicazione per convincere gli elettori. In questo modo sarebbe più facile e probabile rendere innocuo chi cerca di manipolare le opinioni pubbliche in questi paesi, siano manovratori nell'ombra, gli hacker di Putin o di chi altro (che, vale la pena ricordarlo, sono comunque preoccupanti per la democrazia).
Facebook, ecco come Obama violò la privacy degli americani, scrive il 22 marzo 2018 Giampaolo Rossi su "Gli Occhi della Guerra" su "Il Giornale". Carol Davidsen è stata il capo Dipartimento “Media Targeting” dello staff di Obama nelle elezioni del 2012 ed è considerata un’esperta di campagne elettorali online in America. In una conferenza pubblica, tre anni dopo l’elezione di Obama, rivelò qualcosa che allora passò sotto silenzio ma che oggi è dirompente alla luce dello scandalo Cambridge Analityca: “Noi siamo stati capaci di ingerire l’intero social network degli Stati Uniti su Facebook”. Nello stesso intervento affermò che i democratici acquisirono arbitrariamente i dati dei cittadini americani a cui i Repubblicani non avevano accesso; e questo avvenne con la complicità dell’azienda americana che lo consentì tanto che la Davidsen è costretta ad ammettere che “ci fu uno squilibrio di acquisizione informazioni ingiusto” (nel video dal minuto 19:48). Nei giorni scorsi su Twitter, la Davidsen è tornata sulla questione confermando che a Facebook furono sorpresi quando si accorsero che lo staff di Obama aveva “succhiato l’intero social graph” (vale a dire il sistema di connessioni tra gli utenti) “ma non ce lo impedirono una volta capito cosa stavamo facendo”. In altre parole Facebook consentì ad Obama di rubare i dati dei cittadini americani e di utilizzarli per la sua campagna presidenziale, in quanto azienda schierata dalla parte dei democratici. D’altro canto già nel 2012, sul Time, un lungo articolo di Michael Scherer spiegava come Obama si era impossessato dei dati degli americani su Facebook con lo scopo d’intercettare l’elettorato giovanile. Esattamente nello stesso modo in cui lo ha fatto Cambrdige Analytica per la campagna di Trump: attraverso un app che carpì i dati non solo di chi aveva autorizzato, ma anche della rete di amicizie su Facebook ignare di avere la propria privacy violata. Solo che allora la cosa fu salutata come uno dei nuovi orizzonti delle politica online e descritta da Teddy Goff, il capo digital della campagna di Obama, “il più innovativo strumento tecnologico” della nuove campagne elettorali.
Zuckerberg e democratici. La stretta connessione tra Facebook e il Partito Democratico Usa è continuata anche nelle ultime elezioni come rivelano in maniera implacabile le mail di John Podesta, il potente capo della campagna elettorale di Hillary Clinton, pubblicate da Wikileaks. È il 2 gennaio del 2016, quando Sheryl Sandberg, Direttore esecutivo di Facebook e di fatto numero due dell’Azienda, scrive a Podesta una mail di augurio di Buon Anno, affermando: “Sono elettrizzata dai progressi che sta facendo Hillary”. È il periodo in cui si stanno completando i preparativi per la designazione alla primarie del Partito democratico che partiranno a febbraio; e la risposta del Capo Staff di Hillary non lascia adito a dubbi: “Non vedo l’ora di lavorare con te per eleggere la prima donna presidente degli Stati Uniti”.
Sheryl Sandberg (oggi una delle dirigenti Facebook al centro dello scandalo) è la donna che Zuckerberg volle fortemente nella sua azienda strappandola nel 2008 al diretto concorrente Google. La manager, da sempre democratica, aveva lavorato nell’amministrazione di Bill Clinton come capo staff di Larry Summers il Segretario del Tesoro, voluto proprio dal marito di Hillary. Il rapporto tra Podesta e la Sandberg è di vecchia data. Nell’agosto del 2015 lei scrive a lui per chiedergli se fosse disposto ad incontrare direttamente Mark Zuckerberg. Il grande capo di Facebook è interessato ad incontrare persone che “lo aiutino a capire come fare la differenza sulle questioni di politica a cui lui tiene maggiormente” e “comprendere le operazioni politiche efficaci per far avanzare gli obiettivi” tematici a cui lui tiene, come “immigrazione, istruzione e ricerca scientifica”. E chi avrebbe potuto farlo meglio del guru della campagna elettorale di colei che erano tutti convinti, sarebbe diventata il successivo presidente degli Stati Uniti?
Conclusione. Lo scandalo Cambridge Analytica che doveva essere l’ennesimo attacco contro Trump e la sua elezione si sta trasformando in un boomerang per Democratici e sopratutto per Facebook; l’azienda è oggi al centro del mirino delle polemiche per un modello di business che si fonda proprio sull’accaparramento e la cessione dei nostri dati di privacy che possiede nel momento in cui noi inseriamo la nostra vita, le nostre immagini, le amicizie e la nostra identità all’interno del social media. Ma la questione è sopratutto politica: quello che oggi è scandalo perché fatto per la campagna elettorale di Trump, fu ritenuta una grande innovazione quando lo fece Obama. Con in più un particolare di non poco conto: che nel caso di Obama, Facebook ne era a conoscenza e consentì la depredazione dei dati degli americani. Forse, all’interno del suo “mea culpa”, è di questo che Zuckerberg e i vertici di Facebook dovrebbero rispondere all’opinione pubblica.
Cambridge Analytica gate: il dito e la luna, scrive Guido Scorza il 21 marzo 2018 su "L'Espresso". Se esisteva ancora qualcuno al mondo che non conosceva Facebook ora lo conosce certamente. Lo scandalo che ha travolto il più popolare social network della storia dell’umanità è, da giorni, sulle prime pagine dei media di tutto il mondo. Il “diavolo” è nudo. Se non è già avvenuto, presto qualcuno titolerà così uno dei tanti feroci j’accuse all’indirizzo di Zuckerberg. Ma si commetterebbe uno dei tanti errori dei quali la narrazione mediatica globale – in alcuni Paesi tra i quali il nostro più che in altri – è piena zeppa. Vale la pena, quindi, di mettere nero su bianco qualche punto fermo in questa vicenda e provare anche a trarne qualche insegnamento senza rischiare di perder tempo a fissare il dito, lasciando correre via la luna. La prima necessaria considerazione è che nessuno ha rubato né a Facebook, né a nessun altro i dati personali dei famosi 50 milioni di utenti. Non in questa vicenda. Quei dati – stando a quanto sin qui noto – sono stati acquisiti direttamente da 270 mila utenti che hanno deliberatamente – per quanto, naturalmente, si possa discutere del livello di reale consapevolezza – scelto di renderli disponibile al produttore di una delle centinaia di migliaia di app che ciclicamente ci offrono la possibilità di velocizzare il processo di attivazione e autenticazione a fronte del nostro “ok” a che utilizzino a tal fine i dati da noi caricati su Facebook e a che – già che ci sono – si “aspirino” una quantità più o meno importante di altri dati dalla nostra vita su Facebook. Basta andare su Facebook, cliccare su “impostazioni” – in alto a destra – e, quindi, su “app” per rendersi conto di quanto ampio, variegato e affollato sia il club dei gestori di app ai quali, dalle origini del nostro ingresso sul social network a oggi abbiamo dato un permesso, probabilmente, in tutto e per tutto analogo se non identico a quello che i 270 mila ignari protagonisti della vicenda hanno, a suo tempo, dato al gestore dell’app “This is Your Digital Life”. E basta cliccare sull’icona di una qualsiasi delle app in questione per avere un elenco, più o meno lungo, delle categorie di dati che, a suo tempo, abbiamo accettato di condividere con il suo fornitore. E’ tutto li, a portata di click, anche se per aver voglia di arrivare a sfogliare le pagine in questione, forse, è stato necessario che scoppiasse uno scandalo planetario perché, altrimenti, nel quotidiano la nostra navigazione su Facebook sarebbe proseguita si altri lidi, come accaduto sino a ieri e, probabilmente, come succederà nelle prossime settimane. La seconda considerazione – direttamente correlata alla prima – è che Facebook non è stata vittima di nessun breach, nessuna violazione dell’apparato di sicurezza che protegge i propri sistemi, nessun attacco informatico di nessun genere. Non in questa vicenda, almeno. Sin qui, quindi, tanto per correggere il tiro rispetto a quello che si legge sulle prime di centinaia di giornali, nessun furto, nessuno scasso, nessun furto con scasso.
E allora? Come ci è finito Facebook sul banco degli imputati del maxi processo più imponente e severo della sua storia?
La risposta è di disarmante semplicità anche se difficile da conciliare con quanto letto e sentito sin qui decine di volte. Facebook viene portato alla sbarra proprio perché non ha subito nessun furto scasso e questa vicenda ha semplicemente confermato – non certo per la prima volta – che la sua attività – che è la stessa di milioni di altre imprese di minor successo in tutto il mondo – è pericolosa ed espone ad un naturale e ineliminabile rischio alcuni tra i diritti più fondamentali degli uomini e dei cittadini. Attenzione, però: espone a un rischio tali diritti ma non li viola. Al massimo, come accaduto nel Cambridge Analytica gate, facilita l’azione di chi tali diritti voglia consapevolmente violare. Ed è esattamente questo che accaduto nella vicenda in questione: una banda di sicari delle libertà – perché ogni definizione diversa non renderebbe giustizia al profilo dei veri protagonisti negativi della vicenda – assoldati da mandanti nemici dell’A,B,C della democrazia ha furbescamente approfittato della debolezza del sistema Facebook a proprio profitto e in danno della privacy e, forse, della libertà di coscienza di milioni di persone.
E’ la debolezza del suo ecosistema la principale colpa di Facebook. L’aver reso possibile una tragedia democratica che – ammesso che le ipotesi possano trovare una conferma scientifica – ha condizionato l’esito delle elezioni negli Stati Uniti d’America e il referendum che ha portata l’Inghilterra fuori dall’Unione Europea. E guai a dimenticare che sono queste ipotetiche conseguenze ad aver reso una vicenda che in realtà non fa altro che confermare che un uovo sodo ammaccato a una delle due estremità può stare in piedi da solo. Il famoso uovo di Colombo. Perché se la stessa tecnica – egualmente fraudolenta ed egualmente figlia dell’intrinseca debolezza dell’ecosistema Facebook – fosse stata utilizzata, come sarà stata utilizzata milioni di volte, per vendere qualche milione di aspirapolveri, oggi, evidentemente, non saremmo qui a parlarne e non sarebbe accaduto che le Autorità di mezzo mondo si siano messe in fila davanti alla porta di Menlo Park, bussando per chiedere audizioni e ispezioni, rappresentando possibili sanzioni e conseguenze salate. Guai a dire tanto rumore per nulla. E guai anche a suggerire l’assoluzione di Facebook che, tra le sue colpe, ha – ed è forse la più grave – quella di esser stato a conoscenza da anni dei rischi che 50 milioni di propri utenti stavano correndo ma di aver scelto di non informarli. Ma, ad un tempo, se si vuole evitare di lasciarsi trascinare e travolgere dall’onda lunga della sassaiola mediatica val la pena di trovare il coraggio di fissare in mente questa manciata di considerazioni di buon senso prima che di diritto. Anche perché, a condizione di trovare la necessaria serenità di giudizio e una buona dose di obiettività, da questa vicenda c’è, comunque, molto da imparare. Bisogna, però, esser pronti a non far sconti a nessuno, a mettersi in discussione in prima persona e resistere alla tentazione di dare addosso a Facebook con l’approssimazione emotiva che connota la più parte degli attacchi che si leggono in queste ore. In questa prospettiva sul banco degli imputati, accanto a Facebook, dovrebbe salirci un sistema di regole che, evidentemente, ha fallito, ha mancato l’obiettivo e si è rivelato inefficace: è quello a tutela dei consumatori, degli interessati, degli utenti basato sugli obblighi di informazione e sulle dozzine di flag, checkbox e tasti negoziali. Le lenzuolate di informazioni che Facebook – e naturalmente non solo Facebook – da, per legge, ai suoi miliardi di utenti non servono a nulla o, almeno, non sono abbastanza perché questa vicenda dimostra plasticamente che gli utenti cliccano “ok” e tappano flag senza acquisire alcuna consapevolezza sulla portata e sulle conseguenze delle loro scelte. Anzi, a volercela dire tutta, questo arcaico e primitivo sistema regolamentare produce un risultato diametralmente opposto a quello che vorrebbe produrre: anziché tutelare la parte debole del rapporto finisce con il garantire alla parte forte una prova forte e inoppugnabile di aver agito dopo aver informato a norma di legge la parte debole ed aver raccolto il suo consenso.
Così non funziona. E’ urgente cambiare rotta. Basta obblighi di informativa chilometrici e doppi, tripli e quadrupli flag su improbabili check box apposti quasi alla cieca, su schermi sempre più piccoli e mossi, esclusivamente, dalla ferma di volontà di iniziare a usare il prima possibile il servizio di turno. Servono soluzioni più di sostanza. Servono meno parole e più disegni. Servono meno codici e più codice ovvero informazioni capaci di esser lette direttamente dai nostri smartphone e magari tradotte visivamente in indici di rischiosità, attenzione e cautela.
La vicenda in questione è una storia di hackeraggio negoziale. Se si vuole per davvero evitare il rischio che si ripeta è in questa prospettiva che occorre leggerla. E sul banco degli imputati assieme a Facebook dovrebbe, egualmente, salire chi, sin qui, ha sistematicamente e scientificamente ridimensionato il diritto alla privacy fino a bollarlo come un inutile adempimento formale, un ostacolo al business o un freno al progresso. Perché non ci si può ricordare che la privacy è pietra angolare delle nostre democrazie solo quando, violandola, qualcuno – a prescindere dal fatto che riesca o fallisca nell’impresa – si mette in testa di condizionare delle consultazioni elettorali o referendarie. In caso contrario le conseguenze sono quelle che oggi sono sotto gli occhi di tutti: utenti che considerano la loro privacy tanto poco da fare il permesso a chicchessia di fare carne da macello dei propri dati personali, disponendone con una leggerezza con la quale non disporrebbero delle chiavi del loro motorino, della loro auto o del loro portafogli e Autorità di protezione dei dati personali con le armi spuntate e costrette a registrare episodi di questo genere leggendo i giornali quando non i buoi ma i dati personali di decine di milioni di utenti sono ormai lontani dai recinti.
Anche qui bisogna cambiare strada e cambiarla in fretta. E’ urgente tracciare una linea di confine netta, profonda invalicabile tra una porzione del diritto alla protezione dei dati personali che è giusto e indispensabile che resti appannaggio del mercato e una porzione che, invece, meriterebbe di entrare a far parte dei diritti indisponibili dell’uomo come lo sono le parti del corpo umano, sottratta, per legge, al commercio, agli scambi e al mercato a prescindere dalla volontà dei singoli utenti. Ed è urgente investire sulle nostre Autorità di protezione dei dati personali perché non si può, al tempo stesso, scandalizzarsi di episodi come quello della Cambridge Analytica e pretendere che un’Autorità di poche decine di professionisti e finanziata con una percentuale infinitesimale del bilancio dei nostri Stati garantisca protezione, regolamentazione e vigilanza su quello che è ormai diventato il più grande, proficuo e per questo attaccabile mercato globale. Facciamo tesoro di quello che è accaduto. Leggiamo i fatti con obiettività e, soprattutto, facciamo quanto possibile per cambiare rotta perché il problema non è Facebook e, in assenza di correttivi importanti, se anche domani la borsa condannasse Facebook all’estinzione, non avremmo affatto risolto il problema.
Dal Lago: «La disinformazione è diventata un’arma per vincere in politica», scrive Giulia Merlo il 22 Marzo 2018 su "Il Dubbio". «I social ci condizionano come facevano i manifesti della Dc nel 1948 e per questo sono diventati uno strumento decisivo sul piano della propaganda politica». «I social ci condizionano come facevano i manifesti della Dc nel 1948 e per questo sono diventati uno strumento decisivo sul piano della propaganda politica». Per Alessandro Dal Lago, sociologo e studioso dei fenomeni del web, lo scandalo che ha investito Facebook ha fatto venire alla luce lo sfruttamento illegale di informazioni che, però, già da tempo sono diventate uno strumento politico.
L’inchiesta contro Cambridge Analytica ha aperto il vaso di Pandora del lato oscuro dei social?
«Ha rivelato che i nostri dati, sia pubblici che privati come le reti di amicizia su Facebook, possono essere usate per campagne di profilazione e per la creazione di modelli di utenza. In seguito, questa mole di informazioni può essere usata per campagne di marketing e di propaganda politica. Così, il cittadino della lower class americana esasperato dalla mancanza di lavoro e che odia i vicini di casa neri diventa personaggio medio, utilizzabile come modello per studiare una propaganda mirata. Considerando che i dati analizzati hanno permesso alla Cambridge Analytica di profilare 50 milioni di utenti, si capisce la portata del fenomeno».
E questo quali problemi solleva?
«Da una parte c’è il tema della tutela della privacy e le ipotesi sono due: o Facebook sapeva dell’indebita profilazione e dunque è connivente, oppure non sapeva e questo significa che il sistema è penetrabile. Tutto sommato, questa seconda prospettiva mi sembra la più grave».
I dati sono stati usati per fare campagne politiche.
«Il rilievo politico della vicenda porta in primo piano l’esistenza di società di big data, che puntano a controllare l’opinione pubblica e che fanno parte di un mondo pressochè sconosciuto alla collettività. Basti pensare che, prima di qualche giorno fa, nessuno conosceva Cambridge Analytica, e come questa esistono altre centinaia di società analoghe. Senza complottismi, è evidente come esistano ambienti che, attraverso la consulenza strategica, sono interessati a orientale la politica globale. Altro dato, la presenza nell’inchiesta di Steve Bannon – noto suprematista bianco e stratega di Trump – mostra come la capacità di influenzare l’opinione pubblica attraverso la manipolazione dei dati sul web è più forte nella destra globale che non nella sinistra».
Davvero un post pubblicitario su Facebook è in grado di condizionare l’elettorato fino a questo punto?
«E’ più che normale che sia in grado di farlo. La comunicazione si è evoluta: partiamo dal manifesto elettorale, e penso alla geniale trovata di propaganda anticomunista della Dc del 1948, con il manifesto dei cosacchi che si abbeverano a una fontana davanti a una chiesa. Poi sono arrivati i media generalisti come la televisione e la stampa, in cui la propaganda si faceva attraverso i modelli culturali. Penso alla Rai, in cui si propagandava un modello familiare che indirettamente finiva per legittimare la Dc. Oggi la propaganda è molto cambiata: il web e i social creano un pubblico universale, che accede alla stessa sfera comunicativa. Questo permette ai manipolatori intelligenti di arrivare istantaneamente a un pubblico enorme, influenzandoli a un livello impensabile solo fino a qualche anno fa».
In Italia esistono fenomeni simili di sfruttamento del web?
«La Casaleggio Associati è un esempio di questo. La società gestisce un’enorme rete di pagine Facebook e siti collegati al blog delle Stelle e indirettamente a quello di Beppe Grillo».
E come funziona, praticamente, il meccanismo?
«Le faccio un esempio. Esiste una pagina appartenente a questa galassia che si chiama “Alessandro Di Battista presidente del consiglio”, che contiene messaggi di propaganda in stile mussoliniano del tenore di: «Ringraziamo il guerriero Di Battista, eroe nazionale». Ora, si puo dire che queste parole suonino ridicole, ma bisogna leggerle in chiave social e in base al target degli elettori che si vogliono calamitare: giovani elettori del sud Italia, con una scolarità medio bassa. A questi soggetti si propone una propaganda che da una parte martella sull’odio per la casta e dall’altra propone un eroe nazionale. Considerando che pagine come queste hanno centinaia di migliaia di follower, è facile immaginare gli effetti».
Nulla di tutto questo, però, è illegale.
«Certo che no, però esiste un problema di profonda manipolazione della realtà contro la quale non esistono strumenti di difesa adeguati. Le fake news, infatti, non sono solo le notizie inventate ma per la maggior parte si tratta di manipolazioni di notizie verosimili, che vengono caricate di retorica per diventare virali e, nello stesso tempo, nessuno verifica che si tratta di falsi».
Si può parlare di un modello politico?
«E’ certamente un modello. Politicamente, io credo sia inquietante che i parlamentari del Movimento 5 Stelle abbiano sottoscritto un contratto ridicolo nel quale tuttavia si impegnano a versare 300 euro al mese alla Casaleggio Associati, che non è un partito ma un’azienda privata di comunicazione».
Si può dire che, oggi, vince le elezioni chi sa usare meglio questi strumenti del web?
«Diciamo che i social non sono lo strumento esclusivo, ma sono diventati quello decisivo. Difficile dire quanti milioni di voti abbia spostato la campagna di Cambridge Analytica però, se si pensa alle elezioni americane, anche un milione di voti in più o in meno può garantire l’elezione alla Casa Bianca. Insomma, la propaganda sul web è in grado di spostare le decisioni».
Il web, quindi, condiziona la realtà?
«Il web ne condiziona la percezione, e questo è decisivo. La realtà e i conflitti continuano ad esistere, ma il modo in cui vengono percepiti e il luogo in cui si propongono le soluzioni è deciso dalla propaganda sul web. In questo modo la sfera di comunicazione virtuale decide l’orientamento dei settori critici dell’elettorato. Tornando ai 5 Stelle: il loro sistema di comunicazione prevede di generare un cortocircuito tra l’abile uso delle news sul web e la sistematica disinformazione».
Che ipocrisia indignarsi se le nostre vite sono in vendita, scrive Francesco Maria Del Vigo, Giovedì 22/03/2018, su "Il Giornale". Ma siamo sicuri che quello di Cambridge Analytica sia uno scandalo con la esse maiuscola? È davvero una notizia sconvolgente o è una notizia di dieci anni fa? Ricapitoliamo: molti di noi, dal 2007, quotidianamente passano ore a caricare foto, scrivere post, fare giochi, installare app e seminare like su Facebook. Cosa stiamo facendo in quel determinato momento? Stiamo perdendo tempo, dice qualcuno. Ci stiamo divertendo e stiamo socializzando, dice qualcun altro. Stiamo cedendo una mole incredibile di dati sulla nostra vita, dice Mark Zuckerberg. E lo dice chiaramente. Perché vendere, ovviamente in modo anonimo, le nostre informazioni - che poi sono i nostri gusti, i nostri hobby, i luoghi che amiamo o la marca del nostro dentifricio preferito - è la ragione sociale di Facebook. È il suo business, il suo mestiere. Cadere dalle nuvole è surreale, è come stupirsi che un calzolaio lustri le scarpe. Vi siete mai chiesti come ha fatto una matricola di Harvard a racimolare un patrimonio da 70 miliardi di euro? Coi vostri status, le foto dei vostri gatti e i vostri «mi piace». E noi tutti, iscrivendoci al social network, abbiamo accettato, più o meno consapevolmente, questo mercimonio. Ti diamo un po' di noi in cambio di quindici like di notorietà, abbiamo barattato la nostra privacy con una vetrina dalla quale poterci esporre al mondo virtuale. Dunque qual è il problema? Il problema è che in questo caso un'azienda terza ha utilizzato le «nostre» informazioni all'insaputa di Facebook. Grave, certo. Ma nulla di particolarmente sconvolgente. Un traffico che, abbiamo ragione di immaginare, accade molto spesso per scopi commerciali. Il problema è che l'opinione pubblica è disposta ad accettare di vedere comparire sulla propria bacheca la pubblicità della propria maionese preferita, ma se entra in ballo la politica la questione cambia. Se poi, come in questo caso, entrano in ballo la Brexit e gli impresentabili Trump e Bannon allora la faccenda precipita. Possibile che le anime belle della Silicon valley, quelli che per mesi ci hanno detto che Trump era un pazzo scatenato, lo abbiano lasciato giocherellare coi nostri dati? Sì, perché pecunia non olet. Nemmeno per i nerd di San Francisco. E, per loro, la nostra opinione politica è un dato come un altro, masticato e sputato dagli algoritmi per poi essere rivenduto. È l'era dei big data e della data economy. Che prima piacevano tanto agli intelligentoni à la page, ma che ora, sembra andargli di traverso. Ma è anche l'era della data politics. E, al netto delle ripercussioni giudiziarie che ci saranno su questo caso, le campagne elettorali si sposteranno sempre di più sulla profilazione degli utenti del web e sulla psicometria. Così sui nostri social, accanto alla pubblicità delle nostre cravatte preferite, compariranno anche informazioni e annunci politici. È manipolazione? No, è solo un'altra forma di marketing. Elettore avvisato...
Come si manipola l’informazione: il libro che ti farà capire tutto, scrive Marcello Foa il 17 marzo 2018 su "Il Giornale". Ci siamo: il mio saggio “Gli stregoni della notizia. Atto secondo”, pubblicato da Guerini e Associati, è in libreria da quattro giorni e i riscontri sono davvero incoraggianti, sia sui media (ne hanno parlato con ampio risalto il Corriere del Ticino, La Verità, il Giornale, Libero, Dagospia), sia da parte dei lettori. Alcuni mi hanno scritto: ma cosa c’è di nuovo rispetto alla prima edizione del 2006? C’è molto: le tecniche usate dai governi per orientare e manipolare i media, che descrissi 12 anni fa, sono valide ancora oggi e vengono applicate ancor più intensamente, per questo le ripropongo anche in questo secondo atto ma attualizzate, ampliate e, nella seconda parte del libro, arricchite da capitoli completamente nuovi, che permetteranno al lettore di entrare in una nuova dimensione: quella, sofisticatissima ma indispensabile per capire le dinamiche odierne, dell’informazione quale strumento essenziale delle cosiddette guerre asimmetriche, che vengono combattute senza il ricorso agli eserciti ma i cui effetti sono altrettanto poderosi e che raramente vengono spiegate dai media. Attenzione: non riguardano solo il Vicino Oriente o l’Ucraina, ma anche le nostre democrazie, molto più esposte di quanto si immagini. Non mi dilungo, ovviamente. Sappiate che in questo saggio approfondisco l’uso (e l’abuso) del concetto di frame dimostrando come sia stato impiegato per “vendere” al popolo l’euro e impedire per anni un dibattito oggettivo sugli effetti della moneta unica o per costruire il mito del salvataggio della Grecia e quello dell’autorazzismo nei confronti della Germania. Ne “Gli stregoni della notizia. Atto secondo” riprendo alcuni documenti governativi, noti solo agli specialisti, sull’impressionante influenza del Pentagono su film e produzioni di Hollywood, spiego il ruolo opaco degli spin doctor e delle società di PR negli allarmi sanitari (dalla Mucca Pazza all’influenza suina, da Ebola a Zika) e quale ruolo hanno avuto le Ong e le loro sorelle maggiori (le quango ovvero le Ong quasi autonome, sconosciute ai più) nelle rivoluzioni colorate e nelle operazioni di destabilizzazione di Paesi, che un tempo erano opera esclusiva dei servizi segreti. Accendo un faro sugli aspetti poco noti dell’ascesa di Macron, sull’altro volto di Obama, dedico molte pagine all’Italia, in particolare spiegando le tecniche di spin che sono state decisive nell’ascesa e nella caduta di Matteo Renzi e denuncio le ipocrisie sulle fake news, dimostrando come servano a rendere l’informazione non più trasparente ma più docile e, possibilmente, sottoposte a censura. E’ un libro che ho scritto a cuore aperto, documentatissimo, rivolto a lettori che hanno voglia di capire e di scavare oltre le apparenze, come Giorgio Gandola, che lo ha recensito su La verità, ha capito perfettamente. Spero, di cuore, che vi piaccia. Ne parlo anche nella bella intervista che mi ha fatto Claudio Messora per Byoblu e che trovate qui sotto. Vi lascio ricordandovi la presentazione che si svolgerà lunedì 19 a Milano, alla libreria Hoepli, ore 17.30 con Nicola Porro e lo stesso Gandola. Altre seguiranno in diverse città italiane. Grazie a tutti voi e, naturalmente, buona lettura!
Ecco come lavorano i persuasori (non) occulti al servizio dei governi. Gli spin doctor sfruttano le convinzioni diffuse fra il pubblico. E agitano lo spettro complottista, scrive Marcello Foa, Giovedì 15/03/2018, su "Il Giornale". Le insidie che avevo individuato nel 2006, preconizzandone le derive si sono, purtroppo, puntualmente verificate. Allora scrivevo che il fatto che i giornalisti non conoscessero le tecniche per orientare e all'occorrenza manipolare i media, avrebbe non solo reso molto più fragili le nostre democrazie, generando un sentimento di crescente sfiducia verso la classe politica, ma anche danneggiato la credibilità dell'informazione. È il mondo in cui viviamo oggi. Quelle tecniche, come allora, restano ampiamente sconosciute ai media e, naturalmente, al grande pubblico. Eppure comprenderle è indispensabile se si vuole cercare di decodificare l'attualità senza limitarsi all'apparenza, come dovrebbe fare ogni giornalista e come dovrebbe esigere ogni lettore. Certo, il mondo mediatico nel frattempo è cambiato. Un tempo la cosiddetta grande stampa aveva il monopolio dell'informazione, oggi non più e subisce la concorrenza, a mio giudizio salutare, dei siti e dei blog di informazione alternativi. Oggi il mass media è sostituito dal personal media che ognuno si costruisce attraverso la propria rete sui social. Oggi si guarda meno la tv e si passa molto più tempo a «chattare» su Whatsapp, a pubblicare foto e a tessere relazioni su Instagram. Oggi, naturalmente, la diffusione di notizie false è ancora più facile benché, come vedremo, non sia affatto una prerogativa della nostra epoca. Ma gli spin doctor sono ancora tra noi, più influenti, più informati, più pervasivi che mai. E non hanno modificato il loro obiettivo, che resta quello di condizionare noi giornalisti e, in fondo, te, caro lettore; con la decisiva complicità del mondo politico. Lo spin doctor non ha bisogno di contare sul controllo dei media, perché sa che per orientare i giornalisti è sufficiente conoscere le loro logiche. E da buon persuasore è convinto che la propaganda sia davvero efficace solo quando non è facilmente riconoscibile. Infatti opera avvalendosi di:
- una comprensione perfetta dei meccanismi che regolano il ciclo delle informazioni;
- il ricorso a sofisticate tecniche psicologiche, che gli consentono di condizionare le masse.
Tra queste ultime il concetto più importante in assoluto è quello del frame, che è stato elaborato dal linguista americano George Lakoff, il quale sostiene che ognuno di noi ragiona per cornici di riferimento costituite da una serie di immagini o di giudizi o di conoscenze di altro tipo (culturali, identitarie). Ogni giorno noi elaboriamo continuamente, senza esserne consapevoli, dei frame valoriali, che possono essere effimeri o profondi se associati, su temi importanti, a una forte emozione e ai nostri valori più radicati. La nostra visione della realtà e il nostro modo di pensare ne risultano condizionati, perché una volta impressa una larga, solida cornice, il nostro cervello tenderà a giudicare la realtà attraverso questi parametri. Tutte le notizie coerenti con il frame saranno recepite ed enfatizzate facilmente dalla nostra mente, rinforzando la nostra convinzione. Al contrario, tutte quelle distoniche tenderanno a essere relativizzate o scartate come assurde e, nei casi più estremi, irrazionali, folli o stupide. Alla nostra mente non piacciono le contraddizioni e questo spiega perché per un militante di destra gli scandali che colpiscono politici di sinistra sono percepiti come gravissimi e veritieri, mentre quelli che colpiscono la propria parte derubricati come delegittimati, irrisori o faziosi. E naturalmente viceversa. Un abile spin doctor riesce, calibrando le parole, a indirizzare l'opinione pubblica nella direzione voluta. La tecnica del frame viene usata non solo per forgiare un giudizio su notizie contingenti, ma anche per stabilire nell'opinione pubblica dei valori di fondo e dunque il confine tra politicamente corretto e politicamente scorretto; tra ciò che è conveniente o non conveniente dire su un argomento; tra ciò che l'opinione pubblica «moderata» deve considerare ragionevole o deve respingere come scandaloso, ponendo di fatto le premesse per screditare le opinioni che travalicano quel confine invisibile e che possono pertanto, all'occorrenza, essere etichettate come estremiste, complottiste o fasciste.
A proposito di cospirazionismo, sapevate che il termine fu inventato dalla Cia ai tempi dell'omicidio Kennedy per screditare le tesi di coloro che contestavano la versione ufficiale stabilita dalla Commissione Warren? Lo spiega il professor Lance Dehaven-Smith, osservando come gli effetti di quell'operazione, circostanziati nel dispaccio 1035-960, sorpresero persino i vertici di Langley. Da allora è diventato un metodo: quando vuoi screditare qualcuno lo accusi di essere complottista. Facendo così ottieni due scopi: screditi le sue tesi agli occhi della massa e lo costringi ad assumere un atteggiamento difensivo, ovvero a dimostrare di non essere cospirazionista e dunque, sovente, a moderare i toni delle sue denunce, pena l'autoghettizzazione. Che poi le sue accuse siano plausibili o fondate diventa inevitabilmente secondario; anzi, colpendo l'autorevolezza di chi critica, delegittimi in toto le sue idee. E se costui persiste lo fai apparire sacrilego. Impedisci che anche sulle critiche fondate si apra una vera riflessione pubblica. Una volta stabilito, il frame resiste nel tempo e può essere scacciato solo da un altro equivalente che abbia pari o superiore legittimità. Un esempio? La fine politica di Antonio Di Pietro. Come ricorderete a screditarlo fu un'inchiesta di «Report» sul suo (presunto) impero immobiliare, accumulato approfittando anche dei fondi del partito. Quelle accuse non erano nuove, poiché erano già state formulate da alcuni giornali come il Giornale e Libero, ma non avevano scalfito l'immagine dell'ex pm rispetto al suo elettorato, perché ritenute faziose e dunque almeno parzialmente false. Quando però sono state avanzate da Milena Gabanelli, dunque da una fonte autorevole e super partes, il leader dell'Italia dei Valori è stato travolto. Ovvero il frame Gabanelli ha scacciato il frame Di Pietro sul terreno su cui entrambi si erano costruiti la reputazione, quello dell'onestà.
Politici e giornalisti: storia di schiaffoni insulti e picconi… Dai “pennivendoli” di La Malfa alle “puttante” per le “iene dattilografe” di D’Alema, scrive Francesco Damato il 15 Novembre 2018 su "Il Dubbio". Non per difendere i grillini, per carità, ma solo per sbertucciare la loro presunta rivoluzione anche nei rapporti con i giornalisti e, più in generale, col mondo dell’informazione, vorrei ricordare che a darci dei “pennivendoli”, senza aspettare il loro arrivo, che certamente non poteva neppure immaginare, fu Ugo La Malfa dal palco di un congresso del suo partito: il Pri. Che fu per molti anni, a dispetto della sua consistenza elettorale, l’ago della bilancia di governi e maggioranze. «Pennivendoli e anche miserabbili», con la doppia b, ci gridò addosso il segretario del Pri reagendo agli attacchi, ma anche alle ironie, che si era guadagnato destituendo in tronco il collegio dei probiviri della formazione dell’edera presieduto da Pasquale Curatola. Esso aveva predisposto un documento critico sugli esponenti siciliani di cui più si fidava il sicilianissimo La Malfa, a cominciare da Aristide Gunnella. Poco mancò che lo stesso La Malfa nel 1975, vice presidente del Consiglio in un bicolore Dc-Pri guidato da Aldo Moro, non mi schiaffeggiasse nel cosiddetto Transatlantico di Montecitorio per avere rivelato sul Giornale diretto dal comune amico Indro Montanelli un suo incontro riservato con i corrispondenti dei giornali esteri a Roma. In quella occasione egli aveva espresso la convinzione che fosse «ineluttabile» il cosiddetto compromesso storico fra democristiani e comunisti, poi realizzatosi nella versione ridotta di un monocolore scudocrociato sostenuto esternamente dal Pci di Enrico Berlinguer. Nella foga della protesta La Malfa arrivò a minacciare un intervento su Montanelli perché fossi licenziato, e «in tronco». A Montanelli invece egli telefonò il giorno dopo per scusarsi dello scontro avuto con me. Altri anni, altri uomini. Di schiaffi invece ne sono volati davvero nella buvette e nei corridoi di Montecitorio fra deputati e giornalisti. Memorabili, a loro modo, furono quelli scambiati fra il braccio destro di Giulio Andreotti, Franco Evangelisti, e Guido Quaranta, ora fra i più anziani dell’associazione della stampa parlamentare. Lui stesso li ha evocati in una delle quindici interviste di testimonianza degli ultimi settant’anni e più di politica raccolte da Giorgio Giovannetti per i Passi perduti- Storie dal Transatlantico, freschi di stampa per i Quaderni delle Istituzioni della Repubblica, editi da G. Giappichelli. È un libro decisamente e meritoriamente controcorrente rispetto alla rottamazione del Parlamento prevista, o auspicata, dai grillini a vantaggio della democrazia “digitale”. Grazie alla quale Montecitorio e Palazzo Madama potrebbero diventare musei o alberghi, secondo i gusti o le convenienze, potendo i cittadini provvedere da casa, usando il computer, a fare leggi e a far nascere e morire i governi. Di quegli schiaffi a Quaranta, chiamato per la sua impertinenza “la supposta” da Alfredo Covelli, penso che Evangelisti fosse stato poi costretto a scusarsi con Andreotti. Al quale il mio amico Guido stava simpatico per quell’abitudine che aveva di tallonare i politici con un blocchetto di carta in mano. «Che fai? Mi vuoi multare?», gli chiedeva sornione proprio Andreotti nei suoi panni di turno di ministro, o capogruppo democristiano della Camera, o presidente del Consiglio. Non ebbe il tempo invece di reagire ad uno schiaffo di Luigi Barzini, fresco di elezione a deputato liberale, il vecchio giornalista della Stampa Vittorio Statera, rimasto basito per l’affronto e costretto a raccogliere davanti alla porta dei gabinetti gli occhiali saltatigli dal naso. Erano stati decisamente migliori i metodi usati contro lo stesso Statera da Alcide De Gasperi. Che, infastidito pure lui per l’insistenza con la quale il giornalista del quotidiano torinese cercava di sondarne progetti e opinioni, gli chiese una volta, davanti alla porta del suo ufficio di presidente del Consiglio, allora al Viminale: «Ma perché mi interroga sempre come un commissario di Polizia?». E l’indimenticabile Aniello Coppola, dell’Unità, profittò subito della circostanza per chiedere a De Gasperi, che aveva appena scaricato i comunisti dal governo: «E’ una critica alla Polizia?». Sempre per La Stampa, toccò nel 1971 a Vittorio Gorresio scontrarsi, o subire l’assalto del presidente del Senato Amintore Fanfani. Che, non avendo gradito le cronache e i commenti del giornale torinese alla sua corsa al Quirinale, sviluppatasi in una serie di votazioni infruttuose per l’ostinazione di una parte dei deputati del suo partito, la Dc, a contrastarne la candidatura, apostrofò il pur anziano e autorevole giornalista nella buvette dandogli praticamente del servo di Gianni Agnelli. Che lesse dell’incidente sulla Stampa il giorno dopo, avendo Gorresio riferito puntualmente dell’accaduto. Ciò forse contribuì a suo modo al naufragio della già compromessa avventura dell’aretino. Nella votazione successiva a quell’episodio uno dei “franchi tiratori” della Dc si divertì a scrivere sulla scheda, dichiarata nulla sul banco della presidenza di Montecitorio da Sandro Pertini che l’aveva appena letta in silenzio: «Nano maledetto, non sarai mai eletto». Celebre è rimasto nella storia settantennale del Parlamento repubblicano anche lo schiaffo del solitamente impeccabile Alfredo Pazzaglia al giovane cronista politico del Giornale Antonio Tajani – sì, proprio lui, l’attuale presidente del Parlamento Europeoche ne aveva scritto come di un pericolante capogruppo missino della Camera. E, ciò nonostante, impegnato dietro le quinte a fare le scarpe al segretario del partito Giorgio Almirante. Dal quale Pazzaglia aveva peraltro appena ricevuto una telefonata di amichevole solidarietà, apprendendo così dell’articolo che non aveva ancora visto. «Mi è sfuggita la mano sinistra», si scusò poi Pazzaglia col vice presidente della Camera Alfredo Biondi, liberale, accorso in transatlantico per difendere Tajani e precedere le prevedibili proteste dell’associazione della stampa parlamentare. Cui seguì la deplorazione della severa presidente dell’assemblea Nilde Iotti. Che veniva da noi chiamata, con spirito più deferente che critico, “la zarina di Montecitorio”, e della quale è in alcuni tratti davvero toccante il racconto, anzi il ritratto umano, oltre che politico, fattone nei “Passi perduti” di Giorgio Giovannetti dal più stretto e fidato dei suoi collaboratori: Giorgio Frasca Polara. Anche al solitamente pacioso Paolo Cirino Pomicino, al netto della simpatica vivacità napoletana, toccò una volta di derogare dalla linea prudente del suo amico e capocorrente Andreotti in tema di rapporti con i giornali. Gli capitò da ministro del Bilancio di precedere di parecchi anni la rivolta dei grillini contro gli editori “impuri”, che usano i giornali di loro proprietà per difendere attività di tutt’altro segno. In particolare, Pomicino disse che i giornali italiani erano in mano a «poche famiglie» e che «prima o poi bisognerà occuparsene»: cosa, appunto, che si è appena proposto di fare il vice presidente grillino del Consiglio Luigi Di Maio per vendicare l’appena assolta sindaca di Roma Virginia Raggi dall’accusa di falso. Come se fossero stati i giornalisti a rinviarla a giudizio soccombendo col risultato di primo grado. Così Di Maio, iscritto peraltro all’Ordine dei Giornalisti della Campania nell’elenco dei pubblicisti, ha tenuto il passo con l’amico e concorrente Alessandro Di Battista, stanco di viaggiare alla Che Guevara e smanioso di buttarsi nella mischia in Italia sotto le cinque stelle. È suo, dal lontano Nicaragua, il paragone fra giornalisti e «puttane», con tanto di scuse a quest’ultime. Non parliamo, tornando indietro con gli anni, delle picconate della buonanima di Francesco Cossiga, quando era presidente della Repubblica, contro l’omonima Repubblica di carta e il suo editore Carlo De Benedetti, da lui trattato peggio che da Bettino Craxi. I cui rapporti con i giornalisti e gli intellettuali dei «miei stivali», come scappò una volta di dire al leader socialista, raggiunsero picchi memorabili, fra le proteste di Sandro Pertini al Quirinale. Che con i giornali e i giornalisti aveva rapporti eccellenti, anche se ogni tanto, in verità, strapazzava gli uni e gli altri con telefonate di protesta per qualche torto che riteneva di avere ricevuto. Che dire poi delle «iene dattilografe» gridate da Massimo D’Alema contro i colleghi giornalisti che non ne apprezzavano doti e sarcasmo? O del sospetto una volta espresso dal mitico direttore del Tg 3 Alessandro Curzi che il compagno di partito Claudio Petruccioli volesse fargli la festa alla Rai? Ebbene, pur in presenza di reazioni a dir poco vivaci, nessuno fu davvero colto in quei tempi e frangenti da preoccupazioni vere per le sorti della libertà di stampa, presidio di una vera democrazia, come ha appena ricordato o ammonito Sergio Mattarella, evidentemente colpito pure lui dalla veemenza e dalla frequenza degli attacchi dei grillini a giornali e giornalisti non allineati, o non sufficientemente allineati, tanto da potersi risparmiare il rimprovero appena rivolto in una intervista al Foglio dall’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli a quanti cedono il microfono al grillino di turno senza mai interromperlo con una domanda scomoda. O si mettono disciplinatamente in coda nella fila della lottizzazione di turno. De Bortoli perse peraltro la direzione del Corriere dando del «maleducato di talento» all’allora presidente del Consiglio e segretario del Pd Matteo Renzi.
Evidentemente ora il clima politico, e sociale, è davvero cambiato. E si ha paura di quello che era impensabile pur dietro o davanti agli schiaffi e quant’altro, dopo l’avventura irripetibile di un giornalista – Benito Mussolini- che aveva eliminato la libertà di stampa in Italia.
"Pertini il più irascibile, ma Craxi e D'Alema..." I big della nostra politica visti da Quaranta. Da Moro a Leone, mezzo secolo passato a descrivere i leader della Repubblica. Parla Guido Quaranta, giornalista inventore del retroscena e ora novantenne. Che sui nomi di oggi chiosa: «Di Maio? Figurino da Rinascente. Renzi spietato e Meloni una Le Pen Cacio e Pepe», scrive Marco Damilano il 19 giugno 2017 su "L'Espresso". In un’epoca di giornalismo paludato si è inventato un genere che non esisteva prima: il retroscena della politica, il dietro le quinte di quel palcoscenico su cui si recita la comédie della politica tra primattori, spalle, comparse, guitti, il fattore umano. I potenti in mutande («Accompagnai Cossiga dal fisioterapista») raccontati con perfidia e con comprensione per debolezze, vanità, cadute. Guido Quaranta ha compiuto novant’anni il 18 giugno e cura “Banana Republic”, la sua rubrica per L’Espresso. È uno dei maestri del mestiere, ma meglio non dirglielo. «Va bene, chiacchieriamo, ma a una condizione: non mi chiedere analisi; mai fatta una in vita mia. Non mi sono mai sentito un grande giornalista, ho sempre fatto il cronista...».
Rinuncio a definirti, allora. Pensaci tu.
«Resocontista parlamentare, con Paese Sera, dal 1959, per dieci anni. Poi informatore dal Palazzo, con Panorama e dal 1978 con L’Espresso. Qualcuno diceva: spione. Il monarchico Alfredo Covelli mi chiamava “la supposta”. Sono stato ministro: ho firmato per qualche mese una rubrica con lo pseudonimo Minister. Organizzatore di eventi: ho fatto cantare gli onorevoli davanti alle telecamere e ho convinto Vittorio Sgarbi a denudarsi per una copertina. Candidato alla presidenza della Repubblica. Stefano Rodotà che presiedeva lesse per due volte il mio nome nell’aula di Montecitorio durante le votazioni del 1992. La prima volta ci fu un brusio generale, la seconda una risata».
Ora te li ritrovi anche in casa di giorno e di notte, ma all’epoca i politici erano inavvicinabili.
«Io li andavo a cercare fuori dal Palazzo. Aspettavo Giulio Andreotti alle 6 e 30 del mattino al portone del suo studio, davanti a Montecitorio, con il taccuino in mano. “Che fai, sembri un pizzardone: mi vuoi fare la contravvenzione?”, mi prese in giro la prima volta. Mi raccontò che non era vero che fosse così imperturbabile. “Anch’io ogni tanto perdo qualche colpo”, mi disse. “Al Senato durante un dibattito le sinistre lanciavano contro i banchi del governo libri, carte, aste dei microfoni. Io vidi un cestino di vimini per i rifiuti e per proteggermi me lo misi in testa”. Il massimo della scompostezza, per lui».
A differenza di un altro capo della Dc, Amintore Fanfani.
«Avevo scritto di un suo giro in Italia, definendolo misterioso. E mi presentai al Senato per strappargli qualche notizia. Quando mi vide restò pietrificato, poi cominciò a urlare: “Lei osa venire qui, al mio cospetto?”. Mi disse di seguirlo in ascensore. Nella sua stanza da presidente del Senato mi fece una sfuriata: “Io la mando in galera!”. Aveva la bava alla bocca. All’improvviso si calmò e mi spiegò il motivo del viaggio. Gli feci una domanda, poi un’altra ancora e mi misi a scrivere. Alla fine mi chiese: “Lei ha mai visto un mio quadro?”. E ordinò a un commesso di portarne uno: una barchetta verde, con la vela gialla, in mezzo al mare blu. Io dissi che era bellissimo, con toni un po’ eccessivi, e lui lo fece incartare. L’ho portato nella casa in campagna, nella camera da letto».
Con Aldo Moro hai fatto una storica intervista.
«In Transatlantico non parlava con nessuno. Scoprii la chiesa dove andava ogni mattina e gli chiesi un’intervista. Mi promise un appuntamento e qualche tempo dopo mi disse di andarlo a trovare a Terracina, sul litorale laziale. Camminava vestito in giacca, cravatta e soprabito sotto braccio tra i passanti in costume; mi raccontò che faceva pochi bagni e che durante le vacanze aveva visto al cinema due volte “Un uomo da marciapiede”. Poi rispose alle mie domande. Mi voleva bene. Una mattina due carabinieri bussarono alla porta di casa chiedendo le mie generalità. Temevo che volessero arrestarmi. Invece mi consegnarono la nomina a commendatore della Repubblica firmata da Moro».
I più irascibili?
«Sandro Pertini. Scrissi che aspirava a essere rieletto al Quirinale e mi gridò tre volte: “serva!” davanti a tutti, alla Camera. Bettino Craxi: “Devi ringraziare il cielo che non sono diventato presidente del Consiglio”, mi disse minaccioso nel 1979, dopo aver rinunciato all’incarico. Quando riuscì ad arrivare a Palazzo Chigi per L’Espresso gli strappai un colloquio dove attaccava i giornalisti e la stampa a suo dire ostile: “Sto per rompermi i coglioni”. Scrissi tutto e successe un putiferio. Massimo D’Alema si offese perché avevo scritto del suo carattere difficile e mi rivolse una cattiva espressione che non ricordo».
I più permalosi?
«Il presidente Giovanni Leone. Lo seguii nelle sue visite all’estero e scrissi delle sue gaffe. A Tbilisi, in Georgia, si mise a dirigere un coro che in suo onore aveva intonato “Funiculì Funiculà”. In Iran, a Persepoli, di fronte alla tomba di Ciro il Grande, esclamò: “Anche a Napoli abbiamo il nostro Ciro, Ciro a Mergellina”. Quando mi incontrò mi disse: “Ecco l’ambasciatore delle male parole”. Franco Evangelisti, il braccio destro di Andreotti, sottosegretario e ministro. Mi affrontò alla buvette: “Mi hai chiamato Tigellino e hai scritto che ghigno” e mi diede tre schiaffi. Io lo aspettai di fuori, nell’androne della Camera. Lui mi venne incontro, forse voleva scusarsi, ma non gli diedi il tempo perché gli restituii i ceffoni. Ci fu un parapiglia, ci divise Carlo Donat Cattin, per mettere pace intervenne il presidente della Camera».
Una volta hai catalogato i giornalisti che scrivono di politica.
«Li ho divisi in tonni, quelli che si muovono in branco e sono innocui. I pesci azzurri, gli squaletti da passeggio che si limitano a qualche morso indolore. E gli squali, che addentano senza timore. I tonni sono sempre stati numerosi. Oggi forse più di ieri».
Come sono cambiati i rapporti tra giornalisti e politici?
«Allora c’era un’informazione molto paludata. Veline e comunicati ufficiali. I retroscena non esistevano, i politici si infuriavano perché non erano abituati a veder pubblicato ciò che doveva restare riservato. Non mi hanno mai chiamato bugiardo; si arrabbiavano perché scrivevo cose che non dovevano uscire, ma mai cose false. Oggi invece mi sembra che i retroscena siano dettati dai politici, sui giornali finiscono le frasi che loro hanno interesse a far uscire, per scambiarsi qualche messaggio in codice».
Oggi si sa tutto, c’è la trasparenza, le riunioni si fanno in streaming.
«Non è vero, non è cambiato nulla. Mi è capitato di travestirmi per captare qualche riunione segreta. Una volta chiusero un armadio in cui mi ero infilato per ascoltare un vertice del Psiup e rischiai di morire soffocato. A una riunione della Dc alla Camera io e Augusto Minzolini ci infilammo il grembiule nero degli inservienti e ci mettemmo a pulire le finestre. Dopo un po’ fummo individuati e buttati fuori».
È cambiato, forse, che la politica si fa in tv.
«Nel 1983 Enzo Tortora mi chiese di arruolare i politici per il suo nuovo programma, “Cipria”. Dovevo convincerli a cantare davanti alle telecamere per la rubrica “L’ugola del Palazzo”. In molti mi dissero di no: Alessandro Natta si offese, Craxi mi buttò giù il telefono, Andreotti mi disse che aveva la raucedine. Altri abboccarono: il segretario del Pri Oddo Biasini cantò “Signorinella”; il dc Claudio Vitalone “Tu non mi lascerai mai” sul balcone di casa, mano nella mano con la moglie; il missino Tommaso Staiti di Cuddia intonò “Nel blu dipinto di blu” gettandosi con un paracadute da un bimotore. Il meglio lo diede il dc Calogero Mannino, che si esibì sulla “Turandot” e steccò sul “Vincerò”. Per la messa in onda aveva invitato a casa sua parenti e autorità e ci restò male».
Che tenerezza! Dopo abbiamo visto di tutto: chi cucina il risotto, chi gioca a ping pong, chi si butta in testa un secchio di acqua gelida...
«In tv i politici si considerano indispensabili e parlano di tutto. Maurizio Gasparri e Andrea Romano entrano negli studi tv fin dal mattino presto, con la donna delle pulizie, e parlano di Trump e delle buche di Roma con uguale autorevolezza. Una compagnia di giro».
Li racconti per L’Espresso nella rubrica "Banana Republic". Che ti sembrano i nuovi leader?
«Renzi è politicamente spietato: un uomo indifferente, basta vedere come stringe sbadatamente le mani. Di Maio? Un figurino della Rinascente. Salvini ha la faccia familiare di un commensale del vagone ristorante. Bersani sembra lo zio di un film di Pupi Avati. Giorgia Meloni è una Le Pen a cacio e pepe...».
Non salvi nessuno?
«Mi piace Mario Monti: una persona seria che ha salvato l’Italia. E uno come Mario Draghi. Quelli che non ti prendono in giro».
Tra i tuoi direttori chi ricordi con piacere?
«Livio Zanetti. Che mi assunse all’Espresso. E Claudio Rinaldi: nessuno sapeva annusare i pezzi come lui. Nel 1993 vide una foto di Luciano Benetton nudo per una pubblicità e decise di ripetere la copertina con un politico. Mi urlò: “Portami Sgarbi!”. Alla fine Vittorio accettò, interamente nudo fronte e retro, con lo slogan. “Meglio di tanti altri ben vestiti ma scandalosi”. Era l’anno di Tangentopoli. Ci costò quindici milioni di lire».
Oggi la politica si è rivestita? O è ancora nuda?
«La politica è sempre la stessa: insulti, baruffe, riappacificazioni finte. Di nuovo ci sono i trolley che scorrono sui pavimenti di marmo di Montecitorio, quando i deputati tornano a casa».
Quando Enrico Berlinguer sorrideva alla Camera: il racconto di un grande cronista. L’aplomb di Togliatti. Gli zoccoli della Bonino. I congiuntivi di Bossi. Le stagioni di Montecitorio viste da un giornalista in prima fila. «Ricordo l’abilità dialettica di Saragat e quella calma di Moro, che ti parlava come a un paziente. A porre fine all’era dell’abito scuro fu Oscar Mammì, con un maglioncino. Poi arrivarono i jeans. E infine Cicciolina», scrive Guido Quaranta il 09 novembre 2018 su "L'Espresso". Quando, un pomeriggio della primavera del 1959, mi sporsi per la prima volta dal parapetto della tribuna della stampa, affacciata sull’aula affollata della Camera dei deputati, mi colpì soprattutto l’immagine di due personaggi. La prima era quella di un signore tozzo, dalle tempie imbiancate, le orecchie a sventola e un naso a becco così prominente da sembrare posticcio. Appollaiato lassù, su quell’alto scranno, in un ampio salone illuminato a giorno, assistito da commessi in divisa e al cospetto di centinaia di persone sedute nei loro banchi disposti ad anfiteatro, pareva quasi una divinità: era il presidente Giovanni Leone, un notabile democristiano di lungo corso e di mezza età. L’altro personaggio era una signora dai capelli grigi e l’aria un po’ arcigna, in piedi nel settore di sinistra: era la famosa deputata socialista Lina Merlin, di cui allora si parlava molto perché, l’anno prima, era riuscita a imporre la chiusura delle case di tolleranza nel Paese. Da quel pomeriggio della primavera del ’59 sono stati molti i primattori, le primedonne, i comprimari e le comparse della politica che ho potuto vedere da vicino e che ho ascoltato da quella privilegiata veranda di Montecitorio riservata ai cronisti come me e che ho frequentato per parecchi anni della prima Repubblica. Eh sì, da Almirante a Berlusconi, passando per Nilde Iotti, sono stati proprio tanti. Ricordo che Palmiro Togliatti, il capo del Pci, aveva uno sguardo severo e l’oratoria elegante: di solito compariva nell’emiciclo quando era prevista una votazione delicata e importante o se doveva pronunciare un discorso. Il segretario socialista Pietro Nenni, il volto solcato da mille rughe sottili, era un parlatore impetuoso: con la sua foga tribunizia trascinava sempre l’assemblea. Il leader dei liberali, Giovanni Malagodi, perennemente in doppiopetto blu, aveva, invece, il tono secco e uniforme dell’amministratore delegato che illustra la relazione di bilancio ai soci: quando interveniva non faceva quasi mai una pausa. E il repubblicano Ugo La Malfa, infine, era talmente preso dal suo amour fou per la politica che, quando ne discuteva nei dibattiti, si scuoteva tutto, agitando testa, torso, spalle, braccia e gambe. Non dimenticherò l’aspetto massiccio e incombente del socialista Riccardo Lombardi che improvvisava i suoi aspri, frequenti, astrusi e torrenziali discorsi lì per lì, senza badare al foglietto di appunti che lasciava regolarmente riposto sulla tavoletta del suo seggio; come rammento, altrettanto nitidamente, gli interventi asciutti, rari e meditati dello scrittore Leonardo Sciascia, un deputato molto riservato del partito radicale: una volta, durante un’ accesa ed estenuante discussione sul terrorismo, si limitò a parlare soltanto per nove minuti. Diversi onorevoli erano colti e preparati. Uno di loro, per esempio, era Giuseppe Saragat, leader dei socialdemocratici, che entrava nell’aula della Camera sempre con il Times e il Figaro sotto il braccio: più che un grande tribuno, era un abile argomentatore. Un altro è stato il segretario comunista Enrico Berlinguer: aveva un sorriso luminoso e triste, la voce assai pacata e lievemente rauca per le molte sigarette che fumava; e pure lui giungeva reggendo, sotto il braccio, un voluminoso fascio di giornali. E poi c’era il leader democristiano Aldo Moro, con quella sua frezza bianca sulla fronte, la voce calma, distaccata, distante e quell’eloquio da soave anestesista. Molti, invece, erano alquanto diversi. Alcuni usavano un linguaggio ampolloso, infarcito di “altresì”, “pertanto” e “qualsivoglia”. Altri tendevano alla retorica, con polverose citazioni in latino. Altri ancora si esprimevano con il gergo oscuro, involuto, allusivo, il cosiddetto politichese, in uso soprattutto nelle stanze dei partiti della sinistra. Certuni, poi, cedevano al tono professorale, scantinavano nel dottrinario, se ne uscivano con espressioni care agli avvocati di pretura, tipo “Bene ha fatto!” o “Come non ricordare?”. Parecchi, infine, discettavano sul nulla: un giorno gli onorevoli battibeccarono sull’eventualità di abbassare l’Iva sul basilico, la salvia, il rosmarino, lasciandola però intatta sul prezzemolo. C’era chi offendeva la sintassi o non rispettava la grammatica e, se graziava l’una era difficile che avesse pietà dell’altra. Rammento il capo della Lega Nord, Umberto Bossi, camicia verde, modi bruschi e, soprattutto, lessico sgangherato. Una volta, mentre pronunciava un suo colorito discorso, il presidente di turno, Alfredo Biondi, lo interruppe bruscamente e gli disse: «Onorevole, largheggi pure quanto vuole con gli aggettivi ma, per favore, sui congiuntivi, si controlli!». E c’era persino chi sembrava ignorare il significato delle parole. Un giorno, per esempio, un sottosegretario all’Interno, il socialista Aldo Venturini, chiamato a rispondere in Parlamento delle violente cariche della polizia durante una manifestazione studentesca a Roma, lesse un rapporto compilato dai funzionari del suo Ministero e concluse con tono rassicurante: «Onorevoli colleghi, posso, comunque, garantire la Camera che tutti i feriti sono stati portati al Politecnico». Mi hanno raccontato che un leghista del Trentino, Rolando Fontan, distratto dall’incessante chiacchiericcio dei colleghi seduti alle sue spalle, osservò, irritato, che non poteva continuare il suo intervento con quel “ronzino” sulla testa. Quante ne hanno sentite, poveretti, i due stenografi che, ogni cinque minuti, si davano il cambio a un tavolino posto al centro dell’emiciclo, fornito di un altoparlante, appuntavano tutti gli interventi alla velocità di 160 parole al minuto. Mi piace anche ricordare che, qualche anno prima del’59, era d’obbligo, per i deputati, accedere all’aula in abito scuro ed era assolutamente vietato entrarvi senza la cravatta. Ma, a poco a poco, quelle severe regole sull’abbigliamento sono state trasgredite e l’avvio lo diede un ministro, il repubblicano, Oscar Mammì che, tra le occhiate sgomente dei commessi e la sconcertata sorpresa dei colleghi, un bel giorno comparve con una maglietta dolcevita. Poi è stata la volta di un deputato comunista, Antonello Trombadori: reduce da un viaggio a Canton, sfoggiò una giubba di panno blu come quelle dei militari della Repubblica popolare cinese. Quindi fu il turno di un suo collega piacentino, irriducibilmente fascista, Carlo Tassi, che riesumò trionfante la camicia nera. E, infine, un giovane e belloccio democratico di sinistra, il padovano Pietro Folena, si esibì con pantaloni color vinaccia e, addirittura, con un paio di scarpe da tennis ai piedi: quasi un indossatore di Dolce & Gabbana. A quel punto, anche diverse onorevoli si affrettarono a imitare i colleghi. La radicale Emma Bonino comparve calzando audacemente gli zoccoli, divisa d’ordinanza delle prime femministe. Alessandra Mussolini, di Alleanza nazionale, optò per i blue-jeans. L’onorevole Cicciolina inaugurò un abito di lamé aderentissimo. E la berlusconiana Mariella Scirea si mostrò con i guanti di pizzo bianco lunghi sino al gomito come quelli che, ai suoi tempi, la soubrette Wanda Osiris metteva andando in scena. L’unica penalizzata dal nuovo corso, ormai accettato da tutti, fu Anna Maria Ciai, comunista, il giorno in cui mise, la prima volta, i pantaloni: erano così attillati che, in aula, al momento di sedersi, si squarciarono. Imbarazzata, raggiunse l’uscita camminando prudentemente all’indietro, un commesso le fece galantemente da scudo e, procedendo passo passo alle sue spalle, la scortò sino al laboratorio della sartoria della Camera per la riparazione. Non ho assistito ai frequenti tumulti che, soprattutto nei primi anni Cinquanta, hanno infuocato l’aula: con le parlamentari comuniste che colpivano i deputati democristiani sotto la cintura e con i loro compagni di partito che lanciavano penne, libri, scartoffie e le tavolette scardinate dei seggi contro il banco del governo occupato dai ministri. Giulio Andreotti, allora presidente del Consiglio, mi ha raccontato: «Una volta mi riparai in extremis da quel terribile diluvio di oggetti con un cestino di vimini: stava, per fortuna, sotto il mio banco accanto ai piedi, lo afferrai di colpo e me lo misi in testa». Finita la storica stagione degli scontri fisici, la contestazione parlamentare ha perduto la spettacolarità di un tempo e spesso si è ridotta a qualche carnevalata: come quando il leghista Luca Leoni Orsenigo, all’epoca buia di Tangentopoli, sventolò dal suo seggio un cappio da forca per indicare la sorte che, secondo lui, meritavano i corrotti. E un altro leghista, il torinese Mario Borghezio, scalmanato sostenitore dell’avvento della Padania indipendente, pronunciò un discorso in dialetto piemontese esordendo così: «Monsù President, colega parlamentar, ancheuj…». Proseguì affermando che l’italiano era ormai una “lingua da colonia”. E questo è quanto.
Il Pantheon dei capri espiatori. La storia politica dell’Italia repubblicana raccontata attraverso l’odio per il singolo, scrive Francesco Damato il 17 Aprile 2018 su "Il Dubbio". L’articolo di Angela Azzaro in difesa del Pd, e del suo ex segretario, diventato la sentina di tutti i mali della politica e persino della società italiana dopo i risultati elettorali del 4 marzo, mi ha fatto tornare alla mente un po’ di capri espiatori nella storia più che settantennale ormai della Repubblica. Tutto sommato, Matteo Renzi può sentirsi in buona compagnia, pur con tutti gli errori che ha sicuramente compiuti, compreso quello che personalmente gli ho più volte rimproverato di avere negato il Pantheon della sinistra riformista italiana a Bettino Craxi. Di cui pure, volente o nolente, lui ha ripercorso alcune tappe nell’azione di partito e di governo, persino quelle delle reazioni più scomposte e indegne dei suoi avversari, che ne hanno sognato l’arresto, sprovvisto com’era prima dell’elezione a senatore di Scandicci, di quel poco che è rimasto della vecchia immunità parlamentare. O lo hanno più semplicemente scambiato per un aspirante tiranno, come fece appunto con Craxi nel 1983 l’allora segretario del Pci Enrico Berlinguer. Che pure Renzi è tornato anche di recente a preferire al leader socialista nella galleria della sinistra.
Nel 1953 il ruolo del capro espiatorio toccò addirittura al protagonista della ricostruzione post- bellica del Paese: Alcide De Gasperi. Al quale non fu rimproverata, per quanto neppure scattata nelle elezioni di quell’anno, una legge chiamata “truffa” perché contemplava un premio di maggioranza in Parlamento per chi avesse raccolto il 50 per cento più uno dei voti. Roba da ridere rispetto ai premi adottati o tentati durante la cosiddetta seconda Repubblica. Il povero De Gasperi subì l’onta della sfiducia parlamentare ad un governo appena formato, l’ottavo della sua storia personale, e si ritirò fra le montagne del suo Trentino per morirvi praticamente di crepacuore. E ciò mentre il suo successore alla guida della Dc, l’allora giovane Amintore Fanfani, si vantava di essere stato da lui stesso aiutato a subentrargli. «Una fantasia», soleva commentare a labbra strette Giulio Andreotti, che di De Gasperi era stato il braccio destro.
Toccò poi al medesimo Fanfani diventare il capro espiatorio di una rivolta di partito che lo estromise contemporaneamente da segretario, da presidente del Consiglio e da ministro degli Esteri. Furono utilizzati contro di lui persino alcuni incidenti ferroviari per dargli del menagramo. E appendergli in fotografia al collo un corno, come fece in una copertina un settimanale allora in voga – Il Borghese – fondato da Leo Longanesi.
Aldo Moro, succeduto a Fanfani come segretario della Dc nel 1959 e poi anche come presidente del Consiglio alla testa, nel 1963, del primo governo “organico” di centrosinistra, con tanto di trattino, divenne nel 1968 il capro espiatorio del mancato successo elettorale dell’unificazione socialista. Che pure lui aveva cercato di favorire, fra le proteste della maggiore corrente della Dc, quella dei “dorotei”, sponsorizzando nel 1964 l’elezione del suo ministro degli Esteri Giuseppe Saragat al Quirinale. Dove peraltro qualche mese prima il democristiano Antonio Segni era stato colto da ictus in un alterco proprio con Saragat. Fu proprio la mancanza dell’appoggio di Saragat, nell’estate del 1968, a determinare l’allontanamento di Moro da Palazzo Chigi. «Non lasciatemi morire con Moro», si lasciò supplicare quell’estate Pietro Nenni, che ne era stato il vice al vertice del governo. Estromesso dalla presidenza del Consiglio per convergenza di interessi e risentimenti democristiani e socialisti, Moro divenne il bersaglio persino del coltissimo ed ecumenico Giovanni Spadolini. Che da direttore del Corriere della Sera ne contestò in un fondo domenicale il voto espresso nella competente commissione della Camera a favore di un emendamento comunista alla riforma degli esami di Stato, approvato per garantire la promozione dello studente in caso di parità di giudizi. In quel voto Spadolini vide addirittura tracce o indizi della Repubblica conciliare, anticipatrice di quello che sarebbe poi diventato con Berlinguer il progetto del “compromesso storico”. Ricordo ancora lo sconforto confidatomi da Moro per essere stato frainteso da un professore universitario dimentico – mi disse l’ex presidente del Consiglio – che anche un imputato va assolto a parità di voti. Debbo dire che poi Moro, quando gli capitò da presidente del Consiglio, in un bicolore Dc- Pri con Ugo La Malfa, di far nominare Spadolini ministro gli ‘ regalò’ – mi disse – il Ministero dei Beni Culturali fornendogli con un decreto legge il portafogli di cui quel dicastero non disponeva ancora. Dopo tre anni Moro, nel frattempo detronizzato di nuovo da Palazzo Chigi, sarebbe stato sequestrato e ucciso dalle brigate rosse. Il capro espiatorio anche di quella vicenda, e non solo di un presunto deterioramento dei rapporti fra società civile e politica avvertito dal Pci nei risultati stentati di un referendum contro la legge che disciplinava il finanziamento pubblico dei partiti, fu Giovanni Leone. Il quale fu costretto dalla mattina alla sera a dimettersi da presidente della Repubblica, quando mancavano solo sei mesi alla scadenza del mandato quirinalizio.
Così il povero Leone pagò pure, o soprattutto, la colpa di essersi messo di traverso alla linea della fermezza adottata dal governo di fronte al sequestro del presidente della Dc. Di cui invece il capo dello Stato aveva voluto tentare uno scambio predisponendo la grazia per Paola Besuschio, compresa nell’elenco dei tredici detenuti che i terroristi avevano chiesto di liberare per restituire vivo l’ostaggio.
Il turno successivo di capro espiatorio toccò ad Arnaldo Forlani, dimessosi da presidente del Consiglio nel 1981 per le liste della loggia massonica P2 di Licio Gelli, in cui c’era anche il nome di un prefetto che era il suo capo di Gabinetto. Poi Forlani dovette difendersi in una causa alla Corte dei Conti per i danni subiti dai massoni, e risarcibili dallo Stato, a causa della diffusione delle liste, per quanto avvenuta d’intesa tra il governo e la competente autorità giudiziaria. Una vicenda tutta italiana per confusione, caccia alle streghe e quant’altro.
Decisamente più drammatica fu, come capro espiatorio, la sorte di Bettino Craxi, perseguito con «una durezza senza uguali», certificata dopo anni con lettera dell’allora capo dello Stato Giorgio Napolitano alla vedova, per il finanziamento illegale della politica, e reati connessi. Come se Craxi non avesse ereditato ma inventato lui quel fenomeno, per giunta coperto nel 1989 con un’amnistia che aveva consentito a un bel po’ di politici di farla franca.
Giulio Andreotti divenne invece negli stessi anni il capro espiatorio delle carenze nella lotta alla mafia, per quanto il suo ultimo governo avesse trattenuto con un decreto legge di controversa costituzionalità un bel po’ di mafiosi che avevano maturato il diritto di uscire dal carcere. E avesse arruolato al Ministero della Giustizia, proprio per la lotta alla mafia, un campione come il giudice Giovanni Falcone, eliminato per questo dai criminali con la strage di Capaci. Processato, in sovrappiù, ed assolto anche per il delitto Peccorelli, il sette volte presidente del Consiglio, nonché senatore a vita di nomina quirinalizia avendo «illustrato la Patria – secondo la formula dell’articolo 59 della Costituzione – per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario», si è portata nella tomba l’onta, ancora rimproveratagli ogni volta che gli capita dal pubblico accusatore Gian Carlo Caselli, di una prescrizione del reato di associazione a delinquere, prima che diventasse concorso esterno in associazione mafiosa. Da cui in ogni modo Andreotti fu assolto, per ammissione anche di Caselli.
Passati dalla prima alla seconda Repubblica, ci siamo dovuti accontentare, sempre nel campo politico, di capri espiatori, diciamo così, più alla buona. Come il povero Achille Occhetto, sostanzialmente deposto nel 1994 da Massimo D’Alema al vertice dell’ex Pci per la sorprendente e strepitosa vittoria elettorale conseguita sulla sinistra dall’esordiente Silvio Berlusconi. E poi lo stesso Berlusconi per le sue abitudini di vita non da seminario, o per i suoi affari, analoghi a quelli di tutti gli altri imprenditori della sua stazza finanziaria, o persino per le speculazioni subite dai titoli del debito pubblico italiano nell’estate del 2011, quando irruppe sulla scena il loden austero di Mario Monti.
Il ruolo di capro espiatorio è inoltre toccato a D’Alema per essere subentrato nel 1998 a Romano Prodi senza passare per gli elettori con le elezioni anticipate, e per una certa spocchia rimproveratagli a volte a ragione ma a volte anche a torto.
Il povero Fausto Bertinotti, a dispetto delle buone maniere che tutti gli riconoscono, è stato buttato dal mio amico Giampaolo Pansa tra le fiamme come ‘ il parolaio rosso’ per non aver voluto a suo tempo sostenere i governi Prodi oltre le loro materiali capacità di resistenza politica.
Walter Veltroni divenne nel 2009 il capro espiatorio di alcuni rovesci locali del Pd da lui stesso fondato due anni prima, scampando al torto più consistente e per lui dannoso di essersi apparentato a livello nazionale nelle elezioni del 2008 con Antonio Di Pietro, subendone la linea. Matteo Renzi chiude, per ora, la lista per le rottamazioni sbagliate, o per quelle incompiute. E per sopravvivere fisicamente alle sue dimissioni da segretario del Pd dopo la sconfitta del 4 marzo. Già, perché la sua stessa presenza fisica sembra infastidire i vecchi e nuovi avversari politici. E’ incredibile ma vero in questo Paese che continua a chiamarsi Italia.
E la chiamano democrazia. Abbiamo dei Parlamentari votati dal 51% degli Italiani. Abbiamo un Governo votato dal 51% dei Parlamentari. Ergo: siamo governati da una minoranza, ossia il 25% della volontà popolare. E poi dire governati è una parola grossa.
«Non tengo più i miei». Storia della frase che unisce le tre Repubbliche. Luigi Di Maio l’ha usata per chiedere a Salvini più prudenza. Non sa che la usarono Rumor, Piccoli, Berlinguer, Bossi, Bertinotti e Berlusconi, scrive Francesco Damato l'11 Settembre 2018 su "Il Dubbio". Per quanto smentito da Matteo Salvini, che ha raccontato di averne parlato prima solo col presidente del Consiglio Giuseppe Conte raccogliendone peraltro solo la solidarietà o comprensione, è stato largamente pubblicato sui giornali il monito che il grillino Luigi Di Maio avrebbe rivolto al collega leghista di governo per strappargli una frenata, una retromarcia o quant’altro nello scontro con i magistrati: “Così i mei non li tengo più”. Che, guarda caso, conferma un certo stile o modo di ragionare. E’ la stessa frase attribuita a Di Maio, sempre a colloquio con Salvini, dopo l’insediamento delle Camere elette il 4 marzo scorso, per spiegargli il rifiuto di incontrare Silvio Berlusconi, o solo di raccoglierne una telefonata, per l’assegnazione delle presidenze parlamentari e poi per le trattative di governo fra grillini e leghisti. Quei “miei non li tengo più” o loro varianti, come al plurale “i nostri non li teniamo più”, non sono soltanto il ritorno alla “seconda Repubblica”, alla sintonia di governo fra i leghisti e Silvio Berlusconi evocata con pubbliche dichiarazioni dal guardasigilli Alfonso Bonafede dopo il facebook in diretta di Matteo Salvini venerdì sera, nel suo ufficio al Viminale. Dove gli avevano appena notificato l’avviso della Procura di Palermo per il sequestro plurimo e aggravato di persona contestatogli con le procedure del cosiddetto tribunale dei ministri a proposito della vicenda degli immigrati sulla nave Diciotti. Nato solo nel 1976, beato lui, Bonafede non può sapere – e temo che nessuno glielo abbia raccontato – che a non tenere più i loro furono ricorrentemente i grandi partiti – grandi davvero – della cosiddetta e più lontana prima Repubblica, mai in grado o disposti – anche quando ne ebbero i numeri, come capitò alla Dc dopo le elezioni del 18 aprile 1948 – a governare da soli, e sempre protesi invece a governare con altri, direttamente o con il loro appoggio. Ricordo ancora il racconto, anche mimico, che Aldo Moro mi fece una volta delle telefonate e visite dei dirigenti della Dc Mariano Rumor e Flaminio Piccoli, insieme o separatamente, l’uno segretario e l’altro vice segretario del partito, nei quasi cinque anni da lui trascorsi ininterrottamente a Palazzo Chigi alla guida dei primi governi “organici” di centro- sinistra, fra il 1963 e il 1968. “I nostri così non riusciamo più a tenerli”, dicevano i due a Moro rimproverandogli la “troppa pazienza” o “il troppo spago” che lui concedeva ai socialisti. Moro si sfogò con me, imitando – ripeto – con voce e smorfie i colleghi di partito, quando gli andai a fare gli auguri natalizi del 1968. Egli aveva perduto da mesi Palazzo Chigi, per quanto la Dc fosse uscita dalle urne con più voti e più parlamentari di prima, e i socialisti unificati con molti meno voti di quanti non ne avessero preso separatamente cinque anni prima come Psi e Psdi. E al posto di Moro, dopo la solita pausa balneare di Giovanni Leone, si era insediato a Palazzo Chigi Mariano Rumor guidando un’edizione “più incisiva e coraggiosa” del centro- sinistra, senza più la “delimitazione della maggioranza a sinistra”, quindi più aperto all’opposizione comunista, e con la concessione di un’inchiesta parlamentare sui servizi segreti, negata in precedenza ai socialisti da Moro. Che pure nel 1964 aveva già rischiato di perdere il governo per manovre attribuite, a torto o a ragione, ai servizi segreti e tradotti dall’allora vice presidente socialista del Consiglio Pietro Nenni in “rumori di sciabole” scrivendone nei suoi diari. Nel parlare dei “nostri che non riusciamo più a tenere” Rumor e Piccoli, insieme o separatamente, non alludevano solo agli elettori della Dc ma anche, o più in particolare, alla corrente dello scudo crociato – quella dei cosiddetti “dorotei” che condividevano con Moro. E dalla quale egli uscì dopo lo sfratto da Palazzo Chigi guidando per un po’ l’opposizione interna democristiana, sino a superare a sinistra i dorotei con la famosa “strategia dell’attenzione al Pci”, scavalcato anch’esso, in verità, dall’ormai ex presidente del Consiglio nella lettura della storica contestazione sessantottina, ancora oggi di controversa interpretazione. Tre anni dopo, alla fine del 1971, i “dorotei” tornarono a farsi vivi con Moro, in delegazione guidata da Rumor, per spiegargli come e perché, caduta la candidatura di Amintore Fanfani al Quirinale per succedere al socialdemocratico Giuseppe Saragat, essi non fossero “in grado” di designare lui, nel frattempo diventato ministro degli Esteri e sostenuto dal segretario del partito Arnaldo Forlani. “Passeresti agli occhi dei nostri come il candidato del Pci”, dissero Rumor e Piccoli a Moro. Che si limitò a rispondere: “Mi avete confezionato un abito su misura che pure non mi appartiene”. Giorgio Amendola contemporaneamente raccontava ai giornalisti nel “transatlantico” di Montecitorio degli inutili tentativi compiuti “da varie parti” sul Pci per far votare Fanfani e concludeva: “L’unico che non ci ha chiesto i voti è stato Moro”. Troppo orgoglioso forse per farlo, almeno senza una preventiva investitura del suo partito, che perciò non gliela concesse in una votazione a scrutinio segreto nei gruppi parlamentari, a favore invece di Giovanni Leone. Il calendario si sposta di altri quattro anni e ci porta alla fine del 1975. Moro era di nuovo a Palazzo Chigi, a guidare col vice presidente Ugo La Malfa un governo Dc- Pri appoggiato esternamente dai socialisti. Il cui segretario Francesco De Martino gli telefonò per fargli gli auguri di fine anno…. e di fine governo, raccontandogli di non riuscire più a tenere il suo partito nella maggioranza senza la partecipazione anche dei comunisti. Seguirono le elezioni politiche anticipate del 1976, dalle quali la Dc e il Pci uscirono distanziati di soli quattro punti, ma incapaci per ragioni numeriche in Parlamento di governare l’una contro o senza l’altro. Toccò a Moro, ormai soltanto presidente dello scudocrociato ma in realtà il vero regolo della Dc, di sbloccare la situazione con la formula dei “due vincitori” costretti per la loro stessa natura a garantire il sistema con la formazione di una maggiorana transitoria di “solidarietà nazionale”. Il Pci di Enrico Berlinguer – già sottrattosi alla vecchia prospettiva dell’alternativa di sinistra adottando quella del “compromesso storico” con la Dc e chiunque altro disposto ad evitare svolte reazionarie come quella avvenuta nel pur lontano Cile – rispose all’appello con la formula della “non sfiducia” a un governo monocolore democristiano guidato da Giulio Andreotti. Ma alla fine del 1977, in una situazione politica e sociale efficacemente rappresentata su Repubblica da Giorgio Forattini con una vignetta dove Enrico Berlinguer faceva colazione in vestaglia con i capelli dritti procuratigli dai fischi dei metalmeccanici che sfilavano sotto la finestra contro la politica del governo, il segretario del Pci comunicò a Moro di non “riuscire più a tenere” i suoi elettori e militanti su una posizione defilata come l’astensione. Occorreva un passo politico in avanti: un programma ben concordato e magari anche la partecipazione del Pci al governo tramite qualcuno degli indipendenti di sinistra eletti al Parlamento nelle sue liste. Moro, per quanto Andreotti a Palazzo Chigi e Benigno Zaccagnini alla segreteria del Dc fossero disposti ad andare anche oltre, convenne sulla richiesta del programma ma non sul resto per ragioni di politica internazionale, pensando ai sospetti degli americani. Si passò così a marzo del 1978 dall’astensione al voto di fiducia, che significava la partecipazione del Pci a pieno titolo alla maggioranza parlamentare. Purtroppo il tragico sequestro terroristico di Moro traumatizzò il nuovo corso politico, sino a troncarlo con una crisi che riportò nel 1979 spontaneamente il Pci all’opposizione. Ma già all’indomani immediato della morte di Moro, e ancora nel pieno delle polemiche sulla gestione della linea della fermezza adottata contro le brigate rosse, Berlinguer aveva dovuto chiedere e ottenere dalla Dc il sacrificio delle dimissioni di Giovanni Leone da presidente della Repubblica per fronteggiare una crisi nei rapporti fra società civile e società politica avvertita dal segretario del Pci nello stentato salvataggio del finanziamento pubblico dei partiti dall’abrogazione referendaria chiesta dai radicali. E la testa del capo dello Stato, reclamata da Berlinguer perché non riusciva più a trattenere i suoi, rotolò politicamente, anche a costo di accreditare una campagna contro il povero Leone destinata a risolversi giudiziariamente dopo qualche anno a suo favore. O, peggio ancora, a costo di dare l’impressione che il presidente avesse odiosamente pagato l’imprudenza di essersi messo di traverso alla linea della fermezza durante il sequestro di Moro, sino a predisporre la grazia per una detenuta, Paola Besuschio, compresa nell’elenco dei tredici “prigionieri” indicati dalle brigate rosse per uno scambio col presidente della Dc. Anche formule di governo successive alla tragedia Moro, come le edizioni del pentapartito a guida prima socialista e poi democristiana, sino alla fine della cosiddetta prima Repubblica per lo tsumani di Tangentopoli, finirono per la incapacità manifestata dalla Dc e dal Psi, a seconda dei casi, di riuscire a tenere i loro elettori e militanti di fronte ai costi politici della loro difficile alleanza di governo. Ma non mancarono crisi da mancata tenuta di questo o quel partito di governo neppure durante la cosiddetta seconda Repubblica, sia nel centrodestra con la caduta, per esempio, del primo governo di Silvio Berlusconi per mano della Lega di Umberto Bossi, sia nel centrosinistra con la caduta prematura sia del primo sia del secondo e ultimo governo di Romano Prodi per l’insofferenza della sinistra radicale. E infine del governo tecnico di Mario Monti, arrivato si al termine ordinario della sedicesima legislatura ma perdendo per strada l’appoggio di Berlusconi, pure lui convintosi di non riuscire a tenere i suoi elettori continuando a subire l’impopolarità dei provvedimenti del governo tecnico succedutogli nell’autunno di due anni prima. E quella dissociazione per poco non fruttò al Cavaliere una clamorosa vittoria elettorale nel 2013. I grillini, quindi, a dispetto della rivoluzione o del solo “cambiamento” decantato col “contratto” stipulato con i legisti, non stanno scoprendo o vivendo nulla di nuovo nel loro rapporto di governo con Salvini. E neppure quest’ultimo, se e quando deciderà di staccare lui la spina della difficile alleanza col movimento delle 5 stelle sui temi della giustizia o altro. E’ la politica, bellezza.
Il patto "pacifista" di Monaco regalò a Hitler metà Europa. L'accordo disastroso firmato da Chamberlain prova che (a volte) la guerra è l'unica opzione, scrive Fiamma Nirenstein, Giovedì 13/09/2018, su "Il Giornale". Esattamente ottant'anni fa a Monaco, il 30 settembre 1938, Neville Chamberlain, primo ministro inglese, firmando l'accordo con Hitler, compì il gesto per cui Winston Churchill pronunciò la proverbiale frase «Hai avuto una scelta fra la guerra e il disonore. Hai scelto il disonore e hai avuto la guerra». L'accordo trasferì alla Germania i Sudeti, la regione della Cecoslovacchia abitata della minoranza tedesca. Fu un puro tradimento nei confronti di un alleato e un gesto di prepotenza verso uno Stato inerme che veniva, con l'accordo, messo alla mercé di Hitler. L'Europa tutta si trovò in breve tempo invasa dalle armate tedesche. La transazione di Francia e Gran Bretagna con Hitler impose limitate «concessioni territoriali» per pacificare la Germania nazista, ma l'aggressore, immediatamente, proprio come prevedevano i suoi piani relativi al Lebensbraum - lo «spazio vitale» bramato dopo l'umiliazione del trattato di Versailles - violò l'accordo e inghiottì tutto lo Stato della Cecoslovacchia, nel marzo del '39. La Francia, che aveva un trattato di alleanza con la Cecoslovacchia, si era associata all'appeasement senza vergogna. Nessun rappresentante della Cecoslovacchia era presente alla conferenza che si concluse con lo smembramento del suo territorio e la deprivò del 70% degli impianti elettrici, delle fabbriche di ferro e acciaio, di tutti gli impianti chimici e della sua robusta difesa sotterranea. I tedeschi nel frattempo si erano già in parte riarmati infischiandosi delle dure imposizioni del trattato di Versailles. La teoria di conquista per stadi dell'Europa era spiattellata nel Mein Kampf, mentre già le leggi razziali entravano in vigore: la «Notte dei cristalli» aveva già mostrato il disegno di sterminio degli ebrei, e il patto Molotov-Ribbentrop sarebbe arrivato da lì a poco. Ma Chamberlain guardava dall'altra parte. Gli inglesi e i francesi cedevano un piccolo stato indifeso che era anche un alleato, un tradimento da cui Hitler rafforzato trasse la determinazione a invadere la Polonia il primo settembre 1939. Il sacrificio della Cecoslovacchia nella mente di Chamberlain significava, come egli disse - facendo la «V» di Vittoria accolto a casa da folle festanti che credettero di essere state liberate dal lutto patito con la prima guerra mondiale - «Pace nel nostro tempo, pace con onore». Questa immagine, col suo ombrello nero a ciondoloni, è stata immortalata nella coscienza pubblica come il simbolo del tradimento e della stupidità. Ma allora, egli fu ricevuto come un eroe. Nelle ore successive all'accordo ricevette 20mila messaggi di congratulazione. Di lui lo storico sir Lewis Namier disse: «Sventolava l'accordo con Hitler come un cacciatore di autografi felice: Ecco una carta con la sua firma... era furbo, ignorante, presuntuoso, capace di ingannare sé stesso quanto lo richiedeva il suo più profondo istinto e il suo scopo, e anche di ingannare quelli che lo desideravano». Monaco apri le porte a Hitler, alla sua sanguinosa marcia sull'Europa fino alla sconfitta, alla Shoah, agli eccidi di massa, all'inedita ferocia che il nazismo ha tributato alla storia universale. Monaco è così rimasta nella storia del mondo come la capitale dell'appeasement, la scelta di fare la pace a tutti i costi, non importa a che prezzo, per paura, opportunismo, calcolo politico, per poi pagarne un prezzo iperbolico, sanguinante, di certo anche infamante per chi firmò. Crudelmente, la storia l'ha voluta di nuovo sul proscenio con l'eccidio degli atleti israeliani alle Olimpiadi del 1972. Alfred Leslie Rowse, uno storico britannico membro dell'All Souls College di Oxford, vicino all'élite e alla classe politica del suo Paese e agli avvocati intellettuali dell'appeasement, nel 1961 pubblicò il volume: Appeasement: uno studio sul declino politico 1933-1939. All'inizio del suo libro si faceva le stesse domande che oggi ognuno ancora fa a sé stesso: «... questa gente ha preferito affidarsi alla versione dei fatti e agli argomenti preparati dalla propaganda nazista, lasciarsi andare fino al punto che al momento non capì gli schemi di Ribbentrop, goffi, infantili, ovvi. Che cosa li possedeva? Come spiegare la loro cecità? Questo è il problema. Oggi non ci può essere dubbio sul fatto che avessero torto. Ma com'è possibile aver torto fino a questo punto contro ogni prova. PERCHÉ giunsero a tanto... Qui sta il problema. Ed è un problema formidabile...». La risposta ancora oggi è viva, perché la risposta non è solo storica, è morale, è contemporanea, mette sotto il riflettore la proibizione basilare contenuta nella fondazione stessa della società moderna che dice «No alla guerra!» a qualunque costo e che manifesta questa volontà in mille occasioni: quando rifiuta di mettere a fuoco l'autentico scontro di religioni e civiltà da cui si genera il terrorismo islamico, quando mette tutta se stessa nell'accordo del P5 +1 con l'Iran mentre gli Ayatollah si ingegnano a conservare il loro disegno atomico e proseguono la guerra imperialista della shia; quando l'accordo di Oslo e lo sgombero di Gaza hanno luogo contro ogni prova del ripetuto rifiuto del mondo arabo verso la nazione ebraica, che si esprime nella guerra terrorista. Ogni giorno, a ogni latitudine si configura una nuova Monaco, cui la risposta di Chamberlain non è così estranea. Il rifiuto della guerra ebbe un ruolo importante nelle scelte britanniche: la Prima guerra mondiale aveva avuto un enorme impatto come «la guerra che deve porre fine a tutte le guerre», il pubblico rifiutava l'uso della forza che gli aveva portato tanti lutti e miseria; ogni città e villaggio, come accade in tutta Europa, mostrava sui monumenti la lista enorme dei giovani caduti. Quella guerra, cominciata per l'assassinio di un arciduca a Sarajevo, risultava per gli inglesi punteggiata di errori e pessime ragioni. Ricordiamo anche che in Inghilterra era diffusa la convinzione che il trattato di Versailles avesse punito la Germania con misure eccessive e senza criterio; John Mainard Keynes aveva scritto un libro prevedendo che la richiesta di 6 milioni e mezzo di miliardi in riparazioni avrebbe causato caos in tutta Europa, e fu facile collegare queste previsioni alla Grande depressione in Inghilterra. Inoltre c'era una tale ostilità verso l'Unione Sovietica, Stalin, le sue purghe, che il comunismo veniva visto fra gli Inglesi come un pericolo molto maggiore del nazismo. Ultima, ma non minore delle ragioni che portarono all'appeasement, la dimensione imperiale britannica, allora in crisi, che spingeva a una politica estera che lasciasse le mani libere per combattere per l'Impero. Dunque l'appeasement era inevitabile? No. Basta la figura di Churchill, i suoi scritti e la sua definita repulsione per l'atteggiamento di Chamberlain, a portarci a conclusioni diverse. Nel dibattito storiografico, in cui sono coinvolti grandi nomi, come Allan Bullock, Hugh Trevor-Roper, Andreas Hillgruber e poi tutti i cosiddetti storici revisionisti (ma non nel senso popolare della revisione della Shoah!) come A.J.P. Taylor e infine una corrente giustificazionista, tutti si chiedono in definitiva quanto pianificatore e manipolatore sia stato Hitler e quanto ingenuo sia stato il suo interlocutore, o se la Storia non abbia messo un suo tocco di estemporaneità nella malvagia trama dell'uno e nella evidente viltà dell'altro; quanto colpevole sia stato Chamberlain, quanto egoista e immorale, e dall'altra parte quanto invece (e ormai molto storici lo sostengono), seguendo un strada inevitabile, abbia tentato di tenere il suo Paese impoverito e stanco fuori dal gioco, e abbia spinto Hitler in maniera abile e sofisticata a uno scontro definitivo con l'Unione Sovietica. Alla fine, la verità è che il coraggio morale di Winston Churchill, assieme all'unità del popolo inglese in guerra («Sulle spiagge, sulle landing grounds, nei campi, sui monti...»), l'aiuto della democrazia americana e il sacrificio delle rivolte antifasciste, ha fatto fuori la «pestilenza della tirannia nazista». Combattere era indispensabile. Oggi sappiamo, senza dubbio, che l'appeasement fu una fatale resa, che arrendersi fu una pessima idea, e quali che siano i motivi che l'hanno indotta; oggi sappiamo che la prevenzione e la dissuasione devono essere attuati anche a caro prezzo. La guerra è meglio che arrendersi, sperando nella pace, a chi vuole la guerra a tutti i costi e la farà, senza chiederci il permesso per quanto pacifisti ci dimostriamo.
8 settembre: fu il grande giorno dei vigliacchi e degli eroi. 75 anni fa l’annuncio dell’armistizio e la fuga del re, scrive Lanfranco Caminiti l'8 Settembre 2018 su "Il Dubbio". Mi chiedo talvolta dove sarei andato a finire l’ 8 settembre. Cosa avrei fatto? Ho così tanto rispetto per i partigiani, tutti, “azzurri”, azionisti e comunisti, che neppure riesco a ipotizzare se avrei preso la strada della montagna o della lotta clandestina, se avrei “resistito”. Forse avrei provato a tornare a casa o sarei rimasto dove mi trovavo, incerto, sbandato, imbucato o schierato magari per caso, improvvisamente orfano. Orfano di schieramenti. Orfano di Stato. Orfano di patria. Della Patria maiuscola e muscolare, di quella in divisa e berretto, di quella dove c’è chi comanda e chi ubbidisce, chi va al macello e chi prepara i piani per il macello. Quel giorno, Benedetto Croce nel suo diario scrisse: «Sono stato sveglio per alcune ore, tra le 2 e le 5, sempre fisso nel pensiero che tutto quanto le generazioni italiane avevano da un secolo a questa parte costruito politicamente, economicamente e moralmente è distrutto, irrimediabilmente» . Più o meno nelle stesse ore, Luigi Biraghi, classe 1914, tenente del 9° alpini, e che fu poi internato nei campi di concentramento tedeschi per non aver accettato di collaborare con i nazisti, scriveva nel suo diario: «Al mattino del 9 un sottufficiale e alcuni soldati tedeschi vengono all’accampamento e ci danno ordine di non uscire. Il Comandante del Battaglione non si oppone e ci invita ad attendere obbedendo. Più tardi il Colonnello Elefante ci ordina di deporre le armi. Obbediamo, ma poi, mentre siamo radunati in sede di Compagnia, non rendendoci conto della necessità di tale ordine, ci rechiamo al Comando di Battaglione per chiedere spiegazioni. La scena che costì ci si presenta agli occhi è quanto di più tragico e di più grottesco si possa immaginare. Giuseppe Elefante, in goffi abiti civili, pallido e tremante, tenta inutilmente di mettersi in testa un cappello basco per poi partire sulla motocicletta che lo attende e mettersi in salvo». Che due eserciti stranieri si siano combattuti su terre italiane portando strazi e lutti, mentre intanto ci si schierava di qua e di là, dividendosi per faglie che nessuna razionalità storica riesce a ricostruire – come poi forse accade sempre quando gli eventi precipitano in una guerra che diventa per forza di cose fratricida e perciò passionale – non è certo solo eredità dell’8 settembre. La guerra del Vespro, fra Angioini e Aragonesi, per dirne una, durò vent’anni, e sconvolse l’area del Mediterraneo tutto, oltre che i territori nostri. Mai però la frattura fra classi dirigenti – il cui unico obiettivo dopo l’armistizio era salvare la ghirba a qualunque costo – e popolo fu così evidente. Il popolo si divise, si frantumò, andò alla deriva, si arrese, lottò, salì in montagna, fu massacrato di terra, di cielo e di mare, reagì, si diede a ogni nefandezza, insomma visse e subì la guerra. Certo, non tutte le scelte furono uguali e non si possono sovrapporre o paragonare. I ceti dirigenti scapparono. Non era mai successo nelle innumerevoli guerre che si erano combattute sul nostro suolo: ogni ceto emergente si poneva alla testa d’una fazione contro un’altra; ogni principe, ogni barone, ogni prete, ogni chierico, radunava le sue forze, cercava alleanze e si lanciava contro il nemico, vero o supposto: si immolava, spesso, veniva martirizzato, spesso, o, altrettanto spesso, cambiava alleanze, e combatteva quella parte con cui prima aveva pattuito. Sempre esponendosi. L’otto settembre ci fu la fuga. La dismissione generale dei ceti dirigenti italiani. Della catena di comando, delle gerarchie, delle responsabilità, dei compiti istituzionali. Fu il presidente Ciampi – dopo le iniziative per i caduti di Cefalonia e altro – a spendersi tanto per stabilire l’immagine di un esercito che, nello sconquasso generale dopo l’annuncio dell’armistizio, mantenne o scoprì l’onore della Patria, salvandolo dalla vergogna. Un commendevole impegno. Allora, corroborato da un proliferare di trasmissioni televisive e pagine di quotidiani sulla stessa falsariga. Io non vorrei però che le buone intenzioni la scippassero a tutti, questa data, per consegnarla, trasfigurata e imbalsamata, “costituzionale”, alla Storia. Perché, è vero, andrebbe istituito, l’8 settembre, come festa nazionale. Ma a fianco di san Francesco e santa Caterina, san Gennaro e santa Chiara. Come queste, dovrebbe essere una data protettrice popolare, un sant’otto settembre, una ricorrenza in cui chiedere grazie e miracoli, portare a spalla una qualche “macchina”, appendere ex voto, fare pellegrinaggi e comitive. Non si scherza coi santi e in questo caso non si scherzerebbe neanche coi fanti. Perché l’8 settembre è la data dei chiunque, è la data di “quelli in basso” lasciati allo sbando e alla mercé degli eventi, mentre la “classe dirigente” fugge o decide di farsi proteggere da un qualche straniero. Così, all’inizio dell’estate, non appena gli Alleati cominciano a sbarcare e le bombe americane – che sono liberatrici, e non doveva essere facile capirlo lì per lì – cadono copiose il 19 luglio sul quartiere di san Lorenzo a Roma, devastandolo, sovrani e corte, governo, generali e burocrati “di rango” scappano portandosi dietro l’argenteria di famiglia o quanto hanno arraffato nel tempo e che riescono a stipare in fretta e furia tra i bagagli; mentre il lupo nazista, che non ha mai smesso di arrotare i denti, comincia a guardarci come il pranzo che ha ingrassato con lo sguardo e finalmente è da sbranare. Affonderà i denti, il 16 ottobre, nel ghetto. E poi ancora alle Fosse Ardeatine. E ovunque in Italia sarà l’orrore. Nel miserabile corteo di automobili che il 9 settembre portava i Savoia e la loro corte da Villa Ada verso Pescara non c’era neppure l’ambigua disperazione della fuga interrotta a Varennes di Luigi XVI e Maria Antonietta – l’evidenza del crollo d’un mondo millenario di certezze e un ultimo tentativo di preservarle, salvando la propria regale testa. Perché questo è in definitiva l’8 settembre: la vera metafora collettiva, il vero paradigma di questo paese, la vera festa nazionale, dove, quando c’è una emergenza, “in alto” ci si preoccupa del proprio culo e si arraffa e stipa in fretta e furia quanto si può e “in basso” si comincia a pregare e arrangiare senza sapere a che santo votarsi. Quando c’è una emergenza, una catastrofe, un fuggi fuggi. Ma in questo paese il fuggi fuggi, l’emergenza, la catastrofe è pane quotidiano. Ossessiva ricorrenza. Porta Pia, il Piave, Vittorio Veneto, quelle sono le date buone da mandare a memoria da ragazzini, quelle “patrie” dove aleggia una qualche Vittoria, una breccia da sfondare, una trincea tenuta sino allo spasimo, una linea nemica conquistata. Ma l’8 settembre, no, questa lasciatecela: quella è l’Italia della “fuga”, della rotta, del tutti a casa. La Caporetto della Politica, dello Stato, del Governo. Delle politiche, degli stati, dei governi. Un evento tanto italiano. Degli italiani “di rango”, però. Una tenue, e anche un po’ invereconda, giustificazione “storica” della fuga dei Savoia starebbe nella paura della ritorsione dei tedeschi verso la Real Casa dopo la dichiarazione dell’armistizio: salvando se stessi salvavano lo Stato, la possibilità dello Stato. Ma in realtà è agli italiani che sottrassero i loro corpi. E che i corpi degli italiani tutti diventassero carne da macello non li trattenne minimamente. Avessero preso sputi e pernacchie, i fuggiaschi, molte cose forse sarebbero cambiate, chissà. Tornarono, dopo il 25 aprile, quegli stessi che erano scappati e finirono alla testa delle istituzioni incertamente ricostruite (molti non si peritarono di chiedere gli stipendi arretrati). E anche tutto questo è tanto italiano. I costituzionalisti ci spiegano che la “sovranità” si fonda sui “due corpi del re”, uno è quello trasfigurato, sacrale, istituzionale, che incarna l’autorità e tiene insieme il popolo, e l’altro è quello carnale, reale, che si vede, pure da lontano ma che si sa presente. Quando muore, per preservarne la dignitas, si prepara un doppio cereo. Dev’essere una teoria universale, se Kurosawa ci ha fatto un film straordinario, Kagemusha, raccontando la storia del sosia d’un re che interpretò talmente bene la sostituzione di un corpo da convincersi di incarnare anche l’altro. Forse, i brigatisti che rapirono Moro dovevano pensarla così, ma si trovarono fra le mani il corpo d’un uomo ostinatamente umano, mentre il corpo dello Stato si ritrovava altrove e in fretta rinnegava pure quell’altro, dandogli del matto. I “corpi reali” sen fuggirono, senza lasciarci neppure un sosia. Senza dignitas. Noi non abbiamo mai avuto una patria, per secoli. Per secoli, abbiamo avuto monarchie territoriali, feudi e baronie, ducee e contee, ma mai una patria, mai una nazione. Almeno, non nel senso in cui la descrisse Ernest Renan, nella celebre conferenza, Che cos’è una nazione?, tenuta alla Sorbona l’ 11 marzo 1882: «La nazione è dunque una grande solidarietà, costituita dal sentimento dei sacrifici e da quelli che si è ancora disposti a compiere insieme. Presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto tangibile: il consenso, il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme. L’esistenza di una nazione è (mi si perdoni la metafora) un plebiscito di tutti i giorni». Ve lo immaginate un plebiscito, nel 1882, da tenere da Pinerolo a Partinico, da Alghero a Santa Maria di Leuca sulla unità della nazione italiana appena costituita e ancora fragile? L’otto settembre finisce l’Italia costruita nel Risorgimento. Forse a quell’Italia – «tutto quanto le generazioni italiane avevano da un secolo a questa parte costruito» – pensava Croce. Quell’Italia ancora fortemente improntata di intenzioni, volontà, visioni di ceti dirigenti, ma che era riuscita a intercettare secoli di desideri sociali. Il fascismo però – benché avesse voluto pretenziosamente richiamarsi a quella, intestandosi radici e filiazioni che nulla c’entravano – l’aveva già fatta a pezzi, l’Italia del Risorgimento, col suo impero del piffero, le sue leggi razziali, l’asservimento al tedesco. L’otto settembre in realtà chiude la parabola di Caporetto. Che era stato il primo segnale forte di un fallimento di classe dirigente – sarà solo un destino della Storia, che Badoglio fosse l’uomo di Caporetto e anche quello dell’8 settembre – e dello scollamento dei ceti popolari. A Caporetto furono i soldati a fuggire – stanchi dell’insipienza dei comandi, della follia dei loro ordini, dei massacri che continuavano senza senso. Solo le fucilazioni di massa dei carabinieri riporteranno l’ordine. Solo la violenza fascista riporterà l’ordine. L’otto settembre saranno “i comandi” a fuggire. Ma nessun carabiniere sparerà contro di loro.
L’Italia commissariata da Bruxelles vuole al governo PD con 5Stelle, scrive Ruggiero Capone il 14 Marzo 2018 su "ilpensieroforte.it". Il nemico si chiama Valdis Dombrovskis, è lui che parlottando con l’eurodeputata Barbara Spinelli avrebbe accennato all’ipotesi che l’Ue potrebbe mandare un paio di tedeschi (insieme ad un danese ed un olandese) “per gestire l’Italia”. Manovra che non escluderebbe l’entrata dei nuovi parlamentari nelle aule, ma solo per lavorare ad una nuova legge elettorale. “Riconosciamo che un eventuale governo ad interim potrebbe non avere la piena autorità di bilancio”, ha affermato il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, durante la conferenza stampa di presentazione dei rapporti sulle raccomandazioni specifiche per Paese nell’ambito del semestre europeo. Intanto l'Europa, influenzata dai democratici tedeschi, dice anche all’Italia di non fidarsi d’un governo senza Pd. E chiede che a governare l’Italia sia il Partito democratico d’appoggio al “5 Stelle”. La notizia ha raggiunto lo Stivale nel giorno della direzione del Pd, mentre venivano annunciate le dimissioni di Matteo Renzi da segretario. Di fatto qualcuno o qualcosa si muove a Bruxelles per agevolare i “tecnici” nella scalata del Pd. Perché ai tecnocrati Ue piacerebbe che a governare l’Italia ci sia un Luigi Di Maio manovrato dai tecnici democratici. Soprattutto l’Ue intende ostacolare qualsivoglia esecutivo a trazione Lega o ad egemonia berlusconiana. Dietro queste manovre, che mirano ad etero dirigere l’Italia da Bruxelles, c’è il vicepresidente del Verdi (il francese Pascal Durand) da sempre estimatore del “commissariamento totale dell’Italia”, e con la regia di Barbara Spinelli (gruppo Gue, Sinistra unitaria europea). Quello dell'europarlamentare italiana è un volto molto noto in Europa: Barbara Spinelli è la figlia di Altiero Spinelli, tra i padri fondatori dell'Unione europea. Stando ai rumors, appoggiano in Ue l’eventuale governo Pd-5 Stelle-LEU non solo esponenti dei Verdi e di Gue, ma anche i Socialisti e gli europarlamentari del gruppo Alde. Questi ultimi garantiscono che in un simile esecutivo entrerebbe dalla porta principale anche la Bonino col suo “Più Europa”. Questo gruppo di pressione europeo conta di raccogliere un numero elevato di adesioni, ed alla luce del voto che ha visto eleggere il grillino Fabio Massimo Castaldo alla vicepresidenza del Parlamento Europeo: e per poi fare pressione su un Pd (derenzizzato e tecnocratizzato a sinistra) per indurlo a riflettere sulla possibilità di un governo a guida M5S. Nel caso in cui la strada risultasse percorribile, la Commissione europea aprirebbe all’ipotesi di concedere più tempo all’Italia sulle misure di correzione agli squilibri, sia macroeconomici che dei conti. Dall’Ue non escludono nemmeno l’ipotesi d’ un governo ad interim per l’Italia. Tutta questa storia torna a dimostrarci quanto poco conti il volere degli italiani rispetto alle manovre dell’Ue. Così l’elettorato ha bocciato il Partito democratico, ma a Bruxelles c’è chi lo ha gradito “derenzizzato”, più “tecnocratizzato” ed alleato di Leu e Bonino, soprattutto buono per ammansire Di Maio e compari. In parole povere, in Ue gradiscono solo un governo di sinistra che tenga a stecchetto l’Italia. Una sinistra che sappia arginare sia l’antieuropeismo marxista che quello di matrice nazionalista. Insomma un governo che pratichi povertà diffusa e sostenibile, millantando crescita ed integrazione.
Matteo Salvini: "Basta andare a Bruxelles col cappello in mano", scrive il 25 Maggio 2018 "Libero Quotidiano". A mettere il sigillo su una giornata di tensione altissima sulla formazione del governo, poco prima delle 21 il leader della Lega Matteo Salvini ha postato un messaggio su Facebook stringatissimo. Tre parole: "Sono molto arrabbiato". Lo sfogo riguarda le resistenze del Quirinale (istigato dall'Europa) circa la nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia. Mezz'ora dopo, Luigi Di Maio ha messo un "like" al post dell'alleato, confermando così che l'intesa tra i due rimane forte (e che lo sfogo salviniano non era rivolto contro i grillini). Il messaggio del leader del carroccio era stato preceduto da una nota del partito che faceva il punto in modo inequivocabile sulla sua posizione nella contesa per la lista dei ministri: "La Lega non prende in giro gli italiani. Durante la campagna elettorale il Carroccio ha preso impegni precisi su tasse, Europa, giustizia e pensioni e non andrà a Bruxelles col cappello in mano". L'atteggiamento della Lega resterebbe comunque "costruttivo e responsabile".
Gunther Oettinger, il commissario Ue al Bilancio: "I mercati insegneranno agli italiani come si vota", scrive il 29 Maggio 2018 "Libero Quotidiano". Tedesco, iscritto al partito della Merkel e commissario Ue al Bilancio. Gunther Oettinger è come Babbo Natale per Lega e Movimento 5 Stelle. Il 55enne crucco oggi, nel corso di una intervista a una tv tedesca ha detto che "i mercati insegneranno all'Italia come si vota". Poi, non contento, ha anche retwittato la sua dichiarazione, che a quel punto ha varcato i confini della Germania ed è piovuta sul nostro Paese. Suscitando un'ondata di indignazione che ha riunito magicamente l'intero arco parlamentare Italiano, visto che il presidente del Pd Matteo Orfini ha dichiarato a caldo "dichiarazioni di Oettinger, stupide, ottuse e pericolose". E il reggente Maurizio Martina: " “Nessuno può dire agli italiani come votare. Meno che mai i mercati. Ci vuole rispetto per l'Italia”. Matteo Salvini su Twitter: "PAZZESCO, a Bruxelles sono senza vergogna. Il Commissario Europeo al Bilancio, il tedesco #Oettinger, dichiara “i mercati insegneranno agli italiani a votare per la cosa giusta”. Se non è una minaccia questa...Io non ho paura, #primagliitaliani!,". I 5 Stelle, da parte, loro, hanno chiesto l'intervento del presidente della Commissione Ue Jean Claude Junker: “Chiediamo al Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker di smentire immediatamente il Commissario Oettinger. Le sue parole sono di una gravità inaudita e sono la prova delle evidenti manipolazioni che la democrazia italiana ha subito negli ultimi giorni. Oettinger ha gettato la maschera e deve dimettersi!” scrive in una nota la capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo Laura Agea. “Gli europarlamentari del Pd e Forza Italia, per caso, condividono le parole di Oettinger? Il loro silenzio è imbarazzante e dimostra quanto poco sia a cuore l’Italia a questi due partiti”, conclude Agea. “Le parole del Commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger – i mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto – sono assurde e inaccettabili. I nostri cittadini sono in grado di decidere autonomamente come scegliere i propri rappresentanti, senza bisogno di suggerimenti. Le affermazioni del Commissario Ue rischiano di alimentare ulteriormente l’anti-europeismo. Non ne avevamo proprio bisogno”. Così in una nota Mariastella Gelmini di Forza Italia. Giusto qualche giorno fa, il quasi-ministro all'Economia Paolo Savona aveva paragonato la ricetta economico-politica della Germania al progetto del ministro dell'Economia del Terzo Reich. Parlando ad Agorà su La7, Savona aveva detto che "il modello di economia e di società dove l'economia determina la politica continua ad essere applicato. Il nazismo proponeva la Germania come paese d'ordine e proponeva che tutte le monete si dovessero comportare come il marco. Il resto dei paesi, Italia compresa, non doveva dedicarsi all'industria ma all'agricoltura, al turismo e al benessere anche dei tedeschi". Savona affermava che la differenza sta nel fatto che prima la Germania voleva imporsi "manu militari. Oggi hanno inventato un meccanismo che si chiama Europa unita e che porta gli stessi effetti. Un meccanismo nel quale i tedeschi hanno una posizione ideologica dominante".
"Dai mercati segnale agli italiani". È bufera sul commissario Ue. Tensioni in Borsa per l'incertezza politica. Lo spread sfonda i 320 punti. E il commissario tedesco minaccia gli italiani. Salvini: "Io non ho paura". E la Meloni: "Lo spazzeremo via chi vuole l'Italia in ginocchio", scrive Andrea Indini, Martedì 29/05/2018, su "Il Giornale". Ieri Piazza Affari ha bruciato tutti i guadagni accumulati nel 2018. Oggi, invece, abbiamo assistito all'irrefrenabile galoppare dello spread. Un'avanzata inesorabile che è arrivata a sfondare anche la soglia psicologica dei 300 punti base. A pesare è l'incertezza politica. In questo clima infuocato, a peggiorare la situazione ci ha pensato il commissario europeo al Bilancio, Gunther Oettinger. Che parlando col giornalista Bernd Thomas Riegert, che lo ha intervistato a Strasburgo per l'emittente DwNews, si è messo a bacchettare gli italiani dicendo che i mercati e lo spread gli avrebbe spinti a non votare più i populisti. L'incertezza politica comincia a pesare sulle aste di titoli di Stato, con il Tesoro costretto a pagare molto di più in un collocamento di Ctz e Btp indicizzati all'inflazione rispetto a un mese fa. Il differenziale sfiora livelli che non si vedevano dal novembre del 2013. E sale anche la febbre dei titoli biennali del Belpaese, che sul mercato secondario esplodono toccando picchi che si allineano a quando il presidente della Bce, Mario Draghi, si vide costretto a intervenire per dichiarare di essere pronto a fare tutto il necessario per difendere la moneta unica. Quei tempi sembrano ancora lontani, anche perché Francoforte contiene i danni con gli acquisti del quantitative easing, ma i mercati non escludono ipotesi di contagio europeo se la situazione dovesse peggiorare. "Nel caso in cui lo spread si posizionasse in modo convincente sopra quota 200 - si legge in un report di Goldman Sachs - allora i rischi sistemici sugli asset dell'Unione monetaria europea e anche al di là di essa, probabilmente, aumenterebbero". In questo clima difficile, è entrato a gamba tesa il tedesco Oettineger che ha bacchettato gli elettori italiani. Ad anticiparne i contenuti è stato il corrispondente di DwNews con un tweet: "I mercati e un outlook negativo insegneranno agli elettori italiani a non votare per i partiti populisti alle prossime elezioni. Questo avrà un ruolo nella campagna elettorale". Dopo qualche ora, però, Riegert si è "scusato" per aver "citato il commissario in modo errato". E nel farlo ha pubblicato le frasi integrali di Oettinger (leggile qui). Non c'è il verbo "insegnare", ma c'è "indurre". Cambia la forma, ma non la sostanza. Dichiarazioni comunque inaudite che hanno immediatamente scatenato una selva di polemiche da Bruxelles a Roma (guarda il video). Mentre il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha chiesto rispetto per gli elettori italiani, il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ha ricordato che "l'Italia non è una democrazia a sovranità limitata. Non sono i mercati a decidere il destino della Repubblica - ha, poi, sottolineato - ma i cittadini con il loro libero voto e le istituzioni che li rappresentano". "Non ne avevamo proprio bisogno", ha commentato Mariastella Gelmini accusando Oettinger di "alimentare ulteriormente l'anti-europeismo". In Italia il fronte si è dimostrato compatto, da destra a sinistra. "Ci trattano come una colonia estiva dove fare le vacanze", ha tuonato Luigi Di Maio. Tra i grillini c'è chi, come Andrea Colletti, che ha promesso di "fare di tutto per cacciare a calci nel sedere qualche commissario europeo. Da queste cose si vede chi è italiano e chi è anti-italiano". "Pazzesco, a Bruxelles sono senza vergogna!", ha fatto eco Matteo Salvini su Twitter. "Se non è una minaccia questa... io non ho paura". Giorgia Meloni, poi, ha promesso "ai tecnocrati di Bruxelles e ai signori dello spread" che gli italiani "che cosa è la democrazia. L'Italia è una Nazione sovrana: spazzeremo via chi ci vorrebbe in ginocchio". Anche il presidente del Pd Matteo Orfini ha bollato l'intervista come "offensiva, irricevibile e stupida". E sono già in molti a chiederne le dimissioni (guarda il video).
Oettinger, il kaiser delle gaffe che attacca l'Italia. Nel 2003 definì l'Italia ingovernabile. Poi attaccò il governo Berlusconi. Fu accusato di filonazismo, omofobia e razzismo. E non solo, scrive Domenico Ferrara, Martedì 29/05/2018, su "Il Giornale". Guenther Oettinger è il kaiser delle gaffe, delle polemiche e delle uscite a gamba tesa. La dichiarazione sui "mercati che insegneranno agli italiani come votare" è solo l'ultima di una serie di boutade o di frasi che hanno scatenato la bufera. Nel 2003 definì Bulgaria, Romania e Italia "intrinsecamente ingovernabili".
Nel 2007, quando era presidente del governo regionale in Baden Wuerttemberg, Oettinger venne accusato di filonazismo perché durante l'orazione funebre per Hans Filbinger, che fu giudice militare durante il Reich, non ricordò in alcun modo la attività da questi avuta sotto il regime di Hitler. Si mosse persino la Merkel che biasimò il suo collega di partito costringendolo alle scuse. Nel 2010 Oettinger finì poi sotto accusa a Bruxelles per la sua partecipazione a un think tank noto per posizioni antisemite. Nel 2011 disse alla Bild che le bandiere dei paesi sotto procedura per deficit eccessivo, tra cui l'Italia, avrebbero dovuto essere esposte a mezz'asta davanti alle sedi delle istituzioni europee. "Questa sarebbe certamente una misura simbolica, ma avrebbe un effetto dissuasivo'', affermò il tedesco, proponendo inoltre che questi paesi rinunciassero temporaneamente alla loro sovranità in materia di bilancio per trasferirla all'Unione europea. "La misura sarebbe una vera provocazione per ciascuno di questi governi e frenerebbe tutti i paesi che si indebitano troppo'', motivò il commissario Ue. Una sorta di gogna insomma, che scatenò un putiferio generale e che terminò con una telefonata di fuoco di Jean Claude Juncker e con le scuse di Oettinger. Nello stesso anno, Oettinger criticò duramente il governo italiano per come aveva gestito la crisi del debito nazionale. ''L'Italia ha reagito miseramente alla crisi", aveva detto Oettinger. Che poi aveva aggiunto: "Approvando e poi modificando la manovra aggiuntiva, dopo le proteste, il governo Berlusconi ha agito in maniera irresponsabile". Le ingerenze nei confronti di altri paesi hanno preso di mira anche la Grecia e persino la Francia. "L'Euro adesso è ancora più a rischio. Il premier Giorgos Papandreou ha messo la moneta unica in una situazione di pericolo ancora più grande. Se i greci voteranno no le conseguenze saranno imprevedibili. I membri più deboli dell'Unione europea sono tenuti alla chiarezza e fiducia", disse nel 2011. Nel 2014 invece attaccò la Francia accusandola di essere "un paese recidivo" sul deficit, un paese che andrebbe trattato "con rigore". Due anni dopo scoppiò la bufera con Varsavia. L'allora commissario Ue al digitale Oettinger annunciò di voler proporre alla Commissione europea di mettere la Polonia "sotto sorveglianza" dopo la nuova legge approvata a fine 2015 dal parlamento che dava il controllo al governo delle stazioni radiotelevisive pubbliche. Un altro caos avvenne a causa delle dichiarazioni sulla Vallonia, definita "una minuscola regione governata da un pugno di comunisti che blocca l'Europa", sui membri della delegazione cinese in visita alle istituzioni Ue, apostrofati come "quelli con gli occhi a mandorla" e sulle nozze tra omosessuali. Nel novero delle polemiche poi va inserita anche quella per aver usato l'aereo privato dell'uomo d'affari tedesco Klaus Mangold per volare da Bruxelles a Budapest, dove era atteso per cena dal premier ungherese Viktor Orban; quella di essere finito tra le carte di una inchiesta contro la mafia perché conosceva uno degli arrestati nell'ambito dell'Operazione Stige e infine quella di aver avuto la patente di guida ritirata nel 1991, quando aveva 38 anni, dopo essere stato trovato al volante con più alcol nel sangue di quanto permettono le leggi tedesche.
Cosa è successo con la frase del commissario Ue Oettinger che sta scatenando le polemiche. «I mercati insegneranno agli italiani a votare» è un'affermazione che l'esponente europeo non ha mai pronunciato. Si tratta di una errata sintesi del giornalista tedesco che lo ha ascoltato. Ma nel frattempo la bagarre tra chi condanna è già partita, scrive Mauro Munafò il 29 maggio 2018 su "L'Espresso". Il commissario Ue Günther Oettinger non ha mai detto che "i mercati insegneranno all'Italia a votare". Questa frase, che sta scatenando le polemiche e le reazioni di tutti gli schieramenti politici italiani con tanto di richieste di dimissioni, è in realtà solo la sintesi del giornalista che lo ha intervistato e che ha riportato questa frase su Twitter. Il corrispondente dal Belgio Bernd Thomas Riegert, dell'emittente tedesca Dw, ha infatti in un primo tweet scritto in inglese che l'esponente europeo in un'intervista che sarebbe andata in onda qualche ora dopo, gli aveva detto, con tanto di virgolette, che "i mercati avrebbero insegnato a votare agli italiani". Un'affermazione pesantissima che ha subito scatenato le reazioni indignate di tutti gli schieramenti politici italiani e non solo. Qualche minuto dopo però il giornalista ha cancellato il tweet per riportarne uno quasi identico da cui erano però sparite le virgolette: nel gergo giornalistico significa che quella frase è in realtà una sintesi del giornalista stesso. Una volta esplosa la polemica, l'emittente ha messo online i dieci minuti di intervista, da cui si possono estrapolare le frasi corrette, poi twittate dallo stesso Riegert anche in inglese. La frase davvero pronunciata da Oettinger è infatti la seguente, di sicuro meno forte rispetto a quella riportata inizialmente: «La mia preoccupazione e aspettativa è che gli sviluppi dei mercati, delle obbligazioni e dell'economia italiana delle prossime settimane saranno così ampie che potrebbero diventare un segnale che indichi agli elettori, dopotutto, di non votare per i populisti a destra e sinistra» a cui ha poi aggiunto: «Posso solo sperare che questo elemento possa avere un ruolo nella campagna elettorale e inviare un segnale per non consegnare la responsabilità di governare ai populisti di destra e sinistra». Un'affermazione in ogni caso discutibile, che ha infatti portato nella sera ha portato il Commissario a scusarsi con gli elettori italiani.
«Se la persona sbagliata dice la cosa giusta»: lo Spiegel difende la frase di Oettinger. Il settimanale tedesco ammette il passato da gaffeur del commissario Ue al Bilancio, ma ne giustifica le affermazioni sull'Italia. Intanto su alcuni giornali internazionali si ragiona sui rischi di nuove elezioni nel nostro Paese, scrive Nicolò Canonico il 30 maggio 2018 su "L'Espresso". Critiche sempre più forti. Lo stato di incertezza che regna in questo momento nella politica italiana sta provocando malumori anche tra i principali giornali internazionali. In particolare il settimanale tedesco Der Spiegel, già durissimo nei giorni scorsi nei confronti del nostro Paese, rincara la dose: «Se la persona sbagliata dice la cosa giusta» è il titolo dell'editoriale del corrispondente da Bruxelles Markus Becker. L'uomo sbagliato è Günther Oettinger, il commissario europeo al Bilancio; la cosa giusta è la frase che ha pronunciato ieri durante un'intervista (riassunta in modo sbagliato dal giornalista della Deutsche Welle), che ha scatenato un putiferio in Italia. Salvini e Di Maio hanno risposto offesi: «Pazzesco, a Bruxelles non conoscono vergogna!» aveva twittato il segretario della Lega. «Questa gente tratta l'Italia come una colonia estiva dove venire in vacanza» gli aveva fatto eco il leader pentastellato. Ma allo Spiegel non ci stanno e rispondono per le rime: «Pazzesco? Vergogna? Colonia estiva? Questa è la tattica che i populisti amano usare: trasformare la verità nel suo opposto». E ancora, sulla frase incriminata: «Niente di quello che Oettinger ha detto è sbagliato. Né che i mercati potrebbero reagire infelicemente alla politica fiscale ed economica irresponsabile, né che si dovrebbe sperare in una certa comprensione degli elettori di quanto sta avvenendo». Per Becker c'è un solo problema: la frase l'ha pronunciata un noto gaffeur e questo non farà altro che «aiutare i nemici della verità». Voci perplesse iniziano a farsi sentire anche oltreoceano. In un'editoriale comparso sul sito del New York Times, la scelta di Mattarella di bloccare il governo Lega-5 Stelle è una «scommessa audace», che però non ha calmato gli investitori internazionali: «I rendimenti delle obbligazioni bancarie italiane sono saliti bruscamente per i timori di un'altra elezione, che potrebbe potenzialmente dare una maggiore forza ai partiti populisti e costituire una nuova minaccia di abbandono dell'euro da parte dell'Italia». A New York si augurano che un eventuale ritorno alle urne possa trasformarsi invece in un'occasione: «La scelta del presidente Mattarella, almeno, offre agli elettori italiani una seconda possibilità di valutare le loro opzioni dopo aver intravisto cosa potrebbero significare le loro precedenti scelte». Una posizione, quella del quotidiano newyorkese, che assomiglia vagamente alla frase di Oettinger. Il Guardian si chiede se l'Italia, il nuovo laboratorio politico d'Europa, sia «un Paese dove la democrazia liberale cambia tonalità e sprofonda sotto l'orizzonte». Questo perché «hanno vinto non uno, ma due populismi diversi» che sono stati in grado di «colpire duramente i poteri costituzionali del presidente Mattarella e questo mostra quanto siano determinati a rovesciare l'assetto istituzionale del Paese».
«Europea e anti populista» Le Monde fa lo spot a Milano. Il settimanale francese loda la «capitale economica» Gli assessori rilanciano la pagina ma il web si divide, scrive Chiara Campo, Giovedì 31/05/2018, su "Il Giornale". Vignette e affondi internazionali. L'Italia che dal 4 marzo viaggia sulle montagne russe per la formazione di un governo a lungo o brevissimo periodo è presa di mira dalla stampa estera. «Sprofonda nel caos politico» secondo il francese Le Monde, vive «i tempi più drammatici degli ultimi trent'anni» per la Sueddutsche Zeitung, fino al tedesco Der Spiegel che giorni fa ha definito gli italiani «scrocconi aggressivi» («i barboni almeno dicono grazie quando gli si dà qualcosa» ha scritto) sollevando una forte reazione polemica. In controtendenza ieri sempre il settimanale francese Le Monde ha dedicato un'intera pagina a quella che sembra ormai una «città-Stato» che poco c'entra col Belpaese. Titolo: «Milano città aperta». Sottotitolo: «La capitale economica italiana resiste all'ascesa del populismo». L'immagine plastica della «Milano europea» è il quartiere degli affari a Porta Nuova, con i grattacieli che la avvicinano alla Potsdamer Platz di Berlino con un mix di tecnologia, terrazze, locali. Le Monde dedica ampio spazio all'Università Bocconi, «simbolo dell'apertura milanese» dove si formano 14mila studenti in economia, finanza o scienze politiche e dove sta crescendo il grande campus «all'americana» che avrà anche un centro sportivo con piscina olimpionica. Sottolinea che la Bocconi è «presieduta da Mario Monti», che è stato «membro della Commissione Europea» e presidente del Consiglio tra 2011 e 2013 dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi. E tra i bocconiani illustri cita «il sindaco Beppe Sala che è stato anche commissario Expo 2015». Cita i «corsi in inglese per attirare studenti stranieri, già il 20% degli iscritti» e i professori che «arrivano da ogni Paese». Se l'attuale crisi politica inquieta i suoi professori, «perchè temono un'ondata di speculazione sul debito, l'istituzione mostra ottimismo». Il Gianmario Verona ammette che «la situazione politica è confusa» ma «Milano è sempre stata un città un pò più dinamica, rivolta al futuro, e noi pure». Gli assessori comunali rilanciano su Facebook lo «spot» francese: «Martedì gli 8 sindaci di Milano in vita, da Tognoli a Sala, hanno firmato un appello sul ruolo di Milano a fianco delle istituzioni repubblicane e dell'Europa. Oggi questo ruolo di Milano città aperta, europea, che resiste ai populismi viene riconosciuto da una grande paginata de Le Monde» commenta il Pd Pierfrancesco Maran, rilanciato dal collega Pierfrancesco Majorino. Ma il popolo del web si divide: «Attenti perchè già 5 municipi su 9 sono passati al centrodestra e al prossimo giro non basterà più vincere all'interno della Cerchia per farsi riconfermare. E vedendo come vengono trattate certe questioni in periferia, cosa di cui Le Monde ovviamente non si occupa, non sarei così sicuro del fatto che un Sala-bis sia così scontato. Purtroppo (per gli amministratori) non esiste solo la città-vetrina, ma anche la città abitata» scrive Andrea. E per Lorenzo «se Milano non sta molto, ma molto più attenta ad essere aperta al prossimo giro di elezioni diventerà, come viene detto in modo dispregiativo, stra-populista».
Ora è chiaro: l’Europa vuole massacrare l’Italia per annientare Lega e 5 Stelle, scrive il 29 maggio 2018 Marcello Foa su "Il Giornale". A questo punto il disegno è chiaro: l’establishment europeo ha deciso di impedire ad ogni costo la nascita di un governo formato da Lega e 5 Stelle. E ha scelto la strada dell’oppressione. Riepiloghiamo: Mattarella nega al governo Conte il diritto di presentarsi alle Camere sebbene abbia la maggioranza, per le ragioni che ben conosciamo. Ufficialmente perché la persona di Savona non è gradita, in realtà, come spiega l’ex ministro delle Finanze Padoan, “il problema non è Savona, ma le idee di Lega e M5s sull’Europa”. Quella di Mattarella sembra una scelta azzardata, perché, come osservano in molti e come confermato dai sondaggi, alle prossime elezioni Salvini e Di Maio potrebbero ottenere ognuno il 30% dei consensi e dunque ripresentarsi al Quirinale molto più forti di oggi. Davvero strana è anche la nomina di Cottarelli: perché varare un governo tecnico che non ha una maggioranza? Non sarebbe stato più logico confermare Gentiloni per il disbrigo degli affari correnti? Ora, invece, appare tutto terribilmente chiaro e a svelare il gioco è il commissario europeo al Bilancio Oettinger, che, come capita a molti tedeschi di potere, non riesce a trattenere la propria arroganza, e dichiara pubblicamente: “I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto”. E allora tutto diventa chiaro: l’establishment europeista ha deciso di spezzare le reni all’Italia, come ha già fatto con la Grecia. Lo scenario che si profila è il seguente: scatenare una crisi paurosa del debito pubblico italiano, spingendo lo spread a livelli mai visti, provocare il panico, fino al momento in cui l’Italia verrà commissariata e Mattarella invocherà per il bene supremo del Paese la fiducia a Cottarelli (già in carica) e/o l’introduzione di misure straordinarie, come il rinvio sine die delle elezioni e la conseguente distruzione della reputazione e della popolarità di Salvini e di Di Maio, che verranno indicati come i responsabili di questa crisi. Se il piano avrà successo, servirà da monito a tutti i Paesi europei dove i movimenti “populisti” sono in ascesa e comporterà la definitiva sottomissione dei popoli europei alle oligarchie europee. Come dire: colpirne uno per educarne cento. Perché queste sono le logiche, indegne e autoritarie. Opporsi è un dovere civico e morale. Il piano deve fallire.
Germania, lo schifo contro Matteo Salvini e Luigi Di Maio: come insultano loro e l'Italia, scrive il 25 Maggio 2018 "Libero Quotidiano". Tedeschi padroni d'Italia. Torna l'antipatica abitudine di Berlino di impartirci lezioni infarcite di insulti. Dopo Silvio Berlusconi, nel mirino ci finiscono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il settimanale Der Spiegel in un editoriale a firma di Jan Fleischhauer accusa il nostro Paese di voler "scroccare" dal resto dei partner dell'Unione europea. "Come si dovrebbe definire il comportamento di un Paese che prima chiede qualcosa per lasciarsi finanziare il suo proverbiale dolce far niente, e poi minaccia coloro che dovrebbero pagare se questi insistono sul regolamento dei debiti? Chiedere l'elemosina sarebbe un concetto sbagliato. I mendicanti almeno dicono grazie, quando gli si dà qualcosa". E la colpa sarebbe anche di Mario Draghi, presidente della Bce che "ridicolizzava i timori dei tedeschi mentre svalutava le loro assicurazioni sulla vita e i loro risparmi". Anche il settimanale della Frankfurter Allgemeine schiaffa in copertina la vignetta di un'Ape-car italiana (marchiata M5s-Lega) lanciata a rotta di collo giù da un burrone. Alla guida un uomo fa il gesto dell'ombrello. Titolo? "Mamma mia!". E Conte? Viene ritratto come Arlecchino, "servitore di due padroni". Di Maio e Salvini, ovviamente. E c'è anche un'altra emozionante vignetta: Di Maio e Salvini dottori. Nomi? Peste e colera.
Il New York Times all'attacco: "In Italia governo schifoso". Ancora un attacco dalla stampa estera a M5s e Lega: "Sono un branco di miserabili sollevati dalla marea antiliberale", scrive Luca Romano, Martedì 05/06/2018, su "Il Giornale". Il New York Times torna a mettere nel mirino il governo italiano. Questa volta uno degli editorialisti del quotidiano statunitense di fatto va oltre la normale critica e dialettica che può riguardare il dibattito politico. Si passa direttamente agli insulti. Si può pensare bene o male di questo governo gialloverde che ha preso il via qualche giorno fa, ma di certo gli elettori vanno rispettati e soprattutto va rispettato un Paese democratico qual è fino a prova contraria l'Italia. Ma Roger Cohen bolla il nostro esecutivo come "terribile, schifoso". Parole che pesano. Poi aggiunge: "Lega e Movimento Cinque Stelle mettono insieme bigottismo e incompetenza a un livello inusitato. Sono un branco di miserabili sollevati dalla marea antiliberale" (leggi qui l'articolo del New York Times). Insomma nel quadro internazionale non c'è ancora tregua. Dopo l'ondata di insulti arrivati dalla Germania adesso arrivano anche quelli dagli Stati Uniti. Infine Cohen esprime un giudizio forte anche sul modo di fare politica di M5s e Lega: l'uso dei social. "Non vedo niente nella Lega o nel Movimento 5 stelle diffuso via Internet che non mi disgusti". Opinione rispettabile. Ma di certo nessuno in Italia si sogna di definire "schifoso" un governo di un Paese sovrano.
Maledetti italiani! Scrive Giampaolo Rossi il 22 maggio 2018 su "Il Giornale".
I MAESTRINI. Niente da fare è più forte di loro. Non riescono proprio a togliersi quel misto di vanità e arroganza con cui sono soliti occuparsi degli affari degli altri. Quando si tratta dell’Italia poi, il narcisismo ed il senso di superiorità dei governanti francesi e tedeschi travalica le Alpi e dilaga nella nostra politica come un’orda di Galli e di Ostrogoti in preda a frenesia predatoria. È come se l’Italia fosse roba loro; o comunque una provincia, una terra politicamente da saccheggiare o peggio ancora da “educare”, perché il loro modo di rapportarsi a noi ha sempre qualcosa di pedagogico; come i maestrini che devono richiamare all’ordine i loro alunni somari. Simbolo iconico di questa arroganza fu lo scambio di sorrisetti tra Sarkozy e la Merkel contro Berlusconi nel 2011; un’ironia beffarda, oltraggiosa nei confronti non solo di un Primo Ministro che cercava di difendere gli interessi del suo Paese, ma nei confronti di un’intera nazione che quel Premier rappresentava. Quei sorrisetti furono una sorta di segnale convenuto con il quale aprire la campagna d’Italia per lo screditamento del legittimo governo italiano eletto democraticamente ma ostile alle politiche di austerity che Parigi e Berlino volevano imporre; e con la complicità della tecno-finanza europea, dei media e di una banda di sicari italiani guidati da Giorgio Napolitano riuscirono ad imporre Mario Monti, il tecnocrate perfetto, l’uomo che avrebbe ammansito le velleità sovrane dell’Italia. Ora che il nostro Paese torna ad esprimere un Governo almeno apparentemente non espressione dell’élite eurocratica, ecco che rispunta il vizietto franco-tedesco d’interferire nelle nostre scelte; addirittura prima ancora che questo Governo si formi e si insedi. La recente dichiarazione del Ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, non è solo un’analisi preoccupata sul futuro dell’eurozona a causa del nuovo governo Lega/M5S (cosa che dal suo punto di vista di europeista compulsivo è legittima); ma è un vero e proprio pizzino indirizzato alla nostra sovranità: “Tutti devono capire in Italia che il futuro dell’Italia è in Europa e da nessun’altra parte, e perché questo futuro sia in Europa ci sono regole da rispettare”. Praticamente un ministro francese ci viene a dire cosa dobbiamo capire noi. Dando per scontato che lui abbia capito tutto. Ora che in Italia torna un Governo apparentemente non espressione dell’élite eurocratica, rispunta il vizietto franco-tedesco d’interferire nelle nostre scelte. Il messaggio è chiaro: cari italiani scordatevi qualsiasi retorica sulla sovranità; non avete scampo, o vi sottomettete a queste regole che poi sono quelle imposte da noi e dalla Germania, oppure la pagherete. Al francese ha fatto eco il tedesco. In assenza del simpaticone di Schulz, il “Kapo” socialista che per anni ha dato lezioni non richieste all’Italia (salvo poi scomparire dalla scena politica), è arrivato tale Weber, il Kapetto popolare (cioè del PPE) ad ammonirci: “State giocando col fuoco”. E giù la solita retorica sulle regole che devono essere rispettate, che non possono essere cambiate perché altrimenti crolla l’eurozona e con essa l’Europa e con essa il mondo e persino il Sistema solare potrebbe uscirne danneggiato. Poco importa se queste regole spesso valgono per qualcuno e non per altri.
FURBETTI FRANCESI. Nel gennaio scorso il francese Pierre Moscovici, Commissario Ue agli Affari economici, è entrato a gamba tesa nella campagna elettorale italiana attaccando l’ipotesi di ridiscutere il tetto del 3% nel rapporto Deficit/Pil ipotizzata dai 5Stelle e dai partiti sovranisti (Lega e Fdi) orientati a rivedere il Trattato di Maastricht: “un controsenso assoluto” l’ha definito il custode dell’ortodossia europeista. In realtà un controsenso relativo, perché se gli italiani lo ipotizzano sono colpevoli di leso-europeismo, se i francesi lo applicano nessuno dice niente. Dal 2011 al 2016 la Francia ha sistematicamente violato il tetto del 3% nel rapporto Deficit/Pil; l’Italia, dal 2012 lo ha sempre rispettato. Ed anche se nel 2017 il governo di Parigi ha annunciato trionfalmente la discesa sotto il limite consentito (più per trovate contabili che per altro), secondo le stime quinquennali del FMI, il dato è destinato ad aumentare fino al 2022. Inoltre, come ha ricordato Alberto Bagnai, economista ed oggi parlamentare della Lega, al pari dell’Italia anche la Francia ha aumentato il debito pubblico infrangendo un’altra regola di Maastricht secondo cui lo sforamento del rapporto Debito/Pil poteva essere tollerato solo a fronte ad un abbassamento del debito pubblico. Se si guarda il Debito aggregato (Stato ma anche imprese e famiglie), l’Italia è tra le nazioni virtuose, meglio della Francia. D’altronde anche quella del Debito è una narrazione da cambiare. Come ha segnalato sul Sole 24Ore Vito Lops, uno dei più seri giornalisti economici italiani, se si guarda il Debito Pubblico l’Italia è il Paese più a rischio dell’eurozona dopo la Grecia. Ma se si amplia lo sguardo al debito aggregato, ovvero non solo quello dello Stato ma quello di tutti gli attori economici (anche imprese, banche e famiglie) l’Italia si rivela “un Paese nella media, senza grossi problemi di debito”. Ed indovinate un po’ quale diventa il Paese più esposto finanziariamente? La Francia appunto, che sommando esposizione di società, banche e famiglie “viaggia con una leva enorme, che supera il 400% del Pil, pari a 9mila miliardi di debiti cumulati” a fronte del 350% dell’Italia e del 270% della Germania.
DINAMITARDI TEDESCHI. D’altronde quanto sia necessario rivedere Maastricht e i criteri di valutazione delle economie lo dimostra un altro dato inquietante che riguarda la Germania e i paesi apparentemente più virtuosi: le cosiddette “contingent liabilities”, cioè le passività potenziali che i governi accumulano sotto forma di garanzie poste sui debiti contratti da organismi controllati, istituzioni pubbliche o finanziarie. Vere e proprie “bombe ad orologeria” di indebitamenti che però non vengono calcolati nei bilanci ufficiali degli Stati ma che, qualora le cose andassero male, si scaricherebbero sui cittadini. Cosa succederebbe se l’Italia, paese fondatore dell’Ue e terza economia dell’euro zona decidesse di non abbassare più la testa ai diktat di Berlino, Parigi e Bruxelles? Secondo gli ultimi dati Eurostat relativi al 2016, le garanzie prestate dalla Germania ammontano a quasi 450 miliardi di euro, oltre il 14% del Pil; la Francia ha garanzie per 116 miliardi (5,2% del Pil) e l’Italia solo per 41 miliardi (2,4% del Pil). In altre parole noi italiani mostriamo una maggiore oculatezza nella gestione del debito. La cosa incredibile è che se si sommasse il Debito ufficiale con questo Debito fuori bilancio (ma reale) si scoprirebbe che la tanto criticata Italia ha un debito complessivo di poco superiore a quello tedesco e l’obbligo di riduzione imposto alla nostra economia scenderebbe di oltre il 60%.
COSA SPAVENTA DELL’ITALIA? In realtà la paura che ora aleggia nei circoli europei non è legata all’azione di un Esecutivo italiano che ancora deve iniziare a governare (perché i governi si giudicano dal loro operato); ma dal timore che l’Italia inizi a non rispondere più agli ordini dei suoi padroni. In questi anni, l’operazione svuotamento della sovranità ha garantito all’Europa un’Italia docile e remissiva, con governi sottomessi ai placet dell’eurocrazia: Presidenti del Consiglio (da Monti a Renzi fino a Gentiloni) e leadership italiane composte da servizievoli esecutori di decisioni altrui; Presidenti della Repubblica (da Napolitano all’attuale Mattarella) sfacciatamente orientati a rifiutare quel principio di sovranità nazionale fondamento della nostra Costituzione che loro dovrebbero difendere. Che cosa potrebbe succedere se ad un certo punto l’Italia, paese fondatore dell’UE e terza economia dell’eurozona, dovesse decidere di non abbassare più la testa ai diktat di Berlino, Parigi, Francoforte o Bruxelles? Cosa accadrebbe se un nuovo governo a Roma dovesse iniziare a battere i pugni sul tavolo e a reclamare pezzi di sovranità; a chiedere di ridiscutere regole e trattati, a rivendicare ruolo internazionale e ad imporre il proprio interesse nazionale prioritario rispetto alle astratte leggi comunitarie che penalizzano i suoi cittadini e la sua economia? Ecco, è questo il vero pericolo di un governo sovranista e populista. Ed ecco perché siamo tornati ad essere i “Maledetti italiani!”
Italian connections, scrive Sebastiano Caputo il 22 maggio 2018 su "Il Giornale". E’ quasi fatta, Lega e Movimento 5 Stelle potrebbero finalmente raggiungere l’accordo di governo nei prossimi giorni. Non poteva andare meglio per il popolo italiano che il 4 marzo aveva espresso senza mezzi termini – e lo dimostrano il consenso ricevuto dai loro rispettivi elettori nelle votazioni del programma e i risultati in Valle d’Aosta – la volontà di affossare il sistema della continuità. Si è conclusa una prima fase – quella del riavvicinamento, impensabile per gli addetti ai lavori molto poco attenti alle meccaniche della metapolitica, tra i due partiti anti-establishment – e ora inizia la seconda, molto più delicata, perché deve fare i conti con le geometrie internazionali. Siamo un Paese a sovranità limitata e come tale dobbiamo muoverci in funzione degli umori della power elite. Occorre innanzitutto ricordare che l’attuale contesto geopolitico e strategico globale vede l’amministrazione Usa dichiarare una guerra economica e commerciale all’Unione Europa (dazi su alluminio e acciaio, sanzioni alla Russia e rottura dell’accordo sul nucleare con l’Iran) per far girare l’economia americana e addomesticare la Germania, unica profittatrice del sistema eurocentrico, che più di tutti intrattiene rapporti decisivi e costruttivi con Mosca e Teheran tanto che Angela Merkel, accolta pochi giorni fa con un mazzo di fiori a Sochi dal presidente Vladimir Putin, ha detto che sulle questioni internazionali le loro posizioni coincidono e che il Nord Stream 2, il gasdotto che passa sotto il baltico, si farà. E non è un caso infatti che proprio Donald Trump abbia lavorato negli ultimi mesi sul presidente francese Emmanuel Macron in chiave anti-tedesca dopo che Berlino aveva persino annunciato che non si sarebbe allineata ai bombardamenti in Siria. Chi infatti oggi si oppone al governo Lega-M5S sono tutti i mezzi di informazione occidentale che durante la campagna elettorale statunitense tifavano per Hillary Clinton – dal Financial Times al Washington Post, passando per il New York Times che ora attacca Giuseppe Conte – e ovviamente i mercati europei, terrorizzati dalle spinte sovraniste degli economisti italiani. Fino a qui tutto da copione, potremmo dire persino “di buon auspicio”, il problema però è che dietro le preoccupazioni dell’Unione Europea non ci sono Luigi di Maio e Matteo Salvini ma gli americani che ora vogliono addomesticare la coalizione giallo-verde favorendo personalità che gli forniscono tutta una serie di “garanzie atlantiche” (vedi l’idea di Giampiero Massolo agli Esteri e di Giancarlo Giorgetti come Sottosegretario alla presidenza del Consiglio) fino a concedere un critico dell’Euro come Paolo Savona all’Economia proprio per mettere sotto pressione la Germania (se consideriamo che la moneta unica è sempre stata un marco tedesco travestito). La visita prevista la prossima settimana in Italia di Steve Bannon – dopo aver convinto Matteo Salvini ad abbandonare Silvio Berlusconi nel nome del popolo contro l’élite sembra esserci la volontà di testare per conto dei think tank statunitensi i movimenti populisti al governo – potrebbe ora invitare il leader della Lega a mettere l’anti-europeismo in cima alla lista delle priorità così da calmare il desiderio di riavvicinamento con la Russia. L’Italia si ritrova dunque stretta nella morsa di una Germania che pur ricollocandosi nel mappamondo euroasiatico e mediterraneo persegue la crescita economica sulla pelle degli altri Stati dell’Unione, e gli Stati Uniti che invece vogliono utilizzare la coalizione Lega-M5S in funzione anti-tedesca e pro-mercato americano. C’è solo un modo per uscirne: sfruttare il conflitto di interessi tra Usa e Ue, insieme alle concessioni che gli uni e gli altri lasciano in questo preciso momento storico, per sganciare progressivamente l’Italia dall’alleanza atlantica e ripensare allora stesso tempo la moneta unica. Facile a dirsi, direte voi, e avete ragione, intanto è bene iniziare a pensarlo.
Governo, nuovo attacco tedesco: "Ecco lo scenario dell'orrore". I timori dei quotidiani tedeschi sul governo Conte: "L'Italia può cambiare l'intera Ue". Poi l'affondo al "pericolo italiano": "Porterà a euro debole e minore crescita", scrive Giuseppe De Lorenzo, Domenica 27/05/2018, su "Il Giornale". Non c'è due senza tre. In Germania media e opinionisti sono sinceramente preoccupati da Roma. E i timori sono tali da trascinarli in una sorta di gara a dire la propria al Belpaese. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi: si va dagli italiani "scrocconi", fino a Conte "burattino", passando per Salvini e Di Maio paragonati alla peste. L'ultimo affondo, in ordine di tempo, arriva (di nuovo) dal Frankfurter Algemeine Zeitung. Il più importante quotidiano tedesco, che due giorni fa aveva rappresentato con una copertina al vetriolo la situazione politica nostrana, oggi apre la sua edizione online con un'analisi altrettanto dura. Il titolo è eloquente: il pericolo italiano. I due autori, Ralph Bollmann e Dyrk Scherff, delineano due ipotesi nel caso in cui Mattarella dovesse capitolare a dare il via libera a Conte: parlano di un possibile "scenario dell'orrore" e di una più mite, ma comunque "pericolosa", prospettiva di instabilità europea provocata dall'Italia. Ad andare di traverso alla Faz sono le proposte scritte nel contratto firmato da Di Maio e Salvini: dal reddito di cittadinanza all'addio alla Fornero, passando dalla paventata "drastica" riduzione delle tasse. L'Italia, scrive il quotidiano, "pensa addirittura all'introduzione di una valuta parallela. Se tutto ciò fosse vero, il debito annuale del paese raddoppierà o triplicherà. L'Italia romperebbe tutti gli accordi europei e porterebbe l'unione monetaria in una nuova crisi". Per non parlare dell'idea di piazzare un ministro anti euro, Paolo Savona, all'Economia. "Lo scenario dell'orrore - si legge nell'articolo della Faz - è qualcosa di simile: il presidente Sergio Mattarella conferma la prossima settimana il governo, che poi ottiene il voto di fiducia in entrambe le camere del Parlamento" e inizia a lavorare. Così "le leggi sulla spesa eccessiva e sul deficit saranno superate rapidamente. Il deficit nel bilancio dello stato aumenterà, i criteri di stabilità europei e il limite di indebitamento verranno infranti. Gli investitori si spaventeranno e i tassi di interesse sui titoli di stato italiani torneranno ad aumentare. Alla fine - concludono i due autori - l'Italia non potrà più permettersi di finanziarsi e dopo anni di gestione della crisi l'euro potrà di nuovo spezzarsi". Dopo l'Economist ("un bizzarro governo"), lo Spiegel ("italiani scrocconi") e la Suddeutsche Zeitung, la Fez torna quindi ad attaccare Roma. Certo, gli autori riconoscono che la situazione è ben diversa rispetto alla crisi del 2012 e che i mercati per il momento non hanno reagito al contratto con eccessivo nervosismo perché "nessuno sa quanto tempo" Lega e M5S continueranno ad essere alleati. E soprattutto perché per ora si tratta solo di idee. Tra il dire è il fare - è il ragionamento - c'è di mezzo Sergio Mattarella. È proprio al Colle che i tedeschi guardano nella speranza presti "molta attenzione al rispetto delle regole". Senza contare che a garantire la tenuta dell'Italia "anche qualora realizzassero tutte le loro ambiziose proposte", ci sarebbero comunque due fattori: il quantitative easing di Mario Draghi e il fatto che gran parte del debito nostrano è detenuto da investitori privati o istituzionali italiani. Quindi creditori "leali" e poco propensi ad abbandonare la nave. "Nel breve periodo - scrivono dunque i due autori - l'Italia e l'eurozona sono probabilmente in grado di far fronte al crescente nervosismo sui mercati finanziari". I problemi arriveranno, dicono, nel lungo periodo. Tanto che "anche se la crisi del debito può essere prevenuta con l'aiuto della BCE, l'Italia potrebbe cambiare l'intera unione monetaria in modo permanente" (e negativo). Questo potrebbe avvenire "se la Commissione europea non sanzionerà le prevedibili violazioni del stabilità dell'UE", portando così altri Paesi a seguire l'esempio del Belpaese e producendo un calo del "desiderio di riforme economiche". Un incubo per i tedeschi. O meglio, per dirla con Bollmann e Scherff, "non è una buona prospettiva per l'Europa e per gli investitori".
«Spiegel disgustoso, Ecofin ridicolo» Per Fitoussi l’Italia deve «mostrare i muscoli». L’economista francese: «L’arrivo al potere dei populisti in Italia dovevamo aspettarcelo», scrive Gianluca Mercuri il 27 maggio 2018 su "Il Corriere della Sera". La nuova stretta sul capitale delle banche decisa dall’Ecofin «fa ridere». L’arrivo al potere dei populisti in Italia è «un incidente previsto da tempo, c’erano state molte avvisaglie, dovevamo aspettarcelo» a causa di «politiche europee sbagliate». Ma la situazione può peggiorare «con insulti politici fra l’Italia e i partner europei, penso all’articolo disgustoso dello Spiegel» e può farsi «pericolosa», con rischi di stagnazione per l’Italia e l’Europa. L’analisi di Jean-Paul Fitoussi, in questa intervista all’Ansa, non è consolante e non risparmia critiche alle istituzioni europee. I requisiti più severi richiesti alle banche, proprio mentre gli Stati Uniti fanno il contrario, secondo l’economista francese «affrontano il problema alla rovescia» e rischiano di strozzare il credito all’economia. Le raccomandazioni dell’Ecofin dovranno essere approvate dal Consiglio europeo di giugno, ma arrivando mentre tra Roma e Bruxelles pare iniziare un braccio di ferro danno l’idea di una persistente sordità delle istituzioni comunitarie a chi, come il docente di Luiss e Sciences Po, vede l’unico faro nella Bce: lo spread oltre i 200 punti per lui è «un po’ inferiore a quanto avrebbe potuto essere perché tutti sanno che c’è Draghi: gli speculatori sono più attenti». Fitoussi sembra suggerire all’Italia la linea dura: «Un negoziato con l’Europa ci vuole, e quando c’è un negoziato in vista bisogna mostrare i muscoli, non le debolezze».
Caos politico in Italia, mercati in fibrillazione. L'euro si rafforza, lo spread in netto calo. Milano positiva con le banche. Il differenziale di rendimento giù da 205 a 190 punti. Secondo gli analisti, nel brevissimo periodo lo stop (per ora) al governo euroscettico è un beneficio per i Btp. Ripercussioni positive sui titoli delle banche. Ma resta una fase improntata alla turbolenza, scrive Raffaele Ricciardi il 28 Maggio 2018 su "La Repubblica". Ore 9:40. Il "caos" politico (Bloomberg) italiano, la "confusione" (Wsj) e la "crisi istituzionale" (Ft) che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche sui mercati finanziari internazionali. Quelli richiamati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel motivare la scelta di rifiutare il professor Savona al Ministero delle Finanze e - vista la posizione assunta dai partiti di maggioranza - decretando così la fine del tentativo di Giuseppe Conte di dar vita a un governo. Le reazioni degli investitori al momento inedito per la Repubblica sono improntate al nervosismo, ma nelle prime battute domina l'effetto distensivo dato dal fatto che - per ora - si smonta la concreta ipotesi di un governo Lega-M5s, col carico di incertezze sul programma economico-finanziario che si portava dietro. Infatti l'euro si rafforza e per alcuni osservatori ciò si deve allo sbarramento della strada nei confronti di un esecutivo scettico verso la costruzione della moneta unica. La divisa unica apre in rialzo - dopo aver chiuso ai minimi da novembre, venerdì scorso - e passa di mano a 1,1726 dollari e 128,36 yen. Discorso simile per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che secondo la piattaforma Bloomberg crolla in apertura di giornata a 190 punti base (dai quasi 205 di venerdì sera). Il decennale italiano rende il 2,36%. Il calo del differenziale spinge i titoli delle banche, che a loro volta trascinano Piazza Affari: Milano tratta in rialzo grazie alla spinta dei titoli del credito e dopo aver chiuso la scorsa settimana da peggiore in Europa con un calo superiore al 4%. Dopo aver sfiorato il +2% nei primi minuti, però, il Ftse Mib ritraccia al +0,65%. Gli analisti ritengono che questo momento possa esser positivo nell'immediato per il Btp italiano, dopo giorni di passione. Nelle ultime sedute si è infatti visto il processo di "appiattimento della curva" dei rendimenti dei titoli di Stato: i rendimenti sulle scadenze più brevi sono saliti più di quelli a lungo termine, con l'effetto di assottigliare le differenze tra gli uni e gli altri. Un procedimento che in genere accompagna aspettative di tensione nell'immediato. Sensazioni acuite dall'alert lanciato da Moody's sul Paese, con la minaccia di una bocciatura sul rating. Una evenienza che è per il momento rimandata, visto che si poggiava sui dubbi dell'agenzia circa il budget che avrebbero potuto firmare insieme Lega e M5s. Documento per il quale servirà un po' più di tempo. "Entriamo in un periodo di grande incertezza, andando verso le elezioni anticipate - posto che è lì che finiremo - ma non è quello su cui i mercati si concentrano oggi", ha commentato Ray Attrill, strategist della National Australia Bank di Sydney. "Prevale la rassicurazione che l'Italia non avrà, almeno per ora, un ministro delle Finanze dichiaratamente euroscettico". Con l'ipotesi di nuove elezioni alle porte e un esito ancora più incerto - condito da sondaggi che danno la Lega in forte crescita e possibile beneficiaria massima della confusione attuale - l'impressione raccolta dall'agenzia finanziaria Usa è che le turbolenze saranno il pane quotidiano per i prossimi tempi. La tensione sull'Italia si è percepita chiaramente dalla crescita del costo di una assicurazione per proteggersi dal rischio di default tricolore, che si misura guardando al mercato dei cds (credit default swap). Nel caso del contratto sui cinque anni, la scorsa settimana si è vista una crescita di 40 punti base che ha proiettato il costo di assicurarsi dal "rischio Italia" ai massimi dal 2012. Detto dell'Italia, sui mercati internazionali i fattori di riferimento sono le questioni geopolitiche, in primis l'evolversi della situazione tra Corea del Nord e Stati Uniti, e il calo del prezzo del petrolio. Le quotazioni del greggio subiscono le valutazioni fatte dai paesi Opec e dagli altri produttori di petrolio sul successo dei tagli alla produzione stabiliti per eliminare il surplus mondiale di petrolio. I contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio cedono il 2,40% a 66,25 dollari al barile. Il Brent cede l'1,65% a 75,12 dollari. La debolezza dell'oro nero ha condizionato gli scambi in Asia, anche se alla fine della giornata la Borsa di Tokyo è riuscita a spuntare un rialzo dello 0,13%. I listini americani restano chiusi per celebrare il Memorial day: Wall Street è reduce da una seduta mista con il Dow che ha perso lo 0,2% e il Nasdaq positivo dello 0,13%. Anche Londra fa festa, e questo potrebbe incidere sul volume di scambi globale. In cauto rialzo gli altri listini Europei: Parigi sale dello 0,5%, Francoforte dello 0,6%. Quotazioni dell'oro in calo sui mercati asiatici: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.297 dollari l'oncia (-0,29%).
Spread BTP-BUND: i numeri della morte, scrive il 29 maggio 2018 Emilio Tomasini su "Il Giornale". Spread BTP BUND: i giornalisti economici non ci capiscono una beata mazza e ne parlano come se fosse un totem. E ogni giorno leggiamo i giornali come bollettini di guerra con indicazioni di dove sia arrivato lo spread. Terrore dei terrori. In realtà quello che conta non è sapere che oggi lo spread ha chiuso a 230 quello che importa è sapere dove sono le resistenze che lo trasformano in una arma di distruzione di massa. Innanzi tutto lo spread è una differenza di tassi per cui si può ampliare o accorciare per movimento autonomo di uno di entrambi gli elementi, ripeto di uno di entrambi gli elementi. Non ci sono magie e non ci sono riti esoterici. Dire che si amplia lo spread senza specificare se sale il rendimento del BTP o se scende quello del BUND non ha senso perché vedi i sintomi della malattia e non ne vedi le cause e non necessariamente se sale il rendimento del BTP cala quello del BUND. In secundis quello che conta sono come in un qualsiasi grafico di Borsa i massimi e i minimi relativi: nella fattispecie odierna abbiamo un massimo a 212 circa segnato nell’aprile del 2017 e quindi se e solo se questo venerdì avremo uno spread ben ampiamente sopra quel livello potremo iniziare a preoccuparci di una possibile discesa nell’inferno. Il fatto che oggi per un attimo la resistenza sia stata rotta potrebbe essere un peccato veniale. Stiamo a vedere, sicuramente con il cuore in gola, ma non certamente con il panico addosso perché in Borsa non tutti i prezzi sono uguali, ci sono quelli che contano e ci sono altri prezzi che non contano nulla.
Il grande complotto dello spread, Italia rovinata. Gli indizi terrificanti: ecco chi ci comanda davvero, scrive il 30 Maggio 2018 Giuliano Zulin su “Libero Quotidiano”. Ogni giorno uno strazio. La Borsa cede il 2,65% e lo spread, ovvero la differenza di rendimento tra Btp italiani e Bund tedeschi, supera quota 303. Segno che gli investitori vendono a tutta velocità titoli italiani, come non succedeva dal 2013. Perché? Perché non si sa chi comanda in Italia. Come ha titolato in prima pagina Libero ieri siamo in presenza di un «casino mai visto». E allora i gestori dei fondi (gente che prova a far guadagnare i propri clienti) pensano: meglio non rischiare, portiamo via un po' di quattrini e vediamo se, dopo le elezioni, ci sarà una maggioranza certa e meno confusione istituzionale. Lo spread in realtà può salire dove vuole, è solo una speculazione, un termometro della fiducia nei confronti di un Paese. Per inficiare realmente i costi dello Stato nel rifinanziamento continuo del proprio debito (ogni anno vanno in asta circa 400 miliardi titoli pubblici) servono oltre 6 anni. Cioè per mandare in rovina l’Italia veramente bisogna aspettare 6 anni. Certo non è piacevole essere nel mirino dei mercati mondiali. Il problema è solo politico però, perché i fondamentali italiani sono ultra positivi. A parte il Pil che ormai cresce, poco, ma cresce, va considerato che pure le famiglie italiane sono pur sempre fra le più ricche del Vecchio Continente, la proprietà immobiliare è diffusa nell' 80% degli inquilini, l'export galoppa, la manifattura made in Italy è tornata a ruggire in tutto il mondo. Le banche... a fine anno dovrebbero chiudere i bilanci con oltre 10 miliardi di utili. Insomma, non c' è un motivo per speculare sul Belpaese. Se non perché chi dovrebbe amministrare la settima potenza mondiale sta inanellando una serie di errori. A cominciare dal presidente Mattarella.
Stallo al Quirinale - L' economista Mohamed El-Erian, un guru globale nel mercato dei titoli di Stato, parlando ai microfoni di Cnbc ha sostenuto che da parte del Quirinale c' è stata «una incomprensione del movimento anti establishment e dei mercati». Secondo El-Erian, attualmente capo consigliere economico di Allianz ed ex numero uno del fondo americano Pimco, il capo dello Stato «avrebbe dovuto rispettare l'esito delle elezioni e dare al nuovo governo una chance. Nel bloccare la nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia, per via delle sue posizioni anti-euro, Mattarella ha detto che voleva evitare una crisi sui mercati. Ma non ha capito che i mercati si sarebbero chiesti "Cosa succederà?". E quando i mercati si domandano "cosa succederà", si ha tensione nei mercati stessi». Errori sono stati commessi, sempre secondo El-Erian, da tutti i politici italiani nel «confondere la coincidenza di una ripresa della crescita nel mondo con qualcosa che ha le gambe» per correre. La ripartenza del Pil, per lui, è solo una pura «coincidenza fortunata». Ora «la gente sta capendo che la sola economia con le gambe era quella Usa... L' Europa era solo in un processo neutrale di guarigione». Ecco il punto: l'Italia ha tante rogne, ma la Ue di più. Le manovre espansive di Mario Draghi che hanno portato alla creazione di 2mila miliardi di euro dal nulla, alla fine hanno solamente drogato, anestetizzato l'Unione.
Depositi a rischio - Le incomprensioni e i buchi istituzionali restano. A causa dei tanti veti tedeschi. Per dire: non esiste ancora un meccanismo di protezione dei depositi bancari in caso di crac, men che meno si è accennato alla creazione di eurobond, ovvero titoli pubblici continentali, in modo da condividere onori e oneri. Anche a Berlino ammettono che i guai veri - che si trasferiscono subito nell' andamento dell'euro, ormai sceso a 1,15 sul dollaro - sono europei. L' analista di Commerzbank, Ulrich Leuchtmann, infatti ammette: «Il problema non è l'Italia ma lo stato di salute della zona euro, un esperimento politico che, privo di un'unione fiscale, potrebbe fallire se non si raggiungeranno livelli adeguati di crescita e ricchezza». Va bene tutto, ma se Cottarelli non fa il premier, si vota in estate e vince, per dire, il fronte anti-Ue... come sarà lo spread a Ferragosto? Intanto fra due settimane potrebbe chiudersi l'ombrello protettivo di Draghi. E poi dipende dalla stabilità politica dell'Italia: con un governo certo e forte, lo spread magari sarà alto, ma fuori di bolla. Ne risponderà insomma l'esecutivo con i suoi atti. E se diventasse insostenibile? La Bce, ha fatto sapere ieri, ha un programma salva-spread: si chiama Omt, acronimo di Outright Monetary Transactions. In pratica la Banca centrale compra Btp per abbassare la febbre, in cambio chiede riforme ferree. Di fatto un commissariamento.
Psicologia e comportamento di un Presidente, scrive il 29/05/2018 Susy De Martini su "Il Giornale”. Il Presidente della Repubblica, rigettando la proposta di Governo 5 Stelle e Lega, ha manifestato una palese dimenticanza, più o meno inconscia, della volontà degli elettori, così calpestata e tradita. Frotte di Costituzionalisti seri e di personaggi più o meno opportunisti, si sono precipitati a dire che è giusto e che va benissimo così. Da un punto di vista psicodinamico però la storia è un’altra. Il compito centrale della psicologia, si sa, è la comprensione del comportamento umano che, come ben sappiamo, è estremamente complesso. In genere, la psicologia moderna ha tentato di analizzarlo compiutamente, scomponendolo in campi di studio relativamente separati, fra i quali l’apprendimento, il linguaggio, le varie fasi della vita, la famiglia, il lavoro e così via. Ma della psicologia dell’elettore o del politico, è mai importato qualcosa a qualcuno, al di là della contingenza dell’elezione di turno? Erich Fromm, nel saggio Psicanalisi della società contemporanea, dedica un intero capitolo proprio al tema della politica e delle libere elezioni. E’ interessante la premessa, che riporto integralmente: “se per democrazia si intende la possibilità dell’individuo di esprimere la sua convinzione e di affermare la sua volontà, si presume che egli abbia una convinzione e abbia una volontà”. Ne consegue che se noi elettori fossimo più informati e responsabili nelle nostre scelte politiche e più determinati a farci rispettare, allora forse gli eletti e le cariche istituzionali, risponderebbero meglio alle nostre esigenze. Sembra invece che noi cittadini, influenzati dai mass media che agiscono come potenti persuasori, anche se di colori diversi, siamo in grado di sviluppare soltanto opinioni e pregiudizi ma non convinzioni. Sicuramente simpatie e antipatie ma non siamo in grado, se non raramente, di attuare la nostra precisa volontà, perché in realtà non siamo in grado di riconoscerla più. Viviamo quindi condizionati dalla pubblicità in ogni sua forma e questo ci separa, ovvero ci aliena, da ciò che veramente sarebbe la nostra libera scelta, che non sappiamo neanche più quale potrebbe essere! Votiamo quindi male informati, benché leggiamo regolarmente il giornale e guardiamo la TV, apprendendo di milioni di euro spesi, o persi, di milioni di persone uccise, di spread che salgono o scendono, cifre e astrazioni che non ci danno alcuna interpretazione concreta di quanto sta succedendo, in quanto tutto assume una dimensione irreale e impersonale. E così sta avvenendo anche adesso, dopo la decisone del Presidente di non rispettare la volontà popolare: vediamo solo elenchi o sigle che sono richiami per la memoria, come un gioco di indovinelli e non persone dalle quali dipenderanno la nostra vita e quella dei nostri figli. In realtà non dovremmo dimenticare che proprio l’idea del voto di maggioranza è soggetta al processo di alienazione, in altre parole di delega: in questo caso del proprio potere ad un altro. Ma se il votante esprime soltanto la preferenza fra due candidati che si contendono il suo voto, la responsabilità dell’eletto è molto più grande. E maggiore ancora è la responsabilità del Garante. Ho ascoltato le parole di Di Maio e Salvini, che non fanno una piega da questo punto, invece il Garante dal punto di vista psicologico non ha sicuramente ben interpretato la maggioranza dei votanti Italiani. Un vero tradimento, psicologico, non Costituzionale.
Un Re si sarebbe comportato diversamente, scrive il 28 maggio 2018 Paolo Gambi su "Il Giornale". Cosa sarebbe successo se invece del presidente Mattarella ci fosse stato il Re? Che è un po’ come chiedersi cosa sarebbe successo se la nuova Italia del Dopoguerra non fosse nata repubblicana grazie a strane macchinazioni e probabili brogli, ma fosse rimasta monarchica. Intanto il Re non avrebbe vissuto nessun complesso di inferiorità nei confronti dell’Unione Europea, considerando che ben 7 Paesi dell’attuale Unione Europea – tra i più importanti – hanno un Monarca: Gran Bretagna, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Spagna. E non se la passano così male. A questi si devono aggiungere anche Norvegia, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein. E pure il Vaticano. E tramite intrecci matrimoniali vari i Monarchi hanno sempre saputo tessere tele di straordinaria efficacia. Poi di certo il Re non avrebbe avuto nessuno a cui render conto. Un Re non è eletto, né ricandidabile, non ha partito politico d’origine né di riferimento. Un Re avrebbe sostenuto sempre e comunque gli interessi della Nazione ed avrebbe difeso e sostenuto la sua Democrazia. Un Re (magari non fosse stato un Savoia) avrebbe ascoltato quelli che parlano italiano, non quelli che gridano in tedesco. Ma in Italia ce ne freghiamo dei brogli, del vantaggio della Nazione e pure della Democrazia. Per cui ci teniamo al Quirinale un presidente che fa ciò che Mattarella ha appena fatto. E che per fare ciò ci costa circa 240 di milioni di euro all’anno. Quando la Regina d’Inghilterra pesa sulle casse dello Stato appena 80 milioni di sterline. E le restituisce ampiamente in pubblicità al primo Royal wedding. Chissà, magari Di Maio e Salvini se ne renderanno conto e invece di invocare l’impeachment abrogheranno l’articolo 139 della Costituzione.
Anche Mattarella ha dimostrato di essere schiavo delle lobby europee, ora tocca a noi cittadini difendere la nostra sovranità e il Tricolore, scrive il 29 maggio 2018 Andrea Pasini su "Il Giornale". Cari amici, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha messo in atto quello, che senza mezzi termini, possiamo definire un colpo di Stato. No a Paolo Savona, sì a Mario Draghi, sì al FMI, sì alla BCE, sì ad Angela Merkel. Le istituzioni hanno calpestato la Sovranità del popolo Italiano. Lo hanno fatto voltando la schiena alle urne, al volere degli elettori. Mattarella si è macchiato del reato di alto tradimento, deve essere messo in stato d’accusa e rassegnare le dimissioni. Per questo motivo lancio un appello alla mobilitazione di tutti quei cittadini che amano, più di ogni altra cosa, il tricolore, a prescindere dall’appartenenza politica. Dobbiamo difendere la legalità costituzionale. Di fronte a questo crimine epocale stare zitti o limitarsi ad un lamento si traduce nella nostra resa. Gli euroinomani, i banchieri ed i burocrati non ci avranno mai. Il fatto che Mattarella abbia bocciato il Governo proposto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, mettendo il veto alla nomina di Savona al Ministero dell’Economia, è una violenza perorata contro il popolo. La colpa? Una lettera scritta dall’economista tre anni fa. Missiva in cui redarguiva il Presidente della Repubblica per la sua, troppa, confidenza con i mercati internazionali. La NATO&co. hanno posto il veto, uscire dalla gabbia dell’Euro non si può. Tutti in castigo. L’articolo 87 della Costituzione però parla chiaro e l’articolo 92 segna il carico da novanta: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. In aggiunta il veto a Savona, motivato dalle conseguenze apocalittiche che si verificherebbero qualora l’Italia uscisse dall’Euro, costituisce una indebita interferenza nelle scelte politiche di un Governo che gode del consenso della maggioranza degli italiani. Quindi la nostra Nazione cola a picco. Un incerto futuro, con elezioni che devono arrivare imminenti, ma che imminenti non saranno. Con Cottarelli dietro l’angolo e l’alito dei mercati che spira sul nostro collo. Sembriamo piegati ad un destino nefasto, senza possibilità di rivalsa. All’orizzonte si stagliava un esecutivo gialloverde per certi versi rivoluzionario, espressione del malcontento popolare, capace di far schizzare verso il cielo il fantomatico Spread, specchietto per le allodole europeista. Ora tocca a noi, alzare la voce per denunciare questa situazione vergognosa. Non possiamo permettere che il tricolore venga insudiciato dalle logiche dell’UE. Siamo pronti a tutto, proprio come recita l’Inno di Mameli, per questo lembo di terra. Per questa Italia, patria dell’ingegno, patria del futuro dei nostri figli. Saremo senza tregua ad inseguire i traditori del popolo. Saremo in prima fila a chiedere le dimissioni del Presidente Mattarella. Eccoci, sguardo fiero pronto a dipingere nei nostri avversari un presagio di terrore.
The Mattarella Horror Picture Show, scrive il 28 maggio 2018 Giampaolo Rossi su "Il Giornale".
UN DISASTRO ISTITUZIONALE. Pensavamo che dopo Giorgio Napolitano la storia ci avrebbe risparmiato lo spettacolo di un altro Presidente della Repubblica opposto alla volontà popolare. Con Mattarella siamo arrivati ad uno stadio di evoluzione successivo della fine della nostra sovranità: Napolitano aveva abbattuto un governo legittimo; Mattarella ha impedito che nascesse. Nel 2011 il complotto di Napolitano, orchestrato con la collaborazione della tecno-finanza europea e la volontà di Berlino e Parigi di eliminare un Premier scomodo ed eletto dai cittadini (Silvio Berlusconi), consumò un oltraggio che ha segnato nel profondo la nostra democrazia; ciò che allora, uno dei maggiori analisti britannici di questioni europee, Ambrose Evans-Pritchard, definì “un colpo di Stato sicuramente nello spirito se non anche nel diritto costituzionale”. Oggi Mattarella liquida una maggioranza parlamentare ed un governo legittimo con un atto di prevaricazione costituzionale che trasforma le “prerogative del Quirinale” in un’autoritaria intromissione nelle scelte del governo e nelle sue linee politiche; cosa che un Presidente della Repubblica non può fare!!! Come ricorda uno dei nostri costituzionalisti più prestigiosi, Valerio Onida: “il Quirinale non ha potere di indirizzo politico che spetta al Governo sorretto da una maggioranza parlamentare (…) può svolgere funzione di persuasione e influenza ma non ha potere di decisione definitiva”. Lo ribadisce un altro costituzionalista, Mario Esposito: riguardo i ministri “il Presidente della Repubblica può svolgere uno scrutinio sul possesso di requisiti costituzionalmente richiesti, mentre sul piano dell’opportunità può soltanto esercitare moral suasion (…) Altrimenti si rischia di determinare un’ingerenza del Capo dello Stato nell’indirizzo politico di maggioranza, che esula dalle sue attribuzioni”. Una prevaricazione che trasforma le “prerogative del Quirinale” in un’autoritaria intromissione nella linea politica di un Governo.
L’IMBROGLIO SUI “PRECEDENTI”. Quando vi raccontano i precedenti di Pertini, Ciampi o Scalfaro, si dimenticano di spiegarvi le ragioni per cui quei Presidenti della Repubblica convinsero (non imposero) i rispettivi Premier a modificare la scelta su un ministro. In tutti casi vi erano ragioni che attenevano ad opportunità legittime ma che mai si basavano sulla linea politica o sulle loro convinzioni. È il caso di Cesare Previti durante il primo Governo Berlusconi nel 1994, che Scalfaro sconsigliò di inserire al Ministero della Giustizia perché avvocato personale del Premier, quindi per un chiaro problema di conflitto d’interessi; infatti Previti fu nominato alla Difesa. O il caso di Roberto Maroni che nel 2001 Ciampi non volle al Ministero della Giustizia, ma solo perché era stato condannato due anni prima per oltraggio a pubblico ufficiale dopo gli scontri con la polizia davanti alla sede della Lega di via Bellerio a Milano; ma non ci fu un veto su Maroni, tanto che il leghista (allora addirittura ancora secessionista) fu spostato al Ministero del Welfare. Quello che ha fatto Mattarella non ha precedenti! Mattarella ha trasformato una Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenziale senza alcuna riforma della Costituzione.
I TRE “ERRORI” VOLUTI. In realtà tutto l’operato di Mattarella, durante questa crisi, è stato finalizzato ad impedire che un governo legittimo potesse operare con sovranità piena nel nostro Paese. Tre sono gli “errori” che il Presidente della Repubblica ha compiuto nell’atto delle sue funzioni; le firme lasciate in calce al certificato di morte della sovranità italiana:
1) LEGGE ELETTORALE. L’approvazione senza colpo ferire una legge elettorale voluta dal Pd (ormai minoritario nel Paese) per bloccare un futuro governo, e votata anche dal centrodestra (escluso Fratelli d’Italia) per poter tornare il prima possibile al voto; una legge elettorale studiata apposta affinché l’Italia non potesse avere un governo con maggioranza solida e sicura. In questo caso Mattarella è stato un perfetto “parlamentarista” di un Parlamento a maggioranza Pd. Una legge che lui ha firmato senza neanche sentire il bisogno d’inserire una lettera di raccomandazione sul suo uso, come spesso hanno fatto i Presidenti della Repubblica.
2) NO CENTRODESTRA. Il rifiuto ostinato di dare l’incarico di governo (anche solo di tipo esplorativo) a Matteo Salvini, leader della coalizione che aveva vinto le elezioni. Un atto di incomprensibile chiusura che ha mostrato la preclusione di tipo ideologico e politico verso la parte maggioritaria in Italia.
3) CASO SAVONA. Un arroccamento incomprensibile contro uno degli economisti più prestigiosi del nostro Paese; un uomo che già era stato ministro nel 1993 durante il governo Ciampi, ma che Mattarella ha respinto solo perché “sostenitore di una linea, più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell’Italia dall’euro” come lo stesso Presidente ha dichiarato; affermazione gravissima perché non tiene conto che la linea politica di un governo è collegiale e non la decide un ministro. E sopratutto perché non è compito di un Presidente ma del Parlamento giudicare l’esecutività di un ministro. In altre parole Mattarella ha trasformato una Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenziale senza alcuna riforma della Costituzione. Un atto che se non è un colpo di Stato, è sicuramente una violazione spaventosa.
BYE BYE SOVRANITÀ. Mattarella con il suo gesto ha reso esplicita anche un’altra cosa: che in questo Paese è possibile mettere in dubbio tutto, persino la Costituzione, ma non si può mettere in dubbio l’Euro, pena l’esclusione dal consesso democratico. Questa è una porta aperta alla fine della democrazia, un attacco al pluralismo delle idee, un affronto alla libertà di pensiero e al rispetto delle volontà popolari. La decisione di Mattarella è venuta dopo che per giorni le Cancellerie europee e i circoli finanziari hanno svolto una pressione costante contro la nascita di questo Esecutivo. Il modo in cui oggi i giornali tedeschi hanno trionfalmente accolto lo scampato pericolo di un Governo non allineato ai dettami dell’Ue, e l’elogio di Macron al “coraggio di Mattarella” confermano a chi ha fatto comodo questo disastro istituzionale dell’Italia. Oggi è più che mai chiaro che il nostro è un Paese a sovranità limitata. La democrazia rappresentativa e parlamentare si scontra con gli interessi dell’elite e con il tentativo di svuotare ogni diritto di un popolo di scegliersi da chi farsi governare. Lo spirito dei Padri fondatori dell’Europa oggi non è minacciato dai cattivi populisti ma da chi sta liquidando la democrazia.
Emergenza democratica, scrive il 28 maggio 2018 Augusto Bassi su "Il Giornale". Da molti anni vediamo aleggiare l’espressione “emergenza democratica”. Se ne parlò e se ne scrisse tanto sulla Rai, su Micromega e Repubblica nei 1.287 giorni del Berlusconi IV, e ancora, un po’ ovunque, con l’arrivo di Grillo e dei 5Stelle, quindi con l’avanzare del nuovo “Lepenismo” e del “Salvinismo”. Ora, che viviamo un’emergenza democratica autentica, diviene evidente la dissimulata ambivalenza sintattica che ne ha sempre definito la natura. Scendere i gradini dell’ordinamento grammaticale fino ai più elementari momenti di analisi logica non è pedanteria; piuttosto necessario esercizio di disinganno. In questo acquisito sintagma, “democratica” non è, come abbiamo sempre ritenuto, un complemento di specificazione attributiva o più correttamente un complemento di svantaggio. Non equivale a “emergenza della democrazia” / “emergenza per la democrazia”. Siamo invece sempre stati di fronte a un predicato nominale: la democrazia (soggetto) è (copula) un’emergenza (parte nominale). E per quali entità la democrazia sarebbe ormai un’emergenza, un accidente, una difficoltà, un imprevisto, un problema? Precisamente per i democratici soi-disant. In Italia, in Europa, negli Stati Uniti. L’Unione Europea, dai Principii di Barcellona in avanti, si è sempre affermata come promotrice della democrazia, sia nella propria politica economica, esercitata a favore della prosperità degli Stati membri, sia in quella estera. Ebbene, credo sia venuto il momento di tirare le somme. A tal proposito, pur non essendo un grande tifoso dell’autocitazione, trovo che uno dei pochi vantaggi dell’informazione digitale sia che gli articoli di ieri non vanno ad avvolgere i branzini di domani. Così, basta un click per ritrovare ciò che veniva scritto; e che può essere giovevolmente aggiornato a mesi di distanza. Il 6 febbraio scorso in Ignominia Eurocratica mettevo di colore su bianco: Siete voi, burocrati UE, un attacco premeditato ai nostri valori fondamentali! Voi… xenofobi delle idee. Livellatori delle specificità nazionali. Ignobili funzionari dallo sdegno premeditato; voi… che usate le utili tragedie per fare i gargarismi di propaganda e scaracchiate quelle che potrebbero otturarvi il gozzo. Voi… che condannate dal pulpito del vuoto democratico da voi edificato e che ora troneggia nell’abisso come ultima istituzione rimasta a unirci. Voi siete il campo di concentramento delle identità, l’olocausto della memoria collettiva, la negazione del gusto. Con quelle facce macilente, che trasudano povertà di letture, povertà di spirito; con quegli abiti dozzinali, volgari prodotti mass-market della vostra stessa politica. Voi avete annullato il libero dialogo fra singolarità culturali nel tetro monologo della moneta, del soldo, del danaro, che ha reso tutti più poveri. E ora spacciate per ideale comunitario l’avidità impiegatizia della vostra speculazione. Voi avete reciso le trame di senso che ci affratellavano come compatrioti, aperti ad altre patrie nella reciproca legittimazione. Siete voi l’ignobile prassi che vorrebbe mangiare viva l’umana differenza e sostituirla con l’inumano indifferenziato. Infami, laidi, vigliacchi, ma con l’ardire di pontificare su un’integrazione che comandate e non esercitate. Accoglienti nella nazione degli altri. Umanitari nella patria degli altri. Moralisti e schiavisti a distanza. Voi siete la violenza sterminatrice che disintegra le comunità con l’integrazione forzata, che depreda, imbastardisce la cittadinanza. Officianti di un sacerdozio pagano, ciarlatani di una stregoneria senza incanto, senza magia, larga di mezzi e miserrima di suggestioni. Negromanti che evocano gli spiritelli del razzismo, del fascismo, del populismo, dello spread, che difendono la “stabilità” agitando l’esalazione dei risparmi per far chiudere gli occhi dalla paura agli animi semplici e nascondere loro il dispotismo monetario e il permanente saccheggio di cui sono sinistri gerarchi. Dispotismo che rende vano anche il voto, quando non allineato al dogma mercantile. Parla di comunità, l’ignavo Mattarella: «Senza senso della comunità arriva la violenza». E così è. Perché voi ne avete strappato le viscere come un mostruoso selvaggio farebbe con quelle di una ragazzina appena assassinata. Voi nascondete i resti delle sovranità che avete fatto a pezzi in un trolley da Erasmus come un mostruoso selvaggio farebbe con le membra di una ragazzina appena macellata. Vittima vostra. E nostro dovere è condannare questa violenza e l’ignobile ideologia che ne è alla base. Oggi non ho molto altro da aggiungere.
Tutti contro Savona ma porte spalancate a parvenu e “no Tav”, scrive il 25 maggio 2018 Cristiano Puglisi su "Il Giornale". “Le infrastrutture sono da fare e non da smontare”. Le dichiarazioni di Matteo Salvini al termine dell’incontro di ieri con il premier incaricato, Giuseppe Conte, sono state, per fortuna, chiare e precise in merito a cosa il Governo “ircocervo” dovrà evitare. Ossia la cancellazione di opere strategiche per il Paese e per il nord Italia, che metterebbe in serie difficoltà il rapporto con gli alleati di centrodestra. Eppure il complesso mediatico-istituzionale italiano è sembrato ben più preoccupato, rispetto al pericolo di vedere insediati in dicasteri strategici dei parvenu senza pregresse esperienze lavorative o addirittura esagitati attivisti “no Tav”, dal professor Paolo Savona, il possibile ministro dell’Economia cui nelle ultime 48 ore sono state dedicate ore di allarmata discussione nei principali salotti politici televisivi. 82 anni, già ministro dell’Industria nella troppo vituperata (e infinitamente più seria della “Terza”) Prima Repubblica, accademico di lungo corso, consulente di fondi di investimento internazionali, Savona paga lo scotto della posizione euroscettica, che, secondo trasmissioni televisive e importanti quotidiani, lo renderebbe inviso addirittura al Quirinale. Ora, pur con tutte le cautele del caso verso il futuro esecutivo gialloverde, figurarsi un docente universitario che ben conosce le regole d’ingaggio dei tavoli dell’alta politica e dell’alta finanza come un pericoloso e sovversivo lepenista che potrebbe decretare motu proprio l’uscita dell’Italia dall’eurozona fa abbastanza sorridere. Meno comica e ben più tragica sarebbe invece la prospettiva di ritrovarsi la pasionaria pentastellata contraria all’alta velocità Torino-Lione Laura Castelli, 31 anni e una laurea triennale, quale titolare del Ministero delle Infrastrutture. O lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, stessa età, non laureato ed ex webmaster e steward allo stadio San Paolo di Napoli, come titolare di deleghe fondamentali quali Sviluppo Economico e Lavoro. Eppure su di loro neanche una riga, nemmeno un allarme, così come nessuno avrebbe, a quanto si ha modo di capire, nulla da eccepire sulla sostituzione di Savona con altri esponenti leghisti, che pure non nascondono la loro piena contrarietà alla moneta unica. Una situazione strana, che, per quanto concerne i rapporti con l’UE, sembra dimostrare come, per un certo establishment tecnocratico, il pericolo non sia rappresentato tanto dalle posizioni del futuro Governo, o meglio dalle posizioni della Lega, ma dall’autorevolezza di chi potrebbe sostenere la causa dell’Italia sui tavoli che contano. Così come, tornando agli impresentabili aspiranti ministri pentastellati, è palese il disimpegno del medesimo establishment dalla tutela dell’interesse strategico nazionale, che fa da contraltare a una palpabile necessità di garantire lo status quo sul fronte del posizionamento internazionale, da cui le pressioni del Colle, oltre che per l’Economia anche per gli Esteri. Ciò che inoltre traspare con una certa limpidezza è ancora una volta la resistenza del “sistema” più verso la Lega che verso i grillini, cui tutto pare consentito. Una dimostrazione ulteriore dell’inaffidabilità dei nuovi alleati di Salvini che, privo della copertura degli alleati del centrodestra e del loro profilo istituzionale, dovrà essere bravo a gestire i rapporti con un esecutivo di cui è, suo malgrado, socio di minoranza.
Le pressioni dei banchieri Draghi e Visco dietro il veto del Colle sull'economista. La confidenza di Renzi: "Vedono Savona come il fumo negli occhi". Il leghista Borghi: "Mattarella come Napolitano contro Berlusconi", scrive Augusto Minzolini, Lunedì 28/05/2018, su "Il Giornale". Al mattino a un amico che partecipava a uno dei tanti convegni del week-end milanese, Giancarlo Giorgetti, il consigliere principe di Matteo Salvini, ha confidato al telefono tutta la nevrosi accumulata per una estenuante trattativa finita male. «Anche Matteo ha spiegato è altalenante: una volta dice che vuole usare la candidatura del prof. Savona come un piede di porco per far saltare tutto; un altro momento ci ripensa. Sono stressato, spero che al più presto si arrivi a una decisione. Qualunque essa sia». Passa qualche ora e si capisce che sul nome del professor Savona, il vecchio samurai diventato il pomo della discordia, sarebbe fallito il tentativo di Giuseppe Conte. «Anche l'incontro di questa sera tra Mattarella e Conte non servirà a niente-, predice Giorgetti a un amico alle 17 -. Tutti sono rimasti sulle loro posizioni». In realtà a quell'ora si era già capito che le missioni del pomeriggio al Quirinale del leader della Lega, Salvini, prima, e, poi, del capo dei 5stelle, Luigi Di Maio, terrorizzato dal rischio di andare nuovamente alle urne, si erano risolte in un fallimento. «Se su Savona ha tagliato corto Salvini c'è il no di Berlino e dei poteri forti, significa che è il ministro giusto. Se non lo vogliono si torna a votare». «Qui ha confidato Di Maio, di ritorno dal Colle, ai suoi finisce male. La posizione di Mattarella è incomprensibile». Mentre al Quirinale un Capo dello Stato, fuori di sé, non risparmiava nulla ai suoi interlocutori: «Dovranno spiegare agli italiani, quello che succederà da domani in poi sui mercati». La verità è che il «caso Savona» è diventato alla fine l'elemento catalizzatore del «non detto» di queste settimane: c'è stato un problema istituzionale che ha tirato in ballo le prerogative del Capo dello Stato; c'è stato un problema economico che ha riguardato i rapporti con l'Unione Europea; c'è stato un problema finanziario che ha investito anche le relazioni con Bankitalia e con la Bce; ed ancora, ci sono state tutte le contraddizioni, che, piano piano, sono venute in luce nel contratto di governo. E la montagna di parole con cui i mediatori hanno tentato di coprire tutto questo negli ultimi giorni, quello spesso manto di ipocrisia, non è bastata per raggiungere un compromesso. Sicuramente non è bastata la dichiarazione di Savona. Anzi, la sortita del professore ha spostato l'attenzione sul «contratto» di governo, su quelle domande che ieri Mattarella stesso ha rivolto nell'incontro al Quirinale al premier incaricato: esiste un piano «B» per uscire dall'euro o è solo una fantasia? Che tipo di rapporto questo governo vuole instaurare con la Germania? Insomma, con le parole si è tentato di individuare una mediazione impossibile: il lessico di mille dichiarazioni e un intero vocabolario di aggettivi rassicuranti, non avrebbero potuto, infatti, sminuire il significato e i modi della possibile nomina di un personaggio come Savona con il suo profilo, la sua personalità, la sua storia al ministero dell'Economia. Delle due l'una: la nomina di Savona al ministero dei via Venti Settembre avrebbe avuto il significato di un cedimento di Mattarella, per cui l'influenza che il Quirinale via via è venuto ad assumere nei settennati di Scalfaro, Ciampi e, soprattutto, Napolitano, sarebbe diventata un pallido ricordo; se, invece, Salvini avesse accettato l'esclusione del Professore, avremmo avuto il paradosso che il primo governo «sovranista» di questo Paese, sarebbe stato il primo a essere condizionato platealmente dalla Ue e dalla Germania, nella scelta del ministro dell'Economia. Da qui non si scappa. Ci sarebbe stato un vincitore e un perdente. E nessuno era nelle condizioni di poter accettare una sconfitta. Nessuno dei due veri duellanti, Mattarella e Salvini, ha voluto fare un passo indietro, consapevoli della posta in gioco. «Non mi arrendo», ha ripetuto per tutto il giorno Salvini. Un'espressione che il fido Claudio Borghi ha tradotto in questo modo lanciando segnali di nuovo a Berlusconi, dopo il «freddo» di queste settimane, per la prossima campagna elettorale: «Mattarella e compagni non sono lucidi. Stanno facendo a Salvini il favore che l'establishment americano ha fatto a Trump. Le hanno provate tutte. Anche di dividere il ministero dell'Economia in due, per impedire a Savona di partecipare ai vertici europei. La verità è che questa crisi pone non solo il problema del nostro rapporto con l'Europa, ma anche di quanto è avvenuto nel 2011: la domanda da porsi è se l'Italia è un Paese a sovranità limitata o no? È una questione che non nasce ora. Lo sa benissimo Berlusconi che ha l'occasione di vendicarsi per tutto quello che gli hanno fatto. Ieri c'è stato un Capo dello Stato che su ordine della Ue ha fatto fuori un premier. Oggi c'è un Capo dello Stato che ha posto un veto sulla nomina di un ministro, sempre su ordine di Bruxelles. Tutti i nodi sono venuti al pettine». E già, sul nome di Savona è andato in scena lo scontro tra due mondi. Uno scontro che non riguarda solo il tema europeo, ma anche questioni spinose come la politica del credito, delle banche che riaprono vecchie ferite e suscitano nuovi rancori nel nostro establishment. «Mi dicono ha confidato Matteo Renzi ai suoi, per spiegare l'avvitarsi della situazione che Mattarella in questi giorni ha ascoltato molto Draghi e Visco, che vedono Savona come fumo negli occhi. Tra l'altro quello che dice Savona sugli errori fatti da Bankitalia nel trattare i problemi delle piccole banche o il bail-in, io lo firmerei». Quindi, con Bruxelles, Berlino, Draghi, Visco che premevano, Mattarella non ha potuto non mettere quel «veto» su Savona. E ha dovuto accettare un grande rischio, quello su cui D'Alema giorni fa lo ha messo in guardia: «Se il Presidente dice no a Savona, rischia di ritrovarsi di nuovo di fronte lo stesso problema dopo le elezioni. Con Salvini che, però, gli metterà sul tavolo una maggioranza dell'80%». Già, con quel «no» ora Mattarella rischia di diventare l'obiettivo di una campagna elettorale, di essere sfiduciato dal Paese. Ecco perché forse farebbe bene a non tirarsi addosso nuove critiche e polemiche, varando un governo di «tecnici» per portare il Paese al voto (per questa mattina ha convocato al Quirinale il professor Cottarelli, l'uomo che mise in piedi un piano per la spending review). Sarebbe stato più prudente per lui rifugiarsi dietro a qualche precedente, mettere in piedi un governo istituzionale, guidato da uno dei due presidenti delle Camere, come fece Francesco Cossiga nell'87. Come dice il proverbio: «chi lascia la via vecchia per la nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova».
Sergio Mattarella, la rabbia contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini: "Fuori faccia feroce, ma con me...", scrive il 28 Maggio 2018 "Libero Quotidiano". "Nessun veto, capite?". Sergio Mattarella ha spiegato così a Luigi Di Maio e Matteo Salvini la decisione di opporsi a Paolo Savona ministro dell'Economia. Un paradosso, oggettivamente, a cui il Quirinale oppone la contro-offerta del leghista Giancarlo Giorgetti o un interim del premier Giuseppe Conte come alternative all'evidentemente "impresentabile" (per Bruxelles, Berlino e Francoforte) 82enne Savona. "Capiamo tutto, presidente, ma per come si è messa la cosa non possiamo togliere quel nome dalla casella dell'Economia", è stata la replica dei leader di M5s e Lega. Fin qui, uno scontro istituzionale mantenuto nei limiti. Ma pochi minuti dopo, quando la rottura diventa pubblica, si scatena l'inferno con Di Maio e Salvini che parlano davanti ai loro elettori di "democrazia a rischio" e addirittura, dalla piazza grillina, sale l'urlo "impeachment". Roba senza precedenti. E qui, secondo il Corriere della Sera, il presidente Mattarella ha avuto un sbotto rabbioso: "Sono stati degli agnellini davanti a lui, ma fuori hanno fatto la faccia feroce", scrive il quirinalista del Corsera Marzio Breda, che riporta fedelmente il Mattarella-pensiero. Anche da questi dettagli si capisce come la situazione sia tesa come forse mai è successo prima.
E Mattarella chiese a Salvini e Di Maio: «Perché non volete Giorgetti?». Il presidente e il tentativo di mediare sull’Economia, con il leghista di peso. Poi lo stop: il Colle non avrebbe potuto lasciare l’istituzione presidenza della Repubblica colpita e, anzi, lesionata, nelle prerogative fissate dalla Carta costituzionale, scrive Marzio Breda il 27 maggio 2018 su "Il Corriere della Sera". «Non l’ho fatto a cuor leggero», dice Mattarella, e quell’espressione semplice, pronunciata con voce appannata ma ferma, riassume l’assillo che lo ha tormentato queste settimane d’impazzimento generale, prima di giungere alla scelta più drastica. Cade l’ipotesi del governo Lega-5 Stelle e si materializza un incarico per Carlo Cottarelli, convocato per stamane al Quirinale. Non era lui il candidato «coperto» al quale il capo dello Stato qualche settimana fa pensava di affidare un esecutivo «di garanzia e servizio», se il patto gialloverde fosse fallito. Questo nome si è imposto adesso per tamponare in corsa i conti pubblici, dopo che l’Italia è stata messa sotto attacco dagli speculatori finanziari. Ora che tutto è andato in tilt potremo verificare, e lui per primo, quale grado di responsabilità saprà mostrare il Parlamento davanti a una crisi tanto grave quanto senza precedenti. Comunque non c’era altra opzione, per Mattarella. Che non avrebbe potuto lasciare l’istituzione presidenza della Repubblica colpita e, anzi, lesionata, nelle prerogative fissate dalla Carta costituzionale. Un’osservazione che fino all’ultimo ha girato, argomentandola, anche ai due partner dell’ormai disciolta maggioranza, che sono stati degli agnellini davanti a lui. Nessun veto, capite? Piuttosto perché irrigidirsi su Paolo Savona quando al suo posto vi ho proposto un interim a Conte o l’incarico pieno a un leghista di peso come Giorgetti? «Capiamo tutto, presidente, ma per come si è messa la cosa non possiamo togliere quel nome dalla casella dell’Economia», gli hanno risposto. Con garbo. Salvo fare, subito dopo esser usciti dal Palazzo, «la faccia feroce», come dicono a Napoli, mentre si esibivano in piazze e tv fino a vagheggiare l’impeachment. E qui sta il mistero della giornata. Del quale Salvini, e pure Di Maio (che si era difeso dando la colpa al «socio» di governo), dovranno rispondere al loro popolo. L’intera domenica si era consumata in estremi tentativi di mediazione tra i due partiti e il candidato premier, con il coinvolgimento dell’economista controverso, sondato a distanza per un’eventuale disponibilità ad accettare un altro ministero. Una corsa contro il tempo come raramente se ne vedono nella Roma dai tortuosi ritmi bizantini, specie nei negoziati politici. Una guerra di nervi. Con l’incubo dell’irremovibilità dei due leader, ancorati all’ultimatum «o Savona o il voto», che poteva far saltare tutto. Come poi è accaduto. La trattativa a un certo punto si era spostata al Quirinale, dove Salvini e Di Maio erano saliti. Incontri i cui contenuti avrebbero dovuto restare riservati e che sono invece stati subito pubblicamente raccontati (cosa mai vista), confermando che la campagna elettorale più lunga della nostra storia si era riaccesa. Un modo per mettere fin d’ora Mattarella nel mirino, con una speculazione ultrapopulista sui suoi poteri. Insomma: a nessuno dei due interessavano le controindicazioni costituzionali che inducevano l’inquilino del Colle a dire no alla candidatura di Savona all’Economia, quanto cercare il casus belli. Per cavalcarlo. Un momento spartiacque si era avuto all’ora di pranzo, quando il professore cagliaritano aveva fatto diffondere un chiarimento su quella che aveva definito «una scomposta polemica sulle mie idee». Documento ambiguo. Perché si riparava dietro il «contratto» di Lega e 5 Stelle, senza entrare nei nodi di un programma economico insostenibile sul piano della disciplina di bilancio, attraverso investimenti extradeficit. E soprattutto reticente sul «piano» per far uscire l’Italia dall’euro predicato con insistenza da Savona.
Matteo Salvini, il veto di Mattarella che ha fatto saltare tutto: "Io non chino la testa", scrive il 27 Maggio 2018 "Libero Quotidiano". Fino all'ultimo colloquio di questo pomeriggio con Matteo Salvini, Sergio Mattarella ha confermato il veto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Una posizione che ha fatto letteralmente saltare i nervi al leader leghista che, dal comizio a Terni per le amministrative, ha denunciato: "Mi sto convincendo che non siamo un paese libero. Siamo un paese a sovranità limitata. Per noi - ha aggiunto Salvini - un principio viene prima di tutto: per l’Italia decidono solo gli italiani. Per il governo decidono i cittadini italiani, se siamo in democrazia". Le possibilità che il governo M5s-Lega vada in porto sembrano ormai svanite, lo stesso Salvini ne parla con un tono vagamente nostalgico: "Se avessi dovuto seguire la convenienza mia e del partito avrei detto, non ci provo neanche. Ce l’abbiam messa tutta - aggiunge - se qualcuno si prenderà la responsabilità di non far nascere un governo, lo vada a spiegare a sessanta milioni di italiani. Il sospetto di Salvini è dietro la contrarietà del Quirinale sul nome di Savona ci siano le pressioni di Bruxelles e Francoforte, considerando le posizioni anti-euro dell'economista: "Se un ministro dà fastidio a certi poteri forti che ci hanno massacrato vuol dire che quello è il ministro giusto. Non chinerò mai la testa davanti alle richieste di chi non risponde al bene dei cittadini italiani".
Paolo Savona, Paolo Becchi a valanga sul Quirinale: "Perché il colpo di mano di Sergio Mattarella non ha precedenti", scrivono Paolo Becchi e Giuseppe Palma il 27 Maggio 2018 su "Libero Quotidiano". Sono da poco trascorse le 21 che sulla pagina Facebook di Salvini appaiono poche parole che non lasciano presagire nulla di buono: «Sono davvero arrabbiato». Il messaggio in breve tempo diventa virale. Chiaro il riferimento al colloquio informale avvenuto tra Giuseppe Conte - presidente del Consiglio incaricato - e il Capo dello Stato. Mattarella sembrerebbe aver fatto capire a Conte di non volere Paolo Savona al ministero dell'Economia. Il sospetto viene presto confermato da YouTrend, che in un tweet scrive: «Mattarella avrebbe comunicato a Conte la contrarietà del Quirinale alla nomina di Savona all' Economia. Torna così in bilico la possibilità di chiudere un accordo di governo». Ormai la politica si fa (anche) coi social, così ieri sera un nostro pezzo - non apparso sul cartaceo di questo giornale ma solo nella edizione online - ha fatto letteralmente esplodere la rete, perché di fatto anticipava quelle che sarebbero state le mosse di Mattarella. Cosa sta succedendo? Siamo di fronte ad un vero e proprio colpo di mano da parte del presidente della Repubblica, che varca i limiti delineati dalla Costituzione e quelle che sono le sue prerogative nella nomina dei ministri, mutando di fatto la forma di governo da parlamentare a presidenziale. Vediamo perché. Colpo di mano - Il Capo dello Stato, che per l'articolo 92 della Costituzione nomina i ministri su «proposta» del presidente del Consiglio, non ha alcuna discrezionalità nella scelta dei titolari dei dicasteri. Il motivo è semplicissimo: è il presidente del Consiglio, e non il Capo dello Stato, ad assumersi la responsabilità politica del governo davanti alle Camere, alle quali chiede il voto di fiducia ai sensi dell'art. 94. La responsabilità assunta davanti al Parlamento da parte del presidente del Consiglio è dunque sull' intera politica generale del Governo (art. 95), compresa quella economica. Non può essere dunque il Capo dello Stato a scegliere il ministro dell'Economia (e nessun altro ministro), anche perché di quella scelta non si assumerebbe alcuna responsabilità politica, che ricadrebbe soltanto sul presidente del Consiglio. E allora per quale strano motivo Conte dovrebbe assumersi la responsabilità della politica economica del suo governo in base ad un ministro non scelto da lui, né dai partiti che gli votano la fiducia in Parlamento, ma dal Capo dello Stato che è estraneo al rapporto di fiducia Camere-governo? Il motivo non è sotto gli occhi di tutti. Aver perso la sovranità monetaria ci mette nelle condizioni di subordinare la democrazia ai voleri della Ue, che hanno preso il posto della sovranità del popolo. Se i partiti che hanno vinto le elezioni non hanno neppure la facoltà, insieme al presidente del Consiglio, di determinare la politica economica del governo, viene meno la forma di governo parlamentare. A cosa servono le elezioni, in un sistema parlamentare, se poi chi vince non può neppure scegliersi il ministro dell'Economia? Cos'ha che non va Savona? È "euroscettico" e quindi non è gradito all' establishment. Molti rievocano il caso-Previti per giustificare il veto su Savona. L' esempio non calza. Scalfaro si rifiutò di nominare Previti alla Giustizia solo perché era stato l'avvocato di fiducia del presidente del Consiglio - Berlusconi - che ne aveva avanzata la proposta. Ma Scalfaro fu comunque "costretto", per evitare lo strappo, a nominare Previti alla Difesa. La situazione attuale è molto più complessa. Vediamo cosa può succedere. Gli scenari - Primo scenario: Mattarella potrebbe cercare di dividere Salvini da Di Maio per far saltare il governo, oppure per far cedere Salvini su Savona, ma stavolta Matteo non mollerà di un centimetro. Di Maio lo sta appoggiando. L' intesa tra i due resta forte. Non solo, il braccio di ferro sta dando risultati opposti a quelli sperati e mentre Berlusconi pare eclissato, Meloni, pur restando all' opposizione, ha manifestato il suo sostegno a Salvini su Savona. Secondo scenario: il Colle potrebbe indurre Savona a fare un passo indietro, ma Savona è uomo di carattere non lo farà. È diventato per gli italiani il simbolo del cambiamento. Terzo scenario: Conte sale al Quirinale con la lista dei ministri e propone Savona all' Economia, facendo presente che esiste un'irrinunciabile linea politica da parte sua e della maggioranza. A quel punto, per evitare una crisi istituzionale, Mattarella dovrebbe firmare la nomina di Savona. È probabile che lo faccia. In caso contrario, Conte dovrebbe annunciare che Mattarella si è rifiutato di nominare Savona all' Economia, e che quindi lui ha sciolto la riserva rinunciando all' incarico. Ciò farebbe ricadere la responsabilità della crisi sul presidente della Repubblica. E si dovrebbe andare al voto nel più breve tempo possibile.
La condanna di Savona alla Germania: "Il piano tedesco è quello dei nazisti". Nel 2012 Savona pubblicava un libro sull'egemonia tedesca in Europa: "Se non volete che finisca ancora una volta male, non resta che ridiscutere i patti Ue", scrive Sergio Rame, Domenica 27/05/2018, su "Il Giornale". "Ci ritroviamo con l'irreversibilità dell'euro - ovviamente di questo euro e non di quello che avremmo desiderato che fosse - nelle forme che impediscono il realizzarsi delle speranze che ne avevano suggerito la nascita: uno strumento per la crescita e la diffusione della pace e del benessere per tutti". È il Tempo a tirare fuori un estratto del libro Lettera agli amici tedeschi e italiani pubblicato da Paolo Savona nel 2012. Già allora l'economista, che Matteo Salvini vorrebbe portare al ministero dell'Economia e che Sergio Mattarella vorrebbe fuori dalla squadra di governo, intravedeva "la competizione conflittuale" tra la Germania e l'Italia. Il muro contro muro tra Salvini e Mattarella rischia seriamente di travolgere gli accordi di maggioranza con il Movimento 5 Stelle, trascinando con sé non solo il famoso "contratto", ma tutto il governo. A pesare sulla decisione del Colle sono le posizioni euroscettiche di Savona. Posizioni che trapelano molto chiaramente negli ampi stralci pubblicati oggi dal Tempo. Già nel 2012 l'economista, che aveva seguito l'allora premier Carlo Azeglio Ciampi nell'ingresso dell'Italia nell'Unione europea, aveva già visto le influenze negative di Berlino e aveva denunciato "il riproporsi, per fortuna in forme non militari, ma più subdole, della competizione conflittuale che ha causato le drammatiche vicende della guerra e aveva imposto una forte volontà di pace e guidato, sia pure tra sussulti, il processo di unificazione europea". Parlando ai tedeschi, nel suo libro, Savona aveva sollevato il sospetto che stia "scivolando nuovamente sul piano economico nella direzione proposta dal Piano Funk (dal nome dell allora ministro delle Finanze tedesco, ndr) del 1936. La politica economica che voi suggerite getta le basi per una disgregazione del sogno europeo di pace e di un comune progresso civile". Con l'euro, secondo Savona, la Germania ha obbligato le monete nazionali a confluire "nell'area del marco". Non solo. Facendo leva sulla moneta unica e sul mercato comune è riuscita ad appropriarsi dello sviluppo industriale, lasciando spazio solo all'alleato "storico", la Francia. A tutti gli altri Paesi europei avrebbe, invece, lasciato l'agricoltura e i servizi turistici. "Sono dalla parte di chi è convinto che la leadership di qualcuno o di qualche paese sia indispensabile non solo per la stabilità geopolitica, ma anche per il sano principio meritocratico che, per il bene di tutti, deve vincere il migliore - chiosava, quindi, Savona - ma la leadership, soprattutto se praticata a livello sovranazionale comporta dei doveri in materia di sicurezza e di benessere, che (ad esempio) gli Stati Uniti hanno assolto egregiamente nel Dopoguerra". Secondo Savona, in Europa non avrebbe potuto fare quanto avviato in passato dagli Stati Uniti. "L'organismo biogiuridico dell'euro e quello delle politiche fiscali europee presentano un tipo di funzionamento che rivitalizza la sostanza del Piano Funk", scriveva l'economista che, pur ribadendo la necessità di un'Europa unita e accettando il ruolo della Germania come "il Paese che pone ordine in Europa", chiedeva "un contenuto diverso". A partire, appunto, dalla moneta unica. "In assenza di sufficienti politiche compensative degli shock asimmetrici e di una vera libera circolazione degli input e degli output - spiegava - il cambio dell'euro resterebbe per voi sottovalutato e per altri sopravvalutato e tenderebbe a inglobare nella vostra economia i flussi di capitali internazionali e la crescita industriale". Una deriva che verrebbe accelerata dalle politiche fiscali europee. "Se non volete - concludeva Savona - che finisca ancora una volta male nelle relazioni tra i nostri popoli, non resta che ridiscutere seriamente quali debbano essere le correzioni da apportare ai patti che reggono l'Unione europea".
“Ecco la mia Europa…”. Ora parla il professor Savona, scrive il 27 maggio 2018 "Il Dubbio". La replica dell’uomo al centro dello scontro tra Salvini e il presidente Mattarella: “Voglio un’Ue più forte ma più equa”. “Sintetizzo dicendo: voglio una Europa diversa, più forte, ma più equa”. Si chiude così il comunicato con cui il professor Paolo Savona, l’uomo al centro dello scontro tra Matteo Salvini e il presidente Mattarella, chiarisce la sua posizione rispetto alla Ue. Ecco cosa diceva Savona nel 2014: Nel documento pubblicato oggi sul sito scenarieconomici.it, Savona spiega: “Non sono mai intervenuto in questi giorni nella scomposta polemica che si è svolta sulle mie idee in materia di Unione Europea e, in particolare, sul tema dell’euro, perché chiaramente espresse nelle mie memorie consegnate all’Editore il 31 dicembre 2017, circolate a stampa in questi giorni, in particolare alle pagine 126-127. Per il rispetto che porto alle Istituzioni, sento il dovere di riassumerle brevemente:
Creare una scuola europea di ogni ordine e grado per pervenire a una cultura comune che consenta l’affermarsi di consenso alla nascita di un’unione politica;
assegnare alla BCE le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilità monetaria e della crescita reale;
attribuire al Parlamento europeo poteri legislativi sulle materie che non possono essere governate con pari efficacia a livello nazionale;
conferire alla Commissione Europea il potere di iniziativa legislativa sulle materie di cui all’art. 3 del Trattato di Lisbona;
nella fase di attuazione, prima del suo scioglimento, assegnare al Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo compiti di vigilanza sulle istituzioni europee per garantire il rispetto degli obiettivi e l’uso dei poteri stabiliti dai nuovi accordi”.
E ancora: “Per quanto riguarda la trasposizione di questi miei convincimenti nel programma di Governo – prosegue Savona – non posso che riferirmi al contenuto del paragrafo 29, pagine 53-55, del Contratto stipulato tra la Lega e il M5S, nel quale vengono specificati gli intenti che verranno perseguiti dal Governo che si va costituendo” alla luce delle problematicità emerse negli ultimi anni”;
queste inducono a chiedere all’Unione Europea “la piena attuazione degli obiettivi stabiliti nel 1992 con il Trattato di Maastricht, confermati nel 2007 con il Trattato di Lisbona, individuando gli strumenti da attivare per ciascun obiettivo” che nel testo che segue vengono specificati”.
Secondo Savona “anche per le preoccupazioni espresse nel dibattito sul debito pubblico e il deficit il riferimento d’obbligo e il paragrafo 8 di pagina 17 del Contratto in cui è chiaramente detto che “l’azione del Governo sarà mirata a un programma di riduzione del debito pubblico non già per mezzo di interventi basati su tasse e austerità – politiche che si sono rivelate errate ad ottenere tale obiettivo – bensì per il tramite della crescita del PIL, da ottenersi con un rilancio della domanda interna dal lato degli investimenti ad alto moltiplicatore e politiche di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, sia della domanda estera, creando condizioni favorevoli alle esportazioni”. “Spero di aver contribuito a chiarire – conclude Savona – quali sono le mie posizioni sul tema dibattuto e quelle del Governo che si va costituendo interpretando correttamente la volontà del Paese. Sintetizzo dicendo: Voglio una Europa diversa, più forte, ma più equa”. Insomma, il professor Savona non solo non fa alcun passo indietro – l’insistenza sul suo nome sta infatti portando a una situazione di stallo politico e istituzionale – ma rilancia il suo programma sull' “altra Europa”.
Ed alla fine il prof. Savona parlò…dimenticando un passato scomodo, scrive "Il Corriere del Giorno" il 27 maggio 2018. Il prof. Savona affida al sito Scenari Economici la sua prima dichiarazione che lo riguarda, in merito alle sue posizioni sulle politiche economiche europee e prova a difendersi dalle accuse di antieuropeismo. Dice di credere all’unione politica. Valorizza il ruolo dell’Europarlamento. Giro di telefonate in corso per evitare la rottura. Il premier incaricato potrebbe andare al Colle entro stasera per un colloquio informale. Comunicato Prof. Paolo Savona 27 maggio 2018 h. 13.20 “Non sono mai intervenuto in questi giorni nella scomposta polemica che si è svolta sulle mie idee in materia di Unione Europea ed, in particolare, sul tema dell’euro, perché chiaramente espresse nelle mie memorie consegnate all’Editore il 31 dicembre 2017, circolate a stampa in questi giorni, in particolare alle pagine 126-127. Per il rispetto che porto alle Istituzioni, sento il dovere di riassumerle brevemente”:
– Creare una scuola europea di ogni ordine e grado per pervenire a una cultura comune che consenta l’affermarsi di consenso alla nascita di un’unione politica…
– Assegnare alla BCE le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilità monetaria e della crescita reale…
– Attribuire al Parlamento europeo poteri legislativi sulle materie che non possono essere governate con pari efficacia a livello nazionale…
– Conferire alla Commissione Europea il potere di iniziativa legislativa sulle materie di cui all’art. 3 del Trattato di Lisbona…
– Nella fase di attuazione, prima del suo scioglimento, assegnare al Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo compiti di vigilanza sulle istituzioni europee per garantire il rispetto degli obiettivi e l’uso dei poteri stabiliti dai nuovi accordi.
Per quanto riguarda la trasposizione di questi miei convincimenti nel programma di Governo non posso che riferirmi al contenuto del paragrafo 29, pagine 53-55, del Contratto stipulato tra la Lega e il M5S, nel quale vengono specificati gli intenti che verranno perseguiti dal Governo che si va costituendo “alla luce delle problematicità emerse negli ultimi anni“; queste inducono a chiedere all’Unione Europea “la piena attuazione degli obiettivi stabiliti nel 1992 con il Trattato di Maastricht, confermati nel 2007 con il Trattato di Lisbona, individuando gli strumenti da attivare per ciascun obiettivo” che nel testo che segue vengono specificati. Anche per le preoccupazioni espresse nel dibattito sul debito pubblico e il deficit il riferimento d’obbligo è il paragrafo 8 di pagina 17 del Contratto in cui è chiaramente detto che “L’azione del Governo sarà mirata a un programma di riduzione del debito pubblico non già per mezzo di interventi basati su tasse e austerità – politiche che si sono rivelate errate ad ottenere tale obiettivo – bensì per il tramite della crescita del PIL, da ottenersi con un rilancio della domanda interna dal lato degli investimenti ad alto moltiplicatore e politiche di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, sia della domanda estera, creando condizioni favorevoli alle esportazioni.” Spero di aver contribuito a chiarire quali sono le mie posizioni sul tema dibattuto e quelle del Governo che si va costituendo interpretando correttamente la volontà del Paese. Sintetizzo dicendo: Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa. Paolo Savona
Quello che non tutti raccontano…e qualcuno dimentica! Quello che il prof. Savona ha dimenticato di raccontare è una sua vecchia vicenda penale, quando il giudice per l’ udienza preliminare di Milano, Marco Maria Alma, emise ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti di Piergiorgio Romiti, Paolo Savona all’ epoca dei fatti rispettivamente amministratore delegato e presidente di Impregilo ed un revisore dei conti, Maurizio Serafini, indagati nel procedimento Imprepar-Impregilo relativo ai presunti reati di “aggiotaggio” e “falso in comunicazioni sociali” commessi da Impregilo. La procura di Milano aveva chiesto il rinvio a giudizio per falso in bilancio e aggiotaggio n in relazione ai bilanci 20022003. La richiesta di processo inoltrata dal pubblico ministero, Eugenio Fusco, arrivava dopo che il giudice per le indagini preliminari, Caterina Interlandi, aveva respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Il processo a Milano che vedeva imputato per aggiotaggio Paolo Savona venne dichiarato “chiuso per prescrizione” del reato, proprio quella prescrizione che Lega e M5S vorrebbero debellare! Secondo l’accusa, Savona e Romiti avrebbero comunicato false informazioni al mercato per alterare il valore delle azioni nelle sedute di borsa del 25 febbraio, del 10 marzo e del 30 dicembre 2003. In aula successivamente nel corso del dibattimento processuale il pm Eugenio Fusco venne costretto dalle norme di legge vigenti, a chiedere l’applicazione della prescrizione. Le difese chiaramente non si opposero ed il prof. Savona si guardò bene dal rinunciare alla prescrizione e quindi e il Tribunale di Milano dovette dichiarare l’intervenuta prescrizione in base alla legge Cirielli, che aveva ridotto i tempi. E tutti si salvarono felici e contenti…
Salvini non molla su Savona: "No a ministro per i tedeschi". Il leader della Lega difende il prof euroscettico: "Non sceglieremo un nome che piace alla Germania", scrive Luca Romano, Sabato 26/05/2018, su "Il Giornale". Matteo Salvini non chiude la partita con il Quirinale sul nome di Savona per l'Economia. Il leader del Carroccio ha le idee chiare e nella squadra di governo vuole il prof anti-euro che è già stato ministro con il governo Ciampi. Dopo lo scontro di ieri con Mattarella e quello sfogo su Facebook ("Sono molto arrabbiato"), oggi arrivano nuove parole dure e pesanti sempre sui social. Il leader del Carroccio commenta le ingerenze della stampa estera che di fatto ha messo nel mirino il nostro Paese dopo il preicarico affidato a Giuseppe Conte. Insulti e vignette che dipingono gli italiani come "scrocconi" e il Paese sull'orlo del baratro con M5s e Lega. Salvini commentando queste reazioni manda un altro messaggio chiaro al Colle e all'Europa: "Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani". Parole chiare che accendono ancora di più il braccio di ferro. Sul nome di Savona potrebbe cadere già il fragile governo che Conte sta cercando di mettere in piedi. La Lega potrebbe anche arrivare allo strappo definitivo. In quel caso lo scenario possibile è uno solo: voto anticipato. E questa ipotesi che negli ultimi giorni pareva abbastanza lontana, adesso torna prepotentemente di attualità.
Salvini e Di Maio all’attacco del Colle: non ci vuole al Governo, scrive V. Nuti il 27 maggio 2018 su "Il Sole 24 ore". «Mi piacerebbe che l'Italia tornasse a essere un paese libero e non un paese a sovranità limitata». Reduce da un lungo (e segreto fino a cose fatte) colloquio pomeridiano al Quirinale, il leader della Lega in trasferta a Terni lancia un duro affondo politico proprio mentre sul Colle è in corso il faccia a faccia tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier incaricato Giuseppe Conte. Nelle sue parole molti riferimenti diretti al “caso Savona”, il ministro dell’Economia in pectore che ha portato al lo scontro con la presidenza della Repubblica. «Se il professor Savona non può fare il ministro perché ha il difetto di difendere i cittadini italiani mettendo in discussione le regole europee, allora io se vado al governo ci porto il professor Savona», ha spiegato ai simpatizzanti del Carroccio sottolineando «Mai servi di nessuno, mai».
«In Italia Se hai criticato l'Europa non puoi neanche fare il ministro». Si può parlare di strappo, almeno sotto il profilo del bon ton istituzionale, anche per la reazione a caldo del leader del M5S, Luigi Di Maio, che decide di lanciare una diretta Facebook per commentare il naufragio del governo giallo verde proprio mentre sul Colle i giornalisti assistono alle dichiarazioni del presidente Mattarella. Anche nel suo caso, parole di fuoco contro l’inquilino del Quirinale. «In questo Paese puoi essere un criminale condannato, un condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi avere fatto reati contro la pubblica amministrazione, puoi essere una persona sotto indagine per corruzione e il ministro lo puoi fare ma se hai criticato l'Europa non puoi permetterti neanche di fare il ministro dell'Economia in Italia. Ma non finisce qui», ha minacciato parlando ai suoi follower. «Per noi l'Italia è sovrana: se si vuole impedire un governo del cambiamento allora ce lo devono dire chiaramente. Sono molto arrabbiato»., ha poi aggiunto ricordando gli sforzi recenti per uscire dallo stallo politico: «Stiamo lavorando da decine e decine di giorni, dalla mattina alla sera, per assicurare un governo a questo Paese: ma la verità è che stanno facendo di tutto per non mandare il M5s al governo di questo paese».
Di Maio: inutile votare, i governi li decidono sempre gli stessi. La scelta di Mattarella «è incomprensibile, allora inutile votare, governi li decidono sempre gli stessi», si è sfogato ancora Di Maio, poco prima di rivelare la composizione del quasi governo M5S-Lega che avrebbe visto lui e Salvini vicepresidenti del Consiglio dei ministri con rispettivamente l'incarico allo Sviluppo economico e agli Interni. Paolo Savona sarebbe andato all'economia. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarebbe stato il leghista Giancarlo Giorgetti.
Salvini: «Se condizionato dall'Europa il governo con Lega non parte». A Terni, prima di concedersi un bagno di folla con una lunga passeggiata tra i militanti della Lega, Salvini ha poi insistito nella difesa della sua scelta del professor Savona per il dicastero di via XX settembre dalle ingerenze degli altri paesi Ue, la Germania in particolare. «Per il governo che ha in mano il futuro dell'Italia decidono gli italiani, se siamo in democrazia. Se siamo in un recinto dove possiamo muoverci ma abbiamo la catena perché non si può mettere un ministro che non sta simpatico a Berlino, vuol dire che quello è ministro giusto e vuol dire che se ci sono ministri che si impegnano ad andare ai tavoli europei» a difendere gli interessi italiani «parte il governo, se il governo deve partire condizionato dalle minacce dell'Europa il governo con la Lega non parte».
Salvini: Savona autorevole, sarebbe un vanto per governo e Paese. «Chi non vuole Governo lo spieghi a 60 milioni di italiani». «Se un ministro dà fastidio a certi poteri che ci hanno massacrato questo vuol dire che è il ministro giusto», ha proseguito rivolgendosi alla piazza che lo applaude: «Vuol dire che se ci sono ministri che si impegnano ad andare ai tavoli europei a difendere i diritti, il lavoro e la salute dei cittadini italiani parte il Governo, se invece deve partire dalle imposizioni e dalle minacce dell'Europa il Governo con la Lega non parte». Poi un monito esplicito indirizzato al Quirinale: «Noi ce l'abbiamo messa tutta, se qualcuno si prenderà la responsabilità di non far nascere un governo pronto domani mattina, lo vada a spiegare a 60 milioni di italiani».
Renzi: indegno minacciare Mattarella, sulle istituzioni non si scherza. In serata le parole di Salvini provocano la reazione indignata dell’ex premier Matteo Renzi, che affida il suo pensiero ad un tweet schierato apertamente a difesa del Quirinale: «Salvini non voleva governare: ha fatto promesse irrealizzabili, ha paura delle sue bugie, altro che Flat Tax e Fornero. E quindi ha usato l'alibi di un ministro per far saltare tutto: vecchio stile leghista. Ma minacciare #Mattarella è indegno. Sulle Istituzioni non si scherza».
Di Maio: "C'è un problema di democrazia", scrive il 27 maggio 2018 AdnKronos. "Abbiamo un grande problema in Italia che si chiama democrazia. Questa non è una democrazia libera se stiamo in queste condizioni". Così Luigi Di Maio, leader M5S, nel corso di una diretta Facebook. "Sono stato un profondo estimatore del Presidente della Repubblica Mattarella ma questa scelta per me è incomprensibile perché ce l'abbiamo messa tutta" e nel contratto di governo "non c'era l'uscita dall'euro" ma "la rivisitazione di alcune regole europee".
INUTILE ANDARE A VOTARE - "Diciamocelo chiaramente che è inutile andare a votare - attacca Di Maio -, tanto i governi li decidono le agenzie di rating e le lobby finanziarie e bancarie". Se si vuole impedire un governo del M5S e della Lega ce lo devono dire chiaramente perché oggi ce l'hanno dimostrato. Io sono molto arrabbiato... ci abbiamo messo oltre 80 giorni. La verità è che stanno facendo di tutto per non mandare il M5S al governo del Paese". "Non so nei prossimi mesi cosa succederà, noi ci siamo, il M5S ci sarà sempre ma con una consapevolezza differente".
DI MAIO, ECCO I NOMI CHE ABBIAMO FATTO - Di Maio ha letto la lista dei potenziali ministri, sottoposta oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal premier incaricato Giuseppe Conte. Di Maio e Salvini sarebbero dovuti diventare entrambi vicepresidenti del Consiglio, il primo destinato a ricoprire l'incarico di ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e il secondo dell'Interno. La lista prevedeva: Riccardo Fraccaro ai Rapporti col Parlamento e alla democrazia diretta; Giulia Bongiorno alla Pa; Enrica Stefani agli Affari Regionali e alle Autonomie; Barbara Lezzi al Ministero per il Sud; Lorenzo Fontana al Ministero per la Disabilità; Luca Giansanti agli Esteri; Alfonso Bonafede alla Giustizia; Elisabetta Trenta alla Difesa. E ancora: Paolo Savona all'Economia; Gian Marco Centinaio alle Politiche agricole; Mauro Coltorti alle Infrastrutture e ai Trasporti; Marco Bussetti all'Istruzione; Alberto Bonisoli al Mibact; Giulia Grillo alla Salute; Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. "Questa - ha detto il leader M5S - era la squadra di governo che lunedì mattina poteva giurare al Quirinale".
L'ATTACCO AD ALFANO E LA REPLICA - "In questo Paese puoi essere un criminale, condannato per frode fiscale, puoi essere Angelino Alfano - dice Di Maio -, puoi essere una persona sotto indagine per corruzione e il ministro lo puoi fare, ma se hai criticato l'euro e l'Europa non puoi permetterti neanche di fare ministro dell'Economia. Ma non finisce qui". Pochi minuti dopo la replica di Angelino Alfano. ''Di Maio: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita politica. Di Maio sei uguale a niente. Sciacquati la bocca prima di parlare di me. In tribunale risponderai di ciò che hai detto''.
Di Maio e Di Battista chiedono l'impeachment per Mattarella. E a Salvini: "Non si tiri indietro". Il leader della Lega per ora glissa. Berlusconi: "5 stelle irresponsabili". Renzi: "Indegno minacciare Mattarella", scrive Gabriella Cerami su "L'huffingtonpost.it" il 27 maggio 2018. I vertici del M5s chiedono l'impeachment di Sergio Mattarella. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista vogliono lo stato d'accusa per il presidente della Repubblica. "Bisogna parlamentarizzare tutto anche per evitare reazioni della popolazione", ha detto Di Maio telefonando a Che tempo che fa di Fabio Fazio. "Non lo facciamo a cuor leggero", ha ribadito Alessandro, insieme a Di Maio su un palco per un comizio a Fiumicino. Non solo. Sull'attacco al Colle i pentastellati chiedono l'unità dell'asse giallo-verde. "La Lega non può tirarsi indietro, sennò dimostra di non voler andare fino in fondo", ha continuato Di Maio. Ma Salvini - pur criticando fortemente l'operato del Colle - per ora non vuole sentirne parlare. "Mattarella non mi rappresenta ma all'impeachment e cavilli penserò domani. Ora devo sbollire la rabbia", ha detto il leader leghista su fb. Il ribaltamento della strategia grillina è plateale. In questi tre mesi Luigi Di Maio, molto più di Matteo Salvini, aveva curato i rapporti con il Quirinale abbandonando i vecchi toni M5s talvolta scomposti. Nel giro di poche ore il format è stato totalmente rovesciato. Di Maio viene convocato da Mattarella, davanti al quale il capo grillino alza un muro, tiene fede all'accordo con i leghisti: "O Savona al ministero dell'Economia o morte". I pentastellati tornano sulle barricate. Il big M5s va via dal Quirinale da un'uscita secondaria, è scuro in volto, parla a telefono. Come ai tempi di Giorgio Napolitano, M5s è tornato a scontrarsi con il Quirinale. I tempi dicono tutto. Di Maio non aspetta neanche di ascoltare cosa Mattarella ha da dire. Il presidente della Repubblica parlava in diretta su tutti i tg e il capo politico 5Stelle nello stesso tempo era in diretta Facebook per annunciare "un conflitto tra le istituzioni che non si era mai visto prima". Nel Movimento ora si invoca quindi l'impeachment facendo riferimento all'art. 90 della Costituzione secondo il quale "Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri". In sostanza, spiegano i 5Stelle, si accusa il Capo dello Stato di aver impedito la nascita del nuovo governo mettendo quello che viene definito "un veto" sul ministro dell'Economia Paolo Savona e violando la legge nell'esercizio delle sue funzioni. Nei fatti Di Maio inizia la campagna elettorale consapevole che non potrà farsi oscurare da Salvini, cosa successa negli ultimi giorni quando per esempio venerdì scorso ha solo messo un "like" al post al segretario leghista che si diceva "davvero arrabbiato". Ora il capo grillino, che deve stare attento anche a non rimanere schiacciato dal ritorno in campo di Di Battista che per primo ha invocato la piazza contro le decisioni del Colle, ha deciso di mettere nel mirino in Quirinale. Duro anche Carlo Sibilia, più da opposizione che da governo: "Non esiste mandare nel caos il paese per fini ideologici. Credo sia arrivato il momento per impeachment a Mattarella. È una strada obbligata e coerente". Ha invocato l'impeachment anche Giorgia Meloni che a nome di Fratelli d'Italia "chiederà al Parlamento italiano la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento a norma dell'articolo 90 della Costituzione perché di gente che fa gli interessi delle nazioni straniere e non degli italiani ne abbiamo vista fin troppa". Allineati in difesa del capo dello Stato ci sono invece Partito democratico e Forza Italia. "Il movimento Cinque stelle che parla di impeachment è come sempre irresponsabile", dichiara Silvio Berlusconi. E poi scrive Matteo Renzi su twitter: "Salvini non voleva governare. Ha fatto promesse irrealizzabili, ha paura delle sue bugie, altro che flat tax e Fornero. E quindi ha usato l'alibi di un ministro per far saltare tutto: vecchio stile leghista. Ma minacciare Mattarella è indegno. Sulle istituzioni non si scherza". Adesso si attende Salvini che per ora su questo argomento non si esprime: "Impeachment? Di questo non parlo. Sono profondamente incazzato che dopo settimane di lavoro, in mezz'ora ci hanno detto che questo governo non doveva nascere". Lo scontro tra istituzioni è solo all'inizio. Così come la campagna elettorale.
Di Maio e Salvini hanno già vinto (e chi li voleva fermare ha sbagliato tutto). Il veto su Paolo Savona squarcia il velo d’ipocrisia sulle condizioni dell'Italia e porta dritti alla battaglia finale tra europeisti e sovranisti. Una partita a cui Lega e Cinque Stelle arrivano nelle migliori condizioni possibili. Era davvero necessario, che finisse così, caro Presidente? Scrive Francesco Cancellato il 28 Maggio 2018 su "L'Inkiesta". Ieri hanno vinto loro, Di Maio e Salvini. Lo diciamo a malincuore, noi che mai abbiamo avallato la tesi di un Paese a sovranità limitata, di un’Europa fonte di tutti i mali dell’Italia, di una dialettica tra popolo e Palazzo, tra cambiamento e status quo. Hanno vinto loro, perché queste tesi, da oggi, sarà molto difficile negarle. Molto semplicemente, perché Sergio Mattarella, con una scelta e un discorso tanto onesti quanto pericolosi, ha di fatto dato a Lega e Cinque Stelle tutti gli argomenti possibili per giocare la prossima campagna elettorale secondo questo schema. Sarà molto difficile negare, ad esempio, che il nome di Paolo Savona come ministro dell'economia non abbia ricevuto un veto da soggetti che non dovrebbero intervenire nel gioco democratico di questo Paese, siano essi le cancellerie di Germania e Francia o la Banca Centrale Europea, il nostro primo creditore. Sarà difficile perché è stato lo stesso Mattarella a dirlo, affermando che il ministro dell’economia è «un messaggio immediato per gli operatori economici e finanziari» e che non ha accettato il nome di Savona proprio perché sarebbe stato visto come sostenitore di linee che avrebbero potuto «provocare la fuoriuscita dell'Italia dall’euro». Tradotto dalla lingua del Quirinale: se avessi avallato la scelta di Paolo Savona, domani sarebbe iniziata una tempesta perfetta sui titoli di Stato italiani. Vero? Falso? Non lo sapremo mai. Ma, ancora, da domani sarà difficile, se non impossibile, negare che l’Italia sia un Paese a sovranità limitata. Spiacenti, anime belle: siamo l’unico Paese d’Europa, l’unico insieme alla Grecia, che non può permettersi di scegliersi in santa pace i suoi ministri. E il motivo è piuttosto semplice: se hai un debito pubblico di 2.300 miliardi, pari al 131% del prodotto interno lordo, e se le agenzie di rating hanno valutato i tuoi titoli di Stato BBB, a due soli gradini dalla nomea di “junk bond”, titoli spazzatura, che vorrebbe dire fine degli acquisti da parte della banca centrale europea, il tuo creditore, chi ti presta i soldi per sopravvivere, ha voce in capitolo sulle tue scelte. Tanto quanto il popolo, forse più del popolo. E allora è vero pure questo: che il prossimo voto sarà una sfida al calor bianco tra chi vuole riaffermare qui e ora la piena sovranità dell’Italia, anche a costo di saltare per aria, e chi ritiene che questa sovranità la si riconquisti giorno dopo giorno, attraverso la progressiva riduzione della dipendenza dai soldi altrui, anche a costo di sacrifici e scelte dolorose. Tra chi ritiene che l’Euro sia parte del problema, giogo che ci condiziona a essere come gli altri vorrebbero che fossimo, o soluzione, in quanto veicolo di un processo di normalizzazione delle nostre anomalie. Tra chi vuole che l’Italia sia parte degli Stati Uniti d’Europa, prima o poi, e chi ritiene che l’Italia debba essere l’Italia, e basta. Un frame politico che combacia alla perfezione con la narrazione di Matteo Salvini e della Lega, il vero vincitore di questa serata, ben più di Di Maio, tanto da far venire il dubbio che in qualche modo questa crisi sia stata pilotata ad arte per arrivare allo showdown di queste ore. Il bivio a cui ci troviamo oggi è esattamente quello cui Lega e Cinque Stelle volevano arrivare. Perché i difensori della volontà del popolo, della sovranità piena e illimitata, della democrazia che prevale sulle relazioni internazionali, sempre e comunque sono loro. Laddove gli altri si ergono a difesa di un palazzo, il Quirinale, di una moneta, l’Euro, di un’istituzione, l’Unione Europea. Se queste sono le premesse, dicevamo, la sfida che attende il fronte che si erge a difesa del Quirinale e dell’Europa è più che improba. Perché il bivio a cui ci troviamo oggi è esattamente quello cui Lega e Cinque Stelle volevano arrivare. Perché i difensori della volontà del popolo, della sovranità piena e illimitata, della democrazia che prevale sulle relazioni internazionali, sempre e comunque sono loro, laddove gli altri si ergono a difesa di un palazzo, il Quirinale, di una moneta, l’Euro, di un’istituzione, l’Unione Europea. Perché sono riusciti ad arrivare allo scontro finale contro avversari, il Pd e Forza Italia, più che in crisi nera, dilaniati di lotte interne e in crisi verticale di consenso. E allora, forse, quello di Mattarella, seppur ineccepibile nei contenuti e nella forma, è stato un enorme azzardo, che rischiamo di pagare a caro prezzo, molto più della nomina di Paolo Savona. L’avesse avallata, oggi ci troveremmo con un ministro dell’economia scomodo, sotto i riflettori, ma sotto la tutela di un programma che di uscita dall’Euro non parlava, di un presidente del consiglio incaricato che aveva fatto professione di fede europeista e, pur con tutte le ambiguità e gli omissis, pure di un messaggio di Savona stesso, arrivato a poche ore dall’Apocalisse, che a quello stesso programma e a quella stessa professione di fede faceva riferimento, per disinnescare le perplessità sulla sua figura. E con un governo, finalmente, dopo quasi novanta giorni, nel pieno esercizio delle sue funzioni, compresa quella di disinnescare l’aumento dell’Iva e di contribuire al futuro dell’Unione, a partire dal prossimo Consiglio Europeo. Ci ritroviamo, invece, con un governo che aveva i numeri respinto sull’uscio, con un nuovo presidente incaricato, Carlo Cottarelli, cui con ogni probabilità, verrà negata la fiducia dal Parlamento, con la messa in stato d’accusa del presidente della repubblica per alto tradimento, richiesta che avrebbe i numeri per essere approvata dal Parlamento, e che solo Matteo Salvini, uno che fino a qualche mese fa indicava Ciampi e Napolitano come traditori della patria, avrebbe il potere di disinnescare e con una campagna elettorale durissima che è già iniziata e che minaccia di alzare il livello dello scontro sociale a livelli da 1948, se non peggio. Tutto, per Paolo Savona, che per assurdo tra qualche mese potrebbe addirittura essere indicato come presidente del consiglio da Lega e Cinque Stelle, dovessero stravincere come ha preconizzato Massimo D’Alema in fuori onda di qualche giorno fa. Fare peggio, francamente, era davvero difficile.
In principio fu Sandro Pertini. Così cambiò il ruolo del Quirinale. La svolta nello stile comunicativo e istituzionale. Due volumi sui presidenti della Repubblica curati da Sabino Cassese, Giuseppe Galasso e Alberto Melloni (il Mulino), scrive Giovanni Belardelli il 30 maggio 2018 su "Il Corriere della Sera". «I presidenti della Repubblica» (il Mulino, pagine 1269, euro 120, in libreria dal 21 giugno). Per una singolare coincidenza, il Mulino ha dato alle stampe due corposi volumi sui presidenti della Repubblica (in uscita il 21 giugno) proprio quando la crisi politica seguita alle elezioni del 4 marzo ha riportato all’attenzione l’importanza che la prima carica dello Stato riveste nel nostro ordinamento. Con una trentina di autori e oltre 1200 pagine, l’opera è destinata a rappresentare un riferimento imprescindibile. Concorrono a ciò l’autorevolezza dei curatori: Sabino Cassese, Alberto Melloni e Giuseppe Galasso (il cui saggio introduttivo si legge con una certa emozione, essendo l’ultima cosa da lui scritta prima della scomparsa nello scorso febbraio); ma soprattutto vi concorre l’ampiezza degli argomenti presi in esame: dalle biografie di ciascuno degli inquilini del Quirinale alla struttura della presidenza, dal linguaggio utilizzato dai vari capi dello Stato alla loro presenza sulla scena internazionale. Come più volte è stato ricordato, l’Assemblea costituente, volendo marcare una netta cesura rispetto a ogni idea di «uomo forte», aveva finito col fare del capo dello Stato una figura non ben definita, dalle attribuzioni vaghe ed elastiche. Di qui una presidenza della Repubblica dai poteri «a fisarmonica», secondo un’immagine spesso utilizzata, che si estendono o riducono in relazione alla forza o debolezza del governo e delle forze politiche. In una situazione di crisi — ha notato Leopoldo Elia — si ampliano quei poteri presidenziali «di indirizzo e di impulso che nei periodi normali rimarrebbero silenti». Proprio la storia degli ultimi decenni sembra indicare però che i poteri del presidente, soprattutto quelli meno evidenti e formali, possono crescere anche in relazione a un altro fattore: la personalità e le inclinazioni più o meno «interventiste» del capo dello Stato. Nella Repubblica federale tedesca sia Konrad Adenauer sia Ludwig Erhard rifiutarono la candidatura alla presidenza della Repubblica, nota Sabino Cassese. Nulla di simile è mai accaduto in Italia, dove anzi molti leader politici hanno aspirato al Quirinale, così da confermare come i poteri del nostro capo dello Stato siano superiori a quelli del suo omologo tedesco. Secondo il giudice costituzionale (ed ex azionista) Mario Bracci, che lo scriveva nel 1958 all’allora presidente Giovanni Gronchi, la lettera e lo spirito della Costituzione renderebbero addirittura possibile muoversi verso un «tipo originale di Repubblica presidenziale». Nessun presidente della Repubblica ha mai esplicitamente battuto questa via; ma proprio dai due corposi volumi appena usciti si ricava come, sia pure con eccezioni e battute d’arresto, è nella direzione di un semipresidenzialismo di fatto, come a volte lo si è definito, che si è mossa la Costituzione materiale del Paese. Si pensi allo stesso Luigi Einaudi, che nella prima parte del mandato era sembrato voler incarnare il modello del presidente-notaio e aveva poi assunto una fisionomia alquanto diversa: nel 1953, senza procedere a consultazioni, diede l’incarico a Giuseppe Pella, che formò il primo di quelli che sarebbero poi stati definiti «governi del presidente». Il suo successore Giovanni Gronchi fu un capo dello Stato decisamente interventista, sia in politica interna che estera. Fu lui il primo a cercare un dialogo diretto con i cittadini, che cozzava però — nota nel suo saggio Michele Cortelazzo — contro le barriere linguistiche ancora forti nel Paese. E cozzava pure con la tradizione di un’oratoria spesso involuta: il discorso di fine anno del 1961 conteneva una frase di ben 118 parole. Forme e sostanza della comunicazione presidenziale sarebbero cambiate definitivamente con Sandro Pertini, in particolare a partire dal discorso da lui pronunciato alla televisione il 26 novembre 1980, tre giorni dopo il terremoto dell’Irpinia, nel quale criticava severamente il governo per la lentezza dei soccorsi. Al presidente della Repubblica spettano poteri fondamentali come quello di sciogliere le Camere o assegnare l’incarico di formare un nuovo governo (potere, per inciso, particolarmente significativo in un Paese che in settant’anni ha avuto 64 governi). Anche questi poteri hanno avuto un’evoluzione nel tempo: Pertini, ad esempio, fu il primo a non seguire la prassi di assegnare l’incarico di formare il governo a un esponente del partito di maggioranza relativa. Ma ciò che è soprattutto significativo è l’espansione che ha interessato i poteri informali del presidente, analizzati nel volume da Marina Giannetto (oltre che dalle varie ricostruzioni biografiche dei singoli capi dello Stato); si tratta essenzialmente di poteri interdittivi, che gli consentono di «interporsi nella produzione legislativa». In concreto, è il presidente che, come stabilisce la Costituzione, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, promulga le leggi, emana decreti legge. In questi casi al presidente spetta una facoltà di diniego della propria firma, ma dunque anche la possibilità di intervenire in anticipo persuadendo il governo a mutare una certa legge o un certo decreto per evitare che egli si trovi poi a esercitare il proprio potere interdittivo. Il capo dello Stato finisce così per condividere nei fatti una porzione del potere legislativo ed esecutivo. Direi che proprio l’aver illustrato questo con molta chiarezza, cioè il posto che il capo dello Stato occupa nella Costituzione scritta ma anche in quella materiale, rappresenta uno dei pregi maggiori di quest’opera. Sabino Cassese e Alberto Melloni si sono recati 30 maggio al Quirinale per presentare al capo dello Stato Sergio Mattarella l’opera in due volumi I presidenti della Repubblica, edita dal Mulino e curata da loro stessi insieme a Giuseppe Galasso, scomparso nello scorso febbraio. Si tratta di un lavoro a più voci nato da un progetto della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII con il contributo di Intesa Sanpaolo. Il presidente Mattarella ha ricevuto i due studiosi insieme al segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti e al consigliere per l’informazione Gianfranco Astori. Dopo aver manifestato il suo apprezzamento per l’opera, disponibile in libreria dal 21 giugno, il capo dello Stato ha assicurato la sua presenza a un prossimo incontro volto a esporne e discuterne i contenuti.
Da Scalfaro a Napolitano: quando l’uomo del Colle ha detto no…Le liste dei ministri sbianchettate all’ultimo secondo: così saltarono Cesare Previti e Nicola Gratteri, scrive Paolo Delgado il 27 Maggio 2018 su "Il Dubbio". «Il Presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri». E’ intorno a questo articoletto della Costituzione, il 92, che si svilupperà nei prossimi giorni il percorso della crisi. E’ dal braccio di ferro che si sta svolgendo intorno al medesimo articolo che dipenderà la nascita o meno del governo gialloverde. Il caso Conte, con i suoi un po’ grotteschi curricula gonfiati, maschera infatti il vero oggetto del contendere che è il ministero chiave dell’Economia. Il solenne art. 92, per la verità, è stato per lunghi decenni oggetto di ricerche nei “Chi l’ha visto?” dell’epoca. La Repubblica dei partiti semplicemente lo ignorava. A decidere tutto erano i capipartito, trattando tutt’al più con il presidente del consiglio incaricato, ammesso che questi avesse qualche forza di suo. Il notaio del Colle si limitava a eseguire. In un paio d’occasioni la poco commendevole abitudine varcò i confini della commediaccia all’italiana, più Pierino che Monicelli. Successe quando nel 1972, in occasione della nascita del secondo Governo Andreotti, con maggioranza Dc- Psdi-Pli, Carlo Donat- Cattin, insoddisfatto del ministero assegnatogli, non si presentò al giuramento sostituendo l’alto impegno con una visitina dal barbiere di Montecitorio. Rientrò giusto un anno dopo, con un nuovo governo e occupando il posto a cui teneva. Oppure quando, dopo la famigerata ‘ lite tra comari’ sull’Economia, quella tra il ministro del tesoro Andreatta e quello delle Finanze Formica, cadde nell’agosto 1982 il governo Spadolini, in carica da poco più di un anno. Gli equilibri tra i partiti erano così delicati che il primo premier non democristiano della Repubblica nel formare il suo secondo governo, dovette confermare tutta la squadra con una sola variazione. Fu necessario cambiare almeno il sottosegretario alla presidenza, essendo il predecessore, Francesco Compagna, trapassato. Il presidente Pertini non proferì verbo. Il ‘ governo- fotocopia’, come fu prontamente ribattezzato diventò bersaglio di pesantissime ironie, contribuì a squalificare la Repubblica dei partiti e durò pochissimo appena cento giorni. Ma il vento stava cambiando. Pochi anni più tardi, nel 1987, il presidente Cossiga entrò per la prima volta in campo d’impeto per sbloccare una crisi che pareva irresolubile, data l’opposizione del Psi all’incarico per il segretario della Dc De Mita. L’inquilino del Quirinale scelse un premier, il più giovane mai entrato a palazzo Chigi nella storia repubblica, Giovanni Goria, ex ministro del Tesoro, 44 anni, nessun potere reale nella Dc. La lista dei ministri che presentò al Quirinale fu riscritta dal presidente quasi per intero ed non era mai successo prima. La svolta arrivò con Oscar Scalfaro, l’apripista dei presidenti monarchi. Dipese dalle circostanze più che dalla volontà dell’uomo. Appena insediato, la tempesta di tangentopoli e del referendum travolse la prima Repubblica. In quella fase di travagliata transizione, la sovranità scivolò in larga misura nelle mani del capo dello Stato. Fu lui a scegliere il governatore di Bankitalia Ciampi, nel 1993, come premier del governo che avrebbe dovuto gestire il Paese mentre il parlamento cercava l’accordo su una nuova legge elettorale. Fu lui a scegliere, con Ciampi e con i leader del Pds Occhetto e dell’agonizzante Dc Martinazzoli i ministri di quel governo. Quando, dopo la vittoria alle elezioni del 1994, il Polo guidato da Berlusconi vinse le elezioni impedì la nomina a ministro della Giustizia di Cesare Previti, chiacchieratissimo avvocato del premier. Dopo la caduta di quel governo, nel giro di pochi mesi, Scalfaro compilò di nuovo la lista dei ministri con il premier, indicato e poi rinnegato dal disarcionato Berlusconi, Lamberto Dini. Il caso Scalfaro poteva essere una sorta di parentesi emergenziale e in effetti il successore, Carlo Azeglio Ciampi, tornò a un minor protagonismo. Ma nella formazione del secondo governo Berlusconi, nel 2001, mise bocca anche lui. Il Cavaliere era ancora circondato da sospetti in Europa. Serviva un garante e Ciampi indicò Renato Ruggiero, diplomatico di serie a, più volte ministro, direttore generale del WTO: l’uomo dei salotti buoni. Fu un disastro. Tra Berlusconi e Ruggiero non scattò alcun feeling, quando il ministro parlava, raccontò più tardi lui stesso, il premier lavorava sotto il tavolo di piedino per ammonirlo con eloquenti calcetti. Con i leghisti andò anche peggio. Pochi mesi e il garante indicato dal capo dello Stato era già fuori dal governo. Quanto a protagonismo, si sa, Napolitano non è stato secondo a nessuno. Il confine tra presidenza della Repubblica e sovranità piena lo ha varcato più volte e in piena consapevolezza. Sui ministri il suo semaforo rosso è scattato in alcuni casi di fondamentale importanza, al momento della formazione del governo Renzi, nel 2014. Renzi si era presentato con la casella del ministero della Giustizia occupata da un magistrato d’assalto, certamente tra i più efficienti ma anche tra i meno attenti alle garanzie, Nicola Gratteri. E’ probabile che quel nome per Napolitano, che ha sempre guardato con poca benevolenza il giustizialismo, non piacesse per una lista di ragioni lunga quanto un elenco del telefono. Ma per bloccarlo mise in campo un’argomentazione di carattere generale: l’inopportunità di affidare il ministero di via Arenula a un magistrato. Alla fine a essere nominato fu uno degli esponenti del Pd più vicini al presidente: Andrea Orlando. Pochi mesi dopo il problema si ripropose quando la ministra degli Esteri, Federica Mogherini, passò alla Commissione europea. Convinto che il Brand del suo governo fosse la linea generazionale, Renzi propose di sostituirla con Lia Quartapelle, 32 anni, esperienza sia politica che diplomatica pari a zero. Napolitano nemmeno prese in considerazione la surreale idea, cancellò il nome suggerito e al suo posto vergò quello del più scafato Gentiloni. Ma ciascuno di questi presidenti, persino Scalfaro e Ciampi alle prese con Berlusconi, erano alle prese con leader per cui i buoni rapporti con i vertici istituzionali, quelli romani quanto quelli allocati a Bruxelles, erano desiderati e ricercati al punto di sacrificare molto per conquistarli. Mattarella si trova in una situazione diversa e molto più scomoda. Vedremo nel giro di pochi giorni se riuscirà nonostante tutto a incidere o se, dopo il colpo a vuoto del governo del presidente, dovrà registrare sulla nomina dei ministri un nuovo scacco.
Meloni e M5S vogliono mettere in stato d’accusa Mattarella, scrive "Next quotidiano" il 27 maggio 2018. Giorgia Meloni in una nota annuncia di voler chiedere con Fratelli d’Italia la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il veto su Savona che ha fatto fallire il governo di Giuseppe Conte: “Si dice che il Presidente della Repubblica abbia messo il veto sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell’Economia, se questa notizia fosse confermata avrebbe dell’incredibile. E se questo veto fosse confermato sarebbe drammaticamente evidente che il presidente Mattarella è troppo influenzato dagli interessi delle nazioni straniere e dunque Fdi nel caso in cui questo veto impedisca la formazione del nuovo Governo chiederà al Parlamento la messa in stato d’Accusa del Presidente per alto tradimento”. Della stessa idea, dice l’ANSA, è il MoVimento 5 Stelle.
Come funziona la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica. È la complicata procedura annunciata da Di Maio contro Mattarella, ma non sembrano esserci le basi per parlarne seriamente, scrive il 28 maggio 2018 “Il Post”. Dopo la crisi istituzionale cominciata ieri sera con la rinuncia all’incarico di presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, dovuta all’opposizione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla nomina di Paolo Savona come ministro dell’Economia, Luigi Di Maio ha detto che chiederà la “messa in stato d’accusa” di Mattarella. Il leader della Lega Matteo Salvini, che insieme al M5S aveva coordinato la formazione del governo Conte, fin qui non ha seguito Di Maio su questa strada: forse perché estrema e senza precedenti, e forse perché, per come stanno le cose, sarebbe molto improbabile avesse successo. L’accusa a Mattarella – che è anche un ex giudice della Corte Costituzionale – sarebbe, in breve, di aver abusato dei suoi poteri opponendosi al nome scelto per un ministero da due partiti che rappresentano la maggioranza del Parlamento, pur non essendosi presentati alle elezioni come alleati. In realtà l’opinione più condivisa dai costituzionalisti di ogni orientamento è che Mattarella abbia agito entro i limiti delle sue prerogative costituzionali, che prevedono che sia il presidente della Repubblica a nominare i ministri su proposta del presidente del Consiglio. Lo ha ribadito oggi al Corriere della Sera Massimo Luciani, costituzionalista e presidente dell’Associazione costituzionalisti italiani, che ha aggiunto che Mattarella «ha ritenuto che la scelta di un certo ministro per una posizione chiave del governo mettesse a rischio gli interessi del nostro paese. Questa è una valutazione istituzionale». Il comportamento di Mattarella può essere criticato per la sua opportunità politica ma non per la sua costituzionalità, anche perché ci sono stati almeno tre precedenti analoghi negli ultimi 25 anni, con protagonisti tre presidenti diversi: nel 1994 Oscar Luigi Scalfaro con Cesare Previti alla Giustizia; nel 2001 Carlo Azeglio Ciampi con Roberto Maroni alla Giustizia; e nel 2014 Giorgio Napolitano con Nicola Gratteri, sempre alla Giustizia. Ciononostante, Di Maio ha annunciato la volontà di mettere in stato d’accusa Mattarella, e lo stesso aveva fatto poco prima la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.
Cosa dice la Costituzione sulla nomina dei ministri. È interessante ricordare che già nel 2013 il M5S aveva a lungo parlato della stessa cosa, ma riguardo Napolitano: allora il leader del partito era ancora Beppe Grillo, e l’accusa era di aver abusato dei suoi poteri nominando il governo Letta (peraltro in circostanze simili a quelle del governo Conte: un’alleanza parlamentare tra partiti che erano avversari in campagna elettorale). Anche in quel caso non c’era nessuna base costituzionale all’accusa, di cui infatti non si fece niente. Nel 2013 si parlava di questa possibilità con il termine “impeachment”, la parola inglese che fa riferimento a un concetto giuridico esistente negli Stati Uniti (storicamente associato ai presidenti Richard Nixon e Bill Clinton). Nel linguaggio giornalistico italiano, però, è usata per definire una procedura prevista dalla Costituzione con la quale il Parlamento può mettere il presidente della Repubblica in stato d’accusa, ma solo in alcuni rarissimi casi. L’articolo 90 della Costituzione dice infatti che «Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione». Sono quindi soltanto questi i reati imputabili al capo dello Stato che ne prevedono le dimissioni forzate. Di Maio, domenica sera, ha parlato del primo: un reato di cui è difficile dare interpretazioni precise, visto che non è mai stato applicato al presidente della Repubblica, ma che prevede un qualche tipo di comportamento doloso che pregiudichi gli interessi nazionali, che rappresenti una violazione del dovere di fedeltà ai cittadini, o che sovverta l’ordine dello Stato. Cesare Pinelli, ordinario di Diritto Costituzionale alla Sapienza, ha detto all’AGI che parlare di questi reati in riferimento alle decisioni di Mattarella «non sta né in cielo né in terra». Perché inizi quello che sarebbe un processo al presidente della Repubblica, la procedura è molto complessa e prevede diversi passaggi. Innanzitutto deve essere presentata formalmente una richiesta di messa in stato d’accusa al presidente della Camera, corredata da tutto il materiale probatorio che la sostenga. Il presidente della Camera trasmette poi il materiale a un apposito comitato, formato dai componenti della giunta del Senato e da quelli della giunta della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere (i cui membri sono nominati dai presidenti delle Camere, e devono rappresentare tutte le forze politiche). Il comitato è presieduto dal presidente della giunta del Senato o da quello della Camera, una legislatura a testa, e può anche promuovere d’ufficio un’indagine sul presidente della Repubblica, di sua iniziativa. Il comitato valuta la legittimità dell’accusa e dopo aver raggiunto un verdetto – votato a maggioranza – presenta una relazione al Parlamento riunito in seduta comune. Oltre ai relatori scelti dal comitato, il regolamento concede ad altri membri del comitato di presentare relazioni di minoranza. Il rapporto esposto al Parlamento contiene le decisioni del comitato, che può scegliere di archiviare il caso se ritiene che le accuse siano infondate o non corrispondano a quelle stabilite dall’art. 90, oppure di avviare la votazione in aula della messa in stato d’accusa. In entrambi i casi il presidente della Camera riunisce nuovamente il Parlamento in seduta comune, che questa volta dovrà esprimersi sull’autorizzazione a procedere. Se il comitato ha deliberato di archiviare il caso, la decisione viene approvata senza il passaggio del voto. Se invece la relazione propone la messa in stato d’accusa, il Parlamento la vota a scrutinio segreto, e la approva se raggiunge la maggioranza assoluta a favore. Con l’autorizzazione a procedere del Parlamento, la questione passa alla Corte Costituzionale, alla quale per questa particolare circostanza vengono affiancati 16 membri aggregati, estratti a sorte da un elenco di persone aventi i requisiti per fare i senatori, e che viene compilato dal Parlamento ogni nove anni. Il Parlamento elegge anche dei rappresentanti dell’accusa, che in pratica faranno da pubblici ministeri durante le sedute della Corte. È quindi la Corte costituzionale così composta che infine decide se applicare la sentenza rendendola inappellabile. È una procedura lunga e complicata e perché arrivi alla conclusione è necessario che un’ampia maggioranza delle forze politiche la sostenga. Per questo in Italia non si è mai proceduto effettivamente con una messa sotto accusa del capo dello Stato. Spesso, però, i partiti hanno usato questa minaccia per obiettivi politici intermedi o per cercare di ottenere le dimissioni spontanee del presidente. Il PCI minacciò la messa in stato d’accusa del presidente Giovanni Leone, da tempo accusato di presunta complicità nello scandalo Lockheed, per cui poi dovette dimettersi. Nel 1991, invece, fu il PDS (assieme ad altri partiti di opposizione) a chiedere che il presidente Francesco Cossiga fosse messo sotto accusa. Le motivazioni erano molto simili a quelle che il M5S aveva mosso a suo tempo contro Napolitano: Cossiga, secondo i firmatari della richiesta, aveva superato i limiti del suo ruolo per «modificare la forma di governo», aveva avviato «l’esercizio di una propria funzione governante» e assunto comportamenti da «capo di un partito».
Breve storia triste dell'impeachment all'italiana. Mentre il M5s valuta la messa in stato di accusa di Mattarella (che è tecnicamente irrealizzabile, almeno per ora), ecco una carrellata dei precedenti italiani, da Segni a Napolitano, scrive Maurizio Stefanini il 28 Maggio 2018 su “Il Foglio”. Luigi Di Maio e Giorgia Meloni lo chiedono, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi lo escludono, Matteo Salvini dice che ci deve pensare. Ma in realtà in questo momento l'impeachment all'italiana nei confronti del presidente Sergio Mattarella sarebbe tecnicamente impossibile. Secondo l'articolo 90 della Costituzione, “il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”. La decisione spetta poi alla Corte Costituzionale, e l'articolo 135 spiega che “nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte” – che sono quindici – anche “sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari”. Solo che per far votare il Parlamento ci vorrebbe prima l'istruttoria disposta dal comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. Un comitato che però non può essere costituito senza che ci sia un governo nel pieno delle sue funzioni, in grado di stabilire chi è maggioranza e chi è opposizione. E la lista dei 45 cittadini è scaduta da tempo. Questa procedura fu applicata una sola volta, ma non contro un presidente. In origine gli articoli 90 e 96 della Costituzione prevedevano la messa in stato di accusa rispettivamente per il presidente della Repubblica e per il presidente del Consiglio e i ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. L'impeachment scattò nel 1977 per il processo sullo scandalo Lockheed contro gli ex ministri della Difesa Luigi Gui, che fu assolto, e Mario Tanassi, che fu invece condannato. Ma nel 1987 un referendum abolì quella Commissione inquirente e, con la riforma costituzionale del 1989, l'equivalente nostrano dell'impeachment restò in vigore per il solo capo dello stato. Un vero impeachment presidenziale in Italia non c'è dunque mai stato. Eppure ben tre presidenti della Repubblica hanno concluso anticipatamente il loro mandato dietro minacce di ricorrere alla messa in stato d'accusa. Primo fra tutti fu Antonio Segni, che il 7 agosto 1964 ebbe un incontro con Giuseppe Saragat e con il presidente del Consiglio Aldo Moro, nel corso del quale il leader socialdemocratico accusò Segni di aver progettato un colpo di stato assieme al generale De Lorenzo, e minacciò di attivare l'articolo 90. Segni fu colto all'istante da un ictus che lo obbligò alle dimissioni. Dopo i sette anni di Saragat fu la volta di Giovanni Leone che, sul finire del suo mandato, fu coinvolto dallo scandalo Lockheed. Accusato di essere il destinatario di mazzette, Leone comparve sulle copertine dei giornali con le corna in testa, mentre Camilla Cederna lo attaccava in un pamphlet violentissimo. Così Dc e Pci lo costrinsero alle dimissioni con sei mesi di anticipo. Il terzo caso fu quello di Francesco Cossiga, il “picconatore”. Il 6 dicembre 1991 il Pci assieme ad altre forze d'opposizione presentò in Parlamento una richiesta di messa in stato d'accusa con ben 29 capi di imputazione. Il Comitato parlamentare si oppose e la procura di Roma, il 3 febbraio del 1992, dispose l'archiviazione. Ad ogni modo, il 28 aprile Cossiga annunciò le sue dimissioni, con due mesi di anticipo rispetto alla fine del suo mandato. Infine, in un paio di casi più recenti, la minaccia di ricorrere alla messa in stato di accusa non ha portato nemmeno alle dimissioni del capo dello stato. E' successo con Oscar Luigi Scalfaro, dopo che aveva obbligato Berlusconi a spostare Cesare Previti dal ministero della Giustizia a quello della Difesa avvallando il “ribaltone” di Lamberto Dini. Forza Italia alzò i toni, Scalfaro rispose in tv con la celebre frase “Io non ci sto”. Ma il presidente della Repubblica concluse comunque il suo mandato. La stessa cosa si è ripetuta nel 2010 con Giorgio Napolitano, quando il deputato del Pdl Maurizio Bianconi accusò il presidente della Repubblica di “tradire la Costituzione”. Napolitano lo sfidò a chiedere l'applicazione dell'articolo 90, senza esito. Fu invece il Movimento cinque stelle, il 30 gennaio del 2014, a depositare contro di lui una richiesta di messa in stato di accusa per attentato contro la Costituzione, in particolare sulla trattativa stato-mafia. Ma l'11 febbraio successivo il Comitato parlamentare archiviò l'istanza come “manifestamente infondata”.
L’aspetto formale e l’aspetto sostanziale. Perché il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sbagliato. E perché chi lo difende è ignorante o in mala fede. La lezione di chi, il dr Antonio Giangrande, non è titolato, se poi i titoli (accademici) si danno per cooptazione e conformità ed omologazione.
Le Disposizioni sulla Legge in generale, dette anche preleggi o disciplina preliminare al codice civile, sono un insieme di articoli (in origine erano 31, poi dopo l'abrogazione delle corporazioni sono diventati in tutto 16) emanati con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 con cui fu anche approvato il codice civile italiano nel 1942. Si tratta di legge ordinaria di livello paracostituzionale, quindi le disposizioni contenute in tali leggi si collocano subito al di sotto del livello costituzionale e poiché statuiscono disposizioni generali si pongono, come la Costituzione Italiana, al di sopra delle altre leggi, comprese le leggi speciali.
Il primo capo (art. 1-9) delinea le fonti del diritto. Il secondo riguarda l'applicazione della legge in generale.
La gerarchia delle fonti (art. 1) ha subìto nel tempo una modifica in senso testuale, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo. Al contempo ha subito un'estensione interpretativa, in quanto, con l'entrata in vigore della Costituzione e a seguito dell'adesione dell'Italia all'Unione europea, vige il principio cosiddetto della preferenza comunitaria, per cui le leggi e i regolamenti come fonte del diritto devono essere applicati solo ove non contrastanti con le norme di diritto comunitario.
Art. 1 Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) (Le norme corporative, abrogato);
4) gli usi (consuetudini).
Art. 2 Leggi: La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
La riserva di legge, inserita nella Costituzione in varie norme: relativa (23, 97 comma2), assoluta (13 comma2), rinforzata (16), formale (72 comma4, 76, 77, 81), ecc., prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal parlamento come previsto dall'articolo 70.
Fonti costituzionali. Al primo livello della gerarchia delle fonti, si pongono la Costituzione, le leggi costituzionali e gli statuti regionali (delle regioni a statuto speciale), i trattati europei. La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida: "lunga" perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi", riguardando anche altre materie, "rigida" in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto aggravato (vedi art. 138 Cost.). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale.
All’interno Art. 139 si legge che “. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.”
In questo caso, nella gerarchia delle fonti i Principi generali, quale è la democrazia, primeggiano sulle restanti disposizioni.
L’articolo 90 della Costituzione dice infatti che «Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione». Spieghiamo perché è responsabile. Partiamo proprio dalla base della Costituzione italiana.
PRINCIPI FONDAMENTALI. "Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (non sulla libertà). La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".
Qui si enuncia il principio fondamentale che incarnano forma e sostanza. La sostanza ci dice che in Italia c’è la democrazia parlamentare (indiretta) come forma di governo e quindi ci dice che la maggioranza dei votanti (non dei cittadini che non votano più, sfiduciati dalla vecchia politica) elegge i suoi legislatori e, tramite loro, i suoi governanti (stranamente mancano i magistrati). L’esercizio del potere popolare prende forma, non sostanza, attraverso l’enunciazione di articoli costituzionali che mai possono violare il principio fondamentale. E non a caso proprio il primo articolo prende in considerazione l’aspetto democratico della vita dello Stato italiano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA "Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta".
Qui si richiama forma e sostanza dell’art. 1. La sovranità popolare esprime, attraverso i suoi rappresentanti, la scelta del Presidente della Repubblica.
"Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse". "Il Consiglio dei Ministri. Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri".
L’art. 88 e 92 sono articoli formali. Norme che delegano al Presidente della Repubblica, con il ruolo di notaio, la verifica di una maggioranza parlamentare democraticamente eletta per esercitare la sovranità popolare di cui all’articolo 1: Se c'è una maggioranza si forma un Governo sostenuto da essa; se non c'è una maggioranza, non c'è Governo e quindi si va a votare per trovarne una nuova.
Si va contro l’articolo 1 (non a caso primo articolo dei principi generali) e quindi contro la Costituzione se alla volontà popolare che esprime un Governo che mira alla tutela degli interessi nazionali si impone la volontà di un singolo (il Presidente della Repubblica) che antepone qualsiasi altra ragione tra cui i principi dell’art. 10. "L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", e dell’art. art. 11. "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". O dell’Articolo 47. “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese".
In conclusione si chiude il parere, affermando che si è concordi con l’iniziativa della messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, anche se il procedimento è complicato e farraginoso, pensato proprio a non dare esiti positivi, in ossequio ad uno Stato di impuniti. Si è concordi perché l’Italia è una Repubblica Democratica Parlamentare; non è una Repubblica Presidenziale.
Il Quirinale ingrato coi suoi grandi elettori. La storia dei presidenti della Repubblica è stata spesso caratterizzata da rapporti conflittuali con gli inquilini di Palazzo Chigi e i segretari dei partiti, scrive Francesco Damato l'8 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". La storia dei Presidenti della Repubblica è stata spesso caratterizzata da rapporti conflittuali con gli inquilini di Palazzo Chigi e i segretari dei partiti che li avevano fatti eleggere. Il Colle quasi sempre ingrato con i suoi grandi elettori. Lo scontro, o la tensione, fra Sergio Mattarella e Matteo Renzi è probabilmente meno forte della rappresentazione fattane sui giornali dai retroscenisti, ma le resistenze opposte dal presidente della Repubblica alla fretta attribuita, a torto o a ragione, al presidente del Consiglio di andare alle elezioni anticipate dopo la dura sconfitta referendaria sulla riforma costituzionale confermano una costante dei rapporti fra il capo dello Stato e chi ne ha maggiormente voluto l’elezione. Ogni inquilino del Quirinale, prima o dopo, ha procurato delusioni o problemi a chi più si è prodigato a mandarvelo. L’unica eccezione è stata quella di Carlo Azeglio Ciampi, mai, ma proprio mai entrato in collisione col suo grandissimo elettore, che fu l’allora segretario dei Ds Walter Veltroni. Mai, però, forse perché, una volta fattolo eleggere, il 13 maggio 1999, alla prima e unica votazione, Veltroni non ebbe materialmente occasione di avere problemi con lui nei sette anni del mandato. Al mio amico Walter non capitò di guidare alcun governo o di gestire in quel periodo passaggi politici particolarmente difficili. Già nel 2001 egli si ritirò, diciamo così, sul Campidoglio per fare semplicemente il sindaco di Roma e ne scese, per l’avventura del Pd, dopo sette anni, quando già era finita l’esperienza di Ciampi al Quirinale. Le altre storie presidenziali sono state tutte di segno diverso.
Di Enrico De Nicola, il primo della lista dei presidenti, neppure affacciatosi peraltro al Quirinale, vi ho già ricordato di recente le dimissioni che minacciava di continuo. E che misero a dura prova i nervi pur saldissimi di un ancora giovanissimo Giulio Andreotti, il braccio destro del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.
Di Luigi Einaudi, anche lui eletto capo dello Stato con la spinta democristiana, vi ho raccontato la sorpresa fatta alla Dc nominando nel 1953 il governo di Giuseppe Pella, così poco gradito al segretario scudocrociato Amintore Fanfani da essere definito freddamente amico e da durare poco più di quattro mesi.
Giovanni Gronchi fu eletto nel 1955 con un’operazione parlamentare a sorpresa su cui scommisero anche le sinistre per superare il centrismo, ma nel 1960 nominò un governo, quello di Fernando Tambroni, che anziché l’interesse dei socialisti si guadagnò i voti dei missini. Scoppiò il finimondo sulle piazze, con morti e feriti, come vi ha raccontato di recente con la sua solita precisione il buon Giuseppe Loteta, testimone di quei drammatici fatti.
Antonio Segni, succeduto nel 1962 a Gronchi per volontà dell’allora segretario della Dc Aldo Moro allo scopo di bilanciare politicamente sul versante moderato la svolta del centro- sinistra, per poco non troncò la collaborazione di governo con i socialisti nella crisi dell’estate del 1964. Allora, confortato dalle assicurazioni del generale Giovanni De Lorenzo di un saldo controllo delle piazze, egli tentò il ritorno al centrismo offrendo la presidenza del Consiglio a Mario Scelba. Che ha raccontato nella sua autobiografia di avere rifiutato, suggerendo di lasciare Moro al suo posto, quando sentì da Segni che c’era di mezzo proprio quel generale, già capo del servizio segreto. Che fu poi accusato di avere predisposto un colpo di Stato, o qualcosa che gli somigliasse.
Interrotto per un grave malore proprio quell’anno il mandato presidenziale di Segni, al Quirinale fu eletto Giuseppe Saragat per impulso sempre di Moro, interessato alla stabilizzazione del centro- sinistra. Ciò avvenne fra le proteste e i mugugni della maggiore corrente del partito dello stesso Moro: quella dei ‘ dorotei’, che lo accusavano di essere troppo indulgente con gli alleati, peraltro avviati verso un tentativo di rafforzamento con l’unificazione socialista. Dopo le elezioni politiche del 1968, quando fu defenestrato proprio dai dorotei, che lo scavalcarono a sinistra realizzando con i socialisti una edizione ‘ più coraggiosa e incisiva’ del centrosinistra, Moro si aspettò inutilmente un aiuto da Saragat. Che non ci pensò proprio di dargli una mano. Anzi, dopo qualche anno, in occasione di una crisi, egli gli tolse malamente un mandato di governo conferitogli su proposta della Dc formalmente perché tardava a chiudere le trattative, in realtà perché sospettava che Moro volesse privilegiare i rapporti con i socialisti a svantaggio dei socialdemocratici, tornati nel frattempo a separarsi dai fratelli o cugini di area.
A Saragat subentrò al Quirinale alla fine del 1971 Giovanni Leone. Che, pur eletto da una maggioranza di centrodestra dopo il fallimento delle candidature di Amintore Fanfani e di Moro, che non era riuscito neppure ad avere la designazione del suo partito, Leone fu un presidente davvero notarile. Egli si limitò a certificare le maggioranze via via prodotte dai risultati elettorali e dai rapporti fra i partiti, nominando il governo Andreotti della centralità con i liberali di Giovanni Malagodi, poi i governi di centro- sinistra di Mariano Rumor e, nuovamente, di Moro, infine i governi monocolori di Andreotti sostenuti in modo decisivo dai comunisti con la formula della cosiddetta solidarietà nazionale.
Subentrato però nel 1978 il tragico sequestro di Moro ad opera delle brigate rosse, Leone non condivise la linea della fermezza adottata dal governo. E, spiazzando i vertici della Dc e del Pci, assecondò la linea ‘ umanitaria’ dei socialisti, condivisa all’ultimo momento nello scudo crociato solo dall’allora presidente del Senato Fanfani.
In particolare, Leone predispose la grazia per Paola Besuschio, compresa nell’elenco dei tredici detenuti per reati di terrorismo con cui i brigatisti rossi pretendevano di scambiare l’ostaggio. Purtroppo i terroristi precedettero il presidente della Repubblica uccidendo Moro prima che la Besuschio fosse graziata. E Leone, sia pure contestato formalmente per altri motivi, bersagliato da una campagna scandalistica condotta sulle tracce di un libro scritto da Camilla Cederna, poi condannata per diffamazione, fu costretto a dimettersi sei mesi prima che scadesse il proprio mandato. Avrebbe ricevuto solo dopo una ventina d’anni le scuse di chi ne aveva voluto la rinuncia: radicali, comunisti e democristiani. Tardi, certo, ma fortunatamente in tempo perché lui si potesse togliere la soddisfazione di ringraziare di persona, essendo ancora vivo.
Dopo Leone arrivò al Quirinale Sandro Pertini, per il quale fu decisivo l’appoggio dei comunisti, che lo preferirono agli altri socialisti proposti dal segretario del partito Bettino Craxi. Ma bastò poco più di un anno al nuovo presidente per sorprendere i vertici sia del Pci sia della Dc conferendo nell’estate del 1979 l’incarico di presidente del Consiglio a Craxi. Che non riuscì a fare il governo per l’indisponibilità della Dc, ma vi riuscì dopo quattro anni rimanendo a Palazzo Chigi sino al 1987. Il danno politico per il Pci fu enorme, per quanto mitigato nel 1992 e nel 1993 dalle disgrazie giudiziarie e politiche dell’avversario, o concorrente. A Pertini nel 1985 subentrò Francesco Cossiga con un’operazione politica condotta personalmente dall’allora segretario della Dc Ciriaco De Mita. Che però nell’ultimo anno del mandato presidenziale dell’amico e collega di partito lo liquidò pubblicamente definendo il suo caso ‘ clinico’. Erano i tempi del Cossiga ‘ picconatore’, che ogni sera, o quasi, ci faceva rifare all’ultimo momento le prime pagine dei giornali per le sue veementi dichiarazioni contro tutti e tutto.
Il successore di Cossiga fu nel 1992, in un clima di emergenza creato dall’attentato mafioso di Capaci al magistrato Giovanni Falcone, il presidente della Camera appena eletto Oscar Luigi Scalfaro. Al quale, per quanto spinto alla fine dall’emozione per la strage mafiosa, aveva preparato il terreno come solo lui sapeva fare Marco Pannella. Che lo considerava come l’uomo più onesto della Dc. Ma, come era già accaduto a De Mita con Cossiga, il leader radicale ripudiò praticamente il suo idolo non perdonandogli la fretta di sciogliere anticipatamente le Camere elette meno di due anni prima, ma soprattutto il giustizialismo esploso in lui con la vicenda di Tangentopoli.
Con Scalfaro, proveniente d’altronde dalla loro professione, i magistrati conquistarono anche la condizione di autorevoli interlocutori del capo dello Stato nella pratica delle consultazioni al Quirinale per la soluzione delle crisi di governo. Toccò, in particolare, al capo della Procura di Milano Francesco Saverio Borrelli di essere chiamato al Quirinale per un’udienza che servì al presidente della Repubblica per decidere che Craxi, benché designato dalla Dc, non potesse ricevere l’incarico di presidente del Consigliere, per quanto non coinvolto ‘ al momento’ nelle indagini Mani pulite sul finanziamento illegale della politica e sulla corruzione che spesso ne conseguiva. ‘ Al momento’, fu evidentemente spiegato a Scalfaro, significava che potesse esserlo in seguito, come accadde dopo qualche mese. Ai sette anni di Scalfaro, che peraltro Craxi aveva contribuito a fare eleggere al Quirinale preferendolo all’allora presidente del Senato Giovanni Spadolini, in corsa dopo la strage di Capaci come una delle due soluzioni ‘ istituzionali’ della successione a Cossiga, seguirono i sette di Ciampi, di cui ho già scritto parlando del ruolo di regista svolto da Veltroni.
Dopo Ciampi fu la volta di Giorgio Napolitano, dal quale il partito d’origine non ebbe certamente sconti, da lui incalzato più volte sulla strada delle riforme e infine fermato nel 2011, esaurita l’esperienza dell’ultimo governo di Silvio Berlusconi, al palo del Gabinetto tecnico di Mario Monti. Che il capo dello Stato preferì alle elezioni anticipate, pur sapendo che avrebbe potuto vincerle quasi come in una passeggiata il Pd guidato da Pier Luigi Bersani.
Adesso è la volta di Mattarella. Che, portato praticamente al Quirinale meno di due anni fa da Matteo Renzi, anche a costo di rompere il cosiddetto Patto del Nazareno con Berlusconi, con tutte le complicazioni che sono derivate sul percorso parlamentare e infine referendario della riforma costituzionale, si è messo di traverso sulla strada di un rapido ricorso alle elezioni anticipate preferita dal presidente uscente del Consiglio come alternativa a un improbabile governo di larghissime intese e di ‘ responsabilità nazionale’. Che sarebbe l’unico, secondo Renzi, a potersi realisticamente porre l’obbiettivo preferito da Mattarella di portare la legislatura alla sua conclusione ordinaria, cioè sino ai primi mesi del 2018. Renzi probabilmente non confesserà mai dubbi o pentimenti sulla scelta compiuta a favore di Mattarella quasi due anni fa, ma qualche amico sta già borbottando e condividendo l’opinione andreottiana che in politica la gratitudine sia il sentimento del giorno prima, non del giorno dopo.
Quando Napolitano esibiva i suoi scatoloni. I traslochi dei politici dal Quirinale e dal palazzo Chigi, scrive Francesco Damato il 13 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". Nel 2013 fecero notizia gli scatoloni di Giorgio Napolitano, che li ostentava orgogliosamente, ma ancora di più la moglie, agli amici che andavano a trovarlo al Quirinale per esortarlo a lasciarsi ricandidare alla fine del suo mandato. Lui, già infastidito da quel "Re Giorgio" che gli davano più o meno affettuosamente i giornali italiani e stranieri, aveva diffuso note e lettere per spiegare come ritenesse anche troppi i sette anni del mandato prescritti dalla Costituzione. E la moglie aggiungeva, di suo, che anche dell’età e della salute del marito bisognasse avere rispetto. Quando qualcuno osava insistere, il presidente lo accompagnava in un ambiente vicino allo studio per mostrare altri scatoloni ancora e dimostrare così come ormai fosse materialmente impossibile ripensarci. Alcuni scatoloni peraltro erano già stati mandati a Palazzo Giustiniani, dove i suoi collaboratori, ma pare anche lui stesso, avevano già preso visione degli uffici destinatagli come senatore di diritto e a vita. Ad un certo punto non s’impantanò, dopo le elezioni politiche e l’avvio della diciassettesima legislatura – il cui numero già aveva messo in ansia l’inquilino del Quirinale da buon napoletano soltanto la crisi di governo. Che quel capoccione di Pier Luigi Bersani si ostinava a voler far chiudere con una soluzione minoritaria, appesa agli umori, cioè ai malumori, di Beppe Grillo. Cosa che toglieva letteralmente il sonno a Napolitano, costretto ad un certo punto a congelare la crisi per affidarne la prosecuzione al successore. Quel capoccione, sempre lui, di Bersani non riuscì come segretario del maggiore partito rappresentato in Parlamento neppure a fare eleggere i due candidati messi in campo per la successione a Napolitano: prima lo stesso presidente del Pd, ed ex presidente del Senato Franco Marini, e poi Romano Prodi, rimasto prudentemente all’estero per risparmiarsi un’arrabbiatura delle sue a casa. Per "Re Giorgio" non ci fu allora scampo. Dovette arrendersi alla processione dei segretari di partito, governatori regionali, sindaci, amici veri o presunti, ed accettare di farsi rieleggere. Egli dovette personalmente rimettere mano in almeno alcuni degli scatoloni del trasloco per disfarli. Altri addirittura dovettero essere riportati da casa al Quirinale. In questa crisi, per fortuna tutta politica e per niente istituzionale, essendo Sergio Mattarella solo al secondo dei suoi sette anni di mandato, gli scatoloni che hanno fatto notizia sono quelli di Matteo Renzi: una quindicina di varia grandezza, mormorano i commessi di Palazzo Chigi. Scatoloni che Renzi in persona ha in gran parte riempito quasi con voluttà, immaginando di deporre ogni cosa quasi avvolta in un manifesto di Beppe Grillo, come per fargli vedere di che pasta fosse davvero l’uomo che lui aveva mandato a quel posto, con disprezzo, in tante piazze d’Italia. Di quegli scatoloni, una volta svuotati nella sua villetta di Pontassieve, chissà cosa deciderà di fare l’immaginifico ‘ taverniere di Predappio’ come Renzi è stato addirittura sentito definire a Montecitorio prima e durante la campagna referendaria da un fedele, anzi da un devoto amico di Massimo D’Alema. Gli scatoloni di Renzi hanno resistito nei pochi giorni trascorsi fra l’annuncio delle dimissioni, quando ancora i risultati del referendum costituzionale e le dimensioni precise della sconfitta non erano ancora definitivi, e l’incarico a Paolo Gentiloni, ad ogni tipo di pressione. A cominciare da quella di Mattarella, spesosi sino all’ultimo perché il dimissionario accettasse un reincarico, rinunciando a inseguire Grillo sulla strada delle teste da far rotolare, anche quando questa diventa la propria. È un inseguimento, questo di Grillo, che anche Napolitano, a dire il vero, ha rimproverato a Renzi durante la campagna referendaria, quando si è pubblicamente doluto che la riforma costituzionale fosse sostenuta più per la riduzione dei senatori e i risparmi, piccoli o piccolissimi che fossero, che per la semplificazione che poteva introdurre nella produzione delle leggi e la maggiore efficienza che poteva garantire al sistema. Corre voce che, sconsolato per non essere riuscito a smuoverlo lui, Mattarella abbia chiesto una mano al comune e autorevole amico Eugenio Scalfari. Che il suo contributo, per quanto inutile, lo ha dato con l’articolo domenicale su Repubblica. In cui, non so se dopo avergli parlato, fra una telefonata e l’altra a Papa Francesco, Barpapà ha dissentito dagli scatoloni e dal trasloco e ha rimandato Renzi a scuola per studiare meglio Cavour e Garibaldi, imparando dall’uno l’arte del governo e dall’altro quella della rivoluzione. Ma temo che Renzi non troverà il tempo per tornare a studiare, avendo deciso di avventurarsi sulla strada non priva di coraggio, ma neppure di rischi, del congresso anticipato del partito, a ridosso delle elezioni anch’esse anticipate, cui egli spera di arrivare entro giugno con l’aiuto combinato di Gentiloni e di Mattarella, alla ricerca di una rapida ‘ armonizzazione’ delle regole, come l’ha chiamata lo stesso presidente della Repubblica. Vasto programma, avrebbe detto il generale De Gaulle.
Poi arrivò Pertini…La svolta al Quirinale in un torrido 8 luglio di 40 anni fa, scrive Francesco Damato l'8 luglio 2018 su "Il Dubbio". In occasione del quarantesimo anniversario dell’elezione dell’indimenticabile Sandro Pertini al Quirinale, che ricorrerà domenica 8 luglio, si sono naturalmente inseguite iniziative, commemorazioni e ricerche d’archivio. Delle quali ha fatto purtroppo le spese il suo diretto predecessore alla Presidenza della Repubblica, Giovanni Leone, già costretto alle dimissioni sei mesi prima della scadenza del mandato sotto l’onda di una campagna denigratoria demolita poi nei tribunali, ma sfruttata politicamente dai due maggiori partiti di allora, il Pci e la sua Dc. Che, dicendo di voler mandare un segnale all’opinione pubblica tanto delusa dai partiti da averne salvato a stento in un referendum il finanziamento pubblico, in realtà non gli vollero perdonare di essersi messo di traverso alla linea della fermezza adottata dal governo della cosiddetta solidarietà nazionale nella gestione del drammatico sequestro di Aldo Moro ad opera delle brigate rosse. Succedutogli dopo quasi un mese, al termine di una lunga serie di votazioni parlamentari da cui era uscito e rientrato grazie ad un’avveduta rinuncia che aveva spiazzato i settori democristiani originariamente ostili, Pertini lanciò il 9 luglio nel discorso di giuramento un segnale di indubbia amicizia a chi lo aveva preceduto. Dopo avere reso omaggio a tutti gli ex presidenti della Repubblica «per l’opera svolta nel supremo interesse del Paese», egli mandò un particolare «saluto al senatore Giovanni Leone, che oggi vive in amara solitudine». Fu proprio quel saluto amichevole che Pertini più di sei anni dopo, il 31 ottobre del 1984, rinfacciò a Leone in una dura lettera, rimasta inedita sino a lu- nedì scorso, quando l’ha pubblicata il Corriere della Sera. «Ti ho sempre difeso, sempre, da accuse infamanti, da maldicenze che toccavano anche i tuoi familiari. Nel mio discorso di insediamento con parole umane, fraterne, ti ho inviato la mia solidarietà. E tu invece, non fai che della maldicenza idiota nei miei confronti. Questa maldicenza gli scrisse Pertini – degrada te, non tocca me. Sputi su un’amicizia ch’era sincera. Non la meriti, come non meriti più da parte mia alcuna umana considerazione. Da oggi non ti difenderò più ma ti abbandonerò “ad bestias”. Questo e solo questo meriti». Nella lettera – di cui è stata trovata una minuta dattiloscritta, firmata da Pertini a mano col suo solo cognome, tra le carte della Fondazione Turati– Centro Studi Sandro Pertini di Firenze presieduta dal professor Maurizio Degli Innocenti e diretta dallo storico Stefano Carretti, come ha riferito Marzio Breda sul Corriere – seguono due P. S., cioè post scriptum, e una nota che aiutano a capire le circostanze in cui maturò l’arrabbiatura di Pertini. Un giornale aveva riferito di un “analfabeta” che Leone avrebbe dato a Pertini in una conversazione con Franco Evangelisti, uomo di fiducia di Giulio Andreotti. Le smentite opposte dagli stessi Leone ed Evangelisti non avevano evidentemente convinto Pertini. Che nel secondo P. S. scrisse a Leone: «Se tu avessi letto solo una parte di quello che ho letto io per vincere la solitudine del carcere e il peso del confino (14 anni!) ti sentiresti una biblioteca ambulante. Quattordici anni di detenzione, sopportati anche per la tua libertà di dire e fare sciocchezze degradanti. Allora tu marciavi fieramente in orbace e se i tuoi allievi non si presentavano in camicia nera, rifiutavi di esaminarli! Meschino opportunismo che ti dovrebbe rendere più umile e più rispettoso di chi ha sacrificato la sua giovinezza anche perché tu ti sentissi libero, ma non per diffamare e dire sciocchezze, bensì per sentirti più uomo, in piedi, e non in ginocchio». Leone doveva essersi lamentato con Evangelisti anche della mancata risposta di Pertini a un suo telegramma di auguri per il compleanno se il presidente nel primo P. S. gliene contestò il contenuto. Che era questo: «Auguri anche miei Leoni». «Come potevo pensare – gli scrisse Pertini – che fosse tuo un telegramma stilato da un quasi analfabeta? Ho pensato che fosse di un mio compagno romano, al quale ho risposto. Questo ti dico per chiarire un equivoco, di cui tu hai fatto un dramma. E adesso vai per la tua strada, che è opposta alla mia, con il tuo animo meschino, con i tuoi rancori stolti, con la tua pochezza. Io vado per la mia, su cui incontro spesso gente che mi ama, mi stima e mi ammira». L’aggiunta finale – quella peraltro sotto la quale c’è la firma a penna – contesta a Leone di avere lamentato le esternazioni pertiniane rispondendo ad una domanda sulla sua presidenza, peraltro elogiata dal settimanale britannico «e oggi anche dal Time». Eppure – lamenta sempre la minuta, ripeto, della lettera pubblicata anche in foto a pagina 31 del Corriere della Sera di lunedì scorso, 2 luglio – «al Congresso dei Giuristi svoltosi di recente a Taormina tutti gli oratori, tutti, hanno elogiato il comportamento da me tenuto nei quasi sette anni di mia presidenza. E i tuoi anni di “presidenza” sono stati elogiati o biasimati?» chiede retoricamente Pertini: retoricamente, perché erano stati forse ignorati, perdurando quell’anno la dannatio memoriae dell’ex presidente. Le scuse a Leone dai suoi critici, che ne vollero e ottennero le dimissioni, sarebbero arrivate solo nel 1998, vent’anni dopo lo scempio che si era fatto di lui. La famiglia di Leone, composta dalla moglie Vittoria e dai figli Mauro, Paolo e Giancarlo, ha scritto al Corriere per manifestare la sua incredulità, non avendo trovato quella lettera nell’archivio del congiunto depositato al Senato. Marzio Breda ha avuto facile gioco nella risposta citando un passo della biografia di Antonio Maccanico, segretario generale del Quirinale ai tempi di Pertini, in cui si racconta dell’intemerata privata e incontenibile del presidente contro il suo predecessore segnalatagli dalla segretaria, senza che lui potesse intervenire per impedirla, come invece avrebbe voluto. Egli era convinto che il capo dello Stato, pur essendo il più popolare fra tutti quelli avvicendatisi nella storia della Repubblica, dovesse essere «protetto dal suo carattere». Potrebbe pertanto essere accaduto che, ricevutala, Leone avesse cestinato quella lettera perché “indigeribile” anche al suo archivio, come ha scritto Breda. Indigeribile, appunto, fu anche per le mie carte una laconica sfuriata epistolare fattami da Pertini nel 1979, dopo una colazione offertami una domenica nella tenuta presidenziale di Castel Porziano. Si era appena consumata una faticosa crisi politica in cui Pertini aveva spiazzato democristiani e comunisti conferendo l’incarico di presidente del Consiglio al collega di partito Bettino Craxi, costretto poi a rinunciarvi e a passare la mano, dopo un passaggio inutile di Filippo Maria Pandolfi, a Francesco Cossiga. Che realizzò un governo di chiusura della stagione della “solidarietà nazionale”, col Pci tornato all’opposizione e il Psi nella maggioranza. Pertini, che aveva con i comunisti un buon rapporto, tanto da essere arrivato al Quirinale l’anno prima soprattutto grazie a loro, che lo preferirono agli altri socialisti proposti da Craxi, prima Antonio Giolitti e poi Giuliano Vassalli, mi disse di essere rimasto sorpreso della loro “ingenuità”. Che era consistita nella speranza di riprendere il rapporto con la Dc dopo le elezioni anticipate di quell’anno, peraltro provocate proprio dalla loro decisione di ritirare l’appoggio al governo Andreotti formato pochi giorni prima del sequestro di Moro. Tornato nella redazione romana del Giornale, riferii della chiacchierata al direttore Indro Montanelli. E concordammo di farne un pezzo che conciliasse il carattere amichevole dell’incontro, con la riservatezza che poteva derivarne, e il dovere d’informare i lettori delle ragioni per le quali il capo dello Stato aveva consentito l’epilogo della stagione della collaborazione parlamentare fra la Dc e il Pci cominciata dopo le elezioni, anch’esse anticipate, del 1976: quelle in cui – aveva detto Moro– c’erano stati “due vincitori”, la Dc e il Pci, obbligati proprio per questo ad accordarsi per garantire la governabilità del Paese, non disponendo né l’uno né l’altro in Parlamento dei numeri necessari per fare da soli, o l’una contro l’altro con alleati insufficienti. Pur nella sua prudenza, senza ricorso alle virgolette, e ribadendo tutto il rispetto politico e gli antichi rapporti fra Pertini e comunisti, con alcuni dei quali egli aveva condiviso il carcere e il confino durante il fascismo, il presidente non gradì l’articolo. Prima egli tentò un po’ maldestramente, in verità, di bloccare il pezzo in tipografia, anticipato alle agenzie, con una telefonata in cui il suo capo ufficio stampa, e mio amico Antonio Ghirelli, minacciò addirittura le sue dimissioni, sentendosi responsabile dell’invito a colazione. Poi fece diffondere una nota di smentita a un’intervista che non era stata pubblicata come tale. Dati i nostri consolidati rapporti di amicizia, cominciati nei corridoi della Camera quando egli era un vice del presidente Giovanni Leone, gli scrissi una lettera rispettosamente amareggiata, ricordandogli ch’egli stesso mi aveva sempre detto, rammaricandosi delle ricorrenti smentite dei politici, che quando si parla con un giornalista, quale peraltro anche lui era avendo diretto giornali, per quanto di partito, non bisogna mai dimenticarne la professione, e i conseguenti obblighi verso i lettori. Anziché chiarire il caso, lo aggravai con quella lettera. Che il giorno dopo Pertini mi rimandò indietro, tramite un Carabiniere motociclista del Quirinale con tanto di stivaloni e casco, scrivendo di suo pugno sulla busta: «Respinto al mittente con invito a non importunare più il destinatario». Nascosi il fatto a Montanelli per evitare che ne facesse il motivo di uno dei suoi pungenti corsivi di prima pagina, con i quali egli aveva già punzecchiato Pertini, che pure gli era simpatico, ma di cui non apprezzava le troppo frequenti dichiarazioni. Passarono quasi due anni e una mattina una telefonata dal centralino del Quirinale mi buttò giù dal letto. Mi passarono Pertini. Che, dimentico di tutto, voleva sfogarsi con me della «nostra colpa», al plurale, per la tragica fine di Alfedrino Rampi, il bambino caduto in un pozzo nelle campagne romane di Vermicino e morto praticamente in diretta televisiva, col presidente della Repubblica sul posto, avendo voluto seguire personalmente i disperati tentativi di soccorso. Mi assunsi, per ritrovata amicizia, tutte le corresponsabilità attribuite da Pertini all’informazione, che avrebbe finito per complicare gli interventi dei vigili del fuoco e di volontari offertisi a raggiungere il bambino rimasto prigioniero nella caduta. Due anni dopo, nel 1983, sempre lui, Pertini, mi ributtò giù dal letto per un’intemerata contro Montanelli, che mi aveva lasciato andar via dal Giornale per un editoriale non pubblicato in difesa di Craxi, di cui il presidente mi chiese perentoriamente una copia, stimando Bettino pure lui, tanto da dargli dopo qualche mese di nuovo l’incarico, questa volta riuscito, di presidente del Consiglio. Allora egli rimproverava al segretario socialista solo di avere cambiato il simbolo del suo Psi con qualcosa che, secondo lui, assomigliava «più a un pennello da barba che a un garofano». Le sfuriate di Pertini erano tanto incontenibili quanto reversibili. Non escludo pertanto che anche al povero Leone egli avesse poi fatto una telefonata amichevole dopo quella pesantissima lettera di rimprovero. Al povero Antonio Ghirelli capitò nel 1980 di essere licenziato in tronco durante una visita di Stato a Madrid per avere diffuso l’opinione critica di Pertini sulla vicenda esplosa a Roma di Cossiga, accusato in Parlamento, su atti trasmessi dalla magistratura piemontese, di avere rivelato da Palazzo Chigi al suo amico e collega di partito Carlo Donat–Cattin un ordine di arresto spiccato contro il figlio Marco per terrorismo. Il giudizio di Pertini sulla opportunità delle dimissioni di Cossiga, poi salvatosi in Parlamento, fu duramente contestato dall’allora segretario della Dc Flaminio Piccoli, al quale venne praticamente offerto come capro espiatorio il portavoce del Quirinale. Che tre anni dopo però sarebbe diventato con Craxi capo ufficio stampa a Palazzo Chigi. «Non potevo rifiutare a Sandro questo piacere», mi confidò Bettino, che per quell’incarico aveva altri per la testa. E avrebbe poi avuto il suo daffare per coordinare il vulcanico e laicissimo Ghirelli col curiale capo della sua segreteria, che era Gennaro Acquaviva. Amici, per carità, ma a modo loro.
70 anni di elezioni, 18 legislature, 64 governi: tutti i volti della Repubblica, scrive il 27 febbraio 2018 "Il Corriere della Sera". Sono passati 70 anni dalle prime elezioni politiche dopo l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. In attesa della 18a legislatura, facciamo un passo indietro e vediamo tutte le campagne elettorali precedenti incominciando da quell'aprile del '48, dominato da una corsa al voto feroce, infuocato dalla contrapposizione tra due blocchi politici. Democrazia Cristiana da una parte e Partito Comunista e Partito Socialista dall’altra duellarono per conquistare ogni singolo cittadino, e l’alzata di scudi contro il mostro comunista consegnò la vittoria elettorale nelle mani della DC capeggiata da Alcide De Gasperi. Il decreto delle urne non aveva lasciato speranze al Fronte Democratico guidato da Palmiro Togliatti: gli italiani avevano accordato allo «scudo crociato» il 48,5% delle preferenze.
In un’Europa spaccata a metà la corsa al voto del ‘48 assume i toni di uno scontro aperto, e mentre il Vaticano chiama alla mobilitazione ogni singola parrocchia nella lotta contro la minaccia di una rivoluzione comunista, il Pci di Togliatti paventa un futuro di sottomissione alle politiche americane. Dalle urne esce un’Italia profondamente divisa: mentre la DC trionfa conquistando il 48,5% delle preferenze, il «Blocco del popolo» ottiene il 31% dei voti alla Camera e un altrettanto magro 30,76% al Senato della Repubblica, e i più radicali chiedono la messa al bando del Partito Comunista. Passate le elezioni la tensione sociale non accenna a placarsi e diventa esplosiva quando il 14 luglio lo studente Antonio Pallante spara a Palmiro Togliatti ferendolo gravemente. È lo stesso segretario del Pci dal letto d’ospedale a evitare la guerra civile, e il giorno successivo la maglia gialla conquistata da Gino Bartali al Tour de France aiuterà a riportare la calma nel Paese. La prima legislatura della Repubblica Italiana, coi suoi 1875 giorni di durata, dall’8 maggio 1948 al 24 giugno 1953, risulterà la più lunga della storia repubblicana.
Nel 1953 il ritorno alle urne è segnato dallo scontro sulla nuova legge elettorale: la famigerata «legge truffa», voluta fortemente da De Gasperi, scatena una rivolta della sinistra in Parlamento e nelle piazze. La riforma viene approvata tra violenti incidenti, nonostante l’ostruzionismo delle sinistre, che arrivano ad abbandonare Camera e Senato. Il 7 giugno 1953 gli italiani premiano il Pci, il Psi e l’estrema destra, mentre il blocco moderato perde consensi senza riuscire a raggiungere il quorum per l'agognato premio di maggioranza promesso dalla nuova legge per soli 57mila voti. La doccia fredda travolge la Democrazia Cristiana e il suo segretario Alcide De Gasperi, che è costretto a lasciare il testimone del governo allo storico rivale Giuseppe Pella.
Le elezioni del 1958 vedono confermati gli equilibri tra gli schieramenti politici, il gabinetto viene affidato ad Amintore Fanfani che inaugura la cosiddetta stagione del «centro-sinistra». Ma non durerà molto e l’incarico di Primo Ministro viene affidato prima ad Antonio Segni, poi a Tambroni, per tornare infine a Fanfani che con il suo quarto governo darà il via a riforme importanti, dalle pensioni alla scuola, alla nazionalizzazione dell’energia elettrica. «Apertura a sinistra» è il titolo della copertina della Domenica del Corriere firmata Walter Molino nel 1962.
Gli italiani tornano a votare il 28 e 29 aprile 1963, e i risultati portano alla nascita di un governo formato da DC, socialdemocratici, repubblicani e – per la prima volta – dal Partito Socialista Italiano. Dopo anni di tensioni il palcoscenico politico internazionale è dominato dal disgelo tra gli Stati Uniti di John F. Kennedy e l’URSS di Nikita Kruscev, che nel luglio del ’63 firmano il «Trattato sulla messa al bando parziale dei test nucleari». E in Italia dalle consultazioni elettorali emergono nuovi equilibri con la DC per la prima volta sotto il 40% dei consensi e il Pci che consolida il suo ruolo di forza d’opposizione. Sempre nel 1963 la televisione gioca un ruolo importante nella corsa al Parlamento, inaugurando il programma «Tribuna Elettorale». Protagonista della IV legislatura è Aldo Moro - nella foto - che guida tre governi dal 5 dicembre 1963 al 24 giugno 1968, sempre composti da DC, PSI, PSDI, PRI.
Il ‘68 con il suo vento rivoluzionario sfiora solo la campagna elettorale, ma arriverà a coinvolgere tutta la V legislatura con importanti ripercussioni sullo scenario politico del Paese. Dallo spoglio delle schede emerge una Dc stabile, un Pci in crescita, capace di sopravvivere alla perdita del suo leader Palmiro Togliatti, scomparso nel 1964, rastrellando anche i voti dei delusi del Psu. Il simbolo unitario con cui si erano presentati il Psi di Nenni e il Partito Socialista Democratico Italiano di Giuseppe Saragat - nella foto con Paolo VI e Aldo Moro - alla tornata elettorale subisce infatti una dura sconfitta registrando la perdita di un milione di voti. I governi della quinta legislatura si trovano a fronteggiare una tensione sociale senza precedenti: il baricentro della protesta si sposta dalle università alle fabbriche e l’attentato di Piazza Fontana del 1969 apre la tragica epoca del terrorismo. Durante i governi guidati dai democristiani Mariano Rumor ed Emilio Colombo verrà approvato lo «Statuto dei lavoratori», istituito il referendum, e il divorzio diventerà legge dello Stato. Nel 1969, mentre la Democrazia Cristiana è attraversata da una lotta interna tra le diverse correnti e cambia segretario tre volte, l’Italia vive la stagione del cosiddetto «autunno caldo» con serrate, imponenti scioperi e gravi incidenti. La mediazione del ministro del lavoro Carlo Donat Cattin porterà una relativa stabilità nel Paese. Nel 1972 il primo Governo guidato da Giulio Andreotti, non ottiene la fiducia del Parlamento provocando le prime elezioni anticipate della Repubblica.
Le urne nel 1972 rivelano l’avanzata della destra - Movimento Sociale e Monarchici, uniti raccolgono più dell’8% delle preferenze - la sostanziale stabilità della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista che si presenta guidato dal suo nuovo segretario Enrico Berlinguer, mentre il Psi e il Psdi, in caduta libera, racimolano pochi seggi. Mentre le stragi del 1974 di piazza della Loggia a Brescia, del treno Italicus e le azioni armate delle Brigate Rosse segnano la drammatica epoca degli «anni di piombo», l’Italia rivela un volto laico del tutto inaspettato con il trionfo del «No» al referendum abrogativo della legge sul divorzio. A farne le spese sarà soprattutto Amintore Fanfani, strenuo sostenitore del «Sì» che lascerà la segreteria del partito a Benigno Zaccagnini.
Nel 1976 il Paese torna alle consultazioni politiche in un clima esacerbato dal terrorismo, e il Partito Comunista Italiano, guidato da Enrico Berlinguer, sembra sul punto di affermarsi come primo partito del Paese dopo aver incassato un risultato inaspettato alle Regionali. Il «sorpasso» sulla DC sembra a portata di mano e inevitabile scatta l'alzata di scudi. Indro Montanelli dalle colonne del suo «Giornale» si schiera invitando gli italiani a «turarsi il naso e votare Democrazia Cristiana». La conta delle schede conferma l’avanzata del PCI, che conquista il 34,4 percento delle preferenze e arriva a pochissimi punti di distanza dalla Democrazia Cristiana, mentre il Psi scende sotto il dieci percento segnando la fine della segreteria De Martino e il passaggio del testimone a Bettino Craxi. Nasce un Governo di solidarietà nazionale, affidato a Giulio Andreotti, e Tina Anselmi - prima donna della storia del Paese - è nominata Ministro del Lavoro. La VII legislatura è segnata dall’escalation sempre più sanguinosa del terrorismo che nel 1978 arriva rapire e uccidere Aldo Moro, mettendo fine a quell’epoca del «compromesso storico» lanciato da Enrico Berlinguer.
Nel giugno del 1979 cade il quinto Governo Andreotti, rimasto in carica solo 11 giorni, e il Paese è costretto ad andare a elezioni anticipate. Il risultato delle urne incorona ancora una volta la Democrazia Cristiana e il Governo viene affidato a Francesco Cossiga, che rimane in carica sette mesi. Ai due governi Cossiga si avvicenderanno i gabinetti di Arnaldo Forlani, Giovanni Spadolini - primo non democristiano a guidare un governo - e Amintore Fanfani, sostenuti da una larga maggioranza che inaugura la stagione storica del cosiddetto «Pentapartito», costituito dall'alleanza DC, PSI, PSDI, PRI, PLI. Nella foto Spadolini, Fanfani e La Malfa.
Le elezioni del 1983, vedono il trionfo politico di Bettino Craxi che con poco più dell’11% dei voti diventa il secondo presidente del Consiglio non democristiano. Durante il suo mandato viene firmata la revisione del Concordato con il Vaticano e inoltre Nilde Iotti, storica esponente del Partito Comunista, viene eletta Presidente della Camera.
Alla successiva tornata elettorale del 1987, che consegna il Paese saldamente nelle mani della DC - premier Giovanni Goria - per la prima volta si presenta la Lista dei Verdi - che conquista 13 seggi alla Camera e 2 al Senato - e la Lega Lombarda, che porta in Parlamento Giuseppe Leoni alla Camera e Umberto Bossi al Senato. Nella foto Ilona Staller eletta tra le fila dei Radicali. In un quadro internazionale profondamente mutato dopo la caduta del comunismo nei Paesi dell’Est, il Pci guidato da Achille Occhetto vive una profonda discussione interna che porterà alla nascita nel 1991 del Partito Democratico della Sinistra e del Partito della Rifondazione Comunista, che si presentano separati agli elettori.
L’XI legislatura viene inaugurata il 23 aprile 1992 - siamo all’alba del terremoto Tangentopoli che travolgerà la politica italiana - e rimane in carica fino al 14 aprile 1994, per un totale di 722 giorni, di fatto la più breve della storia della Repubblica Italiana nonché l'ultima della cosiddetta «Prima Repubblica». Le urne premiano la Lega Nord di Umberto Bossi - nella foto -, che da 2 rappresentati passa a 80, e La Rete di Leoluca Orlando che ottiene 15 seggi parlamentari. Mentre le inchieste rivelano una classe politica corrotta e una rete di tangenti estesa oltre ogni immaginazione, politici e imprenditori di primissimo piano vengono inquisiti e travolti da una pioggia di avvisi di garanzia. Nel febbraio del 1993 Bettino Craxi si dimette da segretario del Psi. Il grave scandalo spinge il governo Amato a chiedere le dimissioni di ogni suo componente raggiunto da un avviso di garanzia.
La campagna elettorale per la XII legislatura, la prima con la nuova legge elettorale firmata da Mattarella, è segnata dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, che con Forza Italia il 27 e il 28 marzo 1994, raccoglie più del 21 percento delle preferenze affermandosi come nuovo partito di maggioranza. Il tornado di Tangentopoli ribalta il quadro politico italiano e Mino Martinazzoli, ultimo segretario della Democrazia Cristiana, traghetta l’eredità centrista nel Partito Popolare, mentre a destra Gianfranco Fini, segretario del MSI dà vita alla formazione elettorale Alleanza Nazionale. Silvio Berlusconi riceve l’incarico di formare il Governo e per la prima volta nella storia della Repubblica il Movimento Sociale Italiano entra nella squadra di gabinetto. Dopo 8 mesi la Lega Nord ritirerà il suo appoggio facendo cadere il primo governo Berlusconi, che sarà seguito dal governo tecnico guidato da Lamberto Dini. Nella foto con Gianni Letta, Giuseppe Tatarella del Movimento Sociale italiano, che nel 1994 è vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel 1996 si torna nuovamente a votare e il responso delle urne assegna la vittoria all’Ulivo, la coalizione di centrosinistra guidata da Romano Prodi con il Pds primo partito. Il primo governo Prodi rimarrà in carica per oltre 2 anni, salvo dover poi assegnare le dimissioni per il voto contrario del partito Rifondazione Comunista di Fausto Bertinotti, che passa all’opposizione e manda in minoranza il governo. Nonostante lo scossone del partito di Bertinotti, la maggioranza regge e la “campanella” del premier, passa da Prodi a Massimo D’Alema - due volte presidente del Consiglio - e poi a Giuliano Amato.
Le elezioni del 2001 sanciscono la vittoria della coalizione di centrodestra che ottiene oltre il 58 % dei parlamentari. Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi assegna l’incarico di formare il governo a Silvio Berlusconi, che nonostante una piccola crisi e il varo del terzo governo Berlusconi, rimarrà in carica per tutta la legislatura. Nella foto Berlusconi durante la campagna elettorale mostra il «Contratto con gli italiani» alla trasmissione Porta a porta.
Alle elezioni del 2006 la Casa delle Libertà e L’Unione si contendono fino all’ultima scheda. Con uno scarto di poche migliaia di voti (24mila su 38 milioni) la vittoria va al centrosinistra guidato da Romano Prodi, ne facevano parte anche Antonio Di Pietro, Clemente Mastella, Lamberto Dini, Oliviero Diliberto, Francesco Rutelli, Piero Fassino, Fausto Bertinotti. Romano Prodi rimarrà in carica 732 giorni - la seconda legislatura più breve della storia -; rassegnerà le dimissioni infatti il 24 gennaio 2008 dopo essere stato messo in minoranza dall’uscita dall'esecutivo dell'Udeur di Clemente Mastella, che voterà poi contro il governo.
Nel 2008 il ritorno alle urne premia il centrodestra di Silvio Berlusconi che vince con un ampio margine. La sorpresa della tornata elettorale è la scomparsa dal panorama politico parlamentare di diversi partiti che non raggiungono la soglia d’accesso al Senato e alla Camera. A farne le spese soprattutto è la Sinistra Arcobaleno - che raccoglieva sotto il suo ombrello Partito della Rifondazione Comunista, il Partito dei Comunisti Italiani, la Federazione dei Verdi e Sinistra Democratica - che rimarrà senza neanche un rappresentate in Parlamento. Ma il Berlusconi IV: durato sino al 16 novembre 2011 - secondo governo più lungo di sempre - si chiude traumaticamente, con le dimissioni del premier. Tocca al governo tecnico di Mario Monti, traghettare l’Italia fino alle nuove elezioni. Nella foto una manifestazione contro il governo Monti.
Le elezioni del febbraio 2013 segnano l’ingresso in Parlamento del Movimento 5 stelle di Beppe Grillo, e consegnano anche un panorama politico profondamente modificato: nessuna coalizione si aggiudica una vittoria netta. Dopo il tentativo fallito di Bersani, l’incarico di formare il nuovo governo viene affidato a Enrico Letta, che ottiene un’ampia fiducia alle Camere grazie all’appoggio bipartisan di centrodestra e centrosinistra. Il 22 febbraio 2014 cade il governo Letta, ma non si va a elezioni anticipate: il testimone passa a Matteo Renzi, segretario del Pd, che vara il governo numero 63 grazie al «patto del Nazareno» stipulato con Berlusconi. Il nuovo esecutivo rimane in carica per oltre mille giorni realizzando una serie di riforme dal jobs act, alle unioni civili, alla riforma della scuola, ma s’infrange contro il muro del referendum popolare sulla riforma della Costituzione che viene bocciata dagli italiani con un secco 60 percento di voti contrari. Paolo Gentiloni il 12 dicembre 2016 accetta di portare a termine la XVII legislatura. L’anno successivo - 28 dicembre 2017 - il presidente Mattarella firma lo scioglimento delle Camere mettendo fine al ciclo quinquennale iniziato con le elezioni del 2013.
Storia e foto delle elezioni politiche dal 1948 a oggi. In sintesi: i protagonisti, il clima politico, i risultati e le conseguenze del voto nella storia dell'Italia repubblicana, scrive Edoardo Frittoli il 27 febbraio 2018 su "Panorama". In vista delle elezioni politiche fissate per il 4 marzo 2018, ripercorriamo sinteticamente la storia delle 17 tornate elettorali della storia italiana, dal 1948 al 2013. Da De Gasperi a Renzi.
18 APRILE 1948. Furono le prime politiche dell'Italia repubblicana dopo l'entrata in vigore della Costituzione. A soli tre anni dalla fine della guerra, il Paese vive un clima di fortissima contrapposizione ideologica, specchio della divisione mondiale nei due blocchi protagonisti della Guerra Fredda appena iniziata. I Comunisti erano già stati estromessi dalla compagine di governo e si era già consumata la crisi di uno dei partiti chiave della Resistenza: il Partito d'Azione. Il Presidente del Consiglio, il democristiano Alcide De Gasperi, gettava le basi della futura egemonia del partito di maggioranza con un viaggio negli Stati Uniti compiuto nel 1947, dove era tornato con le prospettive del Piano Marshall e la rassicurazione degli aiuti americani nella ricostruzione italiana, garantiti dall'incontro con Harry Truman. A rafforzare in maniera determinante la propaganda democristiana contribuì il Vaticano di Pio XII anche per voce dei Comitati Civici di Luigi Gedda, che indussero i fedeli a considerare il voto per i comunisti come un peccato degno di scomunica. Alle elezioni i partiti si presentarono divisi in due grandi blocchi: da una parte la DC e il mondo cattolico; dall'altra il Fronte Democratico Popolare composto da PCI e PSI. Una terza forza minoritaria si presentò unita nel Blocco Nazionale (PLI e Partito dell'Uomo Qualunque). Da soli correranno i Monarchici e il Movimento Sociale Italiano. La vittoria alle urne della Democrazia Cristiana fu netta, con punte da plebiscito nel Triveneto. I Partiti del Fronte Popolare registrarono un forte arretramento, mentre fu sorprendente il 5% del MSI al Sud. Le elezioni del 1948 segneranno l'ingresso dell'Italia nella fase del cosiddetto "centrismo", caratterizzato dall'egemonia politica dei governi democristiani degli anni '50. (3 governi De Gasperi fino al 1953 durante i quali l'Italia entrerà definitivamente a far parte dell'alleanza Atlantica (NATO).
7 GIUGNO 1953. Il paese arrivava alle urne a fine legislatura con una serie di riforme chiave varate dai governi DC, le più importanti delle quali furono quelle uscite dai dicasteri guidati da Amintore Fanfani: la legge agraria e la legge sull'edilizia popolare, che porta anche il nome del politico DC. Dal momento che la tensione dovuta alla situazione internazionale e sugli esiti delle riforme pareva favorire una ripresa della divisione politica e un rinvigorimento del PCI e del PSI, il Governo varò una assai discussa riforma della legge elettorale, che esacerbò ulteriormente gli animi dell'opposizione. I comunisti e i socialisti paventarono infatti un "ritorno al fascismo" poiché la riforma, nota in seguito come "Legge Truffa", assegnava un enorme premio di maggioranza (65% dei seggi) alla coalizione che avesse superato il 50% dei voti. Alle urne questo obbiettivo fu mancato dalla Dc e dagli alleati per un soffio, in quanto la coalizione di centro arrivò al 49,2%. Nonostante la conferma dell'egemonia democristiana negli ultimi mesi di vita di De Gasperi, il partito vide un sensibile calo a favore della destra monarchica e dell'MSI soprattutto nelle regioni meridionali. La scomparsa di De Gasperi porterà negli anni a venire ad una marcata fase di instabilità nei governi democristiani, guidati in brevi dicasteri da Pella, Fanfani, Scelba, Segni, Zoli.
25 MAGGIO 1958. La campagna elettorale fu specchio del clima di incertezza creato dal susseguirsi di brevi governi DC, nell'anno comunemente individuato come il punto di partenza del "boom" economico. L'esito dei voti vede un lieve incremento della DC e del PSI, le cui premesse di avvicinamento saranno fortemente osteggiate dalla corrente più a destra della Democrazia Cristiana. Dal voto nasceranno due tra i più osteggiati governi del dopoguerra, quelli di Antonio Segni e di Cesare Tambroni che si resse addirittura sull'appoggi esterno del MSI. Il rifiuto dell'opinione pubblica nell'accettare qualunque ruolo degli eredi del fascismo assieme alla crescita della corrente di partito legata ad Aldo Moro porranno le basi per i primi esperimenti agli albori dell'epoca dei governi di centro-sinistra.
28-29 APRILE 1963. Furono le elezioni politiche che segnarono la fine definitiva del centrismo a 10 anni dalla morte di Alcide De Gasperi. Il clima politico fu segnato dalle questioni che fecero seguito alla nazionalizzazione dell'ENEL e soprattutto alle questioni legate alla liquidazione delle ex Società elettriche precedenti alla riforma attuata nel 1962 dal governo Fanfani. L'esito del voto rispecchiò la consunzione della vecchia formula, con la DC che perse terreno a favore dei Socialisti. La stabilità del PCI, l'arretramento del MSI e la quasi completa sparizione dei Monarchici lasciarono spazio al partito di Nenni, che acquisterà sempre più peso per tutti gli anni '60.
19-20 MAGGIO 1968. L'Italia arrivava alle elezioni dopo i tre governi di centro-sinistra guidati da Aldo Moro, noti anche come i governi del quadripartito (DC-PSI-PSDI-PRI). Pesava la battuta d'arresto della lunga crescita economica, che aumentò la conflittualità nel mondo del lavoro contemporaneamente allo scoppio della contestazione studentesca. Mentre languiva la riforma dell'Università si consuma anche la rottura interna ai socialisti con la scissione a sinistra che diede vita allo PSIUP. La crescita più consistente è a favore del PCI, mentre la destra cala. A partire dal governo Rumor nato dopo le elezioni e allo scoppio dell'autunno caldo del 1969 l'ultima propaggine dell'esperienza dei governi di centro-sinistra porterà ad importanti riforme come la legge sul divorzio, Statuto dei Lavoratori e la nascita delle Regioni nel 1970.
7-8 MAGGIO 1972. Sono le prime elezioni anticipate della storia dell'Italia repubblicana in quanto il Presidente della Repubblica Giovanni Leone decise lo scioglimento delle Camere per la crisi generata dall'uscita dei Socialisti dal governo Colombo. Le urne rivelarono una sostanziale conferma dei risultati precedenti per i 4 partiti di governo, mentre i risultati inquietarono il Paese per la forte crescita del MSI nel mezzo degli anni drammatici della strategia della tensione. Gli effetti della altissima conflittualità degli anni precedenti e l'opposizione della "maggioranza silenziosa" scrissero la parola fine sugli anni del centro-sinistra. Il 26 giugno 1972 fu varato un dicastero di centro-destra noto come governo Andreotti-Malagodi con l'ingresso dei Liberali, mentre l'Italia si trova ad affrontare una grave situazione economica culminata con la crisi del petrolio del 1973 e i drammatici anni di piombo.
20-21 GIUGNO 1976. Per la prima volta andarono a votare i diciottenni, per gli effetti della riforma della maggiore età. Le elezioni saranno ricordate come quelle del trionfo del PCI, che si conferma come principale partito in grado di mettere in discussione un trentennio di egemonia democristiana. Questo risultato elettorale avrà anche l'effetto di aumentare l'importanza del PSI nel creare un argine all'avanzata del partito di Enrico Berlinguer. Sono le basi degli anni a seguire, dove i Socialisti guidati da Craxi dopo la "svolta del Midas" dello stesso 1976 avranno sempre più influenza come "ago della bilancia" politica. Dalle urne uscirà anche l'idea del "compromesso storico", interrotto tragicamente dal rapimento e dalla morte di Aldo Moro due anni più tardi. Dalle urne del 1976 nascerà un governo Andreotti retto dall'appoggio esterno dei Comunisti, che otterranno anche la Presidenza della Camera con l'elezione di Pietro Ingrao.
3-4 GIUGNO 1979. Proprio lo choc mondiale che seguì il ritrovamento del corpo di Aldo Moro un anno prima, indusse il neo Presidente Sandro Pertini a sciogliere in anticipo le Camere per le tensioni altissime tra i partiti dei governi di unità nazionale guidati da Giulio Andreotti esplose durante i giorni del rapimento dello statista DC. Per il PCI le elezioni segneranno una sconfitta epocale, mentre la DC avrà sempre maggiore bisogno del sostegno dei Socialisti per poter rimanere in sella. Sono le basi dei futuri governi del pentapartito degli anni '80. Marco Pannella e i Radicali emergono dalle urne come forza politica alternativa e consolidata.
26-27 GIUGNO 1983. Furono le elezioni che consacrarono il lungo periodo dell'egemonia dei Socialisti di Bettino Craxi. Le urne indicarono un'erosione dei consensi alla DC, che fu alla base dell'allargamento al pentapartito dell'area di governo. Dopo le elezioni del 1983 nascerà il primo governo guidato da un Socialista dopo quasi 40 anni di esecutivi DC. Sono i primi anni '80 e gli anni della lotta operaia e sindacale sono alle spalle dopo la sconfitta dei metalmeccanici a Torino di tre anni prima e alla crescita del settore terziario e della piccola e media impresa scarsamente sindacalizzate.
14-15 GIUGNO 1987. Nonostante gli effetti del primo scandalo che investì il PSI, ricordato come il "patto della staffetta"(un accordo tra Craxi e De Mita sull'alternanza alla guida di Palazzo Chigi), in partiti di maggioranza tennero. Anzi, la Democrazia Cristiana centrerà il miglior risultato dal 1958. La novità fu rappresentata dal grande successo dei Verdi, che presero oltre 1,6 milioni di voti e dalla candidatura nelle liste del Partito Radicale di Ilona Staller, la pornostar meglio nota come "Cicciolina". Dalle elezioni nascerà il dicastero guidato da Giovanni Goria.
5-6 APRILE 1992. Furono le ultime elezioni della Prima Repubblica e della Democrazia Cristiana prima della bufera di Tangentopoli. Ed anche le prime a svolgersi dopo la riforma elettorale che prevedeva un sistema proporzionale con preferenze. I Comunisti si presentarono già divisi in seguito alla svolta della "Bolognina", con le due liste del PDS e di Rifondazione Comunista. Il quadro politico fu caratterizzato dalle esternazioni (note come "picconate") del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e dalla crisi di governo dovuta all'uscita del PRI in seguito ai primi passi del pool di Mani Pulite. Alle elezioni partecipa la Lega Nord di Umberto Bossi ottenendo un risultato incoraggiante (8,65%) ed il neonato movimento fondato da Leoluca Orlando e Nando Dalla Chiesa, La Rete. L'astensionismo seguito agli scandali fu elevato e poco dopo fu eletto al Quirinale Oscar Luigi Scalfaro, che affiderà a Giuliano Amato la guida del Governo. La bufera giudiziaria investirà indirettamente anche quest'ultimo, data la carriera politica a fianco di Craxi. L'esecutivo tecnico di Carlo Azeglio Ciampi succeduto al Governo Amato dovrà affrontare una delle più gravi crisi economiche dal dopoguerra.
27-28 MARZO 1994. Per gli effetti travolgenti di Tangentopoli e la crisi profonda dei partiti della Prima Repubblica, le Camere vengono sciolte appena due anni dopo. Anche il sistema elettorale è differente da quello di due anni prima: si vota con un sistema misto (maggioritario-proporzionale) noto come "sistema Mattarella". La grande novità della prime elezioni della Seconda Repubblica fu certamente la "discesa in campo" dell'imprenditore Silvio Berlusconi alla guida di Forza Italia, con l'obiettivo di porre un argine all'avanzata dei postcomunisti dopo la morte dei partiti storici. Oltre ai postcomunisti si presentano coalizzati con FI gli ex-missini raccolti in Alleanza Nazionale dopo la "svolta di Fiuggi". Per la prima volta si delinea uno scenario bipolarità, con un terzo soggetto minoritario costituito dalla lista Patto per L'Italia di Mario Segni. La netta vittoria del Polo del Buon Governo porterà alla nascita del primo Governo Berlusconi. La sua vita sarà breve a causa delle tensioni con la Lega Nord che porteranno alla sua caduta dopo 7 mesi, sostituito dal governo tecnico di Lamberto Dini.
21 APRILE 1996. Ancora una volta, dopo la parentesi dei governi tecnici e la profonda crisi della politica, le Camere sono sciolte in anticipo. Sono le elezioni della coalizione "L'Ulivo" capeggiata da Romano Prodi, comprendente PDS-PPI-PRI-Lista Dini-Verdi con appoggio esterno di Rifondazione. Il Centrodestra si presenta unito nel Polo della Libertà (FI-AN-CCD-CDU) con la Lega Nord da sola e la nuova lista Pannella-Sgarbi. Poco prima della data fissata per il voto, Berlusconi e D'Alema fallirono un tentativo di accordo. L'esito degli scrutini vide un sostanziale pareggio, con uno scarto esiguo a favore dell'Ulivo. Vi furono rivendicazioni da parte del Centrodestra e fu chiesto alla Suprema Corte di Cassazione il nuovo spoglio, che vide confermato il minimo vantaggio del Centrosinistra che ottenne la vittoria e il successivo governo Prodi, che dovette tuttavia dipendere dall'appoggio esterno di Rifondazione Comunista. Proprio l'abbandono da parte di Fausto Bertinotti generò la crisi che porterà alla caduta dell'esecutivo nell'ottobre 1998.
13 MAGGIO 2001. Si arrivò al voto dopo la fine del governo di Massimo D'Alema e alla parentesi del governo tecnico di Giuliano Amato. L'elezione fu ricordata come quella delle "liste civetta", mentre la partita fu combattuta tra il Polo di Silvio Berlusconi (dove era rientrata la Lega Nord) e l'Ulivo guidato da Francesco Rutelli. All'esterno delle due coalizioni si presentarono L'Italia dei Valori dell'ex protagonista di Mani Pulite Antonio Di Pietro e la Lista di Emma Bonino. La campagna elettorale fu una delle più dure, specie in televisione dove si susseguirono le accuse al leader del Centrodestra Silvio Berlusconi. Proprio durante la partecipazione al talk show "Porta a Porta" Berlusconi firmerà il famoso "contratto con gli Italiani". Fu netta la vittoria del Polo, dando vita ad un secondo Governo Berlusconi caratterizzato da una maggioranza netta alla Camera e al Senato, che garantirà all'esecutivo una lunga vita (fino al 2005).
9-10 APRILE 2006. Le elezioni furono indette alla fine naturale della legislatura. Al posto dell'Ulivo si presentava per il Centrosinistra il nuovo soggetto di Romano Prodi, L'Unione. Anche la coalizione di Centrodestra aveva cambiato denominazione divenendo La Casa delle Libertà. Dal momento che la nuova legge elettorale obbligava le coalizioni ad esprimere il candidato premier, vi furono tensioni tra gli alleati ed in particolar modo nel Centrodestra dove Gianfranco Fini e Pierferdinando Casini avanzarono le loro candidature nel caso i loro partiti avessero raggiunto la maggioranza di voti all'interno della coalizione. Romano Prodi vince ancora al fotofinish, generando di nuovo profondi malumori negli avversari per il ruolo determinante del voto degli Italiani all'estero e dei Senatori a Vita.
13-14 APRILE 2008. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano scioglie anticipatamente le Camere in seguito alla vicenda giudiziaria di Clemente Mastella, indagato per abuso d'ufficio mentre ricopre l'incarico di Ministro della Giustizia. Il governo Prodi II era caduto per il mancato appoggio esterno Udeur, inizialmente assicurato dallo stesso Mastella e poi ritirato. La campagna elettorale fu caratterizzata dalla presenza di un nuovo codice di autoregolamentazione per le vicende legate ai candidati indagati. Il periodo pre-elettorale fu incentrato sulla questione del salvataggio della compagnia di bandiera Alitalia, per la quale Silvio Berlusconi auspicava una cordata di imprenditori italiani mentre il Centrosinistra guidato da Walter Veltroni si era espresso a favore del mercato. Il successo di Berlusconi fu ancora una volta nettissimo e dalle urne uscirà rafforzata anche la Lega Nord, che vedrà i propri voti pressoché raddoppiati.
24-25 FEBBRAIO 2013. L'Italia andò a votare pesantemente provata dagli effetti della crisi economica mondiale che aveva colpito a partire dalla fine del 2008. Fu proprio in seguito alla crisi del debito sovrano in Europa che il Governo Berlusconi IV entrò in crisi, seguito dall'esecutivo tecnico di Mario Monti. Questo dicastero sarà caratterizzato dalla politica dell'"austerità" e dei suoi effetti negativi sulla fiducia degli italiani nel Governo e sui partiti che lo sostenevano. Il termine del sostegno all'esecutivo Monti da parte del Popolo della Libertà ne causò la crisi quasi al termine naturale della Legislatura. Le elezioni 2013 furono il banco di prova per il terzo soggetto politico, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e caratterizzate dalla permanenza del premio di maggioranza stabilito dalla Legge Calderoli (il cosiddetto "porcellum"). Gli schieramenti videro la coalizione di Centrosinistra (Italia Bene Comune) guidata da Pierluigi Bersani, il vincitore delle primarie. Comprendeva la sinistra di Vendola (SEL). Il Centrodestra con Silvio Berlusconi candidato vide la scissione dal PDL e la nascita a destra di Fratelli d'Italia. I risultati elettorali presentarono un quadro in cui le tre principali forze politiche non erano in grado di esprimere una maggioranza di governo. Seguì uno stallo politico che durò ben 2 mesi, durante i quali Napolitano, rieletto al Quirinale, chiamò a sè una consulta di "10 saggi" di tutte le formazioni politiche per cercare di superare l'impasse. Al termine delle consultazioni l'incarico fu dato a Gianni Letta perché guidasse un esecutivo di grande coalizione, che rimarrà in carica fino al 13 febbraio 2014 dopo l'uscita di FI in seguito alla decadenza di Silvio Berlusconi dalla carica di Senatore. Letta lascerà le redini del governo al vincitore delle primarie PD, Matteo Renzi.
Tutti i Presidenti della Camera e del Senato dal 1948 al 2018. Da Giovanni Gronchi a Laura Boldrini, da Ivanoe Bonomi a Pietro Grasso. Sette di loro sono stati poi eletti Presidenti della Repubblica. Tre donne alla camera, nessuna al Senato, scrive Edoardo Frittoli il 22 marzo 2018 su "Panorama".
Presidenti della Camera dei Deputati. Sono stati 14 i Presidenti della Camera dei Deputati dal 1948 al 2018. Tre sono state le donne: Nilde Iotti (dal 1979 al 1992 con tre mandati consecutivi), Irene Pivetti (dal 1994 al 1996) e Laura Boldrini (dal 2013 al 2018).
Di questi 14 Presidenti, ben 5 sono stati eletti Presidenti della Repubblica: Giovanni Gronchi, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro, Giorgio Napolitano. La permanenza più lunga alla Presidenza della Camera è stata quella di Nilde Iotti (13 anni), mentre la più breve è quella di Oscar Luigi Scalfaro (un solo mese dal 24 aprile 1992 al 25 maggio 1992 quando fu eletto Presidente della Repubblica. Irene Pivetti (Lega Nord) è stata la più giovane Presidente della Camera. Quando fu eletta aveva soltanto 31 anni. Il più anziano Oscar Luigi Scalfaro che ne aveva 74.
Presidenti della Camera dei Deputati (Montecitorio):
Giovanni Gronchi (1887-1978). Dall'8 maggio 1948 al 29 aprile 1955;
Giovanni Leone. (1908-2001). Dal 10 maggio 1955 al 21 giugno 1963;
Brunetto Bucciarelli-Ducci (1914-1994) Dal 26 giugno 1963 al 14 maggio 1968;
Sandro Pertini (1896-1990). Dal 5 giugno 1968 al 4 luglio 1976;
Pietro Ingrao (1915-2015). Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979;
Nilde Iotti (1920-1999). Dal 20 giugno 1979 al 22 aprile 1992;
Oscar Luigi Scalfaro (1918-2012). Dal 24 aprile al 25 maggio 1992;
Giorgio Napolitano (1925). Dal 3 giugno 1992 al 14 aprile 1994;
Irene Pivetti (1963). Dal 16 aprile 1994 all'8 maggio 1996;
Luciano Violante (1941). Dal 10 maggio 1996 al 29 maggio 2001;
Pier Ferdinando Casini (1955). Dal 31 maggio 2001 al 27 aprile 2006;
Fausto Bertinotti (1940) dal 29 aprile 2006 al 28 aprile 2008;
Gianfranco Fini (1952). Dal 30 aprile 2008 al 14 marzo 2013;
Laura Boldrini (1961). Dal 16 marzo 2013 al 23 marzo 2018.
Presidenti del Senato della Repubblica. Sono stati 21 i Presidenti del Senato dal 1948 al 2018. La carica non è mai stata ricoperta da una donna fino ad oggi. Tra i Presidenti del Senato eletti dopo l'entrata in vigore della Costituzione, solamente due diventeranno Presidenti della Repubblica: Enrico De Nicola e Francesco Cossiga. Il più anziano Presidente del Senato è stato il liberale Giovanni Malagodi (eletto il 22 aprile 1987 all'età di 83 anni). Il più giovane invece Carlo Scognamiglio, eletto il 16 aprile 1994 all età di 50 anni. La permanenza più lunga in carica è stata quella di Cesare Merzagora, durata dal 25 giugno 1953 al 7 novembre 1967. La più breve quella del democristiano Vittorino Colombo, durata dal 12 maggio all'11 luglio 1983.
Presidenti del Senato della Repubblica (Palazzo Madama):
Ivanoe Bonomi (1873-1951). Dall'8 maggio 1948 al 20 aprile 1951;
Enrico De Nicola (1877-1959). Dal 28 aprile 1951 al 24 giugno 1952;
Meuccio Ruini (1877-1970). Dal 25 marzo 1953 al 25 giugno 1953;
Cesare Merzagora (1898-1991). Dal 25 giugno 1953 al 7 novembre 1967;
Ennio Zelioli-Lanzini (1899-1976). Dall'8 novembre 1967 al 4 giugno 1968;
Amintore Fanfani (1908-1999). Dal 5 giugno 1968 al 23 giugno 1973;
Giovanni Spagnolli (1907-1984). Dal 25 giugno 1973 al 4 luglio 1976;
Amintore Fanfani (1908-1999). Dal 5 luglio 1976 al 1 dicembre 1982;
Tommaso Morlino (1925-1983). Dal 9 dicembre 1982 al 6 maggio 1983;
Vittorino Colombo (1925-1996). Dal 12 maggio all'11 luglio 1983;
Francesco Cossiga (1928-2010). Dal 12 luglio 1983 al 24 giugno 1985;
Amintore Fanfani (1908-1999). Dal 9 luglio 1985 al 17 aprile 1987;
Giovanni Malagodi (1904-1991). Dal 22 aprile al 1 luglio 1987;
Giovanni Spadolini (1925-1994). Dal 2 luglio 1987 al 14 aprile 1994;
Carlo Scognamiglio (1944). Dal 16 aprile 1994 all'8 maggio 1996;
Nicola Mancino (1931). Dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001;
Marcello Pera (1943). Dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006;
Franco Marini (1933). Dal 29 aprile 2006 al 28 aprile 2008;
Renato Schifani (1950). Dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013;
Pietro Grasso (1945). Dal 16 marzo 2013 al 23 marzo 2018.
1976: così l’Italia si turò il naso e fermò il sorpasso, scrive Paolo Delgado il 27 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". L’inflazione e l’austerity spaventavano più del terrorismo. La parola chiave era “sorpasso”. Se lo aspettavano in molti, chi pieno di speranza, chi di paura. Mai, prima di quel fatale 1976, la possibilità che il Pci superasse nei consensi era sembrata altrettanto concreta. Mai più lo sarebbe apparsa in seguito. Appena un anno prima, nelle elezioni regionali, il partito di Berlinguer aveva guadagnato 5,60 punti percentuali arrivando a meno di due punti dalla Dc, che aveva invece subito un salasso del 2,46%. Il Pci aveva conquistato Roma e Napoli, a Milano si era insediata per la prima volta una giunta di sinistra: l’onda berlingueriana pareva inarrestabile. All’origine della slavina c’erano, intrecciate, una crisi economica di proporzioni sino a quel momento inaudite e una crisi di credibilità etica della Dc, anch’essa, nelle dimensioni che aveva raggiunto, senza precedenti. L’inflazione era arrivata all’ 11% e di conseguenza le banche avevano sostituito le monete con “miniassegni” che bastavano da soli a diffondere un minaccioso senso di precarietà. Dalle precedenti elezioni politiche, quelle del 1972, il mondo era cambiato. Era successo alla fine del 1973, con lo shock petrolifero provocato dal brusco rialzo deciso dai paesi produttori di petrolio, e per la prima volta una crisi aveva cambiato le abitudini di vita degli italiani con le misure di risparmio energetico della cosiddetta austerity. Il Pil italiano era in caduta libera, nel ‘ 75 era diminuito del 2,1%. Quelle furono le prime elezioni dominate dalla coscienza che il boom era finito e non sarebbe più tornato. Era alle spalle già del 1972, ma almeno nella consapevolezza diffusa del popolo votante non era affatto chiaro che un intero ciclo era cambiato e non si trattava di una parentesi, come nel caso della “congiuntura” del 1964. In quell’anno infatti era stata la violenza politica e la reazione spaurita di una parte considerevole dell’elettorato a tenere banco, e il risultato era stata una vittoria secca del Msi, nonostante una crescita anche del Pci che era arrivato oltre il 27%. Nel 1976, nonostante la violenza politica fosse ormai armata, l’argomento fu meno centrale di quanto non si immagini oggi. Proprio una settimana prima del voto, l’8 giugno, le Brigate rosse spararono per la prima volta per uccidere. Sino a quel momento gli omicidi non erano stati decisi: erano “capitati” come conseguenze di scontri a fuoco oppure erano stati “incidenti sul lavoro”, come le stesse Br avevano definito l’uccisione di due militanti del Psi a Padova, nel corso di un’irruzione che non avrebbe dovuto provocare vittime in una sezione del Msi nel 1974. Nessun incidente invece nell’attacco che costò la vita al procuratore di Genova Francesco Coco, il magistrato che aveva bloccato in extremis la liberazione dei prigionieri in cambio della vita del pm sequestrato dalle Br Mario Sossi, e dei due poliziotti che gli facevano da scorta. Le Br, ormai guidate da Mario Moretti dopo gli arresti di Curcio e Franceschini e dopo l’uccisione di Mara Cagol, avevano scelto di alzare il tiro e non lo avrebbero mai più abbassato. Tuttavia la crisi economica mordeva molto più a fondo di quanto non facesse la sicurezza, accompagnato da una diffusa sfiducia nella capacità di fronteggiarlo da parte della Dc. Lacerata dalle divisioni interne della sinistra di Moro, che guardava alla collaborazione con il Pci in buona misura proprio per fronteggiare la crisi economica, e una destra che al congresso aveva perso di strettissima misura ed era agguerritissima, fiaccata soprattutto dal presunto coinvolgimento ( rivelatosi poi inesistente) del capo dello Stato Giovanni Leone in una storiaccia di tangenti sborsate dalla Lockheed, la balena bianca sembrava ormai a molti troppo corrotta, troppo corrosa dalla clientela e dal peso delle correnti interne, per reagire alla tempesta con la dovuta solidità. Berlinguer giocava consapevolmente su questo intreccio tra paura per lo stato dell’economia e sfiducia nei confronti della Dc. Voleva che il Pci non fosse più solo il partito del movimento operaio e degli intellettuali ma che diventasse il punto di riferimento anche della parte più moderna dell’azienda, del ceto medio- alto, della borghesia. Il Pci chiedeva voti in nome della propria “serietà”, opposta al malcostume democristiano. Si offriva come alfiere di un “rigore” necessario a risollevare le sorti sia etiche che economiche della Repubblica. L’Unità era ormai affiancata dalla neonata Repubblica di Eugenio Scalfari, compiuta espressione di quel progetto politico che mirava apertamente non a sostituire la Dc con il Pci ma ad affiancare i due partiti. Il Pci prometteva di portare in dote, in nome appunto della “serietà” e del “rigore”, quel controllo sull’insubordinazione operaia necessario per varare le politiche anti- crisi. La campagna elettorale fu una lunga attesa del momento della verità. Una tensione crescente alla quale diede voce Indro Montanelli con un’espressione passata alla storia e che ancora risuona: «Bisogna turarsi il naso e votare Dc». Gli elettori centristi seguirono il consiglio, obbedirono, votarono per la Dc svuotando i forzieri elettorali dei partiti minori che della Dc erano alleati. Il Pci arrivò davvero al suo massimo storico, 34,37%, ma la Dc tenne, perdendo meno di mezzo punto rispetto al 1972 e confermando, con il 38,71% un considerevole vantaggio. La delusione non solo tra gli elettori del Pci ma anche tra quelli della sinistra radicale quella notte era su tutte le facce. Per la sinistra, che si era presentata con il cartello Democrazia proletaria, il colpo fu durissimo. In nome di un “voto utile” ante litteram anche una parte della base della sinistra sino a quel momento extraparlamentare votò Pci. Un’altra parte scelse i radicali, considerandoli comunque ottimi “guastatori”. Il cartello si fermò all’ 1,52% e per i partitini della sinistra, che erano stati grandi come strutture di movimento ma erano superflui come forze parlamentari, fu la pietra tombale. La notte del 15 giugno le frase più ripetuta all’arrivo dei risultati, nelle piazze piene e deluse della sinistra, fu «Non cambia niente». Invece quel voto cambiò tutto. «Ci sono stati due vincitori», proclamò Moro, spianando così la strada al governo di unità nazionale e alla sconfitta sociale e politica di tutte le sinistre in campo.
1994, arriva il Cav: sinistre ko, scrive Carlo Fusi l'1 Marzo 2018 su "Il Dubbio". La campagna elettorale è da subito completamente diversa dalle precedenti. Silvio è l’Alieno venuto a colonizzare i campi desertificati da Tangentopoli. Eppure era tutto così chiaro. Bastava guardare la platea accorsa in quel 6 febbraio 1994, e la geometrica potenza che ne sprigionava, per capire come sarebbe finita. Quel pezzo di popolo raccolto nel catino del Palasport di Roma, che Eugenio Scalfari pensando alla campagna elettorale in corso e a chi, nel centrodestra, se ne era assunta la titolarità, avrebbe pochi giorni dopo e con disprezzo sussiegoso bollato come «i clowns che si sono esibiti con i loro volti ricoperti di biacca e di cerone, e così gli acrobati, i comici, le donne- cannone, i giocolieri, i musici e i pulcinella». Invece in quei mesi che segnarono il passaggio dall’inverno della prima Repubblica alla primavera, almeno elettorale, della Seconda, c’era un pezzo d’Italia che non chiedeva altro che ascoltare il suo nuovo Vate, l’imprenditore venuto su dal nulla ( ma no, ma no: dietro e di fianco a lui c’è Craxi, ci sono i vecchi maneggioni, i corrotti e i riciclati, magari perfino la mafia strillavano i suoi avversari: inutilmente), l’uomo del fare pronto a ridare speranze e velleità ai tanti che nei baffetti di Achille Occhetto e Massimo D’Alema vedevano nient’altro che la mal riuscita imitazione dei terribili mustacchi di Stalin, e nella gioiosa macchina da guerra del cartello dei Progressisti ( Pds, Rifondazione Comunista, Socialisti italiani, Rinascita socialista, Verdi, la Rete, Cristiano-sociali e Alleanza democratica) la trasposizione dei cavalli di Koba (l’Indomabile) Iosif Džugašvili stavolta sul serio ad un passo dall’abbeverarsi nelle fontane di piazza San Pietro. E infatti eccolo lì, Silvio Berlusconi, “l’uomo col sole in tasca”, pronto a battezzare la sua scesa in campo in politica per salvaguardare dalle orde di sinistra «il Paese che amo e che alla fine dei conti è tutto quel che ho, tutto quel che abbiamo». «Siamo per le libertà, tutte le libertà», gridava dal palco. A partire da quella televisiva, il poker d’assi del Caimano che lo aveva reso noto e fatto viaggiare sul carro dorato fin nell’empireo della Politica, addirittura a palazzo Chigi. Era stata una campagna elettorale completamente diversa dalle precedenti, e Silvio era l’Alieno venuto a colonizzare i campi desertificati da Tangentopoli. Linguaggio rivoluzionario, occhieggiante e suadente. Televisioni usate a tutto spiano, col risultato di provocare gli stranguglioni ai cronisti incaricati di seguire il Signore di Arcore: mentre loro gironzolavano nel Transatlantico o bivaccavano davanti alle sedi dei partiti, Silvio mandava cassette registrate con i suoi appelli, e i suoi più stretti collaboratori, da Giuliano Urbani a Cesare Previti, stazionavano sul piccolo schermo offrendo a getto continuo materiale per i titoli dei Tg e dei quotidiani. Già, le tv. Il pallino di sempre di Berlusconi, l’intuizione che l’avrebbe fatto diventare il tycoon italiano e uno degli uomini più ricchi del pianeta. Con fiuto che lo contraddistingue aveva capito fin da subito la potenzialità del nuovo mezzo. Da quando nel 1978 aveva rilevato da Giacomo Properzj TeleMilanocavo, una tv privata attiva dal ‘ 74 e destinata ai frequentatori di Milano 2, centro urbano corpo e anima dell’altro amore di Silvio: l’edilizia. Due anni dopo l’emittente era diventata TeleMilano e subito dopo TeleMilano58: progenitrice di Canale 5, varata nel 1980. E mica è finita qui. Tra l’82 e l’84 Berlusconi aveva comprato da Edilio Rusconi e Mario Formenton Italia1 e Rete4: l’impero era pronto a colpire. Ma il linguaggio, la calza davanti alla telecamera per garantire l’effetto “caldo” del messaggio, le posture, gli ammiccamenti, le barzellette spinte non erano sufficienti ad assicurare il pieno successo alla cavalcata berlusconiana. Ci voleva lo strumento politico. Anche quello Silvio l’aveva intuito. Aveva capito che era lì, a portata di mano, il mezzo che l’avrebbe fatto non vincere bensì stravincere: l’addio al proporzionale, stilema obbligato dello scontro politico dal dopoguerra, e l’arrivo del maggioritario. O di qua o di là, che tradotto nel berlusconese voleva dire o con me o contro di me. Addio al Centro, addio alla Dc, addio al pentapartito e addio soprattutto ai riti bizantini e alle liturgie della mediazione: tutti inglobati meglio: fagocitati – dal “nuovo che avanza”, che non può aspettare nessuno perché ha troppa fretta di insediarsi. Se Mani Pulite aveva distrutto i partiti storici, la legge elettorale stilata da Sergio Mattarella aveva sparso il diserbante per non farli più ricrescere. E aveva funzionato da propellente per qualcosa che a Berlusconi si adattava come un guanto: il personalismo, la leadership politica unica e indiscussa, il partito- azienda dove il Capo comanda e gli altri ne riconoscono la supremazia e ubbidiscono. Insomma aveva capito che il mondo era cambiato prima e meglio di chiunque, e che l’Italia non aspettava che il suo profeta. «Entro nell’agone politico – spiegherà in una intervista a Panorama – ma non mi faccio prigioniero della politica. Faccio sul serio e constato che gli avversari del momento se ne sono accorti con quel piccolo ritardo che mi fa piacere. Perché renderà meno difficile combatterli». “Piccolo ritardo”? Un abisso altrochè. Uno iato culturale, si dovrebbe perfino dire. E una capacità tutta imprenditoriale di capire qual è il segmento di mercato giusto dove piazzarsi per fare affari e aumentare il capitale. Altrimenti come altro giudicare l’endorsement nei riguardi di Gianfranco Fini, segretario del Msi, partito reietto e ai margini del gioco: qualunque gioco? Fuori dell’arco costituzionale, perciò inutilizzabile. Invece quel mattino del 23 novembre 1993 a Casalecchio sul Reno, non a una riunione di partito (e quale: Publitalia?) e neppure in un talk show o un in comizio ma al contrario inaugurando l’Euromercato di sua proprietà, Berlusconi non ebbe esitazioni. A Roma si votava per il sindaco e a fronteggiarsi c’erano da un lato Francesco Rutelli e dall’altro proprio il leader missino: «Se fossi elettore nella Capitale? Voterei per Fini, sicuro». In tanti giudicarono quel gesto lo sdoganamento politico dei post- fascisti. Errore. La verità è che Berlusconi aveva assimilato alla perfezione la logica del maggioritario e la stava semplicemente esercitando. Come sempre, aveva visto prima e meglio di tutti. Tutti? Ma tutti chi? Già, perché in quella campagna elettorale c’erano anche gli altri, seppur oscurati. A cominciare dagli alleati di Re Silvio. Geografica- mente divisi: al Nord la Lega di Bossi; da Roma in giù i missini di Gianfranco. Nel mezzo, appunto, Berlusconi perchè quegli altri due non si parlavano. Anzi: si insultavano. «Porcilaia fascista» era il delicato epiteto del Senatur. «Con quelli neanche un caffè», replicava l’ex delfino di Almirante. Era soprattutto Bossi a mordere il freno. L’inchiesta di Antonio Di Pietro aveva spazzato via i partiti storici e l’Umberto s’era intestato il copyright della secessione nordista. E invece si ritrova all’improvviso sorpassato da un Tir in doppiopetto, guidato da un amico di Bettino e con un compagno di cabina come Gianni Letta, quintessenza dell’abilità manovriera profumata di Biancofiore. Bossi è furbo, capisce che senza Berlusconi rimane un prodotto delle valli e non Braveheart. Però trama anche lui. Nei suoi resoconti, Claudio Petruccioli, braccio destro di Occhetto, racconta di un incontro alla vigilia del voto con Roberto Maroni in un hotel di Bologna: «Mi disse che avrebbero vinto le elezioni. E mi chiese se, nel caso la Lega si fosse sganciata subito dopo, avrebbe potuto contare sul sostegno del Pds». Come andò a finire lo sanno tutti: per dettagli chiedere a Lamberto Dini, ministro del Tesoro del primo governo Berlusconi e suo successore a palazzo Chigi. Poi c’era, come detto, Gianfranco Fini. Che incubava Alleanza nazionale «pronta ad abbandonare la casa del padre», e nel frattempo ricordava ad Alberto Statera de La Stampa che Mussolini era stato «il più grande statista del Novecento», mentre irrideva agli anatemi della sinistra prontissima ai parallelismi con il neo- premier: «Berlusconi? Non è certo il Duce. Direi piuttosto un grande piazzista». E poi c’erano quelli a sinistra, i comunisti ridotti ai minimi termini o addirittura spariti dalla geografia politica del Vecchio Continente dopo la caduta del Muro di Berlino e invece continuamente evocati come avversari subdoli e sventolati ad ogni occasione da Berlusconi. Occhetto vestiva di grigio, parlava di «nuovo inizio» e «atto fecondo» cominciato alla Bolognina con l’addio al Pci e l’approdo alla Quercia, e per quanto si sforzasse (poco, in verità: era sicuro di maramaldeggiare) non riusciva proprio a capire come avrebbe potuto perdere le elezioni dopo la splendida avanzata alle amministrative di pochi mesi prima e l’inconsistenza politica del suo competitor. Quando si aprirono le urne e risultò che Forza Italia aveva raggiunto il 21 per cento surclassando di oltre 300 mila voti il Pds, entrò in confusione. Senza più uscirne. Ma a ben vedere gli avversari più ostici e determinati di Berlusconi furono i magistrati di Milano. Le inchieste a suo carico si moltiplicavano, l’avviso di garanzia speditogli mentre presiedeva come capo del governo un convegno internazionale sulla criminalità segnerà uno spartiacque nel conflitto tra politica e toghe, aprendo una ferita non ancora del tutto suturata. Resta tuttavia che quel 27 marzo del 1994, data della valanga vittoriosa del Polo delle Libertà, rimarrà nella storia: e non solo italiana. Il primo esperimento di governo berlusconiano durerà appena otto mesi, complice il ribaltone del Carroccio e il no a nuove elezioni statuito da Oscar Luigi Scalfaro. Per tornare a recitare da presidente del Consiglio Berlusconi dovrà aspettare ben sette anni: un’infinita traversata nel deserto. Tuttavia da quella data di 24 anni fa tutto è cambiato: in tanti giurano in peggio, però convengono sul fatto che indietro non è possibile tornare. Il più convinto di tutti, naturalmente, è proprio Berlusconi che da quella marcia trionfale ha patito vicissitudini di tutti i tipi – politiche, giudiziarie, personali – che avrebbero stroncato un elefante e che invece l’hanno solo scalfito. Al punto che il Signore di Arcore è tuttora in pista, convinto di poter ancora una volta primeggiare nelle urne e nei cuori degli italiani. Il suo avversario adesso non sono più i comunisti, non è più la sinistra che anzi adesso elogia nella persona di Matteo Renzi, con il quale coltiva sintonie non trascurabili. Perfino i giudici azzannano meno: c’è stato Cesano Boscone. Ora gli avversari sono di altro tipo: interni al centrodestra come Matteo Salvini, e fuori dal circuito politico tradizionale come i Cinquestelle. Il perchè, al di là delle fumisterie della propaganda, è chiaro. «Quello in cui milito non è, non vuole essere e non sarà un partito tradizionale. È un Movimento per cittadini che nascono ora alla politica ma non la intendono come un mestiere a vita»: è così che Silvio presentò Forza Italia. Ora quelle parole e quei concetti li spargono i grillini e Berlusconi li combatte strenuamente sapendo che sono suoi cloni. La storia, ancora una volta, si è ripetuta: però rovesciandosi. L’Unto del Signore può, entro certi limiti of course, anche accettare di perdere. Non però di vedersi sfilato il segno del comando. Comprese le parole per dirlo.
#90secondi, Pietro Senaldi il 28 Dicembre 2017 su "Libero Quotidiano": "Auguri alla Costituzione: se siamo messi male è anche colpa sua". Lo scorso 27 dicembre c'è chi ha festeggiato il settantesimo anniversario della Costituzione italiana. Un testo fondamentale, quando è nato, ma che oggi ha bisogno di una radicale svecchiata, se vogliamo salvare l'Italia.
Contro gli "eletti illegittimi" in difesa della Costituzione. Il prossimo Parlamento sarà eletto con una legge elettorale immorale e truffaldina e dunque incostituzionale. Parola di Zagrebelsky e di Montanari, scrive Massimo Bordin il 29 Dicembre 2017 su "Il Foglio". Gli eletti illegittimi non cambino la Carta. A leggere ieri questo titolo, nella pagina dei commenti del Fatto, veniva da chiedersi se il giornalaio si fosse confuso ritirando fuori una vecchia copia del quotidiano ai tempi della riforma costituzionale. Effettivamente una polemica del genere ci fu all’epoca del voto del Parlamento, poi contraddetto dal referendum, ma non c’è stato nessun errore e nessuna ristampa. L’articolo intendeva riferirsi alla stretta attualità e non agli eletti del Parlamento ormai al capolinea ma a quelli ancora da eleggere. Tomaso Montanari ha inteso mettersi avanti col lavoro, intimando ai candidati di impegnarsi solennemente almeno a non modificare la Costituzione, considerato che la loro elezione avverrà attraverso una legge elettorale immorale e truffaldina e dunque incostituzionale. Qui il ragionamento, per così dire, di Montanari ha un’impennata, necessaria per superare un ostacolo. Il professore non può non convenire sul fatto che la Corte costituzionale non si sia neppure sognata di pronunciarsi in quei termini sulla nuova legge elettorale, ma non è questo il punto. Quello che conta, scrive il professore, è che molti insigni costituzionalisti l’abbiano fatto e che fra essi in particolare spicchi il parere, per di più espresso sulle pagine del Fatto, di Gustavo Zagrebelsky. Tanto deve bastare a decretare l’illegittimità preventiva degli eletti. Per fermare un Parlamento una volta era necessario un monarca, oggi può bastare un principe ucraino.
Costituzione inefficiente, Paese ingestibile. Se la sera del 4 marzo prossimo non sapremo chi avrà vinto le elezioni. Non sarà colpa della legge elettorale, ma della Carta, scrive Alessandro Sallusti, Giovedì 28/12/2017, su "Il Giornale". La nostra Costituzione in queste ore compie settant'anni e fioccano le celebrazioni. Non ci uniamo alla retorica, ma a scanso di equivoci diciamo che anche noi vogliamo bene alla Carta repubblicana che ha permesso all'Italia di archiviare una guerra civile e mettersi alle spalle la disfatta militare e morale della Seconda guerra mondiale. Tutte le Costituzioni dei Paesi occidentali sono vecchie, alcune ben più della nostra, ma non tutte sono nate vecchie come la nostra. In quel dicembre del 1947 l'ossessione dei padri costituenti fu di fare in modo che in Italia nessuno potesse comandare senza il consenso e il permesso di tutti, o quasi tutti, gli altri partiti politici, poteri dello Stato e forze sociali. In questi settant'anni abbiamo cioè vissuto in una finta iper democrazia che - amputata volontariamente dell'efficienza - è diventata un carrozzone ingestibile. Questa Costituzione ha prodotto leggi elettorali cervellotiche con le quali nessuno dei vincitori (neppure la Democrazia cristiana) è mai riuscito a governare come promesso agli elettori; abbiamo un presidente del Consiglio attorno al quale ruota l'azione di governo che in realtà non ha poteri; abbiamo un presidente della Repubblica non eletto dai cittadini che apparentemente non conta nulla ma che esercita, lui sì, enormi poteri; abbiamo un Parlamento di transfughi che si vendono al migliore offerente, sindacati con il potere di veto sul legislatore e una magistratura che ha confuso l'autonomia professionale con la libertà di ingerenza e l'impunità. Questa Costituzione ha generato i Tar, tribunali amministrativi di secondo livello, che contano più del Parlamento e del governo. E questa Costituzione agevola e protegge la burocrazia, i fannulloni, a volte anche i ladri. Se la sera del 4 marzo prossimo non sapremo chi avrà vinto le elezioni e se nessuno dei blocchi in lizza potrà governare, non sarà colpa di una legge elettorale così così o della voglia di inciucio di qualcuno. Sarà colpa della Costituzione, che permette che ciò accada impedendo di fatto soluzioni diverse e chiare. Soluzioni che nel '47 potevano anche essere rischiose, ma che certamente oggi non lo sarebbero per nessun motivo. Renzi ci ha provato a cambiare qualcosa con l'abolizione del Senato, ma era una farsa, la gente l'ha capito e lo ha punito. Che sia, la prossima legislatura, la volta buona per portare il Paese nella modernità con una riforma costituzionale, mi auguro in senso presidenziale, che chiuda un'epoca di innaturale consociativismo tra vinti e vincitori, tra controllori e controllati.
L'Italia della disperanza, scrive il 26 novembre 2017 Massimo Giannini su “La Repubblica”. L'ottava Leopolda renziana a Firenze, l'ottantesimo predellino berlusconiano a Milano, l'incubo grillino al Teatro Flaiano di Roma. Le solite riscosse annunciate a sinistra, le solite promesse spudorate a destra, le solite percosse pentastellate al "sistema". Nella campagna elettorale già si colgono i segni di un'inquietante stanchezza democratica. Tanti anni fa Josè Donoso scrisse un magnifico romanzo sul suo Cile: La disperanza. Credo che questo sia ...
Sgravi e contributi, le solite promesse del vecchio Cavaliere, scrive il 28 dicembre 2017 Filippo Ceccarelli su “La Repubblica”. I cavalli di battaglia del leader di Forza Italia per la nuova campagna elettorale sono quelli che ripropone da sempre. Nel paese di Acchiappacitrulli, più che chiedere voti in cambio di progetti, Silvio Berlusconi è un generatore automatico di promesse. Si perdoni il tono risoluto del giudizio, ma sono ormai 24 anni di campagne elettorali, per cui l'ultimissimo scampolo dei suoi impegni - sgravi totali per i giovani, aumento pensioni minime, reddito "di dignità" e flat tax al 23 con automatico calo al 13 per cento - finisce per aggrovigliarsi nella memoria con il penultimo....
Elezioni 2013: campagna elettorale con le solite promesse (mai mantenute). Meno tasse e lavoro, scrive "Finanza Utile" il 14/01/2013. Pagina aggiornata il 2017-12-14. Parole, parole, parole. E’ iniziata la campagna elettorale che ci porterà alle elezioni politiche del prossimo 24 febbraio. E come per “magia” i leader politici che si contendono palazzo Chigi hanno iniziato a fare le solite promesse ai cittadini: meno tasse e più lavoro. Peccato però, che negli ultimi anni (almeno un decennio) queste promesse non sono mai state mantenute.
LE PROMESSE 2013.
Ovviamente la promessa più “roboante” è il calo delle tasse, a cominciare dal balzello più odiato dagli italiani, l'Imu sulla prima casa. Vediamo cosa promettono i tre principali contendenti alla guida del governo: Pier Luigi Bersani, Mario Monti e Silvio Berlusconi.
Il Cavaliere promette, in caso di vittoria, di abolirla, ma non per le abitazioni di lusso.
Bersani propone di affiancare all'Imu, per alleggerirla, un'imposta personale sui grandi patrimoni immobiliari. Per rendere meno pesante il carico fiscale sulle prime case con rendite più modeste, con una soglia di esenzione fino ai 500 euro.
Monti e i suoi alleati centristi centristi promettono agli elettori una modifica che vada nel senso di una maggiore equità. E c'è disponibilità anche per le richieste Ue in tema di riforma del catasto per avvicinarne maggiormente le rendite al valore di mercato.
IL LAVORO.
Altro tema caldo è il lavoro con il conseguente rilancio dell'economia. Anche in questo caso i tre maggiori contendenti hanno idee diverse.
Berlusconi lancia l'idea di esentare le imprese che assumono sia i contributi previdenziali, sia le tasse, per un periodo da 3 a 5 anni. In più, l'ex premier propone di rendere più facile avviare un'impresa, «togliendo tutte le autorizzazioni chesi devono chiedere per aprire un negozio, dare il via ad un cantiere», trasformando queste autorizzazioni in «controlli successivi». Tre le riforme promesse dal leader del Pdl: «un piano per il nuovo apprendistato, la liberalizzazione del collocamento e un fondo per i giovani che vogliono fare gli imprenditori che non pagheranno tasse per i primi tre anni e successivamente pagheranno solo il 5% per altri due anni».
La ricetta di Monti è «più concorrenza e meno favori per tutelare i giovani» e la loro possibilità di avere un futuro nel mondo del lavoro, e contro l'evasione fiscale, il premier si dice pronto a «continuare la battaglia di civiltà». Monti si dice ottimista: tagliare di punto l'Irpef e non alzare di un punto l'Iva.
Per Bersani il tema centrale è alleggerire il peso del fisco sul lavoro e sull'impresa, lottando contro l'evasione e spostando il peso del fisco sulla rendita e sui grandi patrimoni finanziari e immobiliari.
Dieci anni dal predellino. Ma l’Italia continua a parlare di Berlusconi. Il 18 novembre 2007 lo storico discorso di San Babila e la nascita del Pdl. Ennesima intuizione di un leader che non riesce a uscire di scena. Ora il Cav punta alle settime elezioni Politiche della carriera, nonostante la condanna. Lui sembra sempre uguale, ma il mondo che gli sta attorno è cambiato, scrivono Marco Sarti e Alessandro Franzi il 3 Novembre 2017 su “L’Inkiesta”. Milano, domenica 18 novembre 2007. Sono le sei di sera quando Silvio Berlusconi sale sul predellino della sua auto nella centralissima piazza San Babila. Il leader di Forza Italia guida ormai da un anno e mezzo l’opposizione al governo Prodi. Criticato da alleati e avversari, sta vivendo uno dei rari momenti di vera difficoltà della sua carriera. Eppure, nell’improvvisato discorso alla folla di sostenitori, attorniato da un muro di microfoni e telecamere, quella sera di ormai dieci anni fa Berlusconi prende tutti in contropiede. Annuncia lo scioglimento del partito fondato nel 1994 e la nascita di una nuova formazione di centrodestra per unire tutte le anime della coalizione (tranne la Lega). Un azzardo, di cui gli alleati sono all’oscuro. Con il Popolo della Libertà, acronimo Pdl, Berlusconi vincerà di nuovo le elezioni Politiche, nell’aprile successivo. Da quella serata milanese sembra trascorso un secolo. Ma Berlusconi, a suo modo, è ancora in scena. La prossima primavera affronterà le elezioni Politiche per la settima volta, a 81 anni, malgrado una condanna definitiva per frode fiscale che gli impedisce di candidarsi in prima persona. È innanzitutto il panorama attorno a lui, a essere cambiato. All’epoca del discorso del predellino, Walter Veltroni guidava il neonato Partito Democratico, mentre a Palazzo Chigi c’era ancora Romano Prodi, con un elenco di ministri che comprendeva personalità del calibro di Mastella, Amato, Di Pietro. Matteo Renzi faceva ancora il presidente della Provincia di Firenze, praticamente sconosciuto fuori da lì. E il Movimento Cinque Stelle neppure esisteva, sebbene qualche settimana prima si fosse levato il boato del primo Vaffa Day di Beppe Grillo. Tutto era diverso, tranne lui. Oggi, dieci anni dopo, Berlusconi fa ancora Berlusconi. O almeno ci prova. Si veste e si trucca come allora, promette la rivoluzione liberale, entra ed esce da una nota beauty farm di Merano per mettersi in forma in vista dell’ennesima campagna elettorale. Continua a considerarsi il garante del cosiddetto popolo dei moderati.
Dopo 14 anni da "La finestra di fronte”, Ozpetek torna a dirigere Giovanna Mezzogiorno in un thriller ricco di mistero, ragione, follia e sensualità. Milano, domenica 18 novembre 2007. Sono le sei di sera quando Silvio Berlusconi sale sul predellino della sua auto nella centralissima piazza San Babila. Il leader di Forza Italia sta vivendo uno dei rari momenti di vera difficoltà della sua carriera. Eppure, nell’improvvisato discorso alla folla di sostenitori, attorniato da un muro di microfoni e telecamere, prende tutti in contropiede. È il segno evidente di una longevità politica rara e, forse, di un Paese che non sa cambiare. «Non c’è solo il predellino, Berlusconi è protagonista della scena dal 1994» sottolinea Altero Matteoli, senatore berlusconiano e più volte ministro dei governi di centrodestra. «Anzitutto ha una capacità di lavoro impressionante, non ho mai visto nessuno lavorare tante ore come lui. E poi il Cavaliere ha una forte personalità. Ha attraversato una serie di vicissitudini personali che avrebbero ucciso un toro. Lui, invece, è rimasto sempre al suo posto». Ai tempi del predellino, Matteoli era un dirigente di primo piano di Alleanza nazionale, allora saldamente nelle mani di Gianfranco Fini. Che pur non condividendo da subito l’idea del Pdl, alla fine la accettò, confidando anni dopo di aver commesso il suo più grande errore politico. «Quello del partito unico - insiste Matteoli - fu un passaggio fondamentale. Non è un caso se ancora oggi molti rimpiangono il Pdl, e io sono tra loro. Era un partito che metteva insieme tante anime e diverse esperienze». Non durò moltissimo, per la verità. Il Pdl è finito durante la crisi dell’ultimo governo guidato dal Cav, mentre si consumava una drammatica scissione proprio con Fini. Nel 2013, un altro gruppo di ex An si sarebbe presentato alle elezioni con un nuovo soggetto politico: Fratelli d’Italia. E così qualche mese più tardi, dopo la condanna che lo ha estromesso dal Senato, Berlusconi è tornato al vecchio amore: Forza Italia. Sancendo la rottura con l’ex delfino Angelino Alfano, allora vicepremier del governo di larghe intese guidato da Enrico Letta. In quei mesi, Piero Ignazi, politologo dell’Università di Bologna, scriveva un libro dal titolo esplicito: Vent’anni dopo. Berlusconi, comunque la si veda, aveva profondamente segnato un ventennio della politica italiana, più di qualsiasi altro leader del dopoguerra: «Una presenza dominante e continua, un’impronta che non si limita al piano specificamente politico, ma investe gli atteggiamenti e i valori, la comunicazione e lo stile di leadership, la cultura politica in senso lato». Il politologo oggi vede in tutte queste caratteristiche anche il limite che non ha permesso a Berlusconi di trovare un erede: «Non lo ha voluto, tutti i leader con il suo profilo - risponde - non lo vogliono mai. E poi oggettivamente Berlusconi ha i soldi, le televisioni… Come si fa a trovare un vero successore con gli stessi strumenti?».
Per fare una sintesi: Il modello berlusconiano di uomo di successo con il sorriso in tasca ha incarnato nell’immaginario italiano tutto e il contrario di tutto. Il populismo di governo, che ha anticipato molti fenomeni internazionali, qualcuno dice anche Donald Trump. E ha stuzzicato la natura profonda del Paese: un’italianità che sfocia nella contrapposizione allo Stato e al politicamente corretto, ma senza eccessi. Amato e odiato nella stessa misura, anche per questo Berlusconi è sempre rimasto protagonista. Persino sul fronte delle grane giudiziarie: appena l’altro giorno si è saputo di una nuova indagine sulle stragi di mafia del 1993. «Ma le doti comunicative da sole non bastano - sostiene Matteoli -. Anche Matteo Renzi è un grande comunicatore, eppure la sua stagione politica è durata al massimo un paio di anni». Il paragone non è casuale. Sono stati in molti ad aver accostato il segretario del Pd al Cavaliere. Stesso approccio alla politica, uguale ingresso dirompente sulla scena. «Lasciamo stare - sbotta l’ex ministro - Quella è tutta un’altra storia, Berlusconi è di un altro spessore». Semmai Renzi potrebbe presto entrare nel lungo elenco degli avversari sconfitti. E in buona parte scomparsi dalla scena. Da Prodi a Rutelli allo stesso Veltroni, che comunque resta uno dei pochi padri nobili del centrosinistra a sognare un ritorno sulla ribalta. Berlusconi è sopravvissuto a Mario Monti, che nel 2011 prese il suo posto a Palazzo Chigi nel mezzo di una tempesta finanziaria che avrebbe dovuto seppellire definitivamente il ventennio. Pierluigi Bersani, che nella campagna elettorale del 2013 aveva promesso di “smacchiare il giaguaro”, ormai è fuori dal Pd. E poi c'è la lista degli eredi mai cresciuti e alla fine ripudiati: Fini, Fitto, Alfano. Persino nella Lega l’alleato di ferro Umberto Bossi - «lascerò la politica quando la lascerà Silvio» - non conta più nulla. ll modello berlusconiano di uomo di successo con il sorriso in tasca ha incarnato nell’immaginario comune tutto e il contrario di tutto. È stato il populismo di governo, ha stuzzicato la natura profonda del Paese. Amato e odiato nella stessa misura, anche per questo il Cavaliere è sempre rimasto protagonista. Ma Berlusconi, alla fine, è davvero sempre al centro della scena? È lui che può dare le carte, che può decidere gli equilibri del prossimo Parlamento? O è solo una suggestione giornalistica? Per il professor Ignazi il mito Berlusconi ormai sopravvive alle stesse fortune del Cavaliere. Una bulimia mediatica che sopravvaluta le reali forze in campo. «Oggi la Lega raccoglie più consensi di Forza Italia, c’è voluto un esterno come Salvini - sostiene il politologo - per emarginare Berlusconi. Nei confronti di quest’ultimo c’è una specie di coazione a ripetere che non rispecchia la realtà. Forza Italia non ha più l’egemonia, al massimo ci sarà un grosso equilibrio con la Lega che sarà gestito attraverso una contrattazione fra le parti». Nemmeno la leadership carismatica di Berlusconi è rimasta centrale? «No, fa parte di un passato lontano, la crisi - risponde Ignazi - ha travolto l’immagine di successo di Berlusconi. Che semmai cercherà di far dimenticare le malefatte del passato, e il suo successo dipenderà solo dalla capacità di mistificazione che metterà in campo». I suoi sostenitori la vedono ovviamente in modo diverso. Almeno in pubblico, dove i dubbi sulla stanchezza di un leader dalle mille vite vengono mantenuti nascosti. Per Matteoli, il Cavaliere è quello di sempre: «Fateci caso - confida - se Berlusconi parla, tutti i giornali ne scrivono. Se non parla, tutti i giornali cercano di interpretare i suoi silenzi. Lui è così: si può odiare o amare - è vero, c'è persino chi lo ama - gli si può essere amici o avversari, ma tutti concordano su un dato: il protagonista è sempre Berlusconi. La stampa e le tv non possono fare a meno di parlarne. In un mondo dove non ci sono più leader, è una verità indiscussa».
È finita la legislatura degli hashtag, per fortuna. Gli spot, i bonus, le "renzate", i tweet al limite del ridicolo hanno caratterizzato la politica degli ultimi cinque anni. Ora c'è bisogno di calma, scrive il 29 dicembre 2017 Sara Dellabella su Panorama. Tronfio, divisivo, ambizioso, sprezzante dell’opinione altrui. Esageratamente leader. Una parabola quella di Matteo Renzi passato dalle scalate alle ritirate in appena tre anni. Si è chiusa così una legislatura che grazie al leader del PD ha avuto tre governi. Il primo quello di Enrico Letta che è stato disarcionato appena dopo 10 mesi di governo, poi vennero i mille giorni di Renzi che si conclusero con il più grosso tonfo della storia repubblicana degli ultimi anni ed infine l’anno calmo del supplente Paolo Gentiloni, messo lì per tappare un buco e che alla fine si è rivelato un politico affidabile e ben apprezzato dalla gente. Sono passati cinque anni, ma i problemi della politica sono ancora tutti lì e in alcuni casi hanno cambiato casacca anche loro. Dopo il voto del Parlamento, sembrava finita l’era di Berlusconi e invece eccolo risorto come guida del centrodestra, anche se non potrà candidarsi. Tuttavia non è stato risolto il problema della leadership: dopo Berlusconi chi potrà avere un ruolo di federatore carismatico?
Il disastro del Pd. Nel Pd, l’astro nascente di Renzi si è oscurato, il partito è ai minimi storici e con le casse in profondo rosso. Il segretario non rinuncia esplicitamente ad avvalersi a quella regola dello statuto che lo vuole candidato premier, ma i sondaggi non lo premiano e c’è chi continua a credere che dovrebbe allontanarsi per un po’ dalla scena pubblica. Anche perché se l’operato del mite Gentiloni oggi è lodato da tutti, sarebbe giusto dire che non si allontana molto dall’impronta del governo di Enrico Letta prima di essere messo alla porta da uno scalpitante e irrequieto Matteo Renzi che il giorno del discorso di fiducia al Senato, disse “vorrei essere l'ultimo Presidente del Consiglio a chiedere la fiducia a quest'Aula”, così sicuro che gli italiani gli avrebbero dato ragione ed invece…Lui che nel suo libro “Avanti” si è paragonato a Wanna Marchi per come ha presentato la misura degli 80 euro e che in più occasioni per semplificare il linguaggio delle cose complesse ha inseguito i populisti.
La politica degli spot. Ma gli spot, i bonus, le renzate, gli hashtag al limite del ridicolo, alcuni commenti affidati ai social hanno caratterizzato non solo la politica renziana ma la politica degli ultimi cinque anni, tanto che a volte si faceva fatica a distinguere i fake account dai profili originali. Paradossale e a tratti parossistica. Come l'immagine di quel parlamento in seduta comune che ha salutato ogni passaggio del discorso dell’insediamento Napolitano bis con fragorosi applausi. Quella che ad ascoltarla bene è stata la più grande "strigliata" presidenziale a un Parlamento che non era stato capace di trovargli un successore. A riavvolgere il nastro di questo Parlamento, sembra sia andato in scena un lungo film e così assurdo che non bisognerebbe poi tanto sconvolgersi se a 66 giorni dalle elezioni l’unico partito in crescita sia quello degli astenuti. È stata senz’altro la legislatura del cortocircuito, quella in cui il Patto del Nazareno ha spaccato la sinistra e ricompattato il centrodestra. Così oggi, il rottamatore si trova completamente isolato al centro, mentre Liberi e Uguali continua a erodere consensi a sinistra. Il Movimento 5 stelle che oggi è il primo partito rischia di rimanere con il cerino in mano. Ancora non c’è un programma, ancora non si capisce con chi e se si alleerà. Ancora non si sa cosa vogliono fare concretamente per il Paese, proprio come quando sono entrati in Parlamento.
Aggrapparsi alla calma. In questo caos, gli unici appigli sono Sergio Mattarella e Paolo Gentiloni. Quelli che parlano meno di tutti, che appaiono poco e che silenziosamente svolgono la loro funzione con la dovizia dei funzionari pubblici. Traghettatori della Repubblica, esecutori materiali di regole e procedure già scritte che vanno solo attuate. Sono loro l’ultimo appiglio in un agone dove tutti si agitano, dove in questi anni si è giocato a chi la “sparava più grossa”, manco fossimo allo stadio. “Non è tempo di rottamazioni, slogan e leadership solitarie” così anche Carlo Calenda ha messo nero su bianco il suo pensiero circa una nuova scalata di Renzi a Palazzo Chigi. È il tempo della calma che sopravvive al caos, almeno fino al prossimo governo.
2018, si porta molto il pacatismo, scrive Alessandro Gilioli il 29 dicembre 2017 su "L'Espresso". A leggere l'intervista che Berlusconi ha dato al Corriere di oggi, sembra di avere davanti un autorevole e moderato statista di centrodestra: di Gentiloni dice che è stato «insufficiente» ma ne elogia «la cortesia», su Grasso si limita all'aggettivo «inelegante», poi cita John Kennedy, ipotizza uno Ius soli seppur più temperato di quello appena cestinato e infine invita «al buonsenso». Pacatissimo, insomma. E nulla a che vedere con il Cavaliere caimano, spaventoso e a tratti sedizioso che è stato per anni, dal '94 al predellino e oltre. Non molto dissimili erano i toni dell'intervista che Luigi Di Maio ha dato ieri al Fatto: «Voglio dare stabilità al Paese», «confido che il referendum sull'euro non si debba fare perché l’Europa è molto cambiata e per l’Italia ci sono maggiori spazi per farsi sentire», «creeremo una Banca pubblica per gli investimenti sul modello francese». Approccio istituzionale, nessun aggettivo fuori posto, moderazione verbale e programmatica. E nulla a che vedere con anni e anni di blog e comizi di Grillo, non privi di insulti sprezzanti. Di Gentiloni - "l'impopulista", non c'è neppure bisogno che vi dica: la sua conferenza di fine anno è stata una dose di benzodiazepina, tutta tesa a rassicurare, acquietare, confortare, rasserenare. E nulla a che vedere con la baldanza nuovista e un po' isterica del suo predecessore, schiantatosi un anno fa come un motociclista cocainato sulla tangenziale. È curioso come questo Paese sia passato in pochissimo tempo da un estremo al suo opposto. Solo ieri la politica italiana era fatta di tweet deflagranti, accuse violente, promesse di rovesciamenti mirabolanti, il tutto trasmesso con toni urlati, eccitati, demagogici, elettrizzati, talvolta ribellistici se non eversivi, comunque indirizzati alla pancia, finalizzati a provocare sdegno o creare chimere di cambiamenti rivoluzionari. Con tutti e tre i maggiori leader - Berlusconi, Grillo e Renzi - impegnati in questa assordante gara. Adesso siamo alla democristianizzazione comportamentale multipartisan, con il Di Maio statista, il Gentiloni camomilla e la versione mansueta di Berlusconi. E pure quella che un tempo si chiamava "sinistra radicale" si è scelta un leader che non viene dalla piazza, ma dagli stucchi dorati e silenti di Palazzo Madama. Insomma, sembra che la politica non voglia più eccitare, ma sedare. Con poche eccezioni, come Salvini (che però da mesi perde consensi nei sondaggi) e qualche ultrà renziano che non ha ancora capito che è cambiato il vento. Che nove italiani su dieci non si divertono più davanti a pollai urlanti dei talk show, ma cambiano canale appena le voci accalorate si accavallano. Perfino sui social sembra che ci sia meno gente che si accanisce nei flame, avendone ormai constatato l'inutilità totale dello scambio di insulti. È il pacatismo, chissà se una svolta o solo una fase di down dopo la sovreccitazione trasversale recente. Intendiamoci: questa mutazione è avvenuta, con ogni probabilità, più per stanchezza che per saggezza, più per distacco che per maturazione, più per disinteresse che per educazione. Ma intanto è avvenuta. Con tutti suoi lati positivi - evidenti - ma anche quelli negativi, cioè i rovesci della medaglia, essendo un altro estremo opposto: ad esempio il rischio che il confronto perda passione, che la moderazione si tramuti in pigra difesa del presente. Che anche nelle cose da fare - e da cambiare - tutte le vacche diventino nere. E neppure questo farebbe bene, in un Paese sempre più declinante e diseguale, che bisogno tanto di educata razionalità quanto di trasformazioni sociali radicali.
Addio diciassettesima, con te se ne va la Seconda Repubblica, scrive Francesco Damato il 29 Dicembre 2017 su "Il Dubbio". Cinque anni tra renzismo e grillismo. Già con quel numero d’ordine – 17- assegnatole dal calendario parlamentare della Repubblica, la legislatura uscita dalle urne il 25 febbraio del 2013 sembrava inevitabilmente sfortunata, da scongiuri più che da auguri. I risultati elettorali non furono da meno. Il bipolarismo orgogliosamente rivendicato dal centrodestra e dal centrosinistra dal 1994 in poi, come bandiera della cosiddetta seconda Repubblica, risultò superato da un tripolarismo paralizzante, che neppure il premio di maggioranza assicurato dalla legge elettorale infelicemente nota come Porcellum riuscì a correggere. O vi riuscì solo alla Camera, non anche al Senato, dalla cui fiducia nessun governo poteva e può tuttora prescindere. La quasi contemporanea scadenza del settennato presidenziale di Giorgio Napolitano, al Quirinale, rendeva costituzionalmente impraticabile ogni tentazione di elezioni antici- pate, se mai qualcuno le avesse volute davvero, e non solo a parole, come reclamavano i grillini da una parte, col proposito di compiere lo sfondamento mancato al primo colpo, e i leghisti dall’altra. Pier Luigi Bersani come segretario del maggiore partito – se non in termini di voti, viste le contestazioni grilline, sicuramente in termini di seggi parlamentari fra Camera e Senato, ma specie alla Camera – ottenne dal presidente della Repubblica un prudente incarico di formare il nuovo governo. Tanto prudente che, quando Napolitano glielo ritirò negandogli il percorso di un governo curiosamente di «minoranza e di combattimento», appeso agli umori di Beppe Grillo e dei suoi “portavoce” parlamentari, si scoprì che era stato solo un “pre- incarico”. L’insuccesso politico di Bersani crebbe ulteriormente dopo che il segretario del Pd non riuscì a venire a capo neppure dell’elezione di un successore a Napolitano, nel frattempo arrivato al termine ultimo del suo mandato. I due candidati messi in pista da Bersani per il Pd nella corsa al Quirinale – il presidente del partito Franco Marini prima e l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi poi – furono abbattuti dai franchi tiratori. E Bersani per primo fu costretto a salire quaresimalmente al Colle, seguito da quasi tutti gli altri leader di partito, per chiedere a Napolitano la grazia di lasciarsi ricandidare e rieleggere, alla bella età di 88 anni quasi compiuti che “Re Giorgio” già aveva. Quasi tutti, perché i grillini opposero il rifiuto anche a questo passaggio, candidando sulle piazze e in Parlamento Stefano Rodotà, prima di scomunicarlo per avere osato dolersi, dopo qualche tempo, delle loro improvvisazioni, pure nella gestione del movimento che si era proposto di aprire le istituzioni come scatole di tonno. Da Napolitano rieletto alla Presidenza della Repubblica le Camere accolsero con spirito che qualcuno, non solo fra i grillini, definì masochistico i rimproveri per le riforme boicottate dalla precedente edidagli zione del Parlamento e per la diffusa diffidenza mostrata anche nella nuova legislatura verso larghe intese, se necessarie – come lui riteneva – per il governo del Paese. E l’opinione del capo dello Stato non poteva essere liquidata come un capriccio senile perché toccava pur sempre a lui nominare i governi, anche se i cultori del sistema maggioritario avevano dato agli elettori l’illusione che potessero eleggere nelle urne pure il governo, e non solo il Parlamento. Nacquero così le larghe intese governative concordate attorno ad Enrico Letta, mentre Bersani si ritirava in buon ordine, fra il Pd e Silvio Berlusconi, con un programma ambizioso di riforme. Con questa scelta il Pd si allontanò ulteriormente dagli ex alleati elettorali di sinistra e Berlusconi dai leghisti e dalla destra postmissina, ora anche post- finiana. Questo già faticoso avvio della diciassettesima legislatura fece i conti in agosto con una improvvisata sezione feriale della Corte di Cassazione. Che, praticamente diffidata da un fax della Procura di Milano dal lasciar cadere in prescrizione un vecchio processo a carico di Berlusconi per frode fiscale, sia pure di una misura risibile rispetto al peso complessivo delle tasse pagate dall’imputato e dalle sue aziende, condannò in via definitiva l’ex presidente del Consiglio. Sotto i piedi del quale si aprì la botola giudiziaria della cosiddetta legge Severino per farlo decadere anche da senatore con inedita votazione, nell’aula di Palazzo Madama, a scrutinio palese. Le cose si svolsero in modo tale, con forzature difficilmente negabili, visto che anche dall’interno del Pd si erano levate inutilmente voci – per esempio, quella dell’ex presidente della Camera Luciano Violante – a favore di un rinvio di ogni decisione per lasciare alla Corte Costituzionale la possibilità di pronunciarsi sulla controversa legge Severino, che Berlusconi ritirò il suo partito dalla maggioranza. La quale sopravvisse ugualmente, ma di stenti, per il rifiuto del vice presidente del Consiglio e ministro dell’Interno Angelino Alfano, ma anche degli altri ministri dell’allora Pdl, di adeguarsi alle direttive berlusconiane. Nacquero così i “diversamente berlusconiani” del “Nuovo centrodestra”. I loro ormai ex colleghi di partito reagirono tornando orgogliosamente al nome originario di Forza Italia, indossando gli elmetti dell’opposizione e riavvicinandosi ai leghisti. Come una pera dall’albero, cadde dopo poco più di un mese Enrico Letta dalla guida del governo, sotto l’effetto combinato di una più forte opposizione a destra, oltre a quella grillina, e di un cambiamento radicale al vertice del Pd. Dove arrivò impetuosamente Matteo Renzi. Che, senza badare molto alle forme, si spazientì dei metodi e tempi morotei del collega di partito Enrico Letta, che pure non lo aveva per niente ostacolato nella corsa congressuale alla segreteria, e ne prese il posto in poche settimane: giusto il tempo per attenuare l’opposizione di Berlusconi offrendogli una sostanziale riabilitazione politica con un patto, che prese il nome dalla sede del Pd, il Nazareno, sulle riforme. Al plurale, perché oltre a quella della Costituzione c’era da accelerare quella elettorale, avendo la Corte Costituzionale appena bocciato il malfamato e già ricordato Porcellum. Il pronunciamento della Consulta finì per aumentare le difficoltà della legislatura, di cui i grillini si affrettarono a denunciare la delegittimazione, essendo nata con regole risultate appunto illegittime. La Corte, peraltro dirimpettaia al Quirinale, la mise nella incubatrice di una sentenza nella quale si salvavano esplicitamente gli effetti delle elezioni svoltesi col Porcellum. Altro francamente non si poteva fare, perché sennò si sarebbero dovuti demolire anche gli effetti delle elezioni del 2006 e del 2008, svoltesi con le stesse norme. Lì per lì sembrò che i cerotti della Corte Costituzionale tenessero. Nelle elezioni europee di maggio del 2014 Renzi portò il Pd ad oltre il 40 per cento dei voti, come riusciva a fare la Dc nei tempi migliori: forse troppo, però, per i gusti e le abitudini dei compagni e amici di partito del segretario e presidente del Consiglio. Forse anche per Berlusconi, che vide rappresentare il giovane Renzi come il suo erede. “Royal baby”, lo definì Giuliano Ferrara, ministro per i rapporti col Parlamento nel primo governo del Cavaliere. Ma forse fu troppo per lo stesso Renzi, che sopravvalutò la sua forza d’urto. O sottovalutò, come preferite, vecchi e nuovi timori di concorrenti ed avversari, esterni e anche interni al suo partito. La baldanza di Renzi, da quel che riuscii a sapere, se non al Quirinale, nei suoi dintorni ambientali e umani, cominciò ad impensierire anche Napolitano. Che, già stanco di suo, con quel bastone che sempre più lo accompagnava nei corridoi del Quirinale, decise proprio alla fine di quell’anno di accelerare con le dimissioni la fine di quella fase eccezionale che sin dal primo momento aveva ritenuto il suo secondo mandato. E si arrivò così a fine gennaio del 2015 all’elezione del suo successore. Nella soluzione del problema riapertosi al Quirinale Renzi sembrò, a torto o a ragione, condizionato più dai problemi interni di partito che dal collegamento con Berlusconi. Che, anche lui a torto o a ragione, riteneva che del Patto del Nazareno sulle riforme facesse parte anche la ricerca comune del nuovo presidente della Repubblica. L’elezione di Sergio Mattarella finì pertanto per tradursi, malgrado lo stesso Mattarella, nella rottura fra Renzi e Berlusconi, con tutto quello che ne conseguì: anche l’approvazione accindentata della riforma costituzionale e della legge elettorale chiamata Italicum, nonché il sorprendente allineamento nella campagna referendaria sul superamento del bicameralismo e il resto fra l’opposizione berlusconiana, quella dei grillini e la dissidenza della minoranza del Pd. Era una combinazione già micidiale di suo, cui Renzi aggiunse improvvidamente, come lui stesso poi riconobbe, la personalizzazione della partita con l’incauto impegno al ritiro – ma completo- in caso di sconfitta. Che arrivò puntualmente, e smaccatamente. Lo sconfitto rinunciò solo a Palazzo Chigi, trattenendo la segreteria del partito, da cui però sarebbe uscito il grosso delle minoranze. Considerate le condizioni politiche nelle quali si era aperta e si è sviluppata, l’ondata populistica che l’ha accompagnata dal primo momento, e che ha portato i grillini a mantenere intatta la loro presa elettorale, a dispetto delle defezioni e degli incidenti subiti a livello centrale e locale, i cambiamenti intervenuti persino nella geografia dei partiti, con oltre cinquecento passaggi di parlamentari di ogni area da una combinazione all’altra, compresi i presidenti di entrambe le Camere, può ben essere considerato un miracolo che questa legislatura sia arrivata alla sua scadenza ordinaria. E, oltre a consegnarci con Paolo Gentiloni un presidente del Consiglio ancora in partita, abbia potuto annoverare non solo riforme bocciate o mancate, ma anche leggi approvate come quelle che hanno garantito nuovi diritti civili, dalle unioni di fatto al biotestamento, una nuova legge elettorale non derivata dalle forbici della Corte Costituzionale e persino un miglioramento della situazione economica, col passaggio dal meno al più, a dispetto di terremoti, crisi bancarie e altri accidenti. Poteva francamente andare anche peggio, visto com’era cominciata.
Contro gli "eletti illegittimi" in difesa della Costituzione. Il prossimo Parlamento sarà eletto con una legge elettorale immorale e truffaldina e dunque incostituzionale. Parola di Zagrebelsky e di Montanari, scrive Massimo Bordin il 29 Dicembre 2017 su "Il Foglio". Gli eletti illegittimi non cambino la Carta. A leggere ieri questo titolo, nella pagina dei commenti del Fatto, veniva da chiedersi se il giornalaio si fosse confuso ritirando fuori una vecchia copia del quotidiano ai tempi della riforma costituzionale. Effettivamente una polemica del genere ci fu all’epoca del voto del Parlamento, poi contraddetto dal referendum, ma non c’è stato nessun errore e nessuna ristampa. L’articolo intendeva riferirsi alla stretta attualità e non agli eletti del Parlamento ormai al capolinea ma a quelli ancora da eleggere. Tomaso Montanari ha inteso mettersi avanti col lavoro, intimando ai candidati di impegnarsi solennemente almeno a non modificare la Costituzione, considerato che la loro elezione avverrà attraverso una legge elettorale immorale e truffaldina e dunque incostituzionale. Qui il ragionamento, per così dire, di Montanari ha un’impennata, necessaria per superare un ostacolo. Il professore non può non convenire sul fatto che la Corte costituzionale non si sia neppure sognata di pronunciarsi in quei termini sulla nuova legge elettorale, ma non è questo il punto. Quello che conta, scrive il professore, è che molti insigni costituzionalisti l’abbiano fatto e che fra essi in particolare spicchi il parere, per di più espresso sulle pagine del Fatto, di Gustavo Zagrebelsky. Tanto deve bastare a decretare l’illegittimità preventiva degli eletti. Per fermare un Parlamento una volta era necessario un monarca, oggi può bastare un principe ucraino.
Vittorio Feltri, 27 Dicembre 2017 su “Libero Quotidiano”: è finita la legislatura peggiore di sempre. C' è chi esulta perché domani il presidente Mattarella scioglierà le Camere mandando a casa tutti i parlamentari, tra i peggiori della storia repubblicana. L' evento non dispiace neppure a noi, ma saremmo più contenti se sapessimo o sperassimo che dal prossimo giro elettorale uscisse un ceto politico più decente di quello che ci accingiamo ad archiviare. Non è così. Leggi anche: "Casini, vai in mona". Vittorio Feltri lo riduce a brandelli. Banche rotte, il terribile sospetto del direttore sui "ladri". Dalle urne sortiranno soltanto problemi e nessuna soluzione, a meno che Berlusconi, Salvini e Meloni saranno in grado di essere finalmente se stessi, cioè persone di destra come Trump, il quale dopo aver promesso di abbassare le tasse le ha abbassate sul serio. Il nodo centrale infatti è quello fiscale. L' unico modo per rilanciare l'economia e aumentare i consumi, e quindi l'occupazione, è quello di comprimere le imposte. Più soldi nelle tasche degli imprenditori e dei loro dipendenti significa creare posti di lavoro e incentivare gli acquisti. Lo Stato deve fare un passo indietro, comprimere la spesa pubblica, abbassare i costi del welfare, smettere di pagare la sanità ai ricchi e cessare di sprecare denaro per regalare esami di laboratorio a chi non ne ha bisogno. Il reddito di inclusione o di cittadinanza ai nullafacenti è un lusso che non ci possiamo permettere. Occorre che la gente vada a sgobbare, è inammissibile si faccia mantenere dalla pubblica amministrazione. Inoltre è necessario sospendere il finanziamento degli immigrati, evitare di ospitarli gratis in mancanza delle risorse che ci consentano di farlo. Impariamo dall' Austria a regolarci in proposito. Vengano qui soltanto gli stranieri che abbiano l'opportunità di guadagnarsi da vivere. È inammissibile sia l'Europa a decidere ciò che debba avvenire nei singoli Paesi. I quali hanno il diritto di agire secondo la loro convenienza. Purtroppo la nostra sinistra non è capace di amministrare l'Italia cum grano salis ed è per questo che ci troviamo in una situazione drammatica. Non sa che fare e quel poco che fa è sbagliato: vuole aiutare tutti e non aiuta nessuno, spreca soldi per assistere chi non merita di essere assistito, pensa allo ius soli (cittadinanza a chiunque) per ottenere consensi, dice che la priorità è il lavoro e, in realtà, combatte coloro - gli industriali - che avrebbero i mezzi per darne ai disoccupati. I progressisti sono una autentica iattura, odiano il capitale e lo spremono senza spingerlo a progredire. Hanno un solo obiettivo: ammazzare i cittadini di tributi, ma l'unico risultato che raggiungono è l'esplosione della evasione. Sono asini patentati. Hanno costruito negli anni un mastodonte burocratico inefficiente e costoso. Non li sopportiamo più. Agli ex comunisti si sono poi aggiunti i fessi del Movimento 5 Stelle che predicano male e si comportano malissimo, basta vedere come agiscono nelle città che governano con il posteriore. Il mix grillino e democratico produce una miscela di imbecillità che minaccia di sfasciare il Paese. Ci auguriamo che gli italiani non siano tanto stolti da affidarsi alla feccia rampante e tornino a votare con l'intento di non suicidarsi. Vittorio Feltri
Dalla Kyenge alla Boldrini fino al “grigio” Mattarella: 10 cose orribili di questa legislatura, scrive Adriano Scianca il 28 dicembre 2017 su “Primato Nazionale”. Cala il sipario sulla XVII legislatura, quella che qualcuno ha definito la peggiore di sempre. Di sicuro in questi cinque anni ne abbiamo viste delle belle (e soprattutto delle brutte). Ecco le 10 cose orribili viste in politica dal 2013 a oggi.
1 – Sarà banale, sarà diventato ormai uno stereotipo, ma servirà un po’ di tempo prima di riuscire a comprendere il significato politico e metapolitico di un personaggio come Laura Boldrini. Raramente un simile concentrato di spirito anti-italiano era riuscito a insediarsi in una posizione istituzionale di simile prestigio. Ora la Laurona (anti)nazionale ha annunciato che farà politica con “Liberi e uguali”: peggio per loro. Gli italiani, dal canto loro, sperano solo di dimenticarsene.
2 - Letta, Renzi, Gentiloni: una legislatura, tre governi, nessun mandato popolare. D’accordo, d’accordo, l’Italia non è una repubblica presidenziale, i semicolti ce l’hanno spiegato in continuazione. Ma va ricordato come il Porcellum, legge elettorale con cui è stato eletto il parlamento appena sciolto, prevedesse l’indicazione obbligatoria del “capo della coalizione”, che per il centrosinistra era Pier Luigi Bersani, uscito vincitore da primarie che, nel linguaggio corrente e nella percezione comune, servivano proprio a designare il candidato premier. Chi tiene tanto alla letteralità costituzionale dovrebbe avere il coraggio oggi di andare in campagna elettorale dicendo che non propone alcun candidato premier e che sarà il Parlamento a decidere, come accadeva nella prima repubblica. Che è passata da un pezzo, anche se i semicolti non se ne sono accorti.
3 – I pasdaran della Costituzione ricordano anche che nella Carta è espressamente vietato il mandato imperativo: una volta eletto, il parlamentare rappresenta la nazione intera e non una parte, quindi può fare ciò che vuole. Bene, ma senza esagerare. La legislatura appena finita ha visto infatti il record dei cambi casacca (546) e il record di voltagabbana (345). Una transumanza continua, al ritmo di 9,5 al mese. Alla Camera un deputato su tre ha cambiato gruppo. Al Senato quasi uno su due.
4 – La XVII legislatura è stata anche quella dei renziani, questa bizzarra popolazione parlamentare composta da un terzo di berlusconismo, un terzo di banalità liberal e un terzo di legami con le banche. Maniche di camicia arrotolate e “ciaone” sparati come se piovesse, li abbiamo visti colonizzare il Pd con l’arrivismo arrogante degli homines novi, salvo poi implodere per via di un costante disastro comunicativo e politico.
5 – Peggio dei renziani, tuttavia, ci sono solo gli antirenziani di sinistra, questo concentrato di sfiga e rancore ben rappresentato dai capelli di Fassina e dalle occhiaie di Civati. Vorrebbero rappresentare la sinistra che non cede sui valori e sono finiti sul carrozzone di D’Alema, che è un po’ come voler rifondare il Partito fascista partendo da Gianfranco Fini. Su tutto ciò che conta, gli antirenziani sono come i renziani, solo che scopano un po’ meno.
6 – Tra le cose a cui non avremmo mai voluto assistere e invece abbiamo dovuto vedere ci sono sicuramente i grillini, sbarcati in Parlamento nel 2013 con una folla spropositata di eletti, si sono distinti per gaffe improbabili, italiano stentato, proposte surreali. Ideologicamente organici alla sinistra, hanno finito per farne qualcuna giusta solo perché Grillo li ha tenuti a freno e per il loro tabù sul voto in comune col Pd, che spesso li ha fatti astenere in alcuni passaggi cruciali.
7 – Tra gli incubi politici degli ultimi anni, non scordiamoci Valeria Fedeli, il primo ministro dell’istruzione della storia politica occidentale a non aver dato neanche l’esame di maturità. Un esempio di protervia e arroganza del potere, che pretende di poter mettere chiunque dovunque, a prescindere non solo dai meriti, ma anche dalla decenza. Una nomina esclusivamente ideologica, che se fosse venuta da destra avrebbe scomodato fior di editorialisti per spiegare le ragioni dell’ignoranza congenita in quella parte politica e che invece è stata accolta con vergognosa accondiscendenza.
8 – E Cecile Kyenge? Ce la vogliamo dimenticare? Il primo ministro per esclusivi meriti epidermici, di cui nessuno aveva sentito parlare prima e nessuno ha sentito parlare dopo, tanta era la statura politica del personaggio. Una mascotte antirazzista e nulla più, una nomina che ha offeso gli italiani, ma che avrebbe dovuto offendere anche gli immigrati, che di sicuro avranno esponenti più preparati e presentabili da proporre, se proprio di questa proposta si avverte il bisogno.
9 – In questi cinque anni abbiamo visto anche la staffetta al Quirinale: via Giorgio Napolitano, su cui ogni parola sarebbe superflua, dentro Sergio Mattarella. Ovvero, il nulla. Un presidente il cui grigiore ben rappresenta il Parlamento che lo ha eletto.
10 – La legislatura appena finita è stata anche quella che ha visto Silvio Berlusconi, eletto senatore nel 2013, decadere da parlamentare in seguito alla condanna definitiva nel processo Mediaset. Ovviamente il leader di Forza Italia non è certo scomparso dalla politica, ma ha continuato a essere presente a esclusiva tutela dei propri interessi. In quest’ottica vanno visti tanto il patto del Nazareno quanto la sua funzione di “tappo” a ogni autentica tentazione sovranista nel centrodestra italiano. Un finale di carriera politica da pompiere e da inciucista, per un politico che nel bene o nel male aveva voluto invece essere un uomo di rottura. Ce lo saremmo risparmiati volentieri. Adriano Scianca
Questa è la peggior legislatura di sempre? Non avete ancora visto la prossima. Nel 2013 c’erano tre poli, ora ce ne sono cinque. Non c’era una legge elettorale, non ci sarà nemmeno ora. Almeno però Renzi aveva una strategia, allora, ora non c’è nemmeno quella. Il peggio deve ancora venire? Probabilmente sì, scrive Francesco Cancellato su “L’Inkiesta" 12 Maggio 2017. Se vi piacciono le metafore calcistiche, questa legislatura sembra il campionato del Milan o dell’Inter. Iniziata sotto pessimi auspici, proseguita con sorprendenti refoli di speranza - nonostante lo scarso materiale tecnico - grazie alle doti di un bravo timoniere, terminata peggio di com’era iniziata, tra continue sconfitte, scandali e senza alcuna apparente prospettiva che domani possa in qualche modo andare meglio. Perché, bisogna dirlo, finisce peggio di com’era iniziato, il diciassettesimo giro di giostra della politica italiana. C’eravamo svegliati con tre poli, all’indomani delle elezioni del 24 e 25 febbraio e oggi ne abbiamo cinque, con la destra spaccata in due tronconi equipollenti, la sinistra lacerata dalla faida tra renziani e anti-renziani e il Movimento Cinque Stelle che aspetta sulla riva del fiume, sgranocchiando popcorn. Non avevamo una legge elettorale, all’indomani del pronunciamento della Consulta del 4 dicembre 2013 che aveva dichiarato incostituzionale il Porcellum. Non siamo riuscita a darcene una nuova, tre anni esatti dopo, bocciando la riforma costituzionale su cui poggiava l’Italicum, comunque incostituzionale pure quello. Difficilmente riusciremo a darcene una prima che scada il tempo - sia essa il Mattarellum annacquato, il Tedesco corretto, l'Italicum consultellato - poiché a nessuna forza politica conviene. Renzi vuole mostrare al mondo che senza di lui è il diluvio, i Cinque Stelle che la politica fallisce un’altra volta, mentre a Berlusconi e ai piccoli partiti servono proporzionale, capilista bloccati, sbarramenti più bassi possibili e premi di maggioranza impossibili da raggiungere, per evitare la tentazione del voto utile e continuare a contare qualcosa. Perché, bisogna dirlo, finisce peggio di com’era iniziato, il diciassettesimo giro di giostra della politica italiana. C’eravamo svegliati con tre poli, all’indomani delle elezioni del 24 e 25 febbraio e oggi ne abbiamo cinque, con la destra spaccata in due tronconi equipollenti, la sinistra lacerata dalla faida tra renziani e anti-renziani e il Movimento Cinque Stelle che aspetta sulla riva del fiume, sgranocchiando popcorn. In questo marasma tattico, la strategia va a farsi benedire. Allo stato attuale sappiamo solo che Matteo Renzi, rieletto segretario, sarà il candidato premier del Partito Democratico, ma non sappiamo cosa voglia fare, visto che ha passato gli ultimi mesi a cercare di sopravvivere, più che a immaginare il futuro. Prova ne è una sintesi congressuale di tre parole - lavoro, casa, mamma - che nemmeno nei peggiori incubi di chi lo sostenne nel 2012, quando ancora si parlava di Europa, di merito e di futuro. Sintesi che peraltro è stata travolta dall’ennesimo scandalo bancario, vera e propria croce del renzismo, almeno in questa sua prima era. Il resto è commedia dell’assurdo: nella Lega si è aperta la frattura, da tempo sotto la cenere, tra nordisti e nazionalisti, coi primi - guidati dal governatore lombardo Maroni - che promuovono i referendum per l’autonomia di Lombardia e Veneto, per costruire l’Europa delle Regioni e i secondi che vogliono l’Italia fuori dall’Euro. Poco più in là, Berlusconi aspetta la sentenza della Corte Europea di Strasburgo che dovrebbe riabilitarlo e traccheggia, incerto e malandato, alla guida di un partito in bancarotta. A sinistra non si capisce nemmeno chi stia con chi, figurarsi se esiste un programma o un leader. Ciò che sarà dei Cinque Stelle, in spregio alla democrazia diretta, è ancora nella testa di Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Qualunque esito daranno le urne, in ogni caso, non sarà possibile governare. In un contesto tripolare lo sarebbe stato, forse. Se non altro perché il centrodestra a trazione berlusconiana e il centrosinistra a trazione Renzi non sono due entità inconciliabili. La mela è divisa in cinque, però: nessuna accoppiata è in grado di ricomporla per metà. E nessuna alleanza a tre è realisticamente possibile. Il tutto, proprio mentre il Quantitative Easing arriva alle ultime curve, mentre l’Europa sembra avere ripreso la sua marcia verso un percorso di ricostruzione, mentre una nuova rivoluzione tecnologica alle porte. Che sì, la diciassettesima legislatura è stata un disastro. Ma solo perché non abbiamo ancora visto la diciottesima.
La politica italiana? Tutta chiacchiere e distintivo…Stemmi, coccarde pins, badge, spillette, l’irresistibile fascino dei simboli: dai fasci littori, alle falci e martello, dal tricolore di Forza Italia, allo spadone di Alberto da Giussano. E intanto spuntano le stelle dei nuovi sceriffi, scrive Fulvio Abbate l'1 luglio 2018 su "Il Dubbio. Implacabili, i distintivi, sono riapparsi nelle asole delle giacche di alcuni compunti politici. Segnatamente leghisti o anche membri di Forza Italia, Berlusconi a fare da esempio. A proposito di quest’ultimo, forse, rammenterete l’esemplare che, magico, luccicava a favore di telecamera durante un suo messaggio registrato alla Nazione, al «Paese che amo», forse il distintivo più ipnotico degli ultimi decenni, Silvio come Mandrake. Personalmente, perdonate la presunzione, conosco l’argomento, anzi, è il collezionista di questo genere di accessori politici che riflette ad alta voce, consapevole del valore simbolico da dare a questa noticina che fa proprio caso al ritorno trionfale del distintivo da occhiello: segno, appunto, identitario, di appartenenza, supplemento di orgoglio e talvolta perfino di velata minaccia. Nella storia nazionale, il periodo che più ha dato fulgore ai distintivi, lo si sappia, combacia con il “ventennio”. Durante il fascismo, non c’era infatti organizzazione legata più o meno formalmente al regime che non ne mostrasse almeno uno, ufficiale, a corredo ulteriore dell’abbigliamento, iniziando dalla proverbiale “cimice” del PNF, il Partito Nazionale Fascista. Così continuando con la ginnica GIL ( Gioventù Italiana del Littorio), la ricreativa OND ( Opera Nazionale Dopolavoro), la fanciullesca ONB ( Opera nazionale Balilla), compreso perfino ogni singolo evento civico, sportivo o di semplice beneficenza, Littoriale, inaugurazione di Fiera campionaria o Giornata delle Due Croci, cioè campagna antitubercolare, distintivi sempre lì, ora con fascio tradizionale o talvolta stilizzato con modalità perfino cubo- futurista, opportunamente bene in pubblica vista tra tukul, elmetti, pugnali, teschi e gladio, obelischi di Axum, Arco dei Fileni, ecc…Con l’avvento della Repubblica e delle conseguenti istituzioni democratiche, le ditte produttrici – Lorioli e Johnson, in testa hanno comunque, almeno inizialmente, resistito; nell’immediato secondo dopoguerra ogni partito risorto dalla clandestinità ne forniva ai propri tesserati o semplici simpatizzanti, così la falce e martello dei comunisti di Togliatti, idem i socialisti di Nenni con incluso libro e sole dell’avvenire, i liberali, i repubblicani con l’Edera, fino al “torchietto” del Fronte dell’Uomo qualunque di Guglielmo Giannini, ufficioso progenitore dei 5 stelle di Grillo, con l’omino schiacciato dalla burocrazia statale ‘ infame”… Senza dimenticare lo Scudocrociato di De Gasperi e Scelba. Tornando al fascismo, durante i giorni delle “sanzioni”, 1935, si riuscì perfino a coniarne un modello che innalzava una frase- monito del giornalista Mario Appellius: «Dio stramaledica gli inglesi». E ancora, in ambito assai più prosaico, altri, temendo l’introduzione di una multa per gli scapoli, soprattutto in tempo di campa-gna demografica, ne realizzarono una serie sul cui smalto figurava: “Meglio la tassa che la suocera”. Restando in tema, aggiungo ancora che le madri prolifiche ottenevano addirittura una decorazione con fiocchi di alluminio apposti sul nastrino a indicare il numero di figli “generosamente offerti alla Patria” così come l’oro delle vere nuziali. Intendiamoci, anche i paesi del socialismo reale, cominciando dall’Urss, non si sono mai fatti mancare nulla in quest’ambito propagandistico, e forse, cosmonauti a parte, l’acme della produzione risale al 1970, centenario della nascita di Lenin. Culturalmente ragionando, il distintivo serve a mostrare appartenenza, un’orgogliosa indicazione del proprio status politico: noi siamo questo, chiaro? Dimenticavo, nei giorni del Littorio il distintivo era comunque un obbligo, sono giunte fino a noi fotografie dove perfino Luigi Pirandello mostra la “cimice” sull’abito antracite. Si racconta ancora che il giorno stesso della Liberazione molti cittadini se ne disfecero nei tombini, lo sanno bene gli addetti alla pulitura di questi, periodicamente svuotando le fogne, ancora adesso, c’è modo di rinvenire pezzi, compresi quelli dell’Asse Roma-Tokio- Berlino, della Milizia o perfino i teschi delle Brigate nere o dei “Moschettieri del Duce” (sic). Se nel caso della bandiera di Forza Italia di Berlusconi, stesso stilema iconico del trascorso simbolo del Partito comunista italiano, il distintivo corrisponde a un segno, non sembri un bisticcio di parole, di distinzione “borghese”, come nel caso di coloro che appartengono alle organizzazioni para- massoniche quali Rotary e Lions, l’esempio dei leghisti suona quasi come segno di riconoscimento militare, razziale, superiore, di una superiorità tuttavia regionale, circoscrizionale, da ronda di quartiere, da alto portierato, guardiania, quasi che Salvini ne abbia raccomandato implicitamente, perfino a dispetto del ruolo istituzionale, l’uso quotidiano a tutti i suoi, Alberto da Giussano a campeggiare come un Belfagor, spadone ammonitore. Non c’è leghista maschio che partecipi a talkshow che non lo mostri; estremizzando, torna il ricordo dei deputati nazisti sugli scranni del Reichstag tutti rigorosamente in divisa.
È vero, e lo sappiamo, sempre ragionando di distintivi, e ancora di “pins” e di “spillette” come succedanei nel tempo, si può fare altrettanto ritorno al Club di Topolino con i suoi “ispettori” o “governatori generali” a due o tre stellette, o magari alla “girandola” del Club del Corriere dei Piccoli e perfino alla “G” di “Giovani”, il rotocalco beat della fine degli anni Sessanta celebre per i suoi “manifesti”, e tuttavia, nonostante queste altre piccole gemme inoffensive della nostra memoria bambina, ciò che infine resta, sembra raccontare invece una sorta di militarizzazione civile, roba angusta e piccina per un Paese che volesse prendere il volo definitivo dalla subcultura rionale del «… lei non sa chi sono io!». Chiacchiere e distintivo, diceva quell’altro, quasi a ventilare il passo successivo al segno intimidatorio corrispondente alla vista della stella di sceriffo, una parola ancora ed ecco sbucare anche il furgone- cellulare sia della squadra politica sia della “buon costume”. Per non parlare dei contrassegni di riconoscimento che i nazisti formalizzarono ora per gli ebrei ora per i politici ora per gli “antisociali”, e non occorre una laurea in semiologia per capire il nostro semplice ragionamento, o forse, sì, assodato il disprezzo per la complessità culturale che certi signori al governo oggi mostrano come ennesima patente di orgoglio piccolo- borghese.
La maledizione dei presidenti della Camera. Da Casini a Fico, passando per Bertinotti, Fini e la Boldrini. A partire dai primi anni 2000 tutti i presidenti della Camera non hanno mai svolto il proprio ruolo in modo imparziale ma hanno sempre deciso le sorti del governo, scrive Francesco Curridori, Lunedì 02/07/2018, su "Il Giornale". Da Casini a Fico, passando per Bertinotti, Fini e la Boldrini. La chiamano “la maledizione dei Presidenti” e, a partire dai primi anni 2000, ha colpito tutti gli inquilini di Palazzo Montecitorio. La terza carica dello Stato, dalla Seconda Repubblica in poi, fatta eccezione per Luciano Violante, è stata destinata al leader di uno dei partiti minori che componevano la maggioranza di governo. Il Presidente della Camera, poi, è un ruolo istituzionale e chi lo ricopre, solitamente abbandona gli incarichi di partito per assumere, appunto, un aplomb istituzionale, al di sopra delle parti. Ed è così, nel 2001, dopo la vittoria del centrodestra che riporta Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, Pier Ferdinando Casini lascia la guida del suo partito per accasarsi a Montecitorio. Marco Follini diventa prima segretario dell’Udc e, poi, dal 2004 vicepremier. Da quel momento Casini e Follini giocheranno in tandem per “puntellare”, o meglio martellare il governo. "L'Udc sta facendo molti errori. Casini? Non sa dove andare, si trova in mezzo al guado", dirà Berlusconi sempre più infastidito dai continui distinguo dell’allora presidente della Camera. Si arriva alle Regionali del 2005 che decretano una sconfitta per Berlusconi che viene costretto a dar vita a un nuovo esecutivo. Follini ne resta fuori per dedicarsi al partito e nel 2005 si dimette da segretario e di lì a poco passa col centrosinistra. Casini, qualche anno dopo, seguirà la sua stessa strada e la carriera politica di entrambi ne risentirà in maniera decisiva. Fare i “grilli parlanti” della propria maggioranza di governo, non paga. Lo sa bene Fausto Bertinotti che diventa presidente della Camera grazie al 5,8% ottenuto da Rifondazione Comunista alle Politiche del 2006. A distanza di 10 anni, la sinistra litiga ancora su chi sia il responsabile della caduta del secondo governo Prodi: se Clemente Mastella che gli tolse la fiducia o, pur usare le parole del ‘Professore’, “chi ha minato continuamente l'azione del governo, di chi ha fatto certe dichiarazioni istituzionalmente opinabili...”, ossia Bertinotti che lo aveva paragonato al “più grande poeta morente”. Non solo. L’allora presidente della Camera aveva definito il suo governo “un brodino caldo”. Espressione che gli si rivolterà contro dopo il voto delle Politiche del 2008, quando la sinistra radicale, per la prima volta, non entra in Parlamento. Prodi si vendicherà dicendo: “A Bertinotti consiglio di rinfrancarsi con un brodino riscaldato”. Una sorte migliore non è certo toccata a Gianfranco Fini che, dopo aver cavalcato l’onda del giustizialismo e aver fatto cadere il quarto governo Berlusconi nel 2011, è finito egli stesso nel tritacarne dei processi per colpa della famosa ‘casa di Montecarlo’. Resterà indelebile nella memoria della cronaca politica la direzione del Pdl dell’aprile 2010 in cui Fini viene ripudiato come presidente della Camera e come alleato di governo. “Se vuole fare delle dichiarazioni politiche, prima si dimetta dalla presidenza della Camera", sentenzierà Berlusconi. Una frase a cui Fini replicherà con l’ormai notissimo: “Che fai? Mi cacci?”. Il resto è storia. Una storia che si conclude con una cifra che sarà la pietra tombale su Fini come uomo politico: quello 0,4% ottenuto da Fli alle Politiche del 2013. È certamente prematuro ipotizzare che Roberto Fico diventi l’ispiratore/promotore della caduta del governo "gialloverde" e tantomeno che abbia in mente di fondare un partito tutto suo ma i continui distinguo in materia di immigrazione sembrano il remake di un film già visto. Ora non ci è dato sapere nemmeno se questo film sia la "riedizione" di quelli appena descritti oppure se Fico aspiri semplicemente a diventare il ‘paladino dei migranti’ così come lo è stata Laura Boldrini nella passata legislatura. Solo il tempo saprà dare risposta a questi quesiti ma il futuro si preannuncia timidamente burrascoso per il governo Conte.
T-shirt e pugno chiuso: Fico ormai è il leader dell'estrema sinistra. Dal look informale a Pozzallo ai gesti ideologici Così il grillino si smarca da Salvini e Di Maio, scrive Stefano Zurlo, Lunedì 02/07/2018, su "Il Giornale". Una maglietta che viene da lontano. Dagli anni Settanta, dalla cultura antagonista dei movimenti a sinistra del Pci, dalla rottura del protocollo, strappato dai leader di quei movimenti. Il presidente della Camera Roberto Fico in visita all'hotspot di Pozzallo ha esibito quel look ultrainformale, completato con un inelegante gilet da simil-pescatore, e cosi, forse senza nemmeno volerlo, ha messo in chiaro il proprio albero genealogico. Quella maglietta è a modo suo un'icona, come lo è il pugno chiuso, in occasione della parata del 2 giugno, e come lo sono le mani in tasca, mentre veniva intonato l'inno di Mameli, sottile momento di disagio se non di contestazione di un'idea patriottica di Paese che non gli appartiene. Sì, si può dire che Fico sia figlio di quella linea minoritaria ma mai debole che ha sempre riempito le piazze e fatto flop nelle urne: quella dell'ultrasinistra o sinistra radicale che dir si voglia. Naturalmente aggiornata ai tempi di oggi: la sua barba ricorda quelle guerrigliere e operaie di tanti protagonisti della nostra storia recente, dall'immancabile Che a Lula, e la sua formazione ha rimandi semantici sorprendenti a una gauche ora vintage ma cui fino a ieri eravamo abituati. Ecco che la sua tesi di laurea ha un titolo che sembra una scheggia di quel mondo pensoso e strutturato che si è sfaldato da ultimo insieme al suo popolo: «Identità sociale e linguistica della musica neomelodica napoletana». E già ti pare di leggere uno di quei saggi con mal di testa incorporato che tenevano insieme le categorie economiche e gli ideali della solidarietà. Ma Fico, classe 1974, è troppo giovane per essere letto con i sacri crismi di quella stagione. E la sua biografia è un'immersione nella società liquida, frammentata e spezzettata di oggi che ha perso per strada gli operai, le sezioni del Pci e pure le pulsioni di quell'area un tempo scoppiettante e oggi sbiadita nelle facce anonime di Pietro Grasso e dintorni. Dunque, Fico ha recitato più parti in commedia: impiegato in un call center, manager in un hotel, importatore di tessuti dal Marocco, con in più la versatilità e l'inquietudine che sono nel suo Dna napoletano. Poi nel 2005 la fondazione di uno dei primi meetup e l'adesione al verbo grillino, incrociando i temi della giustizia sociale, della difesa dell'ambiente, vedi il referendum sull'acqua nel 2011, e l'eterno ribollire del Sud. Che a Napoli ha avuto un interprete istrionico come Luigi de Magistris, ultima variante del tribuno alla Masaniello. Spinte. Controspinte. Sussulti. E la scoperta che questo ragazzo descamisado, che va a Montecitorio prendendo l'autobus di linea della disastrata Atac, è l'ultimo leader di una sinistra altrimenti irrimediabilmente evaporata. I dissidi con il pragmatico e carrierista Di Maio e la decisione di non salire sul palco di Rimini. L'orgoglio di un'appartenenza, ribadita con parole definitive: «Non saremo mai la Lega del Sud». Ora quella frase eretica in un'Italia sempre più al passo marziale di Salvini: «Io i porti li aprirei». Forse una citazione vintage o forse una consacrazione in un Paese in cui anche il pensiero è sempre più flat.
Ecco il «giglio rosso» grillino che sussurra le leggi a Di Maio. Dall'ex assessore di Vendola al comunista Alleva, chi sono gli esperti di sinistra che affiancano il ministro, scrive Lodovica Bulian, Domenica 1/07/2018 su "Il Giornale". Sembrava una priorità della sinistra. Oggi invece la stretta sui contratti a termine è diventata uno dei punti forti del cosiddetto decreto dignità che Luigi Di Maio promette di portare in consiglio dei ministri domani, al massimo martedì. Resteranno fuori invece voucher e contratti di somministrazione, rinviati al «dibattito in Parlamento». «Il tema della somministrazione - ha chiarito ieri Di Maio - in molti casi si presta a delle disfunzioni però dev'essere oggetto del dibattito parlamentare, non si può intervenire con un decreto. Come per i voucher». Intanto però la lista degli annunci di Di Maio mira a compensare la linea «a destra» dettata dal suo alleato al Viminale. Va ricordato infatti che la scure sui contratti a tempo determinato da un massimo di 5 a 4 rinnovi, che tanto ha fatto infuriare le imprese in questi giorni, era anche una condizione richiesta dagli arancioni di Giuliano Pisapia per convergere col Pd alla vigilia delle ultime elezioni. Quel provvedimento che allora non ci fu facendo saltare l'intesa, rientra oggi dalla porta principale di Palazzo Chigi sotto il vessillo pentastellato. Ma la direzione imboccata nel tentativo di coprire le voragini di consenso lasciate sul terreno dai democratici, non stupisce se si guarda a chi circonda il ministro grillino nei due dicasteri del Lavoro e dello Sviluppo economico. Il giglio di «consulenti» a titolo gratuito scelti dal vicepremier è composto da personalità provenienti dall'area rossa ed ex comunista. Ne fanno parte Piergiovanni Alleva, 71 anni, giuslavorista, una gioventù in Lotta continua, un passato nella consulta giuridica della Cgil, un presente da consigliere regionale in Emilia Romagna con la lista «L'altra Europa con Tsipras», e da membro del comitato del Partito Comunista italiano. Nel 2013 anche candidato al Senato con Rivoluzione civile dell'ex pm Antonio Ingroia. Già ordinario di diritto del lavoro a Bologna, Alleva è il teorico del «lavorare meno, lavorare tutti». Nella cerchia dei «consulenti» gratuiti c'è anche Pasquale Tridico, il già candidato ministro dei Cinque Stelle, quello che ora avrebbe dovuto occupare il posto di Di Maio. «Da uomo di sinistra dico che questa alleanza è un problema»: così dopo aver rinunciato a incarichi per manifesta distanza rispetto alle intese con la Lega, Tridico, professore di economia del lavoro a Roma Tre, ha comunque accettato di aiutare il vicepremier. «È necessario recuperare i diritti e la dignità del lavoro - sosteneva da candidato - reintrodurre l'articolo 18, eliminare il Jobs Act, contrastare la liberalizzazione dei contratti a termine». Proprio il punto del decreto dignità. Infine tra i contatti di Di Maio ci sarebbe anche Marco Barbieri, dirigente di Leu, dal 2005 al 2009 assessore regionale al Lavoro in Puglia nella giunta di Nichi Vendola, e oggi ordinario di diritto del Lavoro all'Università di Foggia. All'indomani delle elezioni del 4 marzo, ammettendo l'irrilevanza della formazione politica fondata da Grasso, dei pentastellati diceva che «promettono in forma vaga ed ondivaga alcune cose che noi caldamente vorremmo. Dobbiamo avere un atteggiamento costruttivo nei loro confronti, di incoraggiamento delle misure giuste». Su Facebook qualcuno gli fa i complimenti per il «nuovo incarico», ma lui precisa di non avere alcuna consulenza ufficiale: «Non c'è nessun incarico». Allora qualcun altro gli fa una battuta sul lavoro a titolo gratuito. Il prof risponde con uno smile.
SCONTRO DI INCIVILTÀ. «Crepa, bastardo!»: quando a incitare all'odio sono politici e giornalisti. Auspici di morte, irrisioni e ingiurie sessuali. Dalla "patata bollente" della Raggi agli insulti antisemiti a Fiano, passando per tweet e prime pagine scandalose: non c'è solo il web a fomentare rancore e violenza, scrive Susanna Turco il 26 dicembre 2017 su "L'Espresso". Testate, aggressioni, insulti, finte decapitazioni, bavagli e fotomontaggi. Violenze, non solo verbali. E meno remore. Pillole incivili dall’Italia che ci avviluppa, con l’orizzonte aspro della campagna elettorale. Antologia di piccoli orrori in crescendo: eccoli.
TESTE. «Le sopracciglia le porta così per coprire i segni della circoncisione». Lo scrive su Facebook a luglio il deputato di Direzione Italia Massimo Corsaro, sopra una foto del dem Emanuele Fiano, firmatario e relatore del ddl sull’apologia del fascismo. Sommerso di critiche, si difende così: «Nessuna volontà di antisemitismo, ho piuttosto inteso dargli del testa di cazzo».
MALARIA. «Morire di malaria non è normale. La infezione viene da lontano, dall’Africa nera. Basta accoglienza». (Tweet di Vittorio Feltri).
BAVAGLI. «Incredibile. Questa è vera violenza. Non mi fanno paura, mi danno ancora più forza: andiamo a governare!». Così il segretario della Lega Matteo Salvini, dopo aver postato una foto che lo ritraeva imbavagliato, alla Moro, davanti al simbolo delle Brigate rosse con il commento «ho un sogno». La minaccia era stata pubblicata sulla pagina facebook “Vento ribelle”: gruppo seguito da 113 mila persone che si definisce antifascista, antirazzista, anticapitalista, antimilitarista, anticolonialista e anti imperialista, il cui sottotitolo è: «Disprezzo assoluto al sistema e al suo governo, né omertà né padroni su questa terra». Tra i membri, un Davide Codenotti che espone nel suo profilo il simbolo del Movimento 5 Stelle. Il giorno dopo, come “provocazione” per la scarsa solidarietà offerta a Salvini, il Tempo pubblica lo stesso fotomontaggio ma con la presidente della Camera Laura Boldrini al posto di Salvini. Vittorio Feltri si complimenta caldamente col direttore Gian Marco Chiocci per l’iniziativa.
FACCE. «Non abbiamo paura di sparire, noi! Ma di avere un parlamento con le solite facce di cazzo!» (il senatore Sergio Puglia, segretario di gruppo dei M5S, in Aula al Senato).
MAIALI. In estate la pagina Facebook Club Luigi Di Maio pubblica una foto di Emanuele Fiano accanto all’immagine di un suino. Di Maio si dissocia subito. Dei 72 mila del club, scrive la Stampa, fa parte almeno un suo amico di sempre: Dario De Falco, già compagno di liceo e di università, oggi nel comitato elettorale ristretto che si occuperà di raccogliere i fondi per la corsa dei Cinque stelle verso le politiche.
ASSASSINI. «Il treno di Renzi non ha ucciso nessuno perché Renzi non ha un treno. La macchina di Grillo invece una famiglia l’ha davvero sterminata». Così recita una card postata dalla pagina facebook Per Matteo Renzi insieme, pro-Pd ma (come per i Cinque stelle) non ufficialmente collegata alla comunicazione dem. Il riferimento è all’incidente che a fine novembre aveva coinvolto una quarantatreenne di Civita Castellana, investita dal treno noleggiato per la campagna elettorale di Renzi, contrapposto all’incidente stradale per il quale il fondatore del M5S è stato condannato per omicidio colposo in Cassazione.
VOLONTÀ PORCA. «Criminali dalla volontà porca, direi genetica, figli del Porcellum. Vi riproducete con le porcate, fate ammucchiate elettorali per grufolare voti. Ma se vi ripugna il parallelo, torno a chiamarvi cri-mi-na-li» (il senatore M5S Sergio Endrizzi, in aula al senato).
VIVI. «Rosato facciamo un patto, se questa legge sarà cassata dalla Consulta, noi ti bruceremo vivo, ok?». (Tweet contro il Pd, Ettore Rosato, scritto da Angelo Parisi, M5S).
DECAPITATI. A settembre, Torino, i manifestanti anti G7 decapitano due fantocci: uno col volto di Matteo Renzi, l’altro con quello del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Sempre a Torino, ma a maggio, durante la Cannabis Parade, si esibiscono manichini di poliziotti investiti da un furgone. A Rho, fine ottobre, il fantoccio del ministro dell’Interno Marco Minniti, in giacca e cravatta, gli abiti riempiti come quelli di uno spaventapasseri, sul volto la sua foto, e quello del leader della Lega Matteo Salvini, in felpa verde e pantaloni di una tuta, vengono trovati davanti le sedi di Pd e Lega accanto a un cartello firmato “Brigate moleste”. Accanto al fantoccio del titolare del Viminale la scritta in stampatello «Minniti fascista- Fate leggi contro il fascismo, ma avete il Duce come ministro degli interni».
CAPOCCIATE. In piena campagna elettorale a Ostia Roberto Spada, incensurato dell’omonimo clan, in favore di telecamera spacca con una testata il setto nasale al giornalista di Nemo Davide Piervincenzi.
Daniele Piervincenzi, inviato del programma di Rai2 Nemo, è stato colpito al volto con una violenta testata da Roberto Spada, titolare di una palestra e fratello del boss Carmine, condannato a 10 anni di carcere. Piervincenzi, che stava incalzando Spada sul suo "endorsement" per il candidato di Casapound Luca Marsella, ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato sottoposto a un intervento d'urgenza. Durante l'aggressione, Spada ha utilizzato anche una mazza con la quale ha colpito anche l'operatore della troupe. Sul suo profilo Facebook, Spada ha poi riportato la sua versione dei fattiVideo da Nemo - Rai2.
VOMITARE. «Questo è sequestro di persona, io vi mangerei soltanto per il gusto di vomitarvi, voi siete i principi del pettegolezzo, quindi non mi coinvolgerete più». Lo afferma, uscendo dall’hotel Forum, Beppe Grillo rivolgendosi ai cronisti che lo attendevano. «Un minimo di vergogna voi la percepite per il mestiere di che fate, sì o no?». (Ansa 19 settembre 2017).
MATTONI. Quattro aggressioni in venti giorni per l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti e la sua troupe, nel corso di servizi sullo spaccio di droga. Il 15 novembre li avevano puntati alcuni pusher stranieri nel parco bolognese della Montagola. Quindici giorni dopo nello stesso parco nuova aggressione. Il 22 novembre, l’inviato di Striscia ed i suoi operatori erano stati aggrediti a Padova, vicino alla stazione. L’ultima, il 2 dicembre nel popolare quartiere romano di San Basilio, una delle piazze dello spaccio della Capitale: Brumotti tentava di fare interviste, un uomo incappucciato si è messo a lanciare mattoni, insulti dai palazzi adiacenti, due spari, aperta un’inchiesta.
OMINO. «Taci omino da quattro soldi, le ore son contate», «Ottimo messaggio», «muori». Sono alcuni degli insulti ricevuti via Facebook a inizio dicembre dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, colpevole di aver negato una sala del comune a Casa Pound per la presentazione del libro di un disabile. Ora è sotto scorta.
FAKE. Tra tante, due recenti. Su Facebook un utente che ha come foto profilo un simbolo pro M5S, condivide una foto che ritrae Boldrini, Boschi e altri esponenti dem a un funerale, con il commento: «Guardate chi c’era a dare l’ultimo saluto a Totò Riina». Mille condivisioni in poche ore, per una cosa mai avvenuta. Il funerale in realtà era quello di Emmanuel, il nigeriano massacrato di botte a Fermo un anno e mezzo fa, per aver provato a difendere la moglie dai razzisti. L’altra: il 29 ottobre la pagina Facebook “Fiamma Nazionale” condivide una vecchia bufala pubblicata nel 2016 nel sito Adessobasta.org, secondo la quale Cecile Kyenge avrebbe detto no ai mercatini di natale, offendono le altre religioni. Il commento più leggero: «Vattene a casa tua».
PIAZZA FORCONA. Alessandro Di Battista sommerso di fischi e insulti dopo essersi presentato a piazza Montecitorio per arringare una piazza che credeva grillina, e invece era dei forconi: «Vattene via, servo di Goldman Sachs», l’offesa più bruciante. Il giorno appresso Vittorio Di Battista, Dibba padre, ha tentato di picchiare il generale dei forconi Antonio Pappalardo: schiaffo mancato. Alessandro Di Battista, convinto di rivolgersi ai militanti pentastellati che protestano in piazza Montecitorio dalla mattina, arringa la folla che manifesta davanti alla Camera. Invece dei sostenitori del Movimento 5 stelle, però, si trova davanti i simpatizzanti del Movimento di Liberazione Italia guidato dall'ex generale Antonio Pappalardo. Di Battista viene accolto con fischi e contestazioni. I seguaci di Pappalardo infatti considerano le posizioni del M5s troppo morbide. Per loro tutti i parlamentari sono abusivi a seguito della sentenza che ha dichiarato incostituzionale il Porcellum che ha portato alla loro elezione.
PIAZZA DIVISA. Dieci dicembre, piazza Santi Apostoli, due manifestazioni in contemporanea. Da un lato il popolo della Lega contro lo Ius soli davanti alla Basilica, dove da quattro mesi vivono accampate nell’atrio 60 famiglie sgomberate a Cinecittà. Dall’altro lato i movimenti per il diritto alla casa e i migranti manifestano (non autorizzati) a sostegno degli sfollati e contro la Lega: «Salvini Roma non ti vuole» e «Odio la lega», tra gli slogan. In mezzo, un blindato della polizia.
ORTICA. Cavalcavia Buccari, al quartiere Ortica, dove studenti, abitanti e gli artisti di zona avevano scritto a grandi lettere: “Bella Ciao Milano”, per festeggiare i 70 anni della resistenza. In una notte di dicembre, qualcuno ha cambiato il murale in un inno fascista: «Duce a noi».
PATATE. Alcuni titoli recenti da Libero, che ne ha fatto un genere. «Dopo la miseria portano le malattie»; «Bastardi islamici», all’indomani delle stragi di Parigi; «Italia 1 - Germania 0», dopo l’uccisione dell’attentatore tunisino al mercatino di Natale di Berlino. Per il filone donne, dopo «Veronica Velina ingrata», «La patata bollente, vita agrodolce della Raggi». «Provocazione per l’otto marzo. Più patate, meno mimose»; «Dal burqua alla museruola».
BANDIERE. In mezzo a tante fake news autentiche, l’esposizione alla caserma Baldissera di Firenze della bandiera del secondo Reich e il tentativo di farla passare come una gaffe storica o addirittura una bufala. La ministra della Difesa, Roberta Pinotti: “Ho condannato con nettezza l’esposizione della bandiera neonazista, da quel momento sono stata ricoperta da insulti e minacce di ogni tipo da parte di chi vorrebbe far credere che in realtà quella bandiera sia semplicemente una vessillo della Marina imperiale tedesca”.
TERRORISTI. “Dovremmo smetterla di considerare il terrorista un soggetto disumano con il quale nemmeno intavolare una discussione” (Alessandro di Battista, sul blog di Grillo, 2014).
STUPRI. «Confessione. Ho fatto fatica a scopare quelle che la davano volentieri, come potrei stuprare una che non ci sta? Superiore alle mie forze» (tweet di Vittorio Feltri per sminuire la campagna #metoo. Ottiene subito 175 retweet e 773 “mi piace”).
VIOLENZE. «Quando una prima acconsente e poi se ne pente, toglie credibilità alle storie delle donne che veramente vengono violentate» (Vladimir Luxuria a Carta Bianca, per sminuire la denuncia delle molestie subite da Asia Argento da parte di Weinstein).
ARRESTIAMOLI TUTTI. «Questi parlamentari, usurpatori di potere politico li arresteremo noi, perché noi siamo dalla parte della legge. Questi sono golpisti, gentaglia, delinquenti che stanno rubando i soldi del nostro paese e stanno affamando il popolo italiano». Il generale dei Forconi Antonio Pappalardo, capo del Movimento per la liberazione dell’Italia, nel videomessaggio sul proprio sito.
LA REPUBBLICA DEGLI INSULTI.
Insultario della Terza Repubblica. Gli scambi proibiti tra alleati e politici, scrive Alessandro Gnocchi, Venerdì 29/06/2018, su "Il Giornale". L'economia sarà un po' ferma, ai Mondiali non partecipiamo, però tutto sommato c'è un settore che non smette mai di produrre perle: quello degli insulti politici. Ecco quindi un piccolo «insultario», dalle baruffe della Terza Repubblica. Senza pretese di completezza, con qualche licenza cronologica e ricordando l'insuperabile Insultario pubblico di Claudio Quarantotto.
EICHMANN «Salvini è l'Eichmann italiano» (Furio Colombo).
HITLER «Berlusconi come Mubarak e Gheddafi? No, intellettualmente parlando il paragone potrebbe essere fatto con Hitler: anche lui giunse al potere con libere elezioni» (Umberto Eco).
IGNORANZA «Di Maio è di una pochezza e d'una ignoranza difficilmente eguagliabili» (Matteo Salvini).
CURRICULUM «Gli insulti di Salvini? Li metto nel curriculum» (Luigi Di Maio).
XENOFOBO «Salvini è xenofobo» (Luigi De Magistris).
RAZZISTA «Salvini è razzista, voglio andarmene dall'Italia» (Gino Strada).
SOVRANISTA «I sovranisti Trump e Salvini fanno a gara per vincere il primato della disumanità allo scopo di sviare l'opinione pubblica dalle inchieste scottanti che li riguardano» (Laura Boldrini).
PIDIOTI I seguaci del Pd secondo i Grullini.
GRULLINI I seguaci dei 5 stelle, secondo i Pidioti.
VOMITO «Vi mangio e poi vi vomito» (Beppe Grillo sui giornalisti).
VOMITEVOLE «Italia vomitevole sui migranti» (Emmanuel Macron).
POPULISTA «I populisti sono come la lebbra» (Macron). Infatti l'insulto, di moda da qualche tempo, ha infettato l'intero arco costituzionale. Matteo Salvini è un populista di destra. Matteo Renzi è un populista di sinistra. Giorgia Meloni è populista per tradizione. Silvio Berlusconi è spesso ritratto come il padre nobile del populismo italiano ma ha denunciato i rischi di una deriva populista. Beppe Grillo ha scritto sul blog di essere «fieramente populista». Poi ci ha ripensato: populisti sono tutti gli altri. E la Chiesa? Il segretario della Cei, Nunzio Galantino, ha sintetizzato così il rischio che corre l'Italia: «Combattere il populismo col populismo».
IPOCRITA «La vera lebbra è l'ipocrisia di chi respinge gli immigrati a Ventimiglia e vuole farci la morale» (Luigi Di Maio).
PIPPE «Abbiamo visto emergere un trio, il Di Battista, il Luigino Di Maio e il Fico oggi si rivelano nelle vesti proprie tre mezze pippe, dei miracolati» (Vincenzo De Luca).
VAFFA Beppe Grillo ha sdoganato l'insulto politico. Il Vaffa è stato a lungo l'unico punto del programma 5 stelle. Interminabile l'elenco degli insulti di Grillo. Bersani: «Un morto che parla», Berlusconi: «Psiconano», Brunetta: «Brunettolo», Lupi: «La figlia di Fantozzi», Monti: «Un mendicante», Prodi: «Alzheimer», Veltroni: «Topo Gigio», Napolitano: «salma», Matteo Renzi: «schiocchino», «pupazzo», «falso bambinone», «bamboccio», «l'ebetino di Firenze», «scrofa ferita», «serial killer»; il Pd in crisi: «diarrea nauseante».
CULO La minoranza Pd «fa ridere» perché «hanno leccato il culo per cinque anni al capo approvando ogni porcheria solo per avere una poltrona e ora gridano allo scandalo perché sono stati fatti fuori» (Alessandro di Battista)
CALCI «Se mai la Fornero passerà da Pontida mi auguro che la prendiate a calci nel culo per 10 chilometri» (Matteo Salvini a Pontida)
CACCA «Mafiosi, schifosi, siete delle merde, ve ne dovete andare, dovete morire» (Paola Taverna ai deputati Pd)
CESSO «I Cinque Stelle sono gente buona a nulla: a Mediaset li prenderei per pulire i cessi» (Silvio Berlusconi).
FOGNE «La destra torni nelle fogne invece di dare lezioni di democrazia» (Ignazio Marino).
SPAZZATURA «L'Alto-Adige non è una discarica di rifiuti politici» (Alessandro di Battista «allude» a Maria Elena Boschi, candidata a Bolzano)
PARANOICO «Salvini è solo un paranoico, la mia riforma non si può cambiare» (Elsa Fornero)
PREGIUDICATO Grillo è «un pregiudicato che dà ordini da un villaggio turistico alla moda sul mare africano» (Matteo Renzi).
MILIONARIO Grillo è «un milionario in pantofole che istiga all'odio» (Francesco Boccia).
CROCE ROSSA «Non vorrei più parlare di Renzi, sembro uno che spara sulla Croce Rossa» (Michele Emiliano).
POVERINA «È una poverina, mi fa pena e tenerezza. Spero sia presidente della Camera ancora per poco, verrà sommersa da 100 mila persone che protesteranno a Milano per fermare Mare Nostrum». (Matteo Salvini su Laura Boldrini)
FASCISTA «Frasi del tipo: siete dei cadaveri ambulanti, vi seppelliremo vivi e così via, sono le frasi di un linguaggio fascista, così come lo abbiamo conosciuto in Italia». (Pier Luigi Bersani sul Movimento 5 stelle)
BELLEZZA «Signora Bindi, devo dirle che mi fa piacere parlare con lei. È più bella che intelligente» (Silvio Berlusconi).
LUMACHE Gli eredi della Democrazia Cristiana sono «lumaconi bavosi e schifosi» (Umberto Bossi).
VERME «Un presidente del consiglio che usa un bambino per la sua campagna elettorale è un verme» (Matteo Salvini su Matteo Renzi)
SCIACALLO «Santoro e Vauro sono due volgari sciacalli che vomitano insulti con le tasche piene di soldi dei cittadini. Gente così alimenta odio e merita solo disprezzo» (Maurizio Gasparri).
CAPRA «Capra! Capra! Capra!» (Vittorio Sgarbi contro tutti)
CAPRETTA «Domani sarò a Laterina (il paese di Boschi, ndr) ma non la troverò lì, l'hanno spedita a Bolzano vestita da Heidi per fare ciao alle caprette» (Alessandro di Battista)
MAIALE «Maiale, vattene» (Francesco Storace a Gianfranco Fini)
QUOTE DE ROSA «Voi donne del Pd siete qui perché siete brave solo a fare i p....ni» (il grillino Felice De Rosa alle deputate del Pd).
ASOR ROSA «Ciò cui io penso è invece una prova di forza che, con l'autorevolezza e le ragioni inconfutabili che promanano dalla difesa dei capisaldi irrinunciabili del sistema repubblicano, scenda dall'alto, instaura quello che io definirei un normale stato d'emergenza, si avvale, più che di manifestanti generosi, dei carabinieri e della polizia di stato congela le camere, sospende tutte le immunità parlamentari, restituisce alla magistratura le sue possibilità e capacità di azione, stabilisce d'autorità nuove regole elettorali, rimuove, risolvendo per sempre il conflitto d'interessi, le cause di affermazione e di sopravvivenza della lobby affaristico-delinquenziale, e avvalendosi anche del prevedibile, anzi prevedibilissimo appoggio europeo, restituisce l'italia alla sua più profonda vocazione democratica». (Alberto Asor Rosa invoca il golpe)
MARIA ETRURIA BOSCHI «Il Pd è una banca, e come alcune banche gestisce in modo torbido i nostri soldi e piazza prodotti tossici come il Jobs Act e queste riforme costituzionali» (Alessandro di Battista)
COMPARSE «Il Pd è morto. Ad ucciderlo non sono stati i Franceschini, le Boschi, i Renzi o i Gentiloni. Costoro sono comparse già finite nell'oblio» (Alessandro di Battista).
BUFFONE «Buffone ... Sono felice di essere sommato tra gli ultimi che odia e su cui fa propaganda politica. Teatro, senza dare alcuna vera risposta. Salvini oggi è definibile ministro della malavita» (Roberto Saviano su Matteo Salvini).
ATTICO «Sentire le omelie di Saviano dal suo patrizio attico di New York fa un effetto spaesante da un certo di punto di vista, perché rivela la distanza abissale che si è prodotta fra gli intellettuali della sinistra e le masse popolari dei lavoratori» (Diego Fusaro su Roberto Saviano).
VALORI «Non sto accusando Napolitano di essere un uomo senza princìpi purtroppo li ha» (Renato Brunetta su Giorgio Napolitano)
PUPAZZO «Conte non faccia il pupazzo nelle mani dei partiti» (Graziano Delrio)
L'Italia è un Paese fondato sull'insulto: da noi il dibattito online più violento d'Europa. I risultati di una ricerca esclusiva che ha coinvolto 4 paesi sui commenti nei profili dei politici. Da cui emerge quanto siano tossiche le conversazioni in Rete. Soprattutto grazie a leader come Salvini che aizzano i follower, scrivono Mauro Munafò e Francesca Sironi il 29 maggio 2018 su "L'Espresso".
Matteo Salvini è il politico europeo che riceve più commenti online. La nuova democrazia degli sciami ha preso casa. Le due forze politiche che hanno provato a formare in questi giorni un governo comune hanno già molto in comune, e da tempo, sul web. Nella realtà ormai concreta della Polis digitale e dei suoi sciami d’opinione, d’odio e d’amore via internet, Lega e 5 Stelle non rappresentano un’avanguardia solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono infatti i politici più attivi sui social network, quelli che pubblicano con maggiore frequenza, che ricevono più risposte e condivisioni, i candidati che avevano già sancito per successo di clic il loro exploit alle urne. Nel nostro paese, certo. Ma hanno un primato anche rispetto ai loro omologhi tedeschi, francesi e svizzeri, in quanto ad attivismo digital. Il “Ruspa” può vantare poi un altro record nel continente. La coalizione di centrodestra con cui è stato eletto batte infatti tutti gli avversari in quanto a tossicità delle conversazioni: il 9,2 per cento dei commenti condivisi sui profili dell’ormai ex asse elettorale è un insulto o un’offesa nei confronti di altri, degli «invasori mercenari di Soros» dei «clandestini che distruggono Firenze» di «quella mucca con i capelli viola» (una signora che contestava il sindacato di polizia), dello «strozzinaggio e potere bancario». I messaggi sulle loro pagine sfrigolano disprezzo, avversioni e fantasmi in misura maggiore di quanto accada, per dire, sui social del gruppo parlamentare del Front National, in Francia. Se in tutta Europa la voce dell’estrema destra sembra così più propensa ad aggregare e sparpagliare veleno web rispetto alle altre formazioni, in Italia questo accade con particolare intensità. Sono alcuni dei risultati di una ricerca esclusiva condotta dall’Espresso insieme a un team di giornalisti internazionali. Partendo da un campione randomizzato, statisticamente significativo, di 320 politici, uomini e donne, in Italia, Francia, Germania e Svizzera, sono stati raccolti in maniera casuale i commenti che hanno ricevuto i deputati sui propri profili pubblici Twitter e Facebook per quattro settimane, dal 21 febbraio al 21 marzo 2018. A questo nucleo sono state aggiunte le conversazioni di 10 leader di partito in ogni paese. Sono stati così esaminati oltre 40 mila messaggi per valutarne l’aggressività, sulla base di una scala elaborata da “Articolo 19”, un’organizzazione che lavora sulla libertà d’espressione in Rete. Ogni insulto è stato quindi indicizzato sulla base di alcune categorie, dall’antisemitismo all’omofobia al sessismo. Fra le prime conclusioni di questo lavoro di analisi c’è una sorpresa positiva: i commenti tossici sono meno del sei per cento del totale. In Italia e Francia la conversazione digitale è più inquinata che negli altri due paesi. Ma resta comunque sotto controllo. Mediamente la conversazione online, sulle pagine dei politici, è insomma abbastanza serena o moderata. Scorre quieta fra il sostegno e la chiacchiera, fra l’indifferenza e il «vergogna» di passaggio. L’aggressività non è trasversale, non è un dato comune e costante del rapporto fra il “popolo del web” e i propri eletti. Piuttosto: si concentra. Si coagula su target o argomenti ben precisi, contro cui lo sciame si rafforza e si amplifica.
No Vax, no casta, no donne. Un esempio è quanto accaduto a Beatrice Lorenzin. Il 22,7 per cento delle parole che le sono state rivolte sui social nel mese del monitoraggio svolto dall’Espresso insieme ai colleghi europei suonavano al tono di «Bastarda bastarda bastarda» o del più grave «Ti maledirò finché avrò un alito di respiro» per la legge sui vaccini. Decine e decine di frecce. Sulla scia della stessa avversione, spesso pronta a virare in vere e proprie minacce di morte, è finito anche un suo compagno di partito: Paolo Alli. Contro di lui le frange anti-vaccini sono arrivate a scrivere post quali: «Lorenzin e Alli. Per avere tradito l’Italia e gli italiani una sola soluzione: fucilazione». Ci sono spigoli del dibattito che più di altri forgiano parole ostili. In Germania il risentimento è dominato dallo spettro anti-immigrati. In Francia le offese aumentano con il sessismo. In Italia sono vere entrambe. Nei confronti di Maria Elena Boschi ad esempio abbondano le reazioni pubbliche che vanno dal «sei bellissima!» al «Sei solo gnocca», a «Perizoma please!!» fino al «La aspetto sempre tra sei mesi sulla statale...». Nel campione della ricerca non sono state trovate differenze sostanziali per quanto riguarda il numero di offese personali rivolte alle donne rispetto a quelle inviate agli uomini. Ma quando si guarda alle deputate con maggiore visibilità l’aumento è rilevante sia in Italia che in Francia. Le donne politiche più in vista ricevono cioè molti più insulti dei loro pari maschi. È molto più facile trovare così attacchi come «Vergognosa PARASSITA radical chic!» o: «Vada a fare la casalinga che è più consono alla sua natura» sotto una riflessione di Anna Finocchiaro, di quanto accada per un suo collega di partito.
Le voci dei capi. Se il sessismo è una sponda facile da cui salire all’attacco, ancora più semplice è attorcigliare la lingua quando il tema batte sulla consueta divisione noi-e-loro. «Pure l’immigrante climatico vogliono portare!», lamenta un seguace di Salvini su Twitter; «Ha la pistola… doveva sparargli», si augura un altro rispondendo al leader che commentava: «Prima in galera, poi espulso nel suo Paese. Basta!!!» in calce a un episodio di molestie di cui era stata vittima una carabiniera di Milano. Il catalogo è scadente e arcinoto. E si inzeppa di «piani Kalergi», «bombe nucleari sulla Libia», «No niente galera solo tante legnate» sempre in risposta a un commento del capo che recitava: «Prima galera, poi castrazione chimica, poi espulsione!». È un cupo gioco al rialzo: «La tossicità arriva spesso dall’alto, dagli stessi leader e partiti politici», ricorda Leonardo Bianchi, autore del saggio “La Gente” pubblicato da minimum fax: «Sui social le persone si sentono legittimate a esprimersi in un certo modo», seguendo le orme dell’intolleranza. «Purtroppo bisogna riconoscere che quel linguaggio ha pagato», riflette Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia, autore di uno dei post più divisivi tracciati dalla ricerca: un semplice manifesto elettorale accompagnato da un incoraggiamento. «Era la prima volta che pubblicizzavo un post su Facebook, e sono rimasto sconvolto dagli insulti che ho letto», racconta, contro Giorgia Meloni - «Vai a fare la mamma», «fotoshopp... leccaculo di Berlusconi...» - e contro di lui. «Sono persone frustrate», dice. Il cui linguaggio è però avallato spesso dall’alto. Ma quando la guida del suo partito parla di “feccia umana” rispetto a due stranieri, per Cirielli, «si tratta solo di una valutazione politica». Giovanni Ziccardi, professore di Informatica giuridica all’Università di Milano, parlando del suo libro “L’odio online” in un intervento su DoppioZero, ricordava chiaramente: «Il politico che parla, per la sua posizione, dovrebbe avere una maggiore responsabilità: il suo potere diffusivo di pregiudizi nei confronti, ad esempio, di un gruppo preso di mira è assai ampio grazie alla camera di risonanza fornita dai mass media di cui può, in ogni momento, usufruire». Ma l’esercizio di quella responsabilità sconta il successo del suo esatto contrario.
Social Fascismo. Gli “immigrati”, i vaccini, le donne. E poi gli sciami si scagliano di volta in volta contro banche, complotti, finanziamenti occulti, o genericamente contro i politici. In un ricco intervento su Nuova Rivista Letteraria ripreso da “Giap”, Alberto Prunetti definiva il linguaggio di questi sciami un «trogolo, dove sono miscelati pastoni e retoriche un tempo considerate altamente tossiche, oggi sdoganate», da un «fascismo del senso comune» che alimenta raid virtuali contro i nemici del momento. Sandra è una 49enne di Milano che a Emanuele Fiano ha scritto frasi come «Sputatevi in faccia speriamo che i vs fratelli africani vengano cercarvi (sic) presto per farvi stessa festa subita dalla povera Pamela Mastropietro allora sì che gli italiani perbene festeggeranno davvero», tutto in stampatello. Oggi risponde cortese alle nostre domande. «Sono una persona tranquilla», dice: «Ma dal 2011 la mia vita professionale è andata peggiorando». È da lì, sostiene, che le è salito l’odio per «questi politicanti di sinistra che tutto facevano tranne tutelare i cittadini italiani. Quando lei sente un politico che inventa problemi come il fascismo che non esistono per distogliere la gente da quelli veri, una qualunque persona di buon senso non può che arrabbiarsi». Che il fascismo sia però tutt’altro che una malattia immaginaria lo racconta la filigrana molto più esplicita politicamente di un altro degli sciami intercettati dalla ricerca. Davide Mattiello a febbraio è un parlamentare uscente e candidato Pd a Torino. «Questa mattina ho presentato un esposto in Procura nei confronti delle organizzazioni politiche Forza Nuova e Casa Pound», scrive il 22 sui social network: «Perché credo che le suddette organizzazioni integrino la fattispecie di reato contenuta nella legge Scelba». Basta a spalancare lo Stige. «Fanculo w il DUCE» è una delle reazioni più caute, le altre scadono nell’omofobia più greve o nei «comunista di merda» fino ai «Perché non ti impicchi?». «Non mi sono mai preoccupato per questi commenti», racconta ora lui: «Fa parte del mio dovere politico, credo, manifestare il mio pensiero nelle piazze dove si trova la gente. E oggi queste sono i social network. Io ci sto con la consapevolezza della loro conflittualità». Ma sono piazze dove le voci che si fanno sentire alla gran cassa sono però monocordi. Dove l’intolleranza, gli “a Noi!” e le paranoie securitarie vanno per la maggiore. «È una tendenza che riguarda tutte le democrazie liberali in Occidente», ragiona Leonardo Bianchi: «Nessuno sa come proporre contronarrazioni all’egemonia di discorsi che trattano l’immigrazione ad esempio attraverso le stesse immagini di “barconi” o “invasioni” da trent’anni. E con il crollo dei partiti social democratici il vuoto viene riempito da chi ha le idee più chiare o dice di averle». Così le conversazioni in rete si fanno prima terra di conquista. Praterie intere di propaganda dove sciamare.
Oasi grillina. Al riparo da questi stormi ostili sta il movimento che al web è legato dalla culla. Solo lo 0,5 per cento dei commenti scritti sulle pagine dei politici del Movimento 5 Stelle è offensivo personalmente nei loro confronti, il 3,3 nei confronti d’altri. È direttamente sulle pagine dei politici avversari che si va magari a pubblicare una fila di stelle come segno di riconoscimento, allora, oppure a indicare, condannare, offendere. Sotto i flussi dei “propri” rappresentanti eletti prevale invece l’appartenenza, l’entusiasmo, la comunità. E pochi si insinuano in quelle oasi per svuotare reciproci sacchi di fiele. Con chi si interfacciano allora, i politici in rete? Solo con chi li blandisce o li vitupera? Le eccezioni esistono. Nel campione analizzato dalla ricerca un esempio è quello di Stefano Quintarelli. Un esperto informatico, imprenditore, ex deputato, che alimenta lunghe conversazioni anche su temi ostici come l’identità digitale. Dove non si registrano risse. Ma sono una rarità. Per il resto i thread sembrano un fiorire di cuori e entusiasmo, di conferme quindi, in gran parte. Oppure di insulti, in quel sei per cento di sciami all’attacco dai pulpiti rumorosi delle nuove piazze digitali dove, come diceva Danny Wallace in un’intervista a “D di Repubblica”: «O attacchi, o sei attaccato, o taci».
La ricerca è stata realizzata dall’Espresso insieme a Rania Wazir; Vincent Coquaz; Alexander Fanta, Marie Bröckling, Julian Pütz e Leo Thüer per netzpolitik.org; Alison Langley per Deutsche Welle.
Nota: Sono stati analizzati oltre 40mila messaggi randomizzati ricevuti da 360 politici di Italia, Germania, Francia e Svizzera. I post sono stati valutati su una scala che va dai commenti neutrali (0), a quelli molto scortesi (1), alle offese esplicite (2) fino al discorso d'odio (3).
Il Diffamatore e l'Assassino. La gang degli anti-Berlusconi pensa che l'Italia debba essere il Paese dei (loro) balocchi. Sono solo degli illusi, scrive Alessandro Sallusti, Domenica 29/04/2018, su "Il Giornale". Avete presente quelli che fanno una battuta e la ripetono all'infinito sperando faccia sempre più ridere e non si accorgono che dopo un po' la gente ride sì, ma di loro? Ecco, il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio sono su questa china dell'informazione-barzelletta che fa ridere solo loro. Hanno scoperto che in una sentenza un giudice esprime, al riparo dell'immunità professionale, un proprio parere su Silvio Berlusconi, definendo il Cavaliere un «delinquente». Bene, da allora ogni due per tre piazzano la parola «Delinquente», con la «D» maiuscola perché la classe non è acqua, al posto di «Berlusconi» nel titolo di prima pagina. Lo hanno fatto anche ieri, con «Il Pd preferisce il Delinquente», immaginiamo rispetto a quell'«assassino» di Beppe Grillo nella trattativa per formare il nuovo governo. Con la differenza che mentre «delinquente» è l'opinione non richiesta di un magistrato, «assassino» è un fatto accaduto, confermato con sentenza definitiva dalla Corte di cassazione. Ma andiamo oltre. Se una persona può essere denigrata in base al contenuto di una sentenza, allora posso sostenere che Marco Travaglio non è un giornalista ma un «diffamatore», avendo lui perso tante cause per diffamazione, soprattutto una in cui aveva dato del mafioso a Cesare Previti e di conseguenza a Berlusconi. Il Diffamatore (D maiuscola per par condicio) secondo una sentenza della Corte europea (a cui fece ricorso sperando di sfangarla), aveva manomesso degli atti giudiziari pubblicando solo la parte che a lui faceva comodo, un po' come il suo amico carabiniere di Napoli che voleva incastrare il papà di Renzi con intercettazioni taroccate. Il Diffamatore T. dice anche che bene fa Di Maio a voler mettere le mani su Mediaset, perché è assurdo che un leader politico possegga mezzi di informazione. Nella sua foga accusatrice, il Diffamatore T. scorda che il suo amico Assassino G. (Beppe Grillo, per chi si fosse perso, ndr) e il di lui socio Casaleggio jr sono contemporaneamente proprietari di un partito (i Cinquestelle) e di due siti di informazione (mascherati da blog) tra i più seguiti in Italia. Ovviamente non penso che il Diffamatore T. ritenga questo un pericoloso conflitto di interessi su cui «mettere mano». Perché il Diffamatore T. e l'Assassino G. pensano di essere i più furbi di tutti, tipo il Gatto e la Volpe di Pinocchio. E che l'Italia debba essere il Paese dei (loro) balocchi. Illusi.
La repubblica degli insulti. I due politici alla fine di una dura campagna elettorale si strinsero la mano. Era il ‘76: Dc e Pci se le dettero di santa ragione. Poi Moro e Berlinguer sedettero allo stesso tavolo, scrive Aldo Varano il 28 Aprile 2018 su "Il Dubbio". È un argomento inedito quel che furoreggia sui social, ma anche nelle dichiarazioni di stimati esponenti e vecchi marpioni della politica italiana. Si sostiene: non si può fare alcun accordo con chi in passato ti ha insultato dicendo di te peste e corna. E ancora: quale credibilità ci sarebbe tra alleati di governo dopo valanghe di accuse e insulti che ci si è rovesciati addosso? Lo gridano pezzi del Pd e del M5s (e anche della Lega e del centro destra) con una furia senza precedenti. Eppure è quasi impossibile trovare tra gli accordi politici dei decenni scorsi qualche accordo che non sia stato preceduto da segni di disistima, polemiche roventi, insulti feroci. Nella politica italiana, fin qui, il “Non possumus” è scattato solo per radicali divergenze ideali e culturali (fascismo-antifascismo; comunismo- anticomunismo), diversità nette sulla collocazione internazionale del paese (Nato- Fuori dalla Nato) o insuperabili diversità programmatiche. Su tutto il resto, insulti compresi, è stata sufficiente sempre un’alzata di spalle. Io me la ricordo la campagna elettorale del 1976, e anche la sua conclusione fissata dalla foto in bianco e nero di un Enrico Berlinguer, fisicamente sempre più striminzito, e un Aldo Moro, con la penna bianca in testa sempre più larga, che si stringono la mano separati dal tavolo. Erano i leader dei principali schieramenti, entrambi convinti da tempo che sarebbe stata necessaria una mediazione e una qualche forma d’accordo tra Pci e Dc per impedire l’implosione del paese. Berlinguer, dopo che Pinochet ha affogato nel sangue la democrazia cilena, è convinto che il Pci non riuscirebbe a governare neanche col 51%. Moro è leader di un partito considerato in declino dopo il disastro delle elezioni comunali dell’anno prima quando i comunisti hanno registrato un picco vertiginoso che sembra annunciare il realizzarsi dell’incubo dell’intera politica italiana: il “sorpasso” dei comunisti sui democristiani. Moro deve poi fare i conti con un’agguerrita opposizione contraria a rapporti col Pci che comprende anche Andreotti, già capo del governo che ha tentato il rilancio del Centrismo. In un clima di crescenti tensioni scandite dal sangue dei terrorismi rosso e nero, dal dilagare di omicidi, scandali e stragi di Stato (vere o presunte), Moro e Berlinguer misurano gesti e parole. Ma i rispettivi eserciti, nel 1976, non ne vogliono sapere. Lo scontro con l’avvicinarsi delle elezioni diventerà cattivo e feroce. L’ultimo governo del paese, diretto da Moro, è durato solo 70 giorni per lo sgambetto degli avversari Dc di Moro di ripristinare l’aborto come reato. Il 30 aprile il governo cade. Il 2 maggio, tre giorni dopo, Giovanni Leone, presidente della repubblica, scioglie le Camere e fissa le elezioni per il 20 e 21 giugno. La data viene vissuta dagli eserciti della Dc e del Pci come la battaglia finale per vincere la guerra che dura da trent’anni. Truppe e soldati mirano al cuore del nemico con una radicalità nuova e mai tanto intensa dal 1948. I democristiani sono i ladri e si stanno mangiando il paese. Lo scandalo della Lockeed, una fabbrica americana che vende aerei accusata di aver distribuito mazzette ai più potenti esponenti della Dc, non lascia dubbi. I giornali sono pieni di dettagli. La Dc è vecchia e corrotta. Il Pci lo ripete in tutti gli angoli delle strade. Nel giorno delle elezioni Scalfari, che proprio nel ’ 76 ha lanciato Repubblica, cavalca il (presunto) sentire del paese: la Dc «è quella che è e come tale va giudicata. Non è più la Dc il pilastro della democrazia italiana; anzi rischia di esserne il becchino». Il caso Lockeed coinvolge il ministro della difesa il Dc Luigi Gui, ma anche altri potentissimi Dc. Paolo Guzzanti tuona: «Si fanno i nomi di Moro Leone e Rumor». Aggiunge: «Nessuno crede all’ipotesi di Moro…» ma si capisce che gli altri sono “Antilope” lo pseudonimo dei corrotti secondo le voci che arrivano dall’America. Se i Dc vengono accusati nei comizi, nei caseggiati (l’andare di casa in casa per chiedere il voto agli elettori) di essere ladri e corrotti, dal dc vicino di casa al Presidente della Repubblica (che sull’onda dello scandalo poi si dimetterà), la Dc non è da meno ad insulti. Il Pci mette a rischio la libertà e la democrazia del paese. Montanelli riconosce che certo la Dc è quella che è, ma bisogna turarsi il naso e votarla ugualmente. Quelle del 20 giugno infatti non sono normali elezioni, si tratta di decidere – rispetto all’assalto comunista che vuole affossare la democrazia – se continuare a garantire la libertà in Italia o accettare un regime. Si deve scegliere tra i corrotti e i nemici della libertà. E’ questo il groviglio di accuse che avvolge il paese. Nessuno rinuncia a far male agli altri: più e peggio degli insulti. Poi il voto. Il Pci volò altissimo: 34,4% il miglior risultato della sua storia alle politiche. La Dc, smentendo le previsioni schizzò al 38,7. Furono le elezioni dei “due vincitori” che si scontravano nel paese dalla fondazione della Repubblica. Il 31 luglio, 40 giorni dopo, Giulio Andreotti forma il governo. I ministri sono tutti Dc e il governo ha l’appoggio del Pci di Berlinguer. Tra le due date la stretta di mano tra i due leader dei partiti che non si erano mai tanto insultati.
Scontro di inciviltà: ecco la politica dell'odio. Insulti, violenze, minacce. E intolleranza verso le idee dell’avversario. Che diventa un nemico da distruggere. Così l’Italia va al voto nel modo peggiore, scrive Marco Damilano il 15 dicembre 2017 su "L'Espresso". C’è un bene più prezioso della stabilità di un governo e anche, per fortuna, di una campagna elettorale vinta o persa che in democrazia dovrebbe essere la routine e non un giudizio di Dio? Sì, c’è, è la qualità del dibattito pubblico. La possibilità di riconoscere l’altro: un avversario da battere nelle urne, non un nemico da eliminare. Quando se ne parla appare una questione di educazione, di bon ton, di galateo, una roba da parrucconi, da bigotti custodi delle regole di buon comportamento. Ma non è così, non di mala educación qui si parla, e neppure soltanto dell’avvicinarsi della campagna elettorale. Perché c’è qualcosa di più inquietante e di più profondo. Un’intolleranza al pensiero altrui. Un’ostilità nei confronti di chi non fa parte della tua stretta cerchia dei veri credenti. Una sotterranea volontà di annientare il diverso, come dimostra anche il tentativo di assalto alle redazioni di Espresso e Repubblica del 6 dicembre ad opera di manifestanti del gruppo neo-fascista di Forza Nuova. Un gruppo di militanti mascherati di Forza Nuova hanno fatto irruzione nel cortile di via Cristofotro Colombo, sede dell'Espresso e di Repubblica. Nel video si vede chiaramente uno di questi figuri che lancia un fumogeno contro una delle finestre della redazione. Non preoccupano solo l’attacco, le maschere sul volto come gli attivisti di Anonymous, il megafono che fa subito anni Settanta, gli striscioni e i fumogeni, il vero simbolo di questa stagione perché tutto copre, confonde, occulta in una nuvola di confusione, ma soprattutto le parole spese nel comunicato pubblicato su facebook con gli insulti («infami, pennivendoli, diffusori del verbo immigrazionista») e le minacce: «Roma e l’Italia si difendono con l’azione, spalla a spalla, se necessario a calci e pugni...». Propositi ribaditi l’11 dicembre, in occasione del presidio delle associazioni sotto la sede dei nostri giornali: «Le guardie dell’antifascismo di regime, nemici della patria e traditori, si sono date appuntamento... preferiamo prendervi a schiaffi nelle piazze piuttosto che doverci difendere dalle vostre calunnie». L’annuncio di azioni violente sulla pagina fb di un’organizzazione che si definisce partito politico e che intende candidarsi alle elezioni. La campagna elettorale inizia nel peggiore clima di tensione, tra aggressioni verbali e minacce, segno di una stagione in cui non si vuole più il dialogo con l'altro. Poi sul giornale l'inchiesta sugli affari di Roberto Fiore, leader dei neofascisti Forza Nuova; l'intervista al ministro Carlo Calenda, uno dei personaggi politici del momento; il ritratto di Federico Ghizzoni, ex amministratore di Unicredit e test chiave della Commissione banche; il nuovo divismo della società contemporanea e le sue strategie. Si può tentare in modo rassicurante di isolare il fenomeno e di ridurlo a un gruppo di ragazzotti, al balzo sulla scena mediatica di un ormai attempato capo fascista, quel Roberto Fiore che nel 2006 aveva provato a entrare in Parlamento grazie all’accordo tra Alessandra Mussolini e Silvio Berlusconi, bloccato dalla reazione degli alleati del Cavaliere (Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini). E poi si può allargare la condanna al gruppo rivale di Forza Nuova, l’altra scheggia di estrema destra Casa Pound, il cui leader Simone Di Stefano meno di tre anni fa, il 28 febbraio 2015, salì sul palco di piazza del Popolo accanto a Matteo Salvini (oggi il leader leghista candidato premier lo dimentica e fa lo schizzinoso: «Io certi voti non li prendo»). Inchiesta della magistratura dopo l'azione intimidatoria di dodici camerati. E sui social network tanta solidarietà alla redazione dell'Espresso. Ma non si fermano i vergognosi attacchi. Intanto Fiore scrive a Minniti: «Perché si dà la colpa a me?» Ma sarebbe un errore circoscrivere. Perché insulti, aggressioni, minacce, gli attacchi squadristi che escono dal virtuale e si fanno reali si muovono in un contesto accogliente per le loro scorribande, amichevole, friendly. Da mesi si rincorrono sul web e nei talk televisivi inviti ad asfaltare, cancellare, polverizzare, bruciare vivi gli esponenti di un altro partito. Si invoca la fine di Aldo Moro, rapito e assassinato nel bagagliaio di un’auto quarant’anni fa, ora per Matteo Salvini ora per Laura Boldrini, sul web o sulla prima pagina di una gloriosa testata, il Tempo di Roma, che un tempo fu soavemente diretta da Gianni Letta. Le testate reali contro un cronista delle Iene davanti alle telecamere del familiare di un clan mafioso a Ostia e gli inviti virtuali a masticarli e vomitarli da parte del fondatore del più votato partito politico italiano (stando ai sondaggi), Beppe Grillo e M5S. Non è finita, perché la delegittimazione reciproca rimbalza dalle piazze virtuali alle aule parlamentari, dalla base al vertice, dal basso - per così dire - verso l’alto, con la legislatura che si conclude nel peggiore dei modi, con lo spettacolo della commissione di inchiesta sulle banche che inghiotte e divora quel che resta della credibilità della Banca d’Italia, di un pezzo di magistratura (ad esempio la procura di Arezzo) e i partiti in campo interessati a distruggere ognuno per parte sua un pezzetto di istituzione pur di portare a casa un brandello di vittoria. E poi l’inchiesta sui carabinieri infedeli che truccano le carte sull’inchiesta Consip per incastrare Matteo Renzi. E quel magistrato consigliere di Stato che usa e abusa della sua posizione per organizzare corsi di formazione che con la scienza e il diritto hanno poco a che fare e che si sente come Albert Einstein, un genio incompreso. «Non si può essere violenti con chi pensa cose diverse da noi. Passato questo limite non si torna più indietro». Il ministro critica duramente il blitz di Forza Nuova nel corso di un lungo colloquio con Marco Damilano. E sullo Ius Soli: «È fondamentale per il futuro del paese» Sono situazioni lontane tra loro, a ciascuno il suo. A metterle insieme si rischia il generico, il mischione, il sospiro perbenista e snob per i brutti, sporchi e cattivi, il signora mia, in un annoiato tintinnar di posate. Ma nell’insieme ognuno di questi casi uniti dalle cronache e dai retroscena politici rappresenta un pezzo di fiducia che se ne va. E qualcosa di profondo che viene corroso. «Sento un rumore di denti di talpe che rodono incessanti le radici di molti alberi», mi ha scritto qualche giorno fa uno degli osservatori più intelligenti e disinteressati che in passato ha ricoperto rilevanti incarichi governativi. Questo dovrebbe interessare tutti: le radici corrose. L’Italia ha vissuto albe elettorali molto più pericolose di questa. Nell’anno che viene, per dirne una, sarà ricordato il 18 aprile 1948, settant’anni fa. Uno scontro di civiltà vero, tra l’Occidente e il socialcomunismo, tra Dio e Stalin, il bene contro il male. Da un lato Togliatti, Nenni, Garibaldi, il vento del Nord, l’Armata rossa. Dall’altro gli americani, Pio XII, le madonnine in lacrime, De Gasperi, il manifesto dello scudocrociato della Dc ponte levatoio che si abbatte sulla masnada rossa: «Non si passa». Walter Lippmann, il guru dei politologi americani, scrisse sul “New York Herald Tribune”: «Se l’Italia sarà il primo paese a diventare comunista, significherà una serie di lotte senza fine, irresolvibili dalla diplomazia». Come dire che dal voto degli italiani dipendeva la pace nel mondo. La classe dirigente dell’epoca, però, provava a tenere lo scontro nei binari della civiltà. Era riluttante a delegittimare il partito politico avverso, nonostante l’asprezza e la violenza della battaglia politica in un paese di frontiera nel tempo della guerra fredda, perché il processo di apprendistato democratico prevedeva esattamente il percorso opposto. Educarsi tutti insieme a convivere nella casa comune dello Stato democratico: cattolici e laici, liberali e comunisti. Oggi viviamo in un’epoca di debolezza della struttura statale e di dissolvenza dei partiti e degli altri canali di rappresentanza. E quelli che resistono non hanno alle spalle ideologie, progetti, identità, una visione delle cose, un’idea di politica. Preferiscono in gran parte carezzare l’elettorato per il verso del pelo, l’Italia del rancore di cui ha parlato l’ultimo rapporto Censis. Il rancore è la nuova ideologia. L’inciviltà non è l’incapacità di rispettare l’etichetta, ma il rifiuto dell’altro, per di più in nome di simboli posticci, di appartenenze virtuali. Il fumogeno da stadio è uno dei simboli di questa epoca perché disvela un dibattito collettivo ridotto a stadio, a curva degli ultras. Si va verso una campagna elettorale di ultras, in cui prevale l’odio per l’avversario piuttosto che l’amore per la propria squadra. E il frastuono dei cori assordante che copre le voci critiche o semplicemente disponibili a comprendere le ragioni degli altri. Un clima rafforzato dal virus proporzionalistico che trasforma il partito più vicino in nemico assoluto, che frantuma gli schieramenti, che esalta l’autoreferenzialità di un leader come Matteo Renzi, contento di essere rimasto quasi da solo, senza coalizione, e la sindrome di autosufficienza del partito in testa nei sondaggi, il Movimento 5 Stelle, orgoglioso di dichiararsi indisponibile a ogni alleanza, considerando tutte le altre forze politiche in blocco una malattia da estirpare. Si possono inseguire le centrali straniere delle fake news, i punti che irradiano sulla rete la falsificazione e la mistificazione, la sfera di influenza di Putin che sostituisce quella antica sovietica. Denunciato ogni tentativo di manipolazione, chi fa politica, cultura, giornalismo ha poi però l’obbligo di seguire i fili, cercare di risalire alle radici dell’odio, comprendere perché intolleranza e violenza hanno ripreso diritto di cittadinanza in un paese democratico, perché l’inciviltà sembra prevalere sulla civiltà e contagiare tutto. Non basta condannare, indignarsi, organizzare manifestazioni e raduni antifascisti. Quando si sarà spenta quella che si annuncia come una delle più brutte e inutili campagne elettorali della storia repubblicana, destinata a non produrre alcun risultato, bisognerà riandare alle radici dello scontro di inciviltà. Per comprendere e raccontare cosa si muove nelle periferie e nelle frontiere del nostro Paese. Diradare i fumogeni.
Fascisti su Facebook, a gestire i gruppi neri ci sono anche i poliziotti. Odio, razzismo e fake news. Questi gli ingredienti delle pagine dell'estrema destra sui social network. Sono create da avvocati, impiegati, commercianti. Ma anche da esponenti delle forze dell'ordine. Ora alzano il tiro: dopo tante parole vogliono passare ai fatti, scrive Arianna Giunti il 27 dicembre 2017 su "L'Espresso". I neofascisti alzano il tiro. E ora - nella galassia nera del web dove si incita all'odio e si reclutano militanti - si è passati alla fase due: la "mobilitazione". Odio che promette di diventare non più virtuale ma reale, di oltrepassare i monitor e le tastiere per raggiungere le strade e compiere azioni dimostrative che servano a far capire che «la rivoluzione nera sta arrivando». Come documentano alcune conversazioni all'interno dei gruppi segreti su Facebook tra i nuovi fascisti, che L'Espresso ha avuto modo di vedere. C'è un'indagine complessa, portata avanti dalla Polizia postale e coordinata dalle Procure di Roma, Milano e Torino, che sta monitorando una settantina di persone appartenenti a una rete virtuale attiva in tutta Italia, che incita all'odio e alla violenza. I suoi canali di diffusione sono, appunto, i gruppi segreti sui social che inneggiano al fascismo e i finti siti di informazione che inondano il web di bufale e fake news per condizionare l'opinione pubblica e fare proselitismo. Stanze virtuali create e frequentate da molti sostenitori e attivisti di CasaPound e Forza Nuova, che vanno a caccia di consensi per conto dei due movimenti di estrema destra. Reclutatori che trovano terreno fertile fra personaggi borderline e che vantano precedenti penali per apologia del fascismo. Ma anche fra gente comune: avvocati, impiegati, commercianti, taxisti. E pure qualche insospettabile: alcune di queste pagine sono gestite da appartenenti alle forze dell'ordine.
L'EX MARESCIALLO E LE BUFALE RAZZISTE. All'attenzione degli inquirenti c'è in particolare la pagina web Avanguardia Nera, che vanta quasi 20 mila iscritti. È lì che sono state pubblicate per la prima volta bufale “storiche” di contenuto razzista - come la vicenda degli immigrati musulmani che distruggono un albero di Natale - e fotomontaggi poi diventati virali. Come quello che ritrae un'attrice americana spacciata per la sorella della Presidente della Camera Laura Boldrini, colpevole - secondo chi ha orchestrato la bufala - di aver messo in piedi una serie di cooperative che lucrano sulla pelle dei profughi. Fra i siti amici di Avanguardia Nera, figura un’altra pagina “clickbait” che fa affari d'oro grazie ai milioni di contatti giornalieri: si tratta di Vox News, il cui cavallo di battaglia sono i crimini degli immigrati. Tutti rigorosamente inventati. Però la rete ha i suoi anticorpi, e così nel web sono nati spontaneamente gruppi di cittadini che operano contro la diffusione delle bufale, come l'attivissimo comitato virtuale “Contro la diffusione della xenofobia e dell'ignoranza”. Avanguardia Nera - più volte segnalata alla Polizia postale e agli organismi di controllo di Facebook per istigazione all'odio razziale - è stata cosl finalmente chiusa lo scorso febbraio. Per poi rinascere però, qualche giorno dopo, con un nuovo nome di chiara ispirazione fascista: “Avanguardia Italia Nera, a Noi!”. Fra gli amministratori, risulta esserci anche un maresciallo dell'esercito italiano (ora in pensione) il cui profilo Facebook è all’esame degli uomini della polizia postale.
UOMINI IN DIVISA NEL “REGIO ESERCITO”. Ma l'ex maresciallo è in buona compagnia. I gruppi di ispirazione fascista nel web continuano a nascere quotidianamente, e alcuni di loro sono frequentati da forze dell'ordine. Ad amministrare il gruppo Facebook "Regio Esercito Fascista" - quasi 1.400 iscritti - c'è per esempio un giovane poliziotto in forza alla Questura di Padova, che risulta aver creato la comunità virtuale nove anni fa. Non si tratta di un gruppo considerato borderline. Al suo interno, va detto, non si leggono frasi di odio razziale o di incitamento alla violenza, ma vengono pubblicate immagini di combattimenti dell'esercito italiano risalenti alla Seconda guerra mondiale, che sottolineano «l'eroismo dei soldati italiani». Però compaiono anche foto storiche del Ventennio e del Duce. Mentre qualche membro pubblica i propri autoscatti mentre si cimenta nel saluto romano. Fra gli iscritti figurano diversi militari. E del resto i precedenti di "poliziotti neri” sono tanti: un anno fa i due agenti scelti Cristian Movio e Luca Scatà dovettero rinunciare alla medaglia d'onore dopo aver catturato e ucciso il terrorista islamico Anis Amri per essersi fatti immortalare, nei loro profili social, mentre facevano il saluto romano e inneggiavano a Benito Mussolini. Alcuni anni fa, fece scalpore la fotografia scattata da un passante che immortalava una bandiera con la croce celtica issata sul muro del Commissariato Città Studi di Milano.
IL CAPO ORDINOVISTA: "IMPICCARE BOLDRINI”. Il timore degli inquirenti che monitorano l'attività web dei gruppi neofascisti non è un mistero: le forze dell’ordine infiltrate vigilano affinché gli sproloqui e l'incitamento alla violenza nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni non si tramutino in qualcosa di reale. Ma il lavoro di indagine è lungo e faticoso. Gli istigatori all'odio solitamente utilizzano nickname difficili da identificare, e la collaborazione del colosso americano Facebook all'identificazione dei profili sconosciuti a volte manca completamente o è troppo lenta. Perché in pochi di loro agiscono io modo scoperto. Fra i nomi degli hater più monitorati dagli inquirenti c'è per esempio il cosentino Vittorio Boschelli, finito nel mirino della Postale per essersi scagliato con violenza contro la Presidente della Camera Laura Boldrini arrivando a scrivere che avrebbe voluto «impiccarla in piazza». Il nome di Boschelli, fondatore del Movimento politico fronte popolare e molto attivo nel web con post che incitano al razzismo non è nuovo agli inquirenti. L'aspirante politico figura infatti fra gli ideologi del partito Identità Nazionale, Il gruppo a cui, secondo il gip dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella, faceva riferimento il gruppo di neofascisti clandestino Avanguardia Ordinovista, decapitato nel 2014 nell'ambito dell'operazione Aquila Nera. Quattordici arresti e decine di indagati che portarono alla luce una rete eversiva di estrema destra diffusa in tutta Italia che pianificava attentati dinamitardi contro Equitalia e nelle stazioni ferroviarie e che progettava l'omicidio di magistrati e politici senza scorta. Anche allora, i neofascisti che volevano resuscitare Ordine Nuovo incitavano all'odio razziale attraverso apposite pagine web e facevano proselitismo arruolando i propri “soldati” utilizzando il più veloce e impermeabile dei social network: Facebook, appunto. Una storia già vista.
Ius soli, da Boldrini a Kyenge: adesso è caccia ai sabotatori. Dopo la mancanza del numero legale in Senato scoppia la bufera sugli assenti. Lite M5s-Pd. Boldrini: "Gravi responsabilità", scrive Nico Di Giuseppe, Domenica 24/12/2017 su "Il Giornale". Da ultimo, mancato, impegno di questa legislatura a primo terreno di scontro per la campagna elettorale che si aprirà tra pochi giorni. Se, infatti, ieri il Senato ha fatto mancare il numero legale condannando la legge sullo ius soli, tra i partiti non si placano le polemiche. "Promessa mancata e occasione persa per rendere più coesa nostra società. 800.000 ragazze e ragazzi, che di fatto già lo sono, attendevano con fiducia di diventare cittadini italiani. Assenti in #Senato e chi ha fatto mancare sostegno si sono assunti grave responsabilità #IusSoli", scrive su Twitter la presidente della Camera Laura Boldrini, che da venerdì è scesa in campo con Liberi e uguali e ha fatto di diritti e uguaglianza una delle sue principali battaglie anche in questi cinque anni di legislatura. Anche la Chiesa e il mondo della solidarietà non usano mezzi termini per raccontare il nulla di fatto. "Non hanno nemmeno fatto lo sforzo di schierarsi e votare a viso aperto per dire sì o no allo ius culturae e allo ius soli temperato. Hanno fatto mancare il numero legale in aula: appena 116 senatori presenti - attacca il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio - Far mancare il numero legale è scelta da politica in fuga. Ieri in fuga dall'ultima responsabilità di legislatura. Una mossa da ignavi". A farsi sentire anche Marco Cappato, leader dell'associazione Coscioni, che chiama in causa anche il Capo dello Stato: "Non mi è chiara la fretta del Presidente Mattarella di sciogliere le Camere, senza regole decenti per la raccolta firme e con provvedimenti importanti come lo ius culturae che potrebbero essere approvati - scrive su Twitter - Non vede l'ora che il nuovo caos prenda il posto del vecchio caos?". Intanto tra i partiti continua il rimpallo delle responsabilità. Colpa del Pd per i 29 senatori dem assenti? "In Senato non abbiamo i numeri - insiste Ivan Scalfarotto - Se il M5S avesse risposto positivamente a questo appello e si fosse raggiunto un accordo politico per approvare la legge, in aula ci sarebbero stati tutti: loro e noi. Ma questo accordo era risaputo che non c'era, perché M5S è un partito di destra e lo ius soli non lo vuole, e dunque era chiaro che il numero legale non sarebbe stato raggiunto in qualsiasi caso". La risposta dei pentastellati non si è fatta attendere: "Abbiamo deciso insieme di non rispondere all'appello perché era una gigantesca ipocrisia. Era una presa in giro demagogica. Una follia, una farsa, una barzelletta. Con la gente già con il trolley nelle mani". "Siamo arrivati troppo tardi a porre" lo Ius soli "come centrale in questa legislatura. Ma è una riforma necessaria, che deve restare all'ordine del giorno del Paese", ha ammesso Minniti. "Abbiamo tradito una promessa. Un impegno preso con quasi un milione di ragazze e ragazzi, bambine e bambini. La promessa di un Paese che riconosceva i propri figli come legittimi", ha dichiarato Cècile Kyenge. Che poi ha aggiunto: "Abbiamo trascinato per anni questi giovani, bambini e bambine, in un dibattito feroce, umiliante e misero. Così come è stato miserevole il siparietto andato in scena ieri al Senato. Una responsabilità che peserà sulle coscienze e sulla credibilità di tutti coloro che hanno contribuito a far saltare il numero legale in aula: il M5S, Gal, Ala, Lega e Forza Italia. La stessa responsabilità peserà anche sui 29 senatori del mio Partito e i 3 di Mdp. Il Gruppo Pd, anche se la presenza dei suoi senatori non avrebbe influito sul risultato finale, aveva l'opportunità di mostrare un'immagine compatta al fianco di chi si è speso per anni in favore di questa battaglia, un battaglia di valore, europea e globale. Un'occasione mancata, che da oggi però avrà un volto e un nome da mostrare in campagna elettorale. Dal canto mio la battaglia continua, perchè, lo ripeto, il punto non è se concedere o meno la cittadinanza a questi bambini, ma come concederla, a conclusione di un percorso di integrazione o al termine di un'iter burocratico pieno di ostacoli? Un giorno, ne sono convinta, questa riforma sarà fatta".
Gli attivisti pro-ius soli pubblicano i nomi dei senatori “disertori”. Gli attivisti pro-ius soli non riescono proprio a digerire la mancata approvazione della legge, scrive Giovanni Giacalone, Martedì 26/12/2017, su "Il Giornale". Gli attivisti pro-ius soli non riescono proprio a digerire la mancata approvazione della legge al punto da arrivare a chiedere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poterla approvare. La conclusione della lettera inviata dal movimento “Ragazzi senza Cittadinanza” è più che eloquente: “Talvolta le autorità di un Paese democratico sono chiamate dalla Storia a promuovere leggi che possono apparire divisive ma che in realtà sono necessarie a potenziare gli anticorpi e a creare argini contro la deriva di forze antidemocratiche e destabilizzanti. Non lasciateci soli ancora una volta". Una possibile interpretazione? Anche se moltissimi italiani sono contrari allo ius soli, la legge va approvata perché chi è contro è un anti-democratico e un destabilizzatore. Così, in un momento estremamente delicato, con l’emergenza immigrati, il rischio terrorismo e un’instabilità politica che necessita elezioni al più presto c’è chi non soltanto chiede di posticipare lo scioglimento delle Camere ma punta il dito contro chi la pensa diversamente sull’approvazione dello ius soli. Intanto però sulla pagina Facebook “La Rete G2-Seconde Generazioni” tale Mohamed Abdallah Tailmoun pubblica un post con scritto: “Ma si sanno i nomi dei senatori Pd e Mdp assenti in aula al Senato il 22 dicembre”? Poco dopo al post risponde tale Said Lahaine che pubblica una lista di una trentina di nominativi di senatori non presenti in aula durante il tentativo per far passare lo ius soli, tra cui il Ministro degli Interni, Marco Minniti. Tra i commenti degli utenti si legge: “che schifo”, “tutti a casa” e “i nomi sono pubblicabili? Ce ne sono altri?”. Un episodio che desta preoccupazione perché potrebbe anche far pensare a una “caccia alle streghe” con ricerca dei presunti “responsabili” della mancata approvazione. Tutto ciò quando pochi giorni prima Unicef Italia si era esposta su Twitter con un post che accusava di “idiozia” e “fascismo” chi è contro lo Ius Soli. Insomma, forse è il caso di valutare bene chi sono gli anti-democratici e i destabilizzatori che utilizzano metodi reazionari.
I razzisti dello ius soli: "Fascista chi è contrario". Un tweet dell'Unicef bolla chi dice no al testo: "Idioti". Liste di proscrizione sui social contro i dem assenti, scrive Fausto Biloslavo, Mercoledì 27/12/2017, su "Il Giornale". Un tweet di Unicef Italia che bolla come «idiota» e «fascista» chi è contro la legge sullo ius soli. E la caccia alle streghe che sta nascendo in rete sui senatori assenti, che hanno affondato la norma sulla cittadinanza in questa legislatura. Un circuito collegato ai firmatari della lettera aperta al capo dello Stato per rimandare lo scioglimento delle Camere, che dimostra tutto l'estremismo di chi si pone come paladino buonista contro razzismo e xenofobia. La vigilia di Natale sul sito ufficiale di Unicef Italia appare un tweet, che assomiglia di più a quello di una fazione che all'agenzia dell'Onu in difesa dei bambini. In riposta a delle critiche pesanti contro lo ius soli gli umanitari rispondono: «Ah sei di quelli che usano nomi stranieri e bio in inglese ma non tollerano che ragazzini nati in Italia che parlano italiano siano considerati italiani» con aggiunti gli hashtag «idiot» e «fascist». In rete si scatena una valanga di polemiche. Il portavoce dell'agenzia dell'Onu è Andrea Iacomini, che faceva lo stesso lavoro ad un assessorato della seconda giunta capitolina del sindaco Walter Veltroni. Per 20 anni impegnato in politica era diventato segretario giovanile del Partito popolare. Candidato per l'Ulivo, in quota Margherita, nelle elezioni comunali di Roma del 2006 non è stato eletto per un soffio. Lo scorso anno non escludeva in un'intervista di rituffarsi in politica. Nel frattempo fa il portavoce di Unicef, sempre molto schierato pro ius soli, che dovrebbe avere anche la responsabilità delle uscite su twitter dell'agenzia dell'Onu. Secondo Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato di Forza Italia, «Iacomini insulta il Parlamento perché non ha varato la legge sullo ius soli. Chieda scusa». Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega alla Camera, sottolinea: «Si dimetta. Siamo stanchi di subire la retorica antifascista da chi si comporta da fascista». Dopo una giornata di polemiche Unicef ritwitta ammettendo in parte la gaffe: «Un troll ha usato l'epiteto idiota contro di noi fino a quando, vistoselo restituire (caduta di stile, lo ammettiamo) è corso dal giornalista amico. () #Stoppiagnisteo». Unicef e Iacomini, esperto blogger, sanno bene che si possono bloccare i troll e chi insulta sui social. E in ogni caso la mezza marcia indietro conferma che i critici dello ius soli sono «#fascist». Stessa linea imbarazzante adottata nella lettera degli «Italiani senza cittadinanza» al presidente Sergio Mattarella per non sciogliere le Camere prima di avere approvato lo ius soli. «Talvolta le autorità di un Paese democratico sono chiamate dalla Storia a promuovere leggi che possono apparire divisive - scrivono - ma che in realtà sono necessarie a potenziare gli anticorpi e a creare argini contro la deriva di forze antidemocratiche e destabilizzanti. Non lasciateci soli ancora una volta». In pratica i rappresentanti degli italiani in Parlamento l'hanno affossata, ma la norma va approvata lo stesso perché i contrari rappresentano un pericolo antidemocratico e destabilizzante. Ovvero sono «fascisti» come scrive l'Unicef. Curioso che una lista dal sapore della proscrizione sia finita sul gruppo Facebook «la rete G2-Seconde generazioni», attivisti pro ius soli collegati proprio agli «Italiani senza cittadinanza». Ieri Mohamed Abdallah Tailmoun si chiedeva in un post: «Ma si sanno i nomi dei senatori Pd e Mdp assenti in aula al Senato il 22 dicembre?», che hanno provocato l'affossamento della legge. Poco dopo Said Lahaine, profilo falso, pubblicava la lista «nera» dei 29 senatori Pd, 3 di Articolo 1 e Corradino Mineo del Gruppo misto. I più noti sono il ministro dell'Interno Marco Minniti, della Difesa Roberta Pinotti, ma pure Sergio Zavoli, Nicola Latorre e Felice Casson. E giù commenti da caccia alle streghe dei democratici buonisti dello ius soli: «Che schifo», «Lol» e «tutti a casa» e «ce ne sono altri?», riferendosi ai 5 stelle.
Idiota e Fascista: così Unicef definisce chi è contro lo ius soli. Sei contro lo Ius Soli? Allora sei un “Idiota” e un “Fascista”; parola di Unicef Italia. Anzi lo sei in inglese, “Idiot” e “Fascist”, scrive Giampaolo Rossi, Domenica 24/12/2017, su "Il Giornale". Sei contro lo ius soli? Allora sei un “Idiota” e un “Fascista”; parola di Unicef Italia. Anzi lo sei in inglese, “Idiot” e “Fascist”. È quello che scrive ufficialmente su Twitter, la sezione italiana dell’Organizzazione Internazionale. Tutto nasce da una polemica con un utente che aveva criticato la presa di posizione del portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, dopo il “naufragio” ieri del ddl sullo ius soli. Iacomini aveva definito una “pagina triste della storia repubblicana” il mancato raggiungimento del numero legale al Senato sul disegno di legge che prevede la concessione della cittadinanza ai nati nel nostro territorio; il presidente del Senato, Grasso, è stato costretto a rimandare la discussione al 9 gennaio quando le Camere saranno presumibilmente sciolte, decretando l’impossibilità dell’approvazione della legge almeno per questa legislatura. Già le dichiarazioni di Iacomini hanno scatenato alcune reazioni: a che titolo il portavoce di un’Organizzazione Internazionale si permette di giudicare in maniera così polemica con le dinamiche parlamentari di uno Stato sovrano? La questione si è poi trasferita sui social e la tenuta nervosa dei responsabili Unicef non ha retto a tal punto da definire “Fascista e Idiota” un utente che aveva criticato lo ius soli. Apriti cielo! I responsabili di Unicef hanno risposto al malcapitato critico con un tweet offensivo e indegno di un’Organizzazione Internazionale e, ironizzando sul suo account straniero, l’hanno attaccato: “Ah sei di quelli che usano nomi stranieri e bio in inglese ma non tollerano che ragazzini nati in Italia che parlano italiano siano considerati italiani. #idiot & #Fascist”. Una rissa indecente a cui hanno fatto seguito commenti di protesta da parte di molti altri utenti di Twitter, indignati dal fatto che l’Unicef si permettesse di offendere e denigrare chi aveva idee diverse dalle loro. D’altro canto gli stessi responsabili Unicef Italia hanno provato a giustificarsi affermando che l’Organizzazione è composta da “cittadini italiani con pieno diritto di esprimersi su qualsiasi vicenda riguardi i diritti dei bambini in Italia”, smentendo così il carattere super partes di una struttura che è “parte integrante di Unicef, organo sussidiario dell’ONU”, come si legge dal sito La rabbia per il fallimento dello ius soli, battaglia voluta fortemente dalla sinistra italiana, ha generato profonda frustrazione nella élite mondialista che lavora nelle Organizzazioni Internazionali e nei centri del potere tecnocratico per favorire processi migratori e di abbattimento delle identità nazionali (processi di cui lo Ius Soli fa parte). L’umanitarista di professione ha spesso un volto intollerante e livoroso. E Unicef Italia lo ha mostrato in tutta la sua arroganza.
Odio ad personam, scrive Francesco Maria Del Vigo, Giovedì 2/11/2017, su "Il Giornale". Caccia all'uomo. Il nemico che i grillini vogliono abbattere è prima di tutti uno: Silvio Berlusconi. L'antiberlusconismo ossessivo non è una meteora, nel firmamento dei Cinque Stelle. L'odio per il leader di Forza Italia è una delle prime ragioni sociali del Movimento. E ora, alla vigilia delle elezioni siciliane e all'antivigilia di quelle politiche, con un Cavaliere sempre più forte, tirano fuori le loro vecchie cartucce. Ma la polvere da sparo ormai è bagnata. Tutto è iniziato a metà degli anni Novanta, Berlusconi non aveva fatto in tempo a mettere un piede nell'arena politica che Grillo lo aveva già messo nel mirino. Prima lo faceva dai palchi dei propri show portando a casa una lauta ricompensa. Poi ha deciso di passare all'incasso elettorale. Lo ha dipinto come un imprenditore sull'orlo del crac finanziario (ma l'unica cosa che è fallita è stata la sua previsione), un capitalista senza scrupoli e un mafioso. Ma era solo l'inizio di una campagna contra personam che sarebbe proseguita per anni, passando dalle minacce agli insulti fisici, dagli auguri di sventure ai nomignoli dispregiativi. Un odio viscerale che dal copione del comico sarebbe poi entrato anche nei programmi del politico. Gli attacchi si fanno sempre più personali, morbosi e violenti. Grillo è sempre in prima linea contro il leader di Forza Italia: nel 2002 porta in giro uno spettacolo di 150 minuti monopolizzato dalla figura del Cavaliere, nel 2003 aderisce a un'azione di boicottaggio contro i prodotti che fanno pubblicità sulle reti Mediaset. Lo scopo? «Difendere la libertà di informazione». Danneggiando un'azienda che offre occupazione a migliaia di persone. Ma era l'Italia dell'antiberlusconismo con la bava alla bocca, del nemico da abbattere a tutti i costi. Quando può, Grillo si accoda a tutte le manifestazioni anti Cav da piazza Navona al Popolo viola, e se ha bisogno di una platea maggiore va in tv, dal suo amico Santoro. Il giorno in cui il Cavaliere viene condannato in via definitiva il leader dei Cinque Stelle brinda «a un evento storico come la caduta del muro di Berlino». Si sa, lui ama sconfiggere i nemici per via giudiziaria più che elettorale. È un'ossessione ai limiti dello stalking. Grillo odia Berlusconi e tutto quello che fa riferimento a lui. A partire da Fininvest: nel 2004 scrive su Internazionale che il colosso di Cologno Monzese ha accelerato il declino del Paese. Non si sa su quali basi. Ma non c'è da stupirsi: Grillo è anche quello che diceva che l'Aids non esiste e che i vaccini sono inutili. Nel 2012 viene condannato per diffamazione a risarcire 50mila euro al Biscione. Ma la persecuzione verso il patrimonio della famiglia Berlusconi (e non solo, nel sedicente francescanesimo grillino i ricchi sono tutti dei pericolosi nemici) arriva anche nella prima bozza del programma dei pentastellati sull'informazione, nel quale è scritto nero su bianco che con un loro ipotetico governo non potrà esistere nessun canale televisivo nazionale posseduto a maggioranza da alcun soggetto privato con più del 10 per cento. Vi viene in mente qualcuno in particolare? Ecco, appunto. Praticamente un esproprio di Stato. Una misura sartoriale fatta per spegnere Mediaset. E poi - insulto dopo minaccia - arriviamo fino agli ultimi mesi, con il tentativo di far fuori Berlusconi dalla vita politica con un emendamento ad hoc da infilare nel Rosatellum. Per chiudere con la ridicola indagine, aperta a Firenze, sulle stragi di mafia, che ricalca uno dei refrain grillini e porta in calce la firma di Nino Di Matteo, amico e grande ispiratore del Movimento 5 Stelle. E siamo solo all'inizio di una lunga campagna elettorale.
Beppe Grillo e il fascismo sessantottino, scrive di Fabio Cammalleri su "Lavocedinewyork.com" il 28 Febbraio 2014. Qualsiasi espressione di dispotismo evoca Mussolini, ma nel caso del Movimento Cinque Stelle bisogna guardare agli anni ’70. Il popolo grillino sa più di assemblearismo scolastico e di fabbrica. Ma la memoria a breve termine è troppo scomoda. È comprensibile che generalmente si tenti di spiegare il Movimento 5 Stelle senza il Movimento 5 Stelle. Perché l’Italia è un Paese antico e perciò i paralleli, le analogie, le suggestioni rampollano dal suo vastissimo passato con naturale facilità. E, nonostante non manchi mai il dubbio “sull’utilità e il danno della storia per la vita”, resta questa facilità di evocazione e di confronto. Meno comprensibile che l’indagine nel tempo susciti risonanze obbligate. Se Grillo si muove in modo dispotico e plebiscitario, a chi si pensa? Al fascismo, naturalmente, sia pure al fascismo in statu nascendi. È una suggestione. Ma se anche non fosse, è l’unico paragone possibile? Forse no. Forse se ne può svolgere un altro più stringente, più comprensibile. Per farlo, però, bisogna uscire da quelle risonanze obbligate. Proviamo. Secondo lo storico Arthur Schlesinger Jr., che fu anche consigliere di John Kennedy, per comprendere i caratteri e le aspirazioni di una realtà politica, sia essa una singola personalità o un gruppo, bisogna considerare gli anni della sua giovinezza, quelli in cui coloro che gli diedero anima e sangue si affacciarono al mondo: gli anni dell’università o del primo lavoro. Espose questa teoria in un saggio, significativamente intitolato: I cicli della storia americana. I giovani di Roosevelt sarebbero stati la società adulta di JFK, la Nuova Frontiera, figlia del New Deal; e il ritenuto conservatorismo degli anni di Reagan, sarebbe derivato da quello degli anni di Ike, della Guerra Fredda entrata a regime. E così via. S’intende che è uno schema molto generale, ed anche generico, ma rende l’idea. Seguendo questa traccia, per capire Grillo non ci serve Mussolini, ci serve l’Italia repubblicana, ci servono gli anni ’70. Si potrebbe obiettare che molti dei “cittadini” non hanno vissuto quel periodo, e non ne potrebbero avere ereditato i caratteri. Se è per questo, non hanno vissuto neanche il fascismo, come nessuno di noi. E poi, essendo il Movimento smaccatamente personalistico, è sulla persona del Capo che occorre soffermarsi, proprio e mentre più protesta la sua fungibilità, la sua non indispensabilità. Perciò, il criterio gioventù-maturità, stretto all’arco della “generazione”, appare quanto mai appropriato. Giacché costringe a soffermarsi sulle persone in carne ed ossa, senza cedere alle comode vie di fuga di un’astrazione che, di fronte ad un quadro, guarda solo alla figura e mai all’autore. Così, il popolo casaleggesco del web, sa più di assemblearismo scolastico e di fabbrica in sedicesimo che di “adunate oceaniche”; più di una compulsione petulante e narcisistica, solo preoccupata di sé e col solo problema di lasciare il segno della parola più forte, della frase più figa, che di uno stazionamento attonito e ammutolito sotto un balcone oracolante; emana un monadismo delle coscienze chiuso nella mera contiguità, sazia e galleggiante, di abitudini inerti e modaiole, più che la tragica comunione di un’autentica povertà che, sperando di superarsi, si inabissa. E non è un caso che il paradigma-Mussolini sia così ampiamente sponsorizzato. Ora che Occupy-Parlamento mima indimenticate occupazioni universitarie e di fabbrica; ora che le espulsioni on line tradiscono il lezzo settario dei “venduti” e “servi del sistema”; ora che la violenza verbale tende sempre più frequentemente a concretarsi, come accadde con l’affabulazione esaltata della “controinformazione”, fattasi poi “lotta continua”, quindi “salto di qualità nella lotta”, e infine “lotta armata” e tutto il resto; ora che i “Poteri Forti” sembrano assolvere alla stessa funzione già attribuita al “terrorismo di stato” e all’ “imperialismo capitalistico”, l’infame funzione di cui ogni deliquio massificato, facinoroso e irresponsabile ha sempre bisogno, la funzione di autogiustificarsi; ora che siamo a questo, che c’entra Mussolini? C’entra, secondo quelle risonanze obbligate. Infatti, per parlare di un secolo fa, per la memoria a lungo termine, c’è sempre spazio. Ma il rispecchiamento imbarazzante, quello che si potrebbe subire appena passando da una stanza all’altra, estraendo il cassetto del comodino e avendo il coraggio di sfogliare il diario del liceo, no; la memoria a breve termine, mai. Meglio la luna. Perché lì, così vicino, c’è tutta la violenza, tutta la viltà, tutta la rozzezza, tutta la miseria, tutto il trasformismo che si attribuiscono all’Orco fascista. Solo che l’Orco fascista, dopo il liturgico richiamo di giornata, sfuma inevitabilmente in una rarefazione fiabesca, in una comoda inattualità. Mentre quel sordo rancore, quella truce disposizione d’animo, possono riprendere a gonfiarsi, ad agire, ad offendere dicendosi offesi, a colpire dicendosi colpiti. E ad inseguire palingenesi e carriere.
Sotto le 5 stelle il rosso: sono uguali ai comunisti. Traditi dal programma di sinistra, dall'odio per i capitalisti al pauperismo, scrive Francesco Maria Del Vigo, Sabato 11/11/2017, su "Il Giornale". Cinque stelle rosse si agitano nel cielo della politica italiana. E non serviva un meteorologo di grande esperienza per prevederlo. Era naturale. Perché la congiunzione astrale tra i grillini e i compagni erranti (nel senso che vagano senza meta, ma pure che sbagliano) che hanno imboccato la strada alla sinistra del Pd era logica e naturale. Non tanto per una questione umana - Bersani e soci nell'immaginario pentastellato sono pur sempre parte della casta - quanto per una questione ideologica e programmatica. Chiunque si sia avventurato nella soporifera lettura del programma dei grillini non ha dubbi: sono di sinistra. E hanno tutti i tic politici e intellettuali di quei cespugli della sinistra radicale che ora non sanno dove attecchire. Volete qualche esempio? La loro storia politica è chiarissima, il loro programma ancor di più. Il movimento muove i primi passi, e raccoglie i primi consensi, a cavallo tra gli orfani dell'antiberlusconismo più violento, del popolo viola e del movimentismo da centro sociale: no global, no tav, no tap, no vax e chi più ne ha più ne metta. Sono quelli che ancora oggi si divertono a decapitare i fantocci di Renzi e lanciare sassate alla polizia, con lo scudo dei politici grillini che ne chiedono subito la scarcerazione (vedi G7 di Venaria). Dietro il completo blu di Di Maio si nascondono eskimo e kefiah. Il programma gestato e partorito in rete è ancora più chiaro e sembra la versione 2.0 di un vecchio manifesto marxista. Le multinazionali? Delle macchine di morte da imbrigliare e sconfiggere a ogni costo, poco importa che diano lavoro a migliaia di persone. Gli Stati Uniti? Il burattinaio cattivo che gestisce di nascosto i destini universali. Il liberismo? Beh, l'ossessione dei Cinque Stelle per il liberismo è quasi patologica. Ogni stortura, ogni giustizia, ogni cosa che non va al mondo - fosse la lampadina bruciata di una periferia di Roma o la crisi idrica in Burkina - è sempre colpa del neoliberismo, madre e padre di tutti i mali. Ne consegue che la ricchezza è una colpa, un difetto di fabbrica, un peccato originale. Emendabile solo con un bel bagno (di sangue) nel lavacro fiscale. Magari con una patrimoniale. Ma i destini di grillini e sinistra radicale si incontrano più di una volta: dal giustizialismo estremo all'ecologismo più spinto, dal mito del pauperismo e della decrescita felice all'odio per il mondo della finanza, senza alcuna distinzione. Esattamente come gli ex Pci preferiscono lo Stato al singolo cittadino, il pubblico al privato. E poi il pacifismo «onirico», quello che, senza fare i conti con la geopolitica, immagina un mondo nel quale le relazioni diplomatiche si possano fare solo con pacche sulle spalle e buffetti. E forse il punto di saldatura più evidente tra grillismo e comunismo è proprio questo: il fondamentalismo ideologico, l'idea che si possa far aderire la realtà ai propri ideali; il desiderio di cambiare e non la società in cui vive. Un delirio messianico che ha seminato solo danni. D'altronde Gianroberto Casaleggio, nel suo ultimo visionario libro Veni Vidi Web, profetizzava un mondo di downshifter (persone che decidono volontariamente di guadagnare di meno per vivere meglio), senza Tv che distrae e costa troppo, senza centri commerciali, con una proprietà privata limitata e le grandi aziende smantellate. Questo è il mondo che sognava il fondatore dei Cinque Stelle. A lui sembrava un paradiso, ma ha più i tratti un inferno sovietico. A lui pareva una nuova ricetta per cambiare il mondo, a noi sembra la solita brodaglia rancida in salsa marxista. È il comunismo digitale.
L'ODIO PER RENZI E IL LUTTO DELLA SINISTRA, scrive Massimo Recalcati il 17 luglio 2017 su "La Repubblica". QUALE è il peccato commesso da Matteo Renzi per aver attirato su di sé un odio così intenso? È un odio pre-politico o politico quello che lo ha così duramente investito? È l'indice di un tramonto irreversibile della sua leadership? È fondato sulla valutazione obbiettiva dei contenuti della sua azione di governo e di segretario del Pd oppure risponde a logiche più arcaiche, più viscerali, più pulsionali? Prendiamo in considerazione in particolare l'odio della sinistra che è il vero nodo della questione. Una prima considerazione generale: fa parte del suo Dna e della sua storia, anche di quella più recente, scatenare l'odio nei confronti di coloro che, dichiarandosi militanti di sinistra, osano introdurre dei cambiamenti che rischiano di minare alla base la sua identità ideologica. L'accusa di essere un rinnegato o un traditore in questi casi scatta come la salivazione condizionata nel cane di Pavlov. La storia ci offre una miriade di esempi, antichi e più recenti. La dichiarazione di voto favorevole al Referendum del 4 dicembre è assimilabile, per chi sente di appartenere al mondo della sinistra, a un vero e proprio outing con tutti i fatali effetti di discriminazione che esso comporta. Un intellettuale lucido verso il quale provo solo stima come Tomaso Montanari esigeva eloquentemente che Pisapia facesse autocritica per aver votato Sì al fine di risultare credibile nel suo sforzo di rifondazione di un nuovo campo della sinistra. Ma possibile che ogni atto, ogni pensiero, ogni gesto politico di Renzi sia sbagliato? Che ogni sua opzione sia divenuta contraria al bene del Paese e a quella del suo stesso partito? Non è un po' sospetto? Matteo Renzi viene identificato non come la cura, ma come la malattia della sinistra. Una infezione, un batterio, una anomalia genetica di fronte alla quale anche i dispositivi democratici che regolano la vita del Pd e che, di fatto, ratificano ogni volta la sua leadership sembrano inadeguati. La convinzione resta inscalfibile: nemmeno l'accoppiamento con un uomo chiaramente di sinistra come Martina, scelto da Renzi come suo vice, la sposta di un solo millimetro. Proviamo a riflettere brevemente sulle origini del sentimento dell'odio. L'odio investe l'altro in quanto eterogeneo e inassimilabile. Renzi per la "sinistra sinistra" è l'incarnazione maligna di una eterogeneità che resiste ad ogni assimilazione. Le sue origini culturali e antropologiche sono differenti da quelle del vecchio gruppo dirigente del Pci che è migrato nel Pd. Un'altra cultura, un'altra sensibilità, ma anche un'altra generazione. Il fatto che questo "eterogeneo inassimilabile" sia divenuto, attraverso il legittimo voto delle primarie, il segretario del maggiore partito della sinistra italiana non è stato vissuto come il segno di un arricchimento, di una contaminazione propulsiva, di un superamento degli steccati ideologici, ma come una vera e propria usurpazione. Per questo è insistente — se non drammaticamente compulsivo — l'invito alla discussione interna sulla linea del segretario; invito chiaramente sintomatico che denuncia, a mio giudizio, proprio quel fantasma di usurpazione relativo ad una eterogeneità giudicata, appunto, originariamente e ideologicamente illegittima. Non solo bisogna infinitamente discutere sulla linea del segretario — non solo oggi che il partito è in difficoltà, ma, occorre ricordarlo, sin da quando Renzi ha acquisito legittimamente il suo incarico —, ma si deve continuare a discutere sino a quando questa eterogeneità scandalosa sarà espulsa o ridotta a una posizione minoritaria… La vera ragione di tutto questo odio è la difficoltà della vecchia sinistra di fare il lutto della sua fine storica. Più schiettamente: Renzi è colpevole di avere messo la sinistra di fronte al suo cadavere. Anziché fare il lutto della sua identità ideologica essa preferisce — come spesso accade — imputare all'eterogeno la colpa della sua morte (già avvenuta). È un fenomeno che ricorda il rito tribale di alcune popolazioni dell'Africa nera riportato da Franco Fornari nel suo celebre Psicoanalisi della guerra: di fronte alla morte insensata di un bambino, la tribù afflitta anziché incamminarsi verso la via dolorosa dell'elaborazione del lutto preferisce attribuirne la responsabilità alla popolazione confinante e ai malefici del suo sciamano dichiarandole guerra. Renzi sciamano? L'odio che lo investe vorrebbe coprire la fine di una concezione del mondo che ha nutrito l'interpretazione della storia per tutto il Novecento: la lotta di classe, una concezione etica dello Stato, l'identificazione del liberalismo e dei sui principi come Male, la gerarchia immobile del partito, la prevalenza della Causa universale sulle relazioni di cura particolari, una differenziazione paranoide del mondo in forze del Bene e in forze del Male, l'inclinazione populista e incestuosa della cosiddetta democrazia diretta, la riduzione delle politiche sociali a un maternage assistenzialista, il sospetto verso le manifestazioni della singolarità in tutte le sue forme, un paternalismo insopportabile che cancella le nuove generazioni. La morte irreversibile di questo paradigma imporrebbe un lavoro del lutto estremamente impegnativo. Molto più facile allora imputare al carattere spurio, meticcio, eterogeneo, sciamanico di Matteo Renzi la crisi del Pd e della sinistra in generale che affrontare questo immane e, in realtà, inaggirabile compito.
Viviamo nell’età dell’invidia. Viviamo tempi di sentimenti estremi, dice il pensatore Gunnar Hindrichs. Divisi su tutto. E uniti solo dalla paura e dalla rabbia verso gli altri. Così oggi sono livore e tristezza ad alimentare i populismi, scrive Stefano Vastano il 29 dicembre 2017 su "L'Espresso". Viviamo incollati a i telefonini e alla Rete. Pratichiamo sport estremi, siamo ossessionati da cibi e diete sempre più radicali. E non crediamo a nessun ideale, non investiamo in associazioni né in partiti, corrotti per definizione. Quello che ci unisce è, da una parte, la livida, schiumante rabbia e l’acido dell’invidia verso tutti i potenti del pianeta, politici, manager o artisti che siano. Dall’altra, il panico per il prossimo attacco terroristico, strage di kamikaze solitari o sedicenti fanatici religiosi. «Siamo nell’era degli estremismi diffusi, nel regno dell’assoluta immanenza», esordisce Gunnar Hindrichs, accogliendoci nel suo studio a Basilea. Nel suo ultimo saggio, “Philosophie der Revolution” (“Filosofia della rivoluzione”, edito da Suhrkamp Verlag Ag., e non ancora tradotto in italiano), il giovane filosofo tedesco ha analizzato i motivi che nell’era moderna, dal 1789 al 1917, hanno spinto l’Occidente alle rivoluzioni. Per concludere che «oggi non c’è più alcuna rivoluzione all’orizzonte e manca ogni senso per la trascendenza. Per questo siamo in preda a una confusa spirale di diversi estremismi».
Per lo storico Eric Hobsbawm il ventesimo secolo è stato il Secolo degli Estremi, cioè delle ideologie radicali. Il ventunesimo sarà dunque quello degli Estremismi?
«L’idea di “estremismo” è difficile da definire, ma il ventunesimo secolo si annuncia come un pullulare di tendenze estremistiche che non seguono più, come è accaduto nelle rivoluzioni della modernità, progetti utopici o trascendenti, ma restano legate al piano della realtà immanente. L’era dell’Estremismo è una inversione rispetto a quella delle Rivoluzioni. Sì, viviamo in un diffuso neo-romanticismo, immersi in una pluralità di trend estremi e soggettivi: non a caso Camus, nell’“Uomo in rivolta”, definì i terroristi “i cuori estremi”».
Per Hegel il terrore giacobino era la furia della sparizione: il terrore non segue opere politiche, dice, solo un fare negativo. Il terrorismo islamico si basa sullo stesso nichilistico cupio dissolvi?
«Nella furia della Rivoluzione i giacobini praticano una doppia “sparizione”, sia delle istituzioni e norme che dell’individuo, ghigliottinato senza pietà. Hegel criticava nel Terrore l’idea soltanto negativa della libertà, ma nel terrorismo islamico non vediamo nessuna idea di libertà, né negativa né universale».
Il Rivoluzionario, scrive nel suo libro, non è guidato, come il Conte di Montecristo, da vendette personali: da Robespierre a Lenin al Che, qual è allora l’idea di fondo della rivoluzione?
«Dopo gli attentati dell’11 settembre, il filosofo Sloterdijk ha visto nel terrorista “una malignità senza scopi”, cioè una strumentalità perversa e fine a se stessa. La forza della rivoluzione sta nel creare invece non solo discontinuità rispetto alle norme tradizionali della politica, ma nel rifondare regole nuove per un nuovo contesto sociale. Rivoluzione è la magia dell’inizio e di una nuova praxis dell’agire sociale, così come abbiamo visto all’inizio della rivoluzione russa con i Consigli dei Soviet».
Insieme all’incubo del terrorismo, altro fortissimo estremismo è il potere di Internet nella nostra vita. L’avvento del regno virtuale ha spento l’ardore per una politica rivoluzionaria?
«Non sopravvalutiamo il potere di Internet. Come la stampa nell’era di Gutenberg anche il web sta modificando le nostre vite, ma computer e tastiere non sono certo l’avvio di una vera rivoluzione. Ha ragione Hannah Arendt che nella rivoluzione vedeva all’opera appunto la creazione di nuove regole, come dicevo, per una nuova praxis sociale. E non mi pare che l’uso dei computer produca creatività e trascendenza».
In Rete circolano intanto, ed è un’altra forma di estremismo, moltissime astruse teorie, complotti e congiure, ondate di fake news da far pensare a un nuovo oscurantismo…
«La sociologia americana ha coniato al riguardo l’espressione “Lunatic fringe”, una follia che parte dai margini del sapere e si espande verso il senso comune. Oggi queste zone oscure sono entrate con Donald Trump nel cuore della Casa Bianca e nel centro della società digitale e dell’informazione, cambiando il senso dell’opinione pubblica. L’estremismo oscurantista delle fake news e congiure, travestendosi da “fatti alternativi”, stravolge il pubblico discorso. E di questo trend sono gli estremisti della politica, i populisti, ad approfittarne».
In che modo?
«I nuovi movimenti populisti non sono solo un concentrato di antipolitica, ma “maligni” nel loro attaccare senza posa e vergogna i più deboli, i profughi e le altre minoranze. Il sentimento-guida che spinge oggi i populismi in Europa non è tanto la paura dello straniero o dei profughi e nemmeno l’acido del risentimento di cui parlava Nietzsche, ma l’occhio velenoso dell’invidia».
Può spiegare meglio questo punto?
«Nella grande tradizione di Tommaso d’Aquino l’invidia è la tristezza per l’essere. Da una triste radice velenosa sprizza l’invidia per la vita e per le risorse altrui. I populisti soffiano sull’invidia quando dicono che quelli al potere - la casta - fanno ciò che vogliono o i migranti incassano i nostri soldi. Nell’era degli estremismi il linguaggio della politica e dell’opinione pubblica è pervaso da tristezza e rabbia viscerali, l’opposto del “gaudium entis”, cioè della felicità per l’essere e per la vita propria e altrui».
Siamo diventati dei mesti Paperino nell’era dell’Estremismo, schiumanti di rabbia per le gioie altrui?
«L’invidioso confronta di continuo il suo essere con quello altrui, per questo la propria vita gli appare misera. È da questo humus accidioso che i populismi oggi traggono la loro forza. I movimenti rivoluzionari e operai erano spinti da una forte carica utopica e da una lucida prospettiva nel futuro, mentre la cupa tristezza è il marchio d’identità nell’era degli Estremismi».
«La nostra è un’epoca di estremismi», scriveva anche Susan Sontag: «Viviamo sotto la minaccia di due prospettive spaventose: la banalità ininterrotta e un terrore inconcepibile»...
«Un’analisi perfetta questa della Sontag perché combina, nella loro immanenza, terrore e banalità, e ci consente di superare il luogo comune che nel terrorismo vede una forma, ancorché violenta, di trascendenza. No, l’estremismo terrorista è il gemello della più cruda banalità, l’apoteosi dell’arbitrarietà e della contingenza».
L’Estremismo è un ingrediente anche delle nostre abitudini alimentari: a tavola siamo tutti ossessionati da trend vegani o da diete sempre più spartane.
«Di recente sono stato invitato ad una conferenza per i 100 anni di “Stato e rivoluzione” di Lenin. A cena i più giovani sostenevano la tesi che con la rivoluzione non solo il menù, ma anche il nostro rapporto con gli animali, la carne e il cibo dovrebbe cambiare».
Hanno ragione questi ultra-rivoluzionari?
«No, credo che vi siano degli standard della società borghese dietro i quali non si possa regredire. Lo storico Karl Schlögel ci assicura che anche dopo la rivoluzione del 1917 nei ristoranti di San Pietroburgo menù e camerieri non erano affatto cambiati. Oggi persino tra giovani leninisti colpisce un certo estremismo dell’immanenza».
Una dose di estremismo fa parte della giovinezza: quando pensavano alla Rivoluzione francese i giovani Schelling, Hegel e Hölderlin osannavano una “Kunstreligion”, una Religione dell’arte in grado di spargere armonia nella società. Oggi l’industria della cultura ha riempito ogni città di musei, gallerie e biennali.
«Il mio maestro Rüdiger Bubner coniò la formula di “estetizzazione delle forme di vita” per caratterizzare la massima espansione di arte ed estetica nella nostra vita post-moderna. Anche le forme della protesta, sia nell’estrema destra che sinistra, hanno assunto ora la forma di pseudo feste rivoluzionarie o eventi estetici, come ad esempio al recente G-20 ad Amburgo. I giovani Hegel, Schelling ed Hölderlin sognavano una mitologia della Ragione, ma oggi del sogno rivoluzionario ci è rimasto solo un vago Estremismo estetico, come Negri e Hardt immaginavano nel loro “Impero”».
Ejzenstejn, invece, rivoluzionò il cinema e il montaggio. Majakowski e i poeti russi hanno ricostruito un linguaggio poetico…
«I futuristi russi si sentivano avanguardia di una nuova Bellezza che spingesse verso nuove forme di vita. Non è un caso se nel mio libro non parlo di Stalin: ho scritto un libro sulla filosofia della rivoluzione, non sul suo fallimento».
Anche Gramsci, nei “Quaderni del carcere”, sognava una politica oltre le paludi del senso comune, che spingesse verso il cosiddetto “Buon senso”.
«Il pensiero di Gramsci è essenziale per chiunque voglia articolare una filosofia della rivoluzione. Il “senso comune” a cui Gramsci si riferiva è il dominio dell’immanenza nelle forme estreme che abbiamo analizzato. Contro il quale si erge una prassi utopica, il “buon senso” di Gramsci appunto, che progetta nuove norme della prassi sociale. Oggi non vediamo da nessuna parte una esigenza rivoluzionaria di nuove forme di trascendenza».
A proposito di trascendenza, Robespierre inventò un culto dell’Essere Supremo. Ma il Dio del Rivoluzionario qual è?
«Il Dio della rivoluzione è quello che nella Bibbia (Esodo 3, 14) si presenta in latino come: “Ego sum qui sum”, e nella versione ebraica come “Ehye asher ehye”, e cioè “sarò colui che sarò”. È nella dimensione escatologica della Bibbia e del Dio d’Israele, come ha visto Michael Walzer, la matrice di ogni prassi rivoluzionaria».
L’era degli Estremismi segna il ritorno ad arcaici politeismi?
«I filosofi del postmoderno sentono il politeismo come più scettico, tollerante e pacifista del monoteismo. Ma più che scegliere tra politeismo o monoteismo, la questione è se l’era degli Estremismi abbia davvero un Dio o no».
E lei cosa dice?
«Che il Dio degli Estremismi è una variabile del tutto immanente e dai tratti antropomorfici: un Dio che non è un vero Dio, senza teologia né trascendenza, percepito come mera religione umana. Ma, come diceva Karl Barth, “la religione non è fede”».
Non per niente l’unico feticcio nell’era dell’Estremismo è il Nazionalismo, l’American First di Trump.
«La casa editrice della Nuova Destra tedesca si chiama “Antaios”, da Anteo, il gigante che come ogni nazionalismo trae la sua forza dalla madre Terra, dalle presunte radici o dai confini tellurici della società. Ma persino il cosiddetto “Movimento Identitario’”, la destra radicale, ha nelle sue bandiere una Lambda greca ispirata a un film sugli spartani di Hollywood, l’industria culturale più globale della storia. Un ennesimo segno dell’estremo mix di rabbia, invidia, tristezza e banalità quotidiana in cui siamo totalmente immersi».
L’analisi più suggestiva di Marx è “Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte”, la storia di una rivoluzione fallita, nel ’48, e della deriva autoritaria in Francia. Gli estremismi che circolano oggi in mezza Europa puntano verso nuovi Bonapartismi?
«Quel saggio di Marx è senza dubbio la chiave per capire gli Estremismi del presente. Bonapartismo è l’ambigua unione dei poteri forti con dubbiosi faccendieri e avventurieri, terroristi e criminali. Oggi persino la Faz, il quotidiano dei conservatori, scrive articoli a favore del movimento xenofobo di Pegida, e Afd fa proseliti tra i professori. Ai tempi di Marx la Repubblica francese implodeva nella forma totalitaria del bonapartismo, ed oggi populisti e l’estrema destra osannano Putin, il nuovo “Uomo forte”. A differenza dei tempi di Marx, però, non c’è più alcuna minaccia rivoluzionaria, ma i populisti rileggono il motto di Cicerone “res publica, res populi” in senso illiberale: nel loro estremismo, la Repubblica è proprietà del popolo e non delle sue libere norme ed istituzioni».
We are under a Mediaset. Generation Attack! Scrive Giuseppe Giusva Ricci venerdì 07 luglio 2017 su Next Quotidiano. La tragedia della situazione politica contemporanea (che travalica e fa apparire obsoleti i concetti di destra e sinistra) risiede nel fatto che individui appartenenti alla MediasetGeneration sono approdati a cariche istituzionali in modo naturale per scadenza biologica dei predecessori. Mezzi-adulti educati e cresciuti nel contesto culturale del berlusconismo carico di molteplici retaggi, di varie diramazioni, e di infiniti caratteri seduttivi, questi perenni adolescenti senza passato vivono secondo una coscienza deforme mossa da arrivismo, egoismo, edonismo, cialtronismo e disincanto nei confronti del Sociale, la dimensione imprescindibile del Bene Comune che una volta si poteva definire Società. In un paese culturalmente devastato dall’ognun-per-sé, dove la lotta di classe si è trasformata in invidia di classe – e che Pierpaolo Capovilla compendia così “Dai, vai, uno su mille ce la fa, stai a vedere, che sei proprio tu … sono accadute tante cose ma non è successo niente, che m’importa a me, che t’importa a te, che c’importa a noi … se tuo fratello resta al palo, mandalo affanculo, non aver pietà o rispetto per nessuno, parola d’ordine nutrire l’avvoltoio è dentro di te”** – data la loro formazione diretta o sublimata e la loro appartenenza a questa condizione ormai cristallizzata, gli attuali giovani leader non possono che essere intimamente e forse inconsapevolmente dediti a ways of life pop-nichilisti nei quali l’ambizione determina scelte e posizioni. È plausibile che siano la vanità e l’arrivismo a muoverli e a farli soccombere alle sirene del benessere privato, ossia quei valori che hanno vinto definitivamente con la resa di gran parte della precedente generazione politica contaminata dal berlusconismo perché già segnata irreparabilmente dalla caduta delle Idee e dal trionfo del privilegio e del profitto privato. Le dinamiche delle rottamazioni (in tutti gli apparati) evidentemente fallite, vista la riesumazione di figure quali Berlusconi e Prodi, furono prefigurate da Antonio Gramsci in Quaderni dal carcere [Vol. 4, 1929-1935] con queste parole: “Fare il deserto per emergere e distinguersi […] Nella svalutazione del passato è implicita una giustificazione della nullità del presente: chissà cosa avremmo fatto noi se i nostri genitori avessero fatto questo e quest’altro, ma essi non l’hanno fatto e, quindi, noi non abbiamo fatto nulla di più.” Con l’impostura del giovanilismo usato come paradigma di rinnovamento e basato sul concetto mistificatorio che approssima il vecchio al superato e allo sbagliato, all’interno degli apparati si sono attuate pseudo-rivoluzioni che hanno instaurato un regime della mediocrità. Questo regime supera l’appartenenza alle tradizioni e ai pensieri forti che non solo hanno mosso il Novecento, ma che paiono imprescindibili visto l’andazzo delle disparità economiche che investono oggi, come già prima delle lotte per i diritti, tutti gli ambiti della società reale. Da quando la principale agenzia di educazione-formazione è diventata la TV con le sue divizzazioni di giovani individui qualunque (o con l’enfatizzazione del ruolo dei professionisti dell’intrattenimento), le gioventù hanno assimilato la mistificazione del nuovo secolo, quella che ripone e misura il significato dell’esistenza quasi esclusivamente sulla base del successo pubblico e del relativo denaro ottenibile, sull’arrivismo e sull’individualismo. Nell’introduzione al suo Atlante illustrato della TV (2011), Massimo Coppola, senza definirla, la spiega così: “La generazione formata in quegli anni – quelli dell’affermazione della tv commerciale – non può che essere formata da anime scisse, indecise, forse incapaci di provare davvero piacere […] gente priva di uno straccio di passato cui attaccarsi senza provare rimorso, rabbia, sottile vergogna”. Questa dinamica nel tempo ha formato la MediasetGeneration, che per forza di cose sarebbe approdata, in parte, anche ai gruppi sociali dirigenti composti dagli attuali trentenni/quarantenni:
–Alessandro Di Battista, classe 1978, a 35 anni deputato e leader di Movimento, a 20-22 anni partecipò a provini per Amici di Maria De Filippi spinto da vocazione attoriale.
–Rocco Casalino, classe 1972, a 42 anni responsabile della comunicazione del M5S, a 28 anni partecipò alla prima edizione del Grande Fratello (poi ospite e opinionista di altre trasmissioni Mediaset: Buona Domenica, ecc.).
– Luigi Di Maio, classe 1986, a 27 anni Vicepresidente della Camera e leader di Movimento, con l’avvento della triade Mediaset del 1984 potrebbe avere assistito all’operazione culturale berlusconiana già dalla culla.
– Matteo Salvini, classe 1973, già a 36 anni europarlamentare, oggi leader della Lega, ancora giovanissimo partecipò a telequiz trasmessi dalle reti berlusconiane – nel 1985 (a dodici anni) a Doppio Slalom; nel 1993 (a vent’anni) a Il pranzo è servito.
– Matteo Renzi, classe 1975, a 29 anni Presidente della Provincia di Firenze, a 34 Sindaco di Firenze, a 38 segretario del PD, a 39 Presidente del Consiglio, nel 1994, diciannovenne, partecipò al telequiz di Canale5 La ruota della fortuna.
[A proposito: Hitler: a 36 anni leader del Partito Nazionalsocialista, a 44 Cancelliere del Reich. Stalin: a 43 anni Segretario Generale del Comitato Centrale, a 47 Capo dell’Urss. Mussolini: a 36 Capo del Partito Fascista, a 39 anni Presidente del Consiglio].
Ancora, il 18 ottobre 1975, dalle colonne del Corriere della Sera, Pier Paolo Pasolini scriveva: “Se i modelli son quelli, come si può pretendere che la gioventù più esposta e indifesa non sia criminaloide o criminale? È stata la televisione che ha praticamente concluso l’era della Pietà, e iniziato quella dell’Edonè. Era in cui dei giovani presuntuosi e frustrati a causa della stupidità e insieme dell’irraggiungibilità dei modelli proposti loro, tendono inarrestabilmente a essere o aggressivi fino alla delinquenza o passivi fino all’infelicità”.
Gli esemplari umani recentemente consacrati mediaticamente come personaggi istituzionali e politici (Renzi, Boschi, Serracchiani, Salvini, Di Maio, Di Battista, Meloni, ecc.) sono, prima di tutto, leader mediatici abili nella spettacolarizzazione di se stessi, sono l’incarnazione dell’affermazione dell’Immagine sulla “Statura”, dello Spettacolo sulla Politica, del marketing sull’esperienza. Questi “giovani politici” sono stati graziati dalla logica da Grande Fratello della “nomination”, hanno partecipato al talent show della non-Politica moderna, e hanno vinto (forse). Se siano stati scelti e nominati da chissà quali alte sfere del Dominio, “cupole” anche diverse tra loro, non è dato sapere con certezza, ma i segnali che siano figure compiacenti e collaborative ci sono…
L’appartenenza alla MediasetGeneration in parte li scagiona, perché è mutazione genetica, poiché essi possono essere ritenuti innocenti delle strutture mentali alle quali obbediscono; ambizione e successo. Ma possono essere ritenuti inconsapevoli dell’arroganza generazionale, del modernismo scalpitante, e del superomismo che li descrive nel loro carrierismo data l’appartenenza alla società dell’opulenza?
Fascisti su Facebook, ecco i gruppi segreti con cui la galassia nera fa proseliti sul web. Si moltiplicano le pagine dove si incita all’odio e alla violenza in nome dell’ideologia, scrive Arianna Giunti il 6 dicembre 2017 su "L'Espresso". Dio, patria e famiglia. E poi valanghe di sterco che si riversano sui "negri", sugli "zingari", sulle "zecche rosse” e sugli "ebrei maiali". Odio feroce alimentato da tonnellate di fake news, notizie false proprio come i siti che le ospitano. Saluti romani che partono dalle braccia di chiunque: video amatoriali che immortalano ignari bambini che eseguono inconsapevolmente il saluto fascista sotto la guida di papà e anziani spinti dai nipoti a scimmiottare l’antico gesto che rimanda al ventennio di morte e persecuzione. E c’è persino un uomo che indossa un saio da frate francescano, che intona Faccetta Nera e che conclude la sua performance con il braccio teso rivolto alla videocamera che lo sta riprendendo. Il fascismo non muore mai. E proprio quando si crede di averlo sconfitto rinasce ancora più forte e più isterico nel web, terreno fertile per estremismi di ogni sorta e impermeabile ai controlli. Hanno nomi evocativi: “A noi”, “Semper Fidelis”, “Fascisti del Terzo Millennio”, “Benito Mussolini ha fatto grande l’Italia”, “Io non ho tradito”, “Fieri di essere fascisti”, “Rivoluzione fascista”. Su Facebook vantano decine di migliaia di iscritti. Alcuni di loro si professano antirazzisti, ma sanno scrivere solo frasi di incitazione all’odio e alla violenza. Altri non perdono neppure tempo a nasconderlo: predicano la difesa della razza. Sono i gruppi segreti dove si inneggia al fascismo. Crescono alla velocità della luce. Lì dentro si pubblicano fotografie di armi e munizioni che gli utenti custodiscono nelle loro case “per difendersi dagli immigrati” e per “preparare la rivoluzione”. Si comprano gadget e bandiere. Si fa propaganda, si augura la morte ai politici e si invita a profanare le tombe dei loro familiari. Si diffondono notizie false e si incita alla violenza. I neofascisti non aprono la porta a chiunque: per essere accettati bisogna saper rispondere alle loro domande e dimostrare di condividere, con la comunità virtuale, ideali e valori ispirati al Ventennio. E così l’Espresso ha provato a verificare di persona. Il risultato è stato agghiacciante.
LA BANDIERA DEL REICH. Le bandiere con il fascio littorio e la croce celtica sono di casa. E anche il vessillo della Marina prussiana, lo stesso stendardo al centro delle polemiche che un giovane carabiniere ha appeso nel suo alloggio all’interno della caserma Baldissera del Battaglione dei Carabinieri Toscana. Una bandiera che effettivamente da un punto di vista storico nulla ha a che vedere con il Terzo Reich, ma che viene abitualmente sventolata dai neonazisti durante le manifestazioni pubbliche. “Onore al Carabiniere camerata!” scrive poche ore fa uno degli amministratori del gruppo “Fascisti del Terzo Millennio” pubblicando una gigantografia della bandiera incriminata. “Uno dei nostri, ti siamo vicini”, “Seigh heil camerata!”, rispondono all’unisono gli altri utenti. Poi però ai neofascisti la situazione scappa la mano. Fino al punto da strumentalizzare le divise dell’Arma pubblicando una foto di repertorio di carabinieri mentre fanno il saluto militare accompagnata alla frase “Siamo pronti per la marcia su Roma”. La galassia nera delle comunità web fascista è vastissima. Molti dei gruppi sono collegati fra di loro. A fare da ponte sono gli utenti più fedeli, che segnalano gli “infiltrati” e le persone che secondo loro sono sospette, quelle che loro chiamano le “zecche rosse”. Per chi veste la divisa, poi, la situazione è delicatissima. Perché fra i frequentatori di queste stanze virtuali ci sono anche alcuni appartenenti alle forze dell’ordine. Ogni volta che inneggiano al fascismo macchiano l’uniforme che indossano, sporcando e trascinando nel fango anche l’istituzione che rappresentano. Come succede nella pagina “Sostenitori delle Elite Forze Armate” - frequentato assiduamente da militari - dove ogni 25 aprile si rinnega la festa della Liberazione.
BAMBINI, PRETI E ANZIANI. Fra le mura virtuali del gruppo “A noi!” gli utenti pubblicano in maniera compulsiva fotografie di se stessi mentre fanno il saluto romano, nell’intimità delle loro case. Qualcuno, per ottenere consenso dalla comunità virtuale, mostra video di bambini - i propri figli - ai quali viene fatto tendere i braccio in un grottesco saluto romano, accompagnato dalla didascalia “piccolo Balilla”. E c’è anche chi nelle usanze neofasciste coinvolge pure la nonna ultra novantenne, immortalata in un video in cui con il braccio teso dice “Eia eia alalà” sotto la guida del nipote. Alcuni utenti, in casa, hanno imbastito altarini alla memoria del Duce, adornati con fiori e lumini. Altri, pubblicano fotografie di pellegrinaggi a Predappio e si fanno vedere impegnati nella manutenzione di quella che sembra una cappella intitolata a Benito Mussolini. E la galleria non è finita. Compare persino il video di un uomo vestito con un saio, che a prima vista sembrerebbe un frate francescano, mentre intona l’inno fascista “Faccetta Nera” e poi tende il braccio. Del resto, per la maggiore vanno anche le video-omelie di padre Giulio Tam, il prete neofascista vicino a Forza Nuova - già scomunicato dal Vaticano - inneggianti al dittatore che trascinò l’Italia nel pantano della Seconda Guerra Mondiale e che firmò le leggi razziali mandando a morire migliaia di ebrei.
"MAIALI EBREI". Perché non c’è solo il razzismo alimentato da tragicomiche fake news a tenere uniti i membri di queste galassie neofasciste. I bersagli sono soprattutto i politici. Il firmatario del disegno di legge che mira a introdurre il reato di propaganda nazista e fascista, Emanuele Fiano, è in cima alla lista. Nelle immagini dei gruppi neofascisti viene spesso raffigurato come una caricatura oscena e ritratto a testa all’ingiù. Nel gruppo “Non ho tradito!” gli utenti sono scatenati. Pubblicano una foto di Fiano - il cui padre Nedo fu deportato ad Auschwitz - e poi incitano i membri del gruppo a latrare come cani inferociti. “Faccia da ebreo”, “muori”, “distruggiamo le tombe della sua famiglia!”, "cominciamo dalla tomba di sua madre", sono solo alcuni dei commenti che i frequentatori dei gruppi vomitano nel muro virtuale. L'odio é rivolto non solo verso il politico di origini ebraiche, ma nei confronti dell'intera "razza infame". "Giudei", urla un ragazzo che avrà sì e no 30 anni, "maiali, quelli non sono italiani". Alla presidente della Camera Laura Bordini non va meglio. Gli utenti la buttano sulle offese a sfondo sessuale, augurandole di subire stupri e violenze di ogni sorta. Nel gruppo “Fascisti del Terzo Millennio” viene spesso ritratta con un fotomontaggio dove un bambino con la divisa dei Balilla le urina addosso.
PROSELITISMO SUL WEB. Il tema su cui i gruppi che inneggiano al fascismo batto il ferro, caldissimo, è quello della sicurezza. Gli utenti pubblicano continuamente fotografie di armi e di munizioni che custodiscono i casa e incitano anche gli altri a farsi giustizia da sé. “Negro, se vieni in casa mia ti aspetta un bel regalo”, scrive uno dei membri del gruppo “A noi!” pubblicando la foto di un cestino pieno di proiettili ancora incartati. “Lo Stato se ne frega di noi”, ribatte un altro ospite, mostrando l’immagine di una pistola semiautomatica a suo dire “ritoccata”. Ma lo scopo di questi gruppi Facebook è soprattutto il proselitismo, che attraverso il web corre alla velocità della luce. Alcuni di loro sono sostenitori dei movimenti Casa Pound e Forza Nuova. Si approfittano dello stato di indigenza e di insoddisfazione che ha travolto molti giovanissimi, e la povertà diventa l’humus ideale per far crescere l’odio e dare vita a una fantomatica “rivoluzione”. E così organizzano raccolte di viveri che poi distribuiscono nei quartieri più problematici, da Milano a Palermo. Mostrano le foto dei pacchi di pasta e dei generi alimentari che i “bravi fascisti” consegnano solo, rigorosamente, agli italiani. Atti di generosità, si suppone, che verranno ricambiati in cabina elettorale.
Pugni, insulti e cinghiate: i fascisti sono tornati a far paura. Negli ultimi mesi sono aumentate esponenzialmente violenze, blitz, pestaggi. I responsabili, il più delle volte, appartengono a gruppi di estrema destra. I bersagli: migranti, Ong, militanti di sinistra, scrive Federico Marconi il 28 luglio 2017 su "L'Espresso". Pestaggi, blitz, aggressioni. La violenza è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi mesi. E la matrice è, spesso, la stessa: l’estrema destra, che sta tornando più prepotente che mai. In alcuni casi i responsabili sono ancora ignoti, ma i bersagli no: sono gli stessi contro cui si scagliano i neofascisti. 6 dicembre 2016. San Basilio, quartiere della periferia est della capitale, si rivolta contro una famiglia marocchina. «Un episodio di profondo degrado morale e civile» commentano dal Campidoglio. Una trentina di residenti ha aggredito la famiglia, legittima assegnataria della casa popolare, in difesa degli occupanti abusivi dell’alloggio: «Non vogliamo i negri, andate via con i barconi». A supportare i riottosi Forza Nuova: «Sosterremo con forza la rivolta popolare per la difesa di Roma contro chi vuole farci diventare minoranza a casa nostra». L'inchiesta di copertina sull'estrema destra che conquista nuovi consensi soffiando sul fuoco della crisi economica e dei flussi migratori: un viaggio nelle istituzioni in cui entrano partiti neofascisti e nel mondo criminale in cui i "neri" la fanno da padrone (e non vengono mai puniti). Con l'anno nuovo, si ricomincia. 21 gennaio 2017, Noi con Salvini e Fratelli d’Italia manifestano contro l’ordinanza con cui la sindaca Raggi destina il Ferrhotel, albergo in disuso vicino la stazione Tiburtina, all’accoglienza dei migranti. Tra i partecipanti la deputata della Lega Nord Barbara Saltamartini. Al termine della manifestazione Forza Nuova e Roma ai Romani occupano la struttura: «Contro i migranti siamo pronti alle barricate». Passano tre giorni. 24 gennaio: Forza Nuova, CasaPound e Roma ai Romani impediscono a una famiglia di egiziani di prendere possesso di una casa popolare dopo lo sgombero degli occupanti, ancora una volta italiani e abusivi: «Non molleremo un centimetro» dichiara Giuliano Castellino, portavoce di Roma ai Romani. Il primo pestaggio il 2 febbraio, a Ostia. «Mi hanno accerchiato, gettato in terra e preso a calci, i passanti non hanno fatto nulla per fermarli». Fuori dal palazzo municipale viene aggredito un attivista di una Onlus che si occupa di migranti. Poco distante un sit-in di CasaPound, Fratelli d’Italia e Noi con Salvini. I partecipanti alla manifestazione negano tutto, ma la Polizia cerca tra loro i responsabili dell’accaduto. Neanche dieci giorni dopo una nuova vittima. Nel viterbese alcuni militanti di CasaPound effettuano una “spedizione punitiva” contro Paolo, ragazzo ventiquattrenne colpevole di aver condiviso su Facebook una vignetta satirica che recitava «Chi mette il parmigiano sulla pasta col tonno non merita rispetto». «Fatti i cazzi tuoi, non prendere in giro CasaPound» gli urlano tra un pugno e una cinghiata. Tra i responsabili c’è Jacopo Polidori, dirigente della sezione viterbese del movimento di estrema destra. Il 20 ottobre inizierà il processo a suo carico. Non solo Roma, la violenza arriva anche a Milano. Nel pomeriggio del 1 aprile, militanti di Forza Nuova effettuano un blitz “con mazze e caschi” al centro sociale Gta. In serata venticinque militanti di CasaPound aggrediscono un componente della Rete degli studenti. Il ragazzo viene inseguito, spintonato e gettato nel Naviglio tra insulti e sputi. Saluti romani e croci celtiche il 25 aprile al cimitero Maggiore di Milano: l’ultradestra commemora i caduti della Repubblica di Salò, beffando la Prefettura che aveva proibito la manifestazione. I mille fascisti presenti al cimitero raddoppiano nel pomeriggio, al raduno sotto la chiesa dei Santi Nereo e Achille. È presente tutto il gotha dell’estrema destra italiana: non solo Forza Nuova, CasaPound e Lealtà Azione, ma anche Zeta Zero Alfa e Hammerskin. Momenti di tensione al Campo 10 del cimitero Maggiore di Milano: alcuni antifascisti, dopo la commemorazione ai partigiani caduti durante la Liberazione, sono stati verbalmente attaccati da militanti di estrema destra arrivati al Campo per rendere omaggio ai loro morti. Al termine del diverbio, uno di loro ha alzato il braccio per il saluto romano e ha urlato "fascisti sempre". Come prevedeva il divieto della Prefettura, non si è svolta una cerimonia ufficiale per i caduti dell'Rsi, ma ognuno di loro ha portato un saluto in forma privata (di Giulia Costetti). A maggio continuano i blitz. Giovedì 4 Forza Nuova effettua una “irruzione pacifica” nella sede dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni a Roma. “La prossima volta potremmo non essere altrettanto teneri” afferma il portavoce Alessio Costantini. Il 6 maggio un nuovo blitz, questa volta a Prato. Al grido di “Ong scafiste” un gruppo di militanti di Movimento Nazionale e Gioventù Identitaria fa irruzione al Festival Mediterraneo Downtown organizzato dalla Ong Cospe. L’estate scalda gli animi dell'estrema destra. Il 15 giugno Forza Nuova protesta sotto Palazzo Madama contro lo Ius Soli: «Ormai è guerra aperta. In questo momento un manipolo di guerrieri sono schierati qui in piazza. La legge non passerà, o sarà battaglia in tutta Italia» è scritto in un post su Facebook del movimento neofascista. La polizia utilizza gli idranti per respingere la manifestazione non autorizzata: a fine giornata sono 64 i forzanovisti identificati e denunciati. Protesta contro lo Ius soli e saluto fascista: così l'estrema destra decide di manifestare il proprio dissenso alla legge in discussione al Senato. Dopo il sit in a Palazzo Madama con CasaPound, Forza Nuova sceglie di marciare per la città invocando il Duce. Tra i blindati della polizia, braccia tese intorno a piazza Cavour, sulle note di "Camicia nera la trionferà". Al termine del corteo 50 persone sono state denunciate per manifestazione non autorizzata, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e apologia di fascismo. Di Giulia Torlone. Appena cinque giorni dopo, il 20 giugno, un diciottenne romano viene aggredito con un tubo di metallo perché “zecca comunista”: è colpevole di indossare una maglietta del Cinema America occupato. Il giorno dopo, fuori da un circolo Arci di Pescara, due ragazzi vengono aggrediti da una coppia di uomini, che alle forze dell’ordine dichiarano di essere “fascisti e razzisti”. Il 28 giugno a Perignano, paesino in provincia di Pisa, Forza Nuova fa un blitz contro il prete che ha ospitato la festa di fine Ramadan nei locali della Chiesa. Il giorno dopo, a Milano, caos a Palazzo Marino, sede del Comune: prima CasaPound irrompe a braccia tese in aula consiliare per chiedere le dimissioni del sindaco Sala, poi sfiora la rissa con alcuni gruppi dei centri sociali fuori dal palazzo del Comune. Irruzione di un gruppo di militanti di CasaPound in Consiglio comunale a Milano, con tanto di saluti romani e la richiesta gridata di dimissioni rivolta al sindaco, Beppe Sala, dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta sugli appalti Expo. "Ferma condanna rispetto ad azioni sqaudriste, che dimostrano come questi signori non conoscano altro che la violenza. Nelle istituzioni democratiche, nella città Medaglia d'oro della Resistenza, non c'è spazio per questi disgustosi rigurgiti fascisti" è il commento del segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati. E l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino sul suo profilo Facebook ha scritto: "Già Beppe mi piaceva come sindaco. Da oggi che lo hanno contestato quattro pirla di CasaPound mi piace ancora di più" (video dalla pagina Facebook di Casa Pound). Il 30 giugno, mentre il neosindaco di Genova Marco Bucci dichiarava «Casapound ha diritto ad aprire una sede», a Roma accadeva di tutto. A Tor Bella Monaca un 52enne bengalese veniva picchiato da quattro ragazzi italiani perché destinatario di una casa popolare. Nel frattempo CasaPound manifestava fuori dal centro di accoglienza della Croce Rossa di via del Frantoio. Chissà se qualcuno di loro ha presenziato la sera alla Festa del Sole, organizzata dal gruppo di ultradestra Lealtà Azione. La formazione nata nel 2011, oggi egemone nel panorama dell’estrema destra lombarda, ha tra i fondatori l’assessore allo Sport di Monza Andrea Arbizzoni, eletto tra le fila di Fratelli d’Italia. Il “senatore” Arbizzoni, come viene chiamato a Monza, è già stato assessore nella precedente giunta leghista. Alla due giorni di incontri e conferenze quest’anno ha partecipato Alfredo Mantica, già senatore nelle fila di An e Pdl e sottosegretario agli Esteri nel II e III governo Berlusconi. La destra moderata ha sempre partecipato alla manifestazione, non perdendo l'occasione di dialogare con i neonazisti. Nel 2015, oltre al vicepresidente di CasaPound Simone Di Stefano, parteciparono Carlo Fidanza, allora membro dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia, Giulio Gallera, consigliere regionale lombardo di Forza Italia, fra i fondatori del partito nel 1994, e Igor Iezzi, segretario della Lega Nord nella provincia di Milano.Festa del Sole 2017L’onda nera arriva anche in Calabria. Il 1 luglio a Riace, la città calabrese considerata nel mondo un’eccellenza nell’accoglienza ai migranti, ha luogo una manifestazione delle destre contro la politica d’accoglienza del sindaco Mimmo Lucano. Per contrastare l’accoglienza dalle parole si passa ai fatti: il 4 luglio a Vobarno, in provincia di Brescia, una molotov viene lanciata contro un hotel che si preparava ad ospitare dei migranti. In quella stessa notte Casapound affiggeva lo striscione “Profughi finti, soldi veri”. Con il caldo le strade non bastano più. E Casapound, il 9 luglio, va in spiaggia a Ostia per "cacciare" i venditori ambulanti abusivi che «fanno concorrenza sleale ai concessionari degli stabilimenti». «Sono atti di forza che non possono essere tollerati» ha dichiarato il commissario di Ostia Domenico Vulpiani dopo il blitz in spiaggia di CasaPound. Ronde in spiaggia a caccia di ambulanti abusivi stranieri. A organizzarle, due giorni fa, sono stati i militanti di CasaPound di Ostia che, vestiti con pettorine rosse, sono scesi sull’arenile di ponente contro "i venditori abusivi che – spiega nel video Luca Marsella, responsabile di Cpi sul lido di Roma – oltre a cianfrusaglie di dubbia provenienza, vendono anche bibite facendo concorrenza sleale ai legittimi concessionari delle strutture che invece sono sovente tartassati da controlli di vigili". Un classico argomento della propaganda dell’estrema destra, secondo cui gli stranieri sono favoriti rispetto agli italiani. Il blitz si inserisce anche nella campagna elettorale che "i fascisti del terzo millennio" hanno iniziato in vista del voto, a novembre, al Municipio di Ostia, commissariato per infiltrazioni mafiose da quasi due anni. Nel giorno del 25° anniversario della strage di via D'Amelio, l'estrema destra protesta a Latina contro la decisione del sindaco di cambiare il nome del Parco "Arnaldo Mussolini", fratello del Duce, in "Falcone e Borsellino". Il 19 luglio, alla presenza della presidente della Camera Laura Boldrini, un folto numero di militanti di CasaPound, Forza Nuova e Fratelli d'Italia è sceso in piazza contro la nuova intitolazione. Tra fischi e braccia tese. È solo l'ultima manifestazione di un'estrema destra che sta tornando e promette «non sarà più tenera».Si è tenuta a Latina la cerimonia di intitolazione del Parco Comunale a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati uccisi dalla mafia venticinque anni fa. Alla cerimonia nella città laziale voluta da Mussolini dopo la bonifica nell'agropontino hanno partecipato molte persone, ma anche decine di contestatori che hanno intonato slogan fascisti indirizzati alla Presidente della Camera. Boldrini è ritornata sulla polemiche che la accusavano di voler abbattere i monumenti dell'epoca fascista: ''Non ho mai detto quelle parole, chi dice il contrario dice menzogne'' servizio di Fabio Butera.
Un anno di violenza fascista. Nel 2017 l'estrema destra ha rialzato la testa. Dai piccoli paesini di provincia alle grandi città. E sempre più spesso blitz, aggressioni e pestaggi hanno fatto da contraltare a propaganda, manifestazioni e cortei. A dimostrazione di come oggi questi gruppi, movimenti e partitini si sentano in grado di poter dire e fare di tutto, scrive Federico Marconi il 29 dicembre 2017 su "L'Espresso". Pestaggi, blitz, aggressioni. La violenza è aumentata in maniera esponenziale nell’ultimo anno. E la matrice è sempre la stessa: l’estrema destra, che è tornata più prepotente che mai. In alcuni casi i responsabili sono ancora ignoti, ma i bersagli no: “sporchi negri”, “zecche” e “froci”. Pugni e cinghiate, insulti e intimidazioni. Dall’inizio dell’anno le azioni “dimostrative” di gruppi neonazisti e neofascisti sono cresciute in maniera esponenziale. E hanno avuto luogo in tutta Italia, dalle grandi città come Roma e Milano, alle più piccole, come Vignanello in provincia di Viterbo. Una spirale di violenza che è stata più volte denunciata sulle pagine dell'Espresso. E che dimostra come oggi questi gruppi, movimenti e partitini, si sentano in grado di poter dire e fare tutto. In un clima in cui, sempre più spesso, queste azioni vengono considerate solamente note di colore. 2017: UN ANNO NERO.
8 dicembre. "Questa va trovata". "Dobbiamo darle una lezione". "Zoccola comunista". La giornalista Arianna Giunti è stata pesantemente insultata e minacciata dopo la pubblicazione di un'inchiesta sui gruppi segreti dei fascisti su Facebook. Pagine in cui si incita all'odio e alla violenza in nome di "Dio, patria e famiglia" .
6 dicembre. Una squadraccia composta da una dozzina di persone sotto la redazione dell'Espresso e di Repubblica. Mascherate, con fumogeni e bandiere nere. Un blitz con cui il partito neofascista Forza Nuova prova a intimidire la nostra testata "colpevole" di dedicare troppa attenzione agli affari della galassia nera italiana e alla storia del segretario di Fn Roberto Fiore. In un comunicato pubblicato su Facebook dopo il raid, i neofascisti non abbassano il tiro: «Oggi è stato solo il "primo attacco" contro chi diffonde il verbo immigrazionista, serve gli interessi di Ong, coop e mafie varie. Questi infami sappiano che non gli daremo tregua, li contesteremo ovunque». E le minacce sul web sono continuate anche nei giorni successivi: «Basta! Oggi boicottaggio, domani esecuzione!» . Una dozzina di persone mascherate, con fumogeni e bandiere, sotto la redazione de l'Espresso e di Repubblica. È l'azione intimidatoria messa in piedi dal partito neofascista di Forza Nuova all'interno della sua campagna di boicottaggio alle testate del nostro gruppo editoriale che nelle ultime settimane hanno dedicato un'ampia serie di inchieste agli affari e agli uomini dell'estrema destra italiana. Il gruppetto è stato accolto dai fischi dei giornalisti.
28 novembre. A Como quindici naziskin del Veneto Fronte Skinhead effettuano un blitz durante una riunione di un’associazione pro migranti. Leggono un comunicato che denuncia la "deriva immigrazionista" in corso in Italia davanti agli aggrediti che non rispondono alla provocazione. Non è l'unico caso. Durante la riunione di Como Senza Frontiere, una rete che unisce decine di associazioni a sostegno dei migranti - al Chiostrino di Santa Eufemia - un gruppo di 15 militanti del VFS, associazione culturale Veneto fronte Skinheads, è entrato nella sala e ha imposto la lettura di un "proclama" che si concludeva con lo slogan "basta invasione". Le decine di partecipanti alla riunione - esterrefatti – non hanno reagito alla provocazione. Il blitz segue le iniziative di tre giorni fa, sempre a opera del VFS, sempre a Como: sagome di migranti dipinte a terra di fronte alle sedi Caritas.
25 novembre. A Medole, sedici naziskin del Vfs hanno fatto irruzione in un dibattito a cui partecipavano la giovane scrittrice Chaimaa Fatihi e il sindaco Ruzzenenti. «Siamo contro questo ennesimo e solito teatrino dei burattini e si oppone allo sdoganamento di una politica sempre più immigrazionista che non perde occasione per ricamare le solite propagande pro-ius soli» dichiara un esponente del gruppo.
7 novembre. A Ostia Daniele Piervincenzi, inviato della trasmissione di Rai2 Nemo, e l’operatore Edoardo Anselmi sono state vittime di una aggressione a Ostia. Uno degli episodi che più hanno indignato l’opinione pubblica. Il protagonista è Roberto Spada, appartenente all’omonimo clan di Ostia e fratello di Carmine, condannato a 10 anni per estorsione con aggravante del metodo mafioso. Piervincenzi e Anselmi stavano chiedendo a Spada dei suoi rapporti con CasaPound – in particolare con Luca Marsella e Carlotta Chiaraluce - e dell’appoggio dato al movimento neofascista nel corso della campagna elettorale. Spada, indispettito dalle domande, sferra una testata al giornalista e poi aggredisce l’operatore con una spranga. Piervincenzi ha riportato la frattura del setto nasale. Daniele Piervincenzi, inviato del programma di Rai2 Nemo, è stato colpito al volto con una violenta testata da Roberto Spada, titolare di una palestra e fratello del boss Carmine, condannato a 10 anni di carcere. Piervincenzi, che stava incalzando Spada sul suo "endorsement" per il candidato di Casapound Luca Marsella, ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato sottoposto a un intervento d'urgenza. Durante l'aggressione, Spada ha utilizzato anche una mazza con la quale ha colpito anche l'operatore della troupe. Sul suo profilo Facebook, Spada ha poi riportato la sua versione dei fatti.
29 ottobre. A Roma, nella centralissima Piazza Cairoli, Kortik Chondro è stato aggredito. La sua colpa? Quella di essere uno «sporco negro». È questo che gli urlano i cinque giovanissimi aggressori – hanno tutti tra i 17 e i 19 anni - mentre lo riempiono di calci e pugni. Uno di loro, alla fine del pestaggio, torna indietro per sferrare un calcio in faccia all’ormai inerme Chondro, 27 enne originario del Bangladesh. Tutti i componenti del branco sono stati fermati dalla polizia un’ora dopo il pestaggio e accusati di lesioni gravissime. Alessio Manzo, il ragazzo che ha colpito il bengalese al volto, è accusato anche di tentato omicidio. Manzo è legato alla galassia dell’estrema destra romana: Forza Nuova, Roma ai Romani, Lotta Studentesca. Con il gruppo di Giuliano Castellino ha partecipato alle manifestazione dello scorso 29 settembre al Trullo.
22 ottobre. Razzismo e fascismo si riaffacciano allo stadio. All’Olimpico, durante Lazio-Cagliari sono stati attaccati in Curva Sud degli adesivi che ritraggono Anna Frank con la maglia giallorossa. E non solo, il settore è stato riempito di sticker che recitano "Romanista frocio", "Romanista ebreo", "Romanista Aronne Piperno". Un vergognoso episodio antisemita di alcuni tifosi biancocelesti.
28 settembre. Al Corviale, periferia sud della Capitale, Forza Nuova e Roma ai Romani si sono uniti ai residenti per opporsi allo sgombero di una famiglia italiana che occupava abusivamente un alloggio popolare. I manifestanti hanno poi voluto impedire l’ingresso dei nuovi legittimi assegnatari, una famiglia italo-eritrea. Sono intervenute le forze dell’ordine, a cui i neofascisti hanno risposto con una sassaiola. Tre agenti sono rimasti feriti, e tre persone sono state fermate. Tra queste Giuliano Castellino, leader del movimento Roma ai Romani, considerato da Forza Nuova come un “prigioniero politico”.
5 agosto. Le squadracce non si sono prese neanche qualche giorno di vacanza. Nel pieno centro di Mantova, un gruppo di cinque ragazzi e ragazze, noti per la loro appartenenza a gruppi di estrema destra, hanno effettuato una spedizione punitiva nei confronti di Lorenzo. È “colpevole” di simpatizzare per la sinistra.
19 luglio. Nel giorno del 25° anniversario della strage di via D'Amelio, l'estrema destra protesta a Latina contro la decisione del sindaco di cambiare il nome del Parco "Arnaldo Mussolini", fratello del Duce, in "Falcone e Borsellino". Tra fischi e braccia tese, un folto numero di militanti di CasaPound, Forza Nuova e Fratelli d'Italia è sceso in piazza contro la nuova intitolazione.
9 luglio. Con il caldo le strade non bastano più. E Casapound allora va in spiaggia a Ostia per "cacciare" i venditori ambulanti abusivi che «fanno concorrenza sleale ai concessionari degli stabilimenti». «Sono atti di forza che non possono essere tollerati» ha dichiarato il commissario di Ostia Domenico Vulpiani dopo il blitz in spiaggia di CasaPound. Ronde in spiaggia a caccia di ambulanti abusivi stranieri. A organizzarle, due giorni fa, sono stati i militanti di CasaPound di Ostia che, vestiti con pettorine rosse, sono scesi sull’arenile di ponente contro "i venditori abusivi che – spiega nel video Luca Marsella, responsabile di Cpi sul lido di Roma – oltre a cianfrusaglie di dubbia provenienza, vendono anche bibite facendo concorrenza sleale ai legittimi concessionari delle strutture che invece sono sovente tartassati da controlli di vigili". Un classico argomento della propaganda dell’estrema destra, secondo cui gli stranieri sono favoriti rispetto agli italiani. Il blitz si inserisce anche nella campagna elettorale che "i fascisti del terzo millennio" hanno iniziato in vista del voto, a novembre, al Municipio di Ostia, commissariato per infiltrazioni mafiose da quasi due anni.
4 luglio. A Vobarno, in provincia di Brescia, una molotov viene lanciata contro un hotel che si preparava ad ospitare dei migranti. In quella stessa notte Casapound affiggeva lo striscione “Profughi finti, soldi veri”.
1 luglio. L’onda nera arriva anche in Calabria. A Riace, la città calabrese considerata nel mondo un’eccellenza nell’accoglienza ai migranti, ha luogo una manifestazione delle destre contro la politica d’accoglienza del sindaco Mimmo Lucano.
30 giugno. A Tor Bella Monaca un 52enne bengalese veniva picchiato da quattro ragazzi italiani perché destinatario di una casa popolare. Nel frattempo CasaPound manifestava fuori dal centro di accoglienza della Croce Rossa di via del Frantoio. "Vattene via, questa casa non è per te": un bengalese è stato aggredito da quattro ragazzi, che lo hanno insultato, scacciato a calci e pugni, mentre era andato a vedere la casa popolare che gli era stata assegnata dal Comune di Roma a largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca. È accaduto lunedì scorso e la vittima, Howlader Dulal, 52 anni, cittadino italiano di orgine bengalese, ha denunciato l'aggressione agli agenti del commissariato Casilino, che hanno avviato le indagini. Al vaglio le telecamere della zona ed eventuali testimonianze.
29 giugno. Caos a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano: prima CasaPound irrompe a braccia tese in aula consiliare per chiedere le dimissioni del sindaco Sala, poi sfiora la rissa con alcuni gruppi dei centri sociali fuori dal palazzo. Scontri davanti al Comune di Milano, tra militanti di sinistra - appartenenti al movimento ''Nessuno è illegale'' e un gruppo di attivisti di CasaPound. La delegazione dell'associazione, legata ai centri sociali, era stata invitata dal Capo di Gabinetto del sindaco di Milano, mentre i manifestanti di CasaPound avevano organizzato un blitz per chiedere le dimissioni di Sala. L'incontro tra i due gruppi è degenerato in scontri sia all'interno che all'esterno di Palazzo Marino, dove è intervenuta la polizia. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell'organizzazione.
28 giugno. A Perignano, paesino in provincia di Pisa, Forza Nuova fa un blitz contro il prete che ha ospitato la festa di fine Ramadan nei locali della Chiesa.
21 giugno. Fuori da un circolo Arci di Pescara, due ragazzi vengono aggrediti da una coppia di uomini, che alle forze dell’ordine dichiarano di essere “fascisti e razzisti”.
20 giugno. Un diciottenne viene aggredito a Roma con un tubo di metallo perché “zecca comunista”: è colpevole di indossare una maglietta del Cinema America occupato.
15 giugno. Forza Nuova protesta sotto Palazzo Madama contro lo Ius Soli: «Ormai è guerra aperta. In questo momento un manipolo di guerrieri sono schierati qui in piazza. La legge non passerà, o sarà battaglia in tutta Italia» è scritto in un post su Facebook del movimento neofascista. La polizia utilizza gli idranti per respingere la manifestazione non autorizzata: a fine giornata sono 64 i forzanovisti identificati e denunciati. Protesta contro lo Ius soli e saluto fascista: così l'estrema destra decide di manifestare il proprio dissenso alla legge in discussione al Senato. Dopo il sit in a Palazzo Madama con CasaPound, Forza Nuova sceglie di marciare per la città invocando il Duce. Tra i blindati della polizia, braccia tese intorno a piazza Cavour, sulle note di "Camicia nera la trionferà". Al termine del corteo 50 persone sono state denunciate per manifestazione non autorizzata, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e apologia di fascismo. Di Giulia Torlone.
6 maggio. Al grido di “Ong scafiste” un gruppo di militanti di Movimento Nazionale e Gioventù Identitaria fa irruzione al Festival Mediterraneo Downtown organizzato dalla Ong Cospe a Prato.
4 maggio. Forza Nuova effettua una “irruzione pacifica” nella sede dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni a Roma. “La prossima volta potremmo non essere altrettanto teneri” afferma il portavoce Alessio Costantini.
25 aprile. Saluti romani e croci celtiche al cimitero Maggiore di Milano: l’ultradestra commemora i caduti della Repubblica di Salò, beffando la Prefettura che aveva proibito la manifestazione. I mille fascisti presenti al cimitero raddoppiano nel pomeriggio, al raduno sotto la chiesa dei Santi Nereo e Achille. È presente tutto il gotha dell’estrema destra italiana: non solo Forza Nuova, CasaPound e Lealtà Azione, ma anche Zeta Zero Alfa e Hammerskin. Momenti di tensione al Campo 10 del cimitero Maggiore di Milano: alcuni antifascisti, dopo la commemorazione ai partigiani caduti durante la Liberazione, sono stati verbalmente attaccati da militanti di estrema destra arrivati al Campo per rendere omaggio ai loro morti. Al termine del diverbio, uno di loro ha alzato il braccio per il saluto romano e ha urlato "fascisti sempre". Come prevedeva il divieto della Prefettura, non si è svolta una cerimonia ufficiale per i caduti dell'Rsi, ma ognuno di loro ha portato un saluto in forma privata. Di Giulia Costetti. 1 aprile. Militanti di Forza Nuova effettuano un blitz “con mazze e caschi” al centro sociale Gta di Milano. In serata venticinque militanti di CasaPound aggrediscono un componente della Rete degli studenti. Il ragazzo viene inseguito, spintonato e gettato nel Naviglio tra insulti e sputi.
11 febbraio. Nel viterbese, alcuni militanti di CasaPound effettuano una “spedizione punitiva” contro Paolo, ragazzo ventiquattrenne colpevole di aver condiviso su Facebook una vignetta satirica che recitava: «Chi mette il parmigiano sulla pasta col tonno non merita rispetto». «Fatti i cazzi tuoi, non prendere in giro CasaPound» gli urlano tra un pugno e una cinghiata. A inizio ottobre il Tribunale di Viterbo ha condannato a 2 anni e 8 mesi il presidente di CasaPound Cimini, il trentenne Jacopo Polidori, e Michele Santini, militante poco più che diciottenne del partito neofascista.
2 febbraio. «Mi hanno accerchiato, gettato in terra e preso a calci, i passanti non hanno fatto nulla per fermarli». Accade a Ostia, fuori dal palazzo municipale. La vittima è un attivista di una Onlus che si occupa di migranti. Poco distante un sit-in di CasaPound, Fratelli d’Italia e Noi con Salvini. I partecipanti alla manifestazione negano tutto, ma la Polizia cerca tra loro i responsabili dell’accaduto.
24 gennaio. Forza Nuova, CasaPound e Roma ai Romani impediscono a una famiglia di egiziani di prendere possesso di una casa popolare dopo lo sgombero degli occupanti, ancora una volta italiani e abusivi: «Non molleremo un centimetro» dichiara Giuliano Castellino, portavoce di Roma ai Romani.
21 gennaio. Noi con Salvini e Fratelli d’Italia manifestano contro l’ordinanza con cui la sindaca Raggi destina il Ferrhotel, albergo in disuso vicino la stazione Tiburtina di Roma, all’accoglienza dei migranti. Tra i partecipanti la deputata della Lega Nord Barbara Saltamartini. Al termine della manifestazione Forza Nuova e Roma ai Romani occupano la struttura: «Contro i migranti siamo pronti alle barricate».
Così Casapound prende soldi con il 5 per mille. Il partito neofascista attraverso una cooperativa riceve i fondi della quota Irpef. Forza Nuova e Fiamma tricolore invece incassano fondi da quell'Europa che criticano continuamente. Ecco come, scrivono Andrea Palladino, Giovanni Tizian e Stefano Vergine l'8 novembre 2017 su "L'Espresso". Mamma Europa aiutaci tu. La richiesta è legittima e la avanzano tutti i partiti. Tuttavia è curioso che la richiesta di sostegno economico arrivi dal partito-movimento Apf. Il nome, Alleanza per la pace e la libertà, non tragga in inganno. Non si tratta di un’associazione di pacifisti. L’acronimo Apf è la casa europea dei neofascisti. A guidarla è Roberto Fiore, il leader di Forza Nuova. Lui è il presidente e fondatore di Apf. Del partito-movimento fanno parte nazionalisti britannici, spagnoli, belgi, slovacchi, svedesi. Conta tre rappresentanti, che eletti con i rispettivi partiti nazionali hanno, poi, aderito al progetto di Fiore. Tra i quadri dirigenti di Apf c’è, per esempio, l’amico di una vita, l’inglese Nick Griffin. Ammirano Putin, parteggiano per Assad, sognano l’Euro-exit. Tuttavia nonostante lo scetticismo radicale verso le istituzioni di Bruxelles, il 19 aprile dell’anno scorso hanno aperto una sede nella cittadella europea a soli 4 minuti dal tanto vituperato palazzo del Parlamento. E da due anni li troviamo in coda, come tutti gli altri odiati partiti del “sistema”, a chiedere le sovvenzioni allo stesso Parlamento. Finanziamenti, cioè, che l’istituzione concede da ormai 13 anni ai partiti politici europei e alle fondazione collegate.
Negli ultimi due anni l’ufficio che si occupa di stanziare il denaro ha riconosciuto ai neofascisti 819 mila euro. Le sovvenzioni, dai documenti ufficiali dell’Europarlamento, risultano “Concesse”. Tuttavia sul loro sito i leader di Apf hanno lanciato in questi giorni una campagna di raccolta fondi. Nel comunicato attaccano l’Unione europea colpevole di avergli congelato i soldi assegnati nell’anno in corso. La galassia neofascista di Fiore drena risorse anche tramite fondazioni “amiche”. Negli ultimi due anni, quelle vicine a Apf, “Europa terra nostra” e “Pegasus” (sponsorizzata da Coalition pour la vie et la famille, movimento in cui ha avuto un ruolo Stefano Pistilli legato a Fiore) hanno ottenuto 649 mila euro. Dunque, sommando le varie cifre i neofascisti di Apf, e quindi Fiore e Forza Nuova, potrebbero incassare potenzialmente più di 1 milione e 200 mila euro. Non sono tuttavia gli unici nazionalfascisti a chiedere soldi all’Unione europea. A seguire, infatti, troviamo l’Alleanza europea dei movimenti delle nazioni (Aemn). I leader sono gli ungheresi di Jobbik. Ma del gruppo fa parte anche Fiamma Tricolore, con Valerio Cignetti (ex Msi) che ricopre il ruolo di segretario generale. Tra il 2012 e il 2015 l’Aemn ha già incassato dall’Europa poco meno di 1 milione e 200 mila euro, mentre è in attesa di riceverne altri 700 mila già concessi per i successivi anni. Discorso diverso per CasaPound. Se Fiamma Tricolore e Forza Nuova, infatti, succhiano risorse a Bruxelles, il movimento di Iannone ha trovato una soluzione alternativa. Lo fa chiedendo ai contribuenti un aiutino attraverso il 5 per mille. Il codice fiscale da inserire nella dichiarazione dei redditi non è, però, quello di CasaPound, bensì della cooperativa l’Isola delle Tartarughe. La tartaruga è il simbolo dell’organizzazione neofascista guidata da Gianluca Iannone e Simone Di Stefano. Solo che CasaPound è ormai a tutti gli effetti un partito, perciò gli spetterebbe il 2 per mille e non il 5. Gli ultimi dati ufficiali disponibili riguardano il 2015, anno che segna il record di incasso: 41.036 mila euro. A partire dal 2007 è stato un continuo crescendo. E il confronto con i 4 mila e pochi spiccioli di dieci anni fa fotografa la crescita degli eredi di Marinetti e Mussolini. Sommando sei anni contributivi, a partire dal 2010, si sfonda quota 200 mila. Tesoretto che fa sempre comodo, utile per finanziare feste, banchetti, iniziative, manifesti. A queste entrate vanno aggiunte le contribuzioni libere, i tesseramenti (aumentati di molto), le attività sul territorio. Non c’è che dire, è decisamente cresciuto questo movimento. Un’onda nera di seimila tesserati, con un centinaio di sedi sparse per l’Italia, una web radio, associazioni di vario genere, librerie, società editrici. E con azienda e cooperative di riferimento, come ogni partito che si rispetti.
Tutti i soldi e le società di CasaPound e Forza Nuova: così si finanziano i partiti neofascisti. I gruppi di estrema destra puntano a entrare in Parlamento. Grazie ai fondi di società e privati in Italia e all’estero. Ecco quali sono, tra esercizi commerciali e misteriosi trust, scrivono Andrea Palladino, Giovanni Tizian e Stefano Vergine l' 08 novembre 2017 su "L'Espresso". Dio, patria e famiglia. Ma anche ristoranti, catene di abbigliamento, gioiellerie, barberie, franchising di poste private, scuole di lingua, startup di comunicazione, imprese immobiliari, misteriosi trust e qualche strana società offshore. Dietro la facciata ufficiale dei fascisti del terzo millennio si nasconde una galassia imprenditoriale che dall’Italia si allarga a Francia e Regno Unito. Passando per Cipro e arrivando fino alla Russia di Vladimir Putin. Una multinazionale nera dove gli ideali di purezza del ventennio si intrecciano alle più attuali esigenze dell’economia di mercato. Con imbarazzanti corollari. Alla vigilia delle prossime elezioni politiche, L’Espresso ha indagato sugli affari dell’estrema destra italiana. Ha cercato di ricostruire nei dettagli la rete imprenditoriale creata negli anni da Forza Nuova e CasaPound, i due principali partiti d’ispirazione fascista. Movimenti che dopo aver conquistato spazio in Europa e aver ottenuto seggi nei consigli comunali di mezza Italia, ora puntano al grande passo: entrare in Parlamento. Missione non impossibile, visto che la nuova legge elettorale ha fissato l’asticella a un abbordabile 3 per cento, che se superato permetterà alle piccole formazioni nostalgiche di avere un inedito potere negoziale nello scenario delle grandi coalizioni necessarie per governare.
Latitanze dorate. Forza Nuova e CasaPound, per quanto diverse tra loro, sono unite da una radice comune. Si chiama Terza Posizione, è un movimento neofascista nato nel 1978 e morto ufficialmente quattro anni dopo. Tra i suoi fondatori, all’epoca poco più che ventenni, c’erano Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi. Inseguiti dalle indagini giudiziarie sul terrorismo di destra, fra cui l’attentato alla stazione di Bologna, Fiore e Adinolfi scapparono dall’Italia rifugiandosi in Inghilterra, il primo, e in Francia, il secondo. Quarant’anni dopo, con alle spalle processi e condanne, i due ragazzi sono tornati. Fiore è diventato il segretario nazionale di Forza Nuova, Adinolfi l’intellettuale di CasaPound. Le radici con il passato non si sono però mai interrotte. Almeno quelle degli affari.
L’Inghilterra è da sempre la base principale del business di Forza Nuova, la fonte originaria dei guadagni. Il legame finanziario tra CasaPound e la Francia si è invece manifestato più di recente, ma è cresciuto in fretta da quando il Front National di Marine Le Pen ha scelto di investire sui camerati italiani.
Roberto Fiore. Fiore segreto. Londra, 1980. Per capire l’oggi è necessario tornare ancora agli anni di piombo, subito dopo la bomba che uccise 85 persone a Bologna. Quando Fiore arriva in gran segreto nella Londra di Margaret Thatcher insieme a Massimo Morsello e ad altri militanti di Terza Posizione, ad aiutarli - si legge in un rapporto sull’eversione nera firmato dai servizi segreti italiani (Sisde) del 1982 - è la League of Saint George, snodo internazionale della destra europea, di cui fa parte tra gli altri anche l’ex presidente del British National Party Nick Griffin. Anni nebulosi, punto di partenza della carriera imprenditoriale del giovane neofascista italiano. Con un’ombra mai chiarita: «Era un agente dei servizi segreti britannici (MI6) fin dai primi anni Ottanta», scriverà in un documento del 1991 letto da L’Espresso la commissione d’inchiesta sul razzismo e la xenofobia del Parlamento europeo, gettando un’ombra inquietante sul legame tra Fiore e il Regno Unito. Di certo, per quasi 20 anni ricercato dall’Italia, il politico romano ha creato solide attività economiche in Inghilterra. A lui e ai suoi uomini più fidati fanno infatti capo diversi marchi specializzati in viaggi-studio Oltremanica, tra cui London Orange e Easy London. Come ha dichiarato alla stampa lo stesso Fiore, forse esagerando un po’, «è la più importante struttura di riferimento per il turismo giovanile europeo».
LA RETE DELLE SOCIETA' NERE. Quello che non era però mai emerso finora è che al leader di Forza Nuova fanno riferimento anche tre trust di diritto britannico. In due di questi, chiamati Saint Michael the Archangel e Saint George Educational, almeno dalla metà degli anni ’90 sono transitate centinaia di migliaia di sterline. Soldi entrati come donazioni anonime e finiti spesso, sotto forma di finanziamenti caritatevoli, a società italiane possedute dalla famiglia del segretario di Forza Nuova o da suoi soci. Per dire: solo negli ultimi quattro anni, il trust dedicato all’arcangelo Michele, fra i cui gestori c’è Beniamino Iannace, già candidato per Forza Nuova alle europee 2009, ha incassato 475 mila euro da elargizioni liberali in Gran Bretagna. Soldi finiti quasi completamente in Italia, con donazioni indirizzate ad almeno tre aziende private che appartengono alla famiglia Fiore: Rapida Vis, Futura Vis e Comeritresa, tutte partecipate dalle figlie del segretario di Forza Nuova. Motivazione ufficiale dei pagamenti? Finanziare la realizzazione di pubblicazioni sulla Chiesa Cattolica. Peccato che di questi soldi non si trovi traccia nei bilanci delle società italiane. Nel 1999 i trust furono messi sotto inchiesta dagli organismi di controllo amministrativo inglesi. Un paio di anni prima il quotidiano The Guardian aveva raccontato che queste due fondazioni stavano finanziando un villaggio nazista in Spagna, Los Pedriches, «occupato da Terza posizione internazionale per creare una comunità nazionalista bianca e addestrare soldati volontari», scriveva il giornale inglese. Le carte dell’indagine, chiusa nel 2005, documentarono legami di affari tra le fondazioni e una società di Fiore e Morsello: «I pagamenti», si legge nel rapporto dell’organo di controllo inglese, «erano stati effettuati a favore della Meeting Point (oggi Easy London, ndr) business privato di Fiore». Il fondatore di Forza Nuova ammise le contestazioni, spiegando che i versamenti servivano per pagare l’affitto di un “charity shop” a Shirland Road, a pochi passi dalle sedi legali delle sue tante società specializzate nell’organizzazione di viaggi di italiani a Londra.
CasaPound e Forza Nuova: la mappa delle società estere dei partiti neofascisti. FN ha la sua ricchezza a Londra, mentre la tartaruga frecciata ha puntato tutto sui francesi del Front National pagati da Putin. Ecco come si articola la galassia societaria nera. I documenti ottenuti ora da L’Espresso indicano che l’attività dei trust è proseguita anche dopo la chiusura dell’indagine inglese. E che le donazioni anonime in alcuni casi sono finite ancora a società private di Fiore. Nel frattempo è nato anche un altro trust, il Saint Mark the Evangelist. Non ci sono bilanci disponibili per capire qual è stata l’attività svolta finora, ma tra i gestori compaiono due nomi molto vicini al politico romano: Maria Beatriz Fiore Burgos, sua figlia, e l’imprenditore Stefano Pistilli, in passato in affari con personaggi dell’estrema destra italiana e oggi gestore di altre tre imprese in Inghilterra, una dal nome particolarmente evocativo: Gladio Consulting, ufficialmente specializzata in consulenza manageriale, ricerche di mercato e sondaggi.
Sognando Putin. Se Londra è stata sempre il centro dei contatti internazionali di Forza Nuova, da qualche anno l’attenzione dei neofascisti si è spostata su Mosca. Fiore non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per Putin. Dichiarazioni encomiastiche verso il numero uno del Cremlino e visite in Russia - diverse, negli ultimi anni, fra cui quella al Forum Conservatore tenutosi a San Pietroburgo due anni fa, alla presenza di quasi tutti i leader del neofascismo europeo - dimostrano che fra i due non manca certo la sintonia politica su temi come l’immigrazione, i gay e la famiglia tradizionale. Secondo la nostra intelligence, però, in cambio dell’appoggio alla causa russa in Europa i movimenti estremisti avrebbero «ricevuto sostegno economico». Anche Forza Nuova? Impossibile saperlo. Le informazioni raccolte da L’Espresso permettono tuttavia di descrivere alcuni legami economici che uniscono Fiore alla Russia.
I fascisti italiani fanno i mercenari per Putin. Partono per combattere in Ucraina al soldo dello "zar" russo. Neonazisti e armati, vengono arruolati nelle nostre città per essere spediti al fronte. Il neofascista italiano non si è infatti limitato a sostenere l’annessione della Crimea: ha anche portato nella penisola affacciata sul Mar Nero un gruppo di imprenditori nostrani. Con effetti quantomeno contraddittori rispetto allo sbandierato patriottismo economico di Forza Nuova, sempre pronta a difendere le produzioni italiane. Dopo i viaggi organizzati, alcuni di questi impresari hanno infatti deciso di delocalizzare in Crimea. Il rapporto economico tra Fiore e la Russia inizia ufficialmente nel 2012. A Nizhny Novgorod, 400 chilometri a est di Mosca, si tiene una due giorni di incontri dal titolo “Dialogo commerciale russo-italiano”. Il programma del summit descrive Fiore come capo dell’associazione italo-russa Alexandrite. Due anni dopo si torna a organizzare missioni imprenditoriali, ma questa volta gli imprenditori vengono portati in Crimea, frattanto passata sotto il controllo russo, e il nome di Fiore non viene più accostato a quello di Alexandrite. Chi a quegli incontri ha partecipato dice però che a organizzare tutto dall’Italia è stato proprio il segretario di Forza Nuova.
"Sporchi negri", "zecche", "froci": tutte le vittime di un anno di violenza fascista. Nella notte del 29 ottobre un bengalese è stato preso a calci in faccia nel pieno centro di Roma. I responsabili? Un gruppo di ragazzi vicini al mondo dell'estrema destra capitolina. Il linciaggio va ad ingrossare l'elenco delle aggressioni nere di quest'anno, l'anno delle squadracce 2.0. «L’associazione mi è stata presentata da un amico e sapevo che Fiore era il presidente», racconta Diego Ebau, piccolo imprenditore sardo che ha preso parte a quei viaggi: «L’obiettivo mio e delle altre decine di imprese presenti non era politico, volevamo capire i vantaggi della Crimea». L’impresario spiega che oggi chi investe almeno 50mila euro nella penisola non deve pagare tasse per cinque anni, e in seguito l’aliquota si ferma a un massimo del 6 per cento. Un paradiso fiscale, insomma, collegato a Mosca tramite il ponte sullo stretto di Kerch voluto da Putin. Niente di più invitante per chi si sente schiacciato in patria da tasse e recessione. Ecco perché alcune delle aziende che hanno partecipato ai viaggi organizzati da Fiore puntano a chiudere la fabbrica in Italia e a riaprirla in Crimea. «Io dopo due viaggi sono uscito dall’associazione Alexandrite perché preferivo fare da solo», dice Ebau, «ma so che un’azienda pugliese del settore tessile dovrebbe aver già spostato lì la produzione. E a dire la verità anche io mi sto organizzando: insieme a un altro imprenditore sardo voglio aprire lì un’azienda per la lavorazione del marmo».
Mistero a Cipro. Non solo delocalizzazione. C’è qualcos’altro che Roberto Fiore non ha mai raccontato pubblicamente. Il politico più patriottico d’Italia per oltre cinque anni è stato proprietario di una società basata a Cipro, isola europea prediletta dai russi, che grazie al segreto bancario è da anni uno dei posti più in voga per chi vuole tenere riservati i propri affari. Nell’ottobre del 2010 Fiore ha infatti aperto sull’isola la Vis Ecologia Ltd, società che si occupa ufficialmente di «riciclo di materiali», ma che ha caratteristiche insolite per un’azienda operativa: nessun dipendente, niente sito internet, la sede registrata presso gli uffici di uno studio di commercialisti. Le visure camerali dicono che l’impresa è stata registrata a Cipro «per scopi fiscali», ma è impossibile sapere se sui conti siano girati soldi dato che l’impresa non ha mai depositato un bilancio. Contattato da L’Espresso, il segretario di Forza Nuova non ha risposto alle richieste di chiarimento sull’attività della sua società cipriota. Di sicuro il leader fascista non era l’unico proprietario dell’impresa basata a Cipro. Il restante 50 per cento delle quote era infatti intestato a Beniamino Iannace, lo stesso giovane che gestisce il trust inglese dedicato a San Michele, in passato candidato alle elezioni per Forza Nuova. Anche lui presente all’incontro organizzato dall’associazione Alexandrite in Russia nel 2012, Iannace è oggi un rampante imprenditore nostrano nel settore delle poste private. Alle domande de L’Espresso si è limitato a rispondere precisando che la Vis Ecologia, la società basata a Cipro, «non è mai stata operativa, non ha mai avuto clienti e per questo non ha mai depositato un bilancio». Di certo mentre era proprietario della scatola offshore, il 36enne campano ha fondato il Gruppo Italiana Servizi Postali. Un franchising che conta oggi 64 filiali sparse per l’Italia. E in cui il nome di Fiore ritorna nuovamente. Non quello di Roberto, ma del primogenito Alessandro. Nel 2013, quando viene costituito il gruppo, il figlio è infatti tra gli azionisti insieme a Iannace e a Fabio Infante, anche lui candidato in passato con Forza Nuova alla Camera.
Così Lucca è diventata la nuova roccaforte dei neofascisti di CasaPound. Viaggio nella città toscana dove la lista della tartaruga frecciata ha conquistato l'8 per cento, portando un suo rappresentante in consiglio comunale. Riempiendo i vuoti lasciati dai partiti tradizionali. Qualche anno dopo Fiore junior vende le sue quote a Iannace, che diventa così azionista di maggioranza del gruppo postale, il cui business non sembra molto redditizio (l’ultimo bilancio disponibile, del 2015, segna un fatturato di 105 mila euro e una leggera perdita) ma offre opportunità interessanti. Perché distribuire multe, atti giudiziari e raccomandate dà accesso potenzialmente a dati personali e indirizzi di milioni di persone: materiale strategicamente importante per un partito politico che vuole farsi conoscere. Un accostamento che Iannace respinge con forza, garantendo che la sua società «non ha mai avuto e mai avrà alcuna colorazione, connotazione o collocazione politica che dir si voglia». Resta da notare solo una contraddizione tra il passato politico di Iannace e la sua attuale attività imprenditoriale. Il punto numero tre del programma storico di Forza Nuova prevede infatti il «blocco dell’immigrazione». Eppure il Gruppo Italiana Servizi Postali ha come partner Western Union, il più famoso servizio di trasferimento denaro utilizzato dagli immigrati di tutto il mondo. Insomma, Iannace e Infante cercano di fare affari con gli stranieri che dall’Italia mandano a casa soldi. Una pratica non proprio in linea con le direttive ufficiali del partito. Ma d’altronde, si sa, business is business.
Francia connection. Se dal punto di vista ideologico Forza Nuova è la truppa neofascista più tradizionale, i cugini di CasaPound rappresentano l’evoluzione moderna del cameratismo. Benché i contenuti della propaganda politica siano identici, a mutare sono i metodi. Così mentre Fiore e soci puntano soprattutto ad ampliare la rete dei contatti internazionali (Forza Nuova ha aperto da pochi anni una filiale negli Usa), i leader di CasaPound hanno lanciato l’assalto al cielo dei consensi in patria. E nel giro di pochi anni hanno raggiunto risultati importanti. Ronde nelle periferie, centinaia di migliaia di seguaci sui social network, spazio nel dibattito pubblico. Ma soprattutto seggi nei consigli comunali. Tanti. Da Bolzano a Lucca, da Arezzo a Grosseto. E il 5 novembre puntano a un risultato a due cifre nel municipio di Ostia, prova generale delle prossime politiche. Dietro la propaganda anti immigrati, cavallo di battaglia dell’organizzazione neofascista che ha il suo quartier generale in un edificio pubblico occupato nel centro di Roma, c’è però una fitta rete di imprese commerciali. Un network politico-affaristico esploso in concomitanza all’arrivo in Italia di alcuni francesi. Tutti vicini al Front National, il partito guidato da Marine Le Pen, decisamente più ricco dei cugini di CasaPound anche grazie a un finanziamento da 11 milioni di euro ricevuto negli ultimi anni dalla Russia, come ha rivelato su Mediapart la giornalista Marine Turchi. Che il Cremlino sia favorevole all’ascesa di partiti euroscettici, xenofobi e filorussi non è d’altronde un mistero. Per questo Putin non dovrebbe essere ignaro delle tante società aperte in Italia dai seguaci della Le Pen. La più famosa si chiama Carré Français, una specie di Eataly in versione transalpina: champagne di tutti i generi, ostriche e formaggi. Un locale elegante nel cuore di Roma, che nel 2015 (ultimo bilancio disponibile) ha fatturato quasi mezzo milione di euro. A controllare il ristorante-concept store è Jildaz Mahé, in gioventù membro del movimento studentesco neofascista francese Gud, lo stesso in cui militavano molti dei francesi che ultimamente hanno aperto società in Italia insieme ad esponenti di CasaPound. C’è ad esempio la catena di trattorie “Angelino dal 1889” - con ristoranti a Roma, Milano, Malaga, pure a Lima - tra i cui proprietari troviamo Maria Bambina Crognale, moglie del leader di CasaPound Gianluca Iannone, e Pierre Simonneau, militante della destra francese. E c’è il Carré Monti, locale a metà tra il bistrot e il pub, fra i cui soci spicca ancora il francese Simonneau insieme all’avvocato di CasaPound Domenico Di Tullio e a Chiara Del Fiacco, candidata alla Camera nel 2013. Il Carré Monti è il luogo di ritrovo abituale, dove spesso organizzano i compleanni dei camerati. Certamente più informale e meno chic del ristorante di Mahé. Chiara Del Fiacco è un donna sulla quarantina, capelli biondi e tatuaggi. Rappresenta il punto di contatto diretto fra i camerati nostrani e quelli d’Oltralpe. Il suo compagno è infatti Sébastien de Boëldieu, considerato il ministro degli esteri di CasaPound, amico di vecchia data di un pezzo da novanta del Front National. Frédéric Chatillon, 49 anni, è infatti l’uomo che ha curato la comunicazione nelle ultime campagne elettorali della Le Pen. Comprese quelle del 2012, 2014 e 2015, finite al centro di alcune inchieste della magistratura francese con accuse che vanno dalla frode all’abuso di beni sociali. Nonostante le incriminazioni Chatillon - il cui nome è emerso anche dai Panama Papers in relazione ad alcune società offshore - non si è perso d’animo. D’altra parte lui è un uomo d’azione, e non si spaventa certo per un’inchiesta. Lo ha dimostrato qualche anno fa, quando emerse che la Riwal aveva lavorato per la Siria di Bashar al Assad prendendo tra i centomila e i centocinquantamila euro l’anno dall’ambasciata siriana a Parigi, aveva scritto sempre Mediapart. Anche in quel caso la magistratura francese si era interessata alla questione, senza alla fine rilevare nulla di penalmente rilevante. Questa volta Chatillon ha però deciso di cambiare aria. Puntando dritto sull’Italia, forte dell’amicizia da lui vantata con esponenti di Alleanza nazionale, Forza Italia, Fratelli d’Italia oltre che con il dirigente di CasaPound Sébastien de Boëldieu.
Così Casapound prende soldi con il 5 per mille. Il partito neofascista attraverso una cooperativa riceve i fondi della quota Irpef. Forza Nuova e Fiamma tricolore invece incassano fondi da quell'Europa che criticano continuamente. Due anni fa lo stratega mediatico della Le Pen ha aperto la Riwal Italia, sede in uno splendido palazzo nobiliare nel centro della capitale. A chi sta offrendo i suoi servizi la società di comunicazione? Alle domande de L’Espresso Chatillon si è limitato a negare rapporti commerciali con CasaPound e Fratelli d’Italia, aggiungendo di non aver mai lavorato «neppure per aziende, associazioni e/o fondazioni politiche». Non resta dunque che affidarsi ai pochi documenti ufficiali disponibili, come il bilancio del 2015 che segna un fatturato di 135mila euro, la cui origine resta dunque inspiegata. Così come non trova conferme ufficiali il ruolo dell’uomo della Le Pen nel Carré Français: sebbene Chatillon non abbia ruoli ufficiali nella società, in un post pubblicato su Tripadvisor a fine 2015 lui stesso si presentava come direttore generale della cosiddetta ambasciata culinaria francese a Roma. Con la stessa discrezione altri francesi hanno intanto avviato business a sud delle Alpi. Mahé, già proprietario del Carré Français, ha costituito quest’anno un’altra società che si occupa di ristorazione.
Frédéric Chatillon e Sébastien de Boëldieu alla festa del marchio di abbigliamento Pivert. Si chiama La Romanée ed è partecipata da due sue connazionali: Simone Rosso e Audrey Orcel. Mediapart, che ha collaborato con L’Espresso a questa parte dell’inchiesta, non ha ottenuto risposta dalle due donne sui motivi del loro investimento in Italia. Risultati simili con Alexandre-Paul Martin, 27 anni, astro nascente del Front National e considerato il delfino di Chatillon, tanto da aver rimpiazzato in patria la Riwal con la sua agenzia di comunicazione, la e-Politic. Anche Martin, che secondo l’account Facebook di Chatillon è appena stato in Siria insieme al suo mentore per visitare le città liberate dall’esercito di Assad con l’aiuto della Russia, ha deciso di investire sull’Italia quest’anno. Ha aperto una società chiamata Squadra digitale, impegnata ufficialmente nel business della comunicazione e registrata a un indirizzo importante: via della Scrofa 39, Roma, storica sede del Msi che oggi ospita la fondazione Alleanza Nazionale e la redazione del Secolo D’Italia. Alle domande inviate da L’Espresso, il giovane imprenditore francese ha riposto con poche righe. Ha escluso qualsiasi rapporto commerciale con forze politiche italiane e con i connazionali del Carré Français, tagliando corto sull’obiettivo della sua nuova società. L’ho fondata, ha risposto, «perché mi interessa sviluppare la mia attività in Italia». Punto. Insomma, nessuno sembra voler svelare il motivo che li ha spinti a investire nella Capitale. C’è anche un filo che collega indirettamente i nazionalisti francesi ad ambienti manageriali italiani, seppure in società che non hanno a che fare con i movimenti di estrema destra. Il presidente del consiglio d’amministrazione di Stroili Oro, brand internazionale dei gioielli (370 negozi, 1.800 dipendenti) con sede in Friuli, è Romain Peninque. Lo è dal 2016, da quando cioè la cordata francese Thom Europe, holding della prima catena di gioiellerie transalpine Histoire d’Or, ha comprato l’italiana Stroili. Romain è il figlio di Philippe Peninque, avvocato, consulente fiscale, già militante nel Gud. Uomo potente, descritto da diversi media transalpini come l’eminenza grigia della Le Pen. Di certo il fatto che il figlio, Romain, sia oggi a capo di Stroili Oro - nel consiglio d’amministrazione siede anche Eric Belmonte, amico e in passato socio d’affari di Peninque - è un paradosso per i francesi dell’estrema destra, accusati di essere piegati ai voleri di Putin. Sì, perché il gruppo Thom Europe in realtà è stato capace di superare nell’offerta di acquisto della catena italiana persino il fondo d’investimento russo Vtb, partecipato al 60 per cento dal Cremlino. «Putin a un passo da Stroili oro», titolavano infatti i quotidiani locali nel 2014. Due anni dopo lo scenario è cambiato: ci sono le sanzioni contro la Federazione russa, rea di aver invaso la Crimea, e il fondo di Putin si ritira lasciando campo libero al gruppo Thom che porterà Peninque in Italia.
Avanguardia fashion. I pacchi alimentari, i picchetti, le occupazioni. Prima gli italiani. L’azione trascina le masse esauste del degrado delle periferie. Ma c’è un livello di interlocuzione che CasaPound ritiene indispensabile: gli intellettuali. Per fare cultura le tartarughe di Iannone non badano a spese. L’ultima sfida è l’informazione. Da tempo è online il quotidiano “Il primato nazionale”, recentemente affiancato dal mensile cartaceo. Periodico sovranista, si definisce. Nel numero d’esordio il direttore Adriano Scianca, responsabile cultura di CasaPound, ha scelto il faccione del deputato Pd Emanuele Fiano da mettere in copertina con il titolo “Il Talebano”, riferimento alla legge da lui promossa che proibisce di fare propaganda attraverso simboli e gesti fascisti. La società editrice de Il Primato nazionale è la Sca 2080 e ha un capitale sociale di 100 mila euro. La prima tiratura del mensile è stata di 20 mila copie. Sui social d’area è un tripudio di complimenti: «Era ora, un giornale libero». La prima inchiesta proposta riguarda i “rossi”: la violenza è da sempre nel Dna dell’antifascismo. Chi ha interesse a investire nell’house organ dei nuovi neri? I soci sono Francesco Polacchi, storico attivista di CasaPound, e uno studio di commercialisti romani intestato a Mauro Polacchi, azionista della casa editrice neofascista attraverso la Holding Minerva. Un’impresa, la Minerva, con varie partecipazioni, persino una nella Eized, dove tra i soci troviamo Lorenza Lei, prima donna a ricoprire il ruolo di direttore generale in Rai. La società editrice del Primato gestisce anche il sito web Mma Europa, dedicato agli amanti delle arti marziali miste. Il culto del corpo resta d’altronde un valore, come ai tempi di Mussolini. CasaPound ha infatti un suo circolo di combattenti. Con atleti-militanti che fanno competizioni internazionali. È lo stesso movimento che a volte organizza incontri in giro per le palestre d’Italia. Altri incassi, insomma. Virilità, vigore, bellezza. E cura dei dettagli estetici, fondamentali per attirare consensi. Sarà per questo che tra gli investimenti della galassia CasaPound troviamo persino la catena di negozi Pivert. Un marchio di abbigliamento casual, affatto etichettabile come fascista, lanciato dagli stessi soci del Primato Nazionale, i Polacchi. Negli anni Pivert ha aperto varie sedi. A Roma, stesso indirizzo della redazione, e a Milano. Ma ha anche rivenditori all’estero. «Sono fiera di sposare questo progetto basato sul made in Italy. Quindi, cari maschietti, un’occhiata dategliela, anche perché noi donne ci stiamo organizzando per non darla più a chi indossa made in China»: musica per le orecchie degli Iannone Boys, specie se a scriverle è showgirl Nina Moric, che ha offerto così la promozione gratuita del brand. Ufficializzandosi come vip organica al movimento neofascista. Non solo Moric, però. Tra i fan del brand troviamo parecchi calciatori, rugbisti, pugili. E all’appuntamento mondano non poteva mancare qualche lepenista. A una delle presentazioni della collezione 2015 erano presenti, infatti, anche i francesi Chatillon e De Boëldieu. Proprio i due nomi che legano CasaPound al Front National.
The Italian far-right money. On the eve of the general elections, an investigation on the financing and the businesses of Forza Nuova and CasaPound, the main Italian neofascist parties. Mentre Forza Nuova non si sforza di aumentare il proprio appeal elettorale e tende a circoscrivere sempre di più la propria nicchia di consensi, i leader di CasaPound si presentano sempre più insistentemente come politici inclusivi. Lo fanno invitando alle loro conferenze giornalisti noti con idee molto distanti dalle loro. Cercano, insomma, di legittimarsi attraverso il confronto pubblico. Senza dimenticare l’estetica. I neofascisti romani hanno un loro barbiere di fiducia, situato a pochi passi dalla sede dell’Esquilino. Si chiama Bullfrog, la rana-toro: marchio famoso, presente in tutta Italia, stile hipster. Una catena di barberie creata da Romano Brida, il cui socio di maggioranza è oggi Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta e imprenditore di successo. Il barbiere frequentato dai neofascisti romani (la società che lo controlla si chiama BF Roma) è solo un affiliato al marchio Bullfrog, nessun legame diretto con Percassi. Tuttavia i titolari del negozio in franchising gravitano attorno al movimento. E hanno creato un legame imprenditoriale con un altro volto noto di CasaPound. Nella società Red Hook, di cui i proprietari della barberia romana sono azionisti, uno dei membri del consiglio d’amministrazione è infatti Marco Clemente. Romano di nascita, milanese d’adozione, Clemente è stato candidato al consiglio comunale nelle liste del Pdl a sostegno di Letizia Moratti sindaco, poi è finito al centro delle polemiche per un’intercettazione shock con un uomo della ’ndrangheta. Successivamente si è avvicinato a CasaPound Milano, diventandone un leader. E affiancando, all’attività politica, quella affaristica: come dimostra il suo ruolo da amministratore nella società Prince, tra i cui azionisti c’è la moglie di Gianluca Iannone. Insomma, un altro esempio di cameratismo in doppio petto. Celtiche e soldi. Saluti romani e fiuto per gli affari. Da Roma a Milano, passando per Parigi, Londra, Cipro e la Crimea. Con la benedizione dei nazionalisti russi.
Aggiornamento dell'8 novembre 2017. Repliche a Cassa Pound. Il mio assistito Jildaz Mahe O’ Chinal - il quale mi ha conferito incarico, anche nell’interesse delle società che rappresenta citate nell’articolo “Cassa Pound” (L’Espresso n. 45) - contesta la ricostruzione dell’infografica (“Da Parigi a Mosca, la rete dei soldi ai neri”) in cui si mette in relazione il mio rappresentato con un ipotetico finanziamento della Russia al Front National, da questo alla società rappresentata dal Sig. Mahe e da quest’ultima a CasaPound. Il Sig. Mahe contesta, altresì, in particolare l’accostamento a “Francia Connection”. Il mio assistito è estraneo a detta ricostruzione, lesiva per la sua immagine e per l’attività che svolge. Il Sig. Mahe è un imprenditore nel settore gastronomico, in cui promuove la cucina francese. Il mio rappresentato non è impegnato nella politica italiana, non finanzia gruppi o partiti tantomeno “neofascisti”. Avv. Massimiliano Cesali
-------------
Il Sig. Frédéric Chatillon mi ha conferito incarico, anche nella qualità di legale rappresentante della Riwal Italia srl, di rettificare l’articolo “Cassa Pound” (L’Espresso n. 45) e contestare la ricostruzione contenuta nella infografica (pag. 42 e 43) in cui si mette in relazione il mio rappresentato con un ipotetico finanziamento della Russia al Front National, da questo alla società rappresentata dal Sig. Chatillon e da quest’ultima a “CasaPound”; il sig. Chatillon contesta, altresì, in particolare l’accostamento a “Francia Connection”. Il mio assistito è estraneo a detta ricostruzione, lesiva per la sua immagine e per l’attività che svolge. Il sig. Chatillon evidenzia di apprezzare la qualità della vita in Italia, di non essere impegnato nella politica italiana e di non avere rapporti economici con i gruppi e/o partiti politici italiani e in particolare con CasaPound. Avv. Paola Cittadini
-------------
Il Sig. Paul Alexandre Martin mi ha conferito incarico, anche nella qualità di legale rappresentante della Squadra Digitale srl, di rettificare l’articolo “Cassa Pound” (L’Espresso n. 45) e contestare la ricostruzione contenuta nella infografica (pag. 42 e 43) in cui si mette in relazione il mio rappresentato con un ipotetico finanziamento della Russia al Front National, da questo alla società rappresentata dal Sig. Martin e da quest’ultima a “CasaPound”; il sig. Martin contesta, altresì, in particolare l’accostamento a “Francia Connection”. Il mio assistito è estraneo a detta ricostruzione, lesiva per la sua immagine e per l’attività che svolge. Il sig. Martin è un imprenditore non interessato alla politica italiana, non finanzia gruppi politici, in particolare Casa Pound. Avv. Luca Ciaglia
La nostra risposta. Il finanziamento erogato dalla banca russa First Czech Russian Bank al Front National non è ipotetico: è stato confermato dallo stesso Front National. L’infografica contestata non mette in relazione né il Sig. Mahé, né il Sig. Chatillon, né il Sig. Martin ai finanziamenti russi ma elenca - attraverso gli strumenti grafici - le società basate in Italia e possedute parzialmente o totalmente da cittadini francesi vicini a movimenti di destra. Tra questi ci sono, appunto, il Carré Français del Sig. Mahé e la Riwal Italia del Sig. Chatillon, che come spiegato nell’articolo sono entrambi ex militanti del Gud, e la Squadra Digitale del Sig. Martin, il quale lavora per il Front National in Francia in qualità di amministratore della società E-Politic. Va inoltre notato, come segnalato sempre nell’articolo, che il Sig. Chatillon, ex responsabile della comunicazione elettorale del Front National, si è autodefinito direttore generale del Carré Français. E che il Sig. Mahé ha presenziato in qualità di procuratore speciale all’atto di costituzione della società italiana posseduta dal Sig. Chatillon, la Riwal Italia, filiale dell’omonima società francese che ha lavorato per il Front National. Nell’articolo non esistono riferimenti a ipotetici finanziamenti di Mahé a gruppi o partiti politici italiani. Lo stesso vale per il Sig. Martin, di cui abbiamo riportato le brevi risposte forniteci. Infine, nell’articolo non c’è alcun passaggio in cui sosteniamo che Riwal abbia lavorato per CasaPound o altri partiti. Scriviamo solo che nel bilancio è indicato un fatturato la cui origine, a questo punto, resta inspiegata visto che il sig. Chatillon nelle risposte inviate al giornale - da noi inserite nell’articolo - esclude che la società Riwal abbia lavorato per «aziende, associazioni e/o fondazioni politiche».
-------------
Rettifica ulteriore di Jildaz Mahé. La vostra precisazione tenta invano di sminuire: il contenuto dell'infografica, la infondata ricostruzione ed i danni provocati, alle persone e alle aziende citate. Si precisa che il Sig. Mahé, per la buona conoscenza della lingua italiana, si è spesso prestato, a titolo gratuito, a dare assistenza a cittadini francesi, amici o conoscenti, che non conoscono la lingua italiana.
-------------
Rettifica Front National. Il Front National precisa di non avere alcun legame economico con società di diritto privato stabilite in Italia – in particolare con quelle indicate nell'infografica – e non avere nessun legame politico ed economico con Forza Nuova o CasaPound.
La nostra risposta. Prendiamo atto della precisazione inviataci dal Front National, ricordando però che nell'articolo L'Espresso si è limitato a riportare fatti documentati, tra cui l'apertura di società in Italia da parte di cittadini francesi – come il Sig Chatillon e il Sig. Martin - che hanno lavorato per il Front National con ruoli rilevanti.
I segreti di Roberto Fiore, il fascista a capo di Forza Nuova. Terrorista nero. Condannato per eversione. Scappato all'estero. Dove ha trovato la protezione dei servizi segreti britannici. Oggi guida il partito di estrema destra. Che in cinque anni è stato denunciato per violenza 240 volte, scrivono Paoloo Biondani, Giovanni Tizian e Stefano Vergine il 20 dicembre 2017 su "L'Espresso". Ventuno aprile 1999, mancano quattro giorni alla festa della Liberazione. Mentre l’Italia democratica si prepara a ricordare la storica sconfitta del nazi-fascismo, all’aeroporto di Fiumicino si materializza un neofascista conclamato. Un terrorista nero che è riuscito a restare impunito. Si chiama Roberto Fiore, è stato condannato per banda armata e associazione sovversiva come capo di Terza posizione, l’organizzazione che alla fine degli anni Settanta ha riunito alcuni dei criminali più violenti della destra eversiva. Dai ranghi di Terza Posizione è uscita una generazione di stragisti, assassini, rapinatori, sequestratori. Dichiarato colpevole in tutti i gradi di giudizio, Fiore avrebbe dovuto scontare almeno cinque anni e mezzo di reclusione. Invece è scappato all’estero. E a Londra ha fatto molti soldi con appoggi sospetti. Quando rientra in Italia, a quattro giorni dal 25 aprile 1999, è un uomo libero. Ricco. Pronto a guidare un nuovo movimento politico. Neofascista, razzista, pieno di criminali violenti. Come il precedente, ma con una sigla diversa: Forza Nuova. La prima fucina della delinquenza politica di oggi. Per capire gli attacchi di questi giorni, le minacce ai giornalisti di Repubblica e del nostro settimanale rivendicate da Fiore in persona come «il primo atto di una guerra politica contro il gruppo Espresso», si può partire da quel ritorno. Che unisce passato e presente nel segno dell’impunità. Il passato è la verità storica e giudiziaria che l’attuale leader di Forza Nuova ha potuto ignorare dopo 19 anni di latitanza all’estero. Perché in Italia cadono in prescrizione perfino le condanne definitive: giuste, meritatissime, ma non eseguibili per scadenza dei termini. Fiore scappa all’estero nel 1980, a 21 anni, prima di poter essere colpito dalla retata che decapita Terza Posizione, il gruppo armato che ha allevato una legione di terroristi neri poi confluiti nei Nar. Quando i suoi ex camerati Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini eseguono la strage di Bologna (2 agosto 1980, 85 vittime), lui è già in Inghilterra. Al sicuro, con altri complici neri. Nel 1982 un giudice britannico respinge la richiesta italiana di estradizione. Fiore e l’altro leader di Terza posizione, Massimo Morsello, restano liberi anche dopo essere stati condannati in tutti i tre gradi di giudizio. In Italia intanto Fioravanti e la Mambro, nel tentativo di sottrarsi all’accusa per la strage, inventano un falso alibi, costruito proprio attorno a Fiore e a un altro fondatore di Terza Posizione, Gabriele Adinolfi, ora ideologo di Casapound. L’intreccio tra le due organizzazioni romane del terrorismo nero è spaventoso. Un esempio tra i tanti: Fioravanti e Mambro vengono condannati anche per l’omicidio di Francesco Mangiameli, ex dirigente siciliano di Terza posizione, ammazzato il 9 settembre 1980 perché era uno dei pochi a conoscere la verità su Bologna. E ne aveva parlato con un ex colonnello dei servizi, Amos Spiazzi, che decise di lanciare l’allarme con una famosa intervista a L’Espresso. La Cassazione, nella sentenza definitiva (a sezioni unite) sulla strage di Bologna, spiega che Fiore e altri ex di Terza Posizione sono scappati proprio per non fare la stessa fine di Mangiameli. Eppure in tutti questi anni non hanno mai rivelato e tantomeno confessato nulla. Silenzio totale, perfino sui responsabili della carneficina nera alla stazione di Bologna. A Londra, nei quasi vent’anni di latitanza, Fiore e Morsello ottengono appoggi importanti e misteriosi. La stampa inglese li accusa più volte di aver collaborato con i servizi segreti (MI6). Fiore ha sempre respinto questo sospetto, che però è confermato, nero su bianco, da un rapporto firmato nel 1991 dalla prima commissione d’inchiesta del parlamento europeo su razzismo e xenofobia. Accuse poi rilanciate in Italia, in particolare, da due importanti esponenti di Alleanza nazionale, Enzo Fragalà e Alfredo Mantica. Nel dossier presentato alla commissione stragi, i due parlamentari ricordano la fortissima amicizia tra Fiore e il leader dell’estrema destra britannica Nick Griffin. Il presidente della commissione stragi, nell’audizione del 2000, mette a verbale una domanda esplicita: «Ritiene che Fiore e Morsello fossero agenti del servizio inglese?». E Fragalà risponde: «Non ritengo, c’è scritto, è un dato obiettivo, mai smentito da nessuno... D’altro canto, altrimenti come si fa a immaginare che due latitanti italiani, segnalati come pericolosi, possano costruire lì in Inghilterra un impero economico con 1.300 appartamenti?». Oggi l’avvocato Fragalà non può più cercare la verità su Fiore: è stato ucciso nel 2010 a Palermo. Per i pm Fragalà è stato ucciso da Cosa nostra perché aveva convinto alcuni clienti a collaborare. La mafia aveva progettato un raid punitivo per dare una lezione a tutta la categoria, ma l’aggressione fu talmente violenta che portò alla morte del legale. Dunque Fiore, quando rientra a Roma, è un ricco neofascista in doppiopetto, che non ha mai dovuto pentirsi del suo curriculum di terrorista e, nella lunga latitanza, ha stretto rapporti con leader razzisti e neonazisti, servizi segreti e finanziatori rimasti nell’ombra. Ai giovani italiani si presenta come un fervente cattolico, fedele ai valori della tradizione, perseguitato da imprecisati poteri forti. Nato a Roma in una famiglia borghese e fascista, è sposato con la spagnola Esmeralda Burgos, padre di undici figli, contrarissimo all’aborto e all’omosessualità. Nel 2000, pochi mesi prima della morte di Morsello, pubblica un libro con Gabriele Adinolfi (“Noi, Terza Posizione”) dove rivela che suo padre, Amedeo Fiore, combattente per Mussolini a Salò, si sarebbe «offerto volontario per il progetto, poi non realizzato, dei kamikaze italiani». Il suo nuovo movimento, Forza Nuova, lo fonda nel 1997, quando ancora è a Londra. Lo struttura come un partito nazionale, aprendo le prime 50 sedi provinciali. Ma già alla fine del 1999 il capo dell’antiterrorismo, Ansoino Andreassi, sentito dal Parlamento, lo accusa di far parte di una rete internazionale di finanziatori di naziskin. Fiore smentisce e querela, ma non intimidisce il prefetto. Un poliziotto molto esperto, il primo a capire la nuova strategia del terrorista mai pentito: non sporcarsi le mani, non farsi invischiare nelle azioni violente dei giovani di Forza Nuova. Da allora, il leader è un intoccabile: molte indagini, qualche processo, ma nessuna nuova condanna. A gestire la violenza politica sono i singoli esponenti del movimento, senza legami documentabili con il vertice, che però li difende. La strategia del doppio binario porta Fiore a presentarsi come leader ufficiale di un partito che partecipa alle elezioni. Alle comunali di Roma, nel 2001, il primo candidato è un nipote di Benito Mussolini. Negli anni d’oro di Berlusconi, Forza Nuova tratta alleanze elettorali con il centro-destra, con esiti alterni. Nel 2008 Fiore entra nel parlamento europeo, occupando il seggio lasciato da Alessandra Mussolini. E fuori dai palazzi, intanto, la base di Forza Nuova scatena un’escalation di violenze. L’Osservatorio democratico sulle nuove destre ha schedato una serie di reati impressionanti. Nell’aprile 1999, a Roma, vengono rinviati a giudizio 25 naziskin per violenze, minacce e istigazione all’odio razziale. Il gruppo fa parte della rete internazionale degli “hammerskin”: il presunto capo-cellula è il responsabile di Forza Nuova a Milano. Lo stesso Fiore viene inquisito come finanziatore dei neonazisti. Ma tutte le accuse restano poi coperte dalla prescrizione. Nel dicembre 2000, un anno dopo l’allarme di Andreassi, il neofascista Andrea Insabato resta ferito mentre fa esplodere una bomba all’ingresso del Manifesto, lo storico quotidiano comunista. Insabato era stato il capo di Terza Posizione nei quartieri romani della Balduina e Monte Mario. «Sono un suo amico», è costretto a dichiarare Fiore a caldo, «ma con Forza Nuova non c’entra nulla». Già nel precedente processo per un raid antisemita, a difendere Insabato era stato il fratello avvocato di Fiore. Negli stessi mesi, a Padova, un gruppo di neofascisti finisce in cella dopo un grosso sequestro di armi ed esplosivi: tra gli arrestati c’è un candidato di Forza Nuova alle comunali. Nel gennaio 2003 una squadraccia di affiliati irrompe in una tv di Verona e si esibisce in un pestaggio in diretta di Adel Smith, un musulmano che contestava i crocefissi nei luoghi pubblici. Nell’aprile 2004, a Bari, 15 forzanovisti vengono arrestati per una serie di raid con mazze, bastoni e catene. Nel marzo 2005 il candidato di Forza Nuova a Siracusa viene accusato di aver organizzato attentati contro la Cgil e un ospedale. Nell’aprile 2005 Andrea Rufino e Giovanni Marion, due soci fondatori di Easy London, la succursale italiana delle imprese di Fiore, vengono arrestati per l’arsenale di armi ed esplosivi (con fucili militari e bombe a mano) scoperto in via Nomentana a Roma. Nel settembre 2007 tredici neofascisti, capeggiati dal responsabile provinciale di Forza nuova, vengono fermati a Rimini mentre cercano di raggiungere un centro sociale con spranghe e taniche di benzina. Nel 2008 il leader dei giovani di Forza nuova a Bologna viene condannato a tre anni per aver spaccato la faccia a due ragazzi di sinistra (con naso e mascella fratturati). Negli ultimi anni crescono soprattutto le violenze contro gli immigrati. Un esempio recente è l’inchiesta del Ros denominata “Banglatour”, avviata dopo che 80 immigrati bengalesi erano finiti al pronto soccorso per essere stati pestati. Secondo l’accusa i raid partivano da due sedi di Forza Nuova a Roma. Dove i minorenni venivano «addestrati a usare coltelli e spranghe in una palestra di odio e violenza». Secondo l’Osservatorio, le vittime sono stranieri poveri, giovani di sinistra, gay e medici: in un assalto in Puglia i forzanovisti gridavano «assassine, criminali» contro le donne ricoverate in attesa di abortire. Le uniche cifre ufficiali su Forza Nuova nel suo insieme sono state fornite due anni fa dal ministero dell’Interno: in 65 mesi, tra il 2011 e il 2016, ben 240 denunce e dieci arresti. Quattro raid al mese. Un attacco neofascista alla settimana. Fiore si è sempre proclamato estraneo a tutti i reati. Rivendica le azioni politiche, anche se apertamente razziste. Nel 2013, ad esempio, la sezione di Macerata attacca con manifesti xenofobi la ministra Kyenge. E lui li difende: «La Kyenge dovrebbe tornare in Congo, non capisco come abbia ottenuto la cittadinanza». Tra un’inchiesta e l’altra, Fiore ha fatto strada anche nel mondo degli affari. I soldi, per lui, sembrano contare almeno quanto la politica. Ma sul tema economico mostra molto meno patriottismo. In Italia risulta infatti intestatario solo di una piccola società, la Immobiliare Brighton. Per il resto la visura camerale mostra una sfilza di cambiali e assegni non pagati. Strano, per un imprenditore che dice di sé: «Sono 40 anni che faccio attività economica e non mi è stato mai trovato un singolo errore». Ad alcuni uomini vicini a Forza Nuova qualche macchia deve averla però trovata la guardia di finanza. C’è infatti un filone tutto economico e ancora riservato nell’inchiesta sui pestaggi ai bengalesi. Nel mirino degli investigatori ci sono cinque imprenditori forzanovisti sospettati di evasione fiscale e false fatturazioni. Gli affari ufficiali di Fiore, dicevamo, sono invece quasi tutti all’estero. Si concentrano in Inghilterra, soprattutto, dove il leader di Forza Nuova è riuscito nell’ardua impresa di creare un impero finanziario mentre era latitante. «Abbiamo cominciato lavando piatti nei ristoranti e facendo gli autisti di taxi. Poi abbiamo avviato una piccola agenzia. Ma il genio degli italiani, si sa, porta oltre». Così lo stesso Fiore ha spiegato l’origine delle sue ricchezze: una rete di società specializzata in viaggi-studio a Londra, forte di proprietà immobiliari e di due marchi noti nel settore, London Orange e Easy London. Al presunto genio italico, però, si aggiunge una massiccia dose di opacità finanziaria. Fanno infatti riferimento a Fiore e ai suoi sodali tre strutture britanniche di trust (società fiduciarie, dove i titolari possono restare anonimi) nelle cui casse sono affluite centinaia di migliaia di sterline. Soldi entrati per anni come donazioni anonime. E poi finiti a società possedute direttamente dalla famiglia del leader di Forza Nuova. Solo negli ultimi quattro anni, per citare un caso, un trust intitolato all’Arcangelo Michele ha incassato 475 mila euro da elargizioni liberali in Gran Bretagna. Chi ha mostrato tanta generosità nei confronti del leader neofascista? Mistero. Di certo buona parte di questi soldi è stata poi girata a Rapida Vis, Futura Vis e Comeritresa, tutte aziende controllate dalla famiglia Fiore. L’attività economica del leader di Forza Nuova non è però circoscritta al solo Regno Unito. Il patriota Fiore ha fatto rotta anche su Cipro, uno dei più rinomati paradisi fiscali europei. Per cinque anni, fino al gennaio del 2016, Fiore è stato infatti azionista della Vis Ecologia, società che si occupa ufficialmente di «riciclo di materiali», ma che ha tutte le caratteristiche della scatola vuota: zero dipendenti, niente sito internet, sede negli uffici di uno studio di commercialisti locali. Le visure camerali dicono che l’impresa è stata registrata a Cipro «per scopi fiscali»: risparmiare sulle tasse. Ma è impossibile sapere quanti soldi abbia gestito: la società non ha mai depositato un bilancio. E Fiore non ha voluto rispondere alle domande de L’Espresso. D’altronde questa non è la sua unica ambiguità. Attraverso l’associazione Alexandrite, il neofascista romano ha di recente organizzato viaggi in Crimea di alcune imprese italiane che hanno poi deciso di trasferire lì la produzione. Non proprio il massimo per chi definisce la globalizzazione «un evento nefasto della storia». Come l’Unione europea, di cui però Fiore ha fatto parte dal 2008 al 2009 come parlamentare, con tanto di finanziamento pubblico da 600 mila euro incassato dalla Apf, la coalizione di estrema destra presieduta dal politico romano. E nefasta come gli stranieri, che a parole Forza Nuova vuole bloccare, ma con i quali intanto fa affari attraverso la società Gruppo Italiana Servizi Postali, un’azienda privata di spedizioni che ha come partner tecnologico Western Union, il servizio di money transfer prediletto dagli immigrati. Eppure proprio Gruppo Italiana Servizi Postali è una delle società più importanti della galassia neofascista: tra i fondatori c’è il figlio di Fiore, Alessandro, mentre l’attuale azionista di maggioranza è l’ex candidato Beniamino Iannace, socio del leader nero in vari altri business in giro per il mondo. Affari e proclami. Slogan per la patria e soldi all’estero. Con altri intrecci, ancora da esplorare: tifo e periferie. Perchè molti dei giovanissimi soldati di Roberto Fiore oggi vengono arruolati tra i giovani dei quartieri di Roma Nord, San Giovanni, Appio, ma anche nelle borgate dimenticate dalla politica. E sugli spalti dell’Olimpico. Nella curva nord della Lazio, in particolare. E da qualche tempo anche tra gli ultras della Roma. La ragazza che ha partecipato al blitz sotto le redazioni di Espresso e Repubblica, per esempio, fa parte degli Irriducibili della Lazio. Una fetta di tifoseria che si è fatta conoscere per le posizione violente, razziste, antisemite, xenofobe. In una parola, neofascisti.
Marco Tarchi: «L'estrema destra è sempre più forte per colpa dei partiti». «Il neofascismo è un frutto avvelenato della globalizzazione ed è sempre più forte in Italia e in Europa» dice il politologo, che avverte: «L'estremismo non è il populismo, hanno programmi completamente differenti», scrive Federico Marconi il 27 luglio 2017 su "L'Espresso". «La società è attraversata da un profondo senso di disagio. I partiti tradizionali e i nuovi populismi non danno risposte convincenti. Per questo le persone decidono di affidarsi a portatori di ipotesi più radicali». E così l'estrema destra torna alla ribalta. A parlare è Marco Tarchi, uno che la destra ce l'ha nel sangue: lo zio Angelo è stato ministro della Repubblica di Salò, lui sin da giovanissimo ha militato nel Msi. Ne è stato cacciato nel 1981 per le sue posizioni in contrasto con la linea di Almirante. Poi si dedica alla ricerca: professore di scienza politica a Firenze e studioso del fenomeno del populismo. Dal 1994 non si considera più di destra.
Professore, l'estrema destra ha una proposta politica nuova? O adotta nostalgicamente ricette del passato?
«Ognuno di questi movimenti rivendica una serie di caratteri di novità e si difende dall’accusa di replicare sistematicamente i modelli del passato. Gli sforzi per distinguersi sono notevoli e continui. Basti pensare al “mutuo sociale” o alla prassi delle occupazioni di palazzi sfitti per darli in uso a canoni molto bassi a famiglie autoctone. Per questo non possiamo parlare di “fascismo del terzo millennio”: è una contraddizione in termini».
Alcune posizioni sembrano simili a quelle dei movimenti populisti...
«Credo sia opportuno dire che l'estrema destra ha ben poco da spartire con il populismo. Sebbene molti insistano nel confonderli, i due soggetti sono strutturalmente ben distinti: non interpretano nello stesso modo i concetti-base a cui si richiamano, non hanno la stessa visione del mondo e della società, non hanno la stessa considerazione degli strumenti che impiegano in politica. Tanto per dirne una: se per i populisti la democrazia è il regime ideale, che andrebbe realizzato integralmente tramite il ricorso a canali di espressione diretta, senza mediazioni istituzionali, per gli estremisti di destra, invece, è un regime criticabile, perché rovescia il principio di autorità ed è soggetto alla volubilità delle masse. E ancora: i partiti populisti credono che le elezioni svolgano una funzione essenziale non solo per raggiungere il potere ma anche per mantenerlo ed esercitarlo, mentre per l’estrema destra le urne sono solo un’obbligata scorciatoia per raggiungere lo scopo, se non se ne possono trovare altre».
Perché questo estremismo sta tornando prepotentemente alla ribalta?
«Perché esistono problemi gravi la cui influenza sulla mentalità e sulle condizioni di vita dei cittadini sta crescendo e a cui le altre componenti della classe politica non sanno o non vogliono dare risposte convincenti. Il caso dei fenomeni migratori di massa è il più evidente, anche se non il solo. Oggi ampie fasce della popolazione sentono minacciati due aspetti cruciali del loro patrimonio socioculturale: il loro livello e modo di vita, per le ricadute negative della globalizzazione e per il contatto forzato con estranei, sempre più numerosi. I partiti maggiori pensano di arginare queste pulsioni insistendo a divulgare una sorta di catechismo del politicamente corretto da recitare quotidianamente, secondo cui gli immigrati sono una risorsa, la loro presenza arricchisce la società sotto ogni punto di vista, non si può far niente per farne cessare l’arrivo, e così via. Questa ricetta non funziona, o quantomeno funziona solo sui già convinti. E crea spazi potenziali per la crescita dei movimenti di estrema destra».
Questo nuovo protagonismo non è un fenomeno solamente italiano, bensì europeo.
«Esattamente, e corrisponde a problemi di portata continentale, se non mondiale. È uno dei “frutti avvelenati” della globalizzazione. Chi pensava che dalle trasformazioni indotte da questo sconvolgimento si sarebbero potute trarre solo conseguente positive, è stato pienamente smentito. E poiché l’estrema sinistra non è riuscita a dare risposte adeguate, il campo è stato lasciato libero all’estrema destra».
Quali responsabilità hanno i partiti tradizionali?
«I partiti maggiori pensano di arginare queste pulsioni divulgando un catechismo del politicamente corretto da recitare quotidianamente: “gli immigrati sono una risorsa”, “la loro presenza arricchisce la società”, “non si può far niente per farne cessare l’arrivo”, e così via. Questa ricetta non funziona, o quantomeno funziona solo sui già convinti. E crea spazi potenziali per la crescita dei movimenti di estrema destra».
Alla propaganda 2.0 attraverso i social network questi gruppi coniugano un forte radicamento sul territorio: è questa la loro forza?
«Non c’è dubbio che internet abbia offerto a questi movimenti di nicchia un canale di espressione in grado di moltiplicare il pubblico di riferimento. Tuttavia tra il raccogliere “mi piace” e il riuscire a mobilitare fisicamente i propri sostenitori, il fossato è ampio. Quindi il lavoro sul territorio rimane cruciale per ottenere visibilità e raggiungere nuovi consensi. Che in qualche caso – molto pochi, per la verità, almeno per il momento – possono tradursi in voti per liste presentate alle elezioni in sede locale, là dove le situazioni di disagio sono più sentite. Ma è improbabile che questi gruppi possano trovare alleati per le elezioni politiche: finirebbero col rovinarsi la fama di “duri e puri”, a cui tengono molto, con il rischio di nuove scissioni».
Alle ultime elezioni amministrative le liste di estrema destra hanno ottenuto moltissimi voti. Ritiene che nelle prossime elezioni politiche usi possano ripetere i risultati ottenuti a livello locale? Quali potrebbero essere le possibili alleanze?
«Moltissimi, non direi: sono cifre sotto il (o attorno) 10%, che fanno impressione per l’immagine di estremismo delle liste. Condensano gli umori di cui dicevo prima. Che questi gruppi possano trovare alleati mi pare molto improbabile; e se ne avessero, finirebbero col rovinarsi la fama di “duri e puri”, a cui tengono molto, con il rischio di nuove scissioni. Comunque, i loro eventuali successi locali dipenderanno dalla (in)capacità dei concorrenti di dare risposte ai problemi che li alimentano».
La Lega Nord di Salvini sembra stia flirtando con politici e gruppi di estrema destra. Da attento studioso del partito sin dai suoi albori, come se lo spiega?
«Nella strategia di allargamento ad altre zone del paese, la Lega aveva bisogno di militanti in grado di preparare e non far fallire alcune manifestazioni tenute nel centro-sud, a partire da Roma. Per questo, e non per altro, ha accettato di fare da punto di riferimento a CasaPound. Ma l’idillio è durato lo spazio di un mattino. Certo, a Salvini non dispiacerebbe intercettare i consensi di quella fetta di elettorato che vede nell’opposizione radicale all’immigrazione il motivo essenziale per decidere per chi votare, e che potrebbe altrimenti confluire su liste gruppuscolari o preferirle Fratelli d’Italia. Si spiega così la solidarietà al bagnino nostalgico di Chioggia».
Il numero di azioni violente da parte di militanti di estrema destra è fortemente cresciuto negli ultimi anni. Perché questo ricorso alla violenza fisica?
«Molte di queste azioni vanno ricondotte allo scontro con gruppi di estrema sinistra, e rimandano al problema dei comportamenti legati alla psicologia dell’estremismo. Estrema destra ed estrema sinistra hanno un fisiologico bisogno di costruirsi e coltivare un nemico principale contro il quale dirigere la propria ostilità. A volte danno l’impressione di non riuscire a sentirsi vive se non si motivano tramite questo procedimento di identificazione in negativo. Certo, entrambe hanno altri obiettivi polemici, ed anzi spesso, per cercare di rimediare alla sensazione di inferiorità psicologica in cui vive, l’estrema destra proclama di non riconoscersi più nella dialettica oppositiva sinistra/destra, ma sul piano della violenza questo resta il terreno principale di scontro. Poi ci sono altri bersagli contro cui l’estrema destra si scaglia, ed è ben noto che gli immigrati – e non i grandi capitalisti, i finanzieri o gli “eurocrati” di Bruxelles, che pure a parole sono oggetto di critiche non meno feroci – sono i più frequenti. In questo influisce senz’altro quel complesso bellicistico che si ricollega all’esaltazione del “guerriero” come figura esemplare, di cui ho già fatto cenno. Questo tratto è uno dei tanti che fa da spartiacque nei confronti dei populisti, che esaltano invece il pacifico uomo qualunque, vessato dai potenti e minacciato dagli estranei, e che non mostrano mai un particolare fervore per militari e guerre, di cui anzi in genere diffidano».
La destra (peggiore) può tornare a vincere. Sovranisti, populisti, anti-parlamentaristi, nazionalisti, no tax, no migranti, fascisti... Si era mimetizzata ma dopo il voto nelle città ha rialzato la testa. E rischia di dominare nelle prossime elezioni. Sotto il comando di Berlusconi, scrive Marco Damilano il 04 luglio 2017 su "L'Espresso". «Non c’è una sufficiente consapevolezza di un pericolo a destra nella vita politica italiana», ad avvertirlo, sembra preistoria, era stato Aldo Moro, in un consiglio nazionale della Dc nel 1961, all’indomani della fallita svolta autoritaria del governo Tambroni. Viene la vertigine, perché da allora sono passati decenni, repubbliche, riforme costituzionali, partiti secolari sono tramontati, leadership scintillanti sono appassite, ma resta l’errore di avversari e analisti: la sottovalutazione, la mancanza di consapevolezza, l’incapacità di vedere cosa si muove nel profondo, nel sotterraneo della società. E come un fantasma, un fiume carsico che riaffiora appena trovi lo sbocco, in questa estate 2017 di deserto della politica, di piazze vuote e urne prosciugate, rispunta la Destra. Si era quasi dimenticata di esistere, come soggetto politico unitario. Si era camuffata, nascosta, mimetizzata, in una legislatura che l’ha vista divisa in mille rivoli: un frammento attorno a Angelino Alfano a puntellare i governi guidati dagli uomini del Pd (Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni) in cambio di poltrone di lusso, un drappello di leghisti e di fratelli d’Italia di discendenza più mussoliniana che garibaldina, il corpaccione berlusconiano in apparenza dormiente, assente, in coincidenza con l’impeachment del suo Capo cacciato dal Parlamento e ridotto ai servizi sociali dopo la condanna in Cassazione del 2013. E poi l’indecifrabile esercito del Movimento 5 Stelle che ostentava equidistanza, né di destra né di sinistra, incolore come uno schermo trasparente o come il camaleonte, che assume di volta in volta i colori degli avversari. Invece, al momento giusto, nella fase finale della legislatura, quando al voto politico mancano pochi mesi, eccola ritornare, la Destra italiana, con le sue molteplici facce. Sovranista, nazionalista, populista, no tax, no migranti, anti-parlamentarista. E fascista. Dopo il ballottaggio delle elezioni amministrative di giugno è il centrodestra «l’attore dominante», si legge nel report post-voto dell’Istituto Cattaneo, che vince in un comune su due, conquista stabilmente le regioni del Nord, mette radici sempre più stabili in Emilia e in Toscana, l’ex cuore rosso del Paese, e nel Centro Italia dove Lazio e Abruzzo, regioni amministrate dal centrosinistra, tornano in bilico. Il Sud si astiene o resta a guardare (con l’eccezione della Puglia di Michele Emiliano) e si conferma un terreno dello scontro che verrà nel 2018, diviso tra ribellismo e rassegnazione, ma non governativo e non rappresentato dalle leadership regionali, tutte in mano al Pd. Se dalla fredda analisi dei dati quantitativi si passa alle ragioni della valanga neroazzurra, ai temi utilizzati in campagna elettorale e ai suoi uomini più rappresentativi cadono molte raffigurazioni circolate a livello nazionale. Ad esempio quella di un centrodestra di «chiaro profilo liberale, moderato, basato su radici cristiane, vincente in tutta Europa e oggi anche in Italia», come recita il burocratico comunicato di Berlusconi all’indomani del voto, emesso da Arcore. È il ritratto di un centrodestra simile ai democristiani di Angela Merkel, il Ppe, il partito popolare europeo che ha portato alla presidenza del Parlamento di Strasburgo l’italiano e forzista Antonio Tajani. Piacerebbe molto a Gianni Letta e a un pezzo di Forza Italia che non vuole finire egemonizzato da Salvini. Peccato a che a Monza, 11,6 chilometri e 26 minuti di macchina da Arcore, la coalizione berlusconiana abbia riconquistato il comune presentandosi con un volto decisamente diverso. Tra i più votati della coalizione del sindaco berlusconiano Dario Allevi c’è Andrea Arbizzoni di Fratelli d’Italia, quarto consigliere più votato in assoluto per numero di preferenze con lo slogan “Difendi Monza”, una campagna tutta su immigrati, topi, strade sicure, presidio alla stazione, difesa della gente «che non si sente sicura a prendere il treno o un caffè». Tra i sostenitori c’è Lealtà Azione che si rifà a Leon Degrelle e a Corneliu Codreanu, non esattamente campioni di moderatismo e liberalismo, per l’associazione di estrema destra il sindaco sconfitto di centrosinistra Roberto Scanagatti aveva chiesto il divieto di manifestare per commemorare la Repubblica di Salò il 25 aprile. «Non ci voleva dare gli spazi e ora andiamo direttamente in Comune», esulta su Facebook Stefano Di Miglio, presidente di Lealtà Azione. La lista Fasci italiani del Lavoro, che a Sermide nel mantovano ha preso il 10 per cento e ha portato Fiamma Negrini in consiglio comunale, non è un caso isolato. A Lucca la lista di CasaPound ha conquistato il 7,8 per cento, più del Movimento 5 Stelle, con Fabio Barsanti, capo ultras della Lucchese. A Todi, nella rossa Umbria, CasaPound ha eletto un consigliere comunale e si è apparentata con il centrodestra che ha strappato il comune al Pd, senza troppi problemi degli altri partner della coalizione (quelli che Berlusconi vorrebbe moderati, liberali, europei eccetera). Protesta contro lo Ius soli e saluto fascista: così l'estrema destra decide di manifestare il proprio dissendo alla legge in discussione al Senato. Dopo il sit in a Palazzo Madama con CasaPound, Forza Nuova sceglie di marciare per la città invocando il Duce. Tra i blindati della polizia, braccia tese intorno a piazza Cavour, sulle note di "Camicia nera la trionferà". Al termine del corteo 50 persone sono state denunciate per manifestazione non autorizzata, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e apologia di fascismo. Di Giulia Torlone. Manifestazioni di CasaPound si sono viste a La Spezia e a L’Aquila, comuni strappati alla sinistra, il neo-sindaco del capoluogo abruzzese è anche un ex militante, anche se, garantisce il leader di CasaPound Simone Di Stefano, sono solo convergenze locali, a livello nazionale le distanze restano enormi, ci mancherebbe. Ma intanto con questi risultati diventa concreta la possibilità che liste di estrema destra si candidino in Parlamento per superare lo soglia del tre per cento alla Camera, con l’attuale legge elettorale. Sarebbe la nascita, in Italia, di qualcosa di simile ad Alba Dorata in Grecia. E, dopo tanto parlare di nuovo in politica, in Parlamento tornerebbero i saluti romani. Solo estremisti, certo. Ma temi, battaglie, parole d’ordine, fanno scuola anche nel cuore del centrodestra vincente. Immigrazione. Frontiere chiuse. No allo ius soli, che il centrosinistra ha portato in aula alla vigilia del voto, dopo anni di paralisi. Il sindaco eletto di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, Forza Italia, ha strappato alla sinistra la sua Stalingrado dopo settant’anni sventolando la bandiera del no alla moschea. A Budrio, alle porte di Bologna, la sinistra è passata all’opposizione, nella cittadina sconvolta dal delitto di Igor il russo, ancora latitante. E Salvini ha percorso in lungo e in largo i paesini liguri, emiliani, toscani. «Buongiorno da Marliana, qui suonano le campane e girano le palle!», ha salutato il leader della Lega in diretta Facebook dalla cittadina di 3200 abitanti in provincia di Pistoia dove erano arrivati 48 profughi. La sinistra litiga sulla rete e organizza gli apericena, la destra assalta il territorio più remoto e le sue paure. La Lega non fa sparire del tutto ma mette in dissolvenza il no all’euro, in Francia non ha portato grandi consensi a Marine Le Pen e sembra un tema spuntato, mentre immigrazione, Islam, sicurezza sono vita quotidiana. E a differenza del Front national in Francia o del partito per la Libertà di Geert Wilders in Olanda, gli sconfitti delle elezioni 2017, la Lega amministra da decenni comuni e le regioni più ricche e europee d’Italia. Per l’autunno i presidenti di Lombardia e Veneto Roberto Maroni e Luca Zaia preparano un referendum consultivo per ottenere maggiore autonomia per l’ente da loro governato. Un voto più simbolico che altro, eppure si trasformerà in un nuovo successo per la Lega, con Berlusconi costretto a inseguire. Immigrazione e sicurezza sono il campo elettromagnetico che attrae l’elettorato che vota centrodestra. Compreso quello che, nel primo turno delle elezioni amministrative, ha votato per il Movimento 5 Stelle. Le ricerche dell’Istituto Cattaneo dimostrano che per M5S si è chiusa la prima fase “movimentista”, quella dei meetup, tendenzialmente di nuova sinistra, ambiente e consumi, e la seconda “identitaria”, quando bisognava trasformare il movimento in un soggetto strutturato. In questa fase “tattica” gli elettori si mescolano più facilmente con il centrodestra per due motivi: perché anti-renziani, e dunque votano tutto quello che si oppone al Pd, e per una vicinanza ad alcuni temi della destra. Per citare le ultime settimane: la polemica contro le Ong che fanno salvataggio in mare per i migranti, la svolta securitaria a Roma di Virginia Raggi contro i rom e l’accoglienza dei profughi, l’astensione al Senato sullo ius soli (che vale voto contrario), l’inserimento tra nel pantheon del leader del Msi e capo gabinetto della Repubblica di Salò Giorgio Almirante da parte di Luigi Di Maio, e sì che nel 2014 Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio si erano contesi con Renzi l’eredità di Enrico Berlinguer. Una sovrapposizione di elettorati che preoccupa Renzi. Il segretario del Pd era il campione della nuova politica post-ideologica, tutta modernità e comunicazione, doveva essere il primo leader che alla guida di un partito di sinistra riusciva a penetrare nell’elettorato moderato, berlusconiano, di destra. E invece l’operazione sfondamento appare fallita: ai ballottaggi il centrosinistra si blocca, non prende i voti del fronte avversario o degli esclusi dal secondo turno, anzi, perde per strada i suoi elettori. Renzi non è amato a sinistra, e si sapeva, ma non recupera a destra. Si è ripetuto alle amministrative il fenomeno del 4 dicembre, quando sul no al referendum costituzionale si sono saldati il centrodestra al completo, da Forza Italia alla Lega a Fratelli d’Italia, il Movimento 5 Stelle e un pezzo di sinistra, compresa quella di Pier Luigi Bersani che allora era ancora dentro il Pd. «Il Pd mostra una crescente difficoltà a vincere nel turno elettorale decisivo», scrive il Cattaneo. Una conclusione che avvicina Renzi a certi campioni di calcio del passato, a volerlo nobilitare un Michel Platini: estroso e carismatico, ma perdeva tutte le finali. E ora appare isolato nel suo partito, attaccato dal fondatore Romano Prodi e da tutti gli ex segretari, da Walter Veltroni a Dario Franceschini. Si è rialzato il muro della Destra, e adesso a sgretolarlo non sarà Renzi, per paradosso l’unico a poterlo fare è l’uomo che lo ha costruito nel 1994, Silvio Berlusconi. L’uomo di Arcore è dilaniato tra un doppio destino che gli sembra ugualmente infelice. Diventare il padre nobile del listone di centrodestra, la fusione o la federazione Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, che finirebbe presto egemonizzato da Salvini e da Giorgia Meloni, come ha capito il presidente della Liguria Giovanni Toti, vincitore a Genova e a La Spezia, pronto a mollare Berlusconi per la nuova alleanza. Oppure prepararsi a fare da stampella a una leadership traballante come quella di Renzi. Tutto dipenderà dalla legge elettorale, ma non è detto che basti. Anche perché, per sfuggire al triste dilemma dei due Mattei, Berlusconi sta coltivando i due schemi contemporaneamente. Un piano A e un piano B, saranno le circostanze a stabilire quale sia quello prioritario. E sta preparando, di conseguenza, una doppia leadership futura. Il piano A prevede di andare da soli alle elezioni con Forza Italia, con il volto rassicurante, popolare, merkeliano e europeo, il capofila in quel caso sarà il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, già portavoce di Berlusconi a Palazzo Chigi nel 1994, forzista della primissima ora ma inserito stabilmente nell’establishment del Ppe europeo, in ottimi rapporti con i democristiani tedeschi che spingono su Berlusconi perché scelga lui. Se la Merkel, come sembra, dovesse vincere le elezioni di settembre in Germania, Tajani potrebbe fare nel 2018 come il suo predecessore Martin Schulz, lasciare la presidenza dell’europarlamento per correre alle elezioni nazionali come candidato premier di Forza Italia. In rottura con Salvini e Meloni e possibile alleato di Renzi dopo il voto. Anche nel piano B, il listone unico Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia, Berlusconi non ha nessuna intenzione di affidare la guida a un leghista. Ed è già stato testato in questa campagna amministrativa, senza dichiararlo, l’appeal elettorale di un altro forzista della prima ora, ma di segno opposto rispetto a Tajani, il giornalista televisivo Paolo Del Debbio. Conteso dai candidati nelle città come un talismano, un portafortuna. Sul palco a Genova, facendo finta di zoppicare, «colpa delle buche», nella sua Lucca con Salvini e Toti, in apertura e chiusura di campagna, a Como con Maria Stella Gelmini, a Sesto San Giovanni, a Monza dove il filosofo si è lasciato andare: «Sono comuni di merda quelli che obbligano i cittadini a rivolgersi alla televisione per risolvere i loro problemi!». Acclamato ovunque come si addice a un leader in rampa di lancio. Tajani e Del Debbio sono due volti di un identico berlusconismo. Ritorna la Destra ed è sfaccettata, come sempre è stata la destra italiana, multiforme, ideologicamente inconsistente, e c’era il fascismo di destra e il fascismo di sinistra, e c’era il liberale conservatore e il rautiano sociale, e c’era la destra confindustriale che si opponeva alla nazionalizzazione dell’energia elettrica e quella militare tentata dal golpe e quella clericale legata al Vaticano. Eppure la destra è solidissima nel suo radicamento, nella difesa spietata dei suoi interessi, nel suo blocco sociale di riferimento, quello che manca alla sinistra in tutte le sue sfumature, dalla leggerezza di Renzi al rancore di D’Alema, è questa la mucca nel corridoio di cui vagheggia Bersani. Questa Destra così disunita e così minacciosa ha ancora bisogno di Berlusconi per mettersi insieme. E solo lui la può far saltare: conclusione amara dopo anni di rottamazioni annunciate, partiti della Nazione che perdono nei paesi, leadership innovative più nella presunzione che nella realtà. Per parafrasare Heidegger, solo un Berlusconi ci può salvare. Altrimenti, rivincono loro.
Noi italiani nati con la camicia (nera), scrive Tommaso Cerno il 12 luglio 2017 su "L'Espresso". La voglia di fascismo? È indole italica, ci conosciamo: tanti, piccoli capetti. Sta dilagando e non ci cambierà una legge. Allarme (non più All’armi) siam fascisti! Come può essere capitato? A noi (pardon), noi italiani democratici che abbiamo scritto la Costituzione vietando al partito che fu di Mussolini di rinascere. “L’Espresso” ci fece una copertina qualche settimana fa. C’erano Grillo, Salvini e Berlusconi con fez e manganello. Tempesta di critiche. E avevano ragione (a propria insaputa) i lettori (di destra) che ci hanno ricoperti di insulti. Non dovevamo disegnare solo loro, ma gli italiani: il popolo nato con la camicia (nera) convinto di avere fatto i conti con la propria indole, prima ancora che con la storia, a suon di leggi e divieti. Voilà, tutti antifascisti mimetizzati nella democrazia, senza risolvere mai quel problemuccio: ci conosciamo, siamo piccoli capetti che danno ragione al capetto più in alto. A casa, in Parlamento, al bar, su Twitter. Ed è questa normalità, mescolata a nostalgia della nazione e maschilismo diffuso, l’arma segreta del fascismo, la sua intima natura. Si chiama conformismo, fino a quando di mezzo non ci sono guerra, galera o esilio. Ma è lo stesso vizio di obbedire che fa ripetere in televisione a tutti le cose che dice il capo. Lo stesso vizio che ci fa parlare del fascismo per non parlare dei migranti. Qualche giorno fa, un signore per strada mi dice: «Troppi immigrati, non possiamo mica...». Io rispondo: «Ha ragione, spariamo ai barconi con donne e bambini, così la smettono». Lui alza la testa e fa: «Ma che dice, è scemo?». Io: «Allora rimandiamoli in Libia. Donne stuprate, bambini torturati». E lui: «Stuprate? Ma allora come si fa?». Ho pensato che questo tipo di dialogo, ai tempi della politica, spettava ai cosiddetti corpi intermedi. Quelli che nel fascismo non c’erano ed erano nati con la Repubblica. Quelli che stiamo eliminando per spending review. Demolendo con l’insulto, nel nome dello spreco, assieme alla base stessa di una democrazia raziocinante. Gli immigrati diventati un problema sono la vera emergenza, dentro cui come un fungo velenoso riemerge il fascismo, non certo i busti del duce o le iscrizioni dell’Eur. La retorica antifascista che ci ha protetti finora, ci ha dato solo l’impressione dello scampato pericolo. Ha commemorato, non ha ricordato. Memoria significa fare i conti con il fascismo interiore. Noi non l’abbiamo fatto, né prima processando il regime, a differenza dei tedeschi, quando mezzo Paese transitava dalla dittatura alla Repubblica, né dopo. Gli unici conti sono stati fatti a piazzale Loreto, epilogo interiorizzato solo nella letteratura. Penso a Levi, Fenoglio, Pavese. E alla guerra civile di Claudio Pavone. Paradossalmente il “dovere antifascista” della prima Repubblica è ciò che ha permesso di non indagare davvero sul fascismo e che ci riporta a Chioggia, decenni dopo, a rivendicare il “diritto fascista”. La colpa è nostra, non di quei loschi figuri. Abbiamo fatto una “defascistazia” lessicale. E come il politicamente corretto non cancella il razzismo, né ridà la vista a un cieco chiamandolo “non vedente”, professare l’antifascismo per legge ci ha portati a una ipnosi, alla rimozione della pregiudiziale storica che credevamo eterna. Pregiudiziale che ormai cade dappertutto. Nel giugno 1945, l’Onu non nasce come parlamento delle nazioni, ma come organizzazione delle nazioni che hanno combattuto l’Asse, con i 5 membri permanenti del consiglio di sicurezza usciti vincitori dal conflitto. Quel mondo sta andando a pezzi. Trump non sa che farsene (è il primo presidente Usa che a Varsavia non visita il monumento degli insorti nel ghetto e ci manda l’ebrea Ivanka), non perché sia fascista, ma perché - a differenza di Bush - è espressione di un mondo che ha perso i legami con la sua storia. Con Norimberga e l’atomica, ma perfino con la Guerra fredda. Cina e India? Per loro l’antifascismo non ha significato storico né culturale. Putin? Per i sovietici la conquista di Berlino fu per decenni il certificato di appartenenza al mondo civile, mentre oggi il presidente russo interpreta la vittoria sul nazismo con una semantica neo-zarista. Perfino Netanyahu ha fatto fare dietrofront all’ambasciatore israeliano a Budapest dopo la protesta contro i manifesti anti-Soros (di sapore antisemita) voluti da Orbán. E via elencando. A questo punto una domanda: siamo sicuri che serva una legge per fermare questo e salvare la democrazia? O forse il problema sta in chi ci rappresenta? Scrisse Bauman: viviamo l’era del divorzio tra potere e politica. La democrazia non è più considerata “valore in sé” da milioni di persone, non perché manchino leggi antifasciste, ma perché i politici possono solo promettere, senza poi attuare tali promesse. E allora che senso ha criticare? Che senso ha votare?
Il pericolo farsista, scrive Marcello Veneziani. MV, Il Tempo 3 dicembre 2017. Siamo alla paranoia ideologica virale. Una bandiera del Secondo Reich, che era una monarchia costituzionale ottocentesca, tenuta in caserma da un ragazzo carabiniere di vent’anni, diventa il pretesto del giorno per gridare al Nazismo risorgente, che non c’entra un tubo con la bandiera e con la storia del secondo Reich. L’uso fake della storia sconfina nel delirio persecutorio. Ma non basta. In pieno autunno del 2017, un benemerito compagno ha scoperto una cosa tremenda: il 20 maggio del 1924, la città di Crema conferì su proposta della giunta locale la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. L’orrenda scoperta ha subito compattato il valoroso popolo de sinistra – enti, associazioni, partiti e sindaca, oltre l’ineffabile Anpi – che ha intimato di provvedere subito a ritirare l’atto osceno in luogo pubblico. Togliendo la cittadinanza onoraria di Crema a Mussolini avremo finalmente un Duce scremato. Tempestivo, non c’è che dire, se ne sentiva l’urgenza, 93 anni dopo. Ma come dice un proverbio politicamente corretto, Chi va piano va Fiano e va lontano. E’ tutta una gara in Italia per scoprire e revocare la cittadinanza onoraria al Duce in un sacco di comuni. Pensavo a questo eroico atto di ribellione al fascismo da parte della città cremosa mentre leggevo per il terzo giorno consecutivo commenti, anatemi e mobilitazioni contro il pericolo fascista dopo la sconcertante “azione squadrista” compiuta a pochi chilometri da Crema, a Como. La Repubblica, per esempio, ha schierato il suo episcopato per condannare il fascismo risorgente e chiamare a raccolta l’antifascismo eterno. Sui tg c’è stato un tripudio di demenza militante a reti unificate. Non avevo intenzione di scriverne, mi pareva immeritevole d’attenzione, ma la paranoia mediatico-politica non accenna a scemare.
1) Ora, per cominciare, quell’irruzione in un’assemblea pro-migranti non è di stampo squadrista semmai di stampo sessantottino. Gli squadristi, come i loro dirimpettai rossi, non irrompevano per leggere comunicati e andarsene senza sfiorare nessuno. L’abitudine di interrompere lezioni, assemblee, lavori è invece tipicamente sessantottina e poi entrò negli usi degli anarco-situazionisti, della sinistra rivoluzionaria, dei centri sociali, ecc. Gli “skin” in questione ne sono la copia tardiva, l’imitazione grottesca.
2) Secondo, i comunicati. Trovate pure demente e mal recitato, quel comunicato che gli impavidi neofascisti hanno letto interrompendo la riunione filo-migranti. A me fa sorridere, se penso ai comunicati degli anni di piombo. Vi ricordate? Davano notizie o annunci di assassini, accompagnavano attentati ed erano a firma Br, Primalinea e gruppi affini. Quando penso a quei comunicati, deliranti ma corrispondenti ad azioni deliranti e sanguinose, trovo farsesco il remake a viso aperto di quattro fasci e l’allarme mediatico che ne è seguito.
3) Terzo, la violenza di irrompere e interrompere. Succede ancora, nelle università, in luoghi pubblici, verso chi non piace ai movimenti di sinistra radicale, lgbt, centri sociali o affini. È capitato anche a me, girando l’Italia, di trovare aule universitarie e luoghi pubblici in cui non riesci a parlare o parli sotto scorta, tra interruzioni, proclami e incursioni. Di questo teppismo i giornali e i tg non ne parlano mai. E nessuna di queste anime belle che gridano indignate al pericolo fascista, ha mai espresso una parola di solidarietà e di condanna. Lo dico anche al pinocchietto fiorentino che esorta la comunità nazionale a indignarsi tutta e non solo la sua parte politica, per l’episodio di Como, anzi per la strage virtuale: lui non ha mai speso una parola per stigmatizzare episodi di segno opposto, assai più numerosi e più violenti e pretende che l’Italia insorga compatta per una robetta del genere? Diamine, ci sono ogni giorno storie di violenza e di morti, aggressioni in casa, e la comunità nazionale intera deve mobilitarsi unita di fronte a un episodio verbale così irrilevante? In realtà, voi informazione pubblica, voi governativi, voi giornaloni e associati, siete i primi spacciatori di bufale o fake news. Perché prendete una minchiata qualsiasi e la fate diventare La Notizia della Settimana, ci imbastite teoremi, prediche, rieducazioni ideologiche, campagne e mobilitazioni antifasciste. Se il pericolo che corrono le nostre istituzioni ha tratti così farseschi, allora il primo pericolo è la ridicolizzazione della storia e della democrazia da voi operata quando sostenete che sono messe a repentaglio da episodi così fatui e marginali. Non sapete distinguere tra una bomba e una pernacchia. E finirete spernacchiati.
Fascismo e antifascismo tra retorica e opportunismo, scrive Leonardo Agate l'8/12/2017 su "TP24". Francamente mi comincia a stare sulle scatole tutta questa retorica antifascista che riempie i mezzi di comunicazione di massa ogni giorno. Sia chiaro che non sono un fascista, e per questo sono antifascista, ma non mi sento di identificarmi con l’antifascismo di maniera, che è quello che non sopporto. Come, per altro aspetto, sono per la lotta alla mafia ma non faccio professione di antimafia. Il fascismo e l’antifascismo, come li abbiamo conosciuti in Italia dopo il crollo del fascismo, sono le due facce della stessa medaglia. Nel passaggio dal Regno alla Repubblica ci fu una corsa sfrenata per salire sul carro del vincitore. Il popolo fu, per fede, per opportunità o per quieto vivere, quasi interamente fascista finché il fascismo rappresentò sviluppo economico e sociale. Il limitato antifascismo crebbe con la creazione dell’asse politico Roma – Berlino, con le leggi razziali e con l’ingresso del nostro Paese nella Seconda Guerra Mondiale. A parte la limitata opposizione al fascismo, proveniente soprattutto dalla sinistra socialista e comunista, fino al 1936 il nostro Paese era massicciamente fascista. Era un regime totalitario, e fece le sue vittime fra gli oppositori, ma nulla a paragone di quello che avveniva in altre regimi totalitari come in Germania o in Russia. Si deve distinguere tra il popolo che inneggiò a Mussolini fino alla creazione dell’Impero, e il limitato antifascismo che il regime perseguì e fece soffrire. Quando il corso della Storia cominciò a cambiare, con l’avvicinamento dell’Italia alla Germania, il nascosto movimento antifascista si ingrossò, fino a sfociare nella Resistenza quando le truppe alleate cominciarono a risalire per lo Stivale. Il crollo definitivo del Regno e del regime fascista con la vittoria degli alleati diede la stura alla più veloce trasformazione degli italiani da fascisti ad antifascisti. Come se nessun consenso il regime mussoliniano avesse avuto fino al 1936, ed anche oltre, gli italiani si scoprirono in massa antifascisti. L’antifascismo che sostituì il fascismo portava nel suo DNA il virus fascista che lo aveva accompagnato per circa un ventennio. Cosicché si poteva dire che in Italia ci sono stati due tipi di fascisti: i fascisti veri e propri e gli antifascisti che li hanno sostituiti. La retorica degli uni è simile, anche se opposta, a quella degli altri. Lo abbiamo visto e sentito in ogni ricorrenza del 25 aprile. L’antifascismo di professione è quello che in queste ultime settimane vuol farci credere che ci sia un pericolo fascista da prendere in seria considerazione, solo perché un gruppo di stupidi estremisti di destra, della sigla “Veneto fronte skinhead”, ha interrotto l’assemblea della rete di associazioni pro migranti “Como senza frontiere”, per leggere un proclama contro l'invasione dei migranti. L’estate scorsa uno stabilimento balneare della riviera toscana è stato per settimane agli onori della cronaca perché il suo titolare esponeva simboli del ventennio fascista e faceva discorsi contro gli immigrati. A Predappio, dove Mussolini aveva la casa, si vendono ricordini del Ventennio, e se ne fa una questione di alta politica. Il deputato Fiano, Pd, ha presentato una proposta di legge per perseguire in modo più radicale i simboli e i comportamenti ritenuti fascisti, come se le norme della Costituzione e quelle della legge Scelba e della legge Mancino non fossero sufficienti ai giudici per perseguire e condannare i colpevoli di reati legati al possibile risorgere di movimenti fascisti. Il fatto è che l’antifascismo è una professione indolore e redditizia per chi gli si dedica: esclude una seria ricostruzione storica del periodo prima fascista e poi repubblicano; è una nuova patacca da mettersi al petto; si tratta ormai di un classico di moda, che dura ininterrottamente da oltre 70 anni. E’ stata un’autoassoluzione che ha sostituito l’orbace con la camicia bianca, mantenendo dentro il petto il pressapochismo e l’opportunismo di sempre.
“Blitz a Repubblica più grave di bomba a carabinieri”. La frase shock di Gabrielli scrive Davide Romano l'8 dicembre 2017 su "Primato nazionale". L’emergenza democratica causata dall' “onda nera” ricorda un po’ il caso Weinstein. Ovvero dopo la prima denuncia di molestie contro il produttore hollywoodiano, qualsiasi cosa, anche una semplice avances o uno sguardo equivoco, veniva innalzato al grado di “molestia sessuale” dall’ultima “vittima” in cerca di notorietà. L’antifascismo ai tempi della propaganda di Repubblica è al pari di una giornata mondiale contro la violenza di genere o ad un hashtag come #metoo. Non serve più nessun aggancio alla realtà per indignarsi o lanciare “l’allarme”. Basta la lettura di un volantino, una bandiera appesa in una caserma e un blitz di 8 persone con 4 fumogeni sotto un giornale per gridare ai quattro venti che “la democrazia è in pericolo”. E il vero pericolo è che a questo tipo di montatura diano fiato e corda il ministro della Giustizia e quello dell’Interno, oltre ad altri esponenti di peso nelle istituzioni. L’ultimo è il capo della Polizia Franco Gabrielli, un tempo noto, oltre che per l’assenza di scrupoli, anche per un certo pragmatismo. Per questo le sue ultime dichiarazioni rispetto alla dimostrazione di Forza Nuova sotto la sede di Repubblica e l’Espresso lasciano di stucco. Commentando l’ordigno esploso davanti ad una caserma dei carabinieri nel quartiere San Giovanni di Roma ha dichiarato: “È un fatto grave ma non dobbiamo amplificarlo oltremodo. Questi episodi sono avvenuti anche in passato. Vorrei quindi dare un messaggio di rassicurazione. Per certi aspetti ritengo molto più grave la piazzata che è stata fatta ieri nei pressi della redazione di un gruppo editoriale importante”. Un ordigno esploso davanti ad una caserma dei carabinieri con tanto di rivendicazione anarchica, è meno grave di una piazzata. Il primo va minimizzato, il secondo amplificato. Questo ci sta dicendo il capo della Polizia, senza tanti giri di parole. Se un tempo la prassi era la distorsione della realtà da parte dei media, ormai siamo arrivati alla sostituzione della realtà, ovvero ciò che è reale lo decide Repubblica e le istituzioni seguono. In questo modo “vale tutto”, eliminato il reale dall’informazione, dalla politica, dalle istituzioni e dal diritto, qualsiasi provvedimento, anche il più illiberale e ingiusto, può essere giustificato. Mala tempora currunt.
Il petardo neofascista contro “Repubblica” e i veri pericoli. L’indignazione per la dimostrazione di Forza Nuova? Ennesimo esempio di un’ansia comprensibile ma non giustificabile, scrive l'8 dicembre 2017 Corrado Poli su "Vvox" (Primaonline.it). Quattro disadattati fanno esplodere un petardo davanti alla sede di Repubblica e immediatamente non par vero che si possa sollevare un’indignazione antifascista fuori misura. Come se migliaia di drappelli marciassero su Roma per occupare le “aule sorde e grigie” del Parlamento. Basta il poco fumo di un petardo di Capodanno per ravvivare la nostalgia della ormai usurata contrapposizione tra fascisti e antifascisti e confondere ancor più le idee. Ci si domanda se si tratti di un fenomeno di ansia patologica o di strumentalizzazione di fatti quasi irrilevanti. L’ansia è comprensibile. Il fascismo rievoca le grandi tragedie del Novecento e sul linguaggio antifascista è cresciuta la riconquistata democrazia e la sua successiva retorica. Il tempo passa e la democrazia è invecchiata; fascismo e guerra li conosciamo solo per sentito dire. L’ansia invece è una patologia e va curata altrimenti ci si concentra su pericoli immaginari e ci si distrae dalle questioni reali. I veri pericoli in Europa vengono dallo s-fascismo delle destre demagogiche di oggi con il solo programma della conquista del potere; e dalluogocomunismo delle sinistre che, essendo state progressiste oltre mezzo secolo, oggi ripetono insignificanti lotte, vecchi slogan e narrazioni nostalgiche. Così ci battiamo contro un inesistente neoliberismo che è invece un corporativismo travestito come nel progetto degli autentici fascisti; ed è allo stesso tempo uno statalismo simile al comunismo sovietico. Entrambi pervadono le soi disantes democrazie liberali occidentali. Di liberista non c’è nulla in Europa se non le piccole imprese, i lavoratori a contratto e i professionisti – quelli che ho definito i prof-letari. Sono cittadini politicamente non rappresentati e quindi davvero potenzialmente rivoluzionari sebbene non violenti. In assenza di un’ideologia solida, a stento si accorgono della loro condizione e il loro voto vaga a casaccio tra l’astensionismo, la destra demagogica e la sinistra luogocomunista. In Italia si avvicina in parte crescente ai Cinque Stelle, l’unico partito europeo alternativo ma “di centro” che prescinde da vecchi modelli politici (anzi politologici). Un Movimento che però non ha ancora elaborato un sistema di pensiero il cui consolidamento ne faciliterebbe la comprensione da parte di un più ampio e stabile elettorato potenziale. Così succede che l’ansia e i vecchi linguaggi portino a confondere un petardo con il pericolo fascista e i ripetitivi congressi delle plurisinistre luogocomuniste con un partito che crede di essere progressista mentre in realtà insegue i fantasmi del futuro di ieri. Purtroppo il progetto economico e sociale comunista e fascista ha già sconfitto le liberal-democrazie che per fortuna conservano ancora il pluralismo politico. Oggi, secondo il progetto economico totalitario fascio-comunista – che potremmo definire di modernizzazione integrale, un obiettivo quasi generale degli anni trenta del novecento – s’è affermato lo strapotere delle grandi imprese, di immense banche, quello delle corporazioni sindacali e di categoria, delle mastodontiche burocrazie autoreferenziali e infine degli eserciti che per ora – non si sa per quanto – stanno tranquilli (ma Berlusconi ha già fatto il nome di un generale come capo del governo)! Lasciamo perdere Forza Nuova e i quattro violenti di sinistra: se delinquono, se ne occupi la polizia e la politica li ignori. I veri pericoli sono da una parte lo sfascismo che induce al totalitarismo di destra; dall’altra una bieca conservazione luogocomunista che vuole trasformare l’Italia in una casa di riposo. Le forze vitali del Paese e dell’Europa sono da una parte il conservatorismo decente delle grandi coalizioni che consente la stabilità. Dall’altra la formazione di movimenti autenticamente progressisti con al centro dei loro programmi una politica federale e comunitaria solidale che ponga al centro la questione ambientale e avvicini al cittadino semplici e legittime istituzioni. Costoro, sia che vadano al governo (contenuti dall’opposizione e dalle strutture burocratiche) sia che restino all’opposizione (incalzando la conservazione) possono svolgere un ruolo fondamentale di progresso civile, intellettuale e in definitiva riformare una democrazia e un’economia sempre più scandenti. Senza lasciarci distrarre da infantili petardi e molotov che svegliano solo i nonni sordi.
L’ossessione per il fascismo del gruppo L’Espresso ora è preoccupante, scrive Giorgio Nigra il 28 luglio 2017 su "Il Primato Nazionale". Appena qualche settimana fa, l’Espresso se ne usciva con una copertina eloquente: il disegno di Grillo, Salvini e Berlusconi vestiti da squadristi, che avanzano minacciosi, manganelli in mano, in un vicolo buio. Titolo: “Ci rifanno neri”. Ecco il livello dell’argomentazione: il consenso dei grillini? La popolarità mediatica di Salvini? L’eterno galleggiamento di Berlusconi? Non servono analisi politologiche, studi sui cambiamenti avvenuti nella nostra società e magari autocritiche sull’incapacità della sinistra di saper comprendere le priorità e le sofferenze del popolo italiano. È solo l’eterno fascismo che rialza la testa. Per sconfiggerlo, quindi, basta il solito richiamo alla “Costituzione nata dalla resistenza” e l’appello a tutti i “sinceri democratici” affinché si uniscano contro la marea nera montante. Non contenti di aver fornito tali indispensabili chiavi al dibattito della società civile, domani quei simpaticoni dell’Espresso se ne usciranno con un numero la cui copertina è tutta un programma: “Nazitalia”, scritto in caratteri gotici. Il tutto in campo rosso, con al centro un cerchio bianco dentro cui campeggiano due Italie sovrapposte nere a formare una rudimentale svastica. L’Italia del 2017, insomma, vive molto semplicemente sotto il nazismo. Non sappiamo cosa ci sia dentro, ma possiamo immaginarlo: il solito dossier con i soliti numeri sparati a caso, le solite interviste all’Osservatorio democratico contro le nuove destre. Insomma, un eterno dejà vu. Come quello che si ha leggendo l’ennesima inchiesta su Repubblica di Paolo Berizzi (un giornalista già autore di gaffe e falsificazioni tali che, in un Paese normale, farebbe da tempo il correttore di bozze nel giornalino della parrocchia). Quale notizia inedita ha generato questo articolo, rispetto all’ultimo, esattamente identico, di poche settimane fa? La foto, postata sui social, di una cena di alcuni esponenti di CasaPound con altri di Lealtà Azione. Caspita, stupisce che il New York Times non vi abbia dedicato una copertina dal titolo “Anche i fascisti cenano”. Si tratta, peraltro, di una foto liberamente diffusa dai diretti interessati. Nulla di nascosto, nulla di segreto, nulla di misterioso. Ma, all’occhio vigile del giornalista democratico, una cena fra amici si rivela per ciò che essa segretamente è: un patto di sangue, un segnale para-mafioso, un messaggio in codice, il simbolo dell’ora delle decisioni irrevocabili finalmente giunta per portare l’eversione in Italia. Qual è il senso di questa cosa? Qual è il valore euristico, anche per chi è di sinistra, di servizi come questi? Quanto fanno avanzare la coscienza democratica del Paese? Si tratta, come è ovvio, di puro scandalismo, di qualunquismo a buon mercato. Spararla grossa per solleticare il pubblico, esattamente come altre testate fanno su altri argomenti. Fa tutto parte di questa estate pazza, in cui per giorni la prima notizia dei giornali è stata la “spiaggia fascista” di Chioggia. E poi l’exploit elettorale dei Fasci italiani del lavoro in un paese di 7000 abitanti, la prof che inneggia al Duce su facebook, l’assurda “pista nera” per i delitti del Mostro di Firenze, le campagne di Fiano e Boldrini contro i monumenti fascisti, i saluti fascisti, gli accendini fascisti. Tutto concorre strumentalmente a rendere l’idea di una emergenza, di una situazione da sanare. Come? Ma è ovvio con una bella legge speciale, con una bella norma liberticida. È tutto così dannatamente chiaro…
Laura Boldrini ossessionata dal fascismo, scrive il 27/09/2017 Emma Moriconi su "Il Giornale d’Italia". Nuovo attacco alle pagine di facebook, paternali infinite e coccole ai partigiani: ecco le pene della presidente della Camera dei Deputati. Laura Boldrini non trova pace, la sua "crociata", la sua "guerra santa" contro il Fascismo sembra un'ossessione, non passa giorno che non ne dica una delle sue. Ieri in occasione dell’incontro con una delegazione di sindaci e delle associazioni partigiane nel 73° anniversario dell’eccidio del Grappa, dopo aver salutato "i sindaci e le sindache" (insistendo sulla femminizzazione esasperata di ogni cosa), ha dichiarato che i cittadini di quelle terre, "insieme ai cittadini di Marzabotto, di Sant'Anna di Stazzema, ai romani che ricordano le Fosse Ardeatine" hanno "la responsabilità di ricordare cosa è stato il nazifascismo, la brutalità con la quale i nazisti trattarono i nostri giovani, la brutalità con la quale tenevano sotto scacco il nostro Paese, il loro disprezzo nei confronti degli italiani". Poi si è lanciata in una disquisizione linguistica (lei, si) sui termini "patriottismo" e "nazionalismo". Lei, Laura Boldrini. Che però Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e le Fosse Ardeatine furono scientemente provocate proprio dai partigiani non lo ha detto. Peccato. Non contenta, non paga, sempre nella giornata di ieri ha voluto precisare: "Abbiamo già rivolto ad aprile a Zuckerberg, accogliendo l'invito dell'Anpi, la richiesta di bloccare le molte pagine Facebook apologetiche del fascismo. Sono almeno 300, a dimostrazione che non si tratta di un fenomeno locale. In Italia l'apologia e' reato, quindi anche su Facebook dovrebbe esserlo. Dobbiamo insistere con facebook- ha detto ancora - che non può continuare a dire che non si occupa di fenomeni locali. Il nazifascismo è un fenomeno mondiale e bisogna dunque evitare di fomentare razzismo e xenofobia. Ispirarsi a questi principi è una minaccia all'assetto democratico". Questi i pensieri che assillano quotidianamente l'animo della "presidenta" della Camera Laura Boldrini, ogni giorno ha un pensiero da dedicare a questo argomento, del resto in effetti in Italia di problemi ve ne sono pochi, c'è giusto il tempo e l'opportunità di dedicarsi a un po' di sana demagogia. L'ossessione, poi, si intensifica sempre di più ogni giorno che passa, quello che vive l'omonima di Bulow è un vero e proprio incubo, un chiodo fisso dal quale non riesce proprio ad affrancarsi. Non riesce, la seconda carica dello Stato, a identificare con esattezza le epoche storiche, vive il Fascismo come se fosse ancora in atto, non le riesce di canalizzarlo nella storia di questa Nazione (Nazione, Patria, Paese, potremmo fare una lunga dissertazione linguistica pure noi, a dire il vero). Sorge il sospetto che questo tormentone antifascista sorga dalla consapevolezza che il suo mandato sta per giungere al termine, e siccome per l'Italia questa signora non ha fatto nulla di buono se non difendere i partigiani, questi siano diventati ormai il solo zoccolo duro che le resta nel Paese (o Patria, o Nazione, faccia lei). Un corpo elettorale assottigliato, però. E pure un po' muffito.
"Il fascismo è l'ossessione di chi non sa vivere senza nemici e rancore". L'intellettuale: "Si appigliano a leggende metropolitane per rianimare la mobilitazione", scrive Davide Brullo, Mercoledì 12/07/2017, su "Il Giornale". Sul grottesco parapiglia in cui si è arenata la discussione parlamentare sul reato di apologia di fascismo abbiamo chiesto un parere a Marcello Veneziani, un intellettuale abituato a pensare oltre i meri spot ornamentali, elettorali. La proposta di legge di Fiano e del suo partito di mandare al carcere chi vende gadget fascisti o divulga in rete immagini del Duce nasconde una insana nostalgia verso le ideologie. Nelle pagine di Storia non ci sono innocenti e non si possono eleggere «giusti» per legge. Lei come la pensa?
«C'è innanzitutto qualcosa di sproporzionato, di mostruoso, nel demonizzare per 72 anni (e non è finita) un'esperienza che è durata poco più di venti. C'è poi una ricerca ossessiva di rassicurazioni identitarie per rianimare la sinistra dispersa: l'antifascismo funziona in questo senso da sala rianimazione, restituisce un nemico assoluto a un'area che non sa vivere senza un rancore verso qualcuno (Berlusconi, la destra, il populismo) e appena ne declina uno, bisogna rimettere in piedi l'Eterno Fascismo (Ur-fascismo diceva Eco). E non si distingue più tra il neofascismo politico di una volta e il folclore, il vintage, la civetteria di esibire cimeli fascisti che non hanno alcuna ricaduta politica, ma solo sentimentale e commerciale. Cominciai a seguire la politica nei primi anni Settanta. Da allora ciclicamente ma ininterrottamente, sento parlare di un imminente pericolo fascista che serpeggia nella società. Una leggenda metropolitana che serve per rianimare la mobilitazione antifascista».
Perché fa così paura il Ventennio? Perché non studiamo a dovere cosa è stato il fascismo? A proposito, cosa è stato?
«Il fascismo non si può ridurre solo a qualcosa di criminale. Non lo farei neanche per il comunismo che per estensione, durata, vicinanza temporale, numero di vittime (in tempo di pace, si badi bene) ha prodotto crimini inarrivabili. C'è poi da chiedersi perché ancora tanta gente ha un giudizio positivo del fascismo. Non si può ricordare del fascismo la violenza, la guerra, la persecuzione razziale (che riguarda il nazismo e solo di riflesso, in modo infame e caricaturale l'ultima fase del fascismo) dimenticando le opere realizzate, la tutela sociale, l'integrazione nazionale, i passi da gigante compiuti dall'Italia nel segno della modernizzazione, la forte passione ideale e civile, il consenso... Durante il fascismo gli italiani ebbero in assoluto il maggior attaccamento allo Stato e maggior fiducia nelle istituzioni, e potrei continuare. Il fascismo fu una rivoluzione conservatrice che modernizzò il paese nel nome di valori e primati tradizionali, cercando di accordare l'avvenire del socialismo con l'eredità della nazione».
Perché, poi, simili posizioni non si esprimono nei riguardi dell'apologia del comunismo o dell'islamismo, a questo punto?
«Il paradosso è che questa ennesima ondata contro il fascismo sorge nell'anno in cui ricorrono i cent'anni dalla Rivoluzione bolscevica. Sul piano storico, è il comunismo il tema di quest'anno, la sua parabola, i suoi orrori, la stretta linea di continuità tra Lenin e Stalin, il fallimento di ogni comunismo in ogni paese e in ogni tempo, i residui tossici che sono rimasti, il passaggio dal Pc al Pd, nel senso del politically correct, il comunismo dei nostri anni. Invece il comunismo è totalmente rimosso, confinato in una dimenticata antichità, salvo qualche reperto mitico, come il Che o da noi come Gramsci e Berlinguer. Gli unici miti spendibili perché sono due comunisti che (per fortuna) non andarono al potere. Come diceva Gomez Davila, gli unici comunisti da rispettare sono quelli che non sono andati al potere».
Le manganellate contro l'apologia di fascismo ricordano simili punizioni inflitte a personaggi ritenuti scomodi. La cultura è ancora strumentalizzata per puri fini di partito ed elettorali?
«La cultura strumentalizzata rientrava ancora in una fase eroica in cui si riteneva che annettersi un autore o condannarne un altro avesse un'incidenza effettiva, e un significato. Oggi la cultura è considerata una zavorra molesta e obsoleta, irrilevante. E nei confronti degli intellettuali non riconducibili alla dominazione corrente non si pratica più la denuncia e la demonizzazione ma, peggio, il silenzio, la finzione d'inesistenza, la non considerazione come autori e scrittori. Non potendo più eliminare fisicamente il dissidente o il nemico, come accadeva ai tempi di Florenskij e di Gentile, lo si elimina moralmente, si certifica con il silenzio la sua morte civile...».
La Boldrini ha dichiarato che i monumenti fascisti urtano la sensibilità dei partigiani. Non ci resta che distruggere i monumenti e l'arte fascista, giusto?
«Se dovessimo realizzare il proposito della Boldrini dovremmo dichiarare inagibili quasi tutte le città italiane. Ovunque c'è l'impronta del fascismo e persino nelle zone rase al suolo dal sisma hanno resistito solo gli edifici fascisti. Se non c'è riuscito un terremoto ad abbatterli, figuriamoci se ci riesce un coccodè, sia pure isterico».
EMANUELE FIANO IL "DEMOLITORE". Scrive il 17 Settembre 2017 Claudio Scaccianoce su “L’Inkiesta". Premessa. Io non sono leghista, piddino, forzista, penta stellato, centrista, radicale, verde, giallo o blù… (rossonero si!). Non sono assolutamente un qualunquista ma cerco di non farmi influenzare dalle mie opinioni quando scrivo. Nessuna sponsorizzazione occulta quindi in questo mio scritto. Guardate, vi prego, alla luna e non al dito che la indica. Dito che in questo frangente è la mia tastiera. Emanuele Fiano è un parlamentare del PD. Uno che pesa alla Camera dei Deputati. Non è uno dei cosiddetti peones, ma è un esponente di primo piano nella compagine renziana. Ha la personalità giusta per fare il frontman quando si devono affrontare con fermezza i temi più delicati, quelli che spaccano, quelli che scatenano azioni e reazioni anche borderline. Non me vorrà Fiano, ma non posso non notare che ha anche un’altra caratteristica. Riesce a risultare a pelle antipatico a moltissime persone che lo vedono per la prima volta, sui social oppure in televisione. Ed infatti è uno dei bersagli preferiti degli haters da tastiera e dei militanti di base delle opposte parti politiche. Probabilmente lo è perché parla con pochi ammortizzatori verbali e punta sempre al cuore del problema. Atteggiamento onesto ma pruriginoso. E poi, in video sorride troppo poco alle telecamere. Lo conosco un cicinin essendo di Milano e rossonero come me ed avendolo intervistato (per i non milanesi un cicinin significa … un pochino) e posso dire che invece è un uomo cordiale anche se non particolarmente espansivo, ed è un uomo decisamente ironico.
Allora, come dicevamo, Fiano è per moltissime persone uno dei più illustri iscritti - suo malgrado - al club “i più odiati dagli italiani”, insieme alla Boldrini, alla Fornero etc etc. Ultimamente si è fatto promotore di una legge che rende illegale la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli fascisti etc etc. Facciamo così. Riportiamo integralmente il testo della proposta di legge, così non lasciamo adito ad interpretazioni sul testo stesso: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri dell'ideologia del Partito fascista e del Partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero fa chiaramente propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da 6 mesi a un anno. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.”
Non l’avesse mai fatto. Il web, i giornali, i social si sono riempiti di commenti ironici, di commenti crudi, di attacchi politici e personali. I meme sono fioriti come primule a primavera. Se ascoltiamo queste voci Fiano vorrebbe demolire gli obelischi del ventennio. Abbattere il quartiere Eur, demolire la Stazione Centrale di Milano. Radere al suolo Latina (ex Littoria), Sabaudia, Pomezia e Guidonia. E si dice, vietare per legge il colore nero per vetture motocicli. E meno male che gli italiani disegnano male, altrimenti avremmo il web pieno anche di novelli Vauro o Krancic (che però deo gratias oltre ad una bella mano hanno anche un bel cervello ed un senso della satira molto sviluppato). Ovviamente ai più queste sparate del web sono subito apparse affidabili quanto le migliori fake news, ma purtroppo qualche benpensante se ne è servito per fare battaglia d’opinione. Era già da qualche giorno che pensavo di contattare Emanuele Fiano per sentire e riportare un suo commento diretto. Ma due ore fa ha pubblicato direttamente lui una nota a margine su FB. Bene mi ha risparmiato una telefonata, nel giorno che abitualmente amo dedicare alla famiglia ed al mio Milan. Riporto le sue parole.
"Questo è il testo della mia Legge, parliamo di questo, non di altre interpretazioni. In questo testo di Legge approvato alla Camera non c'è nessun riferimento alla libera espressione di un opinione, giustamente difeso dall'Art. 21 della Costituzione. Se uno oggi in Italia o domani qualora fosse approvata questa Legge, si dichiarasse fascista, non infrangerebbe nessuna legge, starebbe esprimendo la sua opinione, sarebbe all'interno di uno dei cardini della Democrazia. Se domani qualcuno comprasse o vendesse, francobolli dell'epoca o bottiglie o busti, ma per scopo personale, non starebbe facendo propaganda, non ricadrebbe in questa Legge. In questo testo di Legge, non c'è nessun riferimento a beni culturali o architettonici, di qualsiasi tipo, né alla cancellazione di scritte o altro. Non propongo e non voglio cancellare niente. Non è il mio pensiero. Mi interessa la propaganda fascista non altro. In questo nostro tempo in cui un contesto sociale fragile e disagiato, con tanti problemi irrisolti, produce rabbia e protesta, io voglio impedire che antiche cattive lezioni propongano ancora le loro terribili soluzioni. Per quanto riguarda chi mi dice che ci sono altre priorità, rispondo che nel corso di questa legislatura sono stato relatore della Legge sulla riforma del PA, sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, sulla riforma costituzionale, sulla Legge elettorale, sul riordino delle carriere delle FFOO, dei VVFF, ho seguito la Legge antiterrorismo, la legge per il contrasto alla radicalizzazione islamica, la Legge sulla Sicurezza Urbana, la Legge sull'immigrazione Minniti-Orlando, la legge sul conflitto d'interessi, la Legge sui Partiti. Due anni fa ho presentato questa Legge. Dirmi che non mi occupo d'altro è folle. Detto questo, il compito di contrastare la propaganda di valori legati a quelle ideologie, che la nostra costituzione contrasta, può essere assolto unicamente con dei divieti? Certo che no. Sono la cultura, la formazione e la capacità politica di soluzione dei problemi che devono offrire l'antidoto più determinante in questo campo. Questo vuol dire che allora non c'è bisogno di alcun divieto? Non è la mia opinione. In 72 anni in Germania è rinata una delle nazioni più forti del mondo, la Democrazia tedesca prima nella parte Ovest, con la sua classe dirigente socialdemocratica, ha associato dall'inizio del dopoguerra in poi, una grande capacità di investimento culturale e politico sulla Democrazia ad alcuni ferrei limiti al propagarsi della cultura neonazista. Nessuno ha mai pensato che ciò fosse lesivo della Libertà o della Democrazia. A chi mi risponde che questo divieto già esisteva rispondo che non è così. La Legge Scelba punisce l'apologia di fascismo ma solo nel caso si riferisca ad un progetto di ricostituzione del partito fascista. Oggi il nostro paese conta troppi episodi di propaganda fascista di persone che non hanno nessuna intenzione di organizzare un Partito, e allora? Gliela lasciamo fare? Io non sono ossessionato dal fascismo. Anzi vorrei personalmente uscire dalla dinamica di contrapposizione permanente tra parti. Lo auspico, ma questo può avvenire solo con un lavoro culturale e pubblico di grande profondità, onesto, che faccia quello che in Germania hanno fatto sul Nazismo. La capacità autentica da parte di tutti di guardare alla Storia con onestà. In Italia la conclusione del fascismo e del coinvolgimento degli apparati dello Stato si celebrò con una famosa amnistia. Una cancellazione. È invece un discorso su questo paese e la sua storia che sarebbe più utile, invece che qualsiasi cancellazione. La Libertà di espressione di ognuno di noi non si tocca certo, ma va appunto difesa dalla propaganda di quelle ideologie che vorrebbero negarla, giacché noi rimaniamo figli della definizione di Matteotti, che li fascismo non fu un'idea, ma un crimine. Difendiamo la libertà, difendiamoci dai crimini."
SIC ET SIMPLICITER. Io non aggiungo alcun commento, positivo o critico. Il suo pensiero si può condividere, si può criticare, si può osteggiare con ogni mezzo democratico, si può rilanciare cum laude. Ho deciso di riportarlo solo perché da cronista odio senza mezze misure le fake news e le pseudo testate che distribuiscono spazzatura, animate da falsi giornalisti che pensano che il termine deontologia professionale rappresenti un ingrediente per lo sformato di vitello alla bulgara. Buona domenica.
Vittorio Sgarbi e il fascismo, disintegra Fiano e Laura Boldrini: "Pensate ai comunisti", scrive il 27 Settembre 2017 "Libero Quotidiano". Un Vittorio Sgarbi "a braccio teso" contro la Legge Fiano, Laura Boldrini e chi vive ogni giorno con l'ossessione per il Fascismo di 80 anni fa. Nella sua rubrica quotidiana sul Quotidiano nazionale, "Sgarbi vs Capre", il critico più famoso d'Italia non va per il sottile e svela tutte le ipocrisie della "inutile legge sulla propaganda fascista che ricalca la legge Scelba". Perché, invece, suggerisce, non "perseguire gli imperterriti difensori del comunismo reale"? La proposta del professore è semplice ed efficace: "Richiamare gli ambasciatori italiani da Cuba e Pechino, gli atti di queste dittature sono oggettivamente identici alle violenze contro i diritti umani perpetrate dal fascismo". E anche le ingerenze in Italia sono insopportabili: ad esempio, quando Milano ha ricevuto il Dalai Lama tra le minacce e le intimidazioni del governo cinese. "Ma Fiano - ironizza Sgarbi - si preoccupa delle scritte fasciste sulla spiaggia di Chioggia".
Sala lancia l'allarme nazi. E scorda i centri sociali. Sindaco: "I neofascisti a Milano si rafforzano". Il centrodestra: "No global liberi di occupare", scrive Chiara Campo, Domenica 03/12/2017, su "Il Giornale". «Senza drammatizzare, ma la situazione credo che sia grave. Anche a Milano ci sono segni che il mondo neonazista e neofascista si sta rafforzando e sta entrando nelle fasce più deboli». Il sindaco Beppe Sala lancia l'allarme naziskin. Parteciperà «senz'altro» se potrà alla manifestazione organizzata dal Pd a Como il 9 dicembre dopo il blitz di un gruppo di ultradestra veneto nella sede di un'associazione pro migranti e ha già appoggiato la mozione che approderà domani in Consiglio (primo firmatario David Gentili di Insieme x Milano) che chiede alla giunta di non concedere spazi e patrocini a chi non sottoscrive una carta dei valori antifascisti. Il Comune non potrà vietare le piazze perchè è competenza della questura e Sala si adegua, «solleciterò alla massima attenzione. É chiaro che non possiamo pensare a una città militarizzata ma serve grande vigilanza perchè questi movimenti non prendano piede». Incalza «tutti i partiti, dalla Lega a M5S» sulle liste, «siccome siamo vicini alle elezione dico che queste persone non vanno fatte entrare, da una parte e dall'altra». E ricorda la polemica che scoppiò intorno al nome di Stefano Pavesi, consigliere vicino a Lealta è Azione eletto con la Lega nel Municipio 7. «Leggo anche sui quotidiani che lo hanno trovato a fare il bagarino. Siede ancora in consiglio, continua a chiedermi di dimettermi, ma si dimetta lui». Si riferisce al Daspo inflitto una decina di giorni fa a Pavesi dai vigili, lo avrebbero colto a vendere biglietti per una partita di hockey sul ghiaccio in via Piranesi. Se la propaganda antifascista di Sala scalda la platea della sinistra riunita alla «leopoldina» promossa ieri in zona Certosa dal candidato Pd in Regione Giorgio Gori, il centrodestra richiama invece a concentrarsi sulle priorità e ad accorgersi anche di quei movimenti no global cari alla sinistra che occupano indisturbati palazzi e capannoni. Il capogruppo della Lega Alessandro Morelli intanto difende Pavesi con «le stesse parole che usò Sala quando fu pizzicato sulle varie amnesie nella dichiarazione dei redditi, se ci sarà una multa da pagare la pagherò, Pavesi farà lo stesso anche se mi pare che abbia fatto ricorso contro il Daspo. E mi sembra singolare che il sindaco invochi il garantismo nei propri confronti e non lo pratichi sugli altri». Invece «di demonizzare alcuni ambienti su cui la questura non ha mai ritenuto di intervenire - avverte -, il sindaco e la sinistra pensino piuttosto a sgomberare il centro sociale Cantiere che occupa da anni una sede del Comune e ha pure un ristorante completamente abusivo. L'Annonaria stranamente non se ne è accorta nonostante le numerose denunce. O sgomberi Cascina Ronchetto, la Lega ha depositato anche un esposto in Procura». Il Carroccio boccerà la mozione antifascista perchè «esiste già una legge nazionale e non spetta certo al commissario Gentili il compito di dare in maniera discrezionale la bolla di fascista o oltranzista ai vari gruppi». Il capogruppo Fdi in Regione Riccardo De Corato richiama il sindaco: «La città è ostaggio dei clandestini, i centri sociali fanno il bello e il cattivo tempo, siamo in fondo alle classifiche della sicurezza nelle città e l'unica fissazione di Sala è imbavagliare l'estrema destra».
Skinhead a Como, Meloni: «Intimidazione, ma la violenza è dei centri sociali», scrive Mariano Folgori giovedì 30 novembre 2017 su "Il Secolo D’Italia". «Secondo me quello è un atto di intimidazione e per me l’intimidazione è inaccettabile. Mi consenta però di dire che trovo abbastanza ridicolo l’appello di Matteo Renzi, perché la violenza non è oggettivamente quello che ieri si è visto a Como: è un atto di intimidazione ma non è un atto di violenza». Giorgia Meloni invita a vedere nella giusta dimensione, senza strumentalizzazioni politiche e forzature ideologiche, l’irruzione di un gruppo di naziskin venetia Como in un centro pro migranti. «La violenza – afferma la Meloni a L’Aria che tira – noi l’abbiamo invece vista un sacco di volte dai compagni dei centri sociali, quelli che distruggono intere città e bruciano le macchine degli italiani, e nessuno ha mai fatto gli appelli per la condanna delle violenze dei centri sociali. Quello si può fare. Perché è gente di sinistra e le città si possono distruggere, si può dare fuoco alle macchine della gente, si può dare fuoco alle edicole». La leader di FdI risponde a Renzi che ha tentato di rilanciare l’ennesima mobilitazione antifascista. «Qualsiasi gesto di violenza – ha detto il leader del Pd va condannato senza se e senza ma. Intimidazioni e provocazioni di segno fascistoide vanno respinti non solo dalla sinistra ma da tutta la comunità politica nazionale, senza eccezione alcuna. Su questi temi non si scherza». Salvini: «Il problema è Renzi non i presunti fascisti». Sulla la stessa linea della Meloni è Matteo Salvini: «Il problema dell’Italia è solo Renzi, non i presunti fascisti. Lui – dice Salvini – si occupa di fake news e del ritorno del fascismo che non esiste». «Certo che entrare in casa di altri non invitati non è elegante – ma il tema dell’invasione dei migranti sottolineato dai skinheads è evidente».
Appello Renzi, Meloni: e Centri sociali? Scrive il 30 novembre 2017 "Rai News". "Secondo me è un atto di intimidazione e per me l'intimidazione è inaccettabile. Ma trovo abbastanza ridicolo l'appello di Renzi, perchè la violenza non è oggettivamente quello che ieri si è visto a Como". Così la leader di FdI. Il blitz dei naziskin in un circolo Pd di sostegno ai migranti "è un atto di intimidazione, non di violenza. La violenza noi invece l'abbiamo vista un sacco di volte dai compagni dei Centri sociali che distruggono intere città e bruciano le macchine degli italiani e nessuno ha mai fatto appelli...".
Bologna, raid dei centri sociali: uova e minacce su sede di destra. Il blitz dei centri sociali del Collettivo Polvere Rossa contro la sede di Azione Universitaria a Bologna, scrive Giuseppe De Lorenzo, Venerdì 01/12/2017, su "Il Giornale". Un raid notturno dei centri sociali. Mentre a sinistra si sgolano per "l'irruzione" di Veneto Fronte Skinheads all’assemblea di Como Senza Frontiere, nella rossa Bologna la sede di Azione Universitaria in via Turati viene presa d'assalto dal Collettivo Polvere Rossa. Questa mattina i militanti dell'associazione universitaria di destra si sono ritrovati la porta imbrattata dalle uova con annesso volantino minaccioso, già rimosso dalla Digos. "Non è che un pretesto per concedervi dieci minuti di riflessione - si legge nel proclama - Perché mentre pulirete questa vetrina, anche solo per dieci secondi, vi sentirete disprezzati e non tollerati, proprio nello stesso modo in cui voi fate sentire chi diverge dalla vostra idiozia. Non ci aspettiamo che voi capiate e tantomeno che cambiate. Ci basta lasciarvi questo messaggio con la coscienza di chi anche di giorno vi affronta a viso aperto, con il divertimento di chi vi mette alla berlina in una fredda notte d'autunno. Italiano è chi ha fede nella Costituzione. Italiano è che ha memoria degli ideali della Resistenza. Italiano è chi lotta per il progresso della Patria. Fuori i fascisti da Bologna". La sede di via Turati 25 a Bologna è un luogo storico di aggregazione della destra. Soprattutto in ambito universitario. Dibattiti, discussioni politiche, volantini da stampare, colla e bandiere. Poi la foto di Almirante rivolta verso i presenti e la scritta: "Noi possiamo guardarti negli occhi". Niente di pericoloso insomma, chi scrive lo sa per esperienza. Nessun "rigurgito fascista", onde nere, nazismi alle porte. Anzi: tutto democratico, visto che AU da anni partecipa alle elezioni studentesche, eleggendo pure propri rappresentanti. "Due mesi fa abbiamo subìto un'intimidazione ad un nostro convegno sulla Siria e nessuno è stato punito - racconta Dalila Ansalone, Responsabile Azione Universitaria Bologna - A quanto ci risulta, nessuna Istituzione ha preso provvedimenti seri nei confronti di questi soggetti che vivono nell'illegalità permanente. Visto che nessuno gli si oppone, si sentono onnipotenti e tranquilli nel compiere atti di violenza senza subire alcun tipo di sanzione". Il timore è che le azioni degli antagonisti possano degenerare. "Se non la pensi come loro, usano la violenza - attacca Stefano Cavedagna, Dirigente Nazionale Azione Universitaria - Esattamente come facevano i partigiani in queste zone rosse dopo la guerra. Se non eri con loro, facevi una brutta fine. Non abbiamo timore, rimaniamo solo molto tristi nel vedere fino a dove si possono spingere certi soggetti che fanno della libertà di pensiero il loro mantra, ma poi con la violenza cercano di reprimere idee differenti dalle loro". E mentre sugli skinhead i quotidiani discettano da giorni e Matteo Renzi chiede addirittura "condanna unanime" del gesto, difficilmente il raid degli antagonisti scatenerà pari indignazione e preoccupazione. Si sa: alcune uova e minacce risultano meno aggressive di altre. Sono politicamente corrette. "La Repubblica dice che con acqua e sapone si rimedia, come se il gesto intimidatorio non esistesse e non ci fosse nulla da condannare - attacca Galeazzo Bignami, capogruppo in Regione di Forza Italia - Chissà cosa sarebbe successo se degli estremisti di Destra avessero lanciato delle uova marce contro Repubblica. Avremmo già i manifesti firmati dagli intellettuali radical chic, girotondi arcobaleno, manifestazioni antifasciste e così via". Per la senatrice Anna Maria Bernini (FI) si tratta di "un grave atto intimidatorio, che meriterebbe un'indignazione profonda" e invece "viene curiosamente minimizzato, declinato ad 'una ragazzata'". Solito doppiopesismo della sinistra. "Le forme di intimidazione e violenza - dice infatti Maurizio Gasparri - vanno condannate in egual misura dalle istituzioni e da tutti coloro che credono nei valori della democrazia e della legalità". Duro anche il deputato di Forza Italia Elio Massimo Palmizio, che definisce il raid degli antagonisti "inaccettabile" tanto da costituire "una grave compressione della liberta' di espressione individuale e collettiva garantita dalla nostra Costituzione".
EIA EIA, MA VA' LA. Il Duce unisce più di Renzi: bastano quattro cretini per fare gridare la sinistra al nuovo Ventennio. Ma è silenzio sulle violenze dei centri sociali, scrive Alessandro Sallusti, Venerdì 01/12/2017, su "Il Giornale". Ogni tanto, ma sempre più spesso, scatta l'allarme dell'«all'armi son fascisti». Questa estate la goliardia canaglia di un bagnino di Chioggia che aveva tappezzato il suo lido con frasi mussoliniane era stata spacciata come l'inizio di un nuovo Ventennio. Il malcapitato ha perso il lavoro e si è riciclato come opinionista di avanspettacolo destrorso nelle radio e tv venete dopo essere stato completamente scagionato dai magistrati che avevano aperto un'inchiesta. Nessun tentativo di ricostituire il Partito fascista - hanno concluso i saggi pm - ma solo una gigantesca burla. Adesso ci risiamo con la storia dei quattro ragazzotti di destra che hanno fatto irruzione in un circolo pacifista di Como per leggere ai presenti un comunicato sulla «patria minacciata dagli immigrati». Deplorevole (la violazione di domicilio privato), ridicolo (il gesto), a tratti delirante (il testo), ma comunque fatto anche questo ascrivibile più all'idiozia giovanile che alla fascistizzazione dell'Italia. Il codice penale attuale mi sembra attrezzato a punire eventuali reati che questi ragazzotti possano avere commesso, con i fatti e con le parole, e la cosa dovrebbe finire lì. E invece no, puntuale come la morte arriva da Repubblica il grido di allarme sul pericolo destre. E la panna monta, manco stessimo parlando di un attentato dell'Isis. Facendo una ricerca con Google si scopre che dall'inizio dell'anno i giornali del gruppo Espresso hanno fatto scattare «l'allarme fascismo» 492 volte. Siamo cioè all'antifascismo militante che amplifica ed esalta stupidi episodi e persone ignoranti che sono numericamente, politicamente e socialmente più che marginali. Certamente meno significativi dell'allarme che dovrebbero destare le occupazioni, gli abusi e a volte le devastazioni urbane di quei simpatici ragazzi dei centri sociali; sicuramente meno preoccupanti delle milizie di estrema sinistra che impediscono con la forza la presentazione dei libri di Giampaolo Pansa sul revisionismo della Resistenza, di Magdi Allam sull'islam o una conferenza di Angelo Panebianco all'università di Bologna perché «professore non abbastanza pacifista». Più stupidi dei neofascistelli ci sono solo i tromboni dell'antifascismo a tempo pieno, i quali non si indignano che il leader della Lega Matteo Salvini - democraticamente eletto - possa apparire in pubblico solo se scortato, a volte blindato. A questi tromboni andrebbe ricordato - ironia della sorte - che ancora oggi il nostro codice penale a pagina uno porta in grassetto la firma di chi l'ha promulgato, cioè «Sua Eccellenza Benito Mussolini», come ben sanno studenti di giurisprudenza e addetti ai lavori. Che facciamo, chiudiamo i tribunali, mettiamo al rogo in piazza la tavola delle leggi e proclamiamo la mobilitazione generale? La verità è che il Duce riesce dove ha fallito Matteo Renzi. Cioè unire la sinistra, che - non avendo né presente né futuro - per dare l'impressione di esistere deve per forza attaccarsi ai fantasmi del passato. Diciamolo, i veri nostalgici sono proprio loro.
Assalti, censure e violenze in università. I blitz dei centri sociali non scandalizzano. Da Pansa zittito a Panebianco contestato, le vittime dell'intolleranza rossa, scrive Paolo Bracalini, Venerdì 1/12/2017, su "Il Giornale". Clima da Repubblica di Weimar, nazismo alle porte, l'ombra nera sull'Italia. Il blitz degli skinhead ha svariati precedenti, ma a sinistra. La sinistra unita solo con la caccia al fascista. Aggressioni, minacce, lanci di uova, però più politicamente corretti rispetto a quattro teste rasate, e quindi non meritevoli di allarme per la democrazia in pericolo. Eppure a lungo, per un giornalista come Giampaolo Pansa colpevole di aver messo in discussione la vulgata partigiana sulla guerra civile italiana dopo l'8 settembre, è stato quasi impossibile presentare un semplice libro, considerato negazionista dall'estremismo rosso che accoglieva le presentazioni con insulti, minacce, propaganda a pugni chiusi. Qualche cenno di solidarietà in privato dai leader di sinistra, ma mai pubblico, perché Pansa è un diffamatore della Resistenza, un nemico del popolo. Identica sorte toccata ad Angelo Panebianco, editorialista del Corriere e docente all'Università di Bologna: «Fuori i baroni dalla guerra», gli hanno urlato i collettivi lo scorso febbraio, durante la sua lezione. «Panebianco cuore nero», la scritta lasciata dai centri sociali sulla porta del suo ufficio anni fa. Imbarazzo, silenzio e poco altro anche per Salvini, nel mirino dei centri sociali, più violenti degli skin head, ma col lasciapassare politico. Il leader della Lega è stato aggredito più di una volta, a Bologna gli hanno sfasciato il vetro dell'auto, in Umbria gli antagonisti lo hanno accolto a sputi e cori «stronzo», a Napoli hanno scatenato una guerriglia con sassi e molotov, violenze annunciate con la massima tranquillità alla vigilia («Non assicuriamo un corteo pacifico») senza creare indignazione, anzi (il sindaco de Magistris è con i centri sociali). A Milano sempre i centri sociali hanno distrutto un gazebo della Lega e malmenato due militanti. Scene che si ripetono, senza che mai si parli di un «allarme centri sociali», mentre quattro skin bastano per mobilitare le massime istituzioni. A Daniela Santanchè, donna di destra quindi meno rispettabile, ha raccontato in diretta, mentre discuteva di ius soli con Fiano del Pd (il deputato che vuol mettere in carcere chi ha una immagine di Mussolini in casa) di aver ricevuto un tremendo insulto più minaccia di morte come se niente fosse («Mi è appena arrivato su Twitter Sei una put... da uccidere»). Ancora a Napoli l'ex candidato sindaco di centrodestra, Gianni Lettieri, denunciò un'aggressione per strada da parte degli attivisti di una casa occupata. Ne sanno qualcosa gli ex ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, bersaglio prediletto degli attivisti e centri sociali per le battaglie sui furbetti della pubblica amministrazione e sulla scuola, feudo della contestazione di sinistra. Brunetta, durante un convegno, fu vittima di un blitz della «Rete dei precari» fischi, insulti, striscioni a cui replicò definendoli «l'Italia peggiore». Non l'avesse mai fatto: «Diecimila post di insulti, minacce, addirittura pallottole, sul mio profilo Facebook. Molti legati anche alla mia statura fisica» calcolò l'allora ministro, sempre preciso anche nella contabilità degli insulti ricevuti. Per la Gelmini, si inventò persino un No Gelmini Day, con i collettivi studenteschi in piazza, al grido «Ci vogliono ignoranti, ci avranno ribelli», ma pure senza un chiaro nesso logico «Siamo tutti antirazzisti e antifascisti». Coi fumogeni e i lanci di uova. Tanto i fascisti sono solo a destra.
Ecco il dossier "centri sociali": quelli pericolosi sono 200. Dal Veneto alla Sicilia la mappa delle occupazioni pubbliche e private. E i delinquenti napoletani fermati dopo gli scontri sono già liberi, scrive Luca Rocca su "Il Tempo” il 14 Marzo 2017. Anacronistici ma violenti. Devastano le città, le vetrine dei negozi e quelle delle banche. Picchiano duro, infieriscono sui "nemici", impediscono di parlare. Scendono in piazza rabbiosi, lanciano molotov e bombe-carta. Imbracciano mazze e danno fuoco alle auto. Picchiano i poliziotti nascondendo il volto dietro il passamontagna. Finiscono spesso sotto processo, ma non mollano. Riscendendo per le vie con la loro brutalità. Sono i "centri sociali" più pericolosi sparsi in tutta Italia che negli ultimi anni si sono resi protagonisti di inaudite violenze. Circa 200 strutture autogestite, quelle monitorate dall’Antiterrorismo. Ma sono migliaia i luoghi dove nasce l’odio e cresce la violenza. Negli ultimi tempi a far parlare prepotentemente di sé sono stati quelli di Milano (Conchetta, Cantiere, Soy Mendel, Mandragola), Cremona (Dordoni), Napoli (Insurgencia, Ex Opg Occupato-Je so pazzo), Roma (Macchia Rossa innanzitutto, ma nella Capitale ce ne sono 65, 27 dei quali controllati più da vicino da polizia e carabinieri), Torino (Askatasuna), Palermo (Spazio Anomalia-Ex Karcere), Padova (Pedro), Rimini (Casa Madiba), Brescia (Magazzino 47) e molti altri ancora sparsi in tutta la Penisola. Sono dappertutto e vogliono comandare. Al di là della legge, al di là delle regole. Dei 200 della black list l’Antiterrorismo evidenzia 11 centri in Lombardia, 7 in Piemonte, 4 nelle Marche, 12 in Veneto e altrettanti in Emilia, 10 in Toscana, 4 in Puglia, 8 in Liguria, 4 in Trentino, oltre 20 in Campania, 6 in Calabria e 3 in Sicilia.
CENTRI (POCO) SOCIALI. Solo rifacendoci agli ultimi due anni e mezzo, ad esempio, gli "antagonisti" si sono resi protagonisti di scorribande devastanti. Due anni fa a Cremona gli appartenenti al centro sociale "Dordoni" si scontrano con quelli di CasaPound. Molti sono i feriti. Gravissimo un antagonista, Emilio Visigalli (che poi verrà arrestato poco prima della sua rappresaglia). Otto persone finiscono indagate (e un militante bresciano del collettivo "Magazzino 47" arrestato). Pochi giorni dopo oltre 2mila persone, in testa i "black bloc", scendono in strada per solidarizzare coi loro "compagni", lanciando pietre, bottiglie e bombe-carta contro le forze dell’ordine. Nelle stesse settimane, stavolta a Padova, alcuni componenti del centro sociale «Pedro», nell’ambito di un’inchiesta sull’aggressione a un dirigente della Squadra Mobile, subiscono l’obbligo di dimora (uno finisce ai domiciliari). Nel corso delle perquisizioni nelle loro abitazioni la polizia trova fumogeni, una maglia metallica anti-coltello, fionde e un’arma giapponese usata nelle arti marziali. Stesso dicasi per l’operazioni nei confronti di 17 componenti del movimento antagonista "Spazio Anomalia/Ex Karcere" che ricevono l’obbligo di firma (poi annullata dal giudice) per aver devastato alcuni esercizi commerciali a Palermo (ferendo alcuni poliziotti). I reati contestati: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti contro l’ordine pubblico, violenza, minaccia, lesioni personali.
VIOLENZA "ANTAGONISTA". Nello stesso periodo otto componenti del centro sociale "Cantiere" di Milano vengono condannati per gli scontri scoppiati nel dicembre del 2010 durante una manifestazione in occasione della "prima" della Scala, mentre alcuni esponenti milanesi di Forza Italia subiscono delle intimidazioni subito dopo lo sgombero del "Soy Mendel". A rendersi protagonista, per anni, di scontri violentissimi, è il centro sociale di Torino "Askatasuna", che nell’ultimo biennio non ha cambiato abitudini. Sempre in prima linea nei cortei No-Tav, uno dei suoi militanti, nel dicembre scorso, finisce in carcere per aver violato i domiciliari ottenuti per gli scontri con la polizia in Val di Susa. Pochi mesi prima sette manifestanti legati alla sinistra antagonista No-Tav vengono identificati durante una protesta e fra essi ancora militanti di Askatasuna. Che di violenti ne sforna a iosa, tanto da subire arresti, fermi, indagini, condanne. Quando poi il leader della Lega Nord Matteo Salvini si reca a Macerata per una visita elettorale, gli appartenenti al centro sociale "Sisma" lo accolgono com’è loro tradizione. Lo scontro con la polizia è inevitabile. Il maggio 2015 è segnato dalle manifestazioni No-Expo alle quali partecipano i membri del "Mandragola". Bastoni in mano, passamontagna in testa e la devastazione di Milano è assicurata.
RABBIA "COLLETTIVA". Nell’agosto del 2015 la Digos di Bologna notifica un divieto di dimora per Gianmarco De Pieri, leader del centro sociale "Tpo", che nel corso degli scontri con le forze dell’ordine, avvenuti in seguito allo sgombero di una villa occupata, aveva aggredito un sostituto commissario e lanciato una grossa trave contro un agente. Poche settimane dopo cinque giovani di Askatasuna vengono raggiunti da misure cautelari per le violenze messe in atto durante un comizio di Salvini a Torino, mentre la procura di Bologna punterà i fari su15 appartenenti al centro sociale "Tpo", protagonisti di violenze scatenate durante la manifestazione degli "Indignati". Passa poco tempo e sono ancora i militanti di "Askatasuna" a mettere in atto scontri violentissimi nell’Università di Torino. Di sé fa parlare anche l’"Ex Opg Occupato-Je so pazzo" di Napoli (fra i movimenti antagonisti anti-Salvini dei giorni scorsi), che mesi fa ha portato in piazza i "suoi" per lanciare uova e pietre verso la Mostra d’Oltremare dove l’allora premier Matteo Renzi stava per recarsi. Gli stessi militanti si sono scontrati e pestati con quelli di CasaPound. Rissa violenta, anche quella scatenata, nell’aprile scorso, dai membri del centro sociale "Casa Madiba" di Rimini contro gli esponenti di Forza Nuova.
"MACCHIA" FURIOSA. E proteste rabbiose anche da parte degli appartenenti a "Insurgencia" di Napoli e dei membri di "Macchia Rossa" a Roma, che nel novembre scorso, armati di mazze, spranghe e bombe-carta, si sono scontrati con quelli di Forza Nuova. Nel gennaio tati condannati due appartenenti al centro sociale "Kavarna" di Cremona. A febbraio scorso, infine, i militanti del centro sociale "Zam" e "Cantiere" di Milano si sono azzuffati con la polizia all’esterno del Municipio 4, dove era in corso un incontro sul Giorno del ricordo delle Foibe. Stesso episodio, ma con protagonisti da una parte CasaPound e dall’altra militanti del centro sociale "Bruno", anche a Trento. Ancora una volta per infangare i morti delle Foibe.
Centri sociali: sono legali? Scrive Mariano Acquaviva il 7 dicembre 2017. Breve analisi di un fenomeno controverso: i centri sociali sono legali? Negli ultimi tempi si sente sempre più parlare di centri sociali, soprattutto in riferimento ad episodi di violenza e vandalismo. Cosa sono i centri sociali? In senso generico, si tratta di associazioni che intendono fornire alla collettività alcuni servizi socialmente utili, come ad esempio attività ricreative, culturali o sportive. Nella pratica, però, non è sempre così. In Italia, i centri sociali nascono quale centro di aggregazione politica extraistituzionale, cioè con sede diversa da quella parlamentare. Lo spirito che li agita è sicuramente di protesta ma, come vedremo, bisogna distinguere la protesta pacifica da quella illegale. In realtà, i centri sociali individuano anche un altro fenomeno: quello di un movimento indipendente, di ribellione all’ordine costituito, che si concretizza in atti ai limiti della legalità, quali occupazioni di spazi pubblici o privati, manifestazioni non autorizzate e contestazioni varie. Purtroppo è proprio l’aspetto più riprovevole dei centri sociali ad essere messo in risalto dai mass media, a causa della spirale di violenza che innescano. Analizziamo meglio il fenomeno e spieghiamo se i centri sociali sono legali.
Centri sociali e diritto ad associarsi. Secondo la Costituzione italiana, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono però proibite tutte le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La Costituzione è chiara: tutti hanno il diritto di associarsi liberamente, senza seguire nessuna procedura particolare (salva quella prevista dal codice civile e dalle leggi speciali per ottenere la personalità giuridica), purché l’associazione non persegua scopi penalmente illeciti. Il codice penale, infatti, punisce l’associazione che abbia quale scopo quello di commettere delitti. Perciò, fino a quando i centri sociali assumono la forma di associazione o, comunque, di libera aggregazione per finalità culturali, sportive o, in senso più ampio, pacifiche, la loro esistenza sarà perfettamente legale. Diversamente accade se i centri sociali nascono per perseguire scopi sovversivi o violenti: in questo caso l’associazione sarebbe illegale e perseguibile secondo le norme penali. In Italia, molti centri sociali sono stati legalizzati pur avendo origini tutt’altro che lecite: si pensi a quei centri che si sono visti assegnare le strutture che, in precedenza, avevano abusivamente occupato.
Il problema è che difficilmente un centro sociale sarà costituito con lo scopo dichiarato di compiere reati; normalmente, la nascita di questi organismi avverrà per perseguire finalità perfettamente lecite. Si ricordi, poi, che la contestazione pacifica è sempre ammessa, in quanto rientra tra le espressioni del principio di libera manifestazione del proprio pensiero. Pertanto, un movimento di opposizione alla maggioranza politica, ad esempio, non sarà sicuramente perseguibile dalla legge.
Centri sociali e diritto di riunirsi. La Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di riunirsi, purché pacificamente e senza armi. Per le riunioni non è richiesto preavviso, salvo per quelle organizzate in luogo pubblico: in questo caso, le autorità possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Anche in questo caso, i cortei e gli assembramenti, quando pacifici, sono assolutamente legali; l’unico limite è quello dell’evento organizzato in luogo pubblico, per il quale la legge chiede sia dato un preavviso di almeno tre giorni alla questura competente. Ma quando una manifestazione può diventare sediziosa e, perciò, illegale? Secondo la legge, quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida rivoltose o lesive del prestigio dell’autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o nei cortei predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. È sempre considerata manifestazione sediziosa l’esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità. È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose. Per la giurisprudenza, è sedizioso quell’atteggiamento che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni, ovvero che esprime ribellione, sfida e insofferenza verso i pubblici poteri e verso gli organi dello Stato a cui è demandato il compito di esercitarli.
Centri sociali: sono legali? Da quanto detto finora si evince che i centri sociali sono legali se perseguono le loro attività conformandosi ai basilari principi di non violenza del nostro ordinamento. In caso contrario, essi devono ritenersi assolutamente illegali e, pertanto, non hanno diritto di esistere. La questione è che, molte volte, lo Stato tollera il modo di agire dei centri sociali, tanto che, come sopra detto, è successo più volte che i beni abusivamente invasi fossero poi assegnati agli occupanti stessi. Alcune di queste aggregazioni, poi, sono diventate dei movimenti politici a tutti gli effetti. Il vero problema, allora, è la risposta che lo Stato intende dare al fenomeno in questione.
La sindrome del compagno che sbaglia. L'indignazione non si registra mai quando i No Tav aggrediscono le forze dell'ordine, quando i "ragazzi" dei centri sociali devastano le città, scrive Francesco Maria Del Vigo, Sabato 9/12/2017, su "Il Giornale". Ci sono cretini e cretini. Alla macabra borsa dei crimini, secondo Repubblica, un fumogeno lanciato da quattro cretini contro la propria sede vale molto di più di una bomba fatta esplodere da altri loro colleghi cretini contro i carabinieri. Perché, dicevamo, ci sono cretini e cretini e i cretini fascisti - chissà come mai! - sono sempre più pericolosi di quelli anarchici o di quelli comunisti. Così ieri il quotidiano di Mario Calabresi ha dedicato 3 pagine 3 al ritorno dell'«onda nera», grande battaglia mediatica che vede Repubblica impegnata nel tentativo di riportare il calendario del Paese agli Anni Venti. Invece le bombe contro i carabinieri di giovedì a Roma, rivendicate dagli anarchici come un atto «di guerra contro lo Sato» sono scivolate in un misero articolo a pagina 26. Tra i fattacci di cronaca nera. Come se l'eversione anarchica o rossa, quella che piazza l'esplosivo e prende a sassate i poliziotti, non fosse un problema politico, ma una bagattella, lo sfogo di quattro teste calde. Ognuno, legittimamente, ha la propria gerarchia di notizie, la propria scala di valori, ma è bene sapere che, dunque, un braccio teso mette a rischio la democrazia più di una bomba potenzialmente letale. Il giornale fondato da Scalfari è dalla scorsa primavera impegnato nella creazione di una grande fake news: il ritorno del fascismo. Tutto ebbe inizio con l'emergenza democratica dello stabilimento balneare di Chioggia, il lido fascista che per settimane ha tenuto banco come se fosse il trailer dell'arrivo delle squadracce nere pronte a marciare sulla capitale. Un allarme talmente infondato che persino la procura ha archiviato il caso come folklore. E da lì in poi un crescendo quotidiano di allarmi per la tenuta democratica del Paese: dalla vendita di gadget del Ventennio all'irruzione a Como. Atto idiota e deprecabile ma - non prendiamoci in giro - non certo il preludio di un ritorno delle camicie nere. E, a forza di insistere, la fake news si è auto avverata e quattro cretini in maschera si sono presentati sotto la sede di Repubblica per leggere i loro proclami deliranti. Solidarietà e indignazione generale. Giustamente. Peccato che questa indignazione non si registri mai quando i No Tav aggrediscono le forze dell'ordine, quando i «ragazzi» dei centri sociali devastano le città distruggendo auto e vetrine di incolpevoli cittadini e quando gli anarchici mettono le bombe per diffondere le loro idee criminali. Perché quelli, alla fine, sono sempre compagni che sbagliano e comunque sbagliano sempre meno dei camerati. Ma sottovalutare il pericolo dei cretini è proprio da cretini.
Salvini: "No ai naziskin, ma i volontari non fanno un buon servizio". Matteo Salvini a "Otto e Mezzo" parla degli ultimi episodi che hanno visto protagonisti i naziskin e nega che oggi esista un pericolo fascismo, scrive M. Ribechini su "Blastingnews.com". In occasione della puntata di questo giovedì 7 dicembre di "Otto e Mezzo" su La7 è intervenuto Matteo Salvini, leader della #Lega Nord. Vediamo le parti salienti di quello che ha dichiarato. Salvini si sente più vicino ai naziskin oppure ai volontari dei centri di accoglienza? "Né agli uni, né agli altri". A una specifica domanda di Lilli Gruber sul fatto che la Lega chiede o meno il voto ai neofascisti, Salvini ha risposto: "Io chiedo il voto a sessanta milioni di Italiani, non mi interessa il voto dei #naziskin, non chiedo il loro voto. La gente voterà per noi perché siamo l'unico argine all'#immigrazione clandestina, ma lo facciamo senza far casino andando in giro coi fumogeni a interrompere le riunioni o minacciare i giornalisti: noi lo facciamo coi Sindaci e con i Governatori. Noi portiamo avanti il "prima gli italiani" democraticamente. Penso ai terremotati e ai disabili, non mi interessano le pagliacciate: le violenze vanno condannate da qualsiasi parte arrivino. Che ci sia un problema sull'immigrazione clandestina è un problema evidente". Mentre alla domanda della conduttrice, se si senta più vicino ai naziskin che hanno fatto irruzione a Como oppure ai volontari dei centri di accoglienza, Salvini ha risposto: "Né agli uni, né agli altri. Perché non si interrompono le riunioni altrui e non si entra in casa altrui senza essere invitati, così come non stanno facendo un buon servizio agli italiani e agli immigrati perbene tutte quelle associazioni e cooperative che dicono 'avanti tutti'. Io non ho la testa rasata e non entro in casa altrui, il fascismo e il comunismo sono morti e condannati della storia. Vanno condannati tutti quelli che usano violenza, come gli anarchici che oggi hanno lanciato una bomba davanti a una stazione dei carabinieri". Riguardo all'avvicinamento alla destra più radicale verso le prossime elezioni, Salvini ha detto: "Ma davvero si pensa che ci sia il pericolo del fascismo e del nazismo in Italia? Si pensa che nel 2018 ci sia l'invasione dei fascisti, degli alieni o dei russi? Io non credo. Io escludo che ci sia il pericolo del fascismo, del nazismo e del comunismo in Italia. Punto a capo. Anzi ritengo che qualcuno usi questi argomenti per non parlare di altri problemi: tasse, mutui, lavoro e pensioni. Comunque mi ha fatto specie anche il sindaco di Milano che si è fatto il selfie col pugno chiuso: il comunismo ha fatto centinaia di milioni di morti. Lasciamo stare fascismo e comunismo, torniamo alla vita vera".
Fascisti e comunisti sono tornati (e se li ghettizzate gli fate un favore). Anche in Italia, così come in tutta Europa, le ideologie simbolo del Novecento, che credevamo sepolte dalla Storia, stanno tornando. Chi pensa basti ignorare o reprimere, però, commette un grave errore. Farci i conti vuol dire innanzitutto ragionare sulle cause che le hanno rigenerate, scrive Francesco Cancellato su “L’Inkiesta” il 5 Dicembre 2017. «Il problema vero non sono quattro ragazzi, ma l'immigrazione fuori controllo». Così Matteo Salvini ha commentato l’irruzione compiuta qualche giorno fa dai militanti del Veneto Fronte Skinhead a Como, durante una riunione della rete di associazioni impegnata nell’assistenza ai migranti. Un’affermazione sgradevole, non c’è dubbio. Strumentale, sicuramente. Ma con un fondo di verità che faremmo bene a non sottovalutare e, anzi, a piantarci bene in testa. Che anziché scandalizzarci degli effetti, dovremmo occuparci delle cause che scatenano fenomeni politici nuovi. Ecco, per l’appunto: l’ascesa delle destre nazionaliste e xenofobe a discapito delle destre liberali è un fenomeno politico nuovo. Così come lo è, del resto, pure l’ascesa delle sinistre radicali e anti-sistema. Così come lo è, pure, la nuova improvvisa popolarità di istanze autonomiste e indipendentiste come quelle scozzesi, catalane, corse, lombardo-venete. Fate pure finta di non vederle, ma questo è quel che sta accadendo. Chiamatelo come volete, destra e sinistra, fascismo e socialismo, coscienza di luogo e coscienza di classe, ciò che credevamo irrimediabilmente novecentesco e sepolto dalla Storia sta tornando. A destra, con Orban e Jobbik in Ungheria, Duda in Polonia, Alba Dorata in Grecia, Marine Le Pen in Francia, Alternative fur Deutschland in Germania. E a sinistra, con Tsipras e Varoufakis in Grecia, Pablo Iglesias e Podemos in Spagna, Antonio Costa in Portogallo, Jean Luc Melenchon in Francia. Ognuno di loro non è che un frammento - grande o piccolo, giovane o vecchio, con molteplici gradazioni di estremismo - di un medesimo fenomeno continentale. Figlio a scoppio ritardato dello scongelamento dell’Europa a seguito della caduta del muro di Berlino, e poi della globalizzazione e dalla doppia recessione del 2008 e del 2011: l’allargamento dello spettro politico oltre i confini della liberaldemocrazia e della socialdemocrazia e delle loro ormai endemiche grandi coalizioni. È un problema? Sì, lo è. Perché queste due ideologie - e lo sappiamo bene, l’abbiamo vissuto – portano fisiologicamente con loro lo scontro sociale, azione e reazione, tra popoli o tra classi, tra cittadini e stranieri, tra poveri e ricchi, giusti o sbagliati che siano. E a noi europei occidentali che abbiamo vissuto cinquanta e rotti anni di pace – anni di piombo esclusi, Jugoslavia esclusa - e che pensavamo di perpetrare questa condizione sine die grazie alla chimera dell’Europa Unita, ci ritroviamo al punto di partenza, spaventati e inorriditi dall’inevitabile ciclicità della Storia, maestra di vita fino a un certo punto. Spoiler: quell’Europa è morta. Ed è finita la nostra infanzia felice di popoli rinati dalle ceneri di due conflitti mondiali. Oggi siamo nel pieno di una turbolenta adolescenza senza punti di riferimento, né ancoraggi sociali, siano essi la fabbrica, la famiglia, il partito, il popolo, la nazione, la razza. Siamo meticci e inermi. E poco ci importa, in fondo, se il mondo nel suo complesso sta meglio, se l’economia gira, se non c’è mai stato tanto lavoro, se tutto sommato si tiene botta con l’assistenza sociale più generosa del pianeta e una speranza di vita che tira verso i cento anni, inimmaginabile solo poche decine di anni fa. È il come che non funziona e ci destabilizza. Perché siamo inermi di fronte a processi più grandi di noi – la libera circolazione dei soldi, delle merci, delle persone, delle fabbriche – e perché affrontiamo tutto questo da soli, incapaci di trovare una rappresentazione collettiva in cui rifugiarci. Spoiler: quell’Europa è morta. Ed è finita la nostra infanzia felice di popoli rinati dalle ceneri di due conflitti mondiali. Oggi siamo nel pieno di una turbolenta adolescenza senza punti di riferimento, né ancoraggi sociali, siano essi la fabbrica, la famiglia, il partito, il popolo, la nazione, la razza. Siamo meticci e inermi. E poco ci importa, in fondo, se il mondo nel suo complesso sta meglio. Ed ecco allora che tutto torna: le vecchie bandiere, i vecchi slogan, le vecchie ideologie. Non solo a destra, peraltro: dal nuovo, vecchio Labour di Jeremy Corbyn che anche nella sua iconografia riprende i temi e le immagini delle antiche lotte sindacali degli anni ’70 e ’80, prima che Blair rompesse con le Trade Union, sino alla testuggine di Casa Pound, le bandiere prussiane che sventolano nei cortei tedeschi e troneggiano appese nelle caserme fiorentine, la bandiera verde della falange nazional radicale polacca degli anni ’30, dalle forti connotazioni antisemite, sventolata nel maxi corteo di Varsavia contro l’invasione straniera – in un Paese che ha meno del 2% di stranieri residenti – dello scorso 11 novembre. Spoiler, parte seconda: l’approdo alla nostra età adulta, l’esito della nostra perturbante adolescenza, dipende da come sapremo reagire a questi sommovimenti. Di fronte abbiamo due strade, nessuna delle quali è esente da rischi. Se li ghettizzeremo come scarti del passato, se ne negheremo la cittadinanza politica fino a escluderli da ogni rappresentazione politica e mediatica, se rifiuteremo di misurarci con loro, daremo loro un formidabile strumento di legittimazione tra le masse impaurite, rancorose e rabbiose. Se invece daremo loro piena legittimità a esistere, accettando il confronto con le loro idee e con le loro ricette estreme dovremo essere capaci, da liberaldemocratici e socialdemocratici, di essere all’altezza del dibattito. Altrimenti, senza scomodare il passato, rischiamo di finire come l’Ungheria e la Polonia. Non è una scelta semplice, ma la risposta giusta esiste ed è la seconda. Perché ci impone di agire sulle cause dello stato in cui siamo, anziché semplicemente biasimarne gli effetti. Intendiamoci: agire sulle cause non vuol dire non reprimere chi predica o pratica la violenza e l’intolleranza verso le idee altrui. Nè vuole dire, banalmente, buttare a mare la globalizzazione e il libero mercato. Né chiudere le frontiere e rispedire tutti i migranti a casa loro. Al contrario, consiste nel guardare in faccia alla realtà, nell’accettare il fatto che qualcosa non abbia funzionato, che la Storia non è finita, che il malessere ha più di qualche fondamento. E avere il coraggio di correggere quel qualcosa che non va, anche a costo di generare nuovi squilibri, anche a costo di buttare a mare qualche dogma e qualche certezza. Ad esempio, far pagare le tasse ad Apple e Amazon è una buona idea, tanto per cominciare. E organizzare un sistema di accoglienza dei richiedenti asilo come si deve, senza lasciare che sia un prefetto che decida di ammassarli a caso nell'albergo o nel rudere sfitto del primo palazzinaro che si offre volontario, pure. Non abbiamo abbastanza lungimiranza, né tantomeno una visione politica all’altezza di questa sfida, ma sappiamo che va affrontata. Per farlo bisogna ascoltare pure loro, i nuovi estremisti? Probabilmente sì. È necessario dialogarci, anche a costo di diventarne cassa di risonanza? Altrettanto. È rischioso? Sì, molto. Ma non c’è adolescenza che non lo sia. E non c’è adulto che è realmente tale senza esserci in qualche modo passato in mezzo. Oggi tocca a noi. Prima ce ne facciamo una ragione, meglio è.
Il vero fascismo. Che patologia più grave di un grave tumore aveva Sofri rispetto a Dell'Utri, da essere trattato in modo così diverso? La risposta è semplice: era di sinistra, scrive Alessandro Sallusti, Venerdì 08/12/2017, su "Il Giornale". Devo ricredermi, ha ragione La Repubblica a lanciare l'allarme su un pericoloso rigurgito di fascismo in Italia. Ma non perché - come enfatizza il quotidiano diretto da Mario Calabresi - cinque cretini di Forza Nuova leggono un volantino in un centro culturale pacifista e altrettanti agitano fumogeni sotto la sede del suo giornale mascherati manco fosse carnevale. Stiamo diventando un Paese fascista perché un anziano e malato detenuto viene tenuto in carcere nonostante i medici abbiano certificato che le sue condizioni di salute sono senza dubbio incompatibili con il regime di detenzione. Anzi, per la verità Mussolini gli oppositori politici li mandava al confino nella splendida isola di Ventotene o in esilio, come capitò anche a Indro Montanelli, futuro fondatore di questo Giornale. La decisione di ieri del tribunale di sorveglianza di negare cure adeguate in luoghi adeguati a Marcello Dell'Utri, 76 anni, malato di tumore e ad alto rischio cardiopatico, suona come una condanna a morte di Stato. Condanna che l'imputato ha accettato annunciando di sospendere volontariamente e da subito anche le poche terapie che gli vengono somministrate in carcere. Noi quella condanna non la accettiamo e la cosa dovrebbe fare inorridire anche i sinceri democratici antifascisti che si agitano tanto per le pagliacciate di quattro ragazzotti in cerca di pubblicità (facendo così peraltro il loro gioco) ma che appaiono indifferenti alle violenze fasciste della giustizia. Tanto accanimento, direi odio, nei confronti di Dell'Utri non può che avere radici politiche, perché il codice penale permetterebbe ben altre soluzioni. Tipo quelle trovate per Adriano Sofri, icona della sinistra salottiera e rivoluzionaria, che condannato per l'omicidio del commissario Calabresi (padre dell'attuale direttore della Repubblica) scontò metà di una misera pena (15 anni) nel comodo di casa sua per «motivi di salute». Chiedo ai signori giudici: che patologia più grave di un grave tumore aveva Sofri rispetto a Dell'Utri (che per di più non ha mai ucciso nessuno), da essere trattato in modo così diverso? La risposta è semplice. Sofri era di sinistra (e che sinistra), Dell'Utri è stato a lungo il braccio destro di Berlusconi, e per questo può morire in cella come un cane. Se dovesse succedere, e mi auguro di no, chiunque può fare qualche cosa per fermare questo «fascismo» giudiziario - dal ministro della Giustizia al presidente della Repubblica - e se ne lava le mani dovrà risponderne. Agli uomini liberi da pregiudizi e alla propria coscienza, per tutta la vita.
L’antifascismo paranoico si combatte sul piano culturale e politico, scrive Gianfranco de Turris il 29 dicembre 2017 su “Primato Nazionale”. La paranoia – mi correggano gli specialisti se sbaglio – si manifesta con una sindrome di persecuzione collegata ad una sindrome di onnipotenza. Questa la malattia psichica di cui soffre la classe politico-intellettuale-giornalistica italiana, e non da oggi, una malattia che impedirà sinché dura ogni possibile modus vivendi tra posizioni diverse nel Bel Paese ed è alla base del doppiopesismo che ne governa le decisioni su molti piani. Le recenti manifestazioni d’intolleranza del Partito democratico e dell’Anpi, ai quali spesso e volentieri si aggiungono certi grillini, sono la prova del diffondersi di questa patologia ossessiva che per la sua pericolosità è necessario continuare sempre a mettere in evidenza. Certa sinistra italiana vede ormai manifestazioni dirette e indirette di “fascismo” per ogni dove e s’impegna a fondo per scovarle e denunciarle quasi a voler sottolineare la necessità di approvare la famigerata Legge Fiano. La patologia va peggiorando e non la si può ignorare dato che cerca di influenzare la gente comune, alla quale la questione in sostanza non interessa, come ha sottolineato Alessandra Mussolini in una intervista a il Giornale del 3 dicembre, e creare così una artificiosa sensazione di allarme politico-sociale amplificato dai mass media vicini alla sinistra. Il limite estremo è stato per ora raggiunto, ma di certo verrà superato, dalle indignate protesta di Pd e Anpi, appunto, per una… lettera maiuscola! A Torino ha vinto il bando di concorso per delle manifestazioni natalizie una società che si chiama “Mercatini di Bolzano”. A quanto pare la “M;” iniziale del logo ai piddini ed ai vecchi e giovani partigiani ricorda troppo la “M” di Mussolini e la M” dei Battaglioni M! Incredibile ma vero. Un delirio di persecuzione. C’è anche da dire che il simbolo della società in questione è il Monumento della Vittori (nella Grande Guerra) che a Bolzano da sempre viene visto come fumo negli occhi dagli altoatesini di lingua tedesca. Intollerabile. Sicché questa iniziativa natalizia torinese è stata definita dai paranoidi contestatari “una manifestazione fuori dal perimetro costituzionale”. Ma veramente non si rendono conto del ridicolo? E’ la sindrome di onnipotenza che li acceca. L’immaginazione non ha limiti e siamo passati dal famoso, e dimenticato, “arco costituzionale” inventato da De Mita che serviva a tener fuori il Msi dalla politica parlamentare anche se era legittimamente rappresentato in Parlamento, al “perimetro costituzionale”, idea veramente geniale. Ci aspettiamo adesso la “circonferenza”, la “retta” e il “diametro” costituzionali. Quasi in contemporanea, il 29 novembre 2017, è avvenuto che tredici appartenenti al Veneto Fronte Skinheads (che nel linguaggio giornalistico da sinistra a destra sui quotidiani e in Tv, divengono i “naziskin”) a Como hanno fatto irruzione nella sede della associazione Como Senza Frontiere che si occupa di immigrati ed hanno letto un volantino. Sono stati denunciati per “violenza privata” e hanno sollevato l’indignazione della classe politica, Renzi in testa, che ha parlato di “azione squadristica neofascista”. Che è successo in concreto? I tredici hanno aggredito i presenti, hanno distrutto i locali? No e infatti nessuno ha osato sostenerlo. Si sono limitati a leggere un loro proclama definito “delirante” dalla stampa. L’accaduto lo si potrebbe definire un blitz, un flash-mob, certamente provocatorio ma non violento. Le reazioni esagitate e la condanna dello “squadrismo” sono una tempesta in un bicchier d’acqua ma utilissimo a creare un clima di tensione generale gonfiato dai dibattiti televisivi. Condanne di politici e mass media che mancano sempre quando ad aggredire, a distruggere, a picchiare e a devastare sono i bravi ragazzi dei “centri sociali”. Diciamo cose ovvie, certo, ma nessuno le ricorda mai ai ipocriti e faziosi. Che quella di Como sia stata una strumentalizzazione antifascista lo dimostra a contrario il Corriere della Sera che ha mantenuto sul fatto un profilo bassissimo, quasi ignorandolo. L’Italia però è anche un Paese contraddittorio, che un giorno fa una cosa e il giorno dopo il suo esatto contrario. Mentre, come si disse, vengono dileggiati in quanto “fascisti convinti” illo tempore un Eugenio Scalfari e un Fiorenzo Magni, al quale non si dedica una pista ciclabile a Prato proprio per questo motivo, ecco che invece si fa l’apologia di un altro “fascista convinto”, Mario Sironi, del quale è stato restaurato e presentato in gran pompa il suo enorme affresco (oggi si ama dire murale) dell’aula magna della Università di Roma La Sapienza. Anzi, più che restaurato si dovrebbe dire ripristinato, in quanto sono state asportate dopo oltre mezzo secolo le cancellature e le verniciature che negli anni Cinquanta vennero effettuate sulle parti “fasciste” della sua enorme opera. L’Italia democratica non ne poteva sopportare la vista, proprio come secoli prima certi cardinali pudibondi non potevano sopportare la vista dei nudi michelangioleschi della Cappella Sistina e li fecero ricoprire con i famigerati “mutandoni” oggi anch’essi rimossi da tempo, e proprio come De Gasperi nell’immediato dopoguerra si sentì offeso dalle pudenda esibite dalle statue dello Stadio dei Marmi al Foro ex Mussolini e le fece ricoprire da enormi foglie di fico. A quanti pare nell’odierna Italia sputtanata i motivi per sentirsi offesi sono ben altri. Non siamo certo alla vigilia di una nuova Marcia su Roma, ma si sta verificando una situazione oggettiva su cui la classe dirigente italiana dovrebbe meditare in modo serio: perché a quasi un secolo dalla nascita del fascismo e a oltre settant’anni dalla sua caduta la sua ideologia, la figura di Mussolini e la tragica esperienza della RSI attraggono giovani e giovanissime generazioni, perché i suoi simboli compaiono nei momenti e posti più inaspettati tanto da indurre il molto onorevole Fiano a proporre la sua legge liberticida. L’ideologia democratica e partitocratica ha fallito e perché? Una risposta dovrebbe far ripensare quel che è stato sbagliato invece di ricorrere soltanto alla repressione, spesso ottusa ed sproporzionata Certamente alcuni episodi non collegati fra loro forniscono l’esca a questi allarmi esagerati: vedi la foto di Anna Frank in maglia giallorossa esposta all’Olimpico dagli ultrà laziali, o quel giocatore che dopo un gol fa il saluto romano scopre una maglietta con il simbolo della Repubblica Sociale proprio a Marzabotto. Estremismi giovanili e anche un pizzico di ignoranza che prendono preventivamente in considerazione le reazioni che avrebbero provocato innescando una reazione a catena di denunce, anatemi e condanne. Ci si dimentica sempre che venticinque anni fa la scusa per emanare la Legge Mancino fu una semplice manifestazione con corteo senza violenza né disordini del Veneto Fronte Skinheads nel 1993. Certe cose sono oggettivamente controproducenti ottenendo più danni che benefici, fossero solo di principio. In sostanza aiutano chi vorrebbe varare leggi più generali e generiche contro il “pericolo fascista”, o fornisce ragioni emotive a chi propone di abbattere le “architetture fasciste”. Provocazioni ingenue e che si ritorcono contro. Meglio pensarci prima di metterle in pratica. Meglio agire con cognizione di causa. Meglio applicare una strategia entrista. Meglio ottenere consiglieri comunali o circoscrizionali. Inutile “provocare” a vuoto, meglio andare sui fatti concreti e farsi apprezzare dalla gente comune sul piano politico e culturale puntando sulle contraddizioni degli avversari. Altrimenti si corre il rischio di restare sempre nei limiti di contestatori marginali e inefficaci, chiassosi e provocatori sì, ma del tutto irrilevanti capaci di produrre l’effetto contrario, cioè leggi repressive. Gianfranco de Turris
L’arrestocrazia e il potere del “Coro antimafia”, scrive Piero Sansonetti l'11 Novembre 2017 su "Il Dubbio". Dal caso De Luca al caso Spada, quando l’arresto mediatico e a furor di popolo conta più le regole del diritto. E chi dissente è considerato un complice dei farabutti. Ieri pomeriggio Cateno De Luca è stato assolto per la quattordicesima volta. Niente concussione, nessun reato. A casa? No, resta agli arresti perché dopo 15 accuse, 15 processi e 15 assoluzioni, martedì scorso era arrivata la 16ima accusa. E ci vorrà ancora un po’ prima che sia assolto di nuovo. Stavolta l’accusa è evasione fiscale. Non sua, della sua azienda. Cateno De Luca è un deputato regionale siciliano. Era stato eletto martedì. Lo hanno ammanettato 24 ore dopo. L’altro ieri sera invece era stato fermato Roberto Spada. Stiamo aspettando la conferma del suo arresto. Lui è in una cella a Regina Coeli. Roberto Spada è quel signore di Ostia che martedì ha colpito con una testata – fratturandogli il naso – un giornalista della Rai che gli stava facendo delle domande che a lui sembravano inopportune e fastidiose. È giusto arrestare Spada? È stato giusto arrestare Cateno De Luca? A favore dell’arresto ci sono i giornalisti, gran parte delle forze politiche, una bella fetta di opinione pubblica. Diciamo: il “Coro”. Più precisamente il celebre “Coro antimafia”. Che ama la retorica più del diritto. Contro l’arresto c’è la legge e la tradizione consolidate.
Prendiamo il caso di Spada. La legge dice che è ammesso l’arresto preventivo di una persona solo se il reato per il quale è accusata è punibile con una pena massima superiore ai cinque anni. Spada è accusato di lesioni lievi (perché la prognosi per il giornalista è di 20 giorni) e la pena massima è di un anno e mezzo. Dunque mancano le condizioni per la custodia cautelare. Siccome però il “Coro” la pretende, si sta studiando uno stratagemma per aggirare l’ostacolo. Pare che lo stratagemma sarà quello di dare l’aggravante della modalità mafiosa. E così scopriremo che c’è testata e testata. Ci sono le testate mafiose e le testate semplici. Poi verrà il concorso in testata mafiosa e il concorso esterno in testata mafiosa.
Mercoledì invece, dopo l’arresto di Cateno De Luca, non c’erano state grandi discussioni. Tutti – quasi tutti – contenti. Sebbene l’arresto per evasione fiscale sia rarissimo. Ci sono tanti nomi famosi che sono stati accusati in questi anni di evasione fiscale per milioni di euro. Alcuni poi sono stati condannati, alcuni assolti. Da Valentino Rossi, a Tomba, a Pavarotti a Dolce e Gabbana, a Raul Bova e tantissimi altri. Di nessuno però è stato chiesto, ovviamente, l’arresto preventivo. Perché? Perché nessuno di loro era stato eletto deputato e dunque non c’era nessun bisogno di arrestarlo. L’arresto, molto spesso, specie nei casi che più fanno notizia sui giornali, dipende ormai esclusivamente da ragioni politiche. E il povero Cateno ha pagato cara l’elezione. I Pm non hanno resistito alla tentazione di saltare sulla ribalta della politica siciliana. Comunque qui in Italia ogni volta che qualcuno finisce dentro c’è un gran tripudio. L’idea che ormai si sta affermando, a sinistra e a destra, è che l’atto salvifico, in politica, sia l’arresto. Mi pare che più che in democrazia viviamo ormai in una sorta di “Arresto- Crazia”. E che la nuova aristocrazia che governa l’arresto-crazia sia costituita da magistrati e giornalisti. Classe eletta. Casta suprema. Gli altri sono colpevoli in attesa di punizione. Poi magari ci si lamenta un po’ quando arrestano i tuoi. Ma non è niente quel lamento in confronto alla gioia per l’arresto di un avversario. Il centrodestra per esempio un po’ ha protestato per l’arresto pretestuoso di Cateno De Luca. Il giorno prima però aveva chiesto che fosse sospesa una fiction in Rai perché parlava di un sindaco di sinistra raggiunto da avviso di garanzia per favoreggiamento dell’immigrazione. Il garantismo moderno è così. Fuori gli amici ed ergastolo per gli avversari. Del resto la sinistra che aveva difeso il sindaco dei migranti ha battuto le mani per l’arresto di Cateno.
L’altro ieri intanto è stato minacciato l’avvocato che difende il ragazzo rom accusato di avere stuprato due ragazzini. L’idea è quella: “se difendi un presunto stupratore sei un mascalzone. Il diritto di difesa è una trovata farabutta. Se uno è uno stupratore è uno stupratore e non serve nessun avvocato e nessunissima prova: condanna, galera, pena certa, buttare la chiave”. Giorni fa, a Pisa, era stato aggredito l’avvocato di una ragazza accusata di omicidio colposo (poi, per fortuna, gli aggressori hanno chiesto scusa). Il clima è questo, nell’opinione pubblica, perché questo clima è stato creato dai politici, che sperano di lucrare qualche voto, e dai giornali che un po’ pensano di lucrare qualche copia, un po’, purtroppo, sono scritti da giornalisti con doti intellettuali non eccezionali. E se provi a dire queste cose ti dicono che sei un complice anche tu, che stai con quelli che evadono le tasse, che stai con quelli che danno le testate. Il fatto che magari stai semplicemente col diritto, anche perché il diritto aiuta i deboli mentre il clima di linciaggio, il forcaiolismo, la ricerca continua di punizione e gogna aiutano solo il potere, beh, questa non è nemmeno presa in considerazione come ipotesi. Tempo fa abbiamo pubblicato su questo giornale “La Colonna Infame” di Manzoni. Scritta circa due secoli fa. Due secoli fa? Beh, sembra ieri…
P. S. Ho letto che Saviano ha detto che Ostia ormai è come Corleone. Corleone è la capitale della mafia. A Corleone operavano personaggi del calibro di Luciano Liggio, Totò Riina, Bernardo Provenzano. Corleone è stato il punto di partenza almeno di un migliaio di omicidi. Tra le vittime magistrati, poliziotti, leader politici, sindacalisti, avvocati. Paragonare Ostia a Corleone è sintono o di discreta ignoranza o di poca buonafede. Ed è un po’ offensivo per le vittime di mafia. P. S. 2. Il giornalista Piervincenzi, quello colpito con la testata da Spada, ha rilasciato una intervista davvero bella. Nella quale tra l’altro, spiega di non essere stato affatto contento nel sapere dell’arresto di Spada. Dice che lui in genere non è contento quando arrestano la gente. Davvero complimenti a Piervincenzi. Io credo che se ci fossero in giro almeno una cinquantina di giornalisti con la sua onestà intellettuale e con la sua sensibilità, il giornalismo italiano sarebbe una cosa sera. Purtroppo non ce ne sono.
Quei massoni mafiosi che sussurrano ai potenti. Sacerdoti, politici, magistrati, professionisti, imprenditori. E padrini delle cosche. La commissione parlamentare antimafia ha presentato la relazione sulle infiltrazioni dei clan nella massoneria. Tra Sicilia e Calabria 17 mila iscritti alle 4 obbedienze ufficiali distribuiti in 389 logge. 193 "fratelli" sono collegati a cosa nostra e 'ndrangheta, uno ogni due templi. I nomi restano top secret, scrivono Federico Marconi e Giovanni Tizian il 22 dicembre 2017 su "L'Espresso". Sacerdoti, magistrati, consiglieri comunali e regionali, assessori, sindaci, imprenditori, studenti, professionisti. E mafiosi, calabresi e siciliani. Al gran ballo della massoneria ci sono tutti, non manca proprio nessuno. Alle danze tra Sicilia e Calabria partecipano in 17 mila. In fondo, una loggia non si nega a nessuno. Insomma, tutti pazzi per il grembiule. Il dato inquietante è però un altro: in queste due regioni del Sud c'è un mafioso o un suo complice ogni due logge massoniche. Sono 193, infatti, i “fratelli” collegati ai clan. C'è chi è stato condannato, chi è stato prosciolto, chi ha festeggiato l'assoluzione e chi si sta ancora difendendo nelle aule dei tribunali. Gli iscritti totali alle quattro obbedienze, solo in Sicilia e Calabria, sono oltre 17mila. Una popolazione in grembiule numerosa come quella dell'isola di Capri. La commissione antimafia presieduta da Rosy Bindi ha terminato l'indagine sull'intreccio tra massoneria e mafie. La relazione, approvata il 22 dicembre, è un viaggio nel lato oscuro della massoneria italiana. Un mondo di mezzo nel quale boss e insospettabili professionisti, padrini e rispettabili imprenditori, criminali e politici, si scambiano favori e appoggi. Dei 193 nomi sporchi la commissione precisa che «nove risultano condannati in via definitiva per reati vari, quali il traffico di stupefacenti, ricettazione, falso, bancarotta fraudolenta, o destinatari, in via definitiva, di misure di prevenzione personali, come tali indicative di pericolosità sociale». Poi per altri quattro è in corso il processo di appello con l'accusa di associazione mafiosa o di reati aggravati dal metodo mafioso. Uno di questi in primo grado ha subito già una condanna a 12 anni. L'obbedienza con la maggiore presenza di iscritti dal profilo equivoco è il Goi, il Grande Oriente d'Italia. Il Gran Maestro è Stefano Bisi, il massone che più degli altri si è opposto al lavoro della commissione antimafia bollandolo come un atto fascista. Ora che l'indagine si è conclusa e la riservatezza è stata rispettata- nel documento non è presente alcun nome- si scopre che più di qualche boss ha frequentato i templi. Nella Gran Loggia regolare d'Italia i sospetti sono 58, nella Gran loggia d'Italia sono 9 e nella Serenissima solo 4. «Le risultanze illustrate nella relazione hanno fornito conferme in ordine alla rilevanza del fenomeno, a fronte di una sua negazione da parte dei gran maestri, indice o di un’inconsapevolezza o di una sua sottovalutazione, se non di un rifiuto ad ammettere la possibile permeabilità rispetto a infiltrazioni criminali», osserva l'Antimafia. La commissione, tuttavia, precisa che gli investigatori che hanno collaborato ai risconti sugli elenchi sequestrati nelle sede delle obbedienze hanno indicato solo «i soggetti iscritti per reati di mafia in senso stretto, restando pertanto non segnalati tutti i casi in cui il nominativo risulta essere stato, invece, indagato o condannato per altri reati, taluni certamente di non minore gravità». Come a dire: attenzione, i 193, che possono sembrare poca cosa, potrebbero aumentare sensibilmente se si sommassero a questi i massoni con precedenti per corruzione, abuso d'ufficio, reati economici e tributari. Tutti reati spia di una criminalità mafiosa che si insinua nei centri di potere locali: municipi, assessorati, aziende sanitarie, assemblee regionali e provinciali. «A tal proposito, si segnala che il 17,5 per cento degli iscritti presenti negli elenchi acquisiti dalla Commissione non sono identificabili o compiutamente identificabili». Questo significa che molti nella lista sono indicati con le iniziali, oppure con dati anagrafici errati. Il che ha reso impossibile risalire alla loro identità. «Nell’ambito dei 193 soggetti segnalati vi sono, come risulta dall’anagrafe tributaria, numerosi dipendenti pubblici. Le categorie professionali prevalenti sono quelle dei professionisti, come avvocati, commercialisti, medici e ingegneri. Presenti pure in numero rilevanti i soggetti impiegati nel settore bancario, farmaceutico e sanitario, nonché imprenditori nei più diversi settori, in primis quello edile. Così pure, non mancano coloro i quali hanno rivestito cariche pubbliche». Sono ben 9 gli amministratori, tra sindaci, assessori o consiglieri comunali. «Uno spaccato professionale denotante soggetti di un livello di istruzione medio-alto e, di tutta evidenza, in grado di stringere relazioni anche nel mondo della criminalità e in quello della società civile», si legge nella relazione.
Logge e politica. Un focus la commissione lo ha dedicato alla presenza della massomafia all'interno degli enti locali sciolti per mafia. Caso emblematico l'Asl di Locri, commissariata undici anni fa. «Fra i soggetti a vario titolo menzionati nella relazione della commissione di accesso e nell’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Reggio Calabria, figurano 306 nominativi. Di questi, 17 risultano censiti in logge massoniche. Tra essi, 12 soggetti figurano negli elenchi sequestrati dalla Commissione il 1° marzo 2017; 4 figurano solo negli elenchi (della massoneria ndr) sequestrati dalla Procura della Repubblica di Palmi nel 1993-94 (uno nel frattempo è deceduto); mentre un altro è presente in entrambi gli elenchi. Appare significativo che i 4 soggetti presenti negli elenchi del 1993-94 ma non in quelli del 2017, risultano essere stati raggiunti da provvedimenti cautelari personali o a carattere detentivo, uno dei quali per il reato di cui all’art 416-bis c.p». Ma chi sono questi mafiosi armati di compasso? «Uno è il figlio di un noto capo mafia; un altro, il nipote di un controverso personaggio ritenuto molto influente nell’ambiente mafioso; un altro ancora, figlio di un condannato in primo grado per mafia ma assolto in appello e, comunque, indicato come referente di una nota cosca calabrese, nonché in stretti rapporti con un capo indiscusso di una cosca del mandamento ionico della provincia reggina». Detto dei criminali o presunti tali, nella relazione si evidenzia un altro aspetto: «Deve ritenersi non occasionale, la significativa presenza di massoni in posti apicali dell’azienda sanitaria, nelle società presso la medesima accreditate e nelle pubbliche amministrazioni interessate dall’indagine penale. Di rilievo è il fatto che tali personaggi, di cui si è accertata l’appartenenza a logge massoniche regolari, hanno interagito con altri “fratelli” della stessa loggia o di altre per affari riconducibili a persone indagate e, in taluni casi, condannate per associazione mafiosa». Insomma, non è tanto la quantità di mafiosi presenti nelle logge, ne basta uno per usufruire dei vantaggi che il circolo di amicizie può garantire. Anche la Azienda sanitaria provincia di Cosenza è stata sciolta. Incrociando i risultati emersi nella relazione prefettizia con gli elenchi sequestrati, la commissione ha concluso che «su 220 nominativi individuati, presenti a vario titolo nella relazione conclusiva, 23 persone risulterebbero iscritte a logge massoniche».
A casa del padrino. Nel paese di Matteo Messina Denaro pullulano compassi e grembiuli. Undici logge di varie obbedienze per 31 mila abitanti. Una vera città della massoneria, Castelvetrano. Tanto da essere rappresentata degnamente in consiglio comunale, sempre e comunque. Nell'ultima consiliatura, 2007-2012, «8 consiglieri su 30 appartenevano, o avevano chiesto di entrare in logge massoniche. Tra i componenti del consiglio comunale eletto nel 2012, vi sono 11 iscritti ad associazioni massoniche (anche diverse da quelle in esame), uno dei quali è stato anche assessore e componente della giunta comunale, quest’ultima poi revocata il 28.01.2015. Nella nuova giunta nominata l’11.02.2015, il numero di assessori massoni aumenta considerevolmente, diventando cinque su dodici membri complessivi della giunta, cioè poco meno della maggioranza. In sintesi, considerando le ultime due consiliature del comune di Castelvetrano hanno assunto cariche elettive o sono stati membri di giunta almeno 17 iscritti alle quattro obbedienze. A questi potrebbero aggiungersene verosimilmente altri 4 - per un totale, dunque, di 21 amministratori pubblici. Negli elenchi massonici di una obbedienza (GLRI), vi sono infatti omonimi di altri quattro consiglieri comunali di Castelvetrano tra i soggetti che risultano privi del luogo e della data di nascita in quanto depennati. Il tutto distribuito in 11 logge quasi tutte presenti nella città di Castelvetrano e dintorni».
Capi e massoni. Il collaboratore di giustizia Leonardo Messina: “Molti uomini d’onore quelli che riescono a diventare capi, appartengono alla massoneria (..) perché è nella massoneria che si possono avere i contatti totali con gli imprenditori, con le istituzioni, con gli uomini che amministrano il potere diverso da quello punitivo che ha Cosa nostra.” Lo stesso concetto è stato ribadito alla Commissione, con riferimento ai primi anni del 2000, da un altro collaboratore di giustizia, Francesco Campanella. Anche lui politico, massone e mafioso. Scrive la commissione: «Nelle più recenti indagini giudiziarie, calabresi e siciliane, ricorre la medesima affermazione che appare ancor più vera alla luce del mutamento delle mafie, ormai propense, come è noto, al metodo collusivo/corruttivo seppur collegato alla propria capacità di intimidazione...Anzi, proprio in questo peculiare momento in cui la mafia tende più ad “accordarsi che a sparare”, deve altresì considerarsi il dato oggettivo del continuo aumento del numero degli iscritti alla massoneria». Del resto le inchiesta recenti dell'antimafia di Reggio Calabria puntano a svelare proprio quel sistema criminale fatto di padrini e insospettabili uomini di potere, che spesso si ritrovano in circoli massonici, non per forza ufficiali.
Un favore al “fratello” boss. Nella loggia “Rocco Verduci” di Gerace, a Locri, si sono verificati fatti inquietanti. «Un magistrato onorario, appartenente alla predetta loggia, aveva chiaramente denunciato, ma soltanto in ambito massonico, una prima vicenda, risalente al dicembre 2010, riguardante le pressioni da egli subite ad opera di due suoi confratelli affinché si adoperasse per intervenire sul giudice monocratico del Tribunale di Locri al fine di ottenere, in favore dei figli di uno dei due, sottoposti a un procedimento penale per ricettazione, la derubricazione del reato. Vale la pena aggiungere che il massone che sollecitava l’intervento del magistrato onorario in favore dei propri figli indagati, era un medico della ASL di Locri, poi sciolta per mafia, nonché figlio di un noto boss ‘ndranghetista, mentre il massone che lo accompagnava, per sostenerne la richiesta, era un soggetto che, all’epoca di fatti, svolgeva un ruolo direttivo nell’ambito della “Rocco Verduci”». Allo stesso magistrato onorario viene chiesto successivamente un secondo favore: «Intorno al mese di aprile 2012, fu ulteriormente sollecitato, da un altro dei suoi fratelli di loggia, affinché intervenisse ancora, riservatamente, presso i magistrati della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria al fine di perorare la causa di un terzo massone, già consigliere della Regione Calabria, avendo questi saputo che, in quel momento, nell’ambito di una indagine antimafia, naturalmente coperta dal più rigoroso segreto, si stava vagliando la sua posizione». In questo caso la vicenda assume contorni molto più oscuri. Sia perché è evidente la fuga di notizie che giungono all'orecchio di massoni borderline, sia perché si trattava di indagine in corso. «Vale la pena aggiungere, anche in questo caso, che il massone che si stava prodigando, presso il magistrato onorario, in favore del politico, già si era prestato, nei confronti di quest’ultimo per far ammettere nella loggia un nuovo bussante, figlio incensurato di un soggetto tratto in arresto per associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Saggezza” dell'antimafia di Reggio Calabria».
Tonaca e grembiule. Nello sterminato elenco di personalità, non potevano mancare i sacerdoti delle logge. La chiesa lo vieterebbe, ma questo non ha evidentemente fermato le aspirazioni dei religiosi. «Non è questa la sede per affrontare la questione plurisecolare del rapporto tra Chiesa cattolica e massoneria, tuttavia appare utile ricordare che, in base alla Declaratio de associationibus massonicis emanata dalla Congregazione vaticana per la Dottrina della Fede il 26 novembre 1983 - presieduta dal Prefetto cardinale Joseph Ratzinger, poi papa Benedetto XVI - vi è inconciliabilità tra l’adesione alla Chiesa cattolica e alla massoneria», scrive la Commissione. Di recente, tra l'altro, papa Francesco ha respinto le credenziali di un ambasciatore straniero presso la Santa Sede perché iscritto alla massoneria.
Logge segrete e sconosciute. L'indagine della Commissione è stata effettuata sulle obbedienze conosciute, quelle più note e ufficiali. Tuttavia nel variegato mondo massonico esistono numerosi gruppuscoli più o meno noti, più o meno legali. Il tempo per analizzare anche quel mondo non sarebbe stato sufficiente. Per questo la commissione invita i prossimi membri della futura legislatura a proseguire nell'opera di inchiesta: «È stato evidenziato dallo stesso mondo massonico come in Italia, e in particolar modo nelle regioni del centro-sud, sia presente un florilegio di numerose piccole obbedienze, con dichiarate finalità lecite, considerate alla stregua di massonerie irregolari o di logge spurie. Così come è stato segnalato che esistono canali di dialogo tra queste entità associative e la massoneria regolare». E quindi: «L’insieme di queste dichiarazioni, dunque, proprio perché provenienti dall’interno del circuito massonico, e peraltro da chi lo rappresenta, acquistano particolare valenza in quanto pongono le premesse, unitamente ad altri elementi raccolti da questa Commissione, sulla necessità che il lavoro d’inchiesta avviato in questa Legislatura debba proseguire. Non potrà, infatti, essere trascurato l’approfondimento del mondo magmatico delle massonerie irregolari, del loro potenziale relazionale, dell’atteggiarsi delle mafie nei loro confronti». Interessante a questo proposito i particolari forniti dal gran maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia: «Una cosa che accade spesso è che gli iscritti alla massoneria, alla libera muratoria, sono contemporaneamente iscritti anche ad altre forme associative. Parlo del Rotary, dei Lions, dei Kiwanis. In queste associazioni i massoni di varie obbedienze – ed è l'unico posto dove avviene – si incontrano. Quindi, sarebbe ancora più interessante, secondo me, analizzare queste realtà, perché sono le uniche realtà all'interno delle quali la massoneria irregolare e regolare va a incontrarsi. Spesso, quindi, i presentatori incontrano i presentati all'interno del Rotary o del Kiwanis. Molti iscritti alla massoneria ne sono presidenti».
Gli elenchi? No, grazie. La Commissione pensava di trovare una sponda nei vertici delle obbedienze massoniche. Così non è stato. Nelle audizioni dei vertici delle organizzazioni negavano la presenza di infiltrazioni mafiose e sottolineavano l’esistenza di regole e prassi massoniche – come la richiesta dei carichi pendenti e del certificato antimafia ai nuovi membri – in grado di fronteggiare il possibile ingresso di “personalità problematiche”. Si aggiunge poi il rifiuto, in nome della segretezza, di fornire alla Commissione gli elenchi degli appartenenti alle logge, che una volta consegnati sono risultati parziali e incompleti. Le obbedienze hanno sottovalutato, minimizzato e a volte persino negato la presenza di massoni “problematici” all’interno delle logge. Basti pensare che l’infiltrazione mafiosa non è mai esplicitata nei documenti formali con cui ne viene decretata la chiusura delle logge infiltrate. Piuttosto vengono utilizzati l’espediente della “morosità degli iscritti” o questioni di mero rito massonico.
Quante volte il Gip dice di No al Pm? Mai, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 29 Dicembre 2017 su "Il Dubbio". I casi in cui il Gup dispone il non luogo a procedere sono rarissimi. Quasi sempre preferisce far valutare gli atti ai colleghi del dibattimento. Il Pubblico ministero ha sempre ragione. Il dato emerge con chiarezza dalle statistiche dell’ufficio Gup e Gip. Davanti alle richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura, i casi in cui un giudice dell’udienza preliminare disponga l’archiviazione con sentenza di non luogo a procedere sono infatti rarissimi. Come del resto sono rarissime le decisioni di andare a processo lì dove il pm chieda l’archiviazione. Le conseguenze di questo “appiattimento” del giudice sul pubblico ministero sono particolarmente evidenti nelle indagini sui “colletti bianchi” dove il rinvio a giudizio è ormai una certezza. Quello che decide il pm è giusto. Sempre. Il dato emerge con chiarezza leggendo le statistiche dell’Ufficio gip/ gup. Davanti alle richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura, i casi in un il giudice dell’udienza preliminare disponga l’archiviazione con sentenza di non luogo a procedere sono rarissimi. Le conseguenze di questo “appiattimento” del giudice sul pubblico ministero sono particolarmente evidenti nelle indagini sui “colletti bianchi” dove il rinvio a giudizio è ormai una certezza. A tal proposito, per evitare il clamore mediatico che una decisione del genere inevitabilmente avrebbe, da tempo gli amministratori pubblici coinvolti in un procedimento penale preferiscono saltare l’udienza preliminare, dall’esito scontato, per chiedere il giudizio immediato. Questa strada, che ha di fatto lo scopo di allontanare per qualche mese i riflettori dei media, è stata recentemente scelta dal presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, dal suo vice Mario Mantovani e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, tutti indagati a vario titolo dalla Procura del capoluogo lombardo. Restando a Milano, le statistiche sul punto sono impietose. In un anno le uniche archiviazioni ai sensi dell’art. 425 del codice di procedura penale, cioè quelle del giudice in udienza preliminare, sono relative al comma 1. Quindi per motivi strettamente formali come la mancanza di una condizione di procedibilità, ad esempio la querela da parte della vittima del reato. Inesistenti le archiviazioni in base al terzo comma, quando gli elementi acquisiti dal pm siano “insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Le cause per cui l’udienza preliminare da “filtro” che doveva essere nelle intenzioni del legislatore del codice del 1988 sia diventata un passaggio dall’esito più che prevedibile sono essenzialmente due. La prima riguarda la Cassazione che negli ultimi anni ha sempre accolto i ricorsi presentati dalla Procura e ha annullato sistematicamente le sentenze di non luogo a procedere emesse dai gup. I giudici, per evitare di essere continuamente “smentiti” hanno dunque iniziato di default a rinviare tutti a giudizio. La seconda è di tipo “pratico”. Per archiviare il giudice deve scrivere comunque una sentenza e motivare la decisione presa. Per rinviare a giudizio è sufficiente un rigo. Nell’attuale sistema di valutazione dei magistrati dominato dai numeri, ai fini statistici un procedimento definito con una sentenza di archiviazione equivale ad uno per il quale è stato invece disposto il rinvio a giudizio. La conseguenza è che i giudici dell’udienza preliminare preferiscono far valutare gli atti ai colleghi del dibattimento. Certamente non una bella prospettiva per l’imputato che dovrà affrontare un processo lungo e costoso prima di poter giungere ad una assoluzione che poteva, in molti casi, essere disposta giù in sede di udienza preliminare. Per chi si sente pronto ed ha estrema fiducia nel sistema giustizia per evitare il dibattimento l’unica possibilità resta il giudizio abbreviato. Con tutte le conseguenze che questo rito comporta, in particolare sotto il profilo dell’appello in caso di condanna. Il discorso vale anche al contrario. Sempre a Milano nell’ultimo anno sono state oltre diecimila le richieste di archiviazione da parte della Procura, quasi tutte accolte senza problemi. Rari i casi in cui il giudice per le indagini preliminari abbia ordinato di formulare l’imputazione non accogliendo la richiesta di archiviazione disposta dal pm. Talmente rari questi casi da finire sui giornali, come il procedimento a carico di Marco Cappato per istigazione al suicidio nei confronti di dj Fabo. In considerazione di ciò, sarebbe forse il caso di eliminare l’udienza davanti al gup per una migliore economia processuale. In sostanza uno stravolgimento del processo accusatorio di cui va inevitabilmente preso atto.
Il poliziotto nominato vice dell’Antimafia, scrive Piero Sansonetti il 28 Dicembre 2017 su "Il Dubbio". Oh, il giornalismo d’inchiesta! Sempre allerta. Magari arriva sulla notizia tre mesi dopo. Ma si indigna con prontezza…La storia è questa: un ex poliziotto, che probabilmente ebbe delle responsabilità nella famosa “macelleria cilena” compiuta a Genova dalla polizia durante il G8 del luglio 2001, è stato nominato numero due dell’Antimafia. Perché? Perché pare sia un investigatore molto bravo, che abbia una grande esperienza nella lotta alla mafia e fantastiche doti professionali. È giusto assegnare un incarico così importante ad una persona che è stata giudicata colpevole dalla magistratura e condannata in via definitiva a quasi quattro anni di carcere (di cui tre cancellati dall’indulto)? È una questione molto complicata. Il poliziotto del quale stiamo parlando si chiama Gilberto Caldarozzi, fu considerato responsabile per aver firmato dei verbali nei quali si raccontava di alcune bottiglie molotov trovate nella scuola Diaz (dove i poliziotti irruppero e fecero un massacro ferendo gravemente e poi arrestando decine di persone) mentre in realtà quelle bottiglie erano state portate lì dalla stessa polizia per giustificare la propria azione violenta. Noi non sappiamo se Caldarozzi ebbe o no responsabilità in quella truffa, però sappiamo di sicuro che ha scontato la pena. E non è più interdetto. Per qualunque altro cittadino pretenderemmo il diritto a tornare a pieno titolo e a pieni diritti nella vita civile e anche al suo lavoro. In questo caso però è forse necessaria una cautela maggiore: può un poliziotto che si è comportato male con lo Stato, tornare ad assumere un incarico nel quale assume responsabilità delicatissime (e potere) nei confronti degli indagati, e cioè dei cittadini? Il giornalismo d’inchiesta pronto a scattare sulla notizia! Per ora lasciamo la domanda senza risposta per occuparci di un aspetto marginale di questa vicenda. (Mica tanto marginale…). Lo scandalo Caldarozzi è stato sollevato il 24 dicembre da “Repubblica” e ripreso ieri, con grancassa, dal “Fatto” e da altri quotidiani. La nomina di Caldarozzi invece era stata decisa in settembre, cioè tre mesi fa, annunciata e anche scritta nero su bianco su alcuni giornali tra cui il “Sole 24 Ore”. Nessuno se ne è accorto. Gli occhiuti giornalisti giudiziari, di tutti i giornali, non hanno nemmeno mosso un ciglio, in settembre. Perché? Ecco, questo è il punto. Come funziona, nel 2017, il giornalismo giudiziario italiano? Ve lo dico io. Un buon giornalista giudiziario la mattina a una certa ora deve andare ad appostarsi dietro la porta di un Pm (e deve stare attento a scegliere quello giusto), e aspettare. Se il Pm è buono, o se ha voglia di fare una buona figura sui media, prima o poi gli darà qualche notizia riservata, gli dirà chi è il colpevole, e cosa deve scrivere, e quali sono i sospetti e – probabilmente – gli concederà di trascrivere un po’ di intercettazioni. Se ciò non avviene, non c’è notizia. Il vero giornalista d’inchiesta però è un passo avanti al normale cronista giudiziario. Lui non deve fare la fatica di andare all’ufficio del Pm. Sarà il Pm ad avvertirlo e a fargli avere le carte. Questa è la differenza tra un buon giornalista giudiziario e un giornalista d’inchiesta. E quando si svolge il processo, cosa fa il giornalista? Se ne frega, lo svolgimento del processo è considerato dalla stampa italiana un evento minimale rispetto alla vera vicenda giudiziaria che si svolge prima del rinvio a giudizio. Non esiste nessun’altra via per avere le notizie. E così nessuno si accorge di Caldarozzi, ma tutti, immediatamente, sono pronti ad indignarsi per la nomina di Caldarozzi. Perché il vero compito del giornalismo giudiziario, non è quello di scoprire le notizie, ma quello di indignarsi a comando di un Pm. Come è uscita fuori, stavolta, la notizia di Caldarozzi? Vabbè, non ci crederete: è uscita da una informazione contenuta in una mail inviata da un Pm a una mailing list di altri Pm di Magistratura Democratica. Cioè, anche in questo caso, la fonte è sempre la stessa: la Procura.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Da una parte, l’ideologia comunista si è adoperata con la corruzione culturale:
attraverso la televisione di Stato e similari;
con la propaganda ideologica continua dei giornalisti militanti di regime;
con insegnamenti ed indottrinamenti ideologici scolastici ed universitari frutto di una egemonia culturale.
Dall’altra parte, la depravazione culturale messa in opera dalle televisioni commerciali di Berlusconi, anticomuniste ed antimeridionaliste.
Infine con la perversione delle religioni, miranti ad avere il predominio delle masse per il proprio sostentamento.
Insomma. Lavaggio del cervello: dalla culla alla tomba.
Solo i comunisti potevano pensare una Costituzione, il cui principio portante fosse il Lavoro e non la Libertà. Libertà che la Carta pone solo come obbiettivo per poter esercitare alcuni diritti dalla stessa Costituzione elencati. Libertà come strumento e non come principio. Libertà meno importante addirittura dell’Uguaglianza. Questa ultima inserita, addirittura, come principio meno importante del Lavoro e della Solidarietà. Già. Per i comunisti “IL LAVORO RENDE LIBERI”. ARBEIT MACHT FREI (dal tedesco: “Il lavoro rende liberi”) era il motto posto all'ingresso di numerosi campi di concentramento. Una reminiscenza tratta da una ideologia totalitaria che proprio dal socialismo trae origine: il Nazismo.
Cosa vorrei? Vorrei una Costituzione, architrave di poche leggi essenziali, civili e penali, che come fondamento costitutivo avesse il principio assoluto ed imprescindibile della Libertà e come obiettivo per i suoi cittadini avesse il raggiungimento di felicità e contentezza. Vivere come in una favola: liberi, felici e contenti. Insomma, permettere ai propri cittadini di fare quel che cazzo gli pare sulla propria persona e sulla propria proprietà, senza, però, dare fastidio agli altri, di cui si risponderebbe con pene certe. E per il bene comune vorrei da cittadino poter nominare direttamente governanti, amministratori e giudici, i quali, per il loro operato, rispondano per se stessi e per i propri collaboratori, da loro stessi nominati. Niente più concorsi truccati…, insomma, ma merito! E per il bene comune sarei contento di contribuire con prelievo diretto dal mio conto, secondo quanto stabilito in modo proporzionale dal mio reddito conosciuto al Fisco e da questi rendicontatomi il suo impiego.
Invece...
L'influsso (negativo) di chi vuole dominare l'altro. Ci sono persone che sembrano dare energia. Altre, invece, sembra che la tolgano, scrive Francesco Alberoni, Domenica 01/07/2018, su "Il Giornale".
Ci sono persone che sembrano darti energia, che ti arricchiscono.
Altre, invece, sembra che te la prendano, te la succhino come dei vampiri. Dopo un colloquio con loro ti senti svuotato, affaticato, insoddisfatto. Che cosa fanno per produrre su di noi un tale effetto? Alcune ci parlano dei loro malanni, dei loro bisogni e lo fanno in modo tale che tu ti senti ingiustamente privilegiato ed è come se avessi un debito verso di loro.
C'è un secondo tipo di persone che ti sfibra, perché trasforma ogni incontro in un duello. Non appena aprite bocca sostengono la tesi contraria, vi sfidano, vi provocano. Lo fanno perché vogliono mostrare la loro capacità dialettica ma soprattutto per mettersi in evidenza davanti agli altri. Se gli date retta, vi logorano discutendo su cose che non vi interessano.
Ci sono poi quelli che fanno di tutto per farvi sentire ignoranti. Qualunque tesi voi sosteniate, anche l'idea più brillante e ragionevole ecco costoro che arrivano citando una ricerca americana che dice il contrario. Magari qualcosa che hanno letto in un rotocalco, ma tanto basta per rovinare il vostro discorso. Ricordo invece il caso di un mio collega che, per abitudine, nella conversazione, faceva solo domande. All'inizio gli raccontavo le mie ricerche, gli fornivo i dati, gli mostravo i grafici, le tabelle, mi sgolavo e lui, dopo avere ascoltato, faceva subito un'altra domanda su un particolare secondario. E io giù a spiegare di nuovo e lui, alla fine, un'altra domanda...
Abbiamo poi quelli che, quando vi incontrano, vi riferiscono sempre qualche cosa di spiacevole che la gente ha detto su di voi: mai un elogio, mai un apprezzamento, solo critiche, solo pettegolezzi negativi. E, infine, i pessimisti che quando esponete loro un progetto a cui tenete molto, vi mostrano i punti deboli, vi fanno ogni sorta di obiezioni, vi fanno capire che sarà un fallimento. Voi lo difendete ma loro insistono e, alla fine, restate sempre con dei dubbi. Un istante prima eravate pieno di slancio, ottimista, entusiasta e ora siete come un cane bastonato. Cosa hanno in comune tutti questi tipi umani? La volontà di competere, di affermarsi, di dominare, di opprimere.
L’invidioso cerca di svalutare l’altro agli occhi del maggior numero possibile di persone, soprattutto di quelle che contano. Appena conoscono qualcuno gli trovano da subito dei difetti: il loro sguardo corre a cercare i limiti, le debolezze e sentono l’esigenza di metterli subito in evidenza, di renderli noti e di provocare il commento negativo degli altri. Solitamente gli invidiosi entrano in azione quando il personaggio da svalutare non è presente, mettendo in moto le “chiacchere da cortile”. (Antonio Giangrande, aforisticamente.com/2018/03/26/frasi-citazioni-aforismi-su-svalutare)
Si stava meglio quando si stava peggio.
I miei nonni paterni Giuseppa Caprino e Leonardo Giangrande, democristiani, contadini beneficiari delle terre della riforma fondiaria di stampo fascista e genitori di 8 figli, dicevano che con i democristiani nessuno rimaneva indietro e tutti avevano la possibilità di migliorare il loro stato, se ne avevano la voglia (lavorare e non sprecare). Nonostante gli sprechi a vantaggio di alcuni figli a danno di altri e nonostante il regime cattocomunista, che non riconosce il valore della persona, loro hanno migliorato il loro stato ed hanno avuto la pensione.
Mio nonno materno Gaetano Santo, comunista, povero contadino ed allevatore beneficiario delle terre della riforma fondiaria di stampo fascista, padre di 8 figli cresciuti con l’illusione della loro utilità al suo benessere ed alla sua vecchiaia, tra un bicchiere di vino e l’altro affermava che i ricchi son ricchi perché hanno rubato ed era giusto espropriare i loro beni per distribuirli ai poveri. Nonostante il regime cattocomunista, che non riconosce il valore della persona, lui è morto povero, pur avendo la pensione!
Luigi Malorgio, il nonno materno di mia moglie, prigioniero di guerra e comunista, povero contadino ed allevatore beneficiario delle terre della riforma fondiaria di stampo fascista, padre di 4 figli, tra uno spreco e l’altro affermava, con il solito mantra comunista, che i ricchi son ricchi perché hanno rubato ed era giusto espropriare i loro beni per distribuirli ai poveri. Nonostante il regime cattocomunista, che non riconosce il valore della persona, lui è morto povero, pur avendo la pensione!
Altro mantra dei comunisti era ed è: gli altri vincono perché, essendo ladri, comprano i voti.
E come dire a detta degli interisti e dei napoletani: la Juventus vince perché ruba e quindi ridistribuiamo i suoi scudetti. L’Inter ed il Napoli son morti, comunque, perdenti.
Dopo tanti anni ho constatato che oggi rispetto al tempo dei nonni, nonostante il progresso tecnologico e culturale, non è più possibile migliorarsi ed arricchirsi. Inoltre oggi se si diventa ricchi per frutto della propria capacità e lavoro, non si è più tacciati di ladrocinio, ma di mafiosità. E se prima non c’era, oggi c’è l’espropriazione proletaria antimafiosa, ma non a favore dei poveri, ma solo a vantaggio dell’antimafia di sinistra, sia essa apparato burocratico di Stato, sia essa apparato associativo comunista, sia esso regime culturale rosso.
Dopo tanti anni ho constatato che, nonostante la magistratura politicizzata che collude ed i media partigiani che tacciono, i moralizzatori solidali erano e sono ladri come tutti gli altri, erano e sono mafiosi come, è più degli altri.
Ergo: ad oggi noi moriremo tutti poveri…e probabilmente senza pensione, accontentandoci di un misero reddito di cittadinanza che prima (indennità di disoccupazione) era privilegio solo dei lavoratori sindacalizzati disoccupati.
Di fatto, nel nome di un ridicolo ambientalismo, ci impediscono di farci una casa, ma ci spingono a comprarci un’auto.
Questo non è progressismo politico, ma una retrograda deriva culturale che ti porta a dire che:
è meglio non fare niente, perché si fotte tutto lo Stato con il Fisco;
è meglio non avere niente, perché si fotte tutto lo Stato con l’Antimafia.
Quindi, si stava meglio quando si stava peggio.
Ma lasciate che sia il solo a dirlo, così sanno con chi prendersela ed è facile per loro vincere tutti contro uno. Senza una lapide di rimembranza.
Ultimi della classe (dirigente). Non ci sono in Italia istituzioni politiche, scientifiche o formative unificanti, scrive Francesco Alberoni, Domenica 08/07/2018, su "Il Giornale". Una classe dirigente, ci insegna il grande sociologo Vilfredo Pareto, è formata da tutti coloro che eccellono nella loro attività. Quindi i politici più abili, i giudici più saggi, i giornalisti più ascoltati, i presentatori più seguiti, ma anche gli imprenditori, gli economisti, gli artisti, i registi, gli scrittori, i filosofi, gli scienziati, i professionisti più eminenti. E ha le sue radici nel passato. Il Paese che più di ogni altro ci ha fornito il modello di una grande classe dirigente è stata l'Inghilterra dove c'è stato sempre l'irrompere del nuovo ma anche la sopravvivenza dei poteri tradizionali e il permanere delle grandi istituzioni unificanti. L'Inghilterra è il Paese che innalzava colonne all'eroe Orazio Nelson mentre lasciava morire di fame Lady Hamilton, che glorificava Winston Churchill mentre lo mandava a casa nelle elezioni. Ma anche un Paese che da secoli ha istituzioni scientifico-culturali come la Royal Society, le università di Oxford e di Cambridge e il collegio di Eton dove si è formata la classe dirigente inglese. Non esiste nulla di simile in Italia dove storicamente si sono succeduti gruppi politico ideologici diversi: prima i liberali, poi i fascisti a cui seguono nel dopoguerra i comunisti e i cattolici. Poi la crisi di Mani pulite che ha fatto emergere il potere della magistratura. In seguito, si formano o movimenti o raggruppamenti attorno a un capo come Berlusconi, Prodi, Renzi, Grillo e ora Salvini. Sono gruppi ristretti, formati da amici, conoscenti, simpatizzanti e «clienti» che egemonizzano il potere e creano istituzioni per loro stessi da cui escludono gli altri. Non ci sono in Italia istituzioni politiche o scientifiche o formative unificanti, non c'è una vera, unica classe dirigente. E sembra che a livello popolare non se ne senta neppure l'esigenza. Il politico non viene eletto per ciò che ha dimostrato di sapere fare e non gli si chiede di avere una formazione culturale adeguata. Grillo arriva a sostenere che i parlamentari dovrebbero essere estratti a sorte tra i cittadini. Questa divisione delle élite lascia il potere in mano alla burocrazia che non ha valori, non ha mete, ostacola la creazione e tende solo a crescere su se stessa.
I bulli che umiliano la cultura. Si va diffondendo l'idea che, con una disoccupazione così elevata, sia inutile studiare, scrive Francesco Alberoni Domenica 06/05/2018, su "Il Giornale". Si va diffondendo l'idea che, con una disoccupazione giovanile così elevata, sia inutile studiare, inutile imparare, inutile prendere bei voti perché tanto, si dice, nella vita si affermano i forti, i corrotti, i violenti, quelli che sanno dominare gli altri, imporre il loro volere. È questo il pensiero che sta dietro il diffondersi del bullismo in tutte le sue forme. Dal piccolo gruppo di studenti che domina sugli altri, deride e si beffa dei più deboli, li mette a tacere, fino ai gruppi più aggressivi che offendono ed insultano anche i professori in modo che perdano agli occhi dei loro allievi l'ultima autorità loro rimasta. E così denigrano la cultura, il sapere, l'unica forza che nel mondo moderno fa avanzare tanto gli individui che i popoli. Gli individui, perché emergono solo coloro che fanno le scuole e le università migliori e i popoli perché solo alcuni hanno i centri di ricerca più avanzati, gli studiosi più apprezzati e una ferrea organizzazione del lavoro. E questo modo di pensare disastroso si afferma anche in politica col principio anarchico che «uno vale uno» quindi chiunque, anche il più fannullone e ignorante, può dirigere un Paese moderno e affrontare le bufere geopolitiche di oggi. Bisogna riporre in primo piano l'idea che lo strumento fondamentale con cui gli esseri umani lottano, si affermano, si rendono utili agli altri, è il sapere, la cultura. In tutte le forme: scientifica, artistica musicale, linguistica, come capacità di scrivere e di parlare, di calcolare e di prevedere. Ma voi provate a domandare alla gente che cosa desidera. Vi risponderà che desidera viaggiare, fare crociere, una nuova macchina, una barca, un nuovo televisore. Nessuno vi risponde che desidera imparare la matematica, il diritto, le lingue, l'economia, la biologia o l'informatica. Le spese per svago e per divertimenti superano paurosamente le spese culturali. Ci sono ancora persone che leggono libri? Solo una minoranza, quella che studia con fermezza e costituirà la futura élite internazionale. E gli altri? Gli altri saranno tutti dei disoccupati e dei sottoproletari. Basta, cambiate direzione, datevi da fare. Siete ancora in tempo, per poco.
Vuoi scrivere un libro? Leggine cento, scrive il 16 aprile 2018 Paolo Gambi su “Il Giornale”.
“Se scrivo la mia storia vinco il Nobel per la letteratura”.
“Ti racconto il libro che ho in testa, tu lo scrivi e dividiamo gli utili”.
“La mia vita è così incredibile che voglio farne un romanzo da un milione di copie”.
Da quando faccio lo scrittore più o meno ogni giorno vengo approcciato da qualcuno con una frase del genere. La qual cosa mi lusinga molto: ciascuno di noi è un intreccio di parole che si sono fatte carne e pensare di metterle per iscritto, e di chiedere il mio aiuto per farlo, è per me fonte di soddisfazione ed autostima. E contando che ho scritto libri molto diversi che partono dai romanzi e arrivano a biografie di personaggi molto disparati – dal Cardinal Tonini a Raoul Casadei – non trovo strano che ci sia chi mi interpella. Infatti da qualche tempo a questa parte ho deciso di iniziare a costruire una risposta a chi mi pone queste domande. Solo che se poi alle stesse persone che vogliono scrivere un libro chiedo: “qual è l’ultimo libro che hai letto?”, la risposta di solito è qualcosa come:
“Non mi ricordo, alla sera guardo la televisione”.
“È da quando ero alle superiori che non leggo più”.
“Dai valà, non posso mica perdere il mio tempo così”.
Che è un po’ come se qualcuno volesse vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi per i 100 metri stile libero ma si rifiutasse di andare in piscina ad allenarsi. I dati sulla lettura in Italia continuano ad essere impietosi. Sei italiani su dieci, nel 2016, non hanno letto neppure un libro in un anno. Tutti vogliono scrivere. Pochissimi vogliono leggere. Allora, è meraviglioso sognare di diventare la nuova Rowling o scrivere delle nuove sfumature di grigio (possibilmente meno disgustose) impastate con la propria storia. Però se vuoi scrivere un libro inizia a leggerne almeno cento.
Saviano a Salvini: “Ministro della malavita”. La propaganda fa proseliti e voti. Sei ricco? Sei mafioso! Il condizionamento psicologico mediatico-culturale lava il cervello e diventa ideologico, erigendo il sistema di potere comunista. Cosa scriverebbero gli scrittori comunisti senza la loro Mafia e cosa direbbero in giro per le scuole a far proselitismo comunista? Quale film girerebbero i registi comunisti antimafiosi? Come potrebbero essere santificati gli eroi intellettuali antimafiosi? Quali argomenti affronterebbero i talk show comunisti e di cosa parlerebbero i giornalisti comunisti nei TG? Cosa scriverebbero e vomiterebbero i giornalisti comunisti contro gli avversari senza la loro Mafia? Cosa comizierebbero i politici comunisti senza la loro Mafia? Quali processi si istruirebbero dai magistrati eroi antimafiosi senza la loro mafia? Cosa farebbero i comunisti senza la loro Mafia ed i beni della loro Mafia? Di cosa camperebbero le associazioni antimafiose comuniste? Cosa esproprierebbero i comunisti senza l'alibi della mafiosità? La Mafia è la fortuna degli antimafiosi. Se non c'è la si inventa e si infanga un territorio. Mafia ed Antimafia sono la iattura del Sud Italia dove l’ideologia del povero contro il ricco attecchisce di più. Sciagura antimafiosa che comincia ad espandersi al Nord Italia per colpa della crisi economica creata da antimafia e burocrazia. Più povertà per tutti, dicono i comunisti.
Saviano è il vero intoccabile. Vietato fare satira su di lui. Chi ha provato a scherzare sullo scrittore, da Zalone ai comici Luca e Paolo, è stato subito messo a tacere, scrive Nino Materi, Lunedì 25/06/2018, su "Il Giornale". Scherza con i santi, ma lascia stare Saviano. Giù le mani da Roberto. E poco importa se la mano è quella - innocua - che potresti mettere davanti alla bocca, magari solo per soffocare un inizio di risata. Perché in Italia si può fare ironia su tutti (compresi Papa e presidente della Repubblica), eccetto che sullo scrittore di Gomorra. Chi si è cimentato con la sua parodia, ha subito avvertito la stessa piacevole sensazione di mettere le dita in una presa di corrente. Insomma, Saviano come i fili dell'alta tensione. E una bella scossa, nel corso degli anni, se la sono presa i pochi coraggiosi che hanno tentato di imitarlo comicamente. Niente di pesante, per carità: appena una bonaria presa in giro del suo eloquio da santone in perenne trance sciamanica; del suo incedere messianico sulle acque procellose dell'antimafia; delle sue pause meditative da salvatore della patria in servizio h24; del suo grattarsi la pelata come se pensieri e preoccupazioni fossero solo una sua esclusiva; del suo sapiente gesticolare ostentando più anelli di J-Ax e Fedez messi insieme. Un minimo sindacale satirico che, tuttavia, si è rivelato più che sufficiente per far scendere il «guitto» di turno a più miti consigli. Lo sa bene il grande Checco Zalone che, in uno show televisivo, vestì i panni di uno sfigatissimo Saviano cui tutte le ragazze davano il due di picche «perché la camorra ha il monopolio della f...». Saviano (personaggio che notoriamente non brilla per autoironia), invece di riderci su, si risentì. E con lui si attapirarono tutti i suoi fan secondo i quali «ironizzare su Saviano equivale a fare un favore ai camorristi». Risultato: Checco Zalone, da quella volta, non si «permise» mai più di imitare lo scrittore più scortato del mondo. Stessa parabola censoria anche per il duo comico Luca e Paolo che, addirittura dal palco del Festival di Sanremo, si azzardarono a punzecchiare Roberto, ricordandogli come alcune delle sue denunce equivalessero un po' alla scoperta dell'acqua calda. Apriti cielo. I due artisti furono immediatamente redarguiti dal rigoroso «funzionario Rai» che suggerì loro di «occuparsi d'altro». Meno clamorosa, ma altrettanto deciso il consiglio a «non insistere sull'argomento» indirizzato al cabarettista Sergio Friscia, «reo» di animare un Saviano un po' troppo bozzettistico. La stessa «colpa» attribuita pure ad altri due colleghi di Friscia: Cristian Calabrese, autore di uno sketch dal titolo dissacratorio, Zero Zero Zero ed Enzo Costanza protagonisti di una serie di video esilaranti, ma ritenuti non propriamente savianolly correct. In questi casi non risulta un intervento diretto del giornalista finalizzato a zittire i suoi epigoni parodistici, ma alcune sue dichiarazioni esprimono bene il concetto che Saviano ha rispetto alla creatività umoristica: «La creatività fa, non commenta. E i The Jackal ne sono un esempio». Ma perché mai ai comici dovrebbe essere precluso il diritto al «commento»? e, poi, chi sono «The Jackal»? Al primo quesito Saviano non ha mai risposto; facile invece la risposta al secondo: si tratta di un gruppo di brillanti filmaker che devono il successo a video-parodie cliccatissime su youtube, la più celebre delle quali è: Gli effetti di Gomorra sulla gente. In questo caso, per non correre rischi, Saviano ha voluto prendere parte direttamente ad alcuni ciak. Motivo? I maligni dicono: «Per accertarsi di non essere preso in giro». Intanto lui, un giorno sì e l'altro pure, dà del «buffone», «razzista» e «codardo» al ministro dell'Interno. A offese invertite, Salvini sarebbe già stato costretto alle dimissioni.
L’invidioso cerca di svalutare l’altro agli occhi del maggior numero possibile di persone, soprattutto di quelle che contano. Appena conoscono qualcuno gli trovano da subito dei difetti: il loro sguardo corre a cercare i limiti, le debolezze e sentono l’esigenza di metterli subito in evidenza, di renderli noti e di provocare il commento negativo degli altri. Solitamente gli invidiosi entrano in azione quando il personaggio da svalutare non è presente, mettendo in moto le “chiacchere da cortile”. (Antonio Giangrande, aforisticamente.com/2018/03/26/frasi-citazioni-aforismi-su-svalutare)
Dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Il Potere ti impone: subisci e taci…e noi, coglioni, subiamo la divisione per non poterci ribellare.
Bisogna studiare.
Bisogna cercare le fonti credibili ed attendibili per poter studiare.
Bisogna studiare oltre la menzogna o l’omissione per poter sapere.
Bisogna sapere il vero e non il falso.
Bisogna non accontentarsi di sapere il falso per esaudire le aspirazioni personali o di carriera, o per accondiscendere o compiacere la famiglia o la società.
Bisogna sapere il vero e conoscere la verità ed affermarla a chi è ignorante o rinfacciarla a chi è in malafede.
Studiate “e conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi” (Gesù. Giovanni 8:31, 32).
Studiare la verità rende dotti, saggi e LIBERI!
Non studiare o non studiare la verità rende schiavi, conformi ed omologati.
E ciò ci rende cattivi, invidiosi e vendicativi.
Fa niente se studiare il vero non è un diritto, ma una conquista.
Vincere questa guerra dà un senso alla nostra misera vita.
Dr Antonio Giangrande
Immigrazione/emigrazione. Dimmi dove vai, ti dirò chi sei.
L'immigrato/emigrato italiano o straniero è colui il quale si è trasferito, per costrizione o per convenienza, per vivere in un altro luogo diverso da quello natio.
Soggetti: L’immigrato arriva, l’emigrato parte. La definizione del trasferito la dà colui che vive nel luogo di arriva o di partenza. Chi resta è geloso della sua terra, cultura, usi e costumi. Chi arriva o parte è invidioso degli altri simili. Al ritorno estemporaneo al paese di origine gli emigrati, per propria vanteria, per spirito di rivalsa e per denigrare i conterranei di origine, tesseranno le lodi della nuova cultura, con la litania “si vive meglio là, là è diverso”, senza, però, riproporla al paese di origine, ma riprendendo, invece, le loro vecchie e cattive abitudini. Questi disperati non difendono o propagandano la loro cultura originaria, o gli usi e costumi della terra natia, per il semplice motivo che da ignoranti non li conoscono. Dovrebbero conoscere almeno il sole, il mare, il vento della loro terra natia, ma pare (per soldi) preferiscano i monti, il freddo e la nebbia della terra che li ospita.
Tempo: il trasferimento può essere temporaneo o permanente. Se permanente le nuove generazioni dei partenti si sentiranno appartenere al paese natio ospitante.
Luoghi di arrivo: città, regioni, nazioni diverse da quelle di origine.
Motivo del trasferimento: economiche (lavoro, alimentari, climatiche ed eventi naturali); religiose; ideologiche; sentimentali; istruzione; devianza.
Economiche: Lavoro (assente o sottopagato), alimentari, climatiche ed eventi naturali (mancanza di cibo dovute a siccità o a disastri naturali (tsunami, alluvioni, terremoti, carestie);
Religiose: impossibilità di praticare il credo religioso (vitto ed alloggio decente garantito);
Ideologiche: impossibilità di praticare il proprio credo politico (vitto ed alloggio decente garantito);
Sentimentali: ricongiungimento con il proprio partner (vitto ed alloggio decente garantito);
Istruzione: frequentare scuole o università o stage per elevare il proprio grado culturale (vitto ed alloggio decente garantito);
Devianza: per sfuggire alla giustizia del paese di origine o per ampliare i propri affari criminali nei paesi di destinazione (vitto ed alloggio decente garantito).
Il trasferimento per lavoro garantito: individuo vincitore di concorso pubblico (dirigente/impiegato pubblico); trasfertista (assegnazione temporanea fuori sede d’impresa); corrispondente (destinazione fuori sede di giornalisti o altri professionisti). Chi si trasferisce con lavoro garantito ha il rispetto della gente locale indotto dal timore e rispetto del ruolo che gli compete, fatta salva ogni sorta di ipocrisia dei locali che maschera il dissenso all’invasione dell’estraneo. Inoltre il lavoro garantito assicura decoroso vitto e alloggio (nonostante il caro vita) e civile atteggiamento dell’immigrato, già adottato nel luogo d’origine e dovuto al grado di scolarizzazione e cultura posseduto.
Il trasferimento per lavoro da cercare in loco di destinazione: individuo nullafacente ed incompetente. Chi si trasferisce per lavoro da cercare in loco di destinazione appartiene ai ceti più infimi della popolazione del paese d’origine, ignari di solidarietà e dignità. Costui non ha niente da perdere e niente da guadagnare nel luogo di origine. Un volta partiva con la valigia di cartone. Non riesce ad inserirsi come tutti gli altri, per mancanza di rapporti adeguati amicali o familistici, nel circuito di conoscenze che danno modo di lavorare. Disperati senza scolarizzazione e competenza lavorativa specifica. Nel luogo di destinazione faranno quello che i locali non vorrebbero più fare (dedicarsi agli anziani, fare i minatori o i manovali, lavorare i campi ed accudire gli animali, fare i lavapiatti nei ristoranti dei conterranei, lavare le scale dei condomini, fare i metronotte o i vigilanti, ecc.). Questo tipo di manovalanza assicura un vergognoso livello di retribuzione e, di conseguenza, un livello sconcio di vitto ed alloggio (quanto guadagnano a stento basta per sostenere le spese), oltre l’assoggettamento agli strali più vili e razzisti della popolazione ospitante, che darà sfogo alla sua vera indole. Anche da parte di chi li usa a scopo politico o ideologico. Questi disperati subiranno tacenti le angherie e saranno costretti ad omologarsi al nuovo stile di vita. Lo faranno per costrizione a timore di essere rispediti al luogo di origine, anche se qualcuno tenta di stabilire la propria discultura in terra straniera anche con la violenza.
Ecco allora è meglio dire: Dimmi come vai, ti dirò chi sei.
Il limite del tempo e dell'uomo, scrive Vittorio Sgarbi, Giovedì 28/12/2017, su "Il Giornale". «Due verità che gli uomini generalmente non crederanno mai: l'una di non saper nulla, l'altra di non esser nulla. Aggiungi la terza, che ha molta dipendenza dalla seconda: di non aver nulla a sperare dopo la morte». Un pensiero di Leopardi dallo Zibaldone. Inadatto al clima natalizio, ma terribilmente vero. Forse la forza di un pensiero così chiaro dissolve le nostre illusioni, ma ci impegna a dimenticarlo, per fingere che la nostra vita abbia un senso. Perché vivere altrimenti? L'insensatezza della nostra azione si misura con la brevità del tempo. Da tale pensiero è sfiorato anche Dante, che non dubitava di Dio, ma misurava il nostro limite rispetto al tempo: «Se tu riguardi Luni e Urbisaglia/come sono ite e come se ne vanno/di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia,/udir come le schiatte si disfanno/non ti parrà nuova cosa né forte,/poscia che le cittadi termine hanno./Le vostre cose tutte hanno lor morte,/sì come voi; ma celasi in alcuna/che dura molto, e le vite son corte». Se tutto finisce, perché noi dovremmo sopravviverci? E se ci fosse qualcosa dopo la morte, che limite dovremmo porvi? I nati e i morti, prima di Cristo, gli egizi e i greci, con le loro religioni, che spazio dovrebbero avere, nell'aldilà che non potevano presumere? La vita dopo la morte toccherebbe anche agli inconsapevoli? Con Dante e Leopardi, all'inferno incontreremo anche Marziale e Catullo? O la vita oltre la morte non sono già, come per Leopardi, i loro versi?
Quel che si rimembra non muore mai. In effetti il fascismo rivive non negli atti di singoli imbecilli, ma quotidianamente nell’evocazione dei comunisti.
Una locuzione latina, un motto degli antichi romani, è: dividi et impera! Espediente fatto proprio dal Potere contemporaneo, dispotico e numericamente modesto, per controllare un popolo, provocando rivalità e fomentando discordie.
Comunisti, e media a loro asserviti, istigano le rivalità.
Dove loro vedono donne o uomini, io vedo persone con lo stesso problema.
Dove loro vedono lgbti o eterosessuali, io vedo amanti con lo stesso problema.
Dove loro vedono bellezza o bruttezza, io vedo qualcosa che invecchierà con lo stesso problema.
Dove loro vedono madri o padri, io vedo genitori con lo stesso problema.
Dove loro vedono comunisti o fascisti, io vedo elettori con lo stesso problema.
Dove loro vedono settentrionali o meridionali, io vedo cittadini italiani con lo stesso problema.
Dove loro vedono interisti o napoletani, io vedo tifosi con lo stesso problema.
Dove loro vedono ricchi o poveri, io vedo contribuenti con lo stesso problema.
Dove loro vedono poveri da aiutare, io vedo degli incapaci o degli sfaticati, ma, in specialmodo, vedo persone a cui è impedita la possibilità di emergere dall’indigenza per ragioni ideologiche o di casta o di lobby.
Dove loro vedono immigrati o indigeni, io vedo residenti con lo stesso problema.
Dove loro vedono pelli bianche o nere, io vedo individui con lo stesso problema.
Dove loro vedono cristiani o mussulmani, io vedo gente che nasce senza volerlo, muore senza volerlo e vive una vita di prese per il culo.
Dove loro vedono colti od analfabeti, io vedo discultura ed oscurantismo, ossia ignoranti con lo stesso problema.
Dove loro vedono grandi menti o grandi cazzi, io vedo geni o cazzoni con lo stesso problema.
Gattopardismo. Vocabolario on line Treccani. Gattopardismo s. m. (anche, meno comunem., gattopardite s. f.). – Nel linguaggio letterario e giornalistico, l’atteggiamento (tradizionalmente definito come trasformismo) proprio di chi, avendo fatto parte del ceto dominante o agiato in un precedente regime, si adatta a un nuova situazione politica, sociale o economica, simulando d’esserne promotore o fautore, per poter conservare il proprio potere e i privilegi della propria classe. Il termine, così come la concezione e la prassi che con esso vengono espresse, è fondato sull’affermazione paradossale che «tutto deve cambiare perché tutto resti come prima», che è l’adattamento più diffuso con cui viene citato il passo che nel romanzo Il Gattopardo (v. la voce prec.) si legge testualmente in questa forma «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» (chi pronuncia la frase non è però il principe di Salina ma suo nipote Tancredi).
Se questa è democrazia…
I nostri politici sono solo mediocri amministratori improvvisati assetati di un potere immeritato. Governanti sono coloro che prevedono e governano gli eventi, riformando ogni norma intralciante la modernità ed il progresso, senza ausilio di leggi estemporanee ed improvvisate per dirimere i prevedibili imprevisti.
I liberali sono una parte politica atea e senza ideologia. Credono solo nella libertà, il loro principio fondante ed unico, che vieta il necessario e permette tutto a tutti, consentendo ai poveri, se capaci, di diventare ricchi. Io sono un liberale ed i liberali, sin dall’avvento del socialismo, sono mal tollerati perché contro lobbies e caste di incapaci. Con loro si avrebbe la meritocrazia, ma sono osteggiati dai giornalisti che ne inibiscono la visibilità.
I popolari (o populisti) sono la maggiore forza politica fondata sull’ipocrisia e sulle confessioni religiose. Vietano tutto, ma, allo stesso tempo, perdonano tutto, permettendo, di fatto, tutto a tutti. Sono l’emblema del gattopardismo. Con loro non cambia mai niente. Loro sono l’emblema del familismo, della raccomandazione e della corruzione, forte merce di scambio alle elezioni. Si infiltrano spesso in altre fazioni politiche impedendone le loro peculiari politiche ed agevolano il voltagabbanesimo.
I socialisti (fascisti e derivati; comunisti e derivati) sono una forza politica ideologica e confessionale di natura scissionista e frammentista e falsamente moralista, a carattere demagogico ed ipocrita. Cattivi, invidiosi e vendicativi. La loro confessione, più che ideologia, si fonda sul lavoro, sulle tasse e sul fisco. Rappresenterebbe la classe sociale meno abbiente. Illude i poveri di volerli aiutare, carpendone i voti fiduciari, ma, di fatto, impedisce loro la scalata sociale, livellando in basso la società civile, verso un progressivo decadimento, in quanto vieta tutto a tutti, condanna tutto e tutti, tranne a se stessi. Si caratterizzano dalla abnorme produzione normativa di divieti e sanzioni, allargando in modo spropositato il tema della legalità, e dal monopolio culturale. Con loro cambierebbe in peggio, in quanto inibiscono ogni iniziativa economica e culturale, perché, senza volerlo si vivrebbe nell’illegalità, ignorando, senza colpa, un loro dettato legislativo, incorrendo in inevitabili sanzioni, poste a sostentare il parassitismo statale con la prolificazione di enti e organi di controllo e con l’allargamento dell’apparato amministrativo pubblico. L’idea socialista ha infestato le politiche comunitarie europee.
Per il poltronificio l’ortodossia ideologica ha ceduto alla promiscuità ed ha partorito un sistema spurio e depravato, producendo immobilismo, oppressione fiscale, corruzione e raccomandazione, giustizialismo ed odio/razzismo territoriale.
La gente non va a votare perché il giornalismo prezzolato e raccomandato propaganda i vecchi tromboni e la vecchia politica, impedendo la visibilità alle nuove idee progressiste. La Stampa e la tv nasconde l’odio della gente verso questi politici. Propagandano come democratica l’elezione di un Parlamento votato dalla metà degli elettori Ed un terzo di questo Parlamento è formato da un movimento di protesta. Quindi avremo un Governo di amministratori (e non di governanti) che rappresenta solo la promiscuità, e la loro riconoscente parte amicale, ed estremamente minoritaria.
A chi votare?
Nell’era contemporanea non si vota per convinzione. Le ideologie sono morte e non ha senso rivangare le guerre puniche o la carboneria o la partigianeria.
Chi sa, a chi deve votare (per riconoscenza), ci dice che comunque bisogna votare e votare il meno peggio (che implicitamente è sottinteso: il suo candidato!).
A costui si deve rispondere:
Votare a chi non ci rappresenta? Votare a chi ci prende per il culo?
I disonesti parlano di onestà; gli incapaci parlano di capacità; i fannulloni parlano di lavoro; i carnefici parlano di diritti.
Nessuno parla di libertà. Libertà di scegliersi il futuro che si merita. Libertà di essere liberi, se innocenti.
La vergogna è che nessuno parla dei nostri figli a cui hanno tolto ogni speranza di onestà, capacità, lavoro e diritti.
Fanno partecipare i nostri figli forzosamente ed onerosamente a concorsi pubblici ed a Esami di Stato (con il trucco) per il sogno di un lavoro. Concorsi od esami inani o che mai supereranno. Partecipazione a concorsi pubblici al fine di diventare piccoli “Fantozzi” sottopagati ed alle dipendenze di un numero immenso di famelici incapaci cooptati dal potere e sostenuti dalle tasse dei pochi sopravvissuti lavoratori.
Ai nostri figli inibiscono l’esercizio di libere professioni per ingordigia delle lobbies.
Ai nostri figli impediscono l’esercizio delle libere imprese per colpa di una burocrazia ottusa e famelica. Ove ci riuscissero li troncherebbero con l’accusa di mafiosità.
Ai nostri figli impediscono di godere della vita, impedendo la realizzazione dei loro sogni o spezzando le loro visioni, infranti contro un’accusa ingiusta di reato.
E’ innegabile che le nostre scuole e le nostre carceri sono pieni, come sono strapieni i nostri uffici pubblici e giudiziari, che si sostengono sulle disgrazie, mentre sono vuoti i nostri campi e le nostre fabbriche che ci sostentano.
L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. E non sarei mai votato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Si deve tener presente che il voto nullo, bianco o di protesta è conteggiato come voto dato.
Quindi io non voto.
Non voto perché un popolo di coglioni votanti sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da coglioni.
Informato da chi mette in onda le proprie opinioni, confrontandole esclusivamente con i propri amici o con i propri nemici. Ignorata rimane ogni voce fuori dal coro.
Se nessuno votasse?
In democrazia, se la maggioranza non vota, ai governanti oppressori ed incapaci sarebbe imposto di chiedersi il perché! Allora sì che si inizierebbe a parlare di libertà. Ne andrebbe della loro testa…
Se questa è democrazia. Questo non lo dico io…Giorgio Gaber: In un tempo senza ideali nè utopia, dove l'unica salvezza è un'onorevole follia...Testo Destra-Sinistra - 1995/1996
Le parole, definiscono il mondo, se non ci fossero le parole, non avemmo la possibilità di parlare, di niente. Ma il mondo gira, e le parole stanno ferme, le parole si logorano invecchiano, perdono di senso, e tutti noi continuiamo ad usarle, senza accorgerci di parlare, di niente.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia
ma io dico che la colpa è nostra
è evidente che la gente è poco seria
quando parla di sinistra o destra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
Fare il bagno nella vasca è di destra
far la doccia invece è di sinistra
un pacchetto di Marlboro è di destra
di contrabbando è di sinistra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
Una bella minestrina è di destra
il minestrone è sempre di sinistra
quasi tutte le canzoni son di destra
se annoiano son di sinistra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
Le scarpette da ginnastica o da tennis
hanno ancora un gusto un po’ di destra
ma portarle tutte sporche e un po’ slacciate
è da scemi più che di sinistra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
I blue-jeans che sono un segno di sinistra
con la giacca vanno verso destra
il concerto nello stadio è di sinistra
i prezzi sono un po’ di destra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
La patata per natura è di sinistra
spappolata nel purè è di destra
la pisciata in compagnia é di sinistra
il cesso é sempre in fondo a destra.
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
La piscina bella azzurra e trasparente
è evidente che sia un po’ di destra
mentre i fiumi tutti i laghi e anche il mare
sono di merda più che sinistra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
L’ideologia, l’ideologia
malgrado tutto credo ancora che ci sia
è la passione l’ossessione della tua diversità
che al momento dove è andata non si sa
dove non si sa dove non si sa.
Io direi che il culatello è di destra
la mortadella è di sinistra
se la cioccolata svizzera é di destra
la nutella é ancora di sinistra.
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
La tangente per natura è di destra
col consenso di chi sta a sinistra
non si sa se la fortuna sia di destra
la sfiga è sempre di sinistra.
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
Il saluto vigoroso a pugno chiuso
è un antico gesto di sinistra
quello un po’ degli anni '20 un po’ romano
è da stronzi oltre che di destra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
L’ideologia, l’ideologia
malgrado tutto credo ancora che ci sia
è il continuare ad affermare un pensiero e il suo perché
con la scusa di un contrasto che non c’è
se c'é chissà dov'è se c'é chissà dov'é.
Canticchiar con la chitarra è di sinistra
con il karaoke è di destra
I collant son quasi sempre di sinistra
il reggicalze é più che mai di destra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
La risposta delle masse è di sinistra
con un lieve cedimento a destra
Son sicuro che il bastardo è di sinistra
il figlio di puttana è a destra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
Una donna emancipata è di sinistra
riservata è già un po’ più di destra
ma un figone resta sempre un’attrazione
che va bene per sinistra o destra.
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
Tutti noi ce la prendiamo con la storia
ma io dico che la colpa é nostra
é evidente che la gente é poco seria
quando parla di sinistra o destra.
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
Ma cos'é la destra cos'é la sinistra
Destra sinistra
Destra sinistra
Destra sinistra
Destra sinistra
Destra sinistra
Basta!
Dall'album E Pensare Che C'era Il Pensiero.
E comunque non siamo i soli a dirlo…Rino Gaetano Nuntereggae più, 1978.
Nuntereggae più
Abbasso e alè (NUNTEREGGAEPIU')
abbasso e alè (NUNTEREGGAEPIU')
abbasso e alè con le canzoni
senza fatti e soluzioni
la castità (NUNTEREGGAEPIU')
la verginità (NUNTEREGGAEPIU')
la sposa in bianco, il maschio forte
i ministri puliti, i buffoni di corte
ladri di polli
super pensioni (NUNTEREGGAEPIU')
ladri di stato e stupratori
il grasso ventre dei commendatori
diete politicizzate
evasori legalizzati (NUNTEREGGAEPIU')
auto blu
sangue blu
cieli blu
amore blu
rock and blues
NUNTEREGGAEPIU'
Eja alalà (NUNTEREGGAEPIU')
pci psi (NUNTEREGGAEPIU')
dc dc (NUNTEREGGAEPIU')
pci psi pli pri
dc dc dc dc
Cazzaniga (NUNTEREGGAEPIU')
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli
Susanna Agnelli, Monti, Pirelli
dribbla Causio che passa a Tardelli
Musiello, Antognoni, Zaccarelli (NUNTEREGGAEPIU')
Gianni Brera (NUNTEREGGAEPIU')
Bearzot (NUNTEREGGAEPIU')
Monzon, Panatta, Rivera, D'Ambrosio
Lauda, Thoeni, Maurizio Costanzo, Mike Bongiorno
Villaggio, Raffa, Guccini
onorevole eccellenza, cavaliere senatore
nobildonna, eminenza, monsignore
vossia, cherie, mon amour
NUNTEREGGAEPIU'
Immunità parlamentare (NUNTEREGGAEPIU')
abbasso e alè
il numero 5 sta in panchina
s'è alzato male stamattina
mi sia consentito dire (NUNTEREGGAEPIU')
il nostro è un partito serio
disponibile al confronto
nella misura in cui
alternativo
aliena ogni compromess
ahi lo stress
Freud e il sess
è tutto un cess
ci sarà la ress
se quest'estate andremo al mare
solo i soldi e tanto amore
e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria
è più prosa che poesia
dove sei tu? non m'ami più?
dove sei tu? io voglio tu
soltanto tu dove sei tu?
NUNTEREGGAEPIU'
Uè paisà (NUNTEREGGAEPIU')
il bricolage (NUNTEREGGAEPIU')
il quindici-diciotto
il prosciutto cotto
il quarantotto
il sessantotto
le pitrentotto
sulla spiaggia di Capocotta
(Cartier Cardin Gucci)
Portobello e illusioni
lotteria trecento milioni
mentre il popolo si gratta
a dama c'è chi fa la patta
a settemezzo c'ho la matta
mentre vedo tanta gente
che non c'ha l'acqua corrente
non c'ha niente
ma chi me sente
ma chi me sente
e allora amore mio ti amo
che bella sei
vali per sei
ci giurerei
ma è meglio lei
che bella sei
che bella lei
ci giurerei
sei meglio tu
che bella sei
che bella sei
NUNTEREGGAEPIU'
L’astensione al voto non basta. Come la protesta non può essere delegata ad una accozzaglia improvvisata ed impreparata. Bisogna fare tabula rasa dei vecchi principi catto comunisti, filo massonici-mafiosi.
Noi siamo un unicum con i medesimi problemi, che noi stessi, conoscendoli, possiamo risolvere. In caso contrario un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da “coglioni”.
Ed io non sarò tra quei coglioni che voteranno dei coglioni.
La legalità è un comportamento conforme alla legge. Legalità e legge sono facce della stessa medaglia.
Nei regimi liberali l’azione normativa per intervento statale, per regolare i rapporti tra Stato e cittadino ed i rapporti tra cittadini, è limitata. Si lascia spazio all’evolvere naturale delle cose. La devianza è un’eccezione, solo se dannosa per l'equilibrio sociale.
Nei regimi socialisti/comunisti/populisti l’intervento statale è inflazionato da miriadi di leggi, oscure e sconosciute, che regolano ogni minimo aspetto della vita dell’individuo, che non è più singolo, ma è massa. Il cittadino diventa numero di pratica amministrativa, di cartella medica, di fascicolo giudiziario. Laddove tutti si sentono onesti ed occupano i posti che stanno dalla parte della ragione, c’è sempre quello che si sente più onesto degli altri, e ne limita gli spazi. In nome di una presunta ragion di Stato si erogano miriadi di norme sanzionatrici limitatrici di libertà, spesso contrastati, tra loro e tra le loro interpretazioni giurisprudenziali. Nel coacervo marasma normativo è impossibile conformarsi, per ignoranza o per necessità. Ne è eccezione l'indole. Addirittura il legislatore è esso medesimo abusivo e dichiarato illegittimo dalla stessa Corte Costituzionale, ritenuto deviante dalla suprema Carta. Le leggi partorite da un Parlamento illegale, anch'esse illegali, producono legalità sanzionatoria. Gli operatori del diritto manifestano pillole di competenza e perizia pur essendo essi stessi cooptati con concorsi pubblici truccati. In questo modo aumentano i devianti e si è in pochi ad essere onesti, fino alla assoluta estinzione. In un mondo di totale illegalità, quindi, vi è assoluta impunità, salvo l'eccezione del capro espiatorio, che ne conferma la regola. Ergo: quando tutto è illegale, è come se tutto fosse legale.
L’eccesso di zelo e di criminalizzazione crea un’accozzaglia di organi di controllo, con abuso di burocrazia, il cui rimedio indotto per sveltirne l’iter è la corruzione.
Gli insani ruoli, politici e burocratici, per giustificare la loro esistenza, creano criminali dove non ne esistono, per legge e per induzione.
Ergo: criminalizzazione = burocratizzazione = tassazione-corruzione.
Allora, si può dire che è meglio il laissez-faire (il lasciare fare dalla natura delle cose e dell’animo umano) che essere presi per il culo e …ammanettati per i polsi ed espropriati dai propri beni da un manipolo di criminali demagoghi ed ignoranti con un’insana sete di potere.
Prendiamo per esempio il fenomeno cosiddetto dell'abusivismo edilizio, che è elemento prettamente di natura privata. I comunisti da sempre osteggiano la proprietà privata, ostentazione di ricchezza, e secondo loro, frutto di ladrocinio. Sì, perchè, per i sinistri, chi è ricco, lo è perchè ha rubato e non perchè se lo è guadagnato per merito e per lavoro.
Il perchè al sud Italia vi è più abusivismo edilizio (e per lo più tollerato)? E’ presto detto. Fino agli anni '50 l'Italia meridionale era fondata su piccoli borghi, con case di due stanze, di cui una adibita a stalla. Paesini da cui all’alba si partiva per lavorare nelle o presso le masserie dei padroni, per poi al tramonto farne ritorno. La masseria generalmente non era destinata ad alloggio per i braccianti.
Al nord Italia vi erano le Cascine a corte o Corti coloniche, che, a differenza delle Masserie, erano piccoli agglomerati che contenevano, oltre che gli edifici lavorativi e magazzini, anche le abitazioni dei contadini. Quei contadini del nord sono rimasti tali. Terroni erano e terroni son rimasti. Per questo al Nord non hanno avuto la necessità di evolversi urbanisticamente. Per quanto riguardava gli emigrati bastava dargli una tana puzzolente.
Al Sud, invece, quei braccianti sono emigrati per essere mai più terroni. Dopo l'ondata migratoria dal sud Italia, la nuova ricchezza prodotta dagli emigranti era destinata alla costruzione di una loro vera e bella casa in terra natia, così come l'avevano abitata in Francia, Germania, ecc.: non i vecchi tuguri dei borghi contadini, nè gli alveari delle case ringhiera o dei nuovi palazzoni del nord Italia. Inoltre quei braccianti avevano imparato un mestiere, che volevano svolgere nel loro paese di origine, quindi avevano bisogno di costruire un fabbricato per adibirlo a magazzino o ad officina. Ma la volontà di chi voleva un bel tetto sulla testa od un opificio, si scontrava e si scontra con la immensa burocrazia dei comunisti ed i loro vincoli annessi (urbanistici, storici, culturali, architettonici, archeologici, artistici, ambientali, idrogeologici, di rispetto, ecc.), che inibiscono ogni forma di soluzione privata. Ergo: per il diritto sacrosanto alla casa ed al lavoro si è costruito, secondo i canoni di sicurezza e di vincoli, ma al di fuori del piano regolatore generale (Piano Urbanistico) inesistente od antico, altrimenti non si potrebbe sanare con ulteriori costi sanzionatori che rende l’abuso antieconomico. Per questo motivo si pagano sì le tasse per una casa od un opificio, che la burocrazia intende abusivo, ma che la stessa burocrazia non sana, nè dota quelle costruzioni, in virtù delle tasse ricevute e a tal fine destinate, di infrastrutture primarie: luce, strade, acqua, gas, ecc.. Da qui, poi, nasce anche il problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Burocrazia su Burocrazia e gente indegna ed incapace ad amministrarla.
Per quanto riguarda, sempre al sud, l'abusivismo edilizio sulle coste, non è uno sfregio all'ambiente, perchè l'ambiente è una risorsa per l'economia, ma è un tentativo di valorizzare quell’ambiente per far sviluppare il turismo, come fonte di sviluppo sociale ed economico locale, così come in tutte le zone a vocazione turistica del mediterraneo, che, però, la sinistra fa fallire, perchè ci vuole tutti poveri e quindi, più servili e assoggettabili. L'ambientalismo è una scusa, altrimenti non si spiega come al nord Italia si possa permettere di costruire o tollerare costruzioni alle pendici dei monti, o nelle valli scoscese, con pericolo di frane ed alluvioni, ma per gli organi di informazione nazionale, prevalentemente nordisti e razzisti e prezzolati dalla sinistra, è un buon viatico, quello del tema dell'abusivismo e di conseguenza della criminalità che ne consegue, o di quella organizzata che la si vede anche se non c'è o che è sopravalutata, per buttare merda sulla reputazione dei meridionali.
Prima della rivoluzione francese “L’Ancien Régime” imponeva: ruba ai poveri per dare ai ricchi.
Erano dei Ladri!!!
Dopo, con l’avvento dei moti rivoluzionari del proletariato e la formazione ideologica/confessionale dei movimenti di sinistra e le formazioni settarie scissioniste del comunismo e del fascismo, si impose il regime contemporaneo dello stato sociale o anche detto stato assistenziale (dall'inglese welfare state). Lo stato sociale è una caratteristica dei moderni stati di diritto che si fondano sul presupposto e inesistente principio di uguaglianza, in quanto possiamo avere uguali diritti, ma non possiamo essere ritenuti tutti uguali: c’è il genio e l’incapace, c’è lo stakanovista e lo scansafatiche, l’onesto ed il deviante. Il capitale di per sé produce reddito, anche senza il fattore lavoro. Lavoro e capitale messi insieme, producono ricchezza per entrambi. Il lavoro senza capitale non produce ricchezza. Il ritenere tutti uguali è il fondamento di quasi tutte le Costituzioni figlie dell’influenza della rivoluzione francese: Libertà, Uguaglianza, Solidarietà. Senza questi principi ogni stato moderno non sarebbe possibile chiamarlo tale. Questi Stati non amano la meritocrazia, né meritevoli sono i loro organi istituzionali e burocratici. Il tutto si baratta con elezioni irregolari ed a larga astensione e con concorsi pubblici truccati di cooptazione. In questa specie di democrazia vige la tirannia delle minoranze. L’egualitarismo è una truffa. E’ un principio velleitario detto alla “Robin Hood”, ossia: ruba ai ricchi per dare ai poveri.
Sono dei ladri!!!
Tra l’antico regime e l’odierno sistema quale è la differenza?
Sempre di ladri si tratta. Anzi oggi è peggio. I criminali, oggi come allora, saranno coloro che sempre si arricchiranno sui beoti che li acclamano, ma oggi, per giunta, ti fanno intendere di fare gli interessi dei più deboli.
Non diritto al lavoro, che, come la manna, non cade dal cielo, ma diritto a creare lavoro. Diritto del subordinato a diventare titolare. Ma questo principio di libertà rende la gente libera nel produrre lavoro e ad accumulare capitale. La “Libertà” non è statuita nell’articolo 1 della nostra Costituzione catto comunista. Costituzioni che osannano il lavoro, senza crearne, ma foraggiano il capitale con i soldi dei lavoratori.
Le confessioni comuniste/fasciste e clericali ti insegnano: chiedi e ti sarà dato e comunque, subisci e taci!
Io non voglio chiedere niente a nessuno, specie ai ladri criminali e menzogneri, perché chi chiede si assoggetta e si schiavizza nella gratitudine e nella riconoscenza.
Una vita senza libertà è una vita di merda…
Cultura e cittadinanza attiva. Diamo voce alla piccola editoria indipendente.
Collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo”. Una lettura alternativa per l’estate, ma anche per tutto l’anno. L’autore Antonio Giangrande: “Conoscere per giudicare”.
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante, Inferno XXVI.
La collana editoriale indipendente “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo” racconta un’Italia inenarrabile ed inenarrata.
È così, piaccia o no ai maestrini, specie quelli di sinistra. Dio sa quanto gli fa torcere le budella all’approcciarsi del cittadino comune, ai cultori e praticanti dello snobismo politico, imprenditoriale ed intellettuale, all’élite che vivono giustificatamente separati e pensosi, perennemente con la puzza sotto il naso.
Il bello è che, i maestrini, se è contro i loro canoni, contestano anche l’ovvio.
Come si dice: chi sa, fa; chi non sa, insegna.
In Italia, purtroppo, vigono due leggi.
La prima è la «meritocrazia del contenuto». Secondo questa regola tutto quello che non è dichiaratamente impegnato politicamente è materia fecale. La conseguenza è che, per dimostrare «l'impegno», basta incentrare tutto su un contenuto e schierarsene ideologicamente a favore: mafia, migranti, omosessualità, ecc. Poi la forma non conta, tantomeno la realtà della vita quotidiana. Da ciò deriva che, se si scrive in modo neutro (e quindi senza farne una battaglia ideologica), si diventa non omologato, quindi osteggiato o emarginato o ignorato.
La seconda legge è collegata alla prima. La maggior parte degli scrittori nostrani si è fatta un nome in due modi. Primo: rompendo le balle fin dall'esordio con la superiorità intellettuale rispetto alle feci che sarebbero i «disimpegnati».
Secondo modo per farsi un nome: esordire nella medietà (cioè nel tanto odiato nazional-popolare), per poi tentare il salto verso la superiorità.
Il copione lo conosciamo: a ogni gaffe di cultura generale scatta la presa in giro. Il problema è che a perderci sono proprio loro, i maestrini col ditino alzato. Perché è meno grave essere vittime dello scadimento culturale del Paese che esserne responsabili. Perché, nonostante le gaffe conclamate e i vostri moti di sdegno e scherno col ditino alzato su congiuntivi, storia e geografia, gli errori confermano a pieno titolo come uomini di popolo, gente comune, siano vittime dello scadimento culturale del Paese e non siano responsabili di una sub cultura menzognera omologata e conforme. Forse alla gente comune rompe il cazzo il sentire le prediche e le ironie di chi - lungi dall’essere anche solo avvicinabile al concetto di élite - pensa di saperne un po’ di più. Forse perché ha avuto insegnanti migliori, o un contesto famigliare un po’ più acculturato, o il tempo di leggere qualche libro in più. O forse perchè ha maggior dose di presunzione ed arroganza, oppure occupa uno scranno immeritato, o gli si dà l’opportunità mediatica immeritata, che gli dà un posto in alto e l’opportunità di vaneggiare.
Non c'è nessun genio, nessun accademico tra i maestrini. Del resto, mai un vero intellettuale si permetterebbe di correggere una citazione errata, tantomeno di prenderne in giro l'autore. Solo gente normale con una cultura normale pure loro, con una alta dose di egocentrismo, cresciuti a pane, magari a videocassette dell’Unità di Veltroni e citazioni a sproposito di Pasolini. Maestrini che vedono la pagliuzza negli occhi altrui, pagliuzza che spesso non c'è neppure, e non hanno coscienza della trave nei loro occhi o su cui sono appoggiati.
L'ITALIA ED IL DNA DEGLI ITALIANI.
La bella Italia di Aban feat. Marracash & Gue Pequeno
Ehi, è la mia nazione, niente cambia qua,
Marra, Guè Pequeno, vi porto a fare un giro nella Bella Italia
E dovrei leggere il giornale e guardare il tg, in tv,
per accorgermi che stato e mafia sono intimi,
Dogo Gang, lo sanno già tutti,
Southfam, lo sanno già tutti,
il peggio è che lo sanno già tutti.
Vengo al mondo con il piombo nel '79
con il cielo rosso sangue sopra la nazione
l'anno prima della bomba dentro la stazione
il Paese inginocchiato ai piedi del terrore
l'ambientazione non cambia quando passiamo agli '80
quando è lo stato assassino, sai non esiste condanna
basta una botta di pala per insabbiare la trama
e tutti morti ammazzati dentro le stragi in Italia
poi la nuova alleanza tra politica e mala
la faccia buona e pulita, la mano armata e insanguinata
i pilastri di cemento con i cristiani dentro
l'acido e le vasche, e il primo pentimento
sono gli anni dei maxi processi, la verità viene a galla
lo stato primo assassino, strinse la mano alla mala,
e se volevi lavorare dovevi pagare
l'impiegato, il sindaco, l'appalto comunale.
I nuovi clan del 90 sotto il nome d'azienda
i soldi sporchi riciclati dalle banche di Berna
la politica assassina che soffoca i cittadini
e ruba dallo stipendio per finanziare i partiti
i loro vizi esauditi col sangue degli operai
e i soldi delle pensioni che non bastano mai
12 teste al mese per ogni parlamentare
e 8000 euro all'anno per la fascia popolare
l'onorevole a puttane, l'ha detto il telegiornale
bamba pura di Colombia per l'alto parlamentare
tra i banchi di tribunale c'è chi ha rubato per fame
una vita di lavoro e 5 bocche da sfamare
ma la legge della Bella Italia valuta il prefisso
che davanti al nome è presidente o ministro
e non conta il reato, il verdetto è fisso,
non va dentro Barabba, sconta il povero Cristo.
Non c'è il diavolo contro l'angelo che consiglia
L'alternativa per me è il diavolo o la scimmia
in testa ho merda, fogli in fretta, potere, droga e tette
come in Quirinale, il criminale che non si dimette
ho l'oro bianco al collo frà, ed è gelido come il mio cuore
devo inventarmi soldi, voi vi inventate storie
l'uomo di successo qui è il balordo legalizzato
(???) ci ha promesso che lui non si è mai drogato
la mafia e la politica frà andranno sempre insieme,
come al cesso mano nella mano le due amiche sceme
ed è per questo che molta della mia gente, no, non vota
nella merda frà ci nuota, mentre in tele svolta un altro idiota
questa è la Bella Italia, tira una bella raglia
faccia da galera del magnaccia sul Carrera
scorda i problemi, sogna il montepremi
il frà sul lastrico progetta fuga nel Sud-Est Asiatico.
In Italia di Fabri Fibra feat. Gianna Nannini.
Ci sono cose che nessuno ti dirà…
Ci sono cose che nessuno ti darà…
Sei nato e morto qua
Nato e morto qua
Nato nel paese delle mezza verità
Dove fuggi? In Italia
Pistole in macchine in Italia
Machiavelli e Foscolo in Italia
I campioni del mondo sono in Italia
Benvenuto in Italia
Fatti una vacanza al mare in Italia
Meglio non farsi operare in Italia
Non andare all'ospedale in Italia
La bella vita in Italia
Le grandi serate e i gala in Italia
Fai affari con la mala in Italia
Il vicino che ti spara in Italia
Ci sono cose che nessuno ti dirà…
Ci sono cose che nessuno ti darà…
Sei nato e morto qua
Sei nato e morto qua
Nato nel paese delle mezza verità
Dove fuggi? In Italia
I veri mafiosi sono in Italia
I più pericolosi sono in Italia
Le ragazze nella strada in Italia
Mangi pasta fatta in casa in Italia
Poi ti entrano i ladri in casa in Italia
Non trovi un lavoro fisso in Italia
Ma baci il crocifisso in Italia
I monumenti in Italia
Le chiese con i dipinti in Italia
Gente con dei sentimenti in Italia
La campagna e i rapimenti in Italia
Ci sono cose che nessuno ti dirà…
Ci sono cose che nessuno ti darà…
Sei nato e morto qua
Sei nato e morto qua
Nato nel paese delle mezza verità
Dove fuggi? In Italia
Le ragazze corteggiate in Italia
Le donne fotografate in Italia
Le modelle ricattate in Italia
Impara l'arte in Italia
Gente che legge le carte in Italia
Assassini mai scoperti in Italia
Volti persi e voti certi in Italia
Ci sono cose che nessuno ti dirà…
Ci sono cose che nessuno ti darà…
Sei nato e morto qua
Sei nato e morto qua
Nato nel paese delle mezza verità
Dove fuggi…
Dove fuggi...
La terra dei cachi di Elio e le Storie Tese
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi;
tanta voglia di ricominciare abusiva.
Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate;
il visagista delle dive è truccatissimo.
Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto:
Italia sì Italia no Italia bum, la strage impunita.
Puoi dir di sì puoi dir di no, ma questa è la vita.
Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè:
c'è un commando che ci aspetta per assassinarci un po'.
Commando sì commando no, commando omicida.
Commando pam commando papapapapam, ma se c'è la partita
il commando non ci sta e allo stadio se ne va,
sventolando il bandierone non più sangue scorrerà;
infetto sì? Infetto no? Quintali di plasma.
Primario sì primario dai, primario fantasma,
io fantasma non sarò e al tuo plasma dico no.
Se dimentichi le pinze fischiettando ti dirò
"fi fi fi fi fi fi fi fi ti devo una pinza, fi fi fi fi fi fi fi fi, ce l'ho nella panza".
Viva il crogiuolo di pinze. Viva il crogiuolo di panze.
Quanti problemi irrisolti ma un cuore grande così.
Italia sì Italia no Italia gnamme, se famo du spaghi.
Italia sob Italia prot, la terra dei cachi.
Una pizza in compagnia, una pizza da solo; un totale di due pizze e l'Italia è questa qua.
Fufafifì' fufafifì' Italia evviva.
Italia perfetta, perepepè' nanananai.
Una pizza in compagnia, una pizza da solo:
in totale molto pizzo, ma l ' Italia non ci sta.
Italia sì Italia no, Italia sì
uè, Italia no, uè uè uè uè uè.
Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No
L'italiano medio degli Articolo 31
Io mi ricordo collette di Natale
Campi di grano ai lati della provinciale
Il tragico Fantozzi, la satira sociale
Oggi cerco Luttazzi e
Non lo trovo sul canale
Comunque sono un bravo cittadino
Ho aggiornato suonerie del telefonino
E un bicchiere di vino con un panino
Provo felicità se Costanzo fa il trenino
Ho un santino in salotto
Lo prego così vinco all'enalotto
Ho Gerry Scotti col risotto ma è scotto
Che mi fa diventare milionario come Silvio
Col giornale di Paolo e tanta fede in Emilio
Quest'anno ho avuto fame ma per due settimane
Ho fatto il ricco a Porto Cervo. Che bello!
Però ricordo collette di Natale
Campi di grano ora il grano è da buttare
M'importa poco oggi io vado al centro commerciale
E il mio problema è solo dove parcheggiare
Ohoo Ohoo
Ma a me non me ne frega tanto
Ohoo Ohoo
Io sono un italiano e canto
E datemi Fiorello e Panariello alla tv
Sono l'italiano medio nel blu dipinto di blu
Io sono un bravo cittadino onesto
Bevo al mattino un bel caffè corretto
Dopo cena il limoncello in vacanza la tequila
La Gazzetta d'inverno e d'estate novella 2000
Che bella la vita di una stella
marina o Martina o quella della velina
La mora o la bionda è buona e rotonda
Finchè la barca va finchè la barca affonda
E intanto sto perdendo sulla patente il punto
E un auto blu mi sfreccia accanto
Che incanto
Ohoo Ohoo
Ma a me non me ne frega tanto
Ohoo Ohoo
Io sono un italiano e canto
Non togliermi il pallone e non ti disturbo più
Sono l'italiano medio nel blu dipinto di bluuuuu
Ohoo
Ma spero che un sogno così non ritorni mai più
Mi voglio svegliare, mai più
Ti voglio fare vedere
Che sono proprio un bravo cittadino
Ho il portafoglio di Valentino
E l'importante è quello che ci metto dentro
Vado con il vento a sinistra a destra
Sabato in centro fino a consumare le suole
Ballo canzoni spagnole così non mi sforzo
A seguire le parole e penso a fare l'amore
Alla villa di Briatore alla nonna senza
Ascensore alla donna del calciatore
A qual è il male minore, l'onore, sua eccellenza
Monsignore ancora baciamo la mano
Che del miracolo italiano
Ohoo Ohoo
Ma a me non me ne frega tanto
Ohoo Ohoo
Io sono un italiano e canto
E datemi Fiorello e Panariello alla tv
Sono l'italiano medio nel blu dipinto di blu
Ohoo Ohoo
Ma a me non me ne frega tanto
Ohoo Ohoo
Io sono un italiano e canto
Non togliermi il pallone e non ti disturbo più
Sono l'italiano medio nel blu dipinto di bluuuuu
Ohoo
C'era una volta
E non solo una
Un re che amava così tanto i vestiti nuovi
che spendeva in essi tutto quello che aveva
Possedeva un abito diverso per ogni ora della giornata
Niente importava per lui
Eccetto i suoi vestiti
Eppure non trovava soddisfazione
Il sarto era sull'orlo della disperazione
Disse al re di avere inventato un nuovo tessuto
Che cambiava colore e forma ad ogni momento
Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi
A loro il tessuto sarebbe stato invisibile
E pensate, e pensate
Quelli Che Benpensano di Frankie HI-NRG MC
Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi
A far promesse senza mantenerle mai se non per calcolo
Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile
La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere
E non far partecipare nessun altro
Nella logica del gioco la sola regola è esser scaltro
Niente scrupoli o rispetto verso I propri simili
Perché gli ultimi saranno gli ultimi se I primi sono irraggiungibili
Sono tanti, arroganti coi più deboli,
zerbini coi potenti, sono replicanti,
Sono tutti identici, guardali,
stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere.
Come lucertole s'arrampicano,
e se poi perdon la coda la ricomprano.
Fanno quel che vogliono si sappia in giro fanno
spendono, spandono e sono quel che hanno
Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Sono come me, ma si sentono meglio
Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Sono come me, ma si sentono meglio
e come le supposte abitano in blisters full-optional,
Con cani oltre I 120 decibel e nani manco fosse Disneyland,
Vivono col timore di poter sembrare poveri
Quel che hanno ostentano, tutto il resto invidiano, poi lo comprano,
In costante escalation col vicino costruiscono
Parton dal pratino e vanno fino in cielo,
han più parabole sul tetto che S.Marco nel Vangelo..
Sono quelli che di sabato lavano automobili
che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e I pargoli,
Medi come I ceti cui appartengono,
terra-terra come I missili cui assomigliano.
Tiratissimi, s'infarinano, s'alcolizzano
e poi s'impastano su un albero
Nasi bianchi come Fruit of the Loom
che diventano più rossi d'un livello di Doom
Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Sono come me, ma si sentono meglio
Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Sono come me, ma si sentono meglio
Ognun per se, Dio per se, mani che si stringono tra I banchi delle chiese alla domenica
mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano
Altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano
Mani che poi firman petizioni per lo sgombero,
Mani lisce come olio di ricino,
Mani che brandisco Manganelli, che Farciscono Gioielli,
che si alzano alle spalle dei Fratelli.
Quelli che la notte non si può girare più,
quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardan La TV,
Che fanno I boss, che compra Class,
che son sofisticati da chiamare I NAS, incubi di Plastica
Che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara
Ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera,
Quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera
Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Sono come me, ma si sentono meglio
Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Sono come me, ma si sentono meglio
Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Sono come me, ma si sentono meglio
Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Sono come me, ma si sentono meglio
Sabbie Mobili di Marracash
Non agitarti
Resta immobile
Non agitarti
Resta immobile
Puoi metterci anni
E guardare ogni cosa che
Affonda Nelle sabbie mobili
Si perde Nelle sabbie mobili
Penso spesso che potrei farlo
Andare via di punto in bianco
Così altra città. Altro Stato
Potrei se avessi il coraggio
Ho un orizzonte limitato
E' follia stare qua nel miraggio
Che basti essere capaci
Quanti ne ho visti scavalcarmi
Rampolli Rapaci. Raccomandati
Quanti ne ho visti fare viaggi
E dopo non tornare
Restare. Spaccare. Affermarsi
Qui non c'è il mito di chi si è fatto da solo
Perché chi si è fatto da solo di solito è corrotto
Se sei un ragazzo ambizioso
In un sistema corrotto
Non puoi fare il botto
E non uscirne più sporco
Nessuno lascia le poltrone
Niente si muove
Nessuno osa e nessuno dà un occasione
Impantanati in queste sabbie mobili
Si muore comodi
Lo Stato spreca i migliori uomini
Non agitarti. Resta immobile.
Puoi metterci anni
E guardare ogni cosa che Affonda
Nelle sabbie mobili
Si perde. Nelle sabbie mobili
Parto dal principio
Io della scuola ricordo un ficus
Cioè la pianta che aveva il preside in ufficio
Vale più un mio testo letto in diretta da Linus
Il paese ha un virus
Una paralisi da ictus
Come prima più di prima
Madonna potrebbe essere mia nonna
A 50 anni è ancora a pecorina
E' il nulla
Come la storia infinita
Come la mummia
Che si sveglia e torna in vita
Puzza di muffa
The beautiful people
The beautiful people
La bella gente pratica il cannibalismo
Sa di già visto
Come un film di cui capisci la fine
Già dall'inizio
I vecchi stanno al potere
Non vanno all'ospizio
E se MTV sta per music television
Vorremmo più video e meno reality e fiction
Sono pesante apposta come chi fa sumo
Tu fai musica che piace a tanti
E non fa impazzire nessuno
Non agitarti. Resta immobile
Puoi metterci anni
E guardare ogni cosa che
Affonda. Nelle sabbie mobili
Si perde. Nelle sabbie mobili
Niente di nuovo. Niente di che
Quel rapper che ti piace
Non dice niente di sé
Solo cliché
Attacca il premier
Come se quando cadrà il premier
Vincerà il bene
Se non ci fosse di che parlerebbe
Chi comanda è lì da sempre
E non si elegge con il voto
E prende decisioni senza cuore e senza quorum
E se tornassi indietro io lo rifarei
Il mio incubo era fare la vita dei miei
Sì quella vita strizzata in otto ore
Compressa. La sera sei stanco e c'hai mal di testa
Compressa. Fuori onda il direttore dice che ho ragione
Ma non ci crede
Come chi brinda
Ma poi non beve
Non prendere la bufala
Che tanto non è bufala
E' una bufala
Hai una chance di andartene frà. Usala
Se riesci sei un genio
Se fallisci sei uno zero
Se fai quello che fanno gli altri
Rischi di meno
Quindi. Non agitarti. Resta immobile
Puoi metterci anni
E guardare il paese che
Affonda. Nelle sabbie mobili
Si perde. Nelle sabbie mobili
Io Non Mi Sento Italiano di Giorgio Gaber
Parlato: Io G. G. sono nato e vivo a Milano.
Io non mi sento italiano
Ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Mi scusi Presidente
Non è per colpa mia
Ma questa nostra Patria
Non so che cosa sia.
Può darsi che mi sbagli
Che sia una bella idea
Ma temo che diventi
Una brutta poesia.
Mi scusi Presidente
Non sento un gran bisogno
Dell'inno nazionale
Di cui un po' mi vergogno.
In quanto ai calciatori
Non voglio giudicare
I nostri non lo sanno
O hanno più pudore.
Io non mi sento italiano
Ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Mi scusi Presidente
Se arrivo all'impudenza
Di dire che non sento
Alcuna appartenenza.
E tranne Garibaldi
E altri eroi gloriosi
Non vedo alcun motivo
Per essere orgogliosi.
Mi scusi Presidente
Ma ho in mente il fanatismo
Delle camicie nere
Al tempo del fascismo.
Da cui un bel giorno nacque
Questa democrazia
Che a farle i complimenti
Ci vuole fantasia.
Io non mi sento italiano
Ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Questo bel Paese
Pieno di poesia
Ha tante pretese
Ma nel nostro mondo occidentale
È la periferia.
Mi scusi Presidente
Ma questo nostro Stato
Che voi rappresentate
Mi sembra un po' sfasciato.
E' anche troppo chiaro
Agli occhi della gente
Che tutto è calcolato
E non funziona niente.
Sarà che gli italiani
Per lunga tradizione
Son troppo appassionati
Di ogni discussione.
Persino in parlamento
C'è un'aria incandescente
Si scannano su tutto
E poi non cambia niente.
Io non mi sento italiano
Ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Mi scusi Presidente
Dovete convenire
Che i limiti che abbiamo
Ce li dobbiamo dire.
Ma a parte il disfattismo
Noi siamo quel che siamo
E abbiamo anche un passato
Che non dimentichiamo.
Mi scusi Presidente
Ma forse noi italiani
Per gli altri siamo solo
Spaghetti e mandolini.
Allora qui mi incazzo
Son fiero e me ne vanto
Gli sbatto sulla faccia
Cos'è il Rinascimento.
Io non mi sento italiano
Ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Questo bel Paese
Forse è poco saggio
Ha le idee confuse
Ma se fossi nato in altri luoghi
Poteva andarmi peggio.
Mi scusi Presidente
Ormai ne ho dette tante
C'è un'altra osservazione
Che credo sia importante.
Rispetto agli stranieri
Noi ci crediamo meno
Ma forse abbiam capito
Che il mondo è un teatrino.
Mi scusi Presidente
Lo so che non gioite
Se il grido "Italia, Italia"
C'è solo alle partite.
Ma un po' per non morire
O forse un po' per celia
Abbiam fatto l'Europa
Facciamo anche l'Italia.
Io non mi sento italiano
Ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Io non mi sento italiano
Ma per fortuna o purtroppo
Per fortuna o purtroppo
Per fortuna. Per fortuna lo sono.
Mamma L'Italiani di Après La Classe
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
nei secoli dei secoli girando per il mondo
nella pizzeria con il Vesuvio come sfondo
non viene dalla Cina non è neppure americano
se vedi uno spaccone è solamente un italiano
l'italiano fuori si distingue dalla massa
sporco di farina o di sangue di carcassa
passa incontrollato lui conosce tutti
fa la bella faccia fa e poi la mette in culo a tutti
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
a suon di mandolino nascondeva illegalmente
whisky e sigarette chiaramente per la mente
oggi è un po' cambiato ma è sempre lo stesso
non smercia sigarette ma giochetti per il sesso
l'italiano è sempre stato un popolo emigrato
che guardava avanti con la mente nel passato
chi non lo capiva lui lo rispiegava
chi gli andava contro è saltato pure in a...
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
l'Italia agli italiani e alla sua gente
è lo stile che fa la differenza chiaramente
genialità questa è la regola
con le idee che hanno cambiato tutto il corso della storia
l'Italia e la sua nomina e un alta carica
un eredità scomoda
oggi la visione italica è che
viaggiamo tatuati con la firma della mafia
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
vacanze di piacere per giovani settantenni
all'anagrafe italiani ma in Brasile diciottenni
pagano pesante ragazze intraprendenti
se questa compagnia viene presa con i denti
l'italiano è sempre stato un popolo emigrato
che guardava avanti con la mente nel passato
chi non lo capiva lui lo rispiegava
chi gli andava contro è saltato pure in a...
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
spara la famiglia del pentito che ha cantato
lui che viene stipendiato il 27 dallo stato
nominato e condannato nel suo nome hanno sparato
e ricontare le sue anime non si può più
risponde la famiglia del pentito che ha cantato
difendendosi compare tutti giorni più incazzato
sarà guerra tra famiglie
sangue e rabbia tra le griglie
con la fama come foglie che ti tradirà
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Rivoluzione di Renato Zero
Protesterai
ogni tregua è finita oramai
dalla sabbia la testa alzerai
dritto al cuore colpirai.
Libererai
quello che soffocavi in te
la tua voce è più forte se vuoi
del silenzio e l'omertà
C'è una guerra giusta e devi farla tu
è la tua risposta a chi non chiede più
Rivoluzione è il grido che solleverai
e devi metterci la faccia finché puoi
perché ho pagato il conto ai tuoi caffè
su la testa adesso tocca te
Ti accorgerai
che il nemico è nascosto tra noi
che il futuro non viene da sé
e ogni brivido ha un suo perché
E sentirai
che resistere è pura follia
ci sarà poi chi ride di te
ma è soltanto paura la sua
Perché niente al mondo viene come vuoi
Perché tutto al mondo ha un prezzo d'ora in poi
Rivoluzione è la promessa che mi fai
di calci e sputi non avere mai paura
Non posso andare sempre avanti io
ho già dato e adesso tocca te
Politica assente famiglia vacante
quaggiù si congeda anche Dio
Se la corda si spezza s'incendia la piazza
E ritorno a lottare con te!
Rivoluzione è il grido che solleverai
e devi metterci la faccia finché puoi
perché ho pagato il conto ai tuoi caffè
fuori il cuore adesso tocca te
Rivoluzione è il grido che solleverai
e devi metterci la faccia finché puoi
perché ho pagato il conto ai tuoi caffè
fuori il cuore adesso tocca te
Rivoluzione! Rivoluzione.
Rivoluzione di Frankie hi-nrg mc
In Italia c'è lavoro in qualche punto nero – capita:
ogni volo che finisce sotto a un telo irrita, noi che
qui pure Peppone sa il Vangelo e lo agita, un po' si
esagita, dopo un po' si sventola: senti un po' che
caldo fa… Afa tutto l'anno – più brevemente
“affanno” – non sanno a quale conclusione non
Approderanno. Noi l'Italia siamo e non la stiam
Rappresentando: ciurma! Ai posti di comando!
Mettiamo al bando i vertici politici con tutti i loro
Complici, amici degli amici di chi ha svuotato i
Conti: incassano tangenti celandosi le fonti e han
Cappucci e cornetti sulle fronti.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione,
sesso, razza o religione: tutti pronti per l'azione.
Troppi furbetti nel nostro quartierino e tutti ci
intercettano con il telefonino, ci piazzano vallette
nude sopra allo zerbino e paparazzi sui terrazzi del
vicino: ragazzi che casino! Senza via di
scampo, chiusi dentro al plastico di quel villino ci è
venuto un crampo, siamo titolari confinati a bordo
campo, ci fan pagare l'acqua più salata dello
shampoo. Boh? Magari mi sbaglio, ma vedo tutti
quanti allo sbaraglio, meglio darci un taglio… Figli
mai usciti dal travaglio: qui da masticare non ci
resta che il bavaglio.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione,
sesso, razza o religione: tutti pronti per l'azione.
L'Italia, non lo sai, ha problemi araldici: i baroni
sono pochi e han troppi conti per dei medici. Poi
ha problemi etici, politici, geografici, geologici, ma
i peggio restan quelli genealogici… Visto che la
base del sistema è la clientela e siamo separati
da 6 gradi sì, ma di parentela, maglie di una
ragnatela a forma di stivale, tutti collegati in linea
collaterale come un'unica famiglia in un immenso
psicodramma: sta bravo che altrimenti piange
mamma. Cambio di programma: annulliamo la
rivolta. Abbiamo una famiglia e non dev'essere
coinvolta…
Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in
Televisione… chi c'è andato che delusione! Era
chiuso anche il portone.
"Chi comanda il mondo?" di Povia
Fate la nanna bambini, verranno tempi migliori
Fate la nanna bambini e disegnate i colori
Chi comanda il mondo, c’è una dittatura, c’è una dittatura
Chi comanda il mondo, non puoi immaginare quanto fa paura
Chi comanda il mondo, oltre che il potere vuole il tuo dolore
e dovrai soffrire, e sarai costretto ad obbedire
Chi comanda il mondo, voglia di sapere, voglia di capire
Chi comanda il mondo, sotto questo cielo che ci può sentire
e chi ha creato il mondo, Torre di Babele, Torre di Babele
chi ha creato il mondo, messo sulla croce in Israele
C’è una dittatura di illusionisti finti
economisti equilibristi
terroristi padroni del mondo peggio dei nazisti
che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti stacanovisti
gli illusionisti, che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia
fino a portarci all’apatia
creando nella massa, una massa grassa di armi di divisione di massa
media, oggetti, nomi, colori, simboli
la pensiamo uguale ma siamo divisi noi singoli
dormiamo bene sotto le coperte
siamo servi di queste sorridenti merde
Fate la nanna bambini, verranno tempi migliori
Fate la nanna bambini e disegnate i colori
Fate la nanna che la mamma, vi cullerà sui suoi seni
Fate la nanna bambini volati nei cieli
Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà
e l’uomo più forte del mondo diventerà
portando in alto l’amore
Chi comanda il mondo, c’è una dittatura, c’è una dittatura
Chi comanda il mondo, non puoi immaginare quanto fa paura
Chi comanda il mondo, Torre di Babele, Torre di Babele
chi ha creato il mondo, dice sempre che va tutto bene
La libertà e la lotta contro l’ingiustizia
non sono né di destra né di sinistra
la musica può arrivare nell’essenziale
dove non arrivano le parole da sole
gli illusionisti ci hanno incastrati firmando i trattati
da Maastricht a Lisbona
siamo tutti indignati perché questi trattati
annullano ogni costituzione
quì bisogna dare un bel colpo di scopa
e spazzare via ogni stato da quest’Europa
se ogni stato uscisse dall’Euro davvero
magari ogni debito andrebbe a zero
perché per tutti c’è un punto d’arrivo
nessuno lascerà questo mondo da vivo
vogliamo una terra sana, sana
meglio una moneta sovrana (che una moneta puttana)
Fate la nanna bambini, verranno tempi migliori
Fate la nanna bambini e disegnate i colori
Fate la nanna che la mamma, vi cullerà sui suoi seni
Fate la nanna bambini volati nei cieli
Ma un giorno un bambino di questi si sveglierà
e l’uomo più forte del mondo diventerà
portando in alto l’amore
Chi comanda il mondo, c’è una dittatura, c’è una dittatura
Chi comanda il mondo, non puoi immaginare quanto fa paura
Chi comanda il mondo, oltre che il potere vuole il tuo dolore
e dovrai soffrire, e sarai costretto ad obbedire
Chi comanda il mondo, voglia di sapere, voglia di capire
Chi comanda il mondo, sotto questo cielo che ci può sentire
e chi ha creato il mondo, Torre di Babele, Torre di Babele
chi ha creato il mondo, messo sulla croce in Israele
Fate la nanna bambini volati nei cieli
Intervista all’autore, il dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
«Quando ero piccolo a scuola, come in famiglia, mi insegnavano ad adempiere ai miei doveri: studiare per me per sapere; lavorare per la famiglia; assolvere la leva militare per la difesa della patria; frequentare la chiesa ed assistere alla messa domenicale; ascoltare i saggi ed i sapienti per imparare, rispettare il prossimo in generale ed in particolare i più grandi, i piccoli e le donne, per essere rispettato. La visita giornaliera ai nonni ed agli zii era obbligatoria perché erano subgenitori. I cugini erano fratelli. Il saluto preventivo agli estranei era dovuto. Ero felice e considerato. L'elargizione dei diritti era un premio che puntuale arrivava. Contava molto di più essere onesti e solidali che non rivendicare o esigere qualcosa che per legge o per convenzione ti spettava. Oggi: si pretende (non si chiede) il rispetto del proprio (e non dell'altrui) diritto, anche se non dovuto; si parla sempre con imposizione della propria opinione; si fa a meno di studiare e lavorare o lo si impedisce di farlo, come se fosse un dovere, più che un diritto; la furbizia per fottere il prossimo è un dono, non un difetto. Non si ha rispetto per nessun'altro che non sia se stesso. Non esiste più alcun valore morale. Non c'è più Stato; nè Famiglia; nè religione; nè amicizia. Sui social network, il bar telematico, sguazzano orde di imbecilli. Quanto più amici asocial si hanno, più si è soli. Questa è l'involuzione della specie nella società moderna liberalcattocomunista».
Quindi, oggi, cosa bisogna sapere?
«Non bisogna sapere, ma è necessario saper sapere. Cosa voglio dire? Affermo che non basta studiare il sapere che gli altri od il Sistema ci propinano come verità e fermarci lì, perché in questo caso diveniamo quello che gli altri hanno voluto che diventassimo: delle marionette. E’ fondamentale cercare il retro della verità propinata, ossia saper sapere se quello che sistematicamente ci insegnano non sia una presa per il culo. Quindi se uno già non sa, non può effettuare la verifica con un ulteriore sapere di ricerca ed approfondimento. Un esempio per tutti. Quando si studia giurisprudenza non bisogna fermarsi alla conoscenza della norma ed eventualmente alla sua interpretazione. Bisogna sapere da chi e con quale maggioranza ideologica e perchè è stata promulgata o emanata e se, alla fine, sia realmente condivisa e rispettata. Bisogna conoscere il retro terra per capirne il significato: se è stata emessa contro qualcuno o a favore di qualcun'altro; se è pregna di ideologia o adottata per interesse di maggioranza di Governo; se è un'evoluzione storica distorsiva degli usi e dei costumi nazionali o influenzata da pregiudizi, o sia una conformità alla legislazione internazionale lontana dalla nostra cultura; se è stata emanata per odio...L’odio è un sentimento di rivalsa verso gli altri. Dove non si arriva a prendere qualcosa si dice che non vale. E come quel detto sulla volpe che non riuscendo a prendere l’uva disse che era acerba. Nel parlare di libertà la connessione va inevitabilmente ai liberali ed alla loro politica di deburocratizzazione e di delegificazione e di liberalizzazione nelle arti, professioni e nell’economia mirante all’apoteosi della meritocrazia e della responsabilità e non della inadeguatezza della classe dirigente. Lo statalismo è una stratificazione di leggi, sanzioni e relativi organi di controllo, non fini a se stessi, ma atti ad alimentare corruttela, ladrocinio, clientelismo e sopraffazione dei deboli e degli avversari politici. Per questo i liberali sono una razza in estinzione: non possono creare consenso in una massa abituata a pretendere diritti ed a non adempiere ai doveri. Fascisti, comunisti e clericali sono figli degeneri di una stessa madre: lo statalismo ed il centralismo. Si dicono diversi ma mirano tutti all’assistenzialismo ed alla corruzione culturale per influenzare le masse: Panem et circenses (letteralmente «pane e [giochi] circensi») è una locuzione latina piuttosto nota e spesso citata, usata nell'antica Roma e al giorno d'oggi per indicare in sintesi le aspirazioni della plebe (nella Roma di età imperiale) o della piccola borghesia, o d'altro canto in riferimento a metodi politici bassamente demagogici. Oggi la politica non ha più credibilità perchè non è scollegata dall’economia e dalle caste e dalle lobbies che occultamente la governano, così come non sono più credibili i loro portavoce, ossia i media di regime, che tanto odiano la "Rete". Internet, ormai, oggi, è l'unico strumento che permette di saper sapere, dando modo di scoprire cosa c'è dietro il fronte della medaglia, ossia cosa si nasconda dietro le fake news (bufale) di Stato o dietro la discultura e l'oscurantismo statalista».
Cosa racconta nei suoi libri?
«Sono un centinaio di saggi di inchiesta composti da centinaia di pagine, che raccontano di un popolo difettato che non sa imparare dagli errori commessi. Pronto a giudicare, ma non a giudicarsi. I miei libri raccontato l’indicibile. Scandali, inchieste censurate, storie di ordinaria ingiustizia, di regolari abusi e sopraffazioni e di consueta omertà. Raccontano, attraverso testimonianze e documenti, per argomento e per territorio, i tarli ed i nei di una società appiattita che aspetta il miracolo di un cambiamento che non verrà e che, paradosso, non verrà accettato. In più, come chicca editoriale, vi sono i saggi con aggiornamento temporale annuale, pluritematici e pluriterritoriali. Tipo “Selezione dal Reader’s Digest”, rivista mensile statunitense per famiglie, pubblicata in edizione italiana fino al 2007. Gli argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati ed approfonditi nei saggi analitici specificatamente dedicati e già pubblicati negli stessi canali di distribuzione internazionale in forma Book o E-book. Canali di pubblicazione e di distribuzione come Amazon o Google libri. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a tesi di laurea ed inchieste giornalistiche. I testi hanno una versione video sui miei canali youtube».
Qual è la reazione del pubblico?
«Migliaia sono gli accessi giornalieri alle letture gratuite di parti delle opere su Google libri e decine di migliaia sono le pagine lette ogni giorno. Accessi da tutto il mondo, nonostante il testo sia in lingua italiana e non sia un giornale quotidiano. Si troveranno, anche, delle recensioni deliranti e degradanti di queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando del nulla, ma dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio che l'offeso si ribelli con la denigrazione del palesato».
Perché è poco conosciuto al grande pubblico generalista?
«Perché sono diverso. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati. Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti. In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso. Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da “coglioni”».
Qual è la sua missione?
«“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente…Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili”. Citazioni di Bertolt Brecht. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!»
Perché è orgoglioso di essere diverso?
«E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta...” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso...” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale».
Dr. Antonio Giangrande. Orgoglioso di essere diverso.
La massa ti considera solo se hai e ti votano solo se dai. Nulla vali se tu sai. Victor Hugo: "Gli uomini ti stimano in rapporto alla tua utilità, senza tener conto del tuo valore." Le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale, tangibile ed immediata, da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili da sempre, pur con altissimo valore, sono emarginati o ignorati, inibendone, ulteriormente, l’utilità.
Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
Fa quello che si sente di fare e crede in quello che si sente di credere.
La Democrazia non è la Libertà.
La libertà è vivere con libero arbitrio nel rispetto della libertà altrui.
La democrazia è la dittatura di idioti che manipolano orde di imbecilli ignoranti e voltagabbana.
Cattolici e comunisti, le chiese imperanti, impongono la loro libertà, con la loro morale, il loro senso del pudore ed il loro politicamente corretto.
Per questo un popolo di coglioni sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da coglioni.
Facciamo sempre il solito errore: riponiamo grandi speranze ed enormi aspettative in piccoli uomini senza vergogna.
Un altro errore che commettiamo è dare molta importanza a chi non la merita.
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante, Inferno XXVI
Le pecore hanno paura dei lupi, ma è il loro pastore che le porta al macello.
Da sociologo storico ho scritto dei saggi dedicati ad ogni partito o movimento politico italiano: sui comunisti e sui socialisti (Craxi), sui fascisti (Mussolini), sui cattolici (Moro) e sui moderati (Berlusconi), sui leghisti e sui pentastellati. Il sottotitolo è “Tutto quello che non si osa dire. Se li conosci li eviti.” Libri che un popolo di analfabeti mai leggerà.
Da queste opere si deduce che ogni partito o movimento politico ha un comico come leader di riferimento, perché si sa: agli italiani piace ridere ed essere presi per il culo. Pensate alle battute di Grillo, alle barzellette di Berlusconi, alle cazzate di Salvini, alle freddure della Meloni, alle storielle di Renzi, alle favole di D’Alema e Bersani, ecc. Partiti e movimenti aventi comici come leader e ladri come base.
Gli effetti di avere dei comici osannati dai media prezzolati nei tg o sui giornali, anziché vederli esibirsi negli spettacoli di cabaret, rincoglioniscono gli elettori. Da qui il detto: un popolo di coglioni sarà sempre amministrato o governato, informato, istruito e giudicato da coglioni.
Per questo non ci lamentiamo se in Italia mai nulla cambia. E se l’Italia ancora va, ringraziamo tutti coloro che anziché essere presi per il culo, i comici e la loro clack (claque) li mandano a fanculo.
Antonio Giangrande, scrittore, accademico senza cattedra universitaria di Sociologia Storica, giornalista ed avvocato non abilitato. "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi i miei dolori, i miei dubbi, le mie risate...vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno ha la propria storia. E solo allora mi potrai giudicare." Luigi Pirandello.
Dapprima ti ignorano. Poi ti deridono. Poi ti emarginano. Poi ti combattono. Tu sei solo, ma non per sempre. Loro sono tanti, ma non per sempre. Ed allora sarai vincente, ma solo dopo la tua morte. I primi a combatterti sono i prossimi parenti ed i compaesani ed allor "non ragioniam di loro, ma guarda e passa" (Dante Alighieri). “Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi”. Mt 13, 54-58.
Se si disprezza quello che gli altri sono e fanno, perché, poi, si è come gli altri e si osteggiano i diversi?
"C’è un’azione peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino e consiste nel togliergli la voglia di votare.” (R. Sabatier)
«La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile» - Corrado Alvaro, Ultimo diario, 1961.
Vivere senza leggere, o senza sfogliare i libri giusti scritti fuori dal coro o vivere studiando dai saggi distribuiti dal sistema di potere catto comunista savoiardo nelle scuole e nelle università, è molto pericoloso. Ciò ti obbliga a credere a quello che dicono gli altri interessati al Potere e ti conforma alla massa. Allora non vivi da uomo, ma da marionetta.
Se scrivi e dici la verità con il coraggio che gli altri non hanno, il risultato non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu additato come pazzo. Ti scontri sempre con la permalosità di magistrati e giornalisti e la sornionità degli avvocati avvezzi solo ai loro interessi. Categorie di saccenti che non ammettono critiche. Se scrivi e sei del centro-nord Italia, i conterranei diranno: che bel libro, bravo, è uno di noi. Se scrivi e sei del centro-sud Italia i conterranei diranno: quel libro l’avrei scritto anch’io, anzi meglio, ma sono solo cazzate. Chi siamo noi? Siamo i “coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare. Da bambini i genitori ci educavano secondo i loro canoni, fino a che abbiamo scoperto che era solo il canone di poveri ignoranti. Da studenti i maestri ci istruivano secondo il loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che era solo il pensiero di comunisti arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano “Bella Ciao”. Da credenti i ministri di culto ci erudivano sulla confessione religiosa secondo il loro verbo, fino a che abbiamo scoperto che era solo la parola di pedofili o terroristi. Da lettori e telespettatori l’informazione (la claque del potere) ci ammaestrava all’odio per il diverso ed a credere di vivere in un paese democratico, civile ed avanzato, fino a che abbiamo scoperto che si muore di fame o detenuti in canili umani. Da elettori i legislatori ci imponevano le leggi secondo il loro diritto, fino a che abbiamo scoperto che erano solo corrotti, mafiosi e massoni. Ecco, appunto: siamo i “coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare. E se qualcuno non vuol essere “coglione” e vuol cambiare le cose, ma non ci riesce, vuol dire che è “coglione” lui e non lo sa, ovvero è circondato da amici e parenti “coglioni”.
John Keating: Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Carpe diem. Cogliete l'attimo, ragazzi... Rendete straordinaria la vostra vita!
Gerard Pitts: Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola e lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. John Keating: Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino: noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita. Dal film L'attimo fuggente (Dead Poets Society), film del 1989 diretto da Peter Weir e con protagonista Robin Williams.
Studiare non significa sapere, volere non significa potere. Ai problemi non si è capaci di trovare una soluzione che accontenti tutti, perché una soluzione per tutti non esiste. Alla fine nessuno è innocente, perché in questa società individualista, violenta e superficiale tutti sono colpevoli. Io ho preso la mia decisione mentre la totalità di voi non sa prenderne alcuna (anche nelle cose più semplici). Come potreste capire cosa è veramente importante nella vita? Non saprete mai se avete preso la decisione giusta perché non vi siete fidati di voi stessi. Accusate il sistema, ma il sistema è freddo inesorabile matematico, solo chi è deciso a raggiungere la riva la raggiungerà. Vi auguro tutto il meglio per la vostra vita. “Class Enemy”, di Rok Bicek film del 2013.
Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, destinatario delle denunce presentate dai magistrati per tacitarlo e ricevente da tutta Italia di centinaia di migliaia di richieste di aiuto o di denunce di malefatte delle istituzioni. Ignorato dai media servi del potere.
Come far buon viso a cattivo gioco ed aspettare che dal fiume appaia il corpo del tuo nemico. "Subisci e taci" ti intima il Sistema. Non sanno, loro, che la vendetta è un piatto che si gusta freddo. E non si può perdonare...
Un padre regala al figlio un sacchetto di chiodi. “Tieni figliolo, ecco un sacchetto di chiodi. Piantane uno nello steccato Ogni volta che che perdi la pazienza e litighi con qualcuno perchè credi di aver subito un'ingiustizia” gli dice. Il primo giorno il figlio piantò ben 37 chiodi ma nelle settimane successive imparò a controllarsi e il numero di chiodi cominciò piano piano a diminuire. Aveva infatti scoperto che era molto più facile controllarsi che piantare chiodi e così arrivò un giorno in cui non ne piantò nemmeno uno. Andò quindi dal padre e gli disse che per quel giorno non aveva litigato con nessuno, pur essendo stato vittima d'ingiustizie e di soprusi, e non aveva piantato alcun chiodo. Il padre allora gli disse: “Benissimo figliolo, ora leva un chiodo dallo steccato per ogni giorno in cui non hai perso la pazienza e litigato con qualcuno”. Il figlio ascoltò e tornò dal padre dopo qualche giorno, comunicandogli che aveva tolto tutti i chiodi dallo steccato e che non aveva mai più perso la pazienza. Il padre lo portò quindi davanti allo steccato e guardandolo gli disse: “Figliolo, ti sei comportato davvero bene. Bravo. Ma li vedi tutti quei buchi? Lo steccato non potrà più tornare come era prima. Quando litighi con qualcuno, o quando questi ha usato violenza fisica o psicologica nei tuoi confronti, rimane una ferita come questi buchi nello steccato. Tu puoi piantare un coltello in un uomo e poi levarlo, e lo stesso può fare questi con te, ma rimarrà sempre una ferita. E non importa quante volte ti scuserai, o lui lo farà con te, la ferita sarà sempre lì. Una ferita verbale è come il chiodo nello steccato e fa male quanto una ferita fisica. Lo steccato non sarà mai più come prima. Quando dici le cose in preda alla rabbia, o quando altri ti fanno del male, si lasciano delle ferite come queste: come i buchi nello steccato. Possono essere molto profonde. Alcune si rimarginano in fretta, altre invece, potrebbero non rimarginare mai, per quanto si possa esserne dispiaciuti e si abbia chiesto scusa".
Io non reagisco, ma mi si permetta di raccontare l'accaduto. Voglio far conoscere la verità sui chiodi piantati nelle nostre carni.
La mia esperienza e la mia competenza mi portano a pormi delle domande sulle vicende della vita presente e passata e sul perché del ripetersi di eventi provati essere dannosi all’umanità, ossia i corsi e i ricorsi storici. Gianbattista Vico, il noto filosofo napoletano vissuto fra il XVII e XVIII secolo elaborò una teoria, appunto dei corsi e ricorsi storici. Egli era convinto che la storia fosse caratterizzata dal continuo e incessante ripetersi di tre cicli distinti: l’età primitiva e divina, l’età poetica ed eroica, l’età civile e veramente umana. Il continuo ripetersi di questi cicli non avveniva per caso ma era predeterminato e regolamentato, se così si può dire, dalla provvidenza. Questa formulazione di pensiero è comunemente nota come “teoria dei corsi e dei ricorsi storici”. In parole povere, tanto per non essere troppo criptici, il Vico sosteneva che alcuni accadimenti si ripetevano con le medesime modalità, anche a distanza di tanto tempo; e ciò avveniva non per puro caso ma in base ad un preciso disegno stilato della divina provvidenza.” Io sono convinto, invece, che l’umanità dimentica e tende a sbagliare indotta dalla stupidità e dall’egoismo di soddisfare in ogni modo totalmente i propri bisogni in tempi e spazi con risorse limitate. Trovare il perché delle discrepanze dell’ovvio raccontato. Alle mie domando non mi do io stesso delle risposte. Le risposte le raccolgo da chi sento essere migliore di me e comunque tra coloro contrapposti con le loro idee sullo stesso tema da cui estrapolare il sunto significativo. Tutti coloro che scrivono, raccontano il fatto secondo il loro modo di vedere e lo ergono a verità. Ergo: stesso fatto, tanti scrittori, quindi, tanti fatti diversi. La mia unicità e peculiarità, con la credibilità e l’ostracismo che ne discende, sta nel raccontare quel fatto in un’unica sede e riportando i vari punti di vista. In questo modo svelo le mistificazioni e lascio solo al lettore l’arbitrio di trarne la verità da quei dati.
Voglio conoscere gli effetti, sì, ma anche le cause degli accadimenti: il post e l’ante. La prospettiva e la retrospettiva con varie angolazioni. Affrontare le tre dimensioni spaziali e la quarta dimensione temporale.
Si può competere con l’intelligenza, mai con l’idiozia. L’intelligenza ascolta, comprende e pur non condividendo rispetta. L’idiozia si dimena nell’Ego, pretende ragione non ascoltando le ragioni altrui e non guarda oltre la sua convinzione dettata dall’ignoranza. L’idiozia non conosce rispetto, se non pretenderlo per se stessa.
Quando fai qualcosa hai tutti contro: quelli che volevano fare la stessa cosa, senza riuscirci, impediti da viltà, incapacità, ignavia; quelli che volevano fare il contrario; e quelli, ossia la stragrande maggioranza, che non volevano fare niente.
Certe persone non sono importanti, siamo noi che, sbagliando, gli diamo importanza. E poi ci sono quelle persone che non servono ad un cazzo, non fanno un cazzo e si credono sto cazzo.
Correggi un sapiente ed esso diventerà più colto. Correggi un ignorante ed esso diventerà un tuo acerrimo nemico.
Molti non ti odiano perché gli hai fatto del male, ma perché sei migliore di loro.
Più stupido di chi ti giudica senza sapere nulla di te è colui il quale ti giudica per quello che gli altri dicono di te. Perché le grandi menti parlano di idee; le menti medie parlano di fatti; le infime menti parlano solo male delle persone.
E’ importante stare a posto con la propria coscienza, che è molto più importante della propria reputazione. La tua coscienza sei tu, la reputazione è ciò che gli altri pensano di te e quello che gli altri pensano di te è un problema loro.
Le bugie sono create dagli invidiosi, ripetute dai cretini e credute dagli idioti, perché un grammo di comportamento esemplare, vale un quintale di parole. Le menti mediocri condannano sempre ciò che non riescono a capire.
E se la strada è in salita, è solo perché sei destinato ad arrivare in alto.
Ci sono persone per indole nate per lavorare e/o combattere. Da loro ci si aspetta tanto ed ai risultati non corrispondono elogi. Ci sono persone nate per oziare. Da loro non ci si aspetta niente. Se fanno poco sono sommersi di complimenti. Guai ad aspettare le lodi del mondo. Il mondo è un cattivo pagatore e quando paga lo fa sempre con l’ingratitudine.
Il ciclo vitale biologico della natura afferma che si nasce, si cresce, ci si riproduce, si invecchia e si muore e l’evoluzione fa vincere i migliori. Solo a noi umani è dato dare un senso alla propria vita.
Ergo. Ai miei figli ho insegnato:
Le ideologie, le confessioni, le massonerie vi vogliono ignoranti;
Le mafie, le lobbies e le caste vi vogliono assoggettati;
Le banche vi vogliono falliti;
La burocrazia vi vuole sottomessi;
La giustizia vi vuole prigionieri;
Siete nati originali…non morite fotocopia.
Siate liberi. Studiare, ma non fermarsi alla cultura omologata. La conoscenza è l'arma migliore per vincere.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
Lettera ad un amico che ha tentato la morte.
Le difficoltà rinforzano il carattere e certo quello che tu eri, oggi non lo sei.
Le difficoltà le affrontano tutti in modi diversi, come dire: in ogni casa c’è una croce. L’importante portarla con dignità. E la forza data per la soluzione è proporzionale all’intelligenza.
Per cui: x grado di difficoltà = x grado di intelligenza.
Pensa che io volevo studiare per emergere dalla mediocrità, ma la mia famiglia non poteva.
Per poter studiare dovevo lavorare. Ma lavoro sicuro non ne avevo.
Per avere un lavoro sicuro dovevo vincere un concorso pubblico, che lo vincono solo i raccomandati.
Ho partecipato a decine di concorsi pubblici: nulla di fatto.
Nel “mezzo del cammin della mia vita”, a trentadue anni, avevo una moglie e due figli ed una passione da soddisfare.
La mia vita era in declino e le sconfitte numerose: speranza per il futuro zero!
Ho pensato ai miei figli e si è acceso un fuoco. Non dovevano soffrire anche loro.
Le difficoltà si affrontano con intelligenza: se non ce l’hai, la sviluppi.
Mi diplomo in un anno presso la scuola pubblica da privatista: caso unico.
Mi laureo alla Statale di Milano in giurisprudenza in due anni: caso raro.
Sembrava fatta, invece 17 anni per abilitarmi all’avvocatura senza successo per ritorsione di chi non accetta i diversi. Condannato all’indigenza e al discredito, per ritorsione dei magistrati e dei media a causa del mio essere diverso.
Mio figlio ce l’ha fatta ad abilitarsi a 25 anni con due lauree, ma è impedito all’esercizio a causa del mio disonore.
Lui aiuta gli altri nello studio a superare le incapacità dei docenti ad insegnare.
Io aiuto gli altri, con i miei saggi, ad essere orgogliosi di essere diversi ed a capire la realtà che li circonda.
Dalla mia esperienza posso dire che Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi o valutazioni lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
Per questo un popolo di coglioni sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da coglioni.
Quindi, caro amico, non guardare più indietro. Guarda avanti. Non pensare a quello che ti manca o alle difficoltà che incontri, ma concentrati su quello che vuoi ottenere. Se non lasci opere che restano, tutti di te si dimenticano, a prescindere da chi eri in vita.
Pensa che più difficoltà ci sono, più forte diventerai per superarle.
Volere è potere.
E sii orgoglioso di essere diverso, perché quello che tu hai fatto, tentare la morte, non è segno di debolezza. Ma di coraggio.
Le menti più eccelse hanno tentato o pensato alla morte. Quella è roba da diversi. Perché? Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Per questo bisogna vivere, se lo hai capito: per ribellione e per rivalsa!
Non si deve riporre in me speranze mal riposte.
Io posso dare solidarietà o prestare i miei occhi per leggere o le mie orecchie per sentire, ma cosa posso fare per gli altri, che non son stato capace di fare per me stesso?
Nessuno ha il potere di cambiare il mondo, perché il mondo non vuol essere cambiato.
Ho solo il potere di scrivere, senza veli ideologici o religiosi, quel che vedo e sento intorno a me. E’ un esercizio assolutamente soggettivo, che, d’altronde, non mi basta nemmeno a darmi da vivere.
E’ un lavoro per i posteri, senza remunerazione immediata.
Essere diversi significa anche essere da soli: senza un gruppo di amici sinceri o una claque che ti sostenga.
Il fine dei diversi non combacia con la meta della massa. La storia dimostra che è tutto un déjà-vu.
Tante volte ho risposto no ai cercatori di biografie personali, o ai sostenitori di battaglie personali. Tante volte, portatori delle loro bandiere, volevano eserciti per lotte personali, elevandosi a grado di generali.
La mia missione non è dimostrare il mio talento o le mie virtù rispetto agli altri, ma documentare quanto questi altri siano niente in confronto a quello che loro considerano di se stessi.
Quindi ritienimi un amico che sa ascoltare e capire, ma che nulla può fare o dare ad altri, perché nulla può fare o dare per se stesso.
Sono solo un Uomo che scrive e viene letto, ma sono un uomo senza Potere.
Dell’uomo saggio e giusto si segue l’esempio, non i consigli.
Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.
Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da “coglioni”.
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Il ciclo vitale, in biologia, è l'intervallo tra il susseguirsi di generazioni di una specie. L'esistenza di ogni organismo si svolge secondo una sequenza ciclica di stadi ed eventi biologici, caratterizzata in base alla specie di appartenenza. Queste sequenze costituiscono i cosiddetti Cicli Biologici. Ogni essere vivente segue un ciclo vitale biologico composto dai seguenti stadi: nascita, crescita, riproduzione, senescenza e morte. Per quanto possa essere breve o corta la vita, nessun essere vivente preso singolarmente è immortale. Ma la sua specie diventa immortale attraverso la riproduzione e l'evoluzione. Gli esseri viventi si evolvono nel corso del tempo per potersi meglio adattare alla natura che li circonda. Attraverso la riproduzione le generazioni trasmettono i propri geni a quelle future. Durante questo passaggio le nuove generazioni possono assumere caratteristiche nuove o perderne alcune. Le differenze si traducono in vantaggi o in handicap per chi le possiede, agendo direttamente sul processo evolutivo tramite la selezione naturale degli individui. Le nuove caratteristiche che agevolano l'adattamento all'ambiente offrono all'individuo maggiori probabilità di sopravvivenza e, quindi, di riproduzione. E' innaturale non riprodursi. Senza riproduzione non vi è proseguimento ed evoluzione della specie. Senza riproduzione il ciclo vitale biologico cessa. Ciò ci rende mortali. Parlare in termini scientifici dell'eterosessualità e del parto, quindi di stati naturali, fa di me un omofobo ed un contrabortista, quindi un non-comunista? Cercare di informare i simili contro la deriva involutiva, fa di me un mitomane o pazzo?
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi, vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di mitomania, pazzia o calunnia, oltre che nel disinteresse. Invece parlo di loro, delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di loro stessi e se ne fottono degli altri.
Alla fine di noi rimane il nostro operato, checché gli altri ne dicano. E quello bisogna giudicare. Nasco da una famiglia umile e povera. Una di quelle famiglie dove la sfortuna è di casa. Non puoi permetterti di studiare, né avere amici che contano. Per questo il povero è destinato a fare il manovale o il contadino. Mi sono ribellato e contro la sorte ho voluto studiare, per salire nel mondo non mio. Per 17 anni ho cercato di abilitarmi nell’avvocatura. Non mi hanno voluto. Il mondo di sotto mi tiene per i piedi; il mondo di sopra mi calca la testa. In un esame truccato come truccati sono tutti i concorsi pubblici in Italia: ti abilitano se non rompi le palle. Tutti uguali nella mediocrità. Dal 1998 ho partecipato all’esame forense annuale. Sempre bocciato. Ho rinunciato a proseguire nel 2014 con la commissione presieduta dall’avv. Francesco De Jaco. L’avvocato di Cosima Serrano condannata con la figlia Sabrina Misseri per il delitto di Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana. Tutte mie compaesane. La Commissione d’esame di avvocato di Lecce 2014. La più serena che io abbia trovato in tutti questi anni. Ho chiesto invano a De Jaco di tutelare me, dagli abusi in quell’esame, come tutti quelli come me che non hanno voce. Se per lui Cosima è innocente contro il sentire comune, indotti a pensarla così dai media e dai magistrati, perché non vale per me la verità che sia vittima di un sistema che mi vuol punire per essermi ribellato? Si nega l’evidenza. 1, 2, 3 anni, passi. 17 anni son troppi anche per il più deficiente dei candidati. Ma gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Compiti non corretti, ma ritenuti tali in tempi insufficienti e senza motivazione e con quote prestabilite di abilitati. Così per me, così per tutti. Gli avvocati abilitati negano l’evidenza. Logico: chi passa, non controlla. Ma 17 anni son troppi per credere alla casualità di essere uno sfigato, specialmente perché i nemici son noti, specie se sono nelle commissioni d’esame. In carcere o disoccupato. Tu puoi gridare a squarciagola le ingiustizie, ma nessuno ti ascolta, in un mondo di sordi. Nessuno ti crede. Fino a che non capiti a loro. E in questa Italia capita, eccome se capita! La tua verità contro la verità del potere. Un esempio da raccontare. Ai figli non bisogna chiedere cosa vogliono fare da grandi. Bisogna dir loro la verità. Chiedergli cosa vorrebbero che gli permettessero di fare da grandi. Sono nato in quelle famiglie che, se ti capita di incappare nelle maglie della giustizia, la galera te la fai, anche da innocente. A me non è successo di andare in galera, pur con reiterati tentativi vani da parte della magistratura di Taranto, ma sin dal caso Tortora ho capito che in questa Italia in fatto di giustizia qualcosa non va. Pensavo di essere di sinistra, perché la sinistra è garantismo, ma non mi ritrovo in un’area dove si tollerano gli abusi dei magistrati per garantirsi potere ed impunità. E di tutto questo bisogna tacere. A Taranto, tra i tanti processi farsa per tacitarmi sulle malefatte dei magistrati, uno si è chiuso, con sentenza del Tribunale n. 147/2014, con l’assoluzione perché il fatto non sussiste e per non doversi procedere. Bene: per lo stesso fatto si è riaperto un nuovo procedimento ed è stato emesso un decreto penale di condanna con decreto del Gip. n. 1090/2014: ossia una condanna senza processo. Tentativo stoppato dall’opposizione.
Zittirmi sia mai. Pur isolato e perseguitato. Gli italiani son questi. Ognuno dia la sua definizione. Certo è che gli italiani non mi leggono, mi leggono i forestieri. Mi leggeranno i posteri. Tutto regolare: lo ha detto la tv, lo dicono i giudici. Per me, invece, è tutto un trucco. In un mondo di ladri nessuno vien da Marte. Tutti uguali: giudicanti e giudicati. E’ da decenni che studio il sistema Italia, a carattere locale come a livello nazionale. Da queste indagini ne sono scaturiti decine di saggi, raccolti in una collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", letti in tutto il mondo, ma che mi sono valsi l’ostruzionismo dei media nazionali. Pennivendoli venduti ai magistrati, all’economia ed alla politica, ma che non impediscono il fatto che di me si parli su 200.000 siti web, come accertato dai motori di ricerca. Book ed E-Book che si possono trovare su Amazon.it, Lulu.com. CreateSpace.com e Google Libri, oltre che in forma di lettura gratuita e free vision video su www.controtuttelemafie.it , mentre la promozione del territorio è su www.telewebitalia.eu.
Ho la preparazione professionale per poter dire la sua in questioni di giustizia?
Non sono un giornalista, ma a quanto pare sono l’unico a raccontare tutti i fatti. Non sono un avvocato ma mi diletto ad evidenziare le manchevolezze di un sistema giudiziario a se stante. La mia emigrazione in piena adolescenza in Germania a 16 anni per lavorare; la mia laurea quadriennale in Giurisprudenza presa in soli due anni all’Università Statale di Milano, lavorando di notte e con moglie e due figli da mantenere, dopo aver conseguito il diploma da ragioniere in un solo anno da privatista presso un Istituto tecnico Statale e non privato, per non sminuirne l’importanza, portando tutti i 5 anni di corso; tutto ciò mi ha reso immune da ogni condizionamento culturale od ambientale. I miei 6 anni di esercizio del patrocinio legale mi hanno fatto conoscere le magagne di un sistema che non è riuscito a corrompermi. Per questo dal 1998 al 2014 non mi hanno abilitato alla professione di avvocato in un esame di Stato, che come tutti i concorsi pubblici ho provato, con le mie ricerche ed i miei libri, essere tutti truccati. Non mi abilitano. Perché non sono uguale agli altri, non perché son meno capace. Non mi abilitano perché vedo, sento e parlo. Ecco perché posso parlare di cose giuridiche in modo di assoluta libertà, senza condizionamento corporativistico, anche a certezza di ritorsione. E’ tutta questione di coscienza.
Alle sentenze irrevocabili di proscioglimento del Tribunale di Taranto a carico del dr Antonio Giangrande, già di competenza della dr.ssa Rita Romano, giudice di Taranto poi ricusata perché denunciata, si aggiunge il verbale di udienza dell’11 dicembre 2015 della causa n. 987/09 (1832/07 RGNR) del Tribunale di Potenza, competente su fatti attinenti i magistrati di Taranto, con il quale si dispone la perfezione della fattispecie estintiva del processo per remissione della querela nei confronti del dr Antonio Giangrande da parte del dr. Alessio Coccioli, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, poi trasferito alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Remissione della querela volontaria, libera e non condizionata da alcun atto risarcitorio.
Il Dr Antonio Giangrande era inputato per il reato previsto e punito dall’art. 595 3° comma c.p. “perchè inviando una missiva a sua firma alla testata giornalistica La Gazzetta del Sud Africa e pubblicata sui siti internet lagazzettadelsudafrica.net, malagiustizia.eu, e associazionecontrotuttelemafie.org, offendeva l’onore ed il decoro del dr. Alessio Coccioli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, riportando in detto su scritto la seguente frase: “…il PM Alessio Coccioli, inopportunamente delegando i carabinieri di Manduria, quali PG, ha reso lecito tale modus operandi (non rilasciare attestato di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria ndr), motivandolo dal fatto che non è dannoso per il denunciante. Invece in denuncia si è fatto notare che tale usanza di recepimento degli atti, prettamente manduriana, può nascondere alterazioni procedurali in ambito concorsuale e certamente abusi a danno dei cittadini. Lo stesso PM Alessio Coccioli, inopportunamente delegando i carabinieri di Manduria, quali PG, per la colleganza con il comandante dei Vigili Urbani di Manduria, ha ritenuto le propalazioni del Giangrande, circa il concorso per Comandante dei Vigili Urbani, ritenuto truccato (perché il medesimo aveva partecipato e vinto in un concorso da egli stesso indetto e regolato in qualità di comandante pro tempore e dirigente dell’ufficio del personale), sono frutto di sue convinzioni non supportate da riscontri di natura obbiettiva e facendo conseguire tali riferimenti, al predetto dr. Coccioli, ad altre notazioni, contenute nello stesso scritto, nelle quali si denunciavano insabbiamenti, o poche richieste di archiviazioni strumentali attribuite ai magistrati della Procura della Repubblica di Taranto”.
Il Processo di Potenza, come i processi tenuti a Taranto, sono attinenti a reati di opinione. Lo stesso dr. Alessio Coccioli, una volta trasferito a Lecce, ha ritenuto che le opinioni espresse dal Dr Antonio Giangrande riguardo la Giustizia a Taranto non potessero continuare ad essere perseguite.
Ultimo atto. Esame di Avvocato 2015. A Lecce uno su quattro ce l’ha fatta. Sono partiti in 1.108: la prova scritta è stata passata da 275 praticanti. Preso atto.....
All'attenzione dell'avv. Francesco De Jaco. Illustre avv. Francesco De Jaco, in qualità di Presidente della Commissione di Esame di Avvocato 2014-2015, chi le scrive è il dr Antonio Giangrande. E’ quel signore, attempato per i suoi 52 anni e ormai fuori luogo in mezzo ai giovani candidati, che in sede di esame le chiese, inopinatamente ed invano, Tutela. Tutela, non raccomandazione. Così come nel 2002 fu fatto inutilmente con l’avv. Luigi Rella, presidente di commissione e degli avvocati di Lecce. Tutela perché quel signore il suo futuro lo ha sprecato nel suo passato. Ostinatamente nel voler diventare avvocato ha perso le migliori occasioni che la vita possa dare. Aspettava come tutti che una abilitazione, alla mediocrità come è l’esame forense truccato, potesse, prima o poi, premiare anche lui. Pecori e porci sì, lui no! Quel signore ha aspettato ben 17 anni per, finalmente, dire basta. Gridare allo scandalo per un esame di Stato irregolare non si può. Gridare al complotto contro la persona…e chi gli crede. Eppure a Lecce c’è qualcuno che dice: “quello lì, l’avvocato non lo deve fare”. Qualcuno che da 17 anni, infastidito dal mio legittimo operato anche contro i magistrati, ha i tentacoli tanto lunghi da arrivare ovunque per potermi nuocere. Chi afferma ciò è colui il quale dimostra con i fatti nei suoi libri, ciò che, agli ignoranti o a chi è in mala fede, pare frutto di mitomania o pazzia. Guardi, la sua presidenza, in sede di scritto, è stata la migliore tra le 17 da me conosciute. Purtroppo, però, in quel di Brescia quel che si temeva si è confermato. Brescia, dove, addirittura, l’ex Ministro Mariastella Gelmini chiese scampo, rifugiandosi a Reggio Calabria per poter diventare avvocato. Il mio risultato delle prove fa sì che chiuda la fase della mia vita di aspirazione forense in bruttezza. 18, 18, 20. Mai risultato fu più nefasto e, credo, immeritato e punitivo. Sicuro, però, che tale giudizio non è solo farina del sacco della Commissione di esame di Brescia. Lo zampino di qualche leccese c’è! Avvocato… o magistrato… o entrambi…: chissà? Non la tedio oltre. Ho tentato di trovare Tutela, non l’ho trovata. Forse chiedevo troppo. Marcire in carcere da innocente o pagare fio in termini professionali, credo che convenga la seconda ipotesi. Questo è quel che pago nel mettermi contro i poteri forti istituzionali, che io chiamo mafiosi. Avvocato, grazie per il tempo che mi ha dedicato. Le tolgo il disturbo e, nel caso l’importasse, non si meravigli, se, in occasione di incontri pubblici, se e quando ci saranno, la priverò del mio saluto. Con ossequi.
Avetrana lì 26 giugno 2015. Dr Antonio Giangrande, scrittore per necessità.
E’ da scuola l’esempio della correzione dei compiti in magistratura, così come dimostrato, primo tra tutti gli altri, dall’avv. Pierpaolo Berardi, candidato bocciato. Elaborati non visionati, ma dichiarati corretti. L’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati. Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio. Risultato: un buco nell'acqua. Questi magistrati, nel frattempo diventati dei, esercitano. Esperienza diretta dell'avvocato Giovanni Di Nardo che ha scoperto temi pieni di errori di ortografia giudicati idonei alle prove scritte del concorso in magistratura indetto nel 2013 le cui prove si sono tenute nel Giugno del 2014. Se trovate che sia vergognoso condividete il più possibile, non c'è altro da fare.
Caso Bellomo, le forti parole di Filippo Facci dopo le testimonianze delle allieve, scrive robertogp il 28/12/2017 su "NewNotizie.it". Come redazione di ‘NewNotizie.it‘ abbiamo preferito non parlare della pietosa vicenda riguardante il consigliere di Stato Francesco Bellomo, il quale si trova adesso indagato dalla procura di Bari, Milano e Piacenza per estorsione, atti persecutori e lesioni gravi. In breve, Francesco Bellomo, consigliere di Stato nonché magistrato, conduceva dei corsi volti ad affrontare al meglio l’esame di accesso alla magistratura; l’accusa rivoltagli negli ultimi giorni si precisa in diverse testimonianze di allieve o ex allieve che accusano l’uomo di alcune clausole molto particolari presenti nel contratto d’iscrizione ai suoi corsi. Veniva ad esempio richiesto alle studentesse di recarsi al corso truccate, con tacchi alti, minigonna e altre peculiarità espresse nel dettaglio all’interno del contratto. Altre bizzarre clausole erano presenti nel foglio da firmare, quali ad esempio che il fidanzamento del o della borsista era consentito solo in seguito all’approvazione personale di Bellomo o addirittura la revoca della borsa di studio in caso di matrimonio. Filippo Facci, giornalista di ‘Libero Quotidiano‘ ha espresso il suo parere riguardo la vicenda sostenendo che le allieve che hanno sporto denuncia abbiano “una fisiologica propensione a essere zoccole (auguri per qualsiasi carriera) oppure siano troppo stordita per poter fare il mestiere del magistrato”. Seppur i toni siano decisamente sopra le righe, Facci spiega con tre motivazioni il perché di una frase così forte: “Il corso di Bellomo era un corso non obbligatorio per affrontare l’ esame per magistrato; i contratti di Bellomo erano palesemente nulli, perché nessun contratto può imporre pretese del genere, e per saperlo basta non essere scemi e infine, alcuni contratti venivano firmati da borsiste che avevano accettato una relazione sessuale con Bellomo, approccio che ci è difficile pensare spontaneo e slegato ai buoni esiti del corso”. Facci ricorda infine che “l’ingresso in magistratura non prevede esami psico-attitudinali”. Mario Barba
Filippo Facci per Libero Quotidiano il 28 dicembre 2017. I dettagli su quanto il consigliere Francesco Bellomo sia porco (copyright Enrico Mentana) li trovate in un altro articolo, e così pure gli aggiornamenti sui «contratti di schiavitù sessuale» (copyright Liana Milella, Repubblica) che imponeva a qualche allieva. Ciò posto, scusate: 1) il corso di Bellomo era un corso non obbligatorio per affrontare l'esame per magistrato; 2) i contratti di Bellomo erano palesemente nulli, perché nessun contratto può imporre pretese del genere, e per saperlo basta non essere scemi; 3) alcuni contratti venivano firmati da borsiste che avevano accettato una relazione sessuale con Bellomo, approccio che ci è difficile pensare spontaneo e slegato ai buoni esiti del corso. Detto questo, insomma: una che accetta di vestirsi in un certo modo, e così truccarsi, e i tacchi e le calze, una che accetta clausole che vietavano i matrimoni e condizionavano i fidanzamenti e autorizzavano a mettere in rete ogni dettaglio sessuale, una che crede che altrimenti avrebbe pagato 100mila euro di penale, beh, una così ha una fisiologica propensione a essere zoccola (auguri per qualsiasi carriera) oppure è troppo stordita per poter fare il mestiere del magistrato: troppo facile da circonvenire o corrompere, comunque sprovvista dell' equilibrio necessario a decidere della vita altrui. Lo diciamo non solo perché l'ingresso in magistratura non prevede esami psico-attitudinali, ma perché molte borsiste di Bellomo, magistrati, anzi magistrate, lo sono già diventate.
Concorsi Pubblici ed abilitazioni Truccati. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.
CUORI, TRUFFE E MAZZETTE: È LA FARSA “CONCORSONI”, scrive Virginia Della Sala su "Il Fatto Quotidiano" il 15 agosto 2016. Erano in 6mila per 340 posti. Luglio 2015, concorso in magistratura, prova scritta. Passano in 368. Come in tutti i concorsi, gli altri sono esclusi. Stavolta però qualcosa va diversamente. “Appena ci sono stati comunicati i risultati, a marzo di quest’anno, abbiamo deciso di fare la richiesta di accesso agli atti. Abbiamo preteso di poter visionare non solo i nostri compiti ma anche quelli di tutti i concorrenti risultati idonei allo scritto”, spiega uno dei concorrenti, Lugi R. Milleduecento elaborati, scansionati e inviati tramite mail in un mese. Per richiederli, i candidati hanno dovuto acquistare una marca da bollo da 600 euro. Hanno optato per la colletta: 230 persone hanno pagato circa 3 euro a testa per capire come mai non avessero passato quel concorso che credevano fosse andato bene. E, soprattutto, per verificare cosa avessero di diverso i loro compiti da quelli di chi il concorso lo aveva superato. “Ci siamo accorti che su diversi compiti compaiono segni di riconoscimento: sottolineature, cancellature, strani simboli, schemi”. Anche il Fatto ha potuto visionarli: asterischi, note a piè di pagina, cancellature, freccette. In uno si contano almeno due cuoricini. In un altro, il candidato ha disegnato una stellina. “Ora non c’è molto che possiamo fare per opporci a questi risultati – spiega Luigi – visto che sono scaduti i termini per ricorrere al Tar. Inoltre, molti di noi stanno tentando di nuovo il concorso quest’anno. Ecco perché preferiamo non esporci molto mediaticamente”.
IL RAPPORTO DI BANKITALIA. Eppure, decine di sentenze dimostrano come sia possibile richiedere l’annullamento anche per un solo puntino. “Cancellature, scarabocchi, codici alfanumerici. Decisamente un cuoricino è un segno distintivo per cui può essere sollecitata l’amministrazione – spiega l’avvocato Michele Bonetti –. Qui si parla di un concorso esteso. Ma mi è capitato di assistere persone che partecipavano a un concorso in cui, dei cinque candidati, c’era solo un uomo. Capirà che la grafia di un uomo è facilmente riconoscibile come tale”. Al di là delle scorrettezze, una ricerca della Banca d’Italia pubblicata qualche giorno fa ha dimostrato che in Italia, i concorsi pubblici non funzionano. O, per dirlo con le parole dei quattro economisti autori del dossier Incentivi e selezione nel pubblico impiego (Cristina Giorgiantonio, Tommaso Orlando, Giuliana Palumbo e Lucia Rizzica), “i concorsi non sembrano adeguatamente favorire l’ingresso dei candidati migliori e con il profilo più indicato”. Si parla di bandi frammentati a livello locale, di troppe differenze metodologiche tra le varie gare, di affanno nella gestione coordinata a livello nazionale. Tra il 2001 e il 2015, ad esempio, Regioni ed Enti locali hanno bandito quasi 19mila concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una media di meno di due posizioni disponibili per concorso. Macchinoso anche il metodo: “Prove scritte e orali, prevalentemente volte a testare conoscenze teorico-nozionistiche” si legge nel paper. Ogni concorrente studia in media cinque mesi e oltre il 45 per cento dei partecipanti rinuncia a lavorare. Così, se si considera che solo nel 2014, 280mila individui hanno fatto domanda per partecipare a una selezione pubblica, si stima che il costo opportunità per il Paese è di circa 1,4 miliardi di euro l’anno. La conseguenza è che partecipa solo chi se lo può permettere e chi ha più tempo libero per studiare. Anche perché si preferisce la prevalenza di quesiti “nozionistici” che però rischiano di “inibire la capacità dei responsabili dell’organizzazione di valutare il possesso, da parte dei candidati, di caratteristiche pur rilevanti per le mansioni che saranno loro affidate, quali le ambizioni di carriera e la motivazione intrinseca”. A tutto questo si aggiungono l’eccesso delle liste degli idonei – il loro smaltimento determina “l’irregolarità della cadenza” dei concorsi e quindi l’incertezza e l’incostanza dell’uscita dei bandi, dice il dossier.
LA BEFFA SICILIANA. Palermo, concorsone scuola per la classe di sostegno nelle medie. Quest’anno, forse per garantire l’anonimato e l’efficienza, il concorso è stato computer based: domande e risposte al pc. Poi, tutto salvato su una penna usb con l’attribuzione di un codice a garanzia dell’anonimato. Eppure, la settimana scorsa i 32 candidati che hanno svolto la prova all’istituto Pio La Torre a fine maggio sono stati riconvocati nella sede. Dovevano indicare e ricordarsi dove fossero seduti il giorno dell’esame perché, a quanto pare, erano stati smarriti i documenti che avrebbero permesso di abbinare i loro compiti al loro nome. “È assurdo – commenta uno dei docenti – sembra una barzelletta: dovremmo fare ricorso tutti insieme, unirci e costringere una volta per tutte il Miur ad ammettere che forse non si era ancora pronti per questa svolta digitale”.
IL VOTO SUL COMPITO CHE NON È MAI STATO FATTO. Maria Teresa Muzzi è invece una docente che si era iscritta al concorso nel Lazio ma poi aveva deciso di non parteciparvi. Eppure, il 2 agosto, ha ricevuto la convocazione per la prova orale per la classe di concorso di lettere e, addirittura, un voto per uno scritto che però non ha mai fatto: 30,4. Avrebbe potuto andare a fare l’orale con la carta d’identità e ottenere una cattedra, mentre il legittimo concorrente avrebbe perso la sua chance di cambiare vita. Ha deciso di non farlo e ancora si attende la risposta dell’ufficio scolastico regionale che spieghi come sia stato possibile un errore del genere. In Liguria per la classe di concorso di sostegno nella scuola secondaria di I grado, l’ufficio scolastico regionale ha disposto la revoca della nomina della Commissione giudicatrice e l’annullamento di tutti i suoi atti perché sarebbero emersi “errori che possono influire sull’esito degli atti e delle operazioni concorsuali”. I candidati ancora attendono di avere nuovi esiti delle prove svolte. E, va ricordato, la correzione dei compiti a risposta aperta nei concorsi pubblici ha una forte componente discrezionale. “Ogni concorso pubblico ha margini di errore ed è perfettibile – spiega Bonetti –. In Italia, però, di lacune ce ne sono troppe e alcune sono strutturali al tipo di prova che si sceglie di far svolgere. L’irregolarità vera è propria, invece, riguarda le scelte politiche che, se arbitrarie e ingiuste, sono sindacabili”.
LE BUSTARELLE DI NAPOLI. Il problema è che si alza sempre più la soglia di accesso in nome della meritocrazia, ma si continuano a lasciare scoperti posti che invece servirebbe coprire. Favorendo così le chiamate dirette e i contratti precari. “Dalla scuola al ministero degli esteri all’autority delle telecomunicazioni – spiega Bonetti. La scelta politica è ancora più evidente nel settore della sanità: ci sono meccanismi di chiusura già nel mondo universitario. Oggi il corso di medicina è previsto per 10mila studenti in tutta Italia mentre le statistiche Crui dal 1990 hanno sempre registrato una media di 130mila immatricolati. Sono restrizioni con un’ideologia. Una volta entrati, ad esempio, c’è prima un altro concorso per la scuola di specializzazione e poi ancora un concorso pubblico che però è per 5mila persone. E gli altri? Attendono e alimentano il settore privato, che colma le lacune del sistema pubblico. O sono chiamati come collaboratori, con forme contrattuali che vanno dalla partita iva allo stage”. Nelle settimane scorse, il Fatto Quotidiano ha raccontato dell’algoritmo ritrovato dalla Guardia di Finanza di Napoli che avrebbe consentito ai partecipanti di rispondere in modo corretto ai quiz di accesso per un concorso. Ad averlo, uno degli indagati di un’inchiesta sui concorsi truccati per accedere all’Esercito. Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha ritrovato 100mila euro in contanti, buste con elenchi di nomi (forse i clienti) e un tariffario: il prezzo per superare i concorsi diviso “a pacchetti”, a seconda dell’esame e del corpo al quale accedere (esercito, polizia, carabinieri). La tariffa di 50.000 euro sarebbe relativa al “pacchetto completo”: dai test fisici fino ai quiz e alle prove orali. Solo 20.000 euro, invece, per chi si affidava ai mediatori dopo aver superato le prove fisiche. Uno sconto consistente. Tutto è partito da una soffiata: un ragazzo al quale avevano fatto la proposta indecente, ha rifiutato e ha denunciato. Un altro pure ha detto no, ma senza denunciare. Virginia Della Sala, il Fatto Quotidiano 15/8/2016.
Concorsi truccati all’università, chi controlla il controllore? Scrive Alessio Liberati il 27 settembre 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Sta avendo una grande eco in questi giorni l’inchiesta sui concorsi truccati all’università, ove, come la scoperta dell’acqua calda verrebbe da dire, la procura di Firenze ha individuato una sorta di “cupola” che decideva carriere e futuro dei professori italiani. La cosiddetta “raccomandazione” o “spintarella” (una terminologia davvero impropria per un crimine tanto grave) è secondo me uno dei reati più gravi e meno puniti nel nostro ordinamento. Chi si fa raccomandare per vincere un concorso viene trattato meglio, nella considerazione sociale e giuridica (almeno di fatto) di chi ruba un portafogli. Ma chi ti soffia il posto di lavoro o una progressione in carriera è peggio di un ladro qualunque: è un ladro che il portafogli te lo ruba ogni mese, per sempre. Gli effetti di delitti come questo, in sostanza, sono permanenti.
Ma come si è arrivati a ciò? Va chiarito che il sistema giuridico italiano prevede due distinti piani su cui operare: quello amministrativo e quello penale. Di quest’ultimo ogni tanto si ha notizia, nei (rari) casi in cui si riesce a scoperchiare il marcio che si cela dietro ai concorsi pubblici italiani. Di quello relativo alla giustizia amministrativa si parla invece molto meno. Ma tale organo è davvero in grado di assicurare il rispetto delle regole quando si fa ricorso?
Personalmente, denuncio da anni le irregolarità che sono state commesse proprio nei concorsi per l’accesso al Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia amministrativa, proprio quell’autorità, cioè, che ha l’ultima parola su tutti i ricorsi relativi ai concorsi pubblici truccati. Basti pensare che uno dei vincitori più giovani del concorso (e quindi automaticamente destinato a una carriera ai vertici) non aveva nemmeno i titoli per partecipare. E che dire dei tempi di correzione? A volte una media di tre pagine al minuto, per leggere, correggere e valutare. E la motivazione dei risultati attribuiti? Meramente numerica e impossibile da comprendere. Tutti comportamenti, si intende, che sono in linea con i principi giurisprudenziali sanciti proprio dalla giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato.
E allora il problema dei concorsi truccati in Italia non può che partire dall’alto: si prenda atto che la giustizia amministrativa non è in grado di assicurare nemmeno la regolarità dei concorsi al proprio interno e che, quindi, non può certo esserle affidato il compito istituzionale di decidere su altri concorsi: con un altro organo giurisdizionale che sia davvero efficace nel giudicare le irregolarità dei concorsi pubblici, al punto da costituire un effettivo deterrente, si avrebbe una riduzione della illegalità cui si assiste da troppo tempo nei concorsi pubblici italiani.
Se questa è antimafia…. In Italia, con l’accusa di mafiosità, si permette l’espropriazione proletaria di Stato e la speculazione del Sistema su beni di persone che mafiose non lo sono. Persone che non sono mafiose, né sono responsabili di alcun reato, eppure sottoposte alla confisca dei beni ed alla distruzione delle loro aziende, con perdita di posti di lavoro. Azione preventiva ad ogni giudizio. Alla faccia della presunzione d’innocenza di stampo costituzionale. Interventi di antimafiosità incentrati su un ristretto ambito territoriale o di provenienza territoriale.
Questa antimafia, per mantenere il sistema, impone la delazione e la calunnia ai sodalizi antiracket ed antiusura iscritti presso le Prefetture provinciali. Per continuare a definirsi tali, ogni anno, le associazioni locali sono sottoposte a verifica. L’iscrizione all’elenco è condizionata al numero di procedimenti penali e costituzioni di parti civili attivate. L’esortazione a denunciare, anche il nulla, se possibile. Più denunce per tutti…quindi. Chi non denuncia, anche il nulla, è complice od è omertoso.
A tal fine, per non aver adempito ai requisiti di delazione, calunnia e speculazione sociale, l’Associazione Contro Tutte le Mafie ONLUS, sodalizio nazionale di promozione sociale già iscritta al n. 3/2006 presso il registro prefettizio della Prefettura di Taranto Ufficio Territoriale del Governo, il 23 settembre 2017 è stata cancellata dal suddetto registro.
I magistrati favoriscono la mafia, scrive Barbara Di il 12 novembre 2017 su "Il Giornale".
(Quando diventano magistrati con un concorso truccato, spodestando i meritevoli, e per gli effetti sentendosi dio in terra, al di sopra della legge e della morale, ndr).
Quando lasciano indifesi i cittadini davanti ai soprusi.
Quando costringono un cittadino ad un processo eterno per vedersi dichiarare di aver ragione.
Quando non si studiano le carte di un processo e danno torto a chi ha ragione.
Quando per ignoranza applicano una legge nel modo sbagliato.
Quando ritardano anni una sentenza.
Quando un creditore con una sentenza esecutiva ci mette altri anni per avere una minima parte dei soldi spettanti.
Quando un creditore è costretto ad accettare pochi soldi, maledetti e subito per evitare un lungo e costoso processo.
Quando un proprietario di una casa occupata non riesce a riottenerla.
Quando non cacciano chi occupa abusivamente una casa popolare e chi ne avrebbe diritto dorme per strada.
Quando nei tribunali amministrativi devi attendere anni per vedere annullare provvedimenti assurdi della burocrazia o avere un’inutile autorizzazione ingiustamente negata.
Quando un cittadino è costretto a oliare la burocrazia con favori e bustarelle per non attendere anni quell’inutile autorizzazione o per non subire gli assurdi provvedimenti della burocrazia.
Quando un datore di lavoro si vede annullare il licenziamento di un ladro sindacalizzato.
Quando un lavoratore è costretto ad accettare una conciliazione e una buonuscita ridicola perché non ha soldi per un processo eterno.
Quando un cittadino vede impunito il ladro che lo ha derubato.
Quando lasciano impuniti i delinquenti perché non sono cittadini.
Quando incriminano i cittadini che tentano di difendersi da soli.
Quando danno pene ridicole e mai scontate a rapinatori e violentatori.
Quando danno pene esemplari solo ai violentatori che finiscono sui giornali.
Quando lasciano impuniti violenti devastatori che mettono a ferro e fuoco una città per ideologia.
Quando non indagano sui reati che non finiscono sui giornali.
Quando indagano sui reati solo per finire sui giornali.
Quando si inventano i reati per finire sui giornali.
Quando le assoluzioni per reati mediatici sono relegate in un trafiletto sui giornali.
Quando si inventano condanne assurde per reati mediatici che finiscono puntualmente riformate in appello.
Quando indagano sui politici per ideologia.
Quando arrestano i politici per ideologia e poi li assolvono a elezioni passate.
Quando fanno cadere i governi per impedire la riforma della giustizia.
Quando fanno carriera solo per ideologia o per i processi mediatici che si sono inventati.
Quando impediscono ai bravi magistrati di far carriera perché non appartengono alla corrente giusta o lavorano lontani dalle luci dei riflettori.
Quando non indagano sui colleghi che delinquono.
Quando non puniscono i colleghi per i loro clamorosi errori giudiziari.
Quando non applicano provvedimenti disciplinari ai colleghi che meriterebbero di essere cacciati.
Quando archiviano casi di scomparsa e li riaprono per trovare un cadavere in giardino solo dopo un servizio in televisione.
Quando invocano l’obbligatorietà dell’azione penale solo per i reati mediatici e politici anche se sono privi di riscontro.
Quando si dimenticano dell’obbligatorietà dell’azione penale quando i reati sono comuni e colpiscono i cittadini.
Quando si ricordano che un mafioso è mafioso solo quando dà una testata di stampo mafioso.
Quando un cittadino per avere ciò che gli spetta finisce per rivolgersi agli scagnozzi di un boss mafioso.
Quando gli unici territori dove i cittadini non subiscono furti, violenze e soprusi sono quelli controllati dalla mafia.
Quando i cittadini sono costretti a pagare il pizzo ai mafiosi per essere protetti.
Quando non fanno l’unica cosa che dovrebbero fare: dare giustizia per proteggere loro i cittadini.
Quando per colpa dei loro errori ed orrori in Italia ormai siamo tornati alla legge del più forte.
Quando i magistrati non fanno il loro mestiere, la mafia vince perché è il più forte.
A proposito di interdittive prefettizie.
Proviamo a spiegarci. Le interdittive funzionano così: sono discrezionali. Decide il prefetto. Non c’è bisogno di una condanna penale, addirittura – nel caso ad esempio, del quale stiamo parlando – nemmeno di un avviso di garanzia o di una ipotesi di reato. Il reato non c’è, però a me tu non mi convinci. Punto e basta. Inoltre l’antimafia preventiva diventata definitiva.
Infine, l’età adulta dell’informativa antimafia? Limiti e caratteri dell’istituto secondo una ricostruzione costituzionalmente orientata, scrive Fulvio Ingaglio La Vecchia. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, sentenze 29 luglio 2016, n. 247 e 3 agosto 2016, n. 257.
Interdittive antimafia, una sentenza esemplare, scrive Maria Giovanna Cogliandro, Domenica 12/11/2017 su "La Riviera on line". Di recente il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha emesso una sentenza in cui vengono precisate le condizioni necessarie affinché l'interdittiva antimafia, figlia della cultura del sospetto portata avanti dai professionisti del rancore, non porti a un regime di polizia che metta a rischio diritti fondamentali. In questa continua corsa alla giustizia penale, figlia del populismo antimafia fatto di santoni e tromboni che, dai sottoscala di procure e prefetture, con le stimmate delle loro immacolate esistenze, sono sempre in cerca di un succoso cattivo da dare in pasto all’opinione pubblica, capita di imbattersi in una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, una sentenza di cui tutti dovrebbero avere una copia da conservare con cura nel proprio portafoglio, in mezzo ai santini e alla tessera sanitaria. La sentenza riguarda il ricorso presentato da un gruppo di imprese contro la Prefettura di Agrigento, l'Autorità nazionale Anticorruzione e il Comune di Agrigento. Le imprese in questione sono tutte state raggiunte da interdittiva antimafia. Ricordiamo che l’interdittiva antimafia permette all’amministrazione pubblica di interrompere qualsiasi rapporto contrattuale con imprese che presentano un pericolo di infiltrazione mafiosa, anche se non è stato commesso un illecito per cui titolari o dirigenti siano stati condannati. Per dichiarare l’inaffidabilità di un’impresa è sufficiente un’inchiesta in corso, una frequentazione sospetta, un socio “opaco”, una parentela pericolosa che potrebbe condizionarne le scelte, o anche solo la mera eventualità che l’impresa possa, per via indiretta, favorire la criminalità. La sentenza in questione rompe clamorosamente con questa cultura del sospetto portata avanti dai professionisti del rancore. "Benché un provvedimento interdittivo - argomentano i Giudici - possa basarsi anche su considerazioni induttive o deduttive diverse dagli “indici presuntivi”, è tuttavia necessario che le norme che conferiscono estesi poteri di accertamento ai Prefetti al fine di consentire loro di svolgere indagini efficaci e a vasto raggio, non vengano equiparate a un’autorizzazione a tralasciare di compiere indagini fondate su condotte o su elementi di fatto percepibili poiché, se con le norme in questione il Legislatore ha certamente esteso il potere prefettizio di accertamento della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, non ha affatto conferito licenza di basare le comunicazioni interdittive su semplici sospetti, intuizioni o percezioni soggettive non assistite da alcuna evidenza indiziaria". Non è quindi permesso far patire all'azienda un danno di immagine, sulla base di un fumus che non trovi riscontro nei fatti. In mancanza di condotte che facciano presumere che il titolare o il dirigente di un'azienda sia in procinto di commettere un reato (o che stia determinando le condizioni favorevoli per delinquere o per “favoreggiare” chi lo compia), non è legittimo che questi sia considerato come "soggetto socialmente pericoloso" e che debba, pertanto, sottostare a "misure di prevenzione" che vanno a incidere su diritti fondamentali. Per giustificare l'invio di una interdittiva antimafia, "non è sufficiente - proseguono i Giudici - affermare che uno o più parenti o amici del soggetto richiedente la certificazione antimafia risultano mafiosi, o vicini a soggetti mafiosi; o vicini o affiliati a cosche mafiose e/o a famiglie mafiose". Occorrerà innanzitutto precisare la ragione per la quale un soggetto viene considerato mafioso. "La pericolosità sociale di un individuo - dichiarano i Giudici - non può essere ritenuta una sua inclinazione strutturale, congenita e genetico-costitutiva (alla stregua di una infermità o patologia che si presenti - sia consentita l’espressione - "lombrosanamente evidente" o comunque percepibile mediante indagini strumentali o analisi biologiche), né può essere presunta o desunta in via automatica ed esclusiva dalla sua posizione socio-ambientale e/o dal suo bagaglio culturale; né, dunque, dalla mera appartenenza a un determinato contesto sociale o a una determinata famiglia (semprecchè, beninteso, i soggetti che ne fanno parte non costituiscano un’associazione a delinquere)". Nel provvedimento interdittivo vanno, inoltre, specificate le circostanze di tempo e di luogo in cui imprenditore e soggetto "mafioso" sono stati notati insieme; le ragioni logico-giuridiche per le quali si ritiene che si tratti non di mero incontro occasionale (o di incontri sporadici), ma di “frequentazione effettivamente rilevante", ossia di relazione periodica, duratura e costante volta a incidere sulle decisioni imprenditoriali. In poche parole, prendere il caffè con un mafioso o presunto tale non è sufficiente. Inoltre, emerge dalla sentenza, qualificare un soggetto “mafioso” sulla scorta di meri sospetti e a prescindere dall’esame concreto della sua condotta penale e della sua storia giudiziaria comporterebbe un aberrante meccanismo di estensione a catena della pericolosità "simile a quello su cui si fondava, in un non recente passato, l’inquisizione medievale che, com’è noto, fu un meccanismo di distruzione di soggetti ‘scomodi’ e non già di soggetti ‘delinquenti’; mentre il commendevole e imprescindibile scopo che il Legislatore si pone è quello di depurare la società da incrostazioni e infiltrazioni mafiose realmente inquinanti". L'interdittiva che inchioda per ipotesi non combatte la delinquenza e la criminalità ma diviene strumentale per sgomberare il campo da personaggi scomodi. "D’altro canto - concludono i giudici - se per attribuire a un soggetto la qualifica di ‘mafioso’ fosse sufficiente il mero sospetto della sua appartenenza a una famiglia a sua volta ritenuta mafiosa e se anche la qualifica riferita alla sua famiglia potesse essere attribuita sulla scorta di sospetti; e se la mera frequentazione di un presunto mafioso (ma tale considerazione vale anche per l’ipotesi di mera frequentazione di un soggetto acclaratamente mafioso) potesse determinare il ‘contagio’ della sua (reale o presunta) pericolosità, si determinerebbe una catena infinita di presunzioni atte a colpire un numero enorme di soggetti senza alcuna seria valutazione in ordine alla loro concreta vocazione criminogena. E l’effetto sarebbe l’instaurazione di un regime di polizia nel quale la compressione dei diritti dei cittadini finirebbe per dipendere dagli orientamenti culturali e dalle suggestioni ideologiche (quand’anche non dalle idee politiche) dei funzionari o, peggio, degli organi dai quali essi dipendono". Amen. Ripeto: questa è una sentenza da conservare accanto ai santini. E plastificatela, per evitare che si sgualcisca col tempo.
La strada dell'inquisizione è lastricata dalla cattiva antimafia. Una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana mette in guardia dagli abissi in cui rischiamo di sprofondare perdendo di vista i capisaldi dello Stato di diritto, scrive Rocco Todero il 29 Settembre 2017 su "Il Foglio". Nell’Italia che si è presa il vizio di accusare a sproposito la giustizia amministrativa di essere la causa della propria arretratezza economica e sociale capita di leggere una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (una sezione del Consiglio di Stato distaccata a Palermo) che dovrebbe essere mandata giù a memoria da quanti nel nostro Paese vivono facendo mostra di stellette meritocratiche (più o meno veritiere) negli uffici delle prefetture, nelle aule dei tribunali, nelle sedi delle università, nelle redazioni di molti giornali e, in ultimo, anche nelle aule del Parlamento. Da molti anni, oramai, si combatte in sede giudiziaria una battaglia sulle modalità di applicazione delle misure di prevenzione, le cosiddette informative antimafia, per mezzo delle quali l’eccessiva solerzia inquisitoria degli uffici periferici del Ministero dell’Interno cerca di realizzare quella che nel linguaggio giuridico si definisce una “tutela anticipata” del crimine, un’azione cioè volta a contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico - sociale senza che, tuttavia, si manifestino azioni delittuose vere e proprie da parte dei soggetti interdetti. Il risultato nel corso degli anni è stato abbastanza sconfortante, poiché decine di imprese individuali e società commerciali sono state colpite dall’informativa antimafia e poste, molto spesso, sotto amministrazione prefettizia sulla base di un semplice sospetto coltivato dalle forze dell’ordine. A molti, troppi, è capitato, così, di trovarsi sotto interdittiva antimafia (solo per fare alcuni esempi) a causa di un parente accusato di appartenere ad un’associazione mafiosa o per colpa di un’indagine penale per 416 bis poi sfociata nel proscioglimento o nell’assoluzione o perché una società con la quale s’intrattengono rapporti commerciali è stata a sua volta interdetta per avere stipulato contratti con altra impresa sospettata di subire infiltrazioni mafiose (si, è proprio cosi, si chiama informativa a cascata o di secondo o terzo grado: A viene interdetto perché intrattiene rapporti commerciali con B, il quale non è mafioso, ma coltiva contatti economici con C, il quale ultimo è sospettato di essere, forse, soggetto ad infiltrazioni mafiose. A pagarne le conseguenze è il soggetto A, perché l’infiltrazione mafiosa passerebbe per presunzione giudiziaria da C a B e da B ad A). Spesso i Tribunali amministrativi competenti a conoscere della legittimità delle informative antimafia emanate dalle Prefettura sono stati sin troppo indulgenti con l’Amministrazione pubblica, sacrificando l’effettività della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini sull’altare di una lotta alle infiltrazioni mafiose che risente oramai troppo della pressione atmosferica di un clima allarmistico pompato ad arte per ben altri e meno nobili fini politici. Qualche settimana fa, invece, il Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano (composto dai magistrati Carlo Deodato, Carlo Modica de Mohac, Nicola Gaviano, Giuseppe Barone e Giuseppe Verde), dovendo decidere in sede d'appello dell’ennesima informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento, ha sostanzialmente scritto un bellissimo e coraggioso saggio di cultura giuridica liberale, dimostrando che la lotta alla mafia si può ben coltivare salvaguardando i capisaldi di uno Stato di diritto liberal democratico moderno. Il Tribunale ha preso atto del fatto che per stroncare sul nascere la diffusione di alcune condotte criminose non si può fare altro che emettere “giudizi prognostici elaborati e fondati su valutazioni a contenuto probabilistico” che colpiscono soggetti in uno stadio “addirittura anteriore a quello del tentato delitto”. Ma alla pubblica amministrazione, argomentano i Giudici, non è permesso di scadere nell’arbitrio, cosicché non sarà mai sufficiente un mero “sospetto” per giustificare la limitazione delle libertà fondamentali dell’individuo. Si dovranno piuttosto documentare fatti concreti, condotte accertabili, indizi che dovranno essere allo stesso tempo gravi, precisi e concordanti. Non potranno mai essere sufficienti, continua il Tribunale, mere ipotesi e congetture e non potrà mai mancare un “fatto” concreto, materiale, da potere accertare nella sua esistenza, consistenza e rilevanza ai fini della verosimiglianza dell’infiltrazione mafiosa. Per potere affermare che l’impresa di Tizio è sospettata d'infiltrazioni mafiose, allora, non sarà sufficiente affermare che essa intrattiene rapporti con l’impresa di Caio (non mafiosa) che a sua volta, però, ha stipulato accordi con Mevio (lui si, sospettato di collusioni con la mafia), ma sarà necessario dimostrare che una qualche organizzazione mafiosa (ben individuata attraverso i soggetti che agiscono per essa, non la “mafia” genericamente intesa) stia tentando, in via diretta, d’infiltrarsi nell’azienda del primo soggetto. Il legame di parentela con un mafioso, chiariscono ancora i magistrati, non può avere alcuna rilevanza ai fini del giudizio sull’informativa antimafia se non si dimostrerà che chi è stato colpito dal provvedimento interdittivo, lui e non altri, abbia posto in essere comportamenti che possano destare allarme sociale per il loro potenziale offensivo dell’interesse pubblico, “non essendo giuridicamente e razionalmente sostenibile che il mero rapporto di parentela costituisca di per sé, indipendentemente dalla condotta, un indice sintomatico di pericolosità sociale ed un elemento prognosticamente rilevante”. La nostra non è l'epoca del medioevo, conclude il Consiglio di Giustizia Amministrativa, e l'ordinamento giuridico non può svestire i panni dello Stato di diritto: “Sicché, ove fosse possibile qualificare “mafioso” un soggetto sulla scorta di meri sospetti ed a prescindere dall’esame concreto della sua condotta penale e della sua storia giudiziaria si perverrebbe ad un aberrante meccanismo di estensione a catena della pericolosità simile a quello su cui si fondava, in un non recente passato, l’inquisizione medievale (che, com’è noto, fu un meccanismo di distruzione di soggetti ‘scomodi’ e non già di soggetti ‘delinquenti’; mentre il commendevole ed imprescindibile scopo che il Legislatore si pone è quello di depurare la società da incrostazioni ed infiltrazioni mafiose realmente inquinanti). D’altro canto, se per attribuire ad un soggetto la qualifica di ‘mafioso’ fosse sufficiente il mero sospetto della sua appartenenza ad una famiglia a sua volta ritenuta mafiosa e se anche la qualifica riferita alla sua famiglia potesse essere attribuita sulla scorta di sospetti; e se la mera frequentazione di un presunto mafioso (ma tale considerazione vale anche per l’ipotesi di mera frequentazione di un soggetto acclaratamente mafioso) potesse determinare il ‘contagio’ della sua (reale o presunta) pericolosità, si determinerebbe una catena infinita di presunzioni atte a colpire un numero enorme di soggetti senza alcuna seria valutazione in ordine alla loro concreta vocazione criminogena. E l’effetto sarebbe l’instaurazione di un regime di polizia nel quale la compressione dei diritti dei cittadini finirebbe per dipendere dagli orientamenti culturali e dalle suggestioni ideologiche (quand’anche non dalle idee politiche) dei funzionari o, peggio, degli organi dai quali essi dipendono.” Da mandare giù a memoria. Altro che il nuovo codice antimafia con il quale fare propaganda manettara a buon mercato.
A proposito di sequestri preventivi giudiziari.
Finalmente la giurisprudenza ha cominciato a fare qualche passo in avanti verso la civiltà giuridica. Merita il plauso l'ordinanza n. 48441 del 10 Ottobre 2017 con la quale la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto il principio secondo il quale, se una persona viene assolta dall'accusa di associazione mafiosa, per gli stessi fatti non può essere considerata socialmente pericolosa. Riporto i passaggi più significativi dell'ordinanza.
"Lì dove le condotte sintomatiche della pericolosità siano legislativamente caratterizzate [...] in termini per lo più evocativi di fattispecie penali [...] è evidente che il giudice della misura di prevenzione (nel preliminare apprezzamento di tali 'fatti') non può evitare di porsi il problema rappresentato dalla esistenza di una pronunzia giurisdizionale che proprio su quella condotta [...] ha espresso una pronunzia in termini di insussistenza o di non attribuibilità del fatto all'individuo di cui si discute. [...] L'avvenuta esclusione del rilievo penale di una condotta, almeno tendenzialmente, impedisce di porre quel segmento di vita a base di una valutazione di pericolosità ed impone il reperimento, in sede di prevenzione, di ulteriori e diverse forme di conoscenza, capaci - in ipotesi - di realizzare ugualmente l'effetto di inquadramento nella categoria criminologica. [...] Lì dove il giudizio penale su un fatto rilevante a fini di inquadramento soggettivo abbia avuto un esito definitivo, tale aspetto finisce con il ricadere inevitabilmente nella cd. parte constatativa del giudizio di pericolosità". Questo principio, soprattutto alla luce dell'insegnamento della sentenza De Tommaso, dovrebbe rimettere in discussione la legittimità delle confische disposte nei confronti di persone assolte.
Dove non arrivano con le interdittive prefettizie, arrivano con i sequestri preventivi.
Interdittive: decine di aziende uccise dal reato di parentela mafiosa, scrive Simona Musco il 4 Novembre 2017 su "Il Dubbio". Il fenomeno delle interdittive è nazionale: in cinque anni, dopo la riorganizzazione del 2011, sono circa 400 le imprese allontanate dai lavori pubblici. Solo dalla Prefettura di Reggio Calabria, negli ultimi 14 mesi, sono partite 130 interdittive. Quasi dieci ogni 30 giorni, tutte frutto della gestione del Prefetto Michele Di Bari, approdato nella città dello Stretto ad agosto 2016. Un numero enorme che conferma una tendenza crescente, soprattutto in Calabria, dove in poco più di cinque anni le aziende hanno depositato quasi 500 ricorsi nelle cancellerie dei tribunali amministrativi di Catanzaro e Reggio Calabria. Ma il fenomeno – i cui dai sono ancora incerti – è nazionale: in cinque anni, dopo la riorganizzazione della materia nel 2011, sono circa 400 le imprese allontanate dai lavori pubblici. I numeri non sono ancora chiari, dato che gli archivi informatici dello Stato non hanno tutti i dati. E così succede che mentre dai siti dei tribunali amministrativi risulta un numero enorme di ricorsi (circa 2000 in cinque anni) e annullamenti (tra i 40 e i 90 l’anno), le cifre fornite dalla Dia, la Direzione investigativa antimafia, parlano di 31 annullamenti dal 2011 fino a maggio 2015. Numeri snelliti dal vuoto di informazioni dalle Prefetture di Napoli, Reggio Calabria e Vibo Valentia. La parte più corposa, dunque. La ratio dello strumento è chiara: «contrastare le forme più subdole di aggressione all’ordine pubblico economico, alla libera concorrenza ed al buon andamento della pubblica amministrazione», sentenzia il Consiglio di Stato. Un provvedimento preventivo, che prescinde quindi dall’accertamento di singole responsabilità penali e anticipa la soglia di difesa. «Per questo – dice ancora il Consiglio di Stato – deve essere respinta l’idea che l’informativa debba avere un profilo probatorio di livello penalistico e debba essere agganciata a eventi concreti ed a responsabilità addebitabili». Se c’è un sospetto, dunque, la Prefettura ha il potere e il dovere di tranciare i rapporti tra aziende private e pubblica amministrazione, attraverso tutta una serie di accertamenti ai quali non si può replicare fino a quando non diventano di pubblico dominio. Ovvero quando l’azienda colpita viene esclusa dai bandi pubblici e marchiata come infetta. Un’etichetta che, a volte, è giustificata da elementi tangibili e concreti, consentendo quindi di sfilare dalle mani dei clan l’appalto, ma altre decisamente meno. Tant’è che sono centinaia i ricorsi vinti, di una vittoria che però è solo parziale: sempre più spesso, infatti, chi si è visto colpire da un’interdittiva, pur vincendo il proprio ricorso, non riesce più a reinserirsi nel mondo del lavoro. Partiamo dal modus operandi: la Prefettura punta gran parte della sua decisione sui legami di parentela e su frequentazioni poco raccomandabili. Nulla o quasi, invece, si dice su fatti concreti che possano far temere effettivamente un condizionamento mafioso. Ed è proprio questo che fa crollare i provvedimenti davanti ai giudici amministrativi, per i quali non basta basarsi su rapporti commerciali e di parentela, «da soli insufficienti», dice ancora il Consiglio di Stato. Occorrono perciò, aggiunge, «altri elementi indiziari a dimostrazione del “contagio”». E «non possono bastare i precedenti penali» riferiti «ad indagini in seguito archiviate e, in altra parte, a condanne molto risalenti nel tempo», in quanto servono elementi «concreti e riferiti all’attualità». Un’interpretazione confermata anche dalla Corte costituzionale, secondo cui è arbitrario «presumere che valutazioni comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall’interessato debbano essere automaticamente trasferiti all’interessato medesimo». Ma è proprio questo il meccanismo che genera un circolo vizioso capace di far risucchiare una parte rilevante dell’economia dal vortice del sospetto. E le conseguenze non sono solo per le ditte: le interdittive, infatti, colpiscono aziende impegnate in appalti pubblici che così rimangono bloccati, cantieri aperti che si richiuderanno magari dopo anni. Dell’ambiguità dello strumento, lo scorso anno, aveva parlato il senatore Pd e membro della Commissione parlamentare antimafia Stefano Esposito, che al convegno “Warning on crime” all’Università di Torino aveva dichiarato che «lo strumento non funziona e nel 60% dei casi le interdittive vengono respinte» dai giudici amministrativi. Chiedendo dunque una riforma, che anche Rosy Bindi, poco prima, aveva annunciato, nel 2015. «Le interdittive antimafia sono uno strumento statico, mentre la lotta alla mafia ha bisogno di film», ha spiegato. Un film che nel nuovo codice antimafia coincide col controllo giudiziario delle aziende sospette, i cui risultati sono ancora tutti da vedere.
Che affare certe volte l’antimafia! Scrive Piero Sansonetti il 3 Novembre 2017 su "Il Dubbio". I “paradossi” calabresi. Questa storia calabrese è molto istruttiva. La racconta nei dettagli, nell’articolo qui sopra, Simona Musco. La sintesi estrema è questa: un imprenditore incensurato, e senza neppure un grammo di carichi pendenti (che oltretutto è presidente di Confindustria), vince un appalto per costruire i parcheggi del palazzo di Giustizia a Reggio. Un lavoro grosso: più di 15 milioni. Al secondo posto, in graduatoria, una azienda amministrata da un deputato di Scelta Civica. L’azienda del deputato protesta per aver perso la gara e ricorre al Tar. Il Tar dà ragione all’imprenditore e torto all’azienda del deputato. Poi, all’improvviso, non si sa come, la Prefettura fa scattare l’interdittiva e cioè, per motivi cautelari, toglie l’appalto all’imprenditore e lo assegna all’azienda del deputato che aveva perso la gara. Come è possibile? Proviamo a spiegarci. Le interdittive funzionano così: sono discrezionali. Decide il prefetto. Non c’è bisogno di una condanna penale, addirittura – nel caso ad esempio, del quale stiamo parlando – nemmeno di un avviso di garanzia o di una ipotesi di reato. Il reato non c’è, però a me tu non mi convinci. Punto e basta. E allora io quell’appalto di 16 milioni di euro te lo levo e lo porgo all’azienda di un deputato. Il deputato in questione, peraltro, fa parte della commissione antimafia. E lo Stato di diritto? E la libera concorrenza? E l’articolo 3 del- la Costituzione? Beh, mettetevi il cuore in pace: esiste una parte del territorio nazionale, e in modo particolarissimo la Calabria, nel quale lo Stato di diritto non esiste, non esiste la libera concorrenza e l’Articolo 3 della Costituzione (quello che dice che tutti sono uguali davanti alla legge) non ha effetti. La ragione di questo Far West, in gran parte, è spiegabile con la presenza della mafia, che la fa da padrona, fuori da ogni regola. Ma anche lo Stato, che la fa da padrone, altrettanto al di fuori da ogni regola, e da ogni senso di giustizia, e mostrando sempre il suo volto prepotente, come questa storia racconta. Lo Stato, con la mafia, è responsabile del Far West. Allora il problema è molto semplice. È assolutamente impensabile che si possa condurre una battaglia seria contro la mafia e la sua grande estensione in alcune zone del Sud Italia, se non si ristabiliscono le regole e se non si riporta lo Stato alla sua funzione, che è quella di produrre equità e sicurezza sociale, e non di produrre prepotenza, incertezza e instabilità. La chiave di tutto è sempre la stessa: ristabilire lo Stato di diritto. E questo, naturalmente, vuol dire che bisogna impedire che i commercianti – ad esempio – siano taglieggiati dalla mafia, ma bisogna anche impedire che i diritti di tutti i cittadini – non solo quelli onesti – siano sistematicamente calpestati. La sospensione della legalità, gli strumenti dell’emergenza (come le interdittive, le commissioni d’accesso e simili) possono avere una loro utilità solo in casi rarissimi e in situazioni molto circoscritte. E solo se usati con rigore estremo e sempre con il terrore di commettere prevaricazioni e ingiustizie. Se invece diventano semplicemente – come succede molto spesso – strumenti di potere dell’autorità, magari frustrata dai suoi insuccessi nella battaglia contro la mafia, allora producono un effetto moltiplicatore, proprio loro, del potere mafioso. Perché la discrezionalità, l’arroganza, l’ingiustizia, creano una condizione sociale e psicologica di massa, nella quale la mafia sguazza. Naturalmente non ho proprio nessun elemento per immaginare che l’azienda che ha fatto le scarpe a quella dell’ex presidente di Confindustria (che si è dimesso dopo aver ricevuto questa interdittiva, che ha spezzato le gambe alla sua azienda e i nervi a lui), e cioè l’azienda del deputato dell’antimafia, abbia brigato per ottenere l’interdittiva contro il concorrente. Non ho mai sopportato la politica e il giornalismo che vivono di sospetti. Però il messaggio che è stato mandato alla popolazione di Reggio Calabria, oggettivamente, è questo: se non sei protetto dalla “compagnia dell’antimafia” qui non fai un passo. E se sei deputato, comunque, sei avvantaggiato. Capite che è un messaggio letale? P. S. Conosco molto bene l’imprenditore di cui sto parlando, e cioè Andrea Cuzzocrea, la cui azienda ora è al palo e rischia di fallire. Lo conosco perché insieme a un gruppo di giornalisti dei quali facevo parte, organizzò quattro anni fa la nascita di un giornale, che si chiamava “Il Garantista” e che durò poco perché dava fastidio a molti (personalmente, in quanto direttore di quel giornale, ho collezionato una trentina di querele) e non aveva una lira in cassa. “Il Garantista” era edito da una cooperativa, molto povera, della quale lui assunse per un periodo la presidenza. Non so quali telefonate ebbe con Teresa Munari. Però so per certo due cose. La prima è che Teresa Munari era una giornalista molto accreditata negli ambienti democratici di Reggio Calabria. L’ho conosciuta quattro o cinque anni fa, mi invitò a casa sua a una cena. C’erano anche il Procuratore generale di Reggio e una deputata molto famosa per il suo impegno “radicale” contro la mafia. La Munari collaborò a “Calabria Ora”, giornale regionale che al tempo dirigevo, e successivamente al “Garantista”. Non era raccomandata. E non fu mai, mai assunta. Non era in redazione, non partecipava alla vita del giornale, scriveva ogni tanto degli articoli, che siccome non avevamo il becco di un quattrino credo che non gli pagammo mai. Qualcuno è in grado di spiegarmi come si fa a dire che uno non può costruire un parcheggio perché una volta ha telefonato a Teresa Munari?
Levano l’appalto a un imprenditore incensurato e lo danno a un deputato dell’antimafia, scrive Simona Musco il 3 Novembre 2017 su "Il Dubbio". Reggio Calabria: un imprenditore incensurato si vede annullata l’assegnazione, e i lavori per 16 milioni sono affidati all’azienda di un deputato.
PARADOSSI CALABRESI. Una azienda di Reggio Calabria, guidata da imprenditori incensurati e senza carichi pendenti, vince un appalto molto ricco: la costruzione del parcheggio del palazzo di Giustizia. È un lavoro grosso, da 16 milioni. L’azienda che è arrivata seconda, nella gara d’appalto, fa ricorso. Il Tar gli dà torto. E conferma l’appalto all’azienda che si è classificata prima (su 19). Allora interviene il Prefetto e fa scattare l’interdittiva per l’azienda vincitrice. Che vuol dire? Che il prefetto ha questo potere discrezionale di interdire una azienda, temendo infiltrazioni mafiose, anche se questa azienda non è inquisita. E il prefetto di Reggio ha esercitato questo potere. E così il lavoro è passato al secondo classificato. Chi è? È un deputato. Un deputato della commissione antimafia.
Un appalto da 16 milioni di euro per la costruzione del parcheggio del nuovo Palazzo di Giustizia. Diciannove aziende che decidono di provarci e due che arrivano in cima alla graduatoria con pochissimi punti di distacco. E un’interdittiva antimafia che fa transitare l’appalto dalle mani della prima – la Aet srl – alla seconda, la Cosedil, fondata da un parlamentare della Commissione antimafia, Andrea Vecchio, e patrimonio della sua famiglia. È successo a Reggio Calabria, dove l’ex presidente di Confindustria Andrea Cuzzocrea ha visto sparire, in pochi mesi, un lavoro imponente, la poltrona di presidente degli industriali e la credibilità. Tutto a causa di uno strumento preventivo – l’interdittiva – che ora rischia di mandare a gambe all’aria l’azienda, da sempre attiva negli appalti pubblici, e i due imprenditori che la amministrano, Cuzzocrea e Antonino Martino, entrambi incensurati.
UN APPALTO DIFFICILE. Tutto comincia nel 2016, quando la Aet srl vince l’appalto per la costruzione dei parcheggi del tribunale di Reggio Calabria. Un lavoro che la città attendeva da tempo e che, finalmente, sembra potersi sbloccare. Ma i tempi per la firma del contratto vengono rallentati dai ricorsi. In prima fila c’è la Cosedil spa, azienda siciliana, che chiede al Tar la verifica dell’offerta presentata dalla Aet e dei requisiti dell’azienda e di conseguenza l’annullamento dei verbali di gara. I giudici amministrativi valutano il ricorso, bocciando tutte le obiezioni tranne una, quella relativa la giustificazione degli oneri aziendali della sicurezza, per i quali la Commissione giudicatrice dell’appalto avrebbe commesso «un macroscopico difetto d’istruttoria». Un errore, si legge nella sentenza, dal quale però non deriva «automaticamente l’obbligo di escludere la società prima classificata». Il Tar, a gennaio, interpella dunque la Stazione unica appaltante, alla quale chiede di effettuare una nuova verifica sull’offerta dell’Aet. Risultato: viene confermata «la regolarità e la correttezza» dell’aggiudicazione dell’appalto. La firma sul contratto per l’avvio dei lavori, dunque, sembrano avvicinarsi.
L’INTERDITTIVA. Ma l’iter per far partire i cantieri subisce un altro stop, quando ad aprile la Prefettura emette un’informativa interdittiva a carico dell’azienda, escludendola, di fatto, dai giochi. Cuzzocrea, che nel 2013 aveva chiesto alla Commissione parlamentare antimafia di «istituire le white list obbligatorie per gli appalti pubblici, rendendo così più trasparente un settore delicatissimo», si dimette da presidente di Confindustria. L’interdittiva riassume elementi già emersi in precedenza nella corposa relazione che ha portato allo scioglimento dell’amministrazione di Reggio Calabria, elementi già confutati, ai quali si aggiunge un nuovo dato, relativo alla parentesi da editore di Cuzzocrea. Ed è sulla base di quello che la Prefettura rivaluta tutto il passato, sebbene esente da risvolti giudiziari. Si tratta del contatto (finito nell’operazione “Reghion”) tra Cuzzocrea e l’ex deputato Paolo Romeo, già condannato definitivamente per concorso esterno in associazione mafiosa e ora in carcere in quanto considerato dalla Dda reggina a capo della cupola masso- mafiosa che governa Reggio Calabria. Nessun rapporto, almeno documentato, prima del 2014: i due si conoscono a gennaio di quell’anno, in Senato, dove sono stati entrambi invitati, in quanto rappresentanti delle associazioni, per discutere della costituenda città metropolitana. Dopo quella volta un unico contatto: Cuzzocrea, presidente della società editrice del quotidiano Cronache del Garantista, viene contattato da Romeo, che gli chiede di valutare l’assunzione di una giornalista, Teresa Munari, secondo la Dda strumento nelle mani di Romeo. Cuzzocrea propone la giornalista, nota in città e ormai in pensione, al direttore Sansonetti, che la inserisce tra i collaboratori, pur senza un contratto. Tra i pezzi scritti dalla Munari su quella testata ce n’è uno in particolare, considerato dalla Dda utile alla causa di Romeo. Che avrebbe perorato la causa dell’amica facendola passare come «un’opportunità per il giornale e non come un favore che richiedeva per sé stesso o per la giornalista», si legge nel ricorso presentato al Consiglio di Stato dalla Aet. La Prefettura non contesta nessun altro contatto tra Romeo e Cuzzocrea, che, scrivono i legali dell’azienda, «non poteva pensare, visto il modo in cui la cosa era stata richiesta, che vi fossero doppi fini nel suggerimento ricevuto. Romeo – si legge ancora – non ha mai avuto altri contatti con l’ingegnere Cuzzocrea ed è detenuto. Non si comprende, quindi, perché ci sarebbe il rischio che possa, iniziando oggi (perché in passato non è successo), condizionare l’attività della Aet». Gli elementi vecchi riguardano invece il socio Antonino Martino, socio al 50 per cento, e coinvolto, nel 2004, nell’operazione antimafia “Prius”, assieme ad alcuni suoi familiari. Un’indagine conclusa, per Martino, con l’archiviazione, chiesta dallo stesso pm, il 5 marzo 2009. Di lui un pentito aveva detto, per poi essere smentito, di essersi intestato, tra il 1992 e il 1993, un magazzino, in realtà riconducibile al temibile clan Condello di Reggio Calabria. Intestazione fittizia, dunque, ipotesi che si basava anche sulla convinzione – sbagliata – che il padre di Martino, Paolo, fosse parente di Domenico Condello. Tali elementi, nel 2013, non erano bastati alla Prefettura per interdire la Aet, tanto che l’azienda aveva ricevuto il nulla osta e l’inserimento nella “white list”, la lista di aziende pulite che possono lavorare con la pubblica amministrazione. E se anche fossero potenzialmente fonte di pericolo non sarebbero più attuali, considerato che, contestano i legali dell’azienda, Paolo Martino è morto e Condello si trova in carcere.
LA COSEDIL. La Aet, dopo la richiesta di sospensiva dell’interdittiva rigettata dal Tar, attende ora il giudizio del Consiglio di Stato. Nel frattempo, alle spalle dell’azienda reggina, rimane la Cosedil, fondata nel 1965 dal parlamentare del Gruppo Misto Andrea Vecchio. La Spa, secondo le visure camerali, è amministrata dai figli del parlamentare che rimane, come recita il suo profilo Linkedin, presidente onorario. Ma Vecchio, componente della Commissione antimafia, nelle dichiarazioni patrimoniali pubblicate sul sito della Camera si dichiara amministratore unico di una delle aziende che partecipano la Cosedil (la Andrea Vecchio partecipazioni) e consigliere della Cosedil stessa. Che rimane l’unica titolata a prendere, con un iter formalmente impeccabile, l’appalto.
Antimafia mafiosa. Come reagire, scrive il 27 settembre 2017 Telejato. C’È, È INUTILE RIPETERLO TROPPE VOLTE, UNA CERTA PRESA DI COSCIENZA DELLA TURPITUDINE DELLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA, CHE MEGLIO SAREBBE DEFINIRE “LEGGE DEI SOSPETTI”. ANCHE I PIÙ COCCIUTI COMINCIANO AD AVVERTIRE CHE NON SI TRATTA DI “ABUSI”, DI DOTTORESSE SAGUTO, DI “CASI” COME QUELLO DEL “PALAZZO DELLA LEGALITÀ”, DI FRATELLANZE E CUGINANZE DI AMMINISTRATORI DEVASTANTI. È tutta l’Antimafia che è divenuta e si è rivelata mafiosa. Come si addice al fenomeno mafioso, questa presa di coscienza rimane soffocata dalla paura, dal timore reverenziale per le ritualità della dogmatica dell’antimafia devozionale, del komeinismo nostrano che se ne serve per “neutralizzare” la nostra libertà. Molti si chiedono e ci chiedono: che fare? È già qualcosa: se è vero, come diceva Manzoni, che il coraggio chi non c’è l’ha non se lo può dare, è vero pure che certi interrogativi sono un indizio di un coraggio che non manca o non manca del tutto. Non sono un profeta, né un “maestro” e nemmeno un “antimafiologo”, visto che tanti mafiologhi ci hanno deliziato e ci deliziano con le loro cavolate. Ma a queste cose ci penso da molto tempo, ci rifletto, colgo le riflessioni degli altri. E provo a dare un certo ordine, una certa sistemazione logica a constatazioni e valutazioni. E provo pure a dare a me stesso ed a quanti me ne chiedono, risposte a quell’interrogativo: che fare? Io credo che, in primo luogo, occorre riflettere e far riflettere sul fatto che il timore, la paura di “andare controcorrente” denunciando le sciagure dell’antimafia e la sua mafiosità, debbono essere messe da parte. Che se qualcuno non ha paura di parlar chiaro, tutti possono e debbono farlo. Secondo: occorre affermare alto e forte che il problema, i problemi non sono quelli dell’esistenza delle dott. Saguto. Che gli abusi, anche se sono tali sul metro stesso delle leggi sciagurate, sono la naturale conseguenza delle leggi stesse. Che si abusa di una legge che punisce i sospetti e permette di rovinare persone, patrimoni ed imprese per il sospetto che i titolari siano sospettati è cosa, in fondo, naturale. Sarebbe strano che, casi Saguto, scioglimenti di amministrazioni per pretesti scandalosi di mafiosità, provvedimenti prefettizi a favore di monopoli di certe imprese con “interdizione” di altre, non si verificassero. Terzo. Occorre che allo studio, alle analisi giuridiche e costituzionali delle leggi antimafia e delle loro assurdità, si aggiungano analisi, studi, divulgazioni degli uni e degli altri in relazione ai fenomeni economici disastrosi, alle ripercussioni sul credito, siano intrapresi, approfonditi e resi noti. Possibile che non vi siano economisti, commercialisti, capaci di farlo e di spendersi per affrontare seriamente questi aspetti fondamentali della questione? Cifre, statistiche, comparazioni tra le Regioni. Il quadro che ne deriverà è spaventoso. Quindi necessario. E’ questo l’aspetto della questione che più impressionerà l’opinione pubblica. E poi: non tenersi per sé notizie, idee, propositi al riguardo. Questo è il “movimento”. Il movimento di cui molti mi parlano. Articolo di Mauro Mellini. Avvocato e politico italiano. È stato parlamentare del Partito Radicale, di cui fu tra i fondatori.
Ma cosa sarebbe codesta antimafia, che tutto gli è concesso, se non ci fosse lo spauracchio mediatico della mafia di loro invenzione? E, poi, chi ha dato la patente di antimafiosità a certi politicanti di sinistra che incitano le masse…e chi ha dato l’investitura di antimafiosità a certi rappresentanti dell’associazionismo catto-comunista che speculano sui beni…e chi ha dato l’abilitazione ad essere portavoci dell’antimafiosità a certi scribacchini di sinistra che sobillano la società civile? E perché questa antimafiosità ha immenso spazio su tv di Stato e giornali sostenuti dallo Stato per fomentare questa deriva culturale contro la nostra Nazione o parte di essa. Discrasia innescata da gruppi editoriali che influenzano l’informazione in Italia?
Fintanto che le vittime dell’antimafia useranno o subiranno il linguaggio dei loro carnefici, continueremo ad alimentare i cosiddetti antimafiosi che lucreranno sulla pelle degli avversari politici.
Se la legalità è l’atteggiamento ed il comportamento conforme alla legge, perché l’omologazione alla legalità non è uguale per tutti,…uguale anche per gli antimafiosi? La legge va sempre rispettata, ma il legislatore deve conformarsi a principi internazionali condivisi di più alto spessore che non siano i propri interessi politici locali prettamente partigiani.
Va denunciato il fatto che l’antimafiosità è solo lotta politica e di propaganda e la mafia dell’antimafia è più pericolosa di ogni altra consorteria criminale, perchè: calunnia, diffama, espropria e distrugge in modo arbitrario ed impunito per sola sete di potere. La mafia esiste ed è solo quella degli antimafiosi, o delle caste o delle lobbies o delle massonerie deviate. E se per gli antimafiosi, invece, tutto quel che succede è mafia…Allora niente è mafia. E se niente è mafia, alla fine gli stranieri considereranno gli italiani tutti mafiosi.
Invece mafioso è ogni atteggiamento e comportamento, da chiunque adottato, di sopraffazione e dall’omertà, anche istituzionale, che ne deriva.
Non denunciare ciò rende complici e di questo passo gli sciasciani non avranno mai visibilità se rimarranno da soli ed inascoltati.
Finalmente la giurisprudenza ha cominciato a fare qualche passo in avanti verso la civiltà giuridica. Merita il plauso l'ordinanza n. 48441 del 10 Ottobre 2017 con la quale la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto il principio secondo il quale, se una persona viene assolta dall'accusa di associazione mafiosa, per gli stessi fatti non può essere considerata socialmente pericolosa. Riporto i passaggi più significativi dell'ordinanza.
"Lì dove le condotte sintomatiche della pericolosità siano legislativamente caratterizzate [...] in termini per lo più evocativi di fattispecie penali [...] è evidente che il giudice della misura di prevenzione (nel preliminare apprezzamento di tali 'fatti') non può evitare di porsi il problema rappresentato dalla esistenza di una pronunzia giurisdizionale che proprio su quella condotta [...] ha espresso una pronunzia in termini di insussistenza o di non attribuibilità del fatto all'individuo di cui si discute. [...] L'avvenuta esclusione del rilievo penale di una condotta, almeno tendenzialmente, impedisce di porre quel segmento di vita a base di una valutazione di pericolosità ed impone il reperimento, in sede di prevenzione, di ulteriori e diverse forme di conoscenza, capaci - in ipotesi - di realizzare ugualmente l'effetto di inquadramento nella categoria criminologica. [...] Lì dove il giudizio penale su un fatto rilevante a fini di inquadramento soggettivo abbia avuto un esito definitivo, tale aspetto finisce con il ricadere inevitabilmente nella cd. parte constatativa del giudizio di pericolosità". Questo principio, soprattutto alla luce dell'insegnamento della sentenza De Tommaso, dovrebbe rimettere in discussione la legittimità delle confische disposte nei confronti di persone assolte.
La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per la Saguto e per 15 suoi amici, scrive il 26 ottobre 2017 Telejato. DOPO MESI DI INDAGINI, INTERROGATORI, INTERCETTAZIONI, IL NODO È ARRIVATO AL PETTINE. La procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio per la signora Silvana Saguto, già presidente dell’Ufficio Misure di prevenzione, accusata assieme ad altri 15 imputati, di corruzione, abuso d’ufficio, concussione, truffa aggravata, riciclaggio, dopo una requisitoria durata cinque ore. Saranno invece processati col rito abbreviato i magistrati Tommaso Virga, Fabio Licata e il cancelliere Elio Grimaldi. Tra coloro per cui è stato chiesto il rinvio figurano il padre, il figlio Emanuele e il marito della Saguto, il funzionario della DIA Rosolino Nasca, i docenti universitari Roberto Di Maria e Carmelo Provenzano, assieme ad altri suoi parenti, l’ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo. Posizione stralciata anche per l’altro ex giudice dell’ufficio misure di prevenzione Chiaramontee per il suo compagno Antonio Ticali, per il quale la procura ha chiesto l’archiviazione, e per l’altro professore universitario Luca Nivarra e rito abbreviato per Cappellano Seminara. Prossima udienza il 6 novembre, con la parola alle parti civili e al collegio di difesa. Inutile soffermarci ancora sull’allegro e criminoso modo, portato avanti dalla Saguto, di mettere sotto sequestro aziende alle quali, in qualche modo spesso solo indiziario, si attribuiva una patente di mafiosità per procedere alla loro requisizione e affidarne la gestione agli avvocati o economisti che facevano parte del cerchio magico. L’amministrazione giudiziaria di questi beni ha arrecato danni irreversibili all’economia siciliana, poiché le aziende sono state smantellate e non più restituite, anche quando i proprietari sono stati penalmente assolti da ogni imputazione. E proprio oggi arriva la notizia del dissequestro di due aziende finite nel mirino della Saguto, che nel febbraio 2014 ne aveva disposto il sequestro: si tratta della Fattoria Ferla e della Special Fruit, che hanno operato da anni all’interno del settore ortofrutticolo e che oggi, dopo la disamministrazione affidata a Nicola Santangelo, oggi anche lui sotto processo, sono finite in liquidazione, lasciando disoccupati una decina di lavoratori. Le due aziende erano state accusate di essere sotto la protezione del boss dell’Acquasanta Galatolo, nell’ambito di un sequestro di 250 milioni, ma dopo l’attenta valutazione condotta dai magistrati dell’ufficio misure di prevenzione, oggi affidato al nuovo presidente Malizia e ai giudici Luigi Petrucci e Giovanni Francolini, è stato disposto il dissequestro, in quanto non esiste “neanche il sospetto” di infiltrazioni mafiose. Restano ancora sotto sequestro altri beni ed è in corso il procedimento per il successivo dissequestro.
L’antimafia preventiva diventata definitiva, scrive il 13 ottobre 2017 Telejato.
LA PREVENZIONE. Il caso Saguto ha causato l’implosione di un sistema concepito in origine per aggredire i patrimoni mafiosi e colpire i mafiosi nelle loro ricchezze costruite con l’illegalità. Il sistema, giorno dopo giorno è diventato un metodo in virtù del grande potere attribuito ai giudici di poter sequestrare i beni, anche attraverso la semplice “legge del sospetto”, e di poterli tenere sotto sequestro anche quando i procedimenti penali hanno ufficialmente decretato l’infondatezza di questo sospetto e prosciolto i cosiddetti “preposti”, cioè soggetti a sequestro da ogni imputazione di associazione, contiguità, concorso con il malaffare mafioso. Ancora oggi restano sotto sequestro immensi patrimoni di soggetti che, in altri periodi si sono piegati alla legge del pizzo, in alcuni casi per continuare a lavorare, in altri casi, è giusto dirlo, anche per avere mano libera nel badare ai propri affari. Quello che per loro era un “piegarsi alla regola” della “messa a posto”, per sopravvivere, diventa accusa di collaborazione e concorso in associazione mafiosa, così che le vittime diventano complici. L’imprenditoria siciliana, soprattutto nei suoi risvolti commerciali e nell’edilizia, ha subito tremende battute d’arresto, poiché la mannaia della prevenzione si è abbattuta su aziende che davano lavoro a migliaia di siciliani oggi disoccupati, senza preoccuparsi di sorvegliare la gestione dei beni confiscati, affidati ad amministratori giudiziari, alcuni senza scrupoli, altri del tutto incapaci e incompetenti, che hanno prosciugato i beni dell’azienda loro affidata per foraggiare se stessi e i propri collaboratori. In tal modo quello che avrebbe dovuto essere un momento “preventivo”, al fine di evitare la reiterazione del reato, diventa un momento definitivo, dato il prolungamento all’infinito delle misure di prevenzione, anche ad assoluzione penale avvenuta.
LA NUOVA LEGGE ANTIMAFIA. Da parte di alcuni settori si è gridato alla vittoria e al passo in avanti dato dal nuovo codice antimafia, approvato nel settembre scorso, ma, come abbiamo più volte scritto, si tratta di una legge nata vecchia, con qualche ritocco alla vecchia legge del 2012, senza che siano indicate regole precise né sul periodo, cioè sulla durata in cui un bene deve essere tenuto sotto sequestro, né sulle prove e sulle condizioni che dovrebbero giustificare il sequestro, né sulle penalità da attribuire agli amministratori incompetenti o ai magistrati che hanno agito frettolosamente, senza che la loro azione sia stata giustificata da un minimo di sentenza. È rimasto il solco tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, anzi il procedimento di prevenzione è stato esteso anche ai reati di corruzione, commessi in associazione, senza garanzie sulla possibile restituzione e sul risarcimento dei danni causati dalla disamministrazione. Insomma, come al solito non pagherà nessuno e i magistrati potranno continuare ad agire nel massimo della libertà che non è sempre garanzia di giustizia.
I RESPONSABILI. Dopo questa premessa citiamo, e ricordiamo i numerosi nomi di amministratori che, in un modo o in un altro hanno contribuito a creare sfiducia nella possibilità di potere portare avanti un’azione antimafia decisa e corretta, che avrebbe dovuto avere come finalità primaria la possibilità di non affossare l’economia siciliana, ma di salvaguardarla dalle infiltrazioni mafiose e di costruirla nel rispetto delle regole parallelamente alle condizioni di crisi, di cui ancora non si vede l’uscita, nonostante lo strombazzamento di miglioramenti dei quali in Sicilia non vediamo nemmeno l’ombra. La salvaguardia di quel poco esistente, spesso dovuto al coraggio di imprenditori che hanno rischiato tutto e si sono anche indebitati per costruire un’azienda, non è stata in alcun modo presa in considerazione, e ciò ha causato il crollo di strutture e aziende, come quelle dei Niceta, dei Cavallotti, di Calcedonio Di Giovanni, della catena di alberghi Ponte, della Motoroil, della Clinica Villa Teresa di Bagheria, (sia nel settore sanitario che in quello edilizio), della Meditour degli Impastato, dei supermercati Despar di Grigoli in provincia di Trapani e Agrigento, dell’impero televisivo e concessionario dei Rappa e così via. Responsabili i vari a Cappellano Seminara, Sanfilippo, Santangelo, Aulo Giganti, Ribolla, Scimeca, Benanti, Walter Virga, Rizzo, Modica de Moach e così via. Molti di questi sono ancora al loro posto, mentre altri sono stati sostituiti. Di questo lungo elenco faceva parte Luigi Miserendino che, ieri, si è dimesso da tutti gli incarichi, per avere lasciato al suo posto il re dei detersivi Ferdico, il quale è stato assolto da tutto, ma ricondotto in carcere, mentre il carcere è stato revocato a Miserendino, poiché, dimessosi, non potrà più reiterare il reato.
IL PROFESSORE. Oggi spunta la notizia, altrettanto grave dell’interrogatorio del prof. Carmelo Provenzano, il quale, dopo avere sistemato nelle varie amministrazioni moglie, fratello, cognata e altri amici, dopo avere rifornito di frutta fresca il frigorifero della Saguto e del prefetto di Palermo Cannizzo, dopo avere agevolato la laurea del figlio della Saguto, anche con l’aiuto del rettore dell’Università di Enna Di Maria, oggi dichiara candidamente al giudice Bonaccorso che lo sta interrogando, di avere fatto tutto questo perché rientrava nelle sue funzioni di docente aiutare gli alunni, tra i quali cita anche il figlio dell’ex procuratore capo di Caltanissetta Sergio Lari e si lamenta addirittura che le sue telefonate al figlio di Lari non sono agli atti del procedimento contro di lui. Va tenuto presente comunque che Lari è stato quello che ha dato il via all’inchiesta aperta dei giudici di Caltanissetta contro la Saguto e i suoi collaboratori, o, se vogliamo, complici. Secondo Provenzano tutto quello che è successo era “normale”, tutti facevano così, rientrava nel normale modo di gestire i beni sequestrati quello di aiutarsi e appoggiarsi reciprocamente tra i vari componenti del cerchio magico. Né più né meno come quando Craxi dichiarò in parlamento che il sistema delle tangenti ai partiti era normalità, che tutti facevano così, tutti mangiavano e non poteva essere lui solo a pagare per tutti. E se tutto è normale, non è successo niente, abbiamo scherzato, hanno scherzato i giudici di Caltanissetta ad aprire il procedimento, sono tutti innocenti e tutti dovrebbero essere assolti, Cappellano compreso, perché hanno fatto egregiamente il loro lavoro. Conclusione, ma non solo per Provenzano, è che tutto quello che dovrebbe essere anormale, anche il malaffare, è normale, mentre è anormale il corretto funzionamento della giustizia e l’applicazione di eventuali pene nei confronti di chi sbaglia. Ovvero fuori i mascalzoni e dentro chi si comporta onestamente o chi si permette di denunciare il disonesto modo di amministrare la cosa pubblica, i beni dello stato, il corretto funzionamento della giustizia. Come succede molto spesso in Italia, secondo un detto antichissimo cui ostinatamente non possiamo e non dobbiamo rassegnarci: “La furca è pi li poviri, la giustizia pi li fissa
L’Italia non è un paese per giovani (avvocati): elevare barriere castali e di censo non è una soluzione, scrive il 28 Aprile 2017 “L’Inkiesta”. Partiamo da due disfunzioni che affliggono il nostro Paese e che stanno facendo molto parlare di sé. Da una parte, la crisi delle libere professioni e, in generale, delle lauree, con importanti giornali nazionali che ci informano, per esempio, che i geometri guadagnano più degli architetti. Dall’altra, le inefficienze del sistema giudiziario. Queste, sono oggetto di dibattito da tempo immemorabile, ci rendono tra i Paesi peggiori dell’area OCSE e ci hanno fatti condannare da niente-popò-di-meno-che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Incrociate ora i due trend. Indovinate chi ci rimane incastrato in mezzo? Ovviamente i giovani laureati/laureandi in giurisprudenza, chiusi tra un percorso universitario sempre più debole e una politica incapace di portare a termine una riforma complessiva e decente dell’ordinamento forense. Come risolvere la questione? Con il numero chiuso a giurisprudenza? Liberalizzando la professione legale? Niente di tutto questo, ci mancherebbe. In un Paese dove gli avvocati rappresentano una fetta rilevante dei parlamentari, la risposta fornita dall’ennesima riforma è facile facile. Porre barriere di censo e di casta all’accesso alla professione. Da questa prospettiva tutte le recenti novità legislative acquistano un senso e rivelano una logica agghiacciante. I malcapitati che si laureeranno in Giurisprudenza a partire dall’anno 2016/2017 avranno una prima sorpresina: l’obbligo di frequentare una scuola di formazione per almeno 160 ore. Anche a pagamento se necessario, come da parere positivo del Consiglio Nazionale Forense.
La questione sarebbe da portare all’attenzione di un bravo psicanalista. Giusto qualche osservazione: (1) se la pratica deve insegnare il mestiere, perché aggiungere un’altra scuola obbligatoria?; (2) Se la Facoltà di Legge - che in Italia è lunghissima: 5 anni, contro i 3 di Stati Uniti e Regno Unito e i 4 della Francia, per esempio – serve a così poco, tanto da dover essere integrata anche dopo la laurea, perché non riformarla?; (3) perché fermare i ragazzi dopo la laurea, invece di farlo prima? Ci sarebbero anche altre questioni. Per esempio, 160 ore di formazione spalmate su 18 mesi, per i fortunati ammessi, non sono molte in teoria. Tuttavia, basta vedere le sempre maggiori proteste riportate dai giornali, e rigorosamente anonime, di praticanti-fotocopisti senza nome, sfruttati e non pagati, per accorgersi che la realtà è molto diversa dalla visione irenica (ipocrita è offensivo?) dei riformatori. E, in ogni caso, anche se il praticante fosse sufficientemente fortunato da avere qualche soldo in tasca, ciò non gli permetterebbe di godere del dono dell’ubiquità. Ma così si passerebbe dal settore della psicanalisi a quello della parapsicologia. Meglio evitare. Andiamo oltre.
Abbiamo superato la prima trincea. Coi soldi del nonno ci manteniamo nella nostra pratica non pagata o mal pagata. Magari siamo bravissimi ed accediamo ai corsi di formazione a gratis o con borsa. Arriva il momento dell’esame. Presto l’esame scritto sarà senza codice commentato. E fin qui, nessun problema. Meglio ragionare con la propria testa che affannarsi a cercare la “sentenza giusta”, magari senza capirla. Le prove verteranno sempre su diritto civile, diritto penale e un atto. Segue un esame orale con quattro materie obbligatorie: diritto civile, diritto penale, le due relative procedure, due materie a scelta e la deontologia forense. E qui il fine giurista si deve trasformare in una specie di Pico de La Mirandola, mandando a memoria tutto in poco tempo. Magari col capo che non ti concede più di un mese di assenza dalla tua scrivania. Ma il problema di questo esame è un altro. Poniamo che io sia un praticante in gamba e che abbia trovato lavoro in un grosso studio internazionale leader nel settore del diritto bancario. Plausibilmente, lavorerò con professionisti fantastici e avrò clienti prestigiosi. Serve a qualcosa per l’esame di stato? Risposta: no. Riformuliamo la questione. Se io mi occupo di diritto bancario o di diritto societario, cosa me ne frega di studiare diritto penale, materia che non mi interessa e che non praticherò mai? Mistero. L’esame di abilitazione fu regolato per la prima volta nel 1934 e la sua logica è rimasta ferma lì. Come se l’avvocato fosse ancora un piccolo professionista individuale che fa indifferentemente tutto. Pensateci la prossima volta che sentite qualcuno sciacquarsi la bocca con fregnacce sulla specializzazione degli avvocati e sulla dipartita dell’avvocato generico. Pensateci.
Passata anche la seconda trincea. Siete avvocati. Tutto bene? No. Tutto male. Finirete sotto il fuoco della Cassa Forense, obbligatoria, che vi mitraglierà. Non importa se siete potentissimi astri nascenti o piccoli professionisti. I risultati? Migliaia di giovani avvocati che si cancellano dall’albo ogni anno. Sgombriamo subito il campo da equivoci. Spesso quando si introduce questo tema ci si sente rispondere che in Italia ci sono troppi avvocati e se si sfoltiscono è meglio. Giusto. Ma ciò non può condurre ad affermare che dei giovani siano tagliati fuori da un sistema disfunzionale. La selezione dura va bene; il terno al lotto no. La competizione, anche spietata, va bene; le barriere all’accesso strutturate senza la minima logica no. Dietro le belle parole, si nasconde un sistema che, come avviene anche per altre professioni, cerca di tutelare se stesso sbattendo la porta in faccia ai giovani che vorrebbero entrare. Non tutti ovviamente. Senza troppa malizia vediamo che avrà meno crucci: (1) chi ha il padre, nonno, zio, fratello maggiore ecc… titolare di uno studio legale. Una mancetta arriverà sempre, con essa il tempo libero per frequentare la formazione obbligatoria e una study leave succulenta di un paio di mesi per preparare l’esame; (2) chi è ricco di famiglia e che, dunque, può godere dei vantaggi di cui sopra per vie traverse; (3) chi, date le condizioni di cui ai punti 1 e 2, può sostenere l’esame due, tre, quattro, cinque volte. E la meritocrazia? Naaaa, quello è uno slogan da sbandierare in campagna elettorale, cosa avete pensavate, sciocconi? In definitiva, il sistema come si sta concependo non fa altro che porre barriere all’ingresso che favoriscono il ceto e di casta. Una volta che si è entrati, invece, si fa in modo di cacciare fuori coloro che non arrivano a fine mese, tendenzialmente i più giovani o i più piccoli.
Ci sono alternative? Guardiamo un paese come la Francia. Lì, l’esame duro e temutissimo è quello per l’accesso all’école des Avocats, superato ogni anno da meno di un terzo dei candidati. Ma, (1) lo si sostiene appena terminata l’università, quando si è “freschi”; (2) è la precondizione per l’accesso al tirocinio, non un terno al lotto che viene al termine di 18/24 mesi di servaggio, spesso inutile ai fini del superamento dell’esame. Quindi, se si fallisce, al netto della delusione, si può subito andare a fare altro. Oppure si riprova (fino a tre volte). In ogni caso, però, non si buttano due anni di vita. La conclusione è sempre la stessa. L’Italia è un Paese che investe poco nei giovani. E che ci crede poco, a giudicare dalle frequenti sparate e rimbrotti di ministri vari. Sperando che non si cerchi, di fatto, di risolvere il problema con l’emigrazione, il messaggio deve essere chiaro. Non si faccia pagare ai giovani l’incapacità del sistema di riformarsi seriamente e organicamente. Le alternative ci sono.
Giornalisti? E’ meglio se andate a fare gli operai, scrive di Andrea Tortelli, Responsabile di "GiornalistiSocial.it". E’ meglio se andate a fare gli operai, credetemi. Lo dicono i numeri. Chiunque aspiri a fare il giornalista, in Italia, deve confrontarsi con un quadro di mercato ben più drammatico di quello di altri settori in crisi. Il giornalista rimane una professione molto (troppo) ambita, ma non conferisce più prestigio sociale a chi la pratica e soprattutto non è più remunerativa. Diverse classifiche, non solo italiche, inseriscono quello del reporter fra i lavori a maggiore rischio di indigenza. E chi pratica bazzica in questo mondo non può stupirsene.
Qualche numero sui media. Il mondo dei media è in crisi da tempo, ben prima che arrivassero i social a dare il colpo di grazia. In una provincia come Brescia, dove vivo, non c’è un solo giornale cartaceo o una televisione locale che nell’ultimo quinquennio non abbia ridotto il proprio organico e chiuso qualche bilancio in rosso. Tutto ciò mentre gli on line sopravvivono, ma non prosperano: generando numeri, ma recuperando ben poche delle risorse perse per strada dai media tradizionali. In Italia, va detto, i giornali non hanno mai goduto di troppa gloria. Da sempre siamo una delle popolazioni al mondo che legge meno. Meno di una persona su venti, oggi, compra un quotidiano in edicola e il calo è costante. Il Corriere della Sera, solo per fare un esempio, tra il 2004 e il 2014 ha dimezzato le proprie copie (l’on line, nello stesso periodo, è passato da 2 milioni di utenti al mese a 1,5 al giorno, Facebook da zero a 2 milioni di fan…). Nel 2016, ancora, i cinque giornali cartacei più venduti (Corsera, Repubblica, Sole 24 Ore, La Stampa e Gazzetta dello Sport) hanno perso un decimo esatto delle copie.
Non va meglio sul fronte dei fatturati. Dal 2004 al 2014 – permettetemi di riciclare un vecchio dato – il mercato pubblicitario italiano è passato da 8 miliardi 240milioni di euro a 5 miliardi e 739milioni (fonte DataMediaHub). La tv è scesa da 4 miliardi 451 milioni a 3.510 milioni, la stampa si è più che dimezzata da 2 miliardi 891 milioni a 1 miliardo 314 milioni, il web è cresciuto sì. Ma soltanto da 116 milioni a 474. Vuol dire che – dati alla mano – per ogni euro perso dalla carta stampata in questo decennio sono arrivati sul web soltanto 22 centesimi (del resto, agli attuali prezzi di mercato, mille clic vengono pagati oggi meno di due euro…). E gli altri 80 centesimi dove sono finiti? Un po’ si sono persi a causa della crisi. Ma una grossa fetta – non misurabile – è finita alle big del web, nel grande buco nero fiscale di Google e Facebook. Cioè è uscita dal circuito dell’informazione e dell’editoria.
I giornalisti che fanno? A una drastica riduzione delle copie e dei fatturati consegue ovviamente una drastica riduzione degli organici. Ma a questo dato si somma un aumento significativo dell’offerta (complici le scuole di giornalismo, ma non solo…) e un aumento esponenziale della concorrenza “impropria”, dovuta al fatto che Facebook è ormai la prima fonte di informazione degli italiani e sono molti a operare fuori dal circuito tradizionale (e spesso anche fuori dal circuito legale) dei media. In questo contesto, le possibilità di spuntare un contratto ex Articolo 1 (Cnlg) per un giovane sono praticamente nulle. Ma anche portare a casa almeno mille euro lordi al mese è un’impresa se ci sono quotidiani locali, anche di gruppi importanti, che pagano meno di 10 euro un articolo. E on line, a quotazioni di “mercato”, un pezzo viene pagato anche un euro. Lordo. Non è un caso che sempre più colleghi abbiano decisi di cambiare vita, e molto spesso sono i più validi. Ne conosco molti. C’è chi fa l’operaio part time a tempo indeterminato e arrotonda scrivendo (quasi per passione), chi ha mollato tutto per una cattedra da precario alle superiori, chi all’ennesima crisi aziendale ha deciso di andare a lavorare a tempo pieno in fabbrica per mantenere i figli e chi ancora era caporedattore di un noto giornale – oltre che penna di grandissimo talento – e ora si dedica alla botanica. Con risultati di eguale livello, pare. I dati dell’Osservatorio Job pricing, del resto, indicano che nel 2016 un operaio italiano guadagnava mediamente 1.349 euro. Il collaboratore di una televisione locale, a 25 euro lordi a servizio, dovrebbe fare più di 50 uscite (con montaggio annesso) per portare a casa la stessa cifra. Il collaboratore di un quotidiano locale dovrebbe firmare almeno 100 pezzi, tre al giorno. Senza ferie, tredicesima, malattia e possibilità di andare in banca a chiedere un mutuo se privo della firma di papi. Insomma: il vecchio adagio del “sempre meglio che lavorare” è ancora attuale, ma ha drammaticamente cambiato significato. Visto che il giornalismo è diventato per molti un hobby o una moderna forma di schiavitù, quasi al livello dei raccoglitori di pomodori pugliesi. Dunque?
La soluzione. Dunque… Quando qualcuno mi contatta per chiedermi come si fa a diventare giornalista (circostanza piuttosto frequente, visto che gestisco GiornalistiSocial.it) cerco sempre di fornirgli un quadro completo e oggettivo della situazione, per non illudere nessuno. Alcuni si incazzano e spariscono. Altri ringraziano delusi. I più ascoltano, ma non sentono. Una piccola parte comprende che il mestiere del giornalista, nel 2017, ha un senso solo se sussistono due elementi: una grande passione e la volontà di fare gli imprenditori di se stessi. Fare il giornalista, in Italia ma non solo, richiede oggi una grande capacità di adattamento al sistema della comunicazione e un sistema di competenze tecniche estese (fotografia, grafica, video, social, web, seo e anche marketing, parola che farebbe accapponare la pelle a quelli della vecchia scuola) per sopravvivere a un mercato sempre meno chiuso, in cui i concorrenti sono tanto i colleghi e gli aspiranti colleghi, quanto tutti i laureati privi di occupazione e i liberi professionisti dell’articolato mondo web. Ma questo è un altro capitolo. Nel frattempo, è meglio che andiate a fare gli operai. Oppure ribellatevi.
La precarietà dei giornalisti invisibili, scrive il 16 dicembre 2017 Valentina Tatti Tonni su "Articolo 21". Al pari degli altri danno senso alla verità, ma non sono retribuiti e il loro lavoro non è riconosciuto. In Italia c’è un sistema, perlopiù marcio che le cronache ben conoscono. In Italia per conoscere e volendo tutelare l’esercizio di una professione, c’è bisogno di un Ordine di categoria che come una grande impresa regoli gli iscritti con un badge (tessera di riconoscimento) e un’imposta annuale. Potranno lavorare in modo “regolare” solo i soci onorari dell’impresa. Tutti gli altri si sentiranno o saranno, poco labile la differenza, cittadini fuorilegge che svolgono una professione che non gli compete. C’è una diffusa credenza, falsa per il resto del mondo nel quale non esiste alcun Ordine perentorio e nel quale si è quello che si fa, che si diventi professionista solo entrando in possesso di questo magico libretto, lungi la riconoscenza che avrebbe potuto avere Joseph Pulitzer in assenza. Giornalista ed editore puro americano, di certo non si sarebbe sentito meno rispetto a un qualunque collega italiano. L’Italia dunque è una Repubblica fondata sul lavoro circoscritto a pochi eletti. I restanti fuori da questa ristretta cerchia, passano l’esistenza tra un contratto e un lavoro in nero. Nero come la borsa in tempo di guerra. Con un fazzoletto di volontà ben ripiegato nella tasca della giacca, nella loro mente sanno di essere buoni giornalisti ma si potrebbe affermare in loro l’idea di non essere considerati uguali dagli altri colleghi, non tanto per la giacca quanto per i diritti che si nascondono sotto. “Come hai fatto ad accettare un lavoro nero e sporcare così la professione?” si sentirà chiedere con astio, con tutte le colpe rovesciate in capo. E’ vero, avrebbe potuto non accettare e non avere alcuna visibilità, smettere di cercare l’opportunità giusta anche se spesso questo significherà ripiegare la passione e l’istinto. Avrebbe potuto vendere il suo ideale e il suo buon cuore al miglior offerente, barattare il pensiero prima che potesse giurare la sua lealtà alla Costituzione e alla deontologia. Avrebbe persino potuto evitare qualunque interferenza con la parola, sì, ma cosa sarebbe diventato senza la sua identità a contatto con la pelle? Non è giusto fare generalizzazioni. Esistono persone che sono riuscite nel loro intento, pur non avendo parenti o amici pronti a soccorrerli e indirizzarli. Sono riusciti a imboccare una strada e arrivare fino al traguardo senza scuole di giornalismo né aiuti di sorta. Tuttavia ogni persona ha una sua storia, ed è per questo presumo che il legislatore abbia voluto una legge costruita per assistere la professione, che prevedesse le sue problematiche e tentasse di risolverle. La precarietà in questo senso duplice è una di queste problematiche. E’ precario il lavoratore con un contratto provvisorio di cui si ci si attenda un cambiamento e dunque alla quotidianità vi si leghi un’aspettativa e un’ansia maggiore, ma è precario anche quel lavoratore d’altro canto minacciato per il suo operato o in alternativa imputato dinnanzi a una Corte composta di suoi pari che lo giudicheranno “colpevole di Giornalismo”. La condanna è la derisione ma non è possibile schierarsi per ricevere una miglior difesa, poiché da tale imputazione non ci si macchia per assenso generale ma per comportamento. Queste leggi approvate per rendere la precarietà meno illegale di fatto favoriscono l’incongruenza della disparità, non rendendo alcun merito a chi di questo lavoro ha fatto il suo mantra e la sua missione. Accedere a questo lavoro dovrebbe essere una possibilità, non un privilegio. E invece, le possibilità per accedervi sono ad oggi esclusive: frequentazione di una scuola biennale, il praticantato o la pubblicazione di un numero di articoli firmati e stipendiati in modo continuativo, queste le alternative per accedere alla professione. Il problema però è che a dispetto di dieci anni fa, la continuità è una chimera, così come il contratto, il pagamento, il praticantato, per una grande fetta di imprese editoriali presenti sul territorio non è neanche un’opzione. Va da sé che, esclusa la parentela e una dose di fortuna, il giornalismo resti un mondo a sé stante dove non tutti quelli che vogliono entrarvi a far parte ci riescono e, sia detto che, spesso, non è per mancanza di volontà ma a causa della privazione di tutta una serie di cose, come il fatto che sembra non esista più il mentore che ti dica: “Questo pezzo fa schifo, riscrivilo” e da queste sole piccole parole ti trasmetta il suo sapere e mantenga in te il coraggio di tentare. No, oggi il sapere è inserito dentro un cassetto elettronico, sterile e senza spessore umano. Così quella che si gioca è una corsa a ostacoli per vincere la penna d’oro, una corsa nella quale la competitività va a braccetto con la desolante paura di non essere abbastanza. Essendo l’Ordine un ente pubblico che gestisce l’albo associativo dei giornalisti italiani, dal 1963 anno della sua fondazione obbliga chiunque voglia intraprendere la professione a iscriversi e rispettare le sue leggi. Chiunque altro operi da freelance, non iscritto ad alcun registro, pur rispettando le leggi dell’albo cui vorrebbe appartenere per una forma di dipendenza, istiga tutti alla verità ma è un fuorilegge a tutti gli effetti. Se scrive o filma con cognizione lo può fare solo con le dovute precauzioni da cittadino, allargando così sotto di sé la piaga della casta. Può paragonarsi a un abile narratore, ma se vuole sfruttare la pazienza e l’insegnamento di un giornalista la cui realtà si misura con il badge di inserimento deve rischiare un ruolo che si sente addosso ma che non ha. Appartengono a questa fascia di professionisti, i giornalisti invisibili che vivono anni in un limbo fatto di sacrifici. Se lavorano in nero non è per compiacenza ma per necessità, e anzi, sapendo che prima o poi qualcuno potrebbe accorgersi del loro “stato temporaneo”, quasi in attesa trepidante di un visto speciale, sfoderano dalla penna o dalla telecamera un rigoroso senso morale e critico per ovviare al senso di manifesta inadeguatezza nella quale l’Ordine ci colloca. Se è lecito che non tutti si improvvisino del mestiere, che allo stesso modo verrebbe il dubbio del buon operato se un calzolaio si mettesse di punto in bianco a vendere viaggi, diverso sarebbe il caso di un calzolaio che in seguito a dovuti studi e approfondimenti abbia scoperto che è la pianificazione e la vendita del viaggio per conto terzi a rendere la sua vita migliore, sarebbe allora questo il modo per riconoscergli la possibilità di cambiare. Il giornalista invisibile, ugualmente, non può invece essere riconosciuto per l’inosservanza di un iter burocratico e la sua vita dovrà essere vincolata, senza per questo smettere di dare un senso alla verità rischiando tutto quello che gli basterebbe oltrepassare il confine per essere.
Mi sono laureata nonostante gli abusi dei professori. Mi chiamo Carolina, e sono una neolaureata all'Università Statale di Milano. Mi sono sentita moralmente obbligata a scrivere questa lettera, che spero potrà avere una sua risonanza. So che qualche anno fa i quotidiani si erano già occupati dell'incresciosa situazione logistica in alcune facoltà della Statale, una situazione che ha costretto me come centinaia di altri studenti a seguire per interi semestri le lezioni seduti sul pavimento, quando non addirittura in piedi fuori dalle porte e dalle finestre delle aule. Ma in questa sede vorrei invece parlare della condotta dei professori, della quale ingiustamente non si è mai fatto parola. Per natura tendo a non parlare mai di ciò che non conosco direttamente, quindi mi riferirò esclusivamente alle facoltà sotto la dicitura di Studi Umanistici della Statale. Volendo evitare di fare di tutta l'erba un fascio, ammetto volentieri il fatto di aver incontrato durante la mia carriera universitaria professori competenti e disponibili, e mi piacerebbe poter dire che sono la maggioranza. Ma ciò di cui non si parla mai sono gli altri, una vera e propria casta che segue solamente le proprie regole anche e spesso a dispetto degli studenti. Urge fare qualche esempio pratico. Ci sono professori che perdono esami di studenti e non solo non denunciano l'accaduto, ma bocciano gli studenti interessati sperando che loro non arrivino mai a scoprirlo, ma si limitino semplicemente a ripetere l'esame in questione. Ci sono professori che in una giornata di interrogazioni d'esame si prendono ben tre ore di pausa pranzo. Ce ne sono altri che con appelli programmati da mesi, fanno presentare tutti gli studenti iscritti e poi annunciano di dover partire per un viaggio, e che quelli non interrogati si devono ripresentare due settimane dopo. Alcuni si rifiutano, benché avvisati con anticipo, di interrogare gli studenti che hanno seguito il corso con un altro professore non disponibile per l'appello d'esame. E ultimi, ma certamente non per importanza, ci sono i professori che ogni anno mandano fuori corso decine di studenti che hanno finito per tempo gli esami, impedendogli di laurearsi nell'ultima sessione disponibile per loro e costringendoli a pagare un anno intero di retta universitaria perché "non hanno tempo di seguire questa tesi" oppure perché il candidato "è troppo indietro con la stesura, ci sarebbe troppo da fare". Tutti gli episodi sopra citati sono accaduti ad una sola persona, me. E per quanto io mi renda conto di essere stata particolarmente sfortunata, mi riesce difficile pensare di essere l'unica alla quale cose del genere sono successe. Questi veri e propri abusi di potere rendono quasi impossibile per gli studenti godere del generalmente buon livello di istruzione offerto dall'università. Mi includo nel gruppo quando mi chiedo come mai gli studenti non si siano mai fatti sentire, e mi vergogno quasi un po' a scrivere questa lettera con il mio bell'attestato di laurea appeso in stanza, ma la verità è che mi è costato fin troppa fatica, e non ero disposta a mettere a rischio la possibilità di ottenerlo, dal momento che non ero io ad avere il coltello dalla parte del manico. Ma non mi sembrava ad ogni modo corretto lasciare che tali comportamenti passassero sotto silenzio. L'istruzione pubblica dovrebbe essere un diritto, non un privilegio, ed insegnare dovrebbe essere una grande responsabilità, qualcosa di cui non abusare mai. Carolina Forin 14 ottobre 2017 “L’Espresso”
I mediocri del Politically Correct negano sempre il merito. Sostituiscono sempre la qualità con la quantità. Ma è la qualità che muove il mondo, cari miei, non la quantità. Il mondo va avanti grazie ai pochi che hanno qualità, che valgono, che rendono, non grazie a voi che siete tanti e scemi. La forza della ragione (Oriana Fallaci)
“L'Italia tenuta al guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere.
La “Politica” deve essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione."
TIRANNIDE indistintamente appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
"Quando si cerca di far progredire la conoscenza e l'intelligenza umana si incontra sempre la resistenza dei contemporanei, simile a un fardello che bisogna trascinare e che grava pesantemente al suolo, ribelle ad ogni sforzo. Ci si deve consolare allora con la certezza che, se i pregiudizi sono contro di noi, abbiamo con noi la Verità, la quale, dopo essersi unita al suo alleato, il Tempo, è pienamente certa della sua vittoria, se non proprio oggi, sicuramente domani."(Arthur Schopenhauer)
Il pregio di essere un autodidatta è quello che nessuno gli inculcherà forzosamente della merda ideologica nel suo cervello. Il difetto di essere un autodidatta è quello di smerdarsi da solo.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo con la discultura e la disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè a scuola ci hanno fatto credere con i libri di testo che Garibaldi era un eroe ed i piemontesi dei salvatori; perché i media coltivano il luogo comune di un sud Italia cafone ed ignorante; perché la prima cosa che insegnano a scuola è la canzone “bella ciao”? Per poi scoprire da adulti e solo tramite il web: che il Sud Italia è stato depredato a causa proprio di Garibaldi a vantaggio dei Piemontesi; che solo i turisti che scendono a frotte nel meridione d’Italia scoprono quanto ci sia tanto da conoscere ed apprezzare, oltre che da amare; che “Bella ciao” è solo l’inno di una parte della politica italiana che in nome di una ideologia prima tradì l’Italia e poi, con l’aiuto degli americani, vinse la guerra civile infierendo sui vinti, sottomettendoli, con le sue leggi, ad un regime illiberale e clericale.
Ad Avetrana, il paese di Sarah Scazzi, non sono omertosi, sempre che non si tratti di poteri forti. Ma qualcuno certamente vigliacco e codardo lo è. Sapendo che io ho le palle per denunciare le illegalità, questi deficienti usano il mio nome ed appongono falsamente la mia firma in calce a degli esposti che colpiscono i poveri cristi rei di abusi edilizi o commerciali. I cretini, che poi fanno carriera politica, non sanno che i destinatari dei miei strali sono magistrati, avvocati, forze dell’ordine, e comunque pubblici ufficiali o esercenti un pubblico servizio. Che poi queste denunce finiscono nell’oblio perché “cane non mangia cane” e per farmi passare per mitomane o pazzo o calunniatore o diffamatore, è un’altra cosa. Però da parte di questi coglioni prendersela con i poveri cristi per poi far addossare la colpa a me ed essere oggetto di ritorsioni ingiustificate è da veri vigliacchi. D'altronde un paese di coglioni sarà sempre governato, amministrato, giudicato, istruito ed informato da coglioni.
È molto meglio osare cose straordinarie, vincere gloriosi trionfi, anche se screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spirito che non provano grandi gioie né grandi dolori, perché vivono nel grigio e indistinto crepuscolo che non conosce né vittorie né sconfitte. (...) Non è il critico che conta, né l'individuo che indica come l'uomo forte inciampi, o come avrebbe potuto compiere meglio un'azione. L'onore spetta all'uomo che realmente sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore, dal sangue; che lotta con coraggio; che sbaglia ripetutamente, perchè non c'è tentativo senza errori e manchevolezze; che lotta effettivamente per raggiungere l'obiettivo; che conosce il grande entusiasmo, la grande dedizione, che si spende per una giusta causa; che nella migliore delle ipotesi conosce alla fine il trionfo delle grandi conquiste e che, nella peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno cade sapendo di aver osato abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto a quelle anime timide che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta. Franklin Delano Roosevelt
Cari signori, io ho iniziato a destare le coscienze 20 anni prima di Beppe Grillo e nulla è successo. Io non cercavo gli onesti, ma le vittime del sistema, per creare una rivoluzione culturale…ma un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da “coglioni”.
"Il popolo cornuto era e cornuto resta: la differenza è che il fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e la democrazia lascia che ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace, alle proprie corna... Siamo al discorso di prima: non ci sono soltanto certi uomini a nascere cornuti, ci sono anche popoli interi; cornuti dall'antichità, una generazione appresso all'altra...- Io non mi sento cornuto - disse il giovane - e nemmeno io. Ma noi, caro mio, camminiamo sulle corna degli altri: come se ballassimo..." Leonardo Sciascia dal libro "Il giorno della civetta".
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
In una Italia dove nulla è come sembra, chi giudica chi è onesto e chi no?
Lo hanno fatto i comunisti, i dipietristi, i leghisti, i pentastellati. Lor signori si son dimostrati peggio degli altri e comunque servitori dei magistrati. E se poi son questi magistrati a decidere chi è onesto e chi no, allora se tutti stanno dalla parte della ragione, io mi metto dalla parte del torto.
Ognuno di noi, anziché migliorarsi, si giova delle disgrazie altrui. Non pensando che a cercar l’uomo onesto con il lanternino si perde la ragione. Ma anche a cercarlo con la lanterna di Diogene si perde la retta via. Diogene di Sinope (in greco antico Διογένης Dioghénes) detto il Cinico o il Socrate pazzo (Sinope, 412 a.C. circa – Corinto, 10 giugno 323 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Considerato uno dei fondatori della scuola cinica insieme al suo maestro Antistene, secondo l'antico storico Diogene Laerzio, perì nel medesimo giorno in cui Alessandro Magno spirò a Babilonia. «[Alessandro Magno] si fece appresso a Diogene, andandosi a mettere tra lui e il sole. "Io sono Alessandro, il gran re", disse. E a sua volta Diogene: "Ed io sono Diogene, il cane". Alessandro rimase stupito e chiese perché si dicesse cane. Diogene gli rispose: "Faccio le feste a chi mi dà qualcosa, abbaio contro chi non dà niente e mordo i ribaldi."» (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Diogene il Cinico, VI 60). Diogene aveva scelto di comportarsi, dunque, come "critico" pubblico: la sua missione era quella di dimostrare ai Greci che la civiltà è regressiva e di dimostrare con l'esempio che la saggezza e la felicità appartengono all'uomo che è indipendente dalla società. Diogene si fece beffe non solo della famiglia e dell'ordine politico e sociale, ma anche delle idee sulla proprietà e sulla buona reputazione. Una volta uscì con una lanterna di giorno. Questi non indossava una tunica. Portava come solo vestito un barile ed aveva in mano una lanterna. "Diogene! - esclamo Socrate - con quale nonsenso tenterai di ingannarci oggi? Sei sempre alla ricerca, con questa lanterna, di un uomo onesto? Non hai ancora notato tutti quei buchi nel tuo barile?". Diogene rispose: "Non esiste una verità oggettiva sul senso della vita". A chi gli chiedeva il senso della lanterna lui rispondeva: "cerco l'uomo!". “... (Diogene) voleva significare appunto questo: cerco l’uomo che vive secondo la sua più autentica natura, cerco l’uomo che, aldilà di tutte le esteriorità, le convenzioni o le regole imposte dalla società e aldilà dello stesso capriccio della sorte e della fortuna, ritrova la sua genuina natura, vive conformemente a essa e così è felice."
Aste e usura: chiesta ispezione nei tribunali di Taranto e Potenza. Interrogazione dei Senatori Cinque Stelle: “Prassi illegali e vicende inquietanti”, titola “Basilicata 24” nel silenzio assordante dei media pugliesi e tarantini.
Da presidente dell’ANPA (Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati) già dal 2003, fin quando mi hanno permesso di esercitare la professione forense fino al 2006, mi sono ribellato a quella realtà ed ho messo in subbuglio il Foro di Taranto, inviando a varie autorità (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Procura della Repubblica di Taranto, Ministro della Giustizia) un dossier analitico sull’Ingiustizia a Taranto e sull’abilitazione truccata degli avvocati. Da questo dossier è scaturita solo una interrogazione parlamentare di AN del Senatore Euprepio Curto (sol perché ricoprivo l’incarico di primo presidente di circolo di Avetrana di quel partito). Eccezionalmente il Ministero ha risposto, ma con risposte diffamatorie a danno dell’esponente. Da allora e per la mia continua ricerca di giustizia come Vice Presidente provinciale di Taranto dell’Italia dei Valori (Movimento da me lasciato ed antesignano dei 5 Stelle, entrambi a me non confacenti per mia palese “disonestà”) e poi come presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno, per essermi permesso di rompere l’omertà, gli abusi e le ingiustizie, ho subito decine di procedimenti penali per calunnia e diffamazione, facendomi passare per mitomane o pazzo, oltre ad inibirmi la professione forense. Tutte le mie denunce ed esposti e la totalità dei ricorsi presentati a tutti i Parlamentari ed alle autorità amministrative e politiche: tutto insabbiato, nonostante la mafiosità istituzionale è sotto gli occhi di tutti.
I procedimenti penali a mio carico sono andati tutti in fumo, non riuscendo nell’intento di condannarmi, fin anche a Potenza su sollecitazione dei denuncianti magistrati.
Il 3 ottobre 2016, dopo un po’ di tempo che mancavo in quel di Taranto, si apre un ulteriore procedimento penale a mio carico per il quale già era intervenuta sentenza di assoluzione per lo stesso fatto. Sorvolo sullo specifico che mi riguarda e qui continuo a denunciare alla luna le anomalie, così già da me riscontrate molti anni prima. Nei miei esposti si parlava anche di mancata iscrizione nel registro generale delle notizie di reato e di omesse comunicazioni sull’esito delle denunce.
L’ufficio penale del Tribunale è l’ombelico del disservizio. Non vi è traccia degli atti regolarmente depositati, sia ufficio su ufficio (per le richieste dell’ammissione del gratuito patrocinio dall’ufficio del gratuito patrocinio all’ufficio del giudice competente), sia utenza su ufficio per quanto riguarda in particolare la lista testi depositata dagli avvocati nei termini perentori. Per questo motivo è inibito a molti avvocati percepire i diritti per il gratuito patrocinio prestato, non essendo traccia né delle istanze, né dei decreti emessi. Nell’udienza del 3 ottobre 2016, per gli avvocati presenti, al disservizio si è provveduto con una sorta di sanatoria con ripresentazione in udienza di nuove istanze di ammissione di Gratuito patrocinio e di nuove liste testi (fuori tempo massimo); per i sostituiti avvocati, invece, ogni diritto è decaduto con pregiudizio di causa. Non un avvocato si è ribellato e nessuno mai lo farà, perché mai nessuno in quel foro si è lamentato di come si amministra la Giustizia e di come ci si abilita. Per quanto riguarda la gestione degli uffici non si può alludere ad una fantomatica mancanza di personale, essendo l’ufficio ben coperto da impiegate, oltretutto, poco disponibili con l’utenza.
Io ho già dato per fare casino, non foss’altro che ormai sono timbrato tra i tarantini come calunniatore, mitomane o pazzo, facendo arrivare la nomea oltre il Foro dell’Ingiustizia.
La presente, giusto per rendere edotti gli ignoranti giustizialisti e sinistroidi in che mani è la giustizia, specialmente a Taranto ed anche per colpa degli avvocati.
Cane non mangia cane. E questo a Taranto, come in tutta Italia, non si deve sapere.
Questo il commento del dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie ONLUS che ha scritto un libro “Tutto su Taranto. Quello che non si osa dire”.
Un’inchiesta di cui nessuno quasi parla. Si scontrano due correnti di pensiero. Chi è amico dei magistrati, dai quali riceve la notizia segretata e la pubblica. Chi è amico degli avvocati che tace della notizia già pubblicata. "Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico", proverbio cinese. Qualcuno a me disse, avendo indagato sulle loro malefatte: “poi vediamo se diventi avvocato”...e così fu. Mai lo divenni e non per colpa mia.
Dei magistrati già sappiamo. C’è l’informazione, ma manca la sanzione. Non una condanna penale o civile. Questo è già chiedere troppo. Ma addirittura una sanzione disciplinare.
Canzio: caro Csm, quanto sei indulgente coi magistrati…, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 19 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Per il vertice della Suprema Corte questo appiattimento verso l’alto è l’esempio che qualcosa nel sistema di valutazione “non funziona”. La dichiarazione che non ti aspetti. Soprattutto per il prestigio dell’autore e del luogo in cui è stata pronunciata. «Il 99% dei magistrati italiani ha una valutazione positiva. Questa percentuale non ha riscontro in nessuna organizzazione istituzionale complessa». A dirlo è il primo presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio che, intervenuto ieri mattina in Plenum a Palazzo dei Marescialli, ha voluto evidenziare questa “anomalia” che contraddistingue le toghe rispetto alle altre categorie professionali dello Stato. La valutazione di professionalità di un magistrato che era stato in precedenza oggetto di un procedimento disciplinare ha offerto lo spunto per approfondire il tema, particolarmente scottante, delle “note caratteristiche” delle toghe. «È un dato clamoroso – ha aggiunto il presidente Canzio che i magistrati abbiano tutti un giudizio positivo». Questo appiattimento verso l’alto è l’esempio che qualcosa nel sistema di valutazione “non funziona” e che necessita di essere “rivisto” quanto prima. Anche perché fornisce l’immagine di una categoria particolarmente indulgente con se stessa. In effetti, leggendo i pareri delle toghe che pervengono al Consiglio superiore della magistratura, ad esempio nel momento dell’avanzamento di carriera o quando si tratta di dover scegliere un presidente di tribunale o un procuratore, si scopre che quasi tutti, il 99% appunto, sono caratterizzati da giudizi estremamente lusinghieri. Ciò stride con le cronache che quotidianamente, invece, descrivono episodi di mala giustizia. In un sistema “sulla carta” composto da personale estremamente qualificato, imparziale e scrupoloso non dovrebbero, di norma, verificarsi errori giudiziari se non in numeri fisiologici. La realtà, come è noto, è ben diversa. Qualche mese fa, parlando proprio delle vittime di errori giudiziari e degli indennizzi che ogni anno vengono liquidati, l’allora vice ministro della Giustizia Enrico Costa, parlò di «numeri che non possono essere considerati fisiologici ma patologici». Ma il problema è anche un altro. Nel caso, appunto, della scelta di un direttivo, è estremamente arduo effettuare una valutazione fra magistrati che presentato le medesime, ampiamente positive, valutazioni di professionalità. Si finisce per lasciare inevitabilmente spazio alla discrezionalità. Sul punto anche il vice presidente del Csm Giovanni Legnini è d’accordo, in particolar modo quando un magistrato è stato oggetto di una condanna disciplinare. «Propongo al Comitato di presidenza di aprire una pratica per approfondire i rapporti fra la sanzione disciplinare e il conferimento dell’incarico direttivo o la conferma dell’incarico». Alcuni consiglieri hanno, però, sottolineato che l’1% di giudizi negativi sono comunque tanti. Si tratta di 90 magistrati su 9000, tante sono le toghe, che annualmente incappano in disavventure disciplinari. Considerato, poi, che l’attuale sistema disciplinare è in vigore da dieci anni, teoricamente sarebbero 900 le toghe ad oggi finite dietro la lavagna. Un numero, in proporzione elevato, ma che merita una riflessione attenta. Il Csm è severo con i giudici che depositano in ritardo una sentenza ma è di “manica larga” con il pm si dimentica un fascicolo nell’armadio facendolo prescrivere.
Solo un rimbrotto per il pm che "scorda" l'imputato in galera, scrive Rocco Vazzana il 30 novembre 2016 su "Il Dubbio". Il Csm ha condannato 121 magistrati in due anni. Ma si tratta di sanzioni molto leggere. Centoventuno condanne in più di due anni. È il numero di sanzioni che la Sezione Disciplinare del Csm ha irrogato nei confronti di altrettanti magistrati. Il dato è contenuto in un file che in queste ore gira tra gli iscritti alla mailing list di Area, la corrente che racchiude Md e Movimenti. Su 346 procedimenti definiti - dal 25 settembre 2014 al 30 novembre 2016 - 121 si sono risolti con una condanna (quasi sempre di lieve entità), 113 sono le assoluzioni, 15 le «sentenze di non doversi procedere» e 124 le «ordinanze di non luogo a procedere». L'illecito disciplinare riguarda «il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga, in ufficio o fuori, una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario». Le eventuali condanne hanno una gradazione articolata in base alla gravità del fatto contestato. La più lieve è l'ammonimento, un semplice «richiamo all'osservanza dei doveri del magistrato», seguito dalla censura, una formale dichiarazione di biasimo. Poi le sanzioni si fanno più severe: «perdita dell'anzianità» professionale, che non può essere superiore ai due anni; «incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo»; «sospensione dalle funzioni», che consiste nell'allontanamento con congelamento dello stipendio e con il collocamento fuori organico; fino arrivare alla «rimozione» dal servizio. C'è poi una sanzione accessoria che riguarda il trasferimento d'ufficio. Per questo, la sezione Disciplinare può essere considerata il cuore dell'autogoverno. Perché se il Csm può promuovere può anche bloccare una carriera: ai fini interni non serve ricorrere alle pene estreme, basta decidere un trasferimento. E a scorrere il file con le statistiche sui procedimenti disciplinari salta immediatamente all'occhio un dato: su 121 condanne, la maggior parte (90) comminano una sanzione non grave (la censura) e 11 casi si tratta di semplice ammonimento. Le toghe non si accaniscono sulle toghe. La perdita d'anzianità, infatti, è stata inflitta solo a dieci magistrati (due sono stati anche trasferiti d'ufficio), mentre sette sono stati rimossi. Uno solo è stato trasferito d'ufficio senza ulteriori sanzioni, un altro è stato sospeso dalle funzioni con blocco dello stipendio, un altro ancora è stato sospeso dalle funzioni e messo fuori organico. Ma il dato più interessante riguarda le tipologie di illecito contestate. La maggior parte dei magistrati viene sanzionato per uno dei problemi tipici della macchina giudiziaria: il ritardo nel deposito delle sentenze, quasi il 40 per cento dei "condannati" è accusato di negligenze reiterate, gravi e ingiustificate. Alcuni, però, non si limitano al ritardo: il 4 per cento degli illeciti, infatti, riguarda «provvedimenti privi di motivazione», come se si trattasse di un disinteresse totale nei confronti degli attori interessati. Il 23 per cento delle condanne, invece, riguarda una questione che tocca direttamente la vita dei cittadini: la ritardata scarcerazione. E in un Paese in cui si ricorre facilmente allo strumento delle misure cautelari, questo tipo di comportamento determina spesso anche il peggioramento delle condizioni detentive. Quasi il 10 per cento dei giudici e dei pm è stato sanzionato poi per «illeciti conseguenti a reato». Solo il 6,6 per cento delle condanne, infine, è motivato da «comportamenti scorretti nei confronti delle parti, difensori, magistrati, ecc.. ».
Truccati anche i loro concorsi. I magistrati si autoriformino, scrive Sergio Luciano su “Italia Oggi”. Numero 196 pag. 2 del 19/08/2016. Il Fatto Quotidiano ha coraggiosamente documentato, in un'ampia inchiesta ferragostana, le gravissime anomalie di alcuni concorsi pubblici, tra cui quello in magistratura. Fogli segnati con simboli concordati per rendere identificabile il lavoro dai correttori compiacenti pronti a inquinare il verdetto per assecondare le raccomandazioni: ecco il (frequente) peccato mortale. Ma, più in generale, nell'impostazione delle prove risalta in molti casi – non solo agli occhi degli esperti – la lacunosità dell'impostazione qualitativa, meramente nozionistica, che soprattutto in alcune professioni socialmente delicatissime come quella giudiziaria, può al massimo – quando va bene – accertare la preparazione dottrinale dei candidati ma neanche si propone di misurarne l'attitudine e l'approccio mentale a un lavoro di tanta responsabilità. Questo genere di evidenze dovrebbe far riflettere. E dovrebbe essere incrociato con l'altra, e ancor più grave, evidenza della sostanziale impunità che la casta giudiziaria si attribuisce attraverso l'autogoverno benevolo e autoassolutorio che pratica (si legga, al riguardo, il definitivo I magistrati, l'ultracasta, di Stefano Livadiotti).
Ora parliamo degli avvocati. C’è il caso per il quale l’informazione abbonda, ma manca la sanzione.
Un "fiore" da 20mila euro al giudice e il processo si aggiusta. La proposta shock di un curatore fallimentare a un imprenditore. Che succede nei tribunali di Taranto e Potenza? Scrivono di Giusi Cavallo e Michele Finizio, Venerdì 04/11/2016 su “Basilicata 24". L’audio che pubblichiamo, racconta in emblematica sintesi, le dinamiche, di quello che, da anni, sembrerebbe un “sistema” illegale di gestione delle procedure delle aste fallimentari. I fatti riguardano, in questo caso, il tribunale di Taranto. I protagonisti della conversazione nell’audio sono un imprenditore, Tonino Scarciglia, inciampato nei meccanismi del “sistema”, il suo avvocato e il curatore fallimentare nominato dal Giudice.
Aste e tangenti, studio legale De Laurentiis di Manduria nell’occhio del ciclone, scrive Nazareno Dinoi il 9 e 10 novembre 2016 su “La Voce di Manduria”. C’è il nome di un noto avvocato manduriano nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Taranto sulle aste giudiziarie truccate. Il professionista (che non risulta indagato), nominato dal tribunale come curatore fallimentare di un azienda in dissesto, avrebbe chiesto “un fiore” (una mazzetta) da ventimila euro ad un imprenditore di Oria interessato all’acquisto di un lotto che, secondo l’acquirente, sarebbero serviti al giudice titolare della pratica fallimentare. Questo imprenditore che è di Oria, rintracciato e intervistato ieri da Telenorba, ha registrato il dialogo avvenuto nello studio legale di Manduria in cui l’avvocato-curatore avrebbe avanzato la richiesta “del fiore” da 20mila euro. Tutto il materiale, compresi i servizi mandati in onda dal TgNorba, sono stati acquisiti ieri dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri di Taranto.
I presunti brogli nella gestione dei fallimenti. «Infangata la giustizia per scopi elettorali». Il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio, attacca il M5S: preferisce il sensazionalismo all’impegno per risolvere i problemi, scrive il 15 novembre 2016 Enzo Ferrari Direttore Responsabile di "Taranto Buona Sera". «Ma quale difesa di casta, noi come avvocati abbiamo soltanto voluto dire che il Tribunale non è un luogo dove si ammazza la Giustizia». Vincenzo Di Maggio, presidente dell’Ordine degli Avvocati, torna sulla polemica che ha infiammato gli operatori della giustizia negli ultimi giorni: l’interpellanza di un nutrito gruppo di senatori Cinquestelle su presunte nebulosità nella gestione delle procedure fallimentari ed esecutive al Tribunale di Taranto.
«Fallimenti ed esecuzioni, le procedure sono corrette». Documento delle Camere delle Procedure Esecutive e delle Procedure Concorsuali, scrive "Taranto Buona Sera” il 10 novembre 2016. Prima l’interrogazione parlamentare del M5S su presunte anomalie nella gestione delle procedure fallimentari, a scapito di chi è incappato nelle procedure come debitore; poi il video della registrazione di un incontro che sarebbe avvenuto tra un imprenditore, il suo avvocato e un curatore fallimentare. Un video dagli aspetti controversi e dai contenuti comunque tutti da verificare. Un’accoppiata di situazioni che ha destato clamore e che oggi fa registrare la netta presa di posizione della Camera delle Procedure Esecutive Immobiliari e della Camera delle Procedure Concorsuali. In un documento congiunto, i rispettivi presidenti, gli avvocati Fedele Moretti e Cosimo Buonfrate, fanno chiarezza a tutela della onorabilità dei professionisti impegnati come curatori e custodi giudiziari ed esprimendo piena fiducia nell’operato dei magistrati.
Taranto, rimborsi non dovuti. Procura indaga sugli avvocati. Riflettori accesi su 93mila euro spesi tra il 2014 e il 2015 dopo un esposto del Consiglio, scrive Mimmo Mazza su “La Gazzetta del Mezzogiorno” dell’11 aprile 2016. Finiscono all’attenzione della Procura della Repubblica i conti dell’Ordine degli avvocati di Taranto. A rivolgersi alla magistratura è stato lo stesso Consiglio, presieduto da Vincenzo Di Maggio, dopo che sarebbero emerse irregolarità contabili riguardanti le anticipazioni e i rimborsi alle cariche istituzionali nell’anno 2014, l’ultimo da presidente per Angelo Esposito, ora membro dal Consiglio nazionale forense. Il fascicolo è stato assegnato al sostituto procuratore Maurizio Carbone, l’ipotesi di reato è quella di peculato essendo l’Ordine degli avvocati ente di diritto pubblico (altrimenti si procederebbe per appropriazione indebita, ma il pm non sarebbe Carbone in quanto quest’ultimo fa parte del pool reati contro la pubblica amministrazione). Di questo se ne è parlato agli inizi, perché l’esposto era dello stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, ma poi nulla si è più saputo: caduto nell’oblio. Il silenzio sarà rotto, forse, dalla inevitabile prescrizione, che rinverdirà l’illibatezza dei presunti responsabili.
E poi c’è il caso, segnalato da un mio lettore, di una eccezionale sanzione emessa dalla magistratura tarantina e taciuta inopinatamente da tutta la stampa.
La notizia ha tutti i crismi della verità, della continenza e dell’interesse pubblico e pure non è stata data alla pubblica opinione.
Il caso di cui trattasi si riferisce ad un esposto di un cittadino, presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto contro un avvocato di quel foro per infedele patrocinio, di cui già pende giudizio civile.
Ma facciamo parlare gli atti pubblicabili.
L’11 maggio 2012 viene presentato l’esposto, il 3 aprile 2013 con provvedimento di archiviazione, pratica 2292, si emette un documento in cui si dichiara che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto delibera la sua archiviazione in quanto “non risultano elementi a carico del professionista tali da configurare alcuna ipotesi di infrazione disciplinare”. L’atto è sottoscritto il 17 novembre 2014, nella sua copia conforme, dall’avv. Aldo Carlo Feola, Consigliere Segretario. Mansione che il Feola ricompre da decenni.
Fin qui ancora tutto legittimo e, forse, anche, opportuno.
E’ successo che, con procedimento penale 2154/2016 R.G.N.R. Mod. 21, il 3 ottobre 2016 (depositata il 6) il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, dr Maurizio Carbone, chiede il Rinvio a Giudizio dell’avv. Aldo Carlo Feola, difeso d’ufficio, “imputato del delitto di cui all’art. 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), perché, in qualità di Consigliere con funzione di Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, rilasciava copia conforme all’originale della delibera datata 3 aprile 2013 del Consiglio, con la quale si disponeva di non dare luogo ad apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. Addolorata Renna, con conseguente archiviazione dell’esposto presentato nei suoi confronti da Blasi Giuseppe. Provvedimento di archiviazione risultato in realtà inesistente e mai sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di Taranto. In Taranto il 17 novembre 2014.”
Il Giudice per le Indagini Preliminari, con proc. 6503/2016, il 21 novembre 2016 fissa l’Udienza Preliminare per il 12 dicembre 2016 e poi rinvia per il Rito Abbreviato per il 10 aprile 2017 con interrogatorio dell’imputato ed audizione del teste, con il seguito.
Il Giudice per l’Udienza Preliminare, dr. Pompeo Carriere, il 16 ottobre 2017 con sentenza n. 945/2017 “dichiara Feola Aldo Carlo colpevole del reato ascrittogli, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento. Pena sospesa per cinque anni, alle condizioni di legge, e non menzione. Visti gli artt. 538, 539, 541 c.p.p., condanna Feola Aldo Carlo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla medesima sostenute, che si liquidano in complessivi euro 3.115,00 (tremilacentoquindici) oltre iva e cap come per legge”.
Da quanto scritto è evidente che ci sia stata da parte della stampa una certa ritrosia dal dare la notizia. Gli stessi organi di informazione che sono molto solerti ad infangare la reputazione dei poveri cristi, sennonchè non ancora dichiarati colpevoli.
Travaglio: “I giornali a Taranto non scrivono nulla perchè sono comprati dalla pubblicità”. “E’ vero, ma non per tutti…” Lettera aperta al direttore de IL FATTO QUOTIDIANO, dopo il suo intervento-show al Concerto del 1 maggio 2015 a Taranto, di Antonello de Gennaro del 2 maggio 2015 su "Il Corriere del Giorno". "Caro Travaglio, come non essere felice nel vedere Il Fatto Quotidiano, quotidiano libero ed indipendente da te diretto, occuparsi di Taranto? Lo sono anche io, ma nello stesso tempo, non sono molto soddisfatto della tua “performance” sul palco del Concerto del 1° maggio di Taranto. Capisco che non è facile leggere il solito “editoriale”, senza il solito libretto nero che usi in trasmissione da Michele Santoro, abitudine questa che deve averti indotto a dire delle inesattezze in mezzo alle tante cose giuste che hai detto e che condivido. Partiamo da quelle giuste. Hai centrato il problema dicendo: “A Taranto i giornali non scrivono nulla perchè sono comprati dalla pubblicità”. E’ vero e lo provano le numerose intercettazioni telefoniche contenute all’interno degli atti del processo “Ambiente Svenduto” e per le quali il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia tergiversa ancora oggi nel fare chiarezza sul comportamento dei giornalisti locali coinvolti, cercando evidentemente di avvicinarsi il più possibile alla prescrizione amministrativa dei procedimenti disciplinari e salvarli”.
Comunque, a parte i distinguo di rito dalla massa, di fatto, però, nessuno di questa sentenza ne ha parlato.
In conclusione, allora, va detto che si è fatto bene, allora, ad indicare la notizia della condanna del Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, come un fatto tra quelli che a Taranto son si osa dire…
Chi dice Terrone è solo un coglione. La sperequazione inflazionata di un termine offensivo come nota caratteristica di un popolo fiero. L’approfondimento del dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, che sul tema ha scritto “L’Italia Razzista” e “Legopoli”.
Sui media spopola il termine “Terrone”. Usato dai razzisti del centro Nord Italia in modo dispregiativo nei confronti degli italiani del Sud Italia ed usati dai deficienti meridionali come caratteristica di vanto.
«Non è un reato dare dei terroni ai terroni, indi per cui i terroni sono terroni, punto. Arrivano dalla Terronia, terra di mezzo», diceva al telefono, parlando di un calabrese, una delle campionesse della Capitale Morale, quella Maria Paola Canegrati che smistava affarucci e mazzette per appalti nella Sanità, per circa 400 milioni di euro, a quanto è venuto fuori sinora. Naturalmente, lady Mazzetta, non sa che, invece, dire “terrone” con l'intento di offendere, è reato: ci sono sentenze, anche della Cassazione. Ma a lei deve sembrare un'ingiustizia! «Che cazzo ti devo dire, se adesso è un reato dare del terrone a un terrone, a 'sto punto qui io voglio diventare cittadina omanita»...., scrive Pino Aprile il 22 febbraio 2016.
«Io litigioso? È vero, ma sono migliorato… Mi chiamavano terun, africa, baluba, altro che non incazzarsi…» Dice Teo Teocoli in un intervista a Gian Luigi Paracchini il 22 luglio 2016 su "Il Corriere della Sera".
Gli opinionisti del centro Italia “po’ lentoni” (lenti di comprendonio, anche se oggi l’epiteto, equivalente a “Terrone”, da rivolgere al settentrionale è “Coglione”) su tutti i media la menano sulla terronialità. Cioè l’usare il termine “terrone” come una parola neutra. Come se fossero un po’ tutti leghisti.
Scandali e le mani della giustizia sulla Lega Padania. Come tutti. Più di tutti. I leghisti continuano a parlare, anziché mettersi una maschera in faccia per la vergogna. Su di loro io, Antonio Giangrande, ho scritto un libro a parte: “Ecco a voi i leghisti: violenti, voraci, arraffoni, illiberali, furbacchioni, aspiranti colonizzatori. Non (ri)conoscono la Costituzione Italiana e la violano con disprezzo”. Molti di loro, oltretutto, sono dei meridionali rinnegati. Terroni e polentoni: una litania che stanca. Terrone come ignorante e cafone. Polentone come mangia polenta o, come dicono da quelle parti, po’ lentone: ossia lento di comprendonio. Comunque bisognerebbe premiare per la pazienza il gestore della pagina Facebook “Le perle di Radio Padania”, ovvero quelli che per fornire una “Raccolta di frasi, aforismi e perle di saggezza dispensate quotidianamente dall’emittente radiofonica “Radio Padania Libera” sono costretti a sentirsela tutto il giorno. Una gallery di perle pubblicate sulla radio comunitaria che prende soldi pubblici per insultare i meridionali.
Si perde se si rincorre il Sud come passato, si vince se il Sud è vissuto oggi come consapevolezza di non poterne fare a meno. Accettare di essere comunque meridionale e non terrone a qualunque latitudine. Il treno porta giù, un altro mezzo ti può portare in qualunque altro luogo senza farti dimenticare chi sei e da dove vieni. A chi appartieni? Così si dice al Sud quando ti chiedono chi sia la tua famiglia. È un'espressione meravigliosa: si appartiene a qualcuno, si appartiene anche ai luoghi che vivono dentro di te.
Essere orgogliosi di essere meridionali. Il meridionale non è migrante: è viaggiante con nostalgia e lascia il cuore nella terra natia.
Ciononostante i nordisti, anziché essere grati al contributo svolto dagli emigrati meridionali per il loro progresso sociale ed economico, dimostrano tutta la loro ingratitudine.
Mutuiamo il titolo del libro di Lino Patruno “Alla riscossa Terroni” e “Terroni” di Pino Aprile per farne un motivo di orgoglio meridionale che deve portarci ad invertire una tendenza che data 150 anni. Non rivendichiamo un passato di benessere del Meridione, rivendichiamo un presente migliore per un Sud messo alle corde.
I terroni nascono anche a Gemonio e nelle valli bergamasche, scrive "L'Inkiesta" il 6 aprile 2012. Leggendo le cronache, ma, soprattutto, vedendo le immagini, relative al marciume che sta venendo a galla dai sottoscala leghisti, mi par che si possa dire una grande verità: l'aggettivo spregiativo "terrone" non si può appioppare solo ai meridionali, ma, con grande precisione, anche ai miei conterronei nordici. Devo dire la verità. Io - nordico e fieramente antileghista da molto tempo - che le storie di Roma ladrona, dell'uccello duro, del barbarossa, dell'ampolla sul diopò (che, a dire il vero, mi par più una saracca che un rito), di riti celtici, di fazzolettini verdi come il moccio, erano tutte una rozza e ignorante presa per il culo per ammansire i buoi e farsi in comodo i sollazzi propri, ne ero convinto da tempo. Da ben prima che si svegliassero i soliti magistrati (verrà il giorno, in questo paese dei matocchi, che qualche rivoluzione la farò il popolo?), bastava un po' di fiuto per capire che il sottobosco era questo. Ma le vedete le facce del cerchio magico? Ma avete presente la pacchianità della villa di Gemonio? E poi, la priorità alla "family", come la più bieca usanza del troppo noto familismo amorale, perchè parlare di "famigghia" era troppo terrone. Ma il dato è che questi sono - culturalmente, esteticamente e antropologicamente - terroni. Perchè terrone, per me, non è un epiteto riferibile a una provenienza geografica I.G.P.; è uno stile deteriore di rappresentarsi, chiuso, retrivo, in cui il dialetto non è cultura, ma rozzume esibito con orgoglio (e questo vale tanto per i napoletani, quanto per i veneti), in cui prevale la logica del clan su quella della civile società, in cui si deve fare sfoggio dell'ignoranza perchè questo è "popolare". Terrone è un ignorante retrogrado, cafone, ineducato. Con il risultato che il Bossi e la family sprofondano, il terronismo impera e un peloso, stantio e pietistico meridionalismo riprende fiato. Grazie Bossi, grazie leghisti: avete ucciso non solo la dignità del nord, ma anche la speranza vera che una riforma moderna di questo paese, tenuto insieme con una scatarrata, si potesse fare. Ah, dimenticavo. Se qualcuno mi dovesse dire "parla lui, di ignoranza presentata con orgoglio.
Da che pulpito vien il sermone!", dico: "Non perdete tempo in analisi: son diverso e me ne vanto. Si vuol che dica che sono ignorante e delinquente. Bene lo sono, in un mondo di saccenti ed onesti mafiosi, sono orgoglioso di esser diverso. Cosa concludere, di fronte a tali notizie di carattere storico? Questo: trovo triste che i nostri bravi leghisti rinneghino le proprie radici arabe, albanesi, meridionali, mediterranee. Da loro, così orgogliosi della Tradizione, non me lo aspettavo. Anzi dirò di più. Buon per loro avere origini meridionali, perchè ad essere POLENTONI si rischia di avere una considerazione minore che essere TERRONE.
Secondo Wikipedia Il termine polentone è un epiteto, con una connotazione negativa, utilizzato per indicare gli abitanti dell'Italia settentrionale. Origine e significato. Letteralmente significa mangiatore di polenta, un alimento, questo, storicamente molto diffuso nella cucina povera dell'Italia settentrionale. Fino ai primi anni del XX secolo, infatti, la polenta rappresentava l'alimento base, se non esclusivo, delle popolazioni del nord Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte ecc.) con conseguenze nefaste sulla salute di molti soggetti spesso vittime della pellagra. Polentone, come stereotipo linguistico, ha assunto, quindi, un significato spregiativo, e sta ad indicare una persona zotica un pò lenta di comprendonio (po' lentone). Il termine si è inserito nella dialettica campanilistica fra abitanti del nord e del sud della penisola, essendo usato in contrapposizione all'appellativo terrone: ambedue le parole hanno connotazioni antietniche, tese a rimarcare una asserita inferiorità etnica e culturale. Lo stesso epiteto è utilizzato in Val Padana, soprattutto in Lombardia (pulentùn), per indicare una persona lenta e dai movimenti goffi e impacciati.
Analisi dei termini offensivi. Il termine polentone è un epiteto, con una connotazione negativa, utilizzato dagli abitanti dell'Italia meridionale per indicare gli abitanti dell'Italia settentrionale, scrive Wikipedia. Letteralmente significa mangiatore di polenta, un alimento, questo, storicamente molto diffuso nella cucina povera dell'Italia settentrionale. Fino ai primi anni del XX secolo, infatti, la polenta rappresentava l'alimento base, se non esclusivo, delle popolazioni del nord Italia (Lombardia, Veneto, Piemonte ecc.) purtroppo con conseguenze nefaste sulla salute di molti soggetti spesso vittime della pellagra, anche se li ha salvati da tante carestie alimentari. Polentone, come stereotipo linguistico, ha assunto, quindi, un significato spregiativo nell'Italia del Sud, e sta ad indicare una persona zotica. Il termine si è inserito nella dialettica campanilistica fra abitanti del nord e del sud della penisola, essendo usato in contrapposizione all'appellativo terrone: ambedue le parole hanno connotazioni antietniche, tese a rimarcare una asserita inferiorità etnica e culturale, anche se spesso usate solo in modo bonario. Lo stesso epiteto è utilizzato in Val Padana, soprattutto in Lombardia (pulentùn), per indicare una persona lenta di comprendonio (tonta) e dai movimenti goffi e impacciati.
La Padania o Patanìa (lett. Terra dei Patanari, coltivatori di patate) si estende in tutte le regioni del nord Italia: dalla Val d'Aosta alla Toscana fino al Friuli Venezia Giulia. È facile collocare geograficamente la Patanìa vera e pura: si traccia una retta che attraversa interamente il Po, passando rigorosamente al centro, perché solo la parte nord del Po è padana. La Padania si definisce anche Barbaria, cioè terra di barbari. Il mito di una terra popolata da eroi celtici, circondata da terribili barbari di matrice slava, è il concetto su cui si basa la Lega Nord. Trascurabile il dettaglio che un tempo la Padania fosse abitata da un'accozzaglia di popoli oltre ai Celti.
Terrone è un termine della lingua italiana, utilizzato dagli abitanti dell'Italia settentrionale e centrale come spregiativo per designare un abitante dell'Italia meridionale, talvolta anche in senso semplicemente scherzoso, scrive Wikipedia. In passato il termine era utilizzato con un altro significato e valenza; solo nel corso degli anni sessanta ha acquisito il senso attuale. Con il termine "terrone" (da teróne, derivazione di terra) si indicava nel XVII secolo un proprietario terriero, o meglio un latifondista. Già tra le Lettere al Magliabechi, l'erudito bibliotecario Antonio Magliabechi (1633-1714) il cui lascito, i cosiddetti Codici Magliabechiani costituiscono un prezioso fondo della Biblioteca Nazionale di Firenze, scriveva (CXXXIV -II - 1277): «Quattro settimane sono scrissi a Vostra Signoria illustrissima e l'informai del brutto tiro che ci fanno questi signori teroni di volerci scacciare dal partito delle galere, contro ogni equità e giustizia, già che ho lavorato tant'anni per terminarlo, e ora che vedano il negozio buono, lo vogliono per loro». Il termine in seguito fu utilizzato per denominare chi era originario dell'Italia meridionale e con particolare riferimento a chi emigrava dal Sud al Nord in cerca di lavoro, al pari dei nordici milanesi, etichettati come baggiani, che emigravano nelle valli del Bergamasco, come menzionato da Alessandro Manzoni. Il termine si diffuse dai grandi centri urbani dell'Italia settentrionale con connotazione spesso fortemente spregiativa e ingiuriosa e, come altri vocaboli della lingua italiana (quali villano, contadino, burino e cafone) stava per indicare "servo della gleba" e "bracciante agricolo" ed era riferita agli immigrati del meridione. Gli immigrati venivano quindi considerati, sia pure a livello di folklore, quasi dei contadini sottosviluppati. Il termine, che deriva evidentemente da "terra" con un suffisso con valore d'agente o di appartenenza (nel senso di persona appartenente strettamente alla terra) è stato variamente interpretato come frutto di incrocio fra terre (moto) e (meridi)one, come "mangiatore di terra" parallelamente a polentone, "mangiapolenta", cioè l'italiano del nord; come "persona dal colore scuro della pelle, simile alla terra" o anche come "originario di terre soggette a terremoti" ("terre matte", "terre ballerine"). Il suo maggiore utilizzo data comunque essenzialmente agli anni sessanta e settanta e limitatamente ad alcune zone del nord Italia, in seguito alla forte ondata di emigrazione di lavoratori e contadini del meridione d'Italia in cerca di lavoro verso le industrie del nord e in particolare del triangolo industriale (Genova – Milano – Torino). In tale ambito si spiega anche la diffusione del termine: storicamente, grossi movimenti di popolazioni hanno sempre portato con sé anche fenomeni di intolleranza o razzismo più o meno larvati. Successivamente, allo stesso modo è sorta la locuzione "terrone del nord", generalmente per indicare gli italiani del nord-est (principalmente i veneti, detti "boari"), che per ragioni simili cominciarono negli stessi anni ad emigrare verso il nord-ovest, venendo così accomunati agli emigranti meridionali. Il riconoscimento di terrone come insulto e non come termine folkloristico è un processo che storicamente ha subito molte battute d'arresto e incomprensioni, probabilmente dovute al fatto che solo una parte della popolazione italiana ne riconosceva pienamente la gravità e il suo carattere offensivo. La Corte di Cassazione ha ufficialmente riconosciuto che tale termine ha un'accezione offensiva, confermando una sentenza del Giudice di Pace di Savona e confermando che la persona che l'aveva pronunciata dovesse risarcire la persona offesa dei danni morali. Spesso vengono associati a questo epiteto caratteristiche personali negative, tra le quali ignoranza, scarsa voglia di lavorare, disprezzo di alcune norme igieniche e soprattutto civiche. Analogamente, soprattutto in alcune accezioni gergali, il termine ha sempre più assunto il significato di "persona rozza" ovvero priva di gusto nel vestire, inelegante e pacchiana, dai modi inurbani e maleducata, restando un insulto finalizzato a chiari intenti discriminatori. Inoltre vengono spesso associati al termine anche tratti somatici e fisici, come la carnagione scura, la bassa statura, le gote alte, caratteristiche fisiche storicamente preponderanti al Sud rispetto al Nord Italia.
In conclusione c’è da affermare che bisogna essere orgogliosi di essere meridionali. Il meridionale non è migrante: è viaggiante con nostalgia e lascia il cuore nella terra natia.
Chi proferisce ingiurie ad altri o a se stesso con il termine terrone non resta che rispondergli: SEI SOLO UN COGLIONE.
Si evade il fisco più al Nord che al Sud. E’ uno dei dati che emerge dal rapporto sulla lotta all’evasione redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo Padoan, la somma totale delle principali imposte evase (Iva, Ires, Irpef e Irap) ammonta a 91 miliardi. Il 52% di questa cifra si attesta dunque nel Settentrione, contro i 24 miliardi del centro (26% del totale) e i 19,8 miliardi del Meridione (22%). Il dato è influenzato dal maggior reddito nazionale del Nord. Soprattutto, scrivono i tecnici del Tesoro, la rabbrividire la percentuale di verifiche sulle imprese che trova irregolarità fiscali: è 98,1% tra le grandi, al 98,5% sulle medie e al 96,9% sulle Pmi. Il record tocca agli enti non commerciali, il 99,2% non è in regola. 100% di `positività´ i controlli sugli atti soggetti a registrazione. Ad ogni modo, l’evasione effettiva ‘pizzicata’ dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, ha rilevato il Mef, ammonta a 24,5 miliardi. La maggiore imposta accertata è così salita dell’87% in sette anni, rispetto ai 13,1 miliardi del 2006. Un numero in calo rispetto agli anni 2009-2012 e soprattutto rispetto al picco di 30,4 miliardi del 2011.
LA BALLA DELLA SPEREQUAZIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI DEL NORD A FAVORE DI QUELLE DEL SUD.
In Regione Lombardia non tornano 54 miliardi di tasse versate. (Lnews - Milano 06 settembre 2017). "La Lombardia è la regione che versa più tasse allo Stato ricevendo, in cambio, meno trasferimenti in termini di spesa pubblica. In questi anni, infatti, il residuo fiscale della Lombardia ha raggiunto la cifra record di 54 miliardi (fonte: Eupolis Lombardia). Si tratta del valore in assoluto più alto tra tutte le regioni italiane. Un'immensità anche a livello europeo se si pensa che due regioni tra le più industrializzate d'Europa come la Catalogna e la Baviera hanno rispettivamente un residuo fiscale di 8 miliardi e 1,5 miliardi". Lo scrive una Nota pubblicata oggi dal sito lombardiaspeciale.regione.lombardia.it.
RESIDUO FISCALE - "Con il termine residuo fiscale - spiega la Nota - s'intende la differenza tra quanto un territorio verso allo Stato sotto forma di imposte e quanto riceve sotto forma di spesa pubblica. Se il residuo fiscale abbia segno positivo, il territorio versa più di quanto riceve; se c'è un residuo negativo il territorio riceve più di quanto versa. Secondo James McGill Buchanan Jr, premio Nobel per l'Economia nel 1986, cui si attribuisce la paternità della definizione, il trattamento che lo Stato riserva ai cittadini può considerarsi equo se determina residui fiscali minimi in capo a individui, a prescindere dal territorio nel quale risiedono. Differenze marcate denotano una violazione dei principi di equità basilari".
I DATI PER REGIONE - "Dopo la Lombardia - appunta il teso - si colloca l'Emilia Romagna, con un residuo fiscale di 18.861 milioni di euro. Seguono Veneto (15.458 mln), Piemonte (8.606 mln), Toscana (5.422 mln), Lazio (3.775 mln), Marche (2.027 mln), Bolzano (1.100 mln), Liguria (610 mln), Friuli Venezia Giulia (526 mln), Valle d'Aosta (65 mln). In coda alla classifica: Umbria (-82 mln), Molise (-614 mln), Trento (-249 mln), Basilicata (-1.261 mln), Abruzzo (-1.301 mln), Sardegna (-5.262 mln), Campania (-5.705 mln), Calabria (-5.871 mln), Puglia (-6.419 mln) e Sicilia (-10.617 mln)".
IL DATO PRO CAPITE - Anche per quanto riguarda il residuo fiscale pro capite, la Lombardia presenta i valori più alti d'Italia, con 5.217 euro. Seguono Emilia Romagna (4.239), Veneto (3.141), Provincia Autonoma di Bolzano (2.117), Piemonte (1.950), Toscana (1.447), Marche (1.310), Lazio (641), Valle d'Aosta (508), Friuli Venezia Giulia (430), Liguria (386), Umbria (-92), Provincia Autonoma di Trento (-464), Campania (-974), Abruzzo (-979), Puglia (-1.572), Molise (-1.963), Sicilia (-2.089), Basilicata (-2.192), Calabria (-2.975) e Sardegna (-3.169)", spiega la Nota pubblicata.
Da sempre i giornali e le tv nordiste, spalleggiate dagli organi d’informazione stataliste, ce la menano sul fatto che ci sia un grande disavanzo finanziario tra le regioni del centro-nord ricco e le regioni povere del sud Italia. I conti, fatti in modo bizzarro, rilevano che il centro-nord paga molto di più di quanto riceva e che la differenza vada in solidarietà a quelle regioni che a loro volta sono votate allo spreco ed al ladrocinio. A fronte di ciò, i settentrionali, hanno deciso che è meglio tagliare quel cordone ombelicale e lasciar cadere quella zavorra che è il sud Italia. Ed il referendum secessionista è stato organizzato per questo, facendo leva sull’ignoranza della gente.
Ora facciamo degli esempi scolastici che si studiano negli istituti tecnici commerciali, per dimostrare di quanta malafede ed ignoranza sia propagandato questo referendum.
Una partita iva, persona o società, registra in contabilità la gestione e versa tasse, imposte e contributi nel luogo della sede legale presso cui redige i suoi bilanci semplici o consolidati (gruppi d’impreso con un capogruppo).
Il Centro-Nord Italia, con la Lombardia ed il Lazio in particolare, è territorio privilegiato per eleggere sede legale d’azienda, per la vicinanza con i mercati europei. Dove c’è sede legale vi è iscrizione al registro generale dell’imprese. Ergo: sede di versamento fiscale che alimenta quei numeri, oggetto di nota della Regione Lombardia. Quei dati, però, spesso, nascondono la ricchezza prodotta al sud (stabilimenti, appalti, manodopera, ecc.), ma contabilizzata al nord.
E’ risaputo che nel centro-nord Italia hanno stabilito le loro sedi legali le più grandi aziende economiche-finanziarie italiane e lì pagano le tasse. Il Sud Italia è di fatto una colonia di mercato. Di là si produce merce e lavoro (e disinformazione), di qua si consuma e si alimenta il mercato.
E’ risaputo che le aziende del centro nord appaltano i grandi lavori pubblici, specialmente se le aziende del sud Italia le fanno chiudere con accuse artefatte di mafiosità.
E’ risaputo che al nord il costo della vita è più caro e questo si trasforma proporzionalmente in reddito maggiorato rispetto ai cespiti collegati, come quelli immobiliari.
Il residuo fiscale era tollerato e l’assistenzialismo era alimentato, affinchè il mercato meridionale non cedesse e le aziende del nord potessero continuare a produrre beni e servizi e ad alimentare ricchezza nell’Italia settentrionale, condannando il sud ad un perenne sottosviluppo e terra di emigrazione.
Oggi lo Stato centralista assorbe tutta la ricchezza nazionale prodotta e l'assistenzialismo si è bloccato, ma il sud Italia continua ad essere un mercato da monopolizzare da parte delle aziende del Centro-Nord Italia. Una eventuale secessione a sfondo razzista-economica votata dai nordisti sarebbe un toccasana per i meridionali, che imporrebbero diversi rapporti commerciali, imponendo dei dazi od altre forme di limitazioni alle merci del nord. Il maggior costo di beni e servizi del nord Italia favorirebbe la nascita nel sud Italia di aziende, favorite economicamente dal minor costo della mano d’opera del posto e delle spese di trasporto e logistica locale. Inoltre quello che produce il centro nord è acquisibile su altri mercati. Quello che si produce al Sud Italia è peculiare e da quel mercato, per forza, bisogna attingere e comprare...
Quindi, viva il referendum…secessionista
A votare per questo referendum sono andati i mona. Questo l'ha detto lei, ma è vero". Risponde così il 24 ottobre 2017 all'intervistatore del programma Morning Showdi di Radio Padova il milanese Oliviero Toscani, il noto fotografo già protagonista, nel recente passato, di polemiche sui "veneti popolo di ubriaconi". "Sono andati a votare quattro contadini - rincara la dose - che non parlano neanche l'italiano". E ancora: "Nelle campagne la gente è isolata, incestuosa e vota queste cagate qua". Per lo stesso Toscani, invece, a non votare è stata "la minoranza intellettuale". Così il fotografo, maestro della provocazione, ritorna ad aprire una ferita solo apparentemente chiusa che aveva portato a querele all'epoca degli “imbriagoni”. Nell'intervista radiofonica sui referendum ha anche evidenziato un confronto con la Lombardia dove la percentuale di voto è stata minore. «Non a caso Milano - ha rilevato - è la prima città d'Italia per intellighenzia, e non a caso Milano è una città piena di immigrati. Milano è fatta così, è civile. Mentre i contadini là, che non parlano neanche italiano, cosa vuoi che votino?».
Paradosso sanità: il Sud paga più tasse perché i pazienti devono andare al Nord per curarsi. La mobilità sanitaria passiva ha un impatto enorme sui bilanci delle strutture meridionali. E le Regioni così devono aumentare le aliquote e chiudere strutture, scrive Gloria Riva il 18 gennaio 2018 su "L'Espresso". La distanza fra Catanzaro e Milano la si può calcolare in chilometri, sono 1.159, o in anni di vita in meno, che sono quattro. E in generale la prospettiva di vita in Calabria è molto più simile a quella di Romania o Bulgaria, mentre al Nord si sta come in Svezia. Tutto questo nonostante i cittadini del settentrione spendano in media 1.961 euro a testa per la sanità pubblica, quelli del Sud 1.799 e quelli del Centro 1.928 euro. Insomma, i quattrini da sborsare sono più o meno gli stessi, ma c'è un divario di assistenza sanitaria. Torniamo in Calabria: qui ogni cittadino sborsa 1.875 euro l'anno per la sanità pubblica, di cui 126 euro se ne vanno per pagare il conto presentato da altre Regioni, spesso del Nord, dove i compaesani calabresi sono andati a curarsi. Già, perché nel 2016 il 40,7 per cento dei malati di cancro della Calabria ha scelto l'ospedale di un'altra regione per curarsi. Dall'altro lato la Lombardia ha visto arrivare da fuori regione quasi 17 mila malati oncologici nei propri ospedali. Quell'immigrazione sanitaria consente ai lombardi di spendere “solo” 1.877 euro per una sanità d'eccellenza, risparmiandone 54, pagati appunti dai migranti in cerca di cure. Francesco Masotti è un dirigente sanitario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ed è anche segretario della Cgil Medici, a L'Espresso racconta la storia del commissariamento della sanità calabrese, iniziato nel 2010 e mai terminato: «Siamo al terzo piano di rientro e pare che i conti siano in peggioramento di oltre 30 milioni di euro», tutta colpa di inaspettate poste in bilancio che il commissario Massimo Scura si trova a dover contabilizzare per via di dimenticati debiti pregressi, contenziosi finanziari risalenti a 10 anni fa, recuperi di tariffe mai ritoccate ed esplose in questi ultimi anni, e poi saldi per la mobilità passiva. Rieccola, la mobilità passiva, il grande buco che attanaglia la sanità calabrese e non solo, che da sola si mangia il 65 per cento delle finanze locali. Secondo il rapporto Cergas Bocconi sullo stato di salute del Sistema Sanitario Nazionale, la Calabria da sola genera l'otto per cento dei viaggi sanitari verso altre regioni e un paziente su sei si ricovera fuori regione generando un debito per le tasche dei calabresi di 304 milioni. Una voragine. Succede perché il conto delle cure negli ospedali del Nord viene presentato alla regione Calabria. E visto che l'Italia da 17 anni si è dotata di un sistema federale per la sanità, ogni Regione, attraverso l'Irpef e l'Irap, cioè le tasse pagate dai lavoratori e dalle aziende, deve riuscire a coprire le spese per curare i propri cittadini. Ma non tutte ce la fanno. Va da sé che le Regioni con meno occupazione e povere di industria sono entrate subito in affanno e i sistemi sanitari locali sono stati ben presto commissariati. Per rimettersi in sesto, s'è provveduto a chiudere gli ospedali, ridurre i posti letto e bloccare l'assunzione di nuovi medici e infermieri, al punto che in queste regioni il personale è crollato del 15 per cento. Lo stesso è successo per i livelli essenziali di assistenza: «Il dato della Campania è davvero allarmante perché, rispetto al 2014 le performance si sono ridotte di oltre 30 punti. Ma ci sono peggioramenti anche in Puglia, Molise e Sicilia», si legge nell'indagine Cergas Bocconi, che continua spiegando come il piano di risanamento dei conti della sanità sia ancora in atto in cinque Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e il Lazio che dovrebbe presto uscirne dopo un decennio lacrime e sangue. Mentre la Calabria sembra lontanissima dal traguardo e «ci apprestiamo a entrare nel quarto programma di rientro. Il che significa altri tagli per il sistema sanitario calabrese, già ridotto all'osso. Ne usciremo mai?», si domanda Masotti, che spiega come il disavanzo venga pagato con un aumento delle tasse, dell'Irap e dell'Irpef. Arrivando a situazioni assurde, per cui un operaio di Varese versa l'1,58 di aliquota Irpef per la sanità, il suo collega di Gioia Tauro paga di più, l'1,73, ma poi «va in Lombardia a curarsi». Anche perché in Campania negli 10 anni sono andati in pensione 4.500 operatori - medici e infermieri - mai sostituiti. Ed è stata predisposta la chiusura di una miriade di piccoli ospedali, «a cui nessuno si è opposto, perché tutti ritenevamo fossero pericolosi per il cittadino e per gli operatori sanitari», dice il medico, che aggiunge: «Quei luoghi di cura non sono mai stati riconvertiti in presidi per il territorio». Insomma, la Calabria si trova nel limbo e secondo Masotti «poco o nulla è stato fatto, nonostante un progetto già finanziato dalla comunità e partito sei anni fa, per la costruzione di 20 Case della salute. Solo una è stata realizzata», afferma Masotti. Dunque, se prima del commissariamento la sanità calabrese era costosa perché vaporizzata in una miriade di piccoli ospedali poco efficienti, dopo la stretta economica è andata anche peggio, perché all'inefficienza si è aggiunta la penuria di strutture e di personale. Così i cittadini hanno perso qualsiasi fiducia nell'assistenza locale, hanno fatto le valigie e scelto di andarsi a curare altrove. Il paradosso è che tutto questo ha un costo altissimo per le aziende del territorio, «che per coprire i conti in rosso della sanità devono pagare più tasse che altrove». Infatti in Calabria, ma anche in altre Regioni come Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sicilia le aziende pagano più del 3,9 per cento di Irap. E anche il bollo auto, in molte di queste zone, costa più che al Nord. Insomma, più tasse e meno servizi. Il tipico cane che si morde la coda.
Un referendum da presa per il culo. Il 22 ottobre 2017 si chiede ai cittadini interessati. “Volete essere autonomi e tenere per voi tutto l’incasso?” E’ logico che tutti direbbero sì, senza distinzione di ideologia o natali. Ed i quorum raggiunti sono fallimentari tenuto conto dell’interesse intrinseco del quesito.
Specialmente, poi, se è stato enfatizzato tanto dai giornali e le tv del Nord, comprese quelle di Berlusconi.
“Al di là dell’enorme spreco di soldi pubblici per organizzare due referendum buoni solo a fare un po’ di propaganda elettorale a spese dei contribuenti, ha evidenziato il trionfo dell’egoismo di chi è più ricco e pensa di poter vivere meglio mantenendo sul territorio le risorse derivante dalle imposte dopo aver beneficiato per decenni di aiuti statali e del sostegno dello Stato”. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, per il quale “la Lega ha mostrato, ancora una volta, il suo vero volto che è fatto di odio verso il Sud e i meridionali”.
“Così come ha ricordato anche Prodi, chiedere ai cittadini se vogliono pagare meno tasse ancora una volta a danno dei meridionali è come un invito a nozze che non si può rifiutare, ma il problema è che, per chiederlo, in questo caso, Zaia e Maroni hanno speso milioni di euro di soldi pubblici per farlo” ha aggiunto Borrelli chiedendo ai cittadini lombardi e veneti: “Visto come sprecano i vostri soldi e come hanno speso, in passato, quelli, sempre pubblici, per il finanziamento ai partiti, siete proprio sicuri di volergliene affidare ancora di più?” “La Regione Campania viene privata ogni anno di 250 milioni di euro che vengono sottratti ai servizi sanitari e ai nostri concittadini perché considerata la regione più giovane d’Italia e grazie a una norma introdotta dai governatori leghisti e mai tolta” ha continuato Borrelli, sottolineando che “ogni anno la sola Campania viene depredata di centinaia di milioni di euro di fondi che invece vengono destinati al ricco Nord senza alcuna reale motivazione”. “La Rampa” 23 ottobre 2017.
In Italia conviene non fare nulla e non avere nulla, perché se hai o fai si fotte tutto lo Stato, per dare il tuo, non a chi è bisognoso, ma a chi non sa o non fa un cazzo. Cioè ai suoi amici o ai suoi scagnozzi professionisti corporativi.
L’Italia uccisa dai catto-comunisti, scrive Andrea Pasini il 30 ottobre 2017 su “Il Giornale”. Il comunismo ha ucciso l’Italia. “Max Horkheimer fornì d’altra parte, al termine della sua vita, con una sorprendete confessione, la spiegazione di questa incapacità di analisi da parte dei membri della scuola di Francoforte: riconobbe infatti con dolore che il marxismo aveva preparato il Sistema, che esso ne era responsabile allo stesso titolo dell’ideologia liberale borghese, in quanto la sua visione del mondo si fonda ugualmente su un progetto mondiale economicista e messianico”. Guillaume Faye, all’interno dello scritto "Il sistema per uccidere i popoli", recentemente ripubblicato dai tipi di Aga Editrice, ha fotografato l’evolversi delle idee forti provenienti dal diciannovesimo secolo. Loro ci odiano, odiano il nostro Paese, ma guardandosi allo specchio non possono fare a meno di odiarsi a loro volta. Una spirale senza fine, laddove astio, animosità ed acredini bruciano la base solida di questa nazione. Vittorio Feltri, in un animoso e vitale articolo apparso qualche anno fa sulle colonne di Libero, scrisse: “Gli stessi comunisti si vergognano di esserlo stati, ma la mentalità pauperistica è rimasta e non ha cessato di provocare danni. Risultato: in Italia è impossibile fare impresa o artigianato, aprire un’azienda, essere liberi professionisti senza essere considerati sfruttatori, evasori fiscali se non addirittura ladri”.
Proprio per questo motivo, ogni giorno, metto in campo tutte le mie energie al fine di stoppare, innanzitutto fisicamente, un oblio vertiginoso. Anche questo è il mio dovere in qualità di imprenditore. Lo Stato è in pericolo, la franata negli ultimi decenni è stata infausta. Ma davanti al fatalismo che attanaglia i popoli dobbiamo mettere in campo la nostra fede. Gli uomini di fede, uomini animati da un ardire che non conosce limiti, fanno paura ai catto-comunisti colpevoli di aver ridotto in cenere le speranze del domani. L’avvenire non sarà mai rosso di colore. Tornando ai piedi dello scrittore francese Faye leggiamo: “Gli intellettuali confessano, come Débray o Lévy, di fare oramai solamente della morale e non importa più che la loro verità si opponga alla realtà. La ragione ammette di non aver più ragione”. Il paradosso del marxismo 160 anni dopo. La ragione aveva torto scomodando, il sempre attuale, Massimo Fini. Ora conta credere, ciò che importa è come e quello che si fa per invertire la rotta, per non perdere il timone. Il Paese suona il corno e ci chiama a raccolta. Impossibile, a pochi giorni dal centenario di Caporetto, non rispondere, con tutto il proprio animo in tensione, presente.
In questo rimpallo, tra menti eccelse, contro il dominio sinistrato del presente e del futuro passiamo, nuovamente, la palla a Feltri: “E anche lo Stato, influenzato da alcuni partiti di ispirazione marxista, non aiuta con tutta una serie di vincoli burocratici, lacci e lacciuoli. E i sindacati hanno completato l’opera, contribuendo ad avvelenare i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti, trasformando le fabbriche in luoghi d’odio e di lotta violenta, per umiliare i padroni e il personale non ideologizzato”. La storia non scorre più è tutto fermo nella mente dei retrogradi. Si avvinghiano alla legge Fiano i talebani di quest’epoca, per fare il verso a "Il Primato Nazionale", dimenticandosi dei problemi reali dell’Italia. Burocrati, sordidi e grigi, in doppio petto che accoltellano il ventre molle dello stivale, una carta bollata dopo l’altra. Alzare lo sguardo e tornare a cantare, davanti alle manette rosse della coscienza, non è facile, ma abbiamo il compito di tornare a farlo. Considerando il detto, “il lupo perde il pelo, ma non il vizio”, associandolo con le profetiche lezioni di Padre Tomas Tyn, scopriamo che il comunismo non è sparito, anzi si è rafforzato ed ha trovato gli alleati nei cattolici “non praticanti”. Potrà sembrare un’assurdità, invece è la mera realtà.
L’indiscutibile commistione di progressismo e comunismo, spesso umanitario ed accatto, ha creato con l’unione di un cattolicesimo snaturato una via collegata direttamente con i diritti civili, che non interseca, mai e poi mai, la sua strada con i diritti sociali. Aborto, divorzio, pacs, dico, unioni civili, matrimoni gay e chi più ne ha più ne metta. Fanno tutto ciò che non serve per gli italiani, fanno tutto ciò che non serve per difendere le fasce deboli della nazione. Tanti nostri connazionali hanno abbracciato il nemico, sono diventati uno di loro, per questo dobbiamo denunciare gli errori di chi sfida il tricolore e salvare la Patria. Il peccato, originale e capitale, è insito nell’ideologia marxista e rappresenta il male che sta distruggendo il nostro Paese, senza dimenticare il liberismo a tutti i costi della generazione Macron.
Milano, il paradosso: se la pena è la stessa per il giudice corrotto e per chi ha rubato una bottiglia di vino. Un noto avvocato, che ha svenduto sentenze tributarie in contenziosi da milioni di euro, grazie a vari sconti di pena ha concordato 4 anni in Appello. Quasi la stessa pena, 3 anni e 8 mesi, patteggiata in Tribunale per un reato da 8 euro, scrive Luigi Ferrarella il 30 ottobre 2017 su "Il Corriere della Sera”. Il problema è quando la combinazione dell’algebra giudiziaria, del tutto aderente alle regole, stride al momento di tirare la riga e, come risultato, fa patteggiare 3 anni e 8 mesi a chi ha rubato al supermercato una bottiglia di vino da 8 euro, mentre chi ha svenduto sentenze tributarie in contenziosi da milioni di euro esce dalla Corte d’Appello condannato a poco più: e cioè a pena concordata di 4 anni, ridotta rispetto ai 6 anni e 10 mesi del primo grado, che grazie allo sconto del rito abbreviato aveva già ridimensionato i teorici 10 anni iniziali. Luigi Vassallo è l’avvocato cassazionista che, nelle vesti di giudice tributario di secondo grado, alla vigilia di Natale 2015 fu fermato in flagranza di reato a Milano mentre intascava i primi 5.000 dei 30.000 euro chiesti ai legali di una multinazionale per intervenire su una collega di primo grado e «aggiustare» un contenzioso da milioni di euro. Due «corruzioni in atti giudiziari» nel giudizio immediato, e una «corruzione» e una «induzione indebita» nel successivo giudizio ordinario, lo avevano indotto ad accordarsi con il Fisco per 140.00 euro e a scegliere il rito abbreviato, il cui automatico sconto di un terzo gli aveva abbassato la prima sentenza a 4 anni e 8 mesi, e la seconda a 2 anni e 2 mesi. Per un totale, cioè un cumulo materiale, di 6 anni e 10 mesi. Ora in Appello arriva - come contemplato dalla recente legge in cambio del risparmio di tempo e risorse in teoria legato alla rinuncia difensiva a far celebrare il dibattimento di secondo grado - un altro sconto di un terzo, e si aggiunge già alla limatura di pena dovuta alla «continuazione» tra le 4 imputazioni delle due sentenze di primo grado riunite in secondo grado. Alla vigilia dell’udienza, dunque, l’avvocato Fabio Giarda rinuncia ai motivi d’appello diversi dal trattamento sanzionatorio, a fronte del sì del pg Massimo Gaballo all’accordo su una pena di 4 anni, ratificato dalla II Corte d’Appello presieduta da Giuseppe Ondei. Undici mesi Vassallo li fece in custodia cautelare (fra carcere e domiciliari), sicché non appare irrealistico l’agognato tetto dei 3 anni di pena da eseguire, sotto i quali potrà chiedere di scontarla in affidamento ai servizi sociali senza ripassare dal carcere. In Tribunale, invece, da detenuto arriva e da detenuto va via (senza sospensione condizionale della pena e senza attenuanti generiche) un altro imputato che nello stesso momento patteggia 3 anni e 8 mesi – quasi la stessa pena del giudice tributario – per aver rubato da un supermercato una bottiglia di vino da 8 euro e mezzo: il fatto però che avesse dato una spinta al vigilantes privato che all’uscita gli si era parato davanti, minacciandolo confusamente («non vedi i tuoi figli stasera») e agitando un taglierino, ha determinato il passaggio dell’accusa da «furto» a «rapina impropria», la cui pena-base è stata inasprita dai vari decreti-sicurezza, tanto più per chi come lui risulta «recidivo» a causa di due vecchi furti. Per ridurre i danni, il patteggiamento non scende a meno di 3 anni e 8 mesi. Quasi un anno di carcere per ogni 2 euro di vino.
“La gente non legge, non sa, ma sceglie, decide e parla”.
Intervista al sociologo storico Antonio Giangrande, autore di un centinaio di saggi che parlano di questa Italia contemporanea, analizzandone tutte le tematiche, divise per argomenti e per territorio.
Dr Antonio Giangrande di cosa si occupa con i suoi saggi e con la sua web tv?
«Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!»
Perché dice che “La gente non legge, non sa, ma sceglie, decide e parla”.
«Libri, 6 italiani su dieci non leggono. In Italia poi si legge sempre meno. Siamo tornati ai livelli del 2001. Un dato resta costante da decenni: una famiglia su 10 non ha neppure un libro in casa. I dati pubblicati dall’Istat fotografano l’inesorabile diminuzione dei lettori, con punte drammatiche al Sud. Impietoso il confronto con l’estero, scrive il 27 dicembre 2017 Cristina Taglietti su "Il Corriere della Sera". La gente usa esclusivamente i social network per informarsi tramite lo smartphone od il cellulare. Non usa il personal computer perchè non ha la fibra in casa che ti permette di ampliare più comodamente e velocemente la ricerca e l'informazione. La gente, comunque, non va oltre alla lettura di un tweet o di un breve post, molto spesso un fake nato dall'odio o dall'invidia, e lo condivide con i suoi amici. Non verifica o approfondisce la notizia. Non siamo nell'era dell'informazione globale, ma del "passa parola" totale. Di maggiore impatto numerico, invece, è la ricerca sui motori di ricerca, non di un tema o di un argomento di cultura o di interesse generale, ma del proprio nome. Si digita il proprio nome e cognome, racchiuso tra virgolette, per protagonismo e voglia di notorietà e dalla ricerca risulta quanti siti web lo citano. Non si aprono quei siti web per verificare il contenuto. Si fermano sulla prima frase che appare sulla home page di Google o altri motori similari, estrapolata da un contesto complesso ed articolato. Senza sapere se la citazione è diffamatoria o meritoria o riconducibile all'autore da lì partono querele, richieste di rimozione per diritto all’oblio o addirittura indifferenza».
Ha un esempio da fare sull’impedimento ad informare?
«Esemplari sono le querele e le richieste di rimozione. Libertà di informazione, nel 2017 minacciati 423 giornalisti. I dati dell'osservatorio promosso da Fnsi e Ordine. La tipologia di attacco prevalente è l'avvertimento (37 per cento), scrive il 31 dicembre 2017 "La Repubblica". Ognuno di questi operatori dell'informazione è stato preso di mira per impedirgli di raccogliere e diffondere liberamente notizie di interesse pubblico. La tipologia di attacco prevalente è stata l'avvertimento (37 per cento) seguita dalle querele infondate e altre azioni legali pretestuose (32 per cento)».
E sull’indifferenza…
«Le faccio leggere un dialogo tra me e un tizio che mi ha contattato. Uno dei tanti italiani che non si informa, ma usa internet in modo distorto. Uno di quel popolo di cercatori del proprio nome sui motori di ricerca e che vive di tweet e post. Un giorno questo tizio mi chiede “Lei ha scritto quel libro?”
E' un saggio - rispondo io. - L'ho scritto e pubblicato io e lo aggiorno periodicamente. A tal proposito mi sono occupato di lei e di quello che ingiustamente le è capitato, parlandone pubblicamente, come ristoro delle sofferenze subite, pubblicando l'articolo del giornale in cui è stato pubblicato il pezzo. Inserendolo tra le altre testimonianze. Comunque ho scritto anche un libro sul territorio di riferimento. Come posso esserle utile?
“Volevo giusto capire, io mi sono imbattuto per caso nell'articolo, cercando il mio nome... E sotto l'articolo ho visto un link che mi collegava al suo saggio...Capire più che altro perché prendere articoli di giornale su altra gente e farne un saggio... Sono solo curiosità”.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte - spiego io. - I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta...” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso...” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. In generale. Dico, in generale: io non esprimo mie opinioni. Prendo gli articoli dei giornali, citando doverosamente la fonte, affinchè non vi sia contestazione da parte dei coglioni citati, che siano essi vittime, o che siano essi carnefici. Perchè deve sapere che i primi a lamentarsi sono proprio le vittime che io difendo attraverso i miei saggi, raccontando tutto quello che si tace.
"Siccome io le ho detto mi sono solo imbattuto per "caso"... Io ho visto questa cosa e sinceramente l'ho letta perché ho visto il mio nome, ma se dovessi prendere il suo saggio e leggerlo non lo farei mai. Perché: Cerco di lavorare ogni giorno con le mie forze. I miei aggiornamenti sono tutt'altro. Faccio tutto il possibile per offrirmi un futuro migliore. Sono sempre impegnato e non riuscirei a fermarmi due minuti per leggere".
Rispetto la sua opinione - rispondo. - Era la mia fino ai trent'anni. Dopo ho deciso che è meglio sapere ed essere che avere. Quando sai, nessuno ti prende per il culo...
"Ma per le cose che mi possono interessare per il mio lavoro e il mio futuro nessuno mi può prendere per il culo ... Poi è normale che in ogni campo ci sia l'esperto…"»
Come commenta...
«Confermo che quando sai, nessuno ti prende per il culo. Quando sai, riconosci chi ti prende per il culo, compreso l’esperto che non sa che a sua volta è stato preso per il culo nella sua preparazione e, di conseguenza sai che l’esperto, consapevole o meno, ti potrà prendere per il culo».
Comunque rimane la soddisfazione di quei quattro italiani su dieci che leggono.
«Sì, ma leggono cosa? I più grandi gruppi editoriali generalisti, sovvenzionati da politica ed economia, non sono credibili, dato la loro partigianeria e faziosità. Basta confrontare i loro articoli antitetici su uno stesso fatto accaduto. Addirittura, spesso si assiste, sulle loro pagine, alla scomparsa dei fatti. Di contro troviamo le piccole testate nel mare del web, con giornalisti coraggiosi, ma che hanno una flebile voce, che nessuno può ascoltare. Ed allora, in queste condizioni, è come se non si avesse letto nulla».
Concludendo?
«La gente non legge, non sa, ma sceglie, decide e parla...e vota. Nel paese degli Acchiappacitrulli, più che chiedere voti in cambio di progetti, i nostri politici sono generatori automatici di promesse (non mantenute), osannati da giornalisti partigiani. Questa gente che non legge, non sa, ma sceglie, decide e parla, voterà senza sapere che è stata presa per il culo, affidandosi ai cosiddetti esperti. I nostri politici gattopardi sono solo mediocri amministratori improvvisati assetati di un potere immeritato. Governanti sono coloro che prevedono e governano gli eventi, riformando ogni norma intralciante la modernità ed il progresso, senza ausilio di leggi estemporanee ed improvvisate per dirimere i prevedibili imprevisti».
L'informazione sulla politica? In Italia è troppo di parte (per 6 lettori su 10). I risultati di una ricerca del Pew Research Center di Washington in 38 Paesi: l'Italia è tra gli Stati dove la fiducia nell'imparzialità dell'informazione politica è più bassa. Per sette giovani su 10 è la Rete il luogo principale dove trovare notizie, scrive Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington, il 11 gennaio 2018 su "Il Corriere della Sera". Solo il 36% degli italiani pensa che giornali, televisioni e siti web riportino in modo accurato le diverse posizioni politiche. Tra i Paesi occidentali solo gli spagnoli, con il 33%, e i greci, con il 18%, sono più critici. (In fondo all'articolo, la classifica completa). È uno dei risultati emersi dallo studio del Pew Research Center di Washington, appena pubblicato. Una ricerca di grande impegno, condotta dal 16 febbraio al 8 maggio 2017, raccogliendo 41.953 risposte in 38 Paesi.
Precisione e attendibilità. In tempi di «fake news» (qui la guida di Milena Gabanelli e Martina Pennisi), gli analisti del Pew Center hanno chiesto quanto siano considerati precisi, attendibili i media sui temi della politica. Tra gli Stati occidentali spiccano le percentuali di chi approva il lavoro di stampa e tv nei Paesi Bassi (74%), in Canada (73%) e in Germania (72%). Segue il gruppo intermedio con Svezia (66%) Regno Unito (52%), Francia (47%). Italia, Spagna e Grecia sono in coda. Negli Stati Uniti, già provati da un anno di presidenza di Donald Trump, il 47% degli interpellati apprezza il modo in cui vengono trattate le notizie politiche.
Meglio sugli Esteri. I numeri cambiano, anche sensibilmente, su altri quesiti. In Italia, per esempio, il 46% considera accurata l’informazione che riguarda l’azione di governo; il 60% quella sui principali eventi mondiali. In generale, considerando tutti i Paesi, il 75% del campione non considera accettabile un’informazione apertamente schierata su una posizione politica e il 52% promuove i media.
Per 7 giovani su 10 l'informazione è in Rete. Interessante anche il capitolo sulle news online. Si parte da un esito scontato, (i giovani si informano su Internet), per arrivare a compilare una classifica sul gap tra le diverse fasce di età tra gli utenti del web. Al primo posto il Vietnam, dove l’84% dei giovani tra i 18 e i 29 anni consulta la rete almeno una volta al giorno, contro solo il 10% degli ultra cinquantenni (gap pari al 74%). L’Italia è al terzo posto: 70% di giovani e 25% di navigatori oltre i cinquant’anni (gap del 45%). Gli Stati Uniti sono il Paese dove le distanze generazionali sono più ridotte: il 48% del pubblico più anziano consulta Internet, contro il 69% dei più giovani.
DUE PESI E DUE MISURE. Nicola Porro: "Fake news? No: se le scrive Repubblica, il giornale progressista", scrive il 28 Novembre 2017 "Libero Quotidiano". "Le fake news sono tali solo se non riguardano un tema politicamente corretto e non sono scritte a titoli cubitali...", scrive Nicola Porro sul suo profilo Twitter. Repubblica, sottolinea il vicedirettore de Il Giornale, "a pagina 4 sparava con grande evidenza un numero impressionante: 6.788.000. E la didascalia recitava: Italiane tra i 16 e i 70 anni che hanno subito qualche forma di violenza pari al 31,6%". Peccato che questa notizia sia assolutamente "falsa, doppia come un gettone. Il tutto a corredo di un pezzo che chiede maggiori risorse contro il femminicidio: cioè maggiori tasse per far sì che una donna su tre (così spiega la didascalia) non debba più subire ignobili violenze". Quel numero, continua Porro, "è un macigno" e "il giornale antibufale per eccellenza, e cioè Repubblica", non ci dice "da dove esce". Bene, continua Porro, "nasce da un rapporto Istat del 2015 su dati del 2014", e "non si tratta di un dato puntuale, ma di un sondaggio. Cioè non ci sono 6,7 milioni di donne che hanno denunciato o lamentato o raccontato una violenza. C’è un sondaggio su un campione di 24.761 donne". Proprio così. Non solo, "si dice che il 31,6% delle donne italiane subisce violenza". Ma la maggior parte di loro subisce quella psicologica: il 22% della popolazione nazionale secondo l'Istat, e cioè 4,4 milioni su 6,7 milioni delle loro stime, si lamenta solo della violenza psicologica e non già di quella fisica. Grave comunque, ma ci sarà una differenza tra l’una e l’altra".
Firenze, le fake news dei giornali sugli stupri inventati. Diversi quotidiani nazionali hanno pubblicato la notizia: A Firenze nel 2016 false 90% delle denunce per violenza sessuale. Il questore smentisce, scrive Domenico Camodeca, Esperto di Cronaca l'11 settembre su "it.blastingnews.com". “Tutte le studentesse americane in Italia sono assicurate per lo stupro e a #Firenze su 150-200 denunce all’anno, il 90% risulta falso”. È questo il passaggio incriminato, privo di virgolette nella versione originale, di un articolo apparso il 9 settembre scorso sui quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX, a margine di una intervista al ministro della Difesa, Roberta Pinotti, sui fatti legati all’ancora presunto stupro di Firenze. Anche altre testate, tra cui Il Messaggero, Il Gazzettino e Il Mattino (o, almeno, questa la ricostruzione fatta dalla giornalista del Fatto Quotidiano Luisiana Gaita) hanno poi rilanciato la notizia che, però, si è rivelata essere una #Fake News, una bufala insomma. A smentire i Media ci ha pensato il questore di Firenze Alberto Intini: “Secondo la banca dati della polizia solo 51 denunce per#violenza sessuale nel 2016 e, nei primi 9 mesi del 2017, solo 3 da parte di ragazze americane”. Di fronte alla presunta fake news smascherata, Stampa e Secolo decidono di non mollare, virgolettano la frase da loro pubblicata e la attribuiscono a una non meglio precisata “fonte istituzionale attendibile”, anche se coperta dal segreto professionale. Dunque, a Firenze, nel 2016, ci sono state tra le 150 e le 200 denunce per violenza sessuale (reato che va dal palpeggiamento al vero e proprio stupro), oppure solo 51?. E poi, è vero che le denunce presentate dalle donne americane sarebbero false per il 90%? Sostenitori della prima tesi sono, come detto, le redazioni di Stampa e Secolo le quali, nella nota apparsa successivamente in calce al pezzo contestato, spiegano che “i dati cui fa riferimento la fonte non sono nelle statistiche ufficiali perché non sono ancora confluiti nei database Istat”. Una pezza di appoggio abbastanza fumosa che, infatti, il procuratore di Firenze Intini contraddice fornendo i numeri provenienti dalla banca dati della polizia. Per non parlare dell’altra fake news che tutte le studentesse Usa in Italia sarebbero assicurate contro lo stupro Infatti, come ha spiegato anche Gabriele Zanobini, avvocato delle due ragazze protagoniste della vicenda, l’assicurazione stipulata dalle donne americane che si recano in Italia è generica e comprende ogni tipo di incidente o aggressione in cui si può incorrere.
«Denzel Washington sostiene Trump», la bufala su Facebook. Ennesimo caso di propaganda veicolata da American News, sito che posta contenuti falsi per orientare il dibattito. L’attore trasformato in un supporter del presidente eletto, scrive Marta Serafini su “Il Corriere della Sera” il 16 dicembre 2016. Tanto Denzel Washington risponde ad un giornalista che gli chiedeva un’opinione sulle fake news e sul ruolo dell’informazione moderna. Se non leggi i giornali sei disinformato, se invece li leggi sei informato male. Quindi cosa dovremo fare? chiede il giornalista, Washington replica: “Bella domanda. Quali sono gli effetti a lungo termine di troppa informazione? Una delle conseguenze è il bisogno di arrivare per primi, non importa più dire la verità. Quindi qual è la vostra responsabilità? Dire la verità, non solo arrivare per primi, ma dire la verità. Adesso viviamo in una società dove l’importante è arrivare primi. “Chi se ne frega? Pubblica subito” Non ci interessa a chi fa male, non ci interessa chi distrugge, non ci interessa che sia vero. Dillo e basta, vendi! Se ti alleni puoi diventare bravo a fare qualsiasi cosa. Anche a dire stronzate” tuona il celebre attore e regista.
I giornalisti professionisti si chiedono perché è in crisi la stampa. Le loro ovvie risposte sono:
Troppi giornalisti (litania pressa pari pari dalle lamentele degli avvocati a difesa dello status quo contro le nuove leve);
Troppi pubblicisti;
Troppa informazione web;
Troppi italiani non leggono.
La risposta invece è: troppo degrado intellettuale degli scribacchini e troppi “mondi di informazione”. Quando si parla di informazione contemporanea non si deve intendere in toto “Il Mondo dell’Informazione”, quindi informazione secondo verità, continenza-pertinenza ed interesse pubblico, ma “I Mondi delle Informazioni”, ossia notizie partigiane date secondo interessi ideologici (spesso di sinistra sindacalizzata) od economici. Insomma: quanto si scrive non sono notizie, ma opinioni! I lettori non hanno più l’anello al naso e quindi, diplomati e laureati, sanno percepire la disinformazione, la censura e l’omertà. In questo modo si rivolgono altrove per dissetare la curiosità e l’interesse di sapere. I pochi giornalisti degni di questo titolo sono perseguitati, perchè, pur abilitati (conformati), non sono omologati.
FAKE NEWS, GIORNALI E MORALISMI SENZA PIÙ NOTIZIE, scrive Alessandro Calvi il 22 dicembre 2017 su "Stati Generali". Certo, il problema sono le fake news; eppure, si dovrebbe dire anche dell’informazione di carta, di certe sue degenerazioni; o forse oramai è tardi, forse l’informazione è già morta e quello pubblicato dalla Stampa mercoledì 22 novembre – «La notizia è falsa, ma la riflessione sopravvive» – ne è il perfetto necrologio. Quella frase l’ha scritta Mattia Feltri dopo aver chiesto scusa ai lettori per aver costruito un pezzo su una notizia poi rivelatasi falsa; e però quella chiusa – «La notizia è falsa, ma la riflessione sopravvive» – sembra dirci che i giornali oramai ritengono di poter fare a meno di fatti e notizie, accontentandosi delle opinioni, anche di quelle costruite su notizie false; il necrologio del giornalismo, appunto. La storia è piuttosto semplice. Feltri aveva dedicato una puntata della sua rubrica «Buongiorno» alla notizia secondo cui una bimba di 9 anni sarebbe andata in sposa a un uomo di 45 anni e poi da questo sarebbe stata violentata; tutto si sarebbe svolto nella comunità musulmana di Padova. Ebbene, dopo aver spiegato che di questo genere di storie si conosce poco o nulla poiché «avvengono dentro comunità chiuse, regolate dalla connivenza, persuase di essere nel giusto per volere divino», Feltri ricordava la «battaglia opportuna […] sebbene un po’ scomposta, un po’ genericamente recriminatoria» contro «i Weinstein e i Brizzi di tutto il mondo» e concludeva: «Tanta agitazione per ragazze indotte o costrette a concedersi in cambio di una carriera nel cinema è comprensibile e condivisibile, ma tanto silenzio per donne e bambine sequestrate a vita, in cambio di niente, è spaventoso». Ecco: peccato che alla fine sia uscito fuori che la storia della sposa bambina era falsa. A Feltri non è restato che ammettere l’errore e chiedere scusa, non rinunciando però ad affermare che, sebbene la notizia fosse falsa, «la riflessione sopravvive». E invece no: ché, anzi, a sopravvivere è semmai tutto quell’apparato fatto di notazioni e coloriture – «tanta agitazione» o «battaglia opportuna […] sebbene un po’ scomposta» – il quale, al venir meno dei fatti, si rivela per quello che è: una semplice impalcatura ideologica, forse persino un po’ infastidita da quella «battaglia opportuna […] sebbene un po’ scomposta». Tuttavia, il problema non è certo Feltri al quale piuttosto si dovrebbe riconoscere d’essere un gran signore avendo fatto ciò che pochi fanno: ammettere l’errore e chiedere scusa. D’altra parte, capita a tutti di sbagliare, soprattutto se ogni giorno – ogni giorno! – si è costretti a trarre una morale dalle notizie, con metodo oramai quasi industriale; è capitato anche al più inossidabile, al più inarrestabile, tra i dispensatori di morali e opinioni, Massimo Gramellini; la ricostruzione che fornì Alessandro Gilioli sull’Espresso di uno di questi errori – e di mezzo c’è sempre una fake news presa per buona – vale la lettura. Ma, appunto, il problema non è l’errore in sé, poiché l’errore può capitare. Il problema, sta invece nell’essere oramai diventata accettabile – tanto che non s’è visto alzarsi neppure un sopracciglio – un’affermazione come quella secondo cui «la notizia è falsa, ma la riflessione sopravvive». Il problema riguarda una idea di giornalismo che sembra prescindere dai fatti, per cui le opinioni oramai precedono la cronaca la quale spesso trova spazio soltanto se è in grado di confermare le opinioni, altrimenti se ne fa a meno, poiché comunque «la riflessione sopravvive». Il problema sta insomma nel fatto che l’informazione è stata da tempo ridotta a mero dispensario di opinioni, anche senza più fatti a sostegno. Di recente, sugli Stati Generali, è stato pubblicato un intervento – «Se noi giornalisti siamo sempre meno credibili, ci sarà un perché» – di Fabio Martini, anch’egli giornalista del quotidiano La Stampa, col quale non si può che concordare. E, peraltro, da queste parti si è ragionato spesso sulla crisi del giornalismo, e in particolare sulle conseguenze della marginalizzazione della cronaca. Lo si era fatto ad esempio prendendo spunto da fatti drammatici, come le stragi delle quali i quotidiani quasi non danno più notizia, e si era fatto lo stesso anche a partire da vicende più vicine, come il mancato racconto dell’agonia del lago di Bracciano. Di recente lo si è fatto a proposito di come l’informazione ha trattato le vicende di Ostia e del Virgilio. Comunque sia, il tema è sempre lo stesso: dai primi anni Novanta la cronaca inizia a essere massicciamente sostituita da altro, in particolare dai retroscena; e questo cambia tutto: cambia l’informazione e cambia anche il rapporto tra giornali e potere. «Sulle pagine dei giornali – si perdonerà l’autocitazione da quell’articolo che prendeva a pretesto la vicenda di Ostia per parlare di giornalismo – si affacciano sempre più massicciamente spifferi di Palazzo, brogliacci, verbali. Sembra che il lettore, attraverso la lettura di un verbale riportato pedissequamente dai giornali, possa essere immerso dentro la notizia senza più filtri né mediazioni. Sembra una rivoluzione. È invece l’esatto opposto. Per farsene una idea, basterebbe chiedersi chi dirige il traffico, chi sceglie quali verbali far uscire e quali spifferi lasciar trapelare. Ecco: per lo più, sono le fonti a stabilirlo, se non altro perché sono le fonti che conoscono a fondo il contesto. Insomma, sostituendo lo spazio della cronaca con il retroscena e rarefacendo sempre più il tradizionale lavoro di inchiesta giornalistica, i giornali si sono disarmati e consegnati alle fonti, quindi al potere». Il passaggio dalla cronaca al retroscena, e l’affermarsi progressivo delle opinioni sui fatti, finisce per trasformare anche la scrittura dei giornali. Il linguaggio della cronaca diventa sempre più simile a quello degli editoriali, intessuto di pedagogismi e di toni moralisticheggianti che non dovrebbero trovare spazio nel resoconto di un fatto. Anche questo contribuisce ad allentare il rapporto con la realtà, finendo per trasformare la cronaca – quando ancora trova spazio in pagina – in un racconto di maniera che non dice più molto del mondo. E non è ancora tutto. In questi giorni sono usciti in libreria due libri – non uno, due! – che Michele Serra ha dedicato alla rubrica che da anni cura per Repubblica, «L’amaca». In quello dei due che costituisce l’esegesi dell’altro, Serra scrive che gli anni nei quali iniziò a scrivere corsivi – «gli anni della post-ideologia», afferma – non erano più quelli di Fortebraccio e della sua ferrea faziosità. In realtà, rispetto all’epoca di Fortebraccio stava cambiando soprattutto il contenitore nel quale il corsivo veniva collocato: stavano cambiando i giornali e stava cambiando persino il giornalismo. Prima, informazione era per lo più il resoconto di un fatto e quindi aveva un senso l’esistenza di editoriali e corsivi; poi, con la marginalizzazione della cronaca e l’editorializzazione dell’intero giornale, i corsivi finiscono annegati in un mare di opinioni senza più cronaca, poiché, come s’è appena visto, la cronaca ha lasciato il posto al retroscena il quale ha a sua volta contribuito all’avvicinamento della informazione al potere attraverso il disarmo nei confronti delle fonti. In questo contesto, anche la funzione dei corsivi finisce per essere stravolta rispetto all’epoca di Fortebraccio: e il rischio permanente è che si passi dal graffio contro il potere al moralismo che accarezza lo stato delle cose e che massaggia il potere o la pancia dei lettori. Imboccata questa strada – sostituita la cronaca con il retroscena, scollegata l’informazione dai fatti, ridottala a ragionamento che può essere persino basato su una notizia falsa, stravolta infine la funzione dei corsivi – i giornali si sono ridotti a raccontare sempre meno le cose del mondo e per questo hanno sempre meno lettori e sono sempre più in crisi. A sentire chi i giornali li fa, però, il problema sarebbe soprattutto quello delle fake news o della rete che ruba lettori. E quindi si finisce per ritenere che la soluzione per recuperare lettori e credibilità sia quella di differenziarsi dalla rete, lasciando alla stessa rete il notiziario e concentrandosi ancor di più sulle opinioni. Lo ha spiegato piuttosto chiaramente il direttore di Repubblica Mario Calabresi presentando la nuova veste del giornale, scrivendo di aver addirittura «raddoppiato lo spazio per le analisi e i commenti». Bene. Ma davvero abbiamo bisogno di tutte queste opinioni? Possibile che si abbia tutta questa sfiducia nella capacità dei lettori – sempre che ai lettori si raccontino anche i fatti – di formarsi da sé una opinione? Non sarà, infine, che a forza d’andar dietro alle opinioni si stia rischiando di rendere ancor più flebile il rapporto tra giornali e fatti, oltre a quello oramai quasi evanescente tra giornali e lettori? Lo dirà il tempo. Tuttavia, proprio nel giorno in cui Calabresi annunciava il raddoppio delle analisi e dei commenti, la nuova Repubblica esordiva in edicola con una grande intervista al premier spagnolo Rajoy firmata dallo stesso Calabresi e posta in apertura di edizione. Quello stesso giorno, gli altri giornali raccontavano come Amsterdam avesse sfilato a Milano l’Agenzia europea del farmaco anche per il mancato accordo tra governo italiano e governo spagnolo. Ebbene, nella intervista uscita su Repubblica al capo di quel governo non c’era neppure una domanda su quel fatto. Sarà stata un scelta di opportunità, sarà stato perché l’intervista era stata chiusa prima, comunque si è rimasti con la sensazione che mancasse qualcosa. Quella scelta è stata legittima, certo; difficile però poi lamentarsi se i lettori quel qualcosa non lo cerchino più nei giornali.
Una Costituzione troppo elogiata. Commenti positivi si arrestano sistematicamente alla prima parte del testo, mentre la seconda è ampiamente discutibile e discussa, scrive Ernesto Galli della Loggia il 12 gennaio 2018 su "Il Corriere della Sera". Non si può proprio dire che abbia destato un grande interesse il settantesimo anniversario appena trascorso dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica. Alla fine dell’anno passato, l’evento è stato naturalmente e doverosamente commemorato da tutte le autorità del caso ma nella più completa distrazione della gente immersa nelle festività natalizie. E altrettanto doverosamente esso ha innescato l’ormai consueto ciclo di celebrazioni ufficiali. Che stavolta ha preso la forma di un «viaggio della Costituzione» – organizzato dalla Presidenza del Consiglio - attraverso dodici città italiane ognuna destinata a essere sede di una lezione su un tema centrale della Carta (tra i quali temi fanno bella mostra di sé Democrazia e Decentramento, Stato e Chiesa e Diritto d’asilo, Solidarietà e Lavoro, mentre manca, assai significativamente, il tema della Libertà). Come di prammatica è stata organizzata anche una mostra itinerante, ovviamente multimediale, nella quale ciascuno dei dodici articoli principali è commentato dalla voce di Roberto Benigni, confermato anche in questa occasione nel suo ruolo ormai ufficiale di aedo della Repubblica. Paradossalmente, tuttavia, proprio l’assenza d’interesse da parte del pubblico unita alla piattezza celebrativa condita dei soliti discorsi esaltanti il «testo vivo» della Carta, la sua «sintesi mirabile» e così via magnificando, sono serviti a sottolineare per contrasto qualcosa che è assolutamente peculiare della nostra scena pubblica. Vale a dire la centralità che in essa ha la Costituzione. Una centralità beninteso tutta verbale, fatta per l’appunto di un continuo discorrere sulla Costituzione in ogni circostanza plausibile e implausibile, di una sua incessante evocazione ed esaltazione, di una profusione di elogi per ogni suo aspetto: per la sua saggezza, per la sua lungimiranza, completezza, incisività, bellezza stilistica, e chi più ne ha più ne metta. Credo che in tutta Europa non esista una Carta costituzionale fatta oggetto di un altrettanto inarrestabile fiume di parole laudative, così come credo che non esista un’altra classe politica (ma ci si aggiungono volentieri anche preti e vescovi) che se ne riempia tanto la bocca come quella italiana. A cominciare da coloro che rappresentano le istituzioni, il cui discorso, appunto, è, per la massima parte e in qualsivoglia circostanza più o meno «nobile», una trama di richiami di volta in volta ammonitori o storico-encomiastici alla Costituzione. È una caratteristica così tipicamente italiana da richiedere una spiegazione. La quale credo stia nel fatto che l’ufficialità italiana, non riuscendo a immaginarsi depositaria di un qualunque destino collettivo né investita di una qualunque prospettiva nazionale, non considerandosi attrice credibile e tanto meno portavoce di un qualunque futuro significativo del Paese, sa di non poter fare altro che richiamarsi al passato. Quando in una qualunque circostanza celebrativa la suddetta ufficialità è chiamata a dire di sé e di ciò che rappresenta in modo «alto», essa sa di non essere in grado di spingere lo sguardo avanti, di non avere la statura per dar voce a un progetto o a un destino, e quindi è costretta inevitabilmente a volgere lo sguardo all’indietro, solo all’indietro: cioè per l’appunto alla Costituzione. Naturalmente uno sguardo essenzialmente contemplativo: infatti, lungi dall’essere una retorica in vista dell’azione, la retorica ufficiale della Repubblica è vocazionalmente una retorica della memoria. La dimensione dei foscoliani «Sepolcri», insomma, è ancora e sempre la nostra: anche se oggi priva degli «auspici» che a suo tempo secondo il poeta da essi avremmo dovuto trarre. C’è ancora una considerazione da fare circa il discorso sulla Costituzione tipico della ufficialità italiana. Ed è che esso, nella sua abituale, pomposa, glorificazione del testo, tende sistematicamente a nascondere due verità. La prima è che forse quel testo medesimo così compiuto e perfetto non è, visto che fino a oggi sono almeno 16 (per un totale di oltre venti articoli) le modificazioni che è stato ritenuto utile o necessario apportarvi: e quasi sempre su aspetti per nulla secondari. La seconda verità nascosta dalla magniloquenza celebrativa quando nei suoi elogi si arresta, come fa sistematicamente, alla prima parte della Carta, riguarda la natura viceversa ampiamente discutibile e discussa della seconda parte, quella che tratta dei modi in cui il Paese è quotidianamente e concretamente governato e amministrato. Non a caso il modo come in Italia funzionano l’esecutivo, la giustizia, le Regioni o la burocrazia, non è mai fatto oggetto di attenzione e tanto meno di elogi dal discorso sulla Costituzione. Accortamente i ditirambi sono riservati solo ai massimi principi: alla solidarietà, al ripudio della guerra o al diritto allo studio e via dicendo. Sul resto, silenzio. Con il risultato che modificare ciò che pure a giudizio di moltissimi andrebbe modificato di questa seconda parte si rivela da sempre di una difficoltà titanica, dal momento che la cosa può facilmente essere fatta passare per un subdolo attacco ai principi suddetti. Ma se la Costituzione è così massicciamente presente nel discorso pubblico italiano questo avviene per un’ultima ragione, pure questa patologica. E cioè perché essa viene continuamente adoperata come arma contundente nella lotta politica quotidiana, piegata a suo uso e consumo. In realtà è la Costituzione stessa che si presta a esser adoperata in tal modo. Infatti, il lungo elenco di articoli dal 29 al 47 — articoli astrattamente prescrittivi riguardanti i rapporti «etico sociali» ed economici (l’astrattezza sta nello stabilire come obbligatori per la Repubblica, nella forma perlopiù di altrettanti «diritti» dei cittadini, una lunga serie di costosissimi obiettivi di una vasta quanto assoluta genericità) — tali articoli, dicevo, si prestano molto bene a essere fatti valere a difesa polemica di qualsiasi esigenza contro qualsiasi politica di qualsiasi governo. Non a caso, un tale uso strumentalmente politico della Costituzione cominciò fin dalla sua entrata in vigore, e si può dire che da allora non ci sia stato esecutivo italiano di destra o di sinistra che nelle più svariate occasioni non sia stato accusato in un modo o nell’altro di violare la Costituzione. Inutile dire quanto anche una simile pratica abbia contribuito e contribuisca a impedire che intorno alla Costituzione stessa si formi quell’aura di «sacralità» che invano i suoi celebratori vorrebbero.
Fake news, Gabanelli: “Polizia postale? Eccessivo. Politici e giornalisti hanno sempre raccontato balle”, scrive Gisella Ruccia il 23 gennaio 2018 su "Il Fatto Quotidiano". “Fake news? Adesso sono molto di moda. Perdiamo più tempo a parlare di fake news che non a scovare le notizie vere”. Sono le parole della giornalista Milena Gabanelli, ospite di Otto e Mezzo (La7). La storica ex conduttrice di Report spiega: “Non sono molto appassionata di questo argomento. L’allarme sulle fake news è direttamente proporzionale a quanto ne parliamo e a quanto lo gonfiamo. Le balle le hanno sempre raccontate la classe politica e i giornalisti che seguono la politica, per compiacerla o semplicemente per pigrizia”. E aggiunge: “Trovo veramente eccessivo l’intervento della polizia postale. Se questo è finalizzato a essere un deterrente, ha una qualche utilità. Ma non si può pensare che le 2mila persone della polizia postale, oltre a occuparsi di cyber-terrorismo, di e-banking, di pedopornografia, di pedofilia, di giochi e di scommesse online, di tutto il crimine che passa attraverso il web, debbano mettersi lì a rispondere ai cittadini”.
Giornalisti contro avvocati: «Vietato criticarci», scrive Giulia Merlo il 23 gennaio 2018 su "Il Dubbio". Fnsi, il sindacato dei giornalisti, attacca l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria della Camera penale di Modena che replica: «Travisamento della notizia che offende la classe forense». Accetta di definirlo un «fraintendimento». Da penalista, però, specifica che il fraintendimento da parte della Federazione Nazionale della Stampa Italiana «si colloca tra la colpa grave e il dolo eventuale». La Camera Penale di Modena, per voce del suo presidente, Guido Sola, è al centro di una polemica al vetriolo proprio con la Fnsi e l’Ordine dei Giornalisti, ragione del contendere: la creazione dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria (iniziativa già in atto da due anni a livello nazionale, promossa dall’Unione Camere Penali italiane con la pubblicazione del Libro Bianco sull’informazione giudiziaria). Il “fraintendimento” è nato dopo l’annuncio della Camera Penale di Modena della costituzione dell’Osservatorio: «La cronaca giudiziaria ed i temi della giustizia hanno assunto negli ultimi tempi un interesse sempre maggiore da parte dell’opinione pubblica, tanto che da alcuni anni gli addetti ai lavori ed anche esperti di psicologia e sociologia si stanno interrogando sugli effetti distorsivi dei cosiddetti “processi mediatici”», si legge nel comunicato. E ancora, «l’informazione spesso diventa strumento dell’accusa per ottenere consensi e così inevitabilmente condizionare l’opinione pubblica e di conseguenza il giudicante: pensiamo ad esempio a quanto accaduto nel processo “Aemilia” allorché, pochi giorni dopo gli arresti, prima ancora delle decisioni del tribunale del riesame, è stato pubblicato e diffuso un libro che riportava fedelmente, quasi integralmente, il contenuto della misura cautelare con atti che dovevano rimanere segretati». Proprio questo passaggio ha scatenato la reazione del sindacato nazionale del giornalisti e dell’Ordine dei giornalisti nazionale e locale, che definiscono l’iniziativa dei penalisti «inquietante» e attaccano: «La Camera Penale di Modena fa esplicitamente riferimento al processo “Aemilia”, in corso da oltre un anno a Reggio Emilia, che per la prima volta ha alzato il velo sulle infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna, per decenni sottovalutate. E lo fa proprio in concomitanza con un’udienza dello stesso processo in cui un pentito ha rivelato che, tra i progetti degli ‘ ndranghetisti in Emilia, c’era anche quello di uccidere un giornalista scomodo. Notizia che pare non aver toccato in maniera altrettanto significati- va la sensibilità degli avvocati. Del resto, non è la prima volta che sindacato e Ordine dei giornalisti sono costretti a occuparsi di intimidazioni, esplicite o velate, fatte a chi si occupa di informare i cittadini sul processo “Aemilia”. Ricordiamo le minacce in aula ai cronisti reggiani, le richieste dei legali degli imputati di celebrare il processo a porte chiuse, le proteste contro i giornalisti già manifestate da alcuni difensori alle Camere Penali di competenza». Insomma, quella degli avvocati è un’iniziativa «dal sapore intimidatorio» ed è «grave e inquietante che i media debbano essere messi sotto osservazione da un organismo composto solo da avvocati». Allusioni che indignano il presidente delle Camere Penali modenesi. «Siamo davanti ad un esempio lampante di travisamento della notizia», ha commentato il presidente Sola, «che offende gravemente chi ha deciso di costituire l’Osservatorio e tutta la classe forense». Che quello tra avvocati e giornalisti sia stato o meno di un equivoco, il fatto più grave è che «alla nostra iniziativa è stata associata una difesa ideologica da noi mai espressa alla criminalità organizzata, identificando il difensore con l’imputato». Come se gli avvocati “fossero” i clienti che difendono (nel caso Aemilia, indagati per ‘ ndrangheta). Al contrario, ha spiegato Sola, l’obiettivo dell’Osservatorio è di «aprire un percorso culturale a più livelli sul tema del bilanciamento del diritto di cronaca con il diritto alla difesa. In particolare, il monitoraggio sull’informazione giudiziaria e sulla politica giudiziaria verranno svolti con la finalità di organizzare un convegno e discuterne con tutte le parti in causa». Quanto al citato processo “Aemilia”, Sola ribadisce che «è stato citato come esempio di patologia, ma è scontato che l’Osservatorio non nasce certo per monitorare singoli processi, per di più ancora in corso. Aggiungo che, dal mio punto di vista, le fughe di notizie sono una patologia che non è certo da imputare ai giornalisti ma a chi permette che informazioni coperte da segreto trapelino illecitamente». La polemica non è ancora chiusa e se Sola ribadisce che «sarebbe importante avere un confronto con il mondo del giornalismo, cosa che del resto già è avvenuta proficuamente in molte sedi», la Camera Penale sottolinea come l’accaduto «rafforzi la convinzione che la decisione di costituire l’Osservatorio sia quanto mai più opportuna».
Vi spiego il manuale del perfetto burocrate. Come non prendere una decisione, come rimandarla o come non fare entrare in vigore una legge? Il manuale del perfetto burocrate spiegato dal professore di diritto costituzionale a Roma 3 Alfonso Celotto durante una delle ultime puntate di Virus.
Un viaggio irriverente (e anche amaro) nei labirinti della burocrazia italiana.
“NON CI CREDO, MA È VERO”: LA VITA SECONDO LA BUROCRAZIA, scrive Alfonso Celotto il 2 maggio 2016 su "Stati Generali". La burocrazia diventa parte della nostra vita dal momento in cui nasciamo e per ogni singolo passo che il bambino e poi l’uomo compie nel Paese in cui vive. Il dottor Ciro Amendola percorre un viaggio nei meandri di quel mostro invisibile che è la burocrazia in Italia, raccontando nel suo nuovo libro Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria burocrazia episodi tanto veri quanto folli, e a volte un po’ ridicoli, che ognuno di noi si trova a vivere quotidianamente nell’iter dell’esistenza. La burocrazia è una grande macchina, una grande scatola, ci accompagna dalla nascita alla morte, in ogni attimo della nostra vita, con una serie di certificazioni, copie conformi, firme autenticate, sempre ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. Bastano pochi secondi dopo il parto per entrare nella giungla della burocrazia. La nascita comporta subito almeno 3 adempimenti fondamentali, a carico dei genitori, che dovranno armarsi di santa pazienza e di un adeguato numero di ore di permesso dal lavoro. Occorre ottenere:
· Il certificato di nascita
· Il codice fiscale
· La tessera sanitaria (a cui si collegano il libretto sanitario e la scelta del pediatra).
Per semplificare la vita ai neo genitori, ovviamente vanno richiesti in tre uffici diversi. Il certificato di nascita viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è nato il bambino entro 10 giorni dalla nascita e si basa sulla “attestazione di nascita” rilasciata dalla ostetrica presente al parto. È il momento fondamentale per l’attribuzione del nome. Ai sensi della legislazione vigente, secondo le ultime modifiche del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ogni neonato può avere fino a tre nomi, tutti riportati per esteso e senza virgola (quando firmerà dei documenti ufficiali dovrà quindi sempre mettere tutti i nomi). È vietato per legge dare al bambino lo stesso nome del padre, dei fratelli e delle sorelle o nomi volgari, ridicoli o impronunciabili. A questo punto, si è nati, si ha un nome, ma non si è ancora veramente esistenti per il diritto. Manca il codice fiscale. Che ovviamente non è di competenza del Comune, ma dell’Agenzia delle Entrate. Altra amministrazione, altre regole, altri moduli. La Agenzia delle Entrate rilascia un certificato provvisorio valido per 30 giorni, in attesa del tesserino plastificato che arriva a casa. A quel punto, il genitore si recherà, con il codice fiscale del bambino e un’autocertificazione dello stato di famiglia, presso gli uffici dell’ASL di zona per la scelta del pediatra di base. Gli verrà rilasciato il tesserino sanitario da esibire a ogni prestazione medica richiesta per il bambino, come per esempio le vaccinazioni. E potrà finalmente scegliere il pediatra. La via crucis burocratica è iniziata. Ora il cittadino esiste in vita, con nome, codice fiscale, tessera sanitaria e pediatra! La via crucis della vita burocratica è solo iniziata. Per accompagnarci – fra commi, formulari, procure e deleghe – fino alla pensione, quando ci verrà sottoposto il più paradossale dei moduli: la autocertificazione di esistenza in vita. Nulla di male che l’INPS voglia accertarsi con un modulo che la pensione sta per essere pagata a un tizio ancora in vita. Peccato che la autocertificazione venga richiesta a pena delle sanzioni correlate alle dichiarazioni mendaci! Ma se ho attestato il falso, in quanto già morto, come faccio ad essere sanzionato per aver dichiarato il falso?
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria burocrazia, di Ciro Amendola edito da Historica, 2016. Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria burocrazia: Quali sono i "Dieci comandamenti" a cui si attiene quotidianamente il pubblico impiegato? E plausibile che nel 2015 il Parlamento italiano abbia approvato una legge per istituire la "giornata del dono"? Se viene trovato un geco in un ufficio pubblico intervengono gli ispettori sanitari per sopprimerlo? E possibile che la Guardia forestale abbia fatto causa alla Guardia di finanza sul colore delle divise? Perché ogni anno la Legge finanziaria (ora Legge di stabilità) ha un solo articolo con centinaia di commi? Cosa accadde veramente quando la capitale fu trasferita da Firenze a Roma?
Carte nascoste e riunioni fiume. La resistenza passiva dei burocrati. Esce un manuale di sopravvivenza: “Regola numero uno: chi non fa non sbaglia”. “Non è vero, ma ci credo. Storie di ordinaria burocrazia” (Historica) è il libro che Alfonso Celotto, docente universitario di diritto costituzionale e a lungo negli staff di diversi ministeri, ha scritto firmandolo con il suo alter ego letterario, il dott. Ciro Amendola direttore della Gazzetta Ufficiale, protagonista dei suoi primi precedenti romanzi, scrive il 27/04/2016 Giuseppe Salvaggiulo su "La Stampa". Nella stanza della dott.ssa Martone, capo di gabinetto del ministero dei Beni Culturali, «in ripetute occasioni è stata riferita la presenza di una Tarentola mauritanica». Il rag. Esposito, accompagnato da due tecnici dell’Ufficio sorveglianza sanitaria, è assertivo: «Occorre un prelievo delle feci dell’animale, per effettuare una compiuta analisi di laboratorio, sulla cui base valutare se e come procedere». Ma per la dott.ssa «non se ne parla. Quel geco mi porta fortuna. Andate via». Impossibile, obietta il rag., a meno che «lei non mi firmi il modello H32-bis, assumendosi la responsabilità per l’impropria presenza in ufficio dell’animale vivo». Basta un’autocertificazione per trasformare la temibile Tarentola mauritanica in un innocuo geco. Comincia così una delle «Storie di ordinaria burocrazia» del libro «Non ci credo, ma è vero» dal dott. Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale, sopraffino cultore dell’amministrazione e pseudonimo di Alfonso Celotto, costituzionalista e a lungo grand commis nei ministeri. Ogni racconto è uno spaccato della vita in un ufficio pubblico: leggi e decreti, provvedimenti e circolari, furbizie e vanità, sotterfugi e arabeschi ma anche insospettabile umanità. Nel primo capitolo l’autore ha scientificamente enucleato «le cattive abitudini del pubblico impiegato». Ne viene fuori un manuale di sopravvivenza «in una vita improntata non al senso di servizio per lo Stato, ma alla proficua occupazione delle ore da trascorrere in ufficio», il cui obiettivo è «eludere vagoni di pratiche in modo da offrire il proprio contributo operoso, ma senza prendersi alcuna responsabilità».
COME COMPORTARSI. Prima regola: tenere le carte a posto e far prevalere la forma sulla sostanza, nel senso di «chiedere sempre un parere in più e non uno in meno, seguire pedissequamente le procedure» e infischiarsene del vero interesse pubblico. Si dilatano i tempi? Meglio, l’importante è che l’istruttoria sia accuratissima e irreprensibile. «Di troppo zelo non è mai morto nessuno. Di superficialità molti». Seconda: attenersi rigorosamente al mansionario, «per fare il meno possibile». Il mansionario è «un rebus scritto in burocratese stretto», enigmatico come il responso della Sibilla cumana. Terza: copiare, perché chi copia non sbaglia mai e non si assume responsabilità (c’è sempre un precedente che aiuta e si può allegare). Quarta: nel dubbio, non fare perché «chi non fa non sbaglia» e non si assume responsabilità. Quinta: se proprio non si può evitare di affrontare una questione, convocare una riunione: consente di guadagnare tempo (convocazioni, conferme, rinvii). Indispensabile che i convocati siano almeno dieci, altrimenti la riunione potrebbe rivelarsi decisiva. Sesta: mettere da parte, sul ripiano più nascosto della stanza, le pratiche più difficili. Sono quelle legate a emergenze di attualità, sotto la luce dell’opinione pubblica. Apparentemente vanno risolte con priorità, in realtà «si fanno da sole». Troppe variabili, troppe complicazioni: meglio lasciarle lì. Dopo un paio di settimane l’attenzione scemerà e nessun superiore chiederà conto della mancata soluzione. Settima: non archiviare ordinatamente le carte più importanti, in modo che non siano rintracciabili da chiunque. Il funzionario perspicace aumenterà così il suo potere, rendendosi indispensabile. Ottava: «non regalare mai un minuto», anzi capitalizzare gli straordinari e i permessi. Il conto è semplice: «ai 365 giorni del calendario vanno sottratti 52 sabati, 52 domeniche, 30 giorni di ferie e un’ulteriore quindicina tra malattie, cure specialistiche, riposi compensativi, permessi sindacali, donazioni sangue, scioperi, permessi-studio, permessi familiari». Nona: non derogare ai ritmi della giornata-tipo: 8-11-13-15-16-16,12. Alle 8 lettura giornali e passaggio sui social network, caffè alle 11, pranzo alle 13, caffè alle 15, alle 16 chiusura dei fascicoli anche se incompiuti, in modo da presentarsi puntuali al tornello alle 16 e 12 minuti. «Ogni volta che il dott. Amendola rileggeva queste regole, si imbestialiva. Non si capacitava di atteggiamenti così miseri e gretti».
POST SCRIPTUM. Per un attimo la dott.ssa Martone ebbe voglia di mandare tutto e tutti a quel paese. Non valeva la pena spendere 15 ore al giorno contro quel muro di gomma. Poi... poi prese nel cassetto il modello H32-bis, che le era stato debitamente consegnato, e iniziò a compilarlo. In duplice copia e con firma debitamente autenticata».
“Non ci credo, ma è vero”, il libro di Celotto che racconta i paradossi della burocrazia, scrive Biancamaria Stanco il 3 Maggio 2016 su Cultora. Non ci credo, ma è vero – Storie di ordinaria burocrazia è il nuovo romanzo del giurista Alfonso Celotto firmato dal suo alter ego, il dott. Ciro Amendola. Dopo due romanzi che narrano le gesta e le vicissitudini del dott. Amendola negli uffici della Pubblica Amministrazione, ora è proprio il celebre direttore “a scendere in campo. È questa la grande novità” ha dichiarato Celotto. Il libro è infatti l’esordio narrativo di Ciro Amendola. Ma chi è davvero? È il direttore della Gazzetta Ufficiale Italiana, è un funzionario meticoloso, scrupoloso, maniaco dell’ordine e della precisione ossessionato dalla timbratura del cartellino. Un uomo abitudinario, perfezionista e amante del suo lavoro. E ha due anime: una svizzera, che si esplicita nella rigorosa puntualità e precisione professionale del dott. Amendola, e una più verace, un cuore partenopeo quello di Ciro amante della cucina, del buon vino e tifoso sfegatato del Napoli. Dietro il personaggio di Amendola vibra la personalità e l’esperienza di Alfonso Celotto, costituzionalista, avvocato e professore di Diritto Costituzionale a Roma Tre, ex Capo di Gabinetto e Capo dell’Ufficio legislativo dei ministri Bonino, Calderoli, Tremonti, Barca, Trigilia e Guidi. Un esperto conoscitore quindi delle leggi e della burocrazia che, indubbiamente, ha contribuito alla costruzione della figura del direttore. “Come disse Umberto Eco ‘in ogni romanzo c’è il 50% di un autore’ e in Amendola c’è un’amplificazione del personaggio che rispecchia quanto visto nella mia carriera” ha precisato Celotto. “Si scrive sempre su ciò che si conosce” ha aggiunto. “Come recita l’articolo 54 della Costituzione, Amendola è al servizio della Nazione” afferma il giurista. È un burocrate scrupoloso e molto attento che combatte con le continue violazioni della legge, la cattiva gestione della cosa pubblica e la lentezza della Pubblica Amministrazione. Nel primo capitolo decide di enucleare un decalogo delle «cattive abitudini del pubblico impiegato», un manuale di sopravvivenza improntato «non al senso di servizio per lo Stato, ma alla proficua occupazione delle ore da trascorrere in ufficio». 1. Tieni le carte a posto. 2. Applica con rigore il mansionario. 3. Chi copia non sbaglia. 4. Organizza riunioni con almeno 10 partecipanti. 5. Le pratiche più complesse non vanno lavorate. 6. Le carte importanti non si portano ordinatamente in archivio. 7. Non regalare mai un minuto. 8. Otto, undici, tredici, quindici. 9. Vai in ferie a giugno o a settembre. 10. Per mostrarti aggiornato usa spesso parole inglesi. Sette sono i racconti raccolti nel libro. “Sono tutte storie vere raccontate in maniera romanzata. Tutte cose verosimili” ha spiegato Celotto. Il manoscritto non va considerato un libro-denuncia del malfunzionamento del sistema burocratico italiano, per quanto rimane comunque uno specchio fedele della pessima gestione della cosa pubblica. “Non è vero, ma ci credo” – come ha affermato l’autore – è la raccolta di “racconti-verità scritti per far conoscere al lettore il settore della Pubblica Amministrazione. Una lettura leggera e semplificata. Un modo divertente per raccontare la Pubblica Amministrazione”. Celotto specifica che “il libro non vuole essere una denuncia, basta essere una macchina del fango. È un modo leggero per parlare di temi veri”. La scrittura è un’occasione per far conoscere al lettore la vita difficile di un Direttore fatta di decreti, leggi, circolari, provvedimenti, riti ministeriali e burocratici. Il direttore Amendola è convinto della necessità di riformare il sistema dell’Amministrazione Pubblica e si impegna in prima persona. È altresì convinto della difficoltà, ma da nuovo Ercole intraprende la sfida e affronta l’ennesima fatica. “Non basta una legge per cambiare il sistema, la Pubblica Amministrazione è una macchina ampia e complessa” – asserisce Celotto – “bisogna cambiare la mentalità. Si tratta di attuare un’operazione culturale”. Le parole d’ordine sono – a detta del giurista – “trasparenza” e “semplificazione”. “Serve il coraggio per rendere la macchina più veloce e funzionale” conclude Celotto. Il dott. Amendola non poteva non divenire punto di riferimento e modello di integrità morale per quanti lavorano onestamente e spingono per cambiare le cose. Forse dopo Elena Ferrante assisteremo a un nuovo caso editoriale. La differenza è che “Ciro Amendola esiste davvero, ma non potrà uscire allo scoperto. Non potrà concedersi perché deve lavorare”.
La burocrazia tra Kafka e Totò: a ruba "Non ci credo, ma è vero", scrive Affari italiani, Lunedì 4 luglio 2016. "Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria burocrazia" il libricino introvabile di Alfonso Celotto è diventato un caso letterario. E' un libricino introvabile di poco più di cento pagine sui banconi di pochissime librerie, essendo pubblicato da un editore pressoché sconosciuto e privo di una rete commerciale, Historica. Ma la sua notorietà si diffonde col passaparola e il libricino va a ruba. S'intitola Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria burocrazia. E l'autore Ciro Amendola, non esiste. O meglio è lo pseudonimo di un tipo umano, il dott. Ciro Amendola, uno dei massimi esperti di diritto e burocrazia. Napoletano di nascita(1944), vive a Roma per necessità. Da anni fedele e scrupoloso servitore dello Stato, dal 2001 dirige la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Vive secondo immutabili ritmi svizzero-napoletani per conciliare l'impiego ministeriale con la missione esistenziale di completare la grande banca dati delle leggi d'Italia. Appassionato di cucina, vini, smorfia, scaramanzia, gioco del lotto, segue con attenzione le vicende calcistiche del Napoli. Per il suo esordio da scrittore ha scelto di descrivere i riti della vita ministeriale e della burocrazia che circondano la nostra vita di cittadini, secondo abitudini e prassi ottocentesche. L'idea è dell'autore vero, Alfonso Celotto, professore universitario di Diritto, già gran commis dello Stato (è stato capo di gabinetto di diversi ministeri, tra cui quello dello della Semplificazione, ai tempi del leghista Calderoli e del suo misterioso falò delle leggi inutili), geniale osservatore della vita dei burocrati e penna acuta ed ironica (ha al suo attivo anche per Mondadori Il dott. Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale e per Il mio libro Il Pomodoro va rispettato), a metà tra Kafka, Totò ed Edoardo De Filippo. L'opera è un piccolo gioiellino, veloce e dilettevole a leggersi. Racconta, ad esempio, quali sono i "Dieci comandamenti" a cui si attiene quotidianamente il pubblico impiegato. Si domanda se sia plausibile che nel 2015 il Parlamento italiano abbia approvato una legge per istituire le "giornate del dono". Rivela il fatto che la Guardia Forestale ha fatto causa alla Guardia di Finanza sul colore delle divise. Spiega perché ogni anno la legge Finanziaria (ora Legge di stabilità) ha un solo articolo con centinaia di commi. E molto altro ancora. Leggi, decreti, provvedimenti e circolari. Vini, sfogliate, ministeri e ministeriali. Il dott. Ciro Amendola si confronta non solo con il mondo del diritto e della pubblica amministrazione, ma anche con cucina, scaramanzia, napoletanità. "Poiché diritto e cucina si assomigliano", spiega Celotto alias Amendola nella videointervista ad Affaritaliani.it. "Non sono scienze, sono entrambi opinabili". E noi opiniamo.
D’Alema e la Tap, una storia degli orrori, scrive Nicola Porro, su “Il Giornale” il 20 gennaio 2018. La storia della Tap è una storia degli orrori. Per l’ennesima volta dimostra l’inaffidabilità del nostro «Sistema paese», di cui tutti si riempiono la bocca. La breve cronaca che vi stiamo per fare, è il migliore spot per dire alle imprese straniere: allontanatevi dall’Italia. Per le aziende che invece in questo paese ci campano, purtroppo c’è poco da fare. Altro che fuga di cervelli, la vera domanda è come sia possibile che qualcuno si ostini a rimanere. La nostra storia si compone di un attore, Massimo D’Alema, questa volta il ruolo da protagonista non glielo toglie nessuno. E da una serie di comprimari: otto sindaci delle zone vicine all’approdo del tubo Tap e una serie di sceriffi, questa volta buoni, che sono i giudici di tribunali di ogni ordine e grado. Un lustro fa, il nostro D’Alema, quando ancora era nel Partito Democratico, diceva in un’intervista televisiva che non bisognava raccontare sciocchezze ai cittadini e che il tubo che portava il gas in Italia si sarebbe dovuto fare e che si trattava di «un piccolo tubicino interrato che non comportava impatto»…D’altronde fu proprio D’Alema, quando era premier, a firmare il recepimento di una direttiva europea (Direttiva 96/82/CEE), in cui (semplifichiamo) venne escluso il trasporto gas, comprese le stazioni di pompaggio, dalle dure prescrizioni della cosiddetta Legge Seveso. Non contento di questo duplice atto, D’Alema qualche settima fa ha cambiato idea: «Dovrebbe far riflettere molti il modo in cui il governo nazionale ha potuto decidere con un proprio atto di imperio, dopo una lunghissima vicenda, l’approdo del gasdotto (Tap, ndr) in una delle aree turistiche più qualificate, con la pretesa di militarizzare il cantiere. Di fronte a tanta sfrontatezza, l’intera rappresentanza salentina avrebbe dovuto mettere la testa sotto terra per la vergogna». Qua l’unico che si deve vergognare delle proprie tarantelle è chiaramente D’Alema. La cosa finirebbe qua, se si trattasse solo dell’ennesima presa di posizione di un politico, oggi, con scarso seguito. Il problema è che D’Alema alimenta il clima di ostilità verso un’infrastruttura innocua, utile per la nostra diversificazione energetica, e che ci siamo impegnati a fare. Non parliamo della protesta delinquenziale, che sabota, distrugge e minaccia. Ma di quella ben più efficace fatta in doppiopetto, e alla quale D’Alema evidentemente strizza l’occhio per avere quattro consensi in più. Su ciò rischiando di doverseli spartire con esponenti come Barbara Lezzi del movimento cinque stelle, che sono imbattibili nel bloccare ogni tipo di infrastruttura. Dopo tredici diversi procedimenti e giudizi contro Tap e suoi rappresentanti, tutti incontestabilmente vinti dal Tubo negli ultimi cinque anni, a fine 2017 otto sindaci, non contenti, hanno fatto l’ennesimo esposto penale (a cui evidentemente si ispira D’Alema) contro i rappresentanti del Tap e del ministero. Soldi pubblici buttati nel cestino e minacce giuridiche nei confronti di amministratori che rischiano carriera e quattrini solo per alimentare la campagna elettorale e demagogica di politici che non vedono più in la del loro naso. Le contestazione sono sempre sulla famosa applicabilità della legge Seveso. Dopo che due volte al Tar, una volta al consiglio di Stato e persino un giudice penale hanno scritto nelle loro sentenze che la legge Seveso (quella che D’Alema dovrebbe conoscere bene) non si applica ad un tubo, gli otto sindaci continuano facendo finta di niente: tanto non pagano loro per queste cause temerarie. In realtà sperano che alla fine tra tanti magistrati, uno che gli conceda un piccolo rinvio o supplemento di indagine lo trovano. A quanto si sa, la riapertura dell’inchiesta sarebbe stata decisa perché gli 8 sindaci no Tap hanno chiesto di considerare il Prt (cioè il terminale di ricezione del gas) e il gasdotto di interconnessione alla rete nazionale (di Snam) un impianto unico da Melendugno a Brindisi e, dunque, di valutare se debba essere soggetto a una nuova valutazione di impatto ambientale. Tutte balle. I giudici, con delle sentenze chiarissime, hanno fatto capire che laddove arriva il tubo, non si manipola alcunché. I locali sono in sicurezza. E dunque non si devono richiedere nuove autorizzazioni o fare nuove richieste. Eppure in una sorta di tela di penelope giudiziario-burocratica, gli amministratori pugliesi cercano di rallentare, frenare, denunciare, questionare. Ci troviamo in un paese in cui anche rispettare le nostre leggi più farraginose e garantiste non è sufficiente. Un paese in cui un politico, ritenuto «serio e affidabile» come D’Alema, si rimangia una propria legge e la propria parola per ottenere quattro voti in più.
La storia infinita sull’ ILVA di Taranto. E qualche sospetto…, scrive il 14 dicembre 2017 "Il Corriere del Giorno". Tutelare contestualmente l’occupazione e la salute non è operazione facile ed agevole come dimostra il discutibile ricorso strumentale presentato dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia, fortemente osteggiato e criticato da Governo e sindacati insieme, che rischia di bloccare di nuovo la produzione ed il rilancio dell’occupazione ed economia dell’indotto tarantino. Nelle ultime settimane si è tornati a parlare della ipotesi fortemente cavalcata da Emiliano, improvvisatosi manager ed ambientalista, che lo stabilimento dell’ILVA di Taranto possa essere chiuso, facendo saltare l’acquisizione da parte della cordata Am InvestCo Italy, ma anche il posto di lavoro di 14 mila dipendenti (e circa 4.000 dell’indotto) e soprattutto la bonifica dell’area inquinata limitrofa al quartiere Tamburi di Taranto. L’ultimo problema nella prolungata difficile vita dell’acciaieria tarantina è un ricorso presentato irresponsabilmente al TAR Lecce dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia contro l’autorizzazione che il Governo ha dato all’azienda per consentirle di continuare a produrre fino al 2023, in cui devono essere terminati i lavori di bonifica dell’impianto. Il decreto di Palazzo Chigi di fatto consente allo stabilimento di continuare a produrre nelle condizioni attuali per cinque anni, in vista della bonifica degli impianti pronta a partire. Secondo il Comune di Taranto e la Regione, sostenuti da circa un migliaio di persone aderenti ai vari comitati di cittadini e dalle associazioni pseudo-ambientaliste, sarebbe un periodo di tempo troppo lungo, soprattutto per una città come Taranto che da anni è colpita dalle emissioni fuori misura dell’enorme stabilimento costruito a ridosso del centro urbano. Ma i due ultimi “populisti” pugliesi e cioè il governatore Emiliano ed il “fido” sindaco di Taranto Melucci hanno osteggiato la decisione, trovandosi contro il Governo ed sindacati, alleati a difesa del lavoro, sostenendo unitariamente che il ricorso alla magistratura è la strada sbagliata per poter migliorare la situazione. La travagliata vicenda dell’ILVA di Taranto ha origine nel 2012, quando una certa magistratura fortemente “politicizzata” e soprattutto alla spasmodica ricerca di protagonismo e visibilità nazionale, aveva disposto il sequestro dell’acciaieria e l’arresto di alcuni suoi dirigenti, tra cui i proprietari, la famiglia Riva, per violazioni ambientali affidandoli a commissari giudiziari che definire incompetenti e pericolosi è dir poco. Nell’ordinanza di sequestro della magistratura tarantina era scritto: “Chi gestiva e gestisce l’Ilva ha continuato nell’attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza”. Nei successivi due anni prima il governo Letta e poi quello guidato da Matteo Renzi hanno cercato di mantenere aperta almeno una parte dell’acciaieria, per poter proseguire nella produzione (che si è dimezzata a seguito anche dei lavori di risanamento ad alcuni altoforni), che è molto importante per diversi settori dell’industria italiana. La via per ottenere questo risultato fu l’approvazione di una serie di decreti leggi che, in pratica, consentivano all’ILVA di produrre inquinando oltre i livelli consentiti e prolungando il termine entro il quale l’impianto doveva essere riportato a norma. Operazione per cui occorrevano ingenti somme che neanche il Governo poteva stanziare a causa del divieto comunitario di “aiutare” finanziariamente le aziende. Nel 2014 l’ILVA venne posta dal Governo in amministrazione straordinaria ed affidato agli amministratori nominati dallo Stato venne affidato il compito di iniziare il risanamento ambientale ed economico, e successivamente metterla in vendita. Nel gennaio 2016 venne pubblicato il bando per la messa in vendita di Ilva, e ad aggiudicarselo è stato il consorzio Am InvestCo Italy, costituito dalla multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal (85%) leader mondiale nella produzione di acciaio, e dal Gruppo Marcegaglia (15%) che finora era stato il principale cliente di acciaio prodotto nello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo scorso 29 settembre 2017 il Governo Gentiloni ha approvato una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con cui autorizza lo stabilimento di Taranto a continuare a produrre alle attuali condizioni fino al 2023, allorquando le opere di bonifica e riduzione delle emissione dovranno essere definitivamente ultimate. Nello scorso mese di novembre 2017 la cordata Am InvestCo Italy ha illustrato e reso noto in una serie di incontri con il Governo e con i sindacati, le procedure e tempistiche con cui si intendeva procedere alla definitiva agognata bonifica dell’impianto di Taranto e conseguentemente all’attesa diminuzione delle sue emissioni dannose, impegnandosi a investire 1,15 miliardi di euro per il risanamento ambientale degli impianti dal 2018 al 2023, cioè anno in cui scadrà l’AIA approvata dal governo. I sindacati a partire dai leader nazionali della FIOM insieme a quelli di UILM, il più grande sindacato tra i lavoratori di Taranto, e di FIM CISL, sono sembrati abbastanza soddisfatti. Ma al Comune di Taranto guidato da Rinaldo Melucci un “neofita” della politica (con un recente passato di operatore portuale dai risultati non esaltanti, anzi deficitari) eletto per puro caso, ed alla Regione Puglia nelle mani dell’ex-magistrato Michele Emiliano, due “politicanti” che non hanno entrambi alcuna esperienza manageriale e soprattutto competenza scientifica-ambientale invece, il piano elaborato dai manager della multinazionale Arcelor Mittal non è piaciuto. Lo scorso 16 novembre, era previsto un altro incontro al Ministero dello Sviluppo Economico in cui la cordata Am InvestCo Italy avrebbe dovuto presentare il suo piano ambientale agli enti locali. Incontro a cui con poco tatto istituzionale il sindaco di Taranto, si è rifiutato di partecipare, pretendendo che venisse aperta una trattativa diretta, cioè un “tavolo” a cui avrebbero dovuto partecipare solo gli enti locali toccati direttamente dalla questione dello stabilimento di Taranto. Il sindaco di Taranto Melucci pretendeva di essere convocato entro il 24 novembre ed allorquando si è reso conto di essere stato ignorato, e la convocazione non arrivata, ha annunciato (“pilotato” dietro le quinte da Emiliano) che avrebbe fatto ricorso al TAR contro l’AIA approvata dal governo il 29 settembre, cioè l’autorizzazione che consente all’ILVA di Taranto di continuare a produrre alle attuali condizioni fino al 2023. Michele Emiliano e Melucci hanno annunciato ufficialmente il 28 novembre di aver presentato il ricorso affidandosi ad un avvocato-politicante barese Marcello Vernola già coinvolto nella vicenda delle “consulenze d’oro” del crack Ferrovie Sud Est, in cui la Guardia di Finanza e la magistratura barese hanno accertato sprechi e consulenze d’oro e soprattutto “allegre”. Come purtroppo accade in Italia quando c’è di mezzo la magistratura amministrativa, non è mai chiaro cosa potrebbe succedere in sede di giudizio. Qualora il TAR dovesse accogliere il ricorso del Comune di Taranto e della Regione Puglia è possibile che l’AIA venga sospesa in attesa della decisione finale del Consiglio di Stato al quale inevitabilmente il tal caso il Governo ricorrerebbe in appello. Ma in questa funesta ipotesi lo stabilimento dell’ILVA di Taranto verrebbe di fatto costretto a interrompere tutte le attività, con ingenti danni economici e sopratutto conseguenze sociali ed occupazionali imprevedibili. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda molto presente e responsabilmente attivo sulla vicenda, su cui è calato il silenzio assordante dei partiti a partire dal Pd per finire a Forza Italia, ha duramente criticato la decisione del governatore Emiliano ed ha paventato l’ipotesi che il fermo delle attività produttive dell’ILVA di Taranto, potrebbe indurre la cordata Am InvestCo Italy ad un ritiro dell’offerta di acquisizione. Voci da tenere in considerazione ricordano che tale ipotesi potrebbe far rientrare in gioco il gruppo indiano Jindal concorrente nella gara pubblica di acquisizione dell’ILVA, che aveva persino manifestato (dopo aver perso la gara) la propria disponibilità ad aumentare la propria offerta iniziale che non era particolarmente vantaggiosa. Ed in certi affari dietro le quinte può succedere e “girare” di tutto e di più. Soprattutto in termine di soldi e contributi politico-elettorali…Il ministro Calendo ha ricordato che sinora “Emiliano ha fatto ricorso su tutto: dai vaccini al Tap, all’Ilva stessa. Per fortuna li ha sempre persi. Oggi però la situazione è diversa, perché il rischio è che Arcelor Mittal ritenga impossibile gestire l’acciaieria più grande dell’Unione Europea con il sindaco della città e il presidente della regione che vogliono cacciarlo via”. Come dicevamo poc’anzi i sindacati UILM e FIM-CISL sono schierati con Calenda e quindi con il Governo, la settimana scorsa hanno organizzato una forte protesta proprio di fronte alla sede del Consiglio Regionale di Puglia per protestare e manifestare contro il ricorso di Emiliano e Melucci, che mette a rischio i posti di lavoro dei 14 mila dipendenti ed i 4mila dell’indotto. Il ministro Calenda ha fatto sapere di essere pronto a ricominciare le trattative convocando per il prossimo 20 dicembre un “Tavolo per Taranto” che si terrà a condizione (giusta secondo noi) che la Regione e il Comune di Taranto ritireranno il loro ricorso, annunciando che, fino a quando il TAR non avrà adottato una propria decisione, tutti i colloqui sono sospesi, non volendo sottostare al vero e proprio “ricatto” dei due politicanti pugliesi. Infatti definire “politici” Emiliano e Melucci, potrebbe fare giustamente offendere la lunga tradizione di “veri politici” a cui la Puglia ha dato i Natali, a partire dai compianti Aldo Moro e Pinuccio Tatarella, arrivando a Claudio Signorile, Biagio Marzo, ecc…. Ma il problema ambientale di Taranto è in realtà soltanto l’ultimo dei problemi che si sono presentati nella “questione ILVA”. Un altro ostacolo è relativo alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea, in quanto secondo qualcuno con l’acquisizione di ILVA, il Gruppo Arcelor Mittal (il socio maggioritario e di controllo di Am InvestCo Italy n.d.r.) potrebbe arrivare ad avere una posizione dominante nella produzione dell’acciaio in Europa, violando così la normativa anti-trust dell’Unione. Il procedimento deve terminare entro il prossimo 23 marzo 2018, ma secondo fonti della Commissione dovrebbe concludersi anche prima. La multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal ha già annunciato che in caso di richiesta da parte dell’Antitrust Europea di ridurre la produzione per non superare le soglie comunitarie, che non ridurrà o modificherà la produzione in Italia, ma piuttosto dismetterà altre sue attività all’estero. La storia degli ultimi mesi, conferma che quella dell’ILVA è di fatto una delle questioni industriali più complesse degli ultimi anni, dove si incrociano e scontrano esigenze ed interessi (a volte occultati) differenti e spesso in contrasto fra di loro. La questione delle questioni fondamentali è quella ambientale in quanto a causa delle numerose violazioni della normativa ambientale, lo stabilimento di Taranto, ha causato non pochi danni alla popolazione cittadina, portando a proteste dei cittadini. Ma esiste anche un fondamentale problema occupazionale: l’ILVA dà lavoro direttamente a Taranto 14 mila dipendenti, mantenendo di fatto altrettante famiglie, e tramite l’indotto, ad altre 4mila ed oltre 300 imprese di fornitori ed appaltanti. A Taranto l’ILVA è l’unica reale attività produttiva industriale ed economica, importantissima e fondamentale per l’economia locale. Concludendo c’è una questione industriale, la circostanza che l’acciaio prodotto da ILVA è molto importante per l’economia italiana e, conseguentemente, se gli stabilimenti dovessero chiudere per la gioia e vanità di Emiliano e Melucci e di un migliaio di pseudo-ambientalisti della domenica, diverse aziende italiane sarebbero costrette a rifornirsi all’estero, soprattutto in Germania, acquistando peraltro acciaio a prezzi maggiorati. Ma tutto questo Emiliano e Melucci non lo capiscono o non lo sanno. O forse è proprio quello che vogliono…?
ITALIA. DEMOCRAZIA COL BROGLIO.
Broglio elettorale. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Sono brogli elettorali tutte quelle operazioni illecite di manipolazioni del voto che tendono a falsare una consultazione elettorale.
La moderna espressione italiana deriva da un analogo termine veneziano. Nell'antica Serenissima era infatti consuetudine per i membri della nobiltà impoverita riunirsi in uno spazio antistante il Palazzo Ducale di Venezia per far commercio dei propri voti in seno al Maggior Consiglio che reggeva la città e nel quale sedevano per diritto ereditario. Tale spazio era allora noto col nome di Brolio dal latino Brolus, cioè "orto", retaggio del fatto che la terra su cui tuttora sorge piazza San Marco era in antico proprietà agricola del vicino monastero di San Zaccaria.
Accuse di brogli in Italia. L'accusa di brogli elettorali in Italia è antica. Durante il Risorgimento, le annessioni dei regni preunitari al Regno d'Italia, vennero sempre ratificate mediante plebisciti. Tali consultazioni, a suffragio censitario, si svolsero senza tutela della segretezza del voto e talvolta in un clima di intimidazione. I "no" all'annessione furono in numero irrisorio e statisticamente improbabile. Il procedimento dei plebisciti durante il Risorgimento fu criticato da diverse personalità politiche ed il The Times sostenne che fu «la più feroce beffa mai perpetrata ai danni del suffragio popolare». Tale evento è stato anche trattato nel romanzo "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Alla nascita della Repubblica Italiana, i monarchici attribuirono la loro sconfitta a brogli elettorali. Nella puntata del 5 febbraio 1990 della trasmissione Mixer, condotta da Giovanni Minoli, andò in onda un falso scoop secondo il quale il re avrebbe fatto in modo che il referendum proclamasse la Repubblica per evitare al paese la guerra civile, ma si trattava soltanto di un abile montaggio per esibire quanto la televisione potesse deformare la realtà dei fatti e influenzare il pensiero dei cittadini, e scatenò un mare di polemiche. Appena conclusesi le consultazioni per il rinnovo del parlamento italiano del 2006 il premier Silvio Berlusconi, primo caso nella cinquantennale storia della Repubblica di una tale grave contestazione da parte di un esponente del governo uscente, ha paventato l'ipotesi di brogli elettorali sebbene il presidente Ciampi e il Ministro dell'interno Pisanu avessero espresso il loro compiacimento per lo svolgimento regolare delle elezioni. Durante i giorni dell'insediamento del Senato della Repubblica della XV legislatura Roberto Calderoli ha continuato ad insistere sulle ipotesi di brogli elettorali, confermando la sua convinzione secondo la quale la Casa delle Libertà è risultata vittima di un complotto che l'ha privata della vittoria elettorale. Piuttosto, forti sospetti ha destato l'insolito comportamento di Pisanu. Mai infatti, nella storia dell'Italia repubblicana, un ministro dell'interno aveva abbandonato il Viminale nel corso delle operazioni di spoglio elettorale. Convocato da Berlusconi, il ministro ha dovuto sostenere un faccia a faccia con quest'ultimo e, cosa ancora più strana, nessuno è a conoscenza di quello che fu l'oggetto della loro discussione.
Accuse di brogli al di fuori dell'Italia. Questa sezione sull'argomento politica è solo un abbozzo. Un caso acclarato di frode elettorale è il referendum istituzionale del Vietnam del Sud del 1955, dove i voti conteggiati per la repubblica superarono il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Gravi controversie hanno investito le elezioni presidenziali americane del 2000 nello stato della Florida, che per un soffio, e dopo settimane di esaminazioni da parte della Corte Suprema americana, hanno assegnato la vittoria a Bush. Altre accuse di forti irregolarità sono state registrate durante le elezioni presidenziali americane del 2004, che hanno rieletto il presidente Bush, e le elezioni generali filippine dello stesso anno. Più recentemente forti sospetti di brogli elettorali ci sono stati in Bielorussia, nelle elezioni di marzo 2006, e nel febbraio durante le elezioni ad Haiti. Dopo la consultazione elettorale tenutasi in Iraq il 15 dicembre 2005 il "Fronte dell'accordo iracheno", una delle principali liste sunnite, ha denunciato palesi irregolarità. I brogli si sarebbero registrati in particolare a Baghdad, dove la lista sciita "Alleanza irachena unita" avrebbe ottenuto quasi il sessanta per cento.
GIULIO ANDREOTTI RICORDA LE ELEZIONI DEL 1948: "MENO MALE CHE ABBIAMO VINTO NOI". Scrive Francesco Persili su "Recensito". Democristiano sagace e manovriero, deputato dell’Assemblea Costituente, già presidente della Fuci (dopo Aldo Moro), sottosegretario dal 1947 al 1953 alla presidenza del Consiglio con De Gasperi, parlamentare, ministro dell’Interno (1954), delle Finanze (1955), del Tesoro (1958-59), della Difesa (1959, 1966, 1974) dell’Industria (1966-1968), del Bilancio (1974-1976), degli Esteri (1983-1989). Per ben sette volte presidente del Consiglio tra il 1972 e il 1991, il senatore a vita Giulio Andreotti è dal secolo scorso un protagonista di prima fila della vita politica italiana. “Divo Giulio” (per la stampa), Belzebù (per gli avversari), il dominus della Prima Repubblica sempre sulla scena e continuamente al centro di polemiche, accuse e processi, ricorda: ”A parte le guerre puniche mi è stato attribuito di tutto”, dal concorso esterno in associazione di stampo mafioso all’uso spregiudicato dei servizi segreti deviati. In questa legislatura ha rischiato di diventare Presidente del Senato ed ora si batte contro il progetto di regolamentazione giuridica delle coppie di fatto (c.d. Dico). Giornalista professionista, aforista brillante (“A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina”) scrittore, tiene una rubrica su “Il Tempo” e scrive libri di successo (1953: fu legge truffa? è il titolo della sua ultima fatica letteraria edita da Rizzoli). Abbiamo incontrato il Senatore al termine della proiezione di “Cosacchi a San Pietro”, l’esperimento di controfattualità sulle elezioni del 1948 presentato da “La Storia siamo noi” di Giovanni Minoli.
Presidente Andreotti, le elezioni del 18 aprile 1948 furono un momento decisivo per la Storia dell’Italia repubblicana. Cosa sarebbe successo se avessero vinto i rossi?
Giulio Andreotti: “Il fatto che non abbia vinto il Fronte popolare lo considero una grande fortuna per l’Italia. Paradossalmente la lista unica ci aiutò molto. Nel 1946 il numero di rappresentanti eletti all’Assemblea Costituente da PCI e PSI che si presentarono separati fu molto superiore al nostro. Mi ricordo che Nenni aveva trovato, come al solito, una sintesi molto efficace ed aveva coniato il motto “Marciare divisi per colpire uniti”. La campagna elettorale mi ricordo che fu molto difficile. I comunisti erano più bravi di noi nel mobilitare le masse. Pajetta addirittura frequentò la scuola di dizione per essere più efficace quando parlava. Per le elezioni del 1948 scelsero di fare un fronte unico della sinistra con i socialisti. Il matrimonio non funzionò, meno male”.
Ci potevano essere le condizioni per realizzare in Italia un governo delle sinistre senza vincoli di cieca obbedienza nei confronti di Mosca e del Cominform?
G.A.: ”Non credo ci fossero i margini per mantenere equidistanza da Mosca e da Washington. L’Italia non era un’altra cosa. La via italiana al socialismo difficilmente si sarebbe realizzata. Quando Nenni andò in Unione Sovietica a ricevere il premio Stalin tornò e riferì a De Gasperi ciò che aveva detto a Stalin: “Mi batto per un’Italia neutrale”. Ma quello fece cenno di no con il capo e lo fulminò: “L’Italia al massimo può non essere oltranzista”.
La campagna elettorale del 1948 fu durissima. Lo scontro non era tra DC e Fronte Popolare ma tra due opposte e inconciliabili visioni del mondo. Dopo il 18 aprile la situazione peggiorò. L’avversario era un nemico. Ci furono caccie all’uomo, scontri di piazza. Si arrivò a un passo dalla guerra civile dopo l’attentato a Togliatti. Che ricordo ha del segretario del PCI?
G.A.: “Mi sento responsabile dell’attentato a Togliatti. Quel giorno ero io che parlavo al banco del governo. Si discuteva di una questione che riguardava la fornitura di carta per i giornali. Ero di una noia tale che Palmiro Togliatti decise di andarsi a prendere un gelato da Giolitti. Uscì dalla Camera e Pallante gli sparò. Rimanemmo con il fiato sospeso, poi si riprese e tornò al suo posto. Non ho avuto modo di frequentarlo spesso, né di conoscerlo a fondo. Non dava molta confidenza. Ricordo solo che una volta durante una riunione nella crisi del governo Bonomi mi raccontò del suo viaggio in Mongolia, e mi disse che le notizie o gli venivano taciute o gli giungevano con incredibile ritardo. Mi disse, insomma, che i comunisti italiani contavano poco”.
Il documentario di Minoli si apre con una confessione dell’agente della Cia Milton Friedman che ammette i brogli per favorire la vittoria della DC alle elezioni del 1948. Cosa c’è di vero?
G.A.: “Non ho mai visto un dollaro americano. Feci una campagna senza tanti mezzi, tirando la cinghia e con una macchina scassata con cui muovevo per stradine impervie. Tutta questa pioggia di aiuti americani non la ricordo. Non facevo il tesoriere della Democrazia Cristiana. Per fortuna, non mi sono mai occupato di finanziamenti…”.
Con quale stato d’animo ha ripercorso le storie tese di quei giorni che tennero a battesimo l’Italia repubblicana, democratica e filo-atlantica?
G.A.: “Ho visto questo filmato con grande commozione e partecipazione. Il fiato lungo è lo stesso di quando passammo 3 giorni e 3 notti chiusi dentro Montecitorio a discutere l’adesione dell’Italia al Patto Atlantico mentre fuori impazzava la protesta. Ci fu un tentativo di invasione. Il ministro degli Interni Scelba, una persona preziosa per la democrazia in Italia, aveva dato l’ordine di lasciare fare fino a Piazza Colonna e di intervenire solo qualora i manifestanti avessero cercato di forzare quel blocco. Ci fu molta tensione. Un deputato, Giolitti mi pare, uscì e prese una botta in testa. Quando me lo riferirono risposi: “Un buon motivo per restare dentro”. Una deputata rimase male per questa cosa e per anni non mi parlò.
Come sarebbe andata a finire con un governo delle sinistre?
G.A.: “Non so se sarei stato libero. Probabilmente avremmo corso il rischio di finire come in Cecoslavacchia. La gioia per lo scampato pericolo è grande. Nonostante tutta la buona volontà delle sinistre sarebbe stato inevitabile appiattirsi sulle posizioni dell'Unione Sovietica. (Francesco Persili)
Voto in Sicilia, interpellanza M5s: «Rischio brogli, venga l’Osce». Martedì discussione in Commissione affari costituzionali della Camera. «Nulla lascia presagire che esse saranno libere da inquinamenti estranei alle logiche proprie di una competizione in un Paese democratico», scrive Franco Stefanoni il 27 ottobre 2017 su "Il Corriere della Sera". Il governo deve «adottare tempestivamente iniziative, anche normative» per avanzare all’Osce la richiesta di invio di osservatori elettorali alle elezioni regionali siciliane perché «nulla lascia presagire che esse saranno libere da inquinamenti estranei alle logiche proprie di una competizione in un Paese democratico». È l’interpellanza di M5s, prima firma Danilo Toninelli, che sarà discussa martedì in Commissione Affari costituzionali della Camera. Il documento di M5s (firmato anche da Luigi Di Maio, Daniele Pesco, Simone Valente e Emanuele Scagliusi) rileva che «nessun Paese può dirsi esente da fenomeni illeciti, brogli, violazioni, palesi o latenti» in occasione delle elezioni, ma che tali fenomeni, «ove confinati all’occasionalità o all’esiguità, non intaccano l’essenza democratica di un Paese». Invece «nel nostro Paese i fenomeni di compressione della libertà di voto o connessi a brogli non sono da considerarsi occasionali né esigui». Le elezioni siciliane, poi, «destano particolare preoccupazione» perché «nelle liste di candidati a sostegno degli aspiranti presidenti della giunta regionale sia della coalizione di centrodestra che di centrosinistra sono presenti numerosi personaggi sotto inchiesta ovvero sotto processo ovvero condannati in primo grado ovvero figli di personaggi politici oggetto di pesanti inchieste e condanne nel recentissimo passato», per non parlare del fatto che «vi sono anche numerosi casi di candidati sotto inchiesta per reati legati specificamente al procedimento elettorale». Insomma «nulla lascia presagire che le imminenti elezioni siciliane, data anche la loro primaria rilevanza anche dal punto di vista nazionale, saranno libere da inquinamenti estranei alle logiche proprie di una competizione in un Paese democratico». Di qui l’impegno al governo «ad adottare tempestivamente iniziative, anche normative, per avanzare all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) la richiesta di invio di osservatori elettorali in occasione delle prossime elezioni regionali siciliane del 5 novembre, al fine di assicurare la loro presenza presso gli uffici elettorali di sezione».
Elezioni comunali, scomparse schede elettorali: accusa di brogli. A Città di Castello il rappresentante di lista del M5S ha denunciato la scomparsa di una tessera elettorale per le elezioni comunali, scrive Claudio Cartaldo, Domenica 05/06/2016, su "Il Giornale". Non si fermano i casi di irregolarità alle elezioni comunali. L'ultimo caso arriva da Città di Castello, in Umbria, dove il rappresentante di seggio del Movimento Cinque Stelle ha denunciato la scomparsa di schede elettorali. Quello che se teme è che la scheda o le schede scomparse possano essere usate per modificare il risultato del voto nel comune umbro. L'allarme è scattato durante le operazioni di allestimento del seggio, scrive il Corriere dell'Umbria. Non si sono nemmeno chiusi i seggi che già si fa fatica a tenere il conto delle denunce di brogli alle elezioni odierne. A Napoli i casi più eclatanti. La polizia è dovuta intervenire su segnalazione perché alcune persone sarebbero state intente a comprare voti: 20 euro in cambio della croce sul simbolo del partito desiderato. Sempre a Napoli un candidato nelle liste che appoggiano De Magistris ha denunciato su Facebook presunti brogli del Pd, che avrebbe costretto gli elettori a fare le foto nel seggio per dimostrare di aver votato Valeria Valente. Ma il Pd ha denunciato essere un fake. Infine, a Rivo di Puglia, un presidente di seggio è stato sospeso dal servizio perché avrebbe messo da parte tre schede (poi finite in nella borsa di un altro addetto del seggio) ed è stato scoperto dai rappresentanti di lista.
Elezioni, candidato di De Magistris: "Il Pd fa brogli: ecco la foto". Rosario Maresca, candidato nella lista Dema nella coalizione di De Magistris attacca il Pd a Napoli: "Obbliga elettori a fare le foto della scheda", scrive Claudio Cartaldo, Domenica 05/06/2016, su "Il Giornale". "Vergogna, il PD". Inizia così il messaggio su Facebook di Rosario Maresca, candidato consigliere comunale alle odierne elezioni nella lista Dema nella coalizione di De Magistris. Accusa correlata con una foto. "Ci sono elettori - si legge nel post - costretti a fotografare il proprio voto per il PD accanto al proprio documento di identità in modo da poter dimostrare di aver votato per questi soggetti. Dobbiamo cacciarli da Napoli! Valente, Renzi e questa cupola di affaristi devono essere sconfitti". Il post del candidato consigliere comunale ha ricevuto migliaia di condivisioni, scatenando la reazione indignata del web. Indignata sia nei confronti del presunto broglio (fotografare il proprio voto in cabina elettorale è vietato dalla legge, per evitare il voto di scambio alle elezioni), sia dello stesso "accusatore". "Rosario Maresca invece di pubblicare vai a denunciare!", scrive qualcuno. Altri assicurano trattarsi di una bufala che "è già stata denunciata". Ma la gran parte degli utenti della rete sembra convinto della "bontà" della foto. Di certo il Pd e la candidata Valeria Valente non sono nuovi ad accuse di sospetti brogli alle elezioni, soprattutto quando spuntò un video durante le primarie in cui una persona invitava gli elettori a votare "Valente così ti pagò un obolo da 1 euro". Il candidato Rosario Maresca, intanto, continua per la sua strada. E la foto continua a fare il giro del web. Così come il Pd afferma che la foto si tratterebbe di un fake "che è stato già denunciato".
Brogli elezioni comunali 2017. Segnalazioni, complotti, rumors sulle amministrative: foto nei seggi elettorali. Come a ogni elezione c'è chi denuncia brogli elettorali, accusando questo e quello. Per ora si segnala il caso delle schede pre-votate e un errore tecnico del comune di Palermo, scrive l11 giugno 2017 Roberto Barelli su "Il Sussidiario". Ancora segnalazione riguardo ai possibili brogli elettorali nelle Amministrative 2017. In provincia di Napoli sono diverse le segnalazioni giunte riguardo a misteriosi illeciti, tutte estremamente preoccupanti. Alle 9 di questa mattina, infatti, nel seggio di Baia sono intervenuti i Carabinieri a causa di un uomo sorpreso a fotografare la scheda elettorale. Ad attirare l'attenzione dei presenti è stato il rumore dello scatto del cellulare. In base a quanto riporta Napoli.zon, l'uomo sopracitato è stato denunciato ed il suo voto annullato all'istante. Situazione identica anche ad Acerra, dove una donna è stata pizzicata con una foto sospetta sul suo cellulare. La Digos è intervenuta su richiesta dei rappresentati di lista e si è scoperto che la donna aveva fotografare la scheda appena votata. Sui brogli veri interviene la magistratura e - come dimostra il caso clamoroso delle 321 schede contenenti un facsimile con indicazioni di voto trovate nell'abitazione di una persona in provincia di Napoli - anche "in tempo reale" con arresti e nel modo più duro possibile per garantire un regolare svolgimento delle elezioni. Tuttavia su internet fioriscono, come ogni volta, le accuse di brogli elettorali. A Palermo un errore tecnico da parte del Comune un po' simile a quanto successo in parlamento l'altro giorno quando si è votato sulla legge elettorale, ha reso visibile a tutti una simulazione di voto sul sito del comune. Niente di grave, nessun broglio, ma naturalmente si sono scatenati i complottisti. Ovviamente perché al primo posto dei più votati c'era il sindaco uscente Orlando con il 40% dei voti. A seguire Ferrandelli del centrodestra con il 33% e poi il candidato cinque stelle Fiorello con il 15%. Tutto questo è successo ancora prima dell'inizio del voto e per gli avversari di Orlando si tratta un tentativo di alterare le intenzioni di voto degli elettori. Per i cinque stelle in particolare, ma anche la signora Vardera candidata sindaco si tratta di "un'inaccettabile violazione" mentre Ferrandelli parla di vicenda grottesca. Ci sono volute alcune ore perché il comune rispondesse a quanto era successo: "Con riferimento ad una pagina pubblicata oggi da alcuni siti internet e che riportava alcuni dati di simulazione del sistema si precisa che la stessa era meramente un link di test e non una pagina pubblica (come si evince anche dai link sopra riportati) e che sono in corso accertamenti sull'identità del dipendente che l'ha diffusa all'esterno ingenerando confusione. E' pertanto destituito di qualsiasi fondamento che la pagina riportasse un "sondaggio" come per altro facilmente deducibile dalla scritta riportata nella stessa". Sempre a Palermo nella scuola Rosolino Pilo alcuni presidenti di seggio non hanno trovato il registro cellulari, registro per gli infermi e quello per il voto di militari e naviganti". Scorrendo twitter si dà per scontato che queste elezioni come tante altre siano pregiudicate dai brogli: torna infatti la famosa minaccia della matita cancellabile e si consiglia come al referendum di "leccare le matite prima di votare, altissimo rischio brogli". E chissà perché, si chiamano in causa le ultime elezioni: "In Italia il sistema elettorale va cambiato non assicura trasparenze, le ultime elezioni pene di brogli elettorali". Quelli che spaventano di più sono sempre i voti degli italiani all'estero: "Mi auguro che il M5S chieda di togliere il voto estero, basta brogli e compravendite con fece Matteo Renzi col referendum". Peccato che Renzi quel referendum lo ha perso. E anche se non è un broglio vero e proprio, il candidato della lista di Forza Italia a Buccinasco, ha postato sulla sua pagina facebook la sua scheda dopo il voto, fatto che è vietato per legge.
Brogli e schede rubate nelle elezioni degli italiani all’estero? Un testimone anonimo racconta a Le Iene il metodo con cui l’onorevole Mario Caruso avrebbe truccato le elezioni degli italiani all’estero, scrive Domenico Camodeca su "it.blastingnews.com" il 30 ottobre 2017. Un testimone anonimo racconta a Le Iene i presunti brogli di Mario Caruso nelle elezioni degli italiani all'estero. Il voto degli italiani all’estero sarebbe turbato da pesanti brogli? “Io sono una persona che in occasione delle elezioni politiche del 2013 ho aiutato un candidato che si era presentato all’estero qui in Germania a farsi eleggere al parlamento. Io per l’onorevole #Mario Caruso ho rubato e ho comprato plichi per le votazioni del 2013”. Così si presenta, col volto travisato e la voce modificata, la persona che, di fronte all’inviato de #Le Iene, Filippo Roma, sostiene di aver comprato e rubato plichi elettorali per conto dell’onorevole Mario Caruso. L’onorevole eletto in Germania è già balzato agli onori delle cronache nei giorni scorsi per lo scandalo cosiddetto parentopoli in parlamento, dal quale era emerso che alcuni assistenti parlamentari verrebbero pagati in nero, oppure nemmeno pagati, mentre lui avrebbe assunto il figlio dell’amico sottosegretario Domenico Rossi per, parole sue, “fare una cortesia al papà”, senza che il giovane Fabrizio si presenti mai al suo posto di lavoro.
Come funziona il voto degli italiani all’estero? Filippo Roma de Le Iene spiega il funzionamento del voto degli italiani all’estero, i quali dovrebbero ricevere a casa un plico contenente la scheda elettorale, da compilare, firmare e rimandare al consolato italiano competente che poi si occuperà di inviare le schede votate in Italia, nel centro della Protezione Civile di Castelnuovo di Porto, vicino Roma. Peccato che, in innumerevoli casi, come verificato dalle stesse Iene che si sono recate in Germania, gli elettori di cittadinanza italiana non ricevano proprio nulla a casa perché, questa la rivelazione della gola profonda, i plichi elettorali verrebbero rubati e sottratti illegalmente. Molto diffusa anche la pratica di pagare una cifra compresa tra i 5 e i 10 euro per farsi consegnare direttamente dall’elettore il plico eventualmente ricevuto.
Il racconto che, se confermato, inchioda Mario Caruso. Il racconto del super testimone de Le Iene è dettagliato, fatto da qualcuno che sembra conoscere bene il meccanismo truffaldino. “Io ero un cacciatore di plichi. Quello che voleva l’onorevole erano tre cose: raccogliere plichi, trovare plichi, comprare plichi e se c’era il bisogno rubarli. Io andavo in giro dai miei amici che hanno i bar e altre attività a Colonia”, loro contattavano altri membri della comunità italiana e poi “io andavo a raccoglierli”. Qualcuno lo faceva “sotto forma di piacere, altri invece hanno voluto i soldi” che mi venivano dati “da un assistente dell’onorevole Mario Caruso che si trova qui a Colonia”. La ‘gola profonda’ racconta anche di aver conosciuto un postino italiano e di averlo convinto a consegnare a lui i plichi invece di imbucarli nelle cassette della posta dei nostri connazionali, in cambio di un “regalo di 4-500 euro”. Soldi mai arrivati nelle sue tasche, così come i 5.000 euro promessi da Caruso al ‘cacciatore di plichi’, motivo che avrebbe spinto quest’ultimo a vendicarsi contattando Le Iene.
Altri particolari sui presunti brogli. Il sistema non viene scoperto perché nella maggior parte dei casi, prosegue il racconto, chi non riceve il plico con la scheda elettorale non si preoccupa di richiederlo al consolato perché chi lavora e vive all’estero, sostiene la fonte, “se ne frega”. Chi invece ne ha richiesta una copia ha potuto tranquillamente votare perché, come dimostra Roma, lo spoglio delle schede nella sede di Castelnuovo di Porto non rispetta i termini di legge che impongono di verificare la corrispondenza tra la scheda inviata e un codice numerico (unico per ogni elettore). “Chi se ne frega, basta che se portamo a casa ‘sti 100 euro”, rispondono degli improvvisati scrutatori alle Iene. Inoltre, la fonte anonima racconta di aver messo insieme tre enormi sacchi neri dell’immondizia pieni di plichi (circa 6-7mila) che avrebbe consegnato personalmente a Mario Caruso il quale “aveva una squadra che aveva il compito di aprire le buste, votarlo, firmarlo, chiudere le buste e rispedirlo al consolato”.
LA CONFESSIONE ALLE IENE: «COSÌ HO FATTO BROGLI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2013», scrive Giornalettismo il 30 ottobre 2017. Un cacciatore di plichi confessa in che modo ha organizzato brogli in occasione delle ultime elezioni politiche italiane. «Ho aiutato un candidato che si era candidato all’estero qui in Germania a farsi eleggere al Parlamento». «Io per l’onorevole Mario Caruso ho comprato e rubato plichi per le votazioni del 2013». La testimonianza, anonima, è stata raccolta dall’inviato de Le Iene Filippo Roma, che poche settimane fa si era occupato di un’altra vicenda riguardante lo stesso deputato, la denuncia di un assistente non retribuita. «Io – è il racconto alle Iene dell’intervistato, un italiano che vive a Colonia – ero un cacciatore di plichi». «I plichi sono le lettere che arrivano dal consolato a casa degli italiani in Germania. Dentro c’è una scheda elettorale, bisogna riempirlo, votare la persona favorita, firmarlo, richiudere la busta e rimandarlo al consolato. Il consolato poi li manda in Italia». «Quello che voleva l’onorevole – continua la testimonianza del ‘cacciatore’ – erano tre cose: raccogliere plichi, trovare plichi, comprare plichi e se c’era bisogno rubarli». Un lavoro continuo da svolgere per più giorni. «Io andavo in giro dai miei amici che hanno i bar, che hanno varie attività italiane qui a Colonia e dicevo che bisogna aiutare un nostro amico che sta candidato e servivano i plichi per le sue votazioni». Il proprietario del bar quindi «domandava ai suoi clienti e ai suoi amici» e gli portavano la bar i plichi ogni giorno e «io andavo in giro a raccoglierli». E chi consegnava i plichi in cambio cosa otteneva? «Qualcuno – ha raccontato la fonte anonima – lo ha fatto sotto forma di piacere. Altri hanno voluto i soldi». Chiedevano «la maggior parte 5 euro, qualcuno 10 euro, ma io glieli ho dati lo stesso». I soldi per comprare i plichi, stando a quanto riferito dal ‘cacciatore’, sarebbero arrivati da un assistente dell’onorevole Mario Caruso a Colonia. «Prendevo questi plichi. Li portavo all’assistente di Caruso e quelli là con la X dovevano essere pagati. Lui faceva i conti e mi dava i soldi che il giorno dopo, quando andavo a ritirare i nuovi plichi, pagavo quelli del giorno prima». Ma i plichi venivano anche raccolti in altri modi. «Una volta ho conosciuto un postino italiano. E a lui ho fatto la proposta, se invece di imbucare i plichi nelle buche italiane, me li dava a me». «In cambio per lui c’era un regalo sui 400/500 euro venivano dati da questo onorevole. Lui mi è riuscito a procurare 100 plichi». Soldi tra l’altro mai consegnati dall’onorevole. «Non ne ho presi nemmeno io, non ha dato soldi a nessuno». Secondo la testimonianza i plichi furono chiusi in un patronato di un assistente di Caruso. Sarebbero poi stati caricati nella macchina del ‘cacciatore’ in tre buste grandissime dell’immondizia. Erano «pienissime, c’erano sui 6… 7mila plichi». «Aveva una squadra che aveva il compito di aprire le buste, votarlo, firmarlo, chiudere le buste e rispedirle al consolato». Si tratta di procedure di cui, alle telecamere delle Iene, parla anche Rosario Cambiano, un candidato nella circoscrizione Estero alle Elezioni Politiche del 2006. Anche lui vive a Colonia. «Volete sapere come sono stati eletti i candidati all’estero? Si sono comprati i voti. Ma ci sono le persone che li vendono», è il suo racconto. Il furto delle schede avverrebbe durante il trasporto dalla tipografia alle poste. «Arriva solo una parte». Quelle che non arrivano «se le prendono per favorire il candidato di turno. Qualche cassetta scompare, ci sono mille schede per ogni cartone». «Noi siamo una comunità e ci conosciamo, certe notizia arrivano pure qua. Ci sono tanti modi per rubare schede, anche nelle cassette della posta, e non solo a Colonia, in tutta Europa». Caruso «non è il solo, conoscendo l’ambiente, tutti sono stati eletti con i brogli». L’onorevole, raggiunto in Germania da Filippo Roma, sulla vicenda non ha proferito parola.
Le Iene: «così vengono truccate le votazioni degli italiani all’estero». Le incredibili rivelazioni di un cacciatore di plichi, scrive il 30 Ottobre 2017 "Prima da noi". Un “cacciatore di plichi”, italiano ma residente in Germania, ha confessato a Filippo Roma (Le Iene) come ha fatto i brogli alle ultime elezioni e consentito ad uno dei candidati della circoscrizione Estero di entrare in Parlamento. L’uomo, a volto coperto, ha detto di aver «rubato e comprato plichi per le votazioni del 2013 per l’onorevole Mario Caruso», candidato alla Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero A (Europa), nella lista centrista Con Monti per l'Italia (in quota FLI). Proprio quell’anno Caruso è risultato il primo degli eletti (con 12.576 preferenze) mentre cinque anni prima non ce l’aveva fatta e aveva ottenuto solo 7.100. «Quella raccolta è una testimonianza shock a cui non vogliamo credere», ha detto Roma, decidendo comunque di mandare in onda le accuse. Ma cosa sono i plichi? Sono le lettere che arrivano dal consolato a casa degli Italiani all’estero, e nel caso specifico in Germania. Dentro c’è una scheda elettorale, l’elettore deve riempirla, votare la persona favorita, firmarla, richiudere la busta e mandarla al consolato. Il consolato poi li manda in Italia per il conteggio. Ma il cacciatore di plichi sarebbe riuscito ad ‘intercettare’ circa 7 mila schede pulite, grazie anche alla complicità di alcuni baristi che chiedevano ai clienti le schede, in cambio di regalini da 5 e 10 euro. Fondamentale anche l’aiuto di un postino che in cambio avrebbe dovuto essere ricompensato in denaro. La finalità, come ha raccontato l’uomo, era sempre la stessa: donare le schede al politico che gli aveva chiesto un aiuto. La gola profonda delle Iene ha raccontato che per il servizio reso lui avrebbe dovuto intascare 5 mila euro che però non sarebbero mai arrivati a destinazione. Filippo Roma ha intervistato anche decine e decine di italiani a Colonia e tutti hanno confermato di non aver mai ricevuto la scheda elettorale alle ultime elezioni. Qualcuno ha protestato con il Consolato, ad altri non è importato più di tanto perché «la politica italiana non mi interessa». Un altro candidato ha sostenuto che questo sia un metodo collaudato e Caruso non sarebbe il solo. A chi ne ha fatto richiesta il Consolato ha inviato un duplicato della scheda che, così come l’originale, aveva un numero identificativo associato al nome dell’elettore. Prima della conta dei voti alcuni controllori dovrebbero verificare proprio l’unicità di quella matricola e l’assenza di un’altra scheda con lo stesso numero identificativo proprio per escludere schede doppie o falsi. Ma tramite una telecamera nascosta le Iene hanno mostrato come questo passaggio venga in realtà saltato perché troppo lungo e dispendioso. Caruso, già finito nel mirino delle Iene per il caso dell’assistente parlamentare non pagata (mentre era pagato il figlio del collega sottosegretario, mai visto nell’ufficio), è stato raggiunto in Germania ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. «Che il voto all'estero sia sempre soggetto a brogli lo sappiamo già tutti e questo è il motivo per il quale non lo cambieranno mai», ha commentato su Facebook il deputato abruzzese del Movimento 5 Stelle, Andrea Colletti. Ma dopo aver visto il video e il metodo spiegato «capite perché in Italia nel 2013 prendemmo oltre il 25% e nella circoscrizione estero meno del 10%!» Da anni si parla di pericolosi brogli per le votazioni degli italiani all’estero. Nel 2008 vennero ritrovati a Buenos Aires, nei magazzini di una ditta responsabile di distribuzione, 120mila schede in più rispetto a quelle necessarie per il voto dei nostri connazionali argentini. Nel 2014 Il Fatto Quotidiano raccolse la denuncia del presidente dei Bellunesi nel mondo che raccontò di una vera e propria compravendita di schede per 50 euro l’una. Pure in occasione dell’ultimo Referendum Matteo Salvini lanciò l’allarme: «penso che nei consolati e nelle ambasciate ne siano successe di cotte e di crude ma conto sul fatto che il voto degli italiani, di milanesi torinesi o napoletani, superi gli eventuali Sì inventati e comprati da Renzi in giro per il mondo». Il ministro Angelino Alfano ha invece sempre negato il rischio di eventuali brogli «gli italiani all’estero hanno sempre votato con regolarità e nessuno ha messo mai in discussione tutto quello che è venuto come risultato dal voto estero».
"Il Sud America le schede si comprano per 50 dollari", scrive Ferruccio Sansa, Il Fatto Quotidiano il 13 novembre 2016. Cinquanta dollari per ogni scheda elettorale. Passavano delle persone, strada per strada, e chiedevano di comprare le schede degli italiani all’estero”. Oscar De Bona, presidente dei bellunesi nel mondo ed ex assessore ai flussi migratori della Regione Veneto, racconta quello che gli hanno riferito tanti suoi associati: la compravendita di schede elettorali. Riferisce De Bona: “Succede in Brasile, dove soltanto i veneti sono decine di migliaia e a volte rappresentano la maggioranza della popolazione di intere cittadine. Ma abbiamo avuto segnalazioni anche dall’Argentina. E perfino dalla Svizzera, pur se in Europa il fenomeno è meno rilevante perché c’è più controllo”. In Veneto se ne parla da anni. Ogni volta che si vota arrivano segnalazioni da parenti e amici emigrati lontano. Denunciano procedure approssimative, pasticci, quando non veri e propri tentativi di brogli. Ma stavolta qualcuno ha presentato un ricorso. A firmarlo Pier Michele Cellini, italiano iscritto all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), e Antonio Guadagnini, consigliere regionale di SiamoVeneto (indipendentista). L’atto di citazione tiene conto proprio dei racconti e delle denunce di tanti veneti nel mondo: “Abbiamo raccolto molte testimonianze di gente che ci ha riferito irregolarità. Ormai è chiaro: il sistema di voto degli italiani all’estero così com’è congegnato non va bene. È un colabrodo, non fornisce le minime garanzie contro brogli ed errori. L’articolo 48 della Costituzione dice che il voto deve essere personale, uguale, libero e segreto”, sostiene Guadagnini, “ma per i residenti all’estero nessuna di queste caratteristiche viene garantita”. Spiegazione: “Non è ‘personale’, in quanto non c’è alcun controllo durante l’esercizio del voto, e di conseguenza una persona può votare al posto di un’altra. Non è uguale poiché votare all’interno di un seggio non è la stessa cosa che votare in un luogo scelto a piacere dopo aver ricevuto la scheda per posta. Non è ‘libero’, in quanto la garanzia della libertà di voto si concretizza nell’assicurazione di poter esercitare tale diritto senza subire pressioni o minacce, fisiche o psicologiche. Garanzia che il voto per corrispondenza non fornisce”. E infine, concludono gli autori del ricorso, “il voto degli italiani all’estero non è segreto, in quanto solo un seggio può garantire la segretezza del voto”. Secondo il ricorso, la disciplina che regola il voto per posta deve essere dichiarata incostituzionale. Ma se proprio dovesse essere considerata conforme alla Carta, allora la possibilità di votare per corrispondenza dovrebbe essere estesa a tutti i cittadini, “come accade in Germania, dove ogni cittadino può scegliere il voto per corrispondenza”. Come ricordano Guadagnini e Cellini il voto degli italiani fuori dai confini può essere decisivo, “soprattutto per questo referendum, visto che sarà ammesso anche il voto dei residenti temporanei all’estero, cioè quelli fuoriusciti da almeno tre mesi”. In numeri: gli italiani all’estero con diritto di voto all’ultimo referendum – quello sulle trivellazioni – erano 3.951.448, ma per la consultazione del prossimo 4 dicembre si è già toccata quota 4,1 milioni. La maggior parte in Europa (2,1 milioni) e Sud America (1,3). In pratica parliamo di circa l’8% dell’intero corpo elettorale (circa 51 milioni di aventi diritto al voto). Anche ponendo, come è avvenuto alle ultime consultazioni, che voti solo il 30 per cento di chi ha diritto tra i residenti all’estero, siamo sempre attorno al milione e trecentomila persone. “Ho presentato ricorso – spiega Cellini, veneto che vive in Slovacchia – non perché io sia per il “sì” oppure per il “no”. Ideologia e idee politiche non c’entrano. Già in occasione dell’ultimo referendum non mi hanno convinto per niente le modalità di voto per noi italiani all’estero. Insomma, devi mettere il tuo voto in una scheda e spedirla. Ma non sai chi la aprirà, chi controllerà, chi garantirà la tua manifestazione di volontà. Non sai niente. E falsificare, commettere brogli potrebbe essere facilissimo”, spiega Cellini. Conclude De Bona: “Ci ricordiamo degli italiani all’estero soltanto quando c’è in gioco una posta molto alta come la riforma della Costituzione”. E Guadagnini aggiunge: “Dare voce agli italiani che sono dovuti andare via non significa soltanto dargli in mano una scheda e poi magari farne chissà che cosa. Dobbiamo rispettare davvero la loro volontà di cittadini”.
"E' una legge che va immediatamente cambiata, perché il voto per corrispondenza è uno scandalo". A sostenerlo è il presidente del Senato, Renato Schifani, secondo il quale la legge sul voto degli italiani all'estero "consente tipologie di attività illecite come l'acquisizione del voto addirittura pagandolo: dobbiamo immediatamente procedere a una rivisitazione".
Il prezzo del voto, quello che per la Costituzione dovrebbe essere «personale, uguale, libero e segreto», è una vacanza in Italia. Così pare, stando a una denuncia che arriva dall’Australia e, dopo il caso Di Girolamo del Pdl accusato di aver preso i voti della ‘’ndrangheta, getta nuove ombre sul sistema elettorale che consente dal 2006 agli italiani residenti all’estero di votare per la Camera e il Senato. In un video visto da Avvenire, una parte del quale è apparsa anche su You Tube, i responsabili di alcune associazioni che riuniscono i laziali residenti nello stato di Victoria rivelano di aver partecipato a brogli estesi e ripetuti nel tempo. Affermano di aver raccolto, sia nel 2006 sia nel 2008, pacchi di schede elettorali e di averle consegnate ad emissari di due candidati del Pd nella circoscrizione Africa-Asia-Oceania-Antartide, Marco Fedi, eletto alla Camera, e Nino Randazzo, eletto al Senato. Gli accusati smentiscono, si dichiarano estranei alla vicenda e denunciano per diffamazione gli accusatori. Un processo si aprirà a breve a Roma.
Nel video, i testimoni raccontano, dunque, di voti ceduti in cambio di viaggi in Italia, finanziati dalla Regione Lazio, e di non meglio precisati "favori" ai club che hanno raccolto le schede elettorali; spiegano come abbiano convinto i loro connazionali a consegnare le schede che ciascun elettore iscritto al registro degli italiani residenti all’estero avrebbe dovuto compilare «personalmente e segretamente», prima di rispedirle in busta chiusa; citano luoghi e momenti in cui sarebbe avvenuta la consegna; descrivono dove e come la «catena di montaggio» le avrebbe compilate... Il sistema descritto è esteso quanto il bush australiano e l’impressione che si ricava è che ad alimentarlo c’è uno strano mix: la nostalgia per la madrepatria e la superficialità con cui viene gestito il voto dei nostri emigranti. «Mi dicevano – ricorda Salvatore Marrocco, consigliere dell’associazione Laziali nel Mondo –: raccogli tra amici e compari le buste del Consolato, loro non sanno quello che fanno...».
Un altro consigliere, Paolo Sepe, racconta di aver recuperato tra i connazionali una trentina di buste con le schede e di averle consegnate, «chiuse come le aveva inviate il Consolato».
In un’altra occasione, aggiunge, «siamo stati convocati in una sala di Brunswick», dove si si consegnavano le buste e si veniva registrati ma, spiega, «nessuno di noi ha votato. Votavano quelli che stavano seduti al tavolo». Insomma, seggi clandestini nel cuore di associazioni legate a Consolati e a governo australiano: «Noi siamo andati a votare al Coasit di Melbourne, in Faraday Street – dice Paolo Grosso, stessa associazione –. Ho presentato il passaporto e uno mi ha detto metti una firma qua, su un registro, e poi mi ha detto che potevo andarmene. La scheda elettorale non l’ho vista proprio. Al Coasit c’era una fila... uno dietro l’altro, passavano, firmavano, andavano via». Anche Salvatore Marrocco è stato lì: «E non riuscivamo a parcheggiare, perché c’era troppa gente».
La raccolta delle schede, secondo questi testimoni, avveniva alla luce del sole: «Al ristorante La Porchetta di Carlton, quando ci hanno chiesto le buste, c’era il comitato intero dell’associazione, se ne è parlato davanti a tutti quanti, c’erano Vince Pitoggi, Sal Marrocco, Paolo Sepe...», ricorda Attilio Riccardi, presidente dell’Associazione Laziali nel Mondo del Victoria, che parla di «mille voti mandati a Sydney in aereo».
Uno dei "premi" per chi collaborava, sempre secondo queste accuse, sarebbe stata la partecipazione ai viaggi organizzati per i nostri emigranti dalla Regione Lazio. Per questo, il bersaglio delle accuse, oltre a Fedi e Randazzo, è Antonio Bentincontri, il consultore che gestisce i rapporti tra la Regione e le associazioni australiane da 18 anni. Bisogna dire che contro di loro, per il momento, ci sono solo queste testimonianze e l’avvocato Gian Michele Gentile di Roma, legale di Fedi e Randazzo, ricorda che la Procura di Roma ha già chiesto un rinvio a giudizio per diffamazione. Tuttavia, gli accusatori, guidati da Maurizio Maietti, un ex poliziotto dello Stato di Victoria, non demordono: minacciano di produrre «centinaia» di testimonianze oculari, invocano perizie calligrafiche, divulgano su Internet verbali al vetriolo, accusano lo Stato di foraggiare associazioni inesistenti...
Nel kangoroo-gate, se confermato, non finirebbe insomma solo il sistema di voto degli italiani all’estero ma anche la gestione dei fondi pubblici che alimentano le associazioni degli emigranti: oltre ai finanziamenti della Regione Lazio, ci sono i fondi del governo australiano che transitano attraverso il Coasit e le attività commerciali che ruotano intorno al sentimento nazionale. Un piatto ricco, che fa gola. La polizia dello Stato di Victoria starebbe già indagando. «I brogli non sono una novità nella nostra circoscrizione», dice Teresa Restifa, candidata dal Pdl, sconfitta per duemila voti. Due anni fa aveva chiesto di riesaminare lo scrutinio della circoscrizione: «Abbiamo verificato – ci dice – che 2.000 schede erano partite da Sydney ed erano arrivate a Roma, ma non erano state scrutinate. Parallelamente, ne sono sparite 1.500 partite dal Sudafrica». Il riconteggio, a quanto risulta, non è mai avvenuto.
Mariza Bafile, origini aquilane, ma nata a Caracas, nel 2006 è stata eletta nella Circoscrizione America Meridionale per l’Ulivo. Nel 2008 non ce l’ha fatta, ma quando è tornata in Italia ha denunciato anomalie sul voto degli italiani all’estero.
Ma lei ha denunciato irregolarità. Ce ne vuole parlare?
«Nella mia circoscrizione ci sono Paesi dove il servizio postale non funziona affatto. A volte capita che i plichi elettorali non vengono consegnati e altre volte capita quello che è successo a due miei elettori in Cile: non avevano ricevuto le loro buste per il voto e quando sono andati in consolato gli hanno detto che risultavano tra coloro che avevano votato».
Ma lei ha denunciato le irregolarità?
«L’ho fatto in ogni sede, ai consolati interessati, in Cile, in Venezuela e in Italia. Tra l’altro spesso i consolati affidano a ditte private i plichi elettorali e in un caso ho scoperto che una di queste li tratteneva per oltre 24 ore. Il mio sospetto è che i voti siano andati in una direzione anziché in un’altra all’insaputa degli elettori».
AI MIEI TEMPI...AI MIEI TEMPI...
1. “La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, se ne infischia dell’autorità e non ha nessun rispetto per gli anziani. I ragazzi d’oggi sono tiranni. Non si alzano in piedi quando un anziano entra in un ambiente, rispondono male ai loro genitori...”
2. “Non ho più speranza alcuna per l’avvenire del nostro Paese, se la gioventù d’oggi prenderà domani il comando, perché è una gioventù senza ritegno e pericolosa”.
3. “Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico. I ragazzi non ascoltano più i loro genitori. La fine del mondo non può essere lontana”.
4. “Questa gioventù è guasta fino in fondo al cuore. Non sarà mai come quella di una volta. Quella di oggi non sarà capace di conservare la nostra cultura...”
5. “Oggi i ragazzi amano troppo i propri comodi. Mancano di educazione, disprezzano l'autorità, i figli sono diventati tiranni anziché essere servizievoli. Contraddicono i genitori, schiamazzano, si comportano da maleducati con i loro maestri. Oggi il padre teme i figli. I figli si credono uguali al padre e non hanno né rispetto né stima per i genitori. Ciò che essi vogliono è essere liberi. Il professore ha paura degli allievi, gli allievi insultano i professori; i giovani esigono immediatamente il posto degli anziani; gli anziani, per non apparire retrogradi o dispotici, acconsentono a tale cedimento e, a corona di tutto, in nome della libertà e dell'uguaglianza, si reclama la libertà dei sessi”.
6. «In questi ultimi tempi, il mondo si è degenerato al di là di ogni immaginazione. La corruzione e la confusione sono diventate cose comuni. I figli non obbediscono più ai genitori e ormai non può che essere imminente la fine del mondo».
Di chi sono queste frasi? Di qualche scrittore contemporaneo? Di genitori o professori amareggiati d'oggi? No! Sentite!
La prima citazione è di Socrate, filosofo greco, che visse dal 469 al 399 prima di Cristo.
La seconda citazione è del poeta greco Esidio, vissuto 720 anni prima di Cristo.
La terza citazione è di un sacerdote egiziano che viveva 2000 anni prima di Cristo.
La quarta è stata scoperta recentemente in una cava di argilla tra le rovine di Babilonia, ed avrebbe più di 3000 anni.
Quanto alla quinta, è tolta dal libro VIII de "La Repubblica" di Platone, vissuto dal 428 al 347 prima di Cristo.
La sesta è una tavoletta assira del 2.800.
Conclusione? Tutto quello che si dice o si scrive, è già stato detto o scritto.
COS’E’ LA POLITICA OGGI?
Cos’è la politica oggi?
Un bambino va dal padre e dice: Papà cos' è la politica? Il padre ci pensa e poi dice: Guarda te lo spiego con un esempio:
io che lavoro e porto a casa i soldi sono il CAPITALISTA;
tua madre che li amministra è il GOVERNO;
la nostra cameriera è la CLASSE OPERAIA;
il nonno che controlla che tutto sia in regola è il PARTITO COMUNISTA ed il SINDACATO;
noi tutti ci preoccupiamo che tu stia bene e tu, ormai, che hai qualche voce in capitolo sei il POPOLO;
tua sorella che è appena nata e porta ancora i pannolini è il FUTURO.
Hai capito figlio mio?
Il piccolo ci pensa e dice al padre che vuole dormirci su e riflettere una notte.
Il bambino va a dormire, ma alle due di notte viene svegliato dalla sorella che comincia a piangere perché ha sporcato il pannolino.
Il bambino va a cercare qualcuno.
Visto che non sa cosa fare, va nella camera dei suoi genitori.
Lì c’è solo sua madre che dorme profondamente e chiamata dal bambino non si sveglia.
Così va nella camera della cameriera, ma la trova a letto col padre,
mentre il nonno sbircia dalla finestra.
Tutti sono così occupati che non si accorgono del bambino che chiede aiuto.
Perciò il bimbo ritorna a dormire.
Il mattino dopo il padre chiede al figlio se ha capito cosa sia la politica.
Sì, risponde il figlio.
Il CAPITALISMO approfitta della CLASSE OPERAIA;
Il SINDACATO sta a guardare;
Intanto il GOVERNO dorme;
Il POPOLO che chiede aiuto regolarmente non lo ascolta nessuno e viene completamente ignorato;
Il FUTURO è e resterà nella merda.
QUESTA E’ LA POLITICA!!!
Le pecore hanno paura dei lupi, ma è il loro pastore che le porta al macello.
LA LUNGA STORIA DEI POPULISMI.
Che cos'è il populismo e come si riconosce. Sette caratteristiche che identificano e spiegano parole, atteggiamenti e scelte di individui e movimenti del collage genericamente definito populista, scrive Luigi Gavazzi l'1 marzo 2017 su Panorama.
1- Il popolo. I populisti dicono di parlare "in nome del popolo"; la loro legittimazione, sostengono, deriva direttamente dal popolo; in genere, attraverso le elezioni. Solo che questa legittimazione che arriva dal popolo, giustificherebbe, secondo il credo populista, la delegittimazione delle altre fonti di autorità politica previste dalle costituzioni liberali: il Parlamento, le Corti (fino a quelle costituzionali o supreme), il capo dello Stato, i governi locali, a seconda dell'ordinamento del Paese. In sostanza, il populista non accetta il sistema di pesi e contrappesi tipico delle strutture statuali liberali. Una volta ottenuto l'assenso del popolo in un'elezione, per il resto del mandato, niente deve poter fermare/controllare il governo del popolo.
2- Gli esclusi dal popolo. I populisti quando parlano del "popolo" dal quale deriverebbe la loro legittimazione, identificano come tale solo una parte del popolo reale. A seconda di dove si trovano e dell'opportunità politico-elettorale della quale vorrebbero approfittare, la loro concezione parziale del popolo esclude tutti o alcuni dei gruppi "esterni": gli immigrati, le persone di etnia o di religione diversa, di "razza" non bianca, gli intellettuali, i giornalisti, gli altri politici, le élite (con le più varie attribuzioni), uomini e donne con orientamenti sessuali non etero. Tale concezione del "popolo", è molto simile a quella del Volk dei nazisti e giustifica il concetto di "nemico del popolo", usato indifferentemente dai fascismi storici, dal comunismo, da Putin e, recentemente, da Trump nei confronti dei giornalisti, dei democratici, degli intellettuali.
3- Gli immigrati. Ma i populisti, in questa fase storica, odiano e suscitano odio e paura nei confronti soprattutto degli immigrati, in particolare - in Europa e con Trump anche negli Usa - di quelli di religione musulmana (ma non solo): sono loro la categoria preferita per essere esclusa dal "popolo". E sulla cui richiesta di "esclusione" - con tutte le conseguenze (cittadinanza, welfare, persino istruzione e sanità) - giocano le carte elettorali.
4- Contro il pluralismo. I movimenti populisti non sopportano il pluralismo, la struttura pluralista della democrazia liberale con i contrappesi all'esecutivo; siano istituzionali - come l'ordine giudiziario, il Parlamento (cfr. 1), siano sociali: i media liberi e critici, le organizzazioni della società civile, i partiti, gli intellettuali indipendenti.
5 - Uniformità culturale e religiosa. L'ostilità al pluralismo dei populisti si manifesta anche nella variante "culturale" del populismo: esso ama, pretende, l'uniformità di lingua, religione, comportamenti sessuali, orientamenti sulle libertà individuali: fine vita, aborto, matrimoni.
6 - Contro gli intellettuali. Da 4 e 5 derivano anche l'ossessione anti élite dei populisti. Ossessione che è in realtà una manifestazione dell'ostilità generalizzata contro la cultura, i media, gli intellettuali, gli scrittori, il cinema: persone che hanno due peccati fondamentali agli occhi del populista: disprezzano (a suo dire) la gente del popolo (inteso nel senso esclusivista di 2) e sono dei privilegiati (poco importa per esempio che sia stato o meno il talento a renderli dei privilegiati). Anche il rifiuto degli "esperti", che sconfina in deliri anti-scientifici, per esempio contro i vaccini, è in parte frutto dell'ostilità contro gli intellettuali e la cultura.
7 - Il linguaggio. Il linguaggio dei populisti è sempre aggressivo, scorretto, semplificato, povero, emotivo, banale, violento, oltre la decenza e il rispetto per gli avversari. Più insulta e aggredisce più i sostenitori del tribuno populista si convincono che manterrà davvero le promesse fatte.
Quindi il populista, in un certo senso, è obbligato, anche una volta al potere, a mantenere una campagna elettorale permanente: aiuta a identificare il nemico, a tenere unite le fila dei seguaci e conferma loro che mantiene le promesse. Il concetto di populismo è una famiglia di caratteristiche quasi sempre presenti nei movimenti e negli individui che a esso si richiamano, anche se non tutti i movimenti presentano tutte queste caratteristiche. Prendendo a prestito l'idea di Umberto Eco, che ricordava come il fascismo fosse un "totalitarismo fuzzy", potremmo dire che anche il populismo è un collage di idee e atteggiamenti diversi, spesso anche contraddittori (si pensi alle accuse di autoritarismo che Grillo e Salvini hanno usato contro Renzi nel corso della campagna per il referendum costituzionale, salvo comportarsi, il primo, come un autocrate alla guida del M5S o esprimere - entrambi - l'ammirazione per forme di autoritarismo come quella di Putin in Russia).
Censis, le istituzioni sono in crisi. Cresce il distacco fra politica e società. Le prime non fanno più da cerniera, gli altri due corpi rintanati su se stessi alimentano populismo, scrive "L'Adnkronos" il 02/12/2016. Le istituzioni sono "profondamente in crisi", sono "inermi perché vuote o occupate da altri poteri", e non riescono più "a fare da cerniera fra mondo politico e corpo sociale", mentre è "grande il distacco fra popolo e politica", tanto che i due corpi "si rintanano su se stessi", ognuno "va per proprio conto". Un mix che "alimenta il populismo". E' il Censis a tracciare il perimetro in cui versa la società italiana nelle sue diverse declinazioni nel Rapporto 2016 sulla Situazione Sociale del Paese, diffuso oggi. "Nel parallelo rintanamento chez soi di politica e società cresce il populismo" afferma il Censis che indica la "pericolosa faglia che si va instaurando tra mondo del potere politico e corpo sociale, che vanno ognuno per proprio conto, con reciproci processi di rancorosa delegittimazione". "Il corpo sociale si sente rancorosamente vittima di un sistema di casta" avvertono gli analisti dell'istituto, mentre "il mondo politico si arrocca sulla necessità di un rilancio dell’etica e della moralità pubblica" e le "istituzioni non riescono più a 'fare cerniera' tra dinamica politica e dinamica sociale, di conseguenza vanno verso un progressivo rinserramento". Delle tre componenti di una società moderna, corpo sociale, istituzioni, potere politico, "sono proprio le istituzioni a essere oggi più profondamente in crisi" sottolinea il Censis che passa sotto la lente lo stato dei tre 'gruppi' sociali. La società italiana, rileva, invece "continua a funzionare nel quotidiano, rumina gli input esterni e cicatrizza le sue ferite", scandita da questi "tre processi chiave". Le imprese "continuano a operare" nelle dinamiche di filiera, le famiglie "continuano a coltivare i loro risparmi e i loro patrimoni", il sistema di welfare "continua la sua lucida e spesso dura quadratura" per "non perdere il ruolo cardine di "soddisfare i bisogni sociali". Intanto siamo entrati "in una seconda era del sommerso": non più pre-industriale, ma, rileva il Censis, post-terziario, "non un sommerso del lavoro" ma "un sommerso di redditi" che prolifera nella gestione del risparmio cash, nelle strategie di valorizzazione del patrimonio immobiliare come bed and breakfast o location per event, nel settore dei servizi alla persona, dalle badanti alle babysitter, alle lezioni private, nei servizi di mobilità condivisa e di recapito. È una macchina molecolare, delinea l'istituto, senza un sistemico orientamento di sviluppo, in cui "proliferano figure lavorative labili e provvisorie". Figure, osserva il Censis, che si ritrovano "soprattutto tra i giovani che vivono nella frontiera paludosa tra formazione e lavoro". Il corpo sociale, rimarca l'istituto, finisce così per assicurarsi la sua primordiale funzione, quella di "reggersi" anche senza disporre di strutture portanti politiche o istituzionali. In questo contesto, la politica riafferma orgogliosamente il suo primato progettuale e decisionale. Tutt'e due alimentano il populismo. E in questo scenario, "è tempo per il mondo politico e il corpo sociale di dare con coraggio un nuovo ruolo alle troppo mortificate istituzioni" avverte ed esorta l'istituto di ricerca socio-economica.
Censis, l'Italia bloccata non investe più. Giovani più poveri dei loro nonni. Gli italiani tagliano su tutto ma non sulla comunicazione digitale. Il cinquantesimo Rapporto Annuale parla di un Paese che siede su una montagna di risparmi, 114 miliardi di euro di liquidità aggiuntiva accumulati negli anni della crisi, ma non li spende per paura. E' l'Italia rentier, dove i giovani sono sempre più poveri e intrappolati nel giro infernale dei lavoretti a basso costo e bassa produttività. Si taglia su tutto ma è boom degli acquisti di computer e soprattutto di smartphone, scrive Rosaria Amato il 2 dicembre 2016 su "la Repubblica". Un'Italia involuta, ripiegata su se stessa, "rentier" la definisce il Censis nel Cinquantesimo Rapporto sulla situazione del Paese. Un Paese che più che vivere di rendita però sopravvive, sfruttando fino all'osso le ricchezze del passato, in particolare il patrimonio immmobiliare, finalmente "messo a reddito", ma che non osa più scommettere sul futuro. Dal 2007 a oggi gli italiani hanno accumulato 114 miliardi di euro di liquidità aggiuntiva, un gigantesco patrimonio che equivale al Pil dell'Ungheria e che rimane rigorosamente liquido, pronto a essere usato in una prospettiva futura di tempi ancora più bui, investito davvero in minima parte e sostanzialmente nelle mani degli anziani. Perché nel nostro Paese, ricorda il direttore generale del Censis Massimiliano Valerii, si è dato corso a "un inedito e perverso gioco intertemporale di trasferimento di risorse che ha letteralmente messo k.o. i Millennials". Se l'Italia appare ferma, governata da una classe politica che ha rinunciato da tempo al ruolo di intermediario dei bisogni della società e che, dice il presidente del Censis Giuseppe De Rita, "pensa solo a se stessa, alla possibilità di far primato", gli italiani in realtà si muovono, in una scia di "continuità di cui nessuno si accorge ma che ha una forza incredibile". Per cui non c'è ripresa ma il made in Italy va bene, le esportazioni funzionano, la filiera enogastronomica è apprezzata ovunque, "tre quarti dei macchinari nel mondo sono italiani". La ricchezza ferma. In Italia gli anziani hanno il patrimonio immobiliare e i risparmi di una vita che nei tempi buoni si sono moltiplicati grazie ad investimenti azzeccati, i giovani non hanno pressoché nulla: le famiglie con persone di riferimento che hanno meno di 35 anni hanno un reddito più basso del 15,1% rispetto alla media della popolazione e una ricchezza inferiore del 41,1%. Mentre la ricchezza degli anziani è superiore dell'84,7% rispetto ai livelli del '91. Ma non serve a rimettere in moto il Paese: l'incidenza degli investimenti sul Pil è scesa al 16,6% nel 2015, contro una media europea del 19,5% ma soprattutto il 21,5% della Francia e il 19,9% della Germania e anche il 19,7% della Spagna. La trappola dei "lavoretti". E' l'Italia del post-terziario, del sommerso. Non è più però il sommerso degli anni '70, che nascondeva aree di grande produttività, di sviluppo: questo è un sommerso "post terziario", più statico che evolutivo, "una macchina molecolare" di soggetti che vagano ognuno per proprio conto, senza alcun orientamento. E' il sommerso del danaro messo da parte ma non investito, dei "lavoretti" a bassa produttività che incidono poco o pochissimo sulla crescita del Paese. A fronte di 431.000 lavoratori in più infatti tra il primo trimestre del 2015 e il secondo del 2016 il Pil è aumentato di 3,9 miliardi di euro, lo 0,9% in più. Se la produttività, già bassa, fosse rimasta costante, ragiona il Censis, la nuova occupazione si sarebbe dovuta tradurre in una crescita dell'1,8%. E' la condanna dei Millennials, imprigionati tra "l'area delle professioni non qualificate" e "il mercato dei lavoretti", nel complesso "il limbo del lavoro quasi regolare". La fine del lavoro e del ceto medio. Il problema non è solo dei giovani: in generale diminuiscono le "figure intermedie esecutive" e crescono le professioni non qualificate (più 9,6% tra il 2011 e il 2015) e gli addetti alle vendite e ai servizi personali (più 7,5%). Si riduce anche il numero di operai, artigiani, agricoltori, il lavoro costa meno ma questa riduzione non favorisce la domanda, anche per via della crisi del settore pubblico: la deflazione è figlia anche di questo sistema del massimo ribasso, che ha compresso e impoverito la classe media. Tagliare ancora le spese. La parola d'ordine dunque è spendere il meno possibile, ridurre ancora i consumi, e tenere i soldi a portata di mano: il 51,7% conta di tagliare ulteriormente le spese per la casa e l'alimentazione. In questo rapporto Censis che sembra non offrire neanche un minimo appiglio per guardare al futuro con un po' di fiducia, a differenza delle precedenti edizioni, emergono comunque ancora i dati di un'Italia che continua a produrre e a muoversi, in ordine sparso, senza alcuna coordinazione da parte di una guida politica magari forte, ma sempre più autoreferenziale. Scure anche sulla sanità, su cui pesa anche il ritiro del sistema pubblico: "Gli effetti socialmente regressivi delle manovre di contenimento del governo si traducono in un crescente numero di italiani (11 milioni circa) che nel 2016 hanno dichiarato di aver dovuto rinunciare o rinviare alcune prestazioni sanitarie, specialmente odontoiatriche, specialistiche e diagnostiche". Cosa tira ancora: il turismo e l'export. In primo luogo continuano ad andare benissimo le aziende che si sono ritagliate una fetta di mercato, piccola o grande, con le vendite all'estero. L'Italia resta al decimo posto nella graduatoria mondiale degli esportatori con una quota di mercato del 2,8%. Nel 2015 le aziende esportatrici italiane hanno superato il 5% dell'export mondiale in 28 categorie di attività economiche. Il saldo commerciale del made in Italy è stato di 98,6 miliardi di euro, superiore al fatturato del manifatturiero. La fama che accompagna i nostri prodotti di qualità è quella del "bello e ben fatto". Ed è probabilmente proprio questo a spingere i turisti stranieri di "alta gamma" a venire in Italia: tra il 2008 e il 2015 gli arrivi di visitatori stranieri in Italia sono aumentati del 31,2% e i giorni di permanenza sono aumentati del 18,8%. Gli arrivi negli hotel a 5 stelle sono cresciuti dal 2008 del 50,3% e in quelli a 4 stelle del 38,2%. Il crollo delle categorie inferiori è compensato da un forte aumento delle presenze negli alloggi in affitto, nei bed and breakfast e negli agriturismo. Per cosa si spende: i media digitali. Accanto a queste attività economiche che godono ancora di una forte spinta propulsiva, c'è un unico canale di consumi che sembra convogliare la passione per gli acquisti degli italiani: la comunicazione digitale. Mentre tra il 2007 e il 2015 i consumi in generale si riducevano del 5,7%, gli acquisti di smartphone aumentavano del 191,6% e quelli di computer del 41,4%. "Gli italiani hanno stretto i cordoni della borsa evitando di spendere su tutto - è la spiegazione del Censis - ma non sui media digitali connessi in rete, perché grazie ad essi hanno aumentato il loro potere individuale di disintermediazione". L'utenza del web in Italia nel 2016 è arrivata al 73,7%, mentre il 64,8% usa uno smartphonee il 61,3% Whattsapp (la percentuale dei giovani sale all'89,4%). Sim web superano Sim voce. Per la prima volta, nel 2015 il numero di sim abilitate. In Italia alla navigazione in Rete (50.2 milioni) ha superato quello delle sim utilizzate esclusivamente per i servizi voce (42,3 milioni). E i volumi di traffico dati sono aumentati nel 2015 del 45% rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi degli operatori dei servizi crescevano del 6,2%.
Censis, 11 milioni di italiani obbligati a dire no alle cure sanitarie. Meno ricoveri, visite dal dentista ed esami preventivi a causa dei tagli da parte del governo. Un welfare che penalizza la salute viene fotografato del cinquantesimo rapporto dei sociologi sulla situazione del Paese, scrive il 2 dicembre 2016 "La Repubblica". Gli italiani sempre più spesso costretti a rinunciare alle cure mediche per mancanza di soldi. E' il quadro che emerge dal cinquantesimo "Rapporto Censis" sulla situazione sociale del Paese. Gli effetti socialmente regressivi delle manovre di contenimento del governo si fanno sentire. E, nei fatti, si traducono in un crescente numero di italiani, circa 11 milioni, che nel 2016 hanno dichiarato di aver dovuto rinunciare o (perlomeno) rinviare alcune prestazioni sanitarie, specialmente odontoiatriche, specialistiche e diagnostiche. Riduzione spesa sanitaria. "Il progressivo restringimento del welfare legato agli obiettivi di finanza pubblica appare evidente nella dinamica recente della spesa sanitaria", rilevano i sociologi nella loro fotografia annuale. Così, se mentre dal 2009 al 2015 si registrava solo una lieve riduzione in termini reali della spesa pubblica, nello stesso arco di tempo la spesa sanitaria privata, dopo una fase di crescita significativa, si riduce a partire dal 2012, per riprendere ad aumentare negli ultimi due anni (+2,4% dal 2014 al 2015), fino a raggiungere nel 2015 i 34,8 miliardi di euro, cioè poco meno del 24% della spesa sanitaria totale. Compartecipazione dei privati. Aumenta poi la compartecipazione dei cittadini alla spesa: +32,4% in termini reali dal 2009 al 2015 (con un incremento più consistente della partecipazione alla spesa farmaceutica: 2,9 miliardi, +74,4%). "Infine - si legge nel Rapporto - anche l'offerta ospedaliera mostra una progressiva riduzione dei posti letto (3,3 per 1.000 abitanti in Italia nel 2013 secondo i dati Eurostat, contro i 5,2 in media dei 28 Paesi Ue, gli 8,2 della Germania e i 6,3 della Francia)".
La lunga storia dei populismi, da Tolstoi a Peron, scrive l'11 novembre 2016 “Il Dubbio". I primi movimenti nascono in Russia a fine '800. Da allora questo termine non è mai stato adoperato tanto spesso come negli ultimi anni
Il 24 gennaio del 1878 la rivoluzionaria russa Vera Zasulic sparò al governatore di Pietroburgo, il generale Trepov, che aveva fatto frustare quasi a morte un detenuto reo di non essersi tolto il cappello al suo passaggio. Con una sentenza a sorpresa l'attentatrice fu assolta e fece in tempo a fuggire prima che il governo impugnasse la scandalosa sentenza. Da quel momento gli attentati in Russia si moltiplicarono e il 13 marzo 1881 uccisero con una bomba l'obiettivo più elevato possibile, lo zar Alessandro II. Vera Zasulic faceva parte del gruppo Zemlja i Volja, Terra e libertà. A eliminare Alessandro II fu l'organizzazione che ne discendeva, Narodnaja Volja, Volontà del popolo. Erano entrambe braccia operative del populismo russo, benedette dal suo profeta in esilio Aleksandr Herzen. Non si limitavano a combattere l'autocrazia in nome del popolo, ritenevano che nel mondo contadino russo esistesse uno spirito comunitario intrinsecamente positivo che avrebbe permesso di evitare la fase della rivoluzione borghese. Sul versante non violento, posizioni simili erano espresse da Tolstoj col quale Lenin polemizzò, prendendolo però sul serio come meritava, in alcuni articoli molto serrati. Da allora, il termine "populismo" non è mai stato adoperato tanto spesso come negli ultimi anni. E' improbabile però che si riferiscano a quel populismo i dottori che ogni giorno, dalle colonne di tutti i giornali e dagli studi di tutte le tv, lo citano come il nuovo spettro che si aggira non solo per l'Europa. Se così fosse non si spiegherebbe la piega sdegnosa della bocca, l'espressione a metà tra lo schifato e la sufficienza di chi si sente immensamente superiore. Al populismo di Herzen e Tolstoj nessuno negherebbe uno spessore che mal si concilia con gli sbrigativi anatemi a cui si abbandonano i dotti in ogni circostanza: Brexit, Marine Le Pen, Orban, M5S, Tsipras, Podemos, Hofen... Tutte varianti del medesimo demonio, stupido ma non per questo meno pericoloso: "Il populismo". Il riferimento sarà forse al People's Party, formazione indipendente americana che ebbe il suo momento di gloria tra il 1891 e il 1896, raggiungendo l'8% alle elezioni presidenziali del 1892? Qualche punto di contatto in effetti ci sarebbe. Il programma del partito era ferocemente ostile alle grandi banche, proponeva la nazionalizzazione delle ferrovie e del telegrafo, puntava sulla tassazione progressiva. Ma quella era un'organizzazione di estrema sinistra, poi confluita come ala radicale nel Partito democratico. Se sul banco degli accusati del XXI secolo ci fossero solo Tsipras e Iglesias ancora ancora si potrebbe attribuire al populismo contemporaneo quella improbabile discendenza genealogica, ma come metterla con quella componente dei reprobi che solo a sentir parlare di sinistra mette mano alla pistola? La definizione ossessivamente ripetuta è in realtà tanto vaga e approssimativa da potersi adattare a quasi tutto. Se per populismo s'intende il rapporto diretto e fortemente emozionale del leader carismatico con le masse, sarebbero certamente da considerarsi movimenti populisti il fascismo e il nazismo. I quali tuttavia non presentano punti di contatto con l'originario movimento russo e sono antitetici rispetto alla visione etica che del populismo offriva nel 1969 il suo massimo profeta recente, il sociologo americano Christopher Lasch: «Il populismo è la voce autentica della democrazia. Si basa sul principio che gli individui hanno diritto al rispetto finché non si dimostrano indegni di averne, ma esige che tutti si assumano le loro responsabilità». Nei regimi totalitari, inoltre, il nesso diretto ed emotivo tra il capo e le masse era solo una componente, fondamentale ma non tale da caratterizzarli in maniera eminente. Probabilmente il modello di governo che più merita l'incresciosa nomea è quello di Juan Domingo Peròn, presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955, con la sua continua chiamata alla mobilitazione plebiscitaria del popolo che tuttavia non degenerò in dittatura o regime. Quando l'etichetta viene applicata a leader Berlusconi in Italia è proprio al modello peronista che ci si riferisce. Solo che nessuna di queste esperienze storiche, e neppure quella italiana del partito dell'Uomo qualunque, citata dal sociologo di destra Marco Tarchi come apogeo del populismo de noantri, spiega l'inflazione corrente del termine e la sua trasformazione in parolaccia. Il populismo, per come viene inteso e debitamente demonizzato oggi, è qualcosa di simile a quelle esperienze ma con al suo interno slittamenti profondi. È un messaggio di rivolta contro le élites indirizzato al popolo, demagogico e pericoloso ma non perché infondato. Al contrario, le stesse firme che nei giorni pari suonano l'allarme rosso per la minaccia populista, in quelli dispari dissertano sulle medesime nefandezze delle élites che il "populismo" denuncia. L'elemento demagogico sta nell'illudere il popolo che quei limiti possano essere superati contrapponendosi alle élites invece che affidandosi alla loro capacità di autoriformarsi. Non è che le élites in sé siano buone. È che sono comunque meglio della massa vociante, della plebe ignorante. Sbaglieranno pure, ma almeno sanno quello che fanno. Dunque solo loro possono invertire la marcia senza provocare quei disastri che sarebbero invece garantiti affidando la guida al popolino. Perché classi dirigenti che nel giro di pochi anni hanno inanellato i disastrosi interventi in Iraq e Libia, la legge sull'accorpamento delle banche d'affari e degli istituti di risparmio, la crisi del 2008, la politica del rigore in Europa, il salvataggio delle banche a spese di tutti dovrebbero «sapere quello che fanno» resta oscuro. Cosa permetta di sperare in una loro capacità di cambiare rotta lo è ancora di più. A differenza degli anatemi del passato, come «anarchici» o «fascisti», l'accusa generalizzata di «populismo» maschera una visione del mondo fondata sul censo e una diffidenza radicata e montante nei confronti della democrazia. L'uso smodato del termine «populisti» declinato come sprezzante accusa dice pochissimo sugli oggetti dell'accusa. Però dice tutto su chi sono e cosa realmente pensano quelli che la muovono.
Dai politici ai rapper, trionfa l'irresponsabilità. Cosa accomuna gli imprenditori dei social media, le star della musica e politici come Beppe Grillo, Matteo Salvini, Nigel Farage, Donald Trump? Una manifestazione caratteristica dello spirito del tempo: non avere nessun obbligo morale rispetto alle conseguenze di ciò che dicono e predicano, scrive Massimiliano Panarari il 17 Febbraio 2017 su “L’Espresso". S’avanza, tra squilli di fanfara (e in un tripudio di post, tweet, meme e immagini di ogni genere), una neo-ideologia. Nel senso proprio del concetto, quello di un apparato di opinioni, visioni e rappresentazioni che orientano un certo gruppo sociale. Anzi, svariati gruppi, visto che si tratta di un’ideologia tagliata su misura per un’epoca come la nostra solo in apparenza postideologica; ed è un’ideologia (o, se si vuole, una meta-ideologia) che genera inquietudine. Cosa accomuna, infatti, gli imperatori dei social media (a cominciare da Mark Zuckerberg), Beppe Grillo, Matteo Salvini, Nigel Farage, Julian Assange e Donald Trump? (e chi più ne ha, più ne metta: per esempio, potremmo agevolmente fare rientrare nel gruppo, su un altro piano, anche un bel po’ di star della musica rap e reggaeton). Al netto di varie, palesi, differenze, tutte queste figure della vita pubblica contemporanea appaiono, difatti, come altrettante incarnazioni di una manifestazione molto caratteristica – e preoccupante – dell’attuale Spirito del tempo. Quella compendiabile nello slogan (che vale, a suo modo, come un trattato di scienza sociale di un certo tipo di comportamento collettivo): «Lanciare il sasso, nascondere la mano». Una scienza tutta da riscrivere ai tempi dei Social, Network e dei Big Data. Perché sono cambiati i paradigmi, i filtri, i metodi con cui avviene la persuasione. Tra post verità e terremoti politici. Che si tratti dei capi e degli imprenditori politici di quel fenomeno complesso e molto sfaccettato che etichettiamo, per ragioni di semplicità, come “populismo”, piuttosto che dei creatori dei social network o di cantanti seguitissimi da eserciti di giovanissimi (e non solo), ad accomunarli è l’idea di non avere sostanzialmente alcun obbligo morale rispetto alle conseguenze di quello che dicono e predicano. Sono infatti, a vario titolo, tutti leader dotati di grande potere di persuasione e influenza sulla società, che si presentano come irresponsabili (o non pienamente responsabili). Differente è la scala del “fattore di impatto” di ciascuno di loro (in alcuni casi autenticamente planetario), ma analogo l’esito finale; taluni di loro stanno battendo, da tempo, la strada dei cattivi maestri, altri invece non intervengono come dovrebbero nei processi che hanno innescato e di cui sono gli dei ex machina, non nel senso che non li governano (perché lo fanno, eccome), ma in quello del loro attenersi allo schema – assai diffusosi in epoca postmoderna – per cui vasti settori delle classi dirigenti invocano per sé gli onori senza volersi sobbarcare i corrispondenti oneri. Apprendisti stregoni, incendiari, pifferai magici, o agnostici alfieri dell’indifferentismo che incoraggiano azioni, processi e tendenze di massa rifiutandosi di valutarne le conseguenze e le implicazioni. Poiché pensano all’incasso – economico o elettorale – immediato e pronta cassa (che si tratti, variamente, di trimestrali di borsa piuttosto che di consenso politico). Lo misuriamo in relazione a un clima politico nel quale la ragionevolezza sembra perduta, ed è considerata un sinonimo di mollezza, una “patetica ossessione” per gente “senza attributi”, mentre populisticamente spopolano l’urlo, l’esagitazione, la sparata e, soprattutto, la creazione del nemico (un must della lotta politica, parecchio tornato in voga nell’Italia e nel Villaggio globale odierni). Al punto che i toni del bipolarismo muscolare della stagione berlusconiani vs. antiberlusconiani sembrano ora roba “da educande e scolarette”. Lo vediamo nella circolazione di falsità, panzane e “bufale”, e nella proliferazione di fake veicolati attraverso la propaganda o gli eserciti di trolls che immettono nella discussione pubblica e nello svolgimento del processo elettorale un sacco di elementi non veritieri capaci di incidere in maniera anche significativa sulla scelta di voto di alcuni cittadini. Ovvero, il paesaggio politico e l’orizzonte concettuale riscritti dalla post-verità, termine non a caso rigettato sdegnosamente dai leader e dai teorici dell’ideologia dell’irresponsabilità, tanto avversi (almeno a parole…) al “relativismo dei valori morali” (e favorevoli al ritorno a quelli tradizionali, “veri” e “autentici”), quanto invece alacremente e attivamente impegnati nella promozione del relativismo rispetto all’obiettività delle questioni, dei temi e dei fatti della vita pubblica. E se non piace la formula della post-verità, si può rispolverare il sempre utile e lungimirante Walter Lippmann, il quale, già negli anni Venti del Novecento, scriveva della creazione da parte dei mezzi di comunicazione di massa di uno “pseudo-ambiente” quale dimensione parallela che si prestava perfettamente alla manipolazione dell’opinione pubblica; oppure si può ricorrere agli “pseudoeventi” (oggi diremmo i “fattoidi”) di cui parlava, negli anni Sessanta, lo storico Daniel Boorstin, più sofisticati della propaganda perché orientano la gente mescolando elementi oggettivi (fatti) e altri creati ad arte (artefatti), e volutamente falsificati. E poi lo vediamo nell’archiviazione della militanza di partito, rimpiazzata da una sorta di hooliganismo politico (a cui anche le internettiane camere dell’eco hanno fornito uno stimolo potente). E negli hate speeches che dilagano sui social – insieme a una marea di sciocchezze sottoculturali, affermazioni misogine o razziste ed esaltazioni del bullismo – e nella circolazione di materiale visivo pornografico o sessuale che scappa dai protagonisti e dal loro uso privato per finire travasato nella “corrida” del Web. Qui, giustappunto, arriva la problematica della responsabilità di ciascuno di noi, utenti della Rete, persone che vogliono dire la propria in politica o esprimere passioni per qualcosa; e, a volte, e molto duramente, i singoli pagano. Ma c’è anche – finora un po’ troppo aggirata – la questione dell’assunzione di un’obbligazione etica e di un dovere morale rispetto alle conseguenze del proprio operato da parte di chi ricopre un ruolo pubblico rilevante o è il padrone delle piattaforme internettiane. Un nodo serissimo da sciogliere, altrimenti la facile ideologia dell’irresponsabilità farà ancora più danni di quelli (già tanti, troppi) che sta pericolosamente facendo ora. Tu chiamala, se vuoi, etica della responsabilità e, come insegnava Max Weber, dovrebbe risultare indissolubile dalla politica. Mentre di una certa – malintesa – etica della (pseudo)convinzione, come pure (in misura ancora maggiore) di opportunismo, sono lastricate le strade del far west. Oppure quelle dell’inferno. Che non sono precisamente due luoghi di libertà, così come l’invito al senso di responsabilità, a dispetto di quanto strillano in maniera strumentale gli ideologi dell’irresponsabilità, non è censura, né moralismo. Ma tutt’altro.
Che cos'è la propaganda ai tempi di Facebook. Una “scienza” tutta da riscrivere ai tempi dei social network e dei Big data. Perché sono cambiati i paradigmi, i filtri, i metodi con cui avviene la persuasione. Tra post-verità e terremoti politici, scrive Fabio Chiusi il 2 dicembre 2016 su "L'Espresso”. Fa una certa impressione interpellare i massimi esperti di una disciplina e sentirli vacillare perché un evento ne ha appena riscritto i confini. Accade mentre l’Espresso è in conversazione con Russ Castronovo e Jonathan Auerbach, curatori dell’“Oxford Handbook of Propaganda”, la Bibbia del settore. Perché l’evento è l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti; e la disciplina, lo studio della propaganda. L’obiettivo è vederci più chiaro, capire se la storia e la teoria di quella nozione, nata con Bolla papale nel Seicento per “propagare” la fede cattolica nel “nuovo mondo”, ci possa aiutare a comprendere l’era di Brexit, Trump e dei populismi. «Gli eventi delle ultime due settimane negli Usa», risponde invece Castronovo stroncando le speranze sul nascere, «hanno messo a dura prova ciò che molti di noi pensavano di sapere su propaganda e comunicazione. Credo che dovremo riesaminare a lungo diverse nostre premesse e conclusioni». Il docente dell’Università di Wisconsin-Madison aggiunge poi che «l’elezione di Trump ha cambiato il modo in cui pensavamo circolasse l’informazione, come le persone comunicano, ma anche come processano e diffondono la propaganda». Mentre ragiona su quello che definisce un «drammatico campanello d’allarme per molti studiosi di comunicazione politica e retorica», l’intero mondo dei media è invece impegnato a chiedersi se Trump è alla Casa Bianca per colpa di Facebook. Delle notizie false che vi circolano, che diventando “virali” fanno di video, memi e post potenti mezzi di propaganda politica. Potenti al punto di portarci nella “post-verità”. In un’era del rapporto tra potere e informazione, cioè, «in cui i fatti oggettivi contribuiscono meno alla formazione dell’opinione pubblica degli appelli emotivi e le credenze personali». Lo credono diversi analisti e commentatori politici; per l’“Oxford Dictionary” post-verità è addirittura la “parola dell’anno”. Ma per gli studiosi di propaganda sa tutto di già visto. Harold Lasswell scriveva qualcosa di simile già nel 1941, parlando di un mondo in cui «un sospetto generale è diretto contro ogni fonte di informazione»; e in cui i cittadini finiscono per «convincersi che non ha senso cercare il vero negli affari pubblici». Due decenni prima di lui era stato Walter Lippmann, giornalista e poi padre degli studi moderni sulla propaganda, a coniare la definizione che avrebbe ripreso con così tanta fortuna Noam Chomsky: «fabbricare il consenso”. L’idea è perfettamente attuale oggi, nell’era del “sovraccarico informativo” e dell’economia dell’attenzione: nel mondo ci sono troppe informazioni, dice Lippmann in “Public Opinion”, e l’uomo vi fa fronte, per natura, coi pregiudizi. Finché non giungono i media a dare loro forma, secondo i loro interessi. Sono i media, insomma, a colmare la distanza necessaria tra evento e pubblico che rende possibile la propaganda. Sono loro, diremmo anche oggi, il “filtro”. Cosa è dunque successo con Trump? Secondo il filosofo sloveno Slavoj Žižek, la “fabbrica del consenso” si è, molto semplicemente, spezzata. In un ecosistema informativo in cui i media perdono autorevolezza, e chiunque diventa il proprio media grazie a Facebook, Twitter o YouTube, la distanza tra evento e pubblico si azzera. Il “filtro” non serve più: ciascuno ha il proprio, sotto forma di un algoritmo di selezione delle notizie di un social network o presentazione dei risultati di ricerca. Ma c’è molto altro, suggerisce Žižek: «La democrazia», dice in “How political elites failed”, «non è fatta solo dalle formali regole elettorali. È un’intera, spessa rete che detta come viene costruito il consenso politico, con diverse regole non scritte. E ora gli Stati Uniti si trovano a un momento importante, in cui la macchina che costruisce il consenso si è rotta». Rotti i partiti tradizionali, di cui Trump rappresenta la negazione. Rotti i media, che lui e i suoi detestano. Rotte le rappresentanze sociali. Rotto il futuro. Rotta la democrazia, che non interessa a oltre 2/3 dei millennial americani. Rotto anche l’algoritmo di Facebook, certo: ma c’è una realtà, fuori dalla “bolla” mediatica, e a volte riaffiora. Quando lo fa a questo modo ne seguono momenti “catastrofici”, dice Žižek, che possono condurre dritti al fascismo. O a Trump. Non è un caso che Mike Cernovich, il maestro dei memi pro-Trump oggetto di un recente ritratto del “New Yorker”, dica: «Se tutto è narrazione, allora c’è bisogno di alternative alla narrazione dominante». Molto, infatti, è cambiato. La propaganda, fino a oggi, non era materia di scienziati, ma di artigiani. Anche malvagi, come Joseph Goebbels; ma artigiani. «La propaganda è un’arte che richiede un talento speciale», scriveva Leo Bogart ancora nel 1995, «non è un lavoro meccanico, scientifico. Nessun manuale può guidare un propagandista». Eppure nell’era dei Big Data e della profilazione totale quando si legge di propaganda sempre più si leggono numeri, correlazioni, dati. Si contano i profili Twitter arruolati da Isis, o i “bot” che automatizzano la diffusione di contenuti propagandistici sui social media. Si mappano le relazioni sociali online dei propagandisti - e se ne mutano i nodi più grandi in celebrità internazionali. Si contano “like”, condivisioni e pagine viste e le si confrontano per testate tradizionali e siti di disinformazione. Ma si perdono di vista contraddizioni fondamentali. Nel 2011, per esempio, i social media venivano generalmente considerati come promotori di democrazia, non di nuovi autoritarismi. La “Primavera araba” era stata definita “Twitter revolution”. Possibile sia Trump il passo successivo? Forse entrambe le retoriche sono fallaci: era falso cinque anni fa che fosse Twitter a provocare rivolte democratiche; è falso oggi che la strada del magnate alla presidenza sia lastricata di tweet. Eppure, nota Castronovo, «entrambi i movimenti hanno usato con successo i social media come piattaforma per diffondere le loro idee». La questione, in tutti questi dibattiti, resta confinata al dominio del tecnologico. Così si parla sempre più di propaganda, ma come disciplina a sé resta marginale, negli studi filosofici, in quelli storici e di comunicazione. È una lamentela che accomuna tutti i classici del settore, negli ultimi quarant’anni. «Per non temere la propaganda dobbiamo capirla», scrivono gli studiosi. Ma pochi li ascoltano. Per Jason Stanley, di Yale, la spiegazione sta nel fatto che la teoria politica si è a lungo occupata di democrazie liberali “ideali”, in cui - essendo tali - non c’è propaganda. Castronovo ne offre un’altra, più umana e sottile: «Jacques Ellul ha scritto che le persone più influenzabili dalla propaganda sono quelle che credono di esserne immuni». Per esempio, «la classe intellettuale, che presume di avere la razionalità, l’intelligenza e le abilità analitiche» necessarie a sfuggirvi. Ellul ha tuttavia sottolineato anche che la propaganda ci è necessaria, perché ci procura piacere. Un passaggio cruciale, che oggi lascia Auerbach senza parole: «Avevo sottostimato la maniera in cui Trump è stato in grado di mescolare paura e piacere, facendo in modo si nutrissero l’una dell’altro quando io li consideravo opposti». È un modo per solleticare gli istinti, per esempio quelli razzisti o islamofobi, e insieme lenire la colpa di desiderare razzismo e islamofobia. Perché quella che molti chiamano “post-verità” condivide alcuni dei tratti del “neo-fascismo”, ricorda Castronovo. E attenzione ai numeri: Stanley, in “How Propaganda Works”, aggiunge che «perfino se accurate, le statistiche possono avere una funzione propagandistica verso il dominio e l’oppressione, oscurando le narrazioni che le metterebbero in luce». Tornare al significato delle parole, alla loro storia, è dunque imperativo. I demagoghi che aizzano le folle a mezzo propaganda per accelerare la fine della democrazia ci sono già in Platone e Aristotele. La sostituzione della realtà con una sua versione di comodo a scopi elettorali non viene da Trump, ma dalle analisi del totalitarismo di Hannah Arendt. Perfino l’idea che la propaganda debba essere ovunque, per funzionare, che vi si debba essere “immersi” come in una realtà virtuale, non deriva dall’essere sempre connessi: Ellul, altrimenti, non avrebbe potuto scriverne già negli anni Sessanta. Resta da capire, tuttavia, se questo apparato concettuale sia ancora utilizzabile, in tutto o in parte, o sia invece scaduto. Nell’era in cui si teme le elezioni finiscano vittima di hacker, come un telefonino; in cui squadre di troll assaltano gli avversari politici fino a intasarne gli spazi di discussione e la pazienza; in cui non solo, come sosteneva Edward Bernays nel 1928, «siamo governati, le nostre menti plasmate, i nostri gusti formati, le nostre idee suggerite in gran parte da uomini di cui non abbiamo mai sentito parlare prima», ma forse quei manipolatori non sono più nemmeno uomini, ma “bot”: ha ancora senso, in un’epoca simile, studiare il passato? Rispondere sembra più complesso di quanto vorremmo.
IL POLITICAMENTE CORRETTO. LA NUOVA RELIGIONE DELLA SINISTRA.
Insultare la Boldrini è prova di «maschia libertà», scrive Piero Sansonetti il 16 Aprile 2017, su "Il Dubbio". Sul web troneggia la notizia degli affari d’oro che la sorella di Laura Boldrini combina sulla pelle degli immigrati. Questa sorella della Boldrini – dice il web – si chiama Luciana ed è la presidente di 340 cooperative di assistenza ai profughi. Chiaro che si mette in tasca i milioni. E chiaro anche che è stata Laura a indicarle la buona strada. E giù insulti. «Scandalo, scandalo!!! E i giornali, complici non ne parlano! Farabutta, farabutta!». Eh già: Boldrini è la casta, signori, vedete come è arrogante?. Però non è vero niente. Insultare Laura Boldrini è prova di «maschia libertà»? La sorella di Laura Boldrini è morta alcuni anni fa. La sorella di Laura Boldrini non si chiamava Luciana. La sorella di Laura Boldrini non presiedeva alcuna cooperativa ma faceva la restauratrice di opere artistiche. Non è vero niente ma sono veri, e bruciano, gli insulti che piovono a valanga sui social, nei post, nelle mail. In questa storia si congiungono due questioni, diverse, che spesso si mescolano. La questione delle fake news, ossia delle notizie false (quelle che una volta si chiamavano leggende metropolitane) e la questione, cosiddetta, del linguaggio dell’odio. Le leggende metropolitane sono una vecchia storia, non si sapeva come nascessero ma entravano nel cuore dell’opinione pubblica. Una volta si diceva che la moglie di Rutelli fosse la proprietaria di tutti i parcheggi con le strisce blu di Roma. Oppure che il tale leader politico avesse determinate abitudini sessuali, o una certa fidanzata o un certo fidanzato segreto, e cose simili. Tutto falso. Ma ci sono anche leggende metropolitane più pericolose, come quella – per citarne una storica – che gli zingari rubano i bambini, o che gli ebrei sono proprietari di tutti i posti chiave nell’economia di una città, o di una regione. Fino a qualche anno fa queste leggende “aleggiavano” e facevano danni, ma non potevano diffondersi, e soprattutto “inverarsi”, attraverso la potenza incontrollabile della rete. Ora il problema si è molto aggravato, perché non solo è sempre più difficile smentire le fake news, ma la proporzione tra notizie vere e notizie false si sta ribaltando. Le notizie vere diventano minoranza, e in questo modo il rapporto tra conoscenza e verità salta in aria.
È un problema? Si, è un problema serissimo, soprattutto perché al diffondersi dell’informazione non vera (quella che in Unione sovietica era ben organizzata dallo Stato, si chiamava “disinformazia” ed era un formidabile strumento di governo e di controllo sociale) si è sommato il dilagare del linguaggio dell’odio. Di che si tratta? Della convinzione sempre più diffusa che la misura del valore di ciascun odi noi – della nostra libertà, e del nostro coraggio, e della nostra capacità ideale – risieda nella forza d’odio che riusciamo ad esprimere. Usando modi di espressione violenti e mirando a demolire l’interlocutore col quale vogliamo dissentire, e umiliarlo, e ferirlo profondamente.
Gli avvocati italiani (e cioè il Cnf, il Consiglio nazionale forense) sono riusciti in queste settimane a organizzare un evento che avrà una notevole importanza: un G7 degli avvocati, che si svolgerà in settembre e metterà a confronto i rappresentanti delle avvocature dei sette paesi più industrializzati del mondo. E questo G7 degli avvocati avrà come tema dei suoi lavori proprio questo: come opporsi al linguaggio dell’odio senza mettere in discussione la libertà di parola, di pensiero, di espressione, di stampa.
Problema non semplice e che sicuramente riguarda molto da vicino il giornalismo italiano. Perché è chiaro che il dilagare della “disinformazia” e dell’odio è uno dei risultati della perdita di funzione del giornalismo. Il quale aveva tra i suoi compiti principali quello di mediare tra notizie e popolo, e dunque produrre informazione vera, verificata, di qualità, approfondita. Il giornalismo si è trovato spiazzato dall’improvviso successo della rete, e ha visto assottigliarsi il suo ruolo di mediatore e di “intellettuale”. Ma invece di elaborare una strategia di rilancio dell’informazione di qualità, ha preferito accodarsi al linguaggio dell’odio e alle fake news. Facilitato dalla retorica anti- casta. Le fake news e l’odio vengono usati come mazza per colpire la casta, cioè soprattutto i politici, e in questo modo si costruisce una gigantesca auto- giustificazione: “vado contro il potere dunque sono coraggioso – dunque ho ragione”. Il ruolo della verità sparisce. A dare la prova di correttezza e di giustezza non è il vero o il falso, ma il grado di rabbia e di attacco al presunto potere. Questa abitudine giornalistica – il caso Consip, con le clamorose balle che ha prodotto, è un esempio lampante e recente – è sospinta da un’ “onda” popolare, ma a sua volta è lei stessa il motore che alimenta quest’onda, e la protegge, e la giustifica, e la sostiene. Qual è la causa e quale l’effetto è difficile dire. È facile dire, invece, che se il giornalismo non si pone il problema di affrontare la propria crisi di identità, sarà difficile fronteggiare la barbarie del falso e dell’odio. E chi vorrà inondare di fango la Boldrini, o chiunque altro, potrà farlo liberamente e sentirsi eroico, libero e vero maschio.
Perché diciamo “migrante” anziché “immigrato”? Ce lo spiega la Boldrini, scrive Adriano Scianca il 18 maggio 2015 su “Il Primato Nazionale”. “Migrante”, participio presente del verbo “migrare”. Grammaticalmente, la parola indica un’azione che è in corso, che si sta svolgendo in questo momento, senza riguardo al passato o al futuro. Indica quello che stai facendo ora, non ciò che hai fatto o ciò che farai. Non c’è né origine né destinazione in un participio presente. Forse è per questo che il termine è stato scelto come definizione ufficiale delle masse sradicate che muovono il grande business dell’immigrazione. Finché la lingua italiana ha avuto una sua logica esistevano gli emigrati (chi lasciava una terra per andare altrove) e gli immigrati (chi si era mosso da casa sua e raggiungeva un nuovo luogo), che potevano anche essere le stesse persone ma viste da prospettive differenti. L’emigrato è andato da qui verso altrove, l’immigrato è arrivato qui da altrove. Resta comunque l’idea di un punto di partenza e di arrivo, lo spostamento è una parentesi limitata al fatto di raggiungere un determinato luogo.
Nei primi anni Ottanta, tuttavia, comincia a comparire nei documenti ufficiali della Cee la parola “migrante”. Il giornalismo italiano recepisce la novità a partire dalla fine di quel decennio, ma è in questi ultimi anni che la parola entra nel linguaggio comune, sospinta anche dall’eugenetica linguistica operata dal politicamente corretto.
I motivi del cambio sono spiegati dall’Accademia della Crusca: “Rispetto a migrante, il termine emigrante pone l’accento sull’abbandono del proprio paese d’origine dal quale appunto si esce (composto con il prefisso ex via da) per necessità e mantenendo un senso profondo di sradicamento su cui proprio quel prefisso ex sembra insistere […]. Migrante sembra invece adattarsi meglio alla condizione maggiormente diffusa oggi di chi transita da un paese all’altro alla ricerca di una stabilizzazione: nei molti transiti, questo è il rischio maggiore, si può perdere il legame con il paese d’origine senza acquisirne un altro altrettanto forte dal punto di vista identitario con il paese d’arrivo, restare cioè migranti”.
L’emigrante, nel nostro immaginario collettivo, è l’italo-americano o l’italiano che si è stabilito in Belgio o Germania per trovare lavoro. Persone che, per quanto siano riuscite a integrarsi, spesso solo dopo diverse generazioni, per noi restano sempre “italiani all’estero”, con un legame anche solo virtuale che non si spezza. Ma legami e appartenenze non sono visti di buon occhio oggi, potrebbero essere portatrici o suscitatrici di razzismo.
Aggiunge il sito della Treccani: “Emigrante, come dice l’etimo, sottolinea il distacco dal paese d’origine, calca sull’abbandono da parte di chi ne esce, come segnala anche l’etimologico e- da ex- latino. Ad emigrante, proprio per via di quel prefisso, ma anche a causa del precipitato storico che si è sedimentato nell’uso della parola, si associa l’idea del permanere di un’identità segnata dal disagio del distacco, e dunque l’allusione a una certa difficoltà di inserimento nella nuova realtà di vita […]. In ogni caso, migrante sembra adattarsi meglio alla definizione di una persona che passa da un Paese all’altro (spesso la catena include più tappe) alla ricerca di una sistemazione stabile, che spesso non viene raggiunta. In tal senso, il senso di durata espresso dal participio presente che sta alla base del sostantivo viene sottolineato: il migrante sembra sottoposto a una perpetua migrazione, un continuo spostamento senza requie e senza un approdo definitivo”.
Una “perpetua migrazione”: è questo il concetto chiave. E va interpretato alla luce di un ragionamento illuminante fatto a suo tempo da Laura Boldrini, secondo la quale il migrante è “l’avanguardia dello stile di vita che presto sarà lo stile di vita di moltissimi di noi”. Anzi, secondo la Boldrini gli immigrati “sono molto più contemporanei di noi. Di me ad esempio che sono nata in Italia, sono cresciuta in Italia, ho anche lavorato fuori ma poi continuerò come tanti di noi a vivere in questo Paese”. Ecco quindi perché dire “migrante” anziché “immigrato”: perché indica una condizione di sradicamento generale, di continuo movimento, di nomadismo spirituale in cui forgiare il nuovo cittadino del mondo, rappresentato dall’immigrato ma al cui modello tutti ci dobbiamo ispirare. L’immigrazione è un esperimento di laboratorio, la creazione di un uomo nuovo a cui tutti prima o poi ci dovremo conformare, eliminando il peccato originale del radicamento per essere anche noi “più contemporanei” e cessare di pensarci come italiani, marocchini, cinesi o romeni. A quel punto, finalmente, nascerà l’homo boldrinicum, senza più origini né radici. Adriano Scianca
Boldrini regina del politicamente corretto: amica dei migranti ma lei non migra, scrivono il 15 Agosto 2016 Francesco Borgonovo e Adriano Scianca su “Libero Quotidiano”. È come il bambino di quella storiella, quello che indica il sovrano in veste adamitica e dice: «Il re è nudo». Anzi, no, il paragone non calza. Questa è un'altra favola. Qui non c' è il re, c' è una regina ed è vestita. È lei che guarda il popolo e urla: «Siete tutti nudi». È il motivo per cui perfino la sua corte la odia: parla troppo, parla troppo sinceramente, dice quello che sarebbe conveniente non dire, smaschera tutti i piani. Se sveli al popolo che lo stai riducendo in mutande, il gioco si rompe. Lei è Sua Maestà Laura Boldrini, la regina del politicamente corretto. Sul fatto che, anche nella metafora, lei sia vestita è meglio insistere, giusto per autotutelarsi: tre anni fa, per esempio, cominciò a girare in rete una foto di una donna nuda vagamente simile al presidente della Camera. Era un fake, una bufala. Ma chi la condivise sui social network si ritrovò nel giro di qualche giorno la polizia alla porta. È fatta così, lei, sta sempre allo scherzo. È una delle ragioni per cui, pur essendo l'incarnazione vivente del pensiero dominante, finisce per non riscuotere troppi consensi nemmeno in tale ambito: non solo parla troppo, ma è pure permalosa. Del resto, quando qualche anno fa decise di rendersi «più simpatica», la Boldrini scelse come consulente Gad Lerner. Uno di cui tutto si può dire tranne che sia «popolare» o, appunto, particolarmente simpatico. Basta questo particolare a rendere l'idea di quanta presa sulle masse sia capace di esercitare Laura.
Una così sarebbe capace di gettare discredito su qualsiasi causa appoggiasse. E se si tratta di una causa particolarmente impopolare, un certo tatto è necessario. Prendiamo la Grande Sostituzione. Significa che prendi l'Italia, scrolli via da essa gli italiani come se fossero formiche attaccate a un tramezzino durante un picnic, e ci metti dentro popoli venuti da altri continenti. È quello che sta succedendo, qui da noi e non solo. Ma non lo puoi dire così, altrimenti c' è il rischio che qualcuno si incazzi sul serio. Devi per lo meno girarci attorno, ammantare le tue argomentazioni di finto buonsenso, se possibile citare «gli economisti» o non precisati «studi americani». Laura no, non ce la fa. Lei è priva della malizia dei politici. Quando prova a ragionare in soldoni risulta goffa, come quando twittò: «Italia è Paese a crescita zero. Per avere 66 milioni di abitanti nel 2055 dovremo accogliere un congruo numero di #migranti ogni anno». Sì, vabbé, ma chi se ne frega di avere 66 milioni di abitanti qualsiasi nel 2055, possiamo anche essere 55 milioni di italiani senza dover portare l'Africa intera in casa nostra, no? A quanto pare, per Madama Boldrini non è così. Ma il meglio di sé, Laura lo dà quando parla a briglia sciolta. Una delle sue uscite più memorabili riguardò la confusione tra immigrati e turisti: «Non possiamo, senza una insopportabile contraddizione, offrire servizi di lusso ai turisti affluenti e poi trattare in modo, a volte, inaccettabile i migranti che giungono in Italia dalle parti meno fortunate del mondo, spesso in condizioni disperate», disse. Ma cosa c' entra? La Boldrini proprio non riusciva a capire che noi non «offriamo» servizi di lusso a nessuno ma che i turisti li hanno solo perché pagano per averli. Per gli immigrati, invece, è lo Stato a pagare. Ma la vera origine di queste gaffes è «filosofica».
Il top del Boldrini-pensiero risiede infatti nella sua visione del futuro in stile Blade Runner. Parliamo di quella volta in cui disse che il migrante è «l'avanguardia di questa globalizzazione» e, soprattutto, è «l'avanguardia dello stile di vita che presto sarà lo stile di vita di moltissimi di noi». Capito?
Non si tratta di trasformare l'immigrato in cittadino europeo, come vorrebbe (vanamente) la retorica dell'integrazione. Siamo noi a dover diventare come lui. Noi dobbiamo integrarci con i suoi usi e costumi, o meglio con il rifiuto di ogni uso o costume, occorre solo abbandonarsi a un insensato nomadismo, all' abbandono generalizzato di ogni radice. Che l'obiettivo fosse quello di ridurre in miseria noi anziché di dare benessere a loro era già chiaro. Ma, appunto, è una di quelle cose che in genere si dicono con una certa prudenza. Laura no, lei non ha filtri. Del resto non è una politica di professione e non ha quindi le astuzie della categoria.
Laureata in Giurisprudenza, durante l'università ha dedicato metà del tempo allo studio, metà a viaggi nel Sud-est asiatico, Africa, India, Tibet: all' epoca preferiva ancora andare lei nel Terzo Mondo anziché portare il Terzo Mondo qua. Giornalista pubblicista, ha lavorato per un periodo anche in Rai prima di dar seguito alla sua vera vocazione: mettere radici nell' inutile carrozzone burocratico dell'Onu. Nel 1989, grazie ad un concorso per Junior Professional Officer, comincia la sua carriera alle Nazioni Unite lavorando per quattro anni alla Fao come addetta stampa. Dal 1993 al 1998 lavora presso il Programma alimentare mondiale come portavoce e addetta stampa per l'Italia. Dal 1998 al 2012 è portavoce della Rappresentanza per il Sud Europa dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (UNHCR) a Roma. Qui scopre il suo vero eroe: il migrante. Quando vede un migrante, Laura perde ogni freno: deve ospitarlo, mantenerlo, incensarlo. Arrivano orde di stranieri sui barconi? Lei vuol dare a tutti il permesso di soggiorno. Erdogan perseguita i turchi? Nemmeno il tempo di capire se ci saranno persone in fuga dal Paese che lei è già pronta a spalancare le frontiere. Tanto, che male può mai fare il Santo Migrante? Di sicuro non può essere un possibile jihadista, perché il terrorismo e l'immigrazione, per la Boldrini, non hanno alcun legame. E, comunque sia, i conflitti religiosi non esistono. Dunque, dal migrante non ci si può attendere che buone cose. Dopo tutto, egli è un po' il partigiano del nuovo millennio. Sì, Laura lo disse davvero, nel corso di un 25 aprile: «70 anni fa erano i partigiani che combattevano per la libertà in Italia, oggi capita che molti partigiani che combattono per la libertà nei loro Paesi, dove la libertà non c' è, siano costretti a scappare, attraversando il Mediterraneo con ogni mezzo». Combattono o scappano? Perché fare le due cose insieme non è possibile. In genere si usano i verbi come due contrari, anzi. O combatti, o scappi. Ma la logica, si sa, è un riflesso indotto dalla società patriarcale. Così come la grammatica. I suoi siparietti con i deputati che si ostinano a usare la «sessista» lingua italiana sono noti. Ma per lei è una crociata: «Sono arciconvinta - ha detto recentemente al Corriere della Sera - che la questione del linguaggio rappresenti un blocco culturale.
La massima autorità linguistica italiana, la Crusca, dice chiaramente che tutti i ruoli vanno declinati nei due generi: al maschile e al femminile. Ma la maggior parte accetta di farlo solo per i ruoli più semplici, e si blocca per gli altri». La Crusca le dà ragione. La Crusca: quella di «petaloso». Per la Boldrini, la politica è fatta solo di simboli, battaglie di principio, questioni formali. Un altro dei suoi chiodi fissi sono le pubblicità. «Certe pubblicità che noi consideriamo normali, con le donne che stanno ai fornelli e tutti gli altri sul divano, danno un'immagine della donna che invece non è normale e che non corrisponde alla realtà delle famiglie», disse una volta. Donne in cucina, che orrore, dove andremo a finire di questo passo? Praticamente non parla d' altro.
Nel maggio del 2013 auspicò orwellianamente nuove «norme sull' utilizzo del corpo della donna nella comunicazione e nella pubblicità» perché «se la donna viene resa oggetto nella sua immagine puoi farne quel che vuoi». Si sa, è un attimo passare dallo spot della crema abbronzante al femminicidio. Passarono pochi mesi e nel luglio 2013, si guadagnò più di qualche critica definendo una «scelta civile» quella della Rai di non trasmettere più Miss Italia. Nel settembre successivo tornò sul punto in un convegno, parlando di pubblicità e stampa. «Penso a certi spot italiani in cui papà e bambini stanno seduti a tavola mentre la mamma in piedi serve tutti. Oppure al corpo femminile usato per promuovere viaggi, yogurt, computer». Pubblicità obbligatorie con papà che cucinano: è praticamente il punto in cima alla sua agenda. Il femminismo caricaturale della Boldrini arriva al punto di distinguere gli attacchi politici a seconda del genere di chi attacca: «Per principio mi rifiuto di entrare in dispute tra donne che vanno a indebolire la posizione femminile. Se una donna mi attacca, mi aggredisce in quanto donna, non rispondo. Non mi presto». Ma che vuol dire? Se ti attacca un uomo rispondi, se lo fa una donna no? Questa non è discriminazione? Curioso strabismo. Non è l'unico caso.
Attenta alle parole degli spot, Laura è stata molto più di bocca buona nel soppesare il linguaggio del «Grande imam di al-Azhar Ahmad Mohammad Ahmad al-Tayyeb», invitato qualche mese fa a tenere una «Lectio Magistralis» sul tema «Islam, religione di pace» che si sarebbe dovuta tenere nella Sala della Regina di Montecitorio. E pazienza se lo stesso aveva esaltato gli attacchi suicidi contro i civili in Israele, se aveva detto in tv che alle mogli si possono rifilare «percosse leggere», se ai combattenti dell'Isis voleva infliggere «la morte, la crocifissione o l'amputazione delle loro mani e piedi» ma non - attenzione - perché siano degli assassini, ma perché «combattono Dio e il suo profeta», cioè perché non interpretano l'islam come dice lui. Le donne in cucina negli spot, no. Se vengono percosse leggermente dall' imam, invece, va tutto bene. Contraddizioni, ipocrisia? Non nel fantastico mondo di Laura. Dove tutti i migranti sono buoni. Anche perché tutti sono migranti. Francesco Borgonovo e Adriano Scianca
Chissà se madonna Laura Boldrini, papessa della Camera, ha letto di recente I promessi sposi e s'è dunque imbattuta in Donna Prassede, bigottissima moglie di Don Ferrante, convinta di rappresentare il Bene sulla terra e dunque affaccendatissima a "raddrizzare i cervelli" del prossimo suo e anche le gambe ai cani, sempre naturalmente con le migliori intenzioni, di cui però - com'è noto - è lastricata la via per l'Inferno, scrive Marco Travaglio per Il Fatto Quotidiano l'11 marzo 2014. Noi tenderemmo a escluderlo, altrimenti si sarebbe specchiata in quel personaggio petulante e pestilenziale descritto con feroce ironia da Alessandro Manzoni, e avrebbe smesso di interpretarlo ogni giorno dal suo scranno, anzi piedistallo di terza carica dello Stato. Invece ha proseguito imperterrita fino all'altroieri, quando ha fatto sapere alla Nazione di non avere per nulla gradito l'imitazione "sessista" della ministra Boschi fatta a Ballarò da Virginia Raffaele, scambiando la satira per lesa maestà e l'umorismo su una donna potente per antifemminismo. E chissenefrega, risponderebbe in coro un altro paese, abituato alla democrazia, dunque impermeabile alla regola autoritaria dell'Ipse Dixit. Invece siamo in Italia, dove qualunque spostamento d'aria provocato dall'aprir bocca di un'Autorità suscita l'inevitabile dibattito.
Era già capitato quando la Rottermeier di Montecitorio aveva severamente ammonito le giovani italiane contro la tentazione di sfilare a Miss Italia, redarguito gli autori di uno spot che osava financo mostrare una madre di famiglia che serve in tavola la cena al marito e ai figli, sguinzagliato la Polizia postale alle calcagna degli zuzzurelloni che avevano postato sul web un suo fotomontaggio in deshabillé e fare battutacce - sessiste, ça va sans dire - sul suo esimio conto (come se capitasse solo a lei), proibito le foto e i video dei lavori parlamentari in nome di un malinteso decoro delle istituzioni, fatto ristampare intere risme di carta intestata per sostituire la sconveniente dicitura "Il presidente della Camera" con la più decorosa "La presidente della Camera". Il guaio è che questa occhiuta vestale della religione del Politicamente Corretto è incriticabile e intoccabile in quanto "buona". E noi, tralasciando l'ampia letteratura esistente sulla cattiveria dei buoni, siamo d'accordo: Laura Boldrini, come volontaria nel Terzo Mondo e poi come alta commissaria Onu per i rifugiati, vanta un curriculum di bontà da santa subito. Poi però, poco più di un anno fa, entrò nel listino personale di Nichi Vendola e, non eletta da alcuno, anzi all'insaputa dei più, fu paracadutata a Montecitorio nelle file di un partito del 3 per cento e issata sullo scranno più alto da Bersani, in tandem con Grasso al Senato, nella speranza che i 5Stelle si contentassero di così poco e regalassero i loro voti al suo governo immaginario. Fu così che la donna che non ride mai e l'uomo che ride sempre (entrambi per motivi imperscrutabili) divennero presidenti della Camera e del Senato.
La maestrina dalla penna rossa si mise subito a vento, atteggiandosi a rappresentante della "società civile" (ovviamente ignara di tutto) e sventolando un'allergia congenita per scorte, auto blu e voli di Stato. Salvo poi, si capisce, portare a spasso il suo monumento con tanto di scorte, auto blu e voli di Stato. Tipo quello che la aviotrasportò in Sudafrica ai funerali di Mandela, in-salutata e irriconosciuta ospite, in compagnia del compagno. Le polemiche che ne seguirono furono immancabilmente bollate di "sessismo" e morte lì. Sessista è anche chi fa timidamente notare che una presidente della Camera messa lì da un partito clandestino dovrebbe astenersi dal trattare il maggior movimento di opposizione come un branco di baluba da rieducare, dallo zittire chi dice "il Pd è peggio del Pdl" con un bizzarro "non offenda", dal levare la parola a chi osi nominare Napolitano invano, dal dare di "potenziale stupratore" a "chi partecipa al blog di Grillo", dal ghigliottinare l'ostruzionismo per agevolare regali miliardari alle banche. Se ogni tanto si ghigliottinasse la lingua prima di parlare farebbe del bene soprattutto a se stessa, che ne è la più bisognosa. In fondo non chiediamo molto, signora Papessa. Vorremmo soltanto essere lasciati in pace, a vivere e a ridere come ci pare, magari a goderci quel po' di satira che ancora è consentito in tv, senza vederle alzare ogni due per tre il ditino ammonitorio e la voce monocorde da navigatore satellitare inceppato non appena l'opposizione si oppone. Se qualcuno l'avesse mai eletta, siamo certi che non l'avrebbe fatto perché lei gli insegnasse a vivere: eventualmente perché difendesse la Costituzione da assalti tipo la controriforma del 138 (che la vide insolitamente silente) e il potere legislativo dalle infinite interferenze del Quirinale e dai continui decreti del governo con fiducia incorporata (che la vedono stranamente afona). Se poi volesse dare una ripassatina ai Promessi Sposi, le suggeriamo caldamente il capitolo XXVII: "Buon per lei (Lucia) che non era la sola a cui donna Prassede avesse a far del bene; sicché le baruffe non potevano esser così frequenti. Oltre il resto della servitù, tutti cervelli che avevan bisogno, più o meno, d'esser raddrizzati e guidati; oltre tutte l'altre occasioni di prestar lo stesso ufizio, per buon cuore, a molti con cui non era obbligata a niente: occasioni che cercava, se non s'offrivan da sé; aveva anche cinque figlie; nessuna in casa, ma che le davan più da pensare, che se ci fossero state. Tre eran monache, due maritate; e donna Prassede si trovava naturalmente aver tre monasteri e due case a cui soprintendere: impresa vasta e complicata, e tanto più faticosa, che due mariti, spalleggiati da padri, da madri, da fratelli, e tre badesse, fiancheggiate da altre dignità e da molte monache, non volevano accettare la sua soprintendenza. Era una guerra, anzi cinque guerre, coperte, gentili, fino a un certo segno, ma vive e senza tregua: era in tutti que' luoghi un'attenzione continua a scansare la sua premura, a chiuder l'adito a' suoi pareri, a eludere le sue richieste, a far che fosse al buio, più che si poteva, d'ogni affare. Non parlo de' contrasti, delle difficoltà che incontrava nel maneggio d'altri affari anche più estranei: si sa che agli uomini il bene bisogna, le più volte, farlo per forza". Poco dopo, sventuratamente, la peste si portò via anche lei, ma la cosa fu così liquidata dal Manzoni: "Di donna Prassede, quando si dice ch'era morta, è detto tutto". Amen.
Sgarbi contro il vocabolario politicamente corretto della Boldrini, scrive il 4 gennaio 2017 "New notizie". Vittorio Sgarbi vs Laura Boldrini: il noto critico d’arte, che non si fa problemi a dire pubblicamente quello che pensa di ogni situazione che richiami la sua attenzione, ha preso di mira la Presidente della Camera, Laura Boldrini: non si tratta della prima volta, ricordiamo che quest’estate Sgarbi aveva demolito la sua decisione di istituire una fantomatica commissione parlamentare contro l’Odio. “La Commissione contro l’odio porterà a risultati sorprendenti. Riconosceremo finalmente i sentimenti di Totò Riina. Saremo indotti a giustificarlo e forse ad amarlo, anche se non lo abbiamo concesso ai suoi figli. Sì, esorcizziamo l’odio. Cerchiamo le radici del male. Perché odiare gli assassini del Bangladesh? Perché provare rabbia e rancore? Rispettiamo lo slancio religioso dei terroristi. Condividiamo il loro martirio, i valori reali che li ispirano” aveva allora criticato Sgarbi. Ma non si ferma qui: il noto critico, che ha tantissimi seguaci sui social e non solo, ha anche preso di mira il nuovo vocabolario della Boldrini, il cui scopo politico primario sembra essere quello di declinare al femminile ogni nome. Con buona pace della grammatica italiana. ‘Sindaca’ e ‘Ministra’ o addirittura ‘Presidente’, neologismi che sono già mutuati da alcuni organi di informazione. Per deridere questa “battaglia”, Sgarbi chiama il presidente della Camera Boldrina. “Napolitano ha detto una cosa semplice: che i ruoli prescindono dai sessi, che non si applicano ai sessi, che sono persone ma che essendo di genere femminile non diventano femminili, un persono sostiene Sgarbi.
La ministra Fedeli e i discorsi di Totò. L’uso caricaturale del politicamente corretto rischia di essere ridicolo anche quanto si propone obiettivi seri, come nel caso dei decreti delegati sulla scuola, scrive Gian Antonio Stella il 18 aprile 2017 su "Il Corriere della Sera". «Signore e signori, dottoresse e dottori, idrauliche ed idraulici, oboiste ed oboisti, sfogline e sfoglini…». Avanti così, Valeria Fedeli rischia di fare il verso a certi discorsi del mitico Totò. L’uso caricaturale del politicamente corretto, infatti, riesce ad essere ridicolo anche quando si propone obiettivi seri. E se la British Medical Association, come ha raccontato su il foglio Giulio Meotti, ha tracciato il solco in Gran Bretagna invitando «i medici a non parlare più di expectant mothers (mamme in attesa), ma di un più generico pregnant people (gente incinta), per rispettare l’eventuale natività gay» la nostra ministra dell’Istruzione si è incamminata lesta nel solco. Come spiega Tuttoscuola, infatti, dopo aver esordito alla ripresa delle lezioni dopo l’Epifania con un tonante «Care ragazze e cari ragazzi, bentornate e bentornati», la signora ha sfidato le scontate ironie della popolazione scolastica (che in queste cose sa essere feroce) con i testi definitivi dei decreti delegati. Dove ha sfondato la barriera del suono del politicamente corretto: «Ventinove (29) volte bambino è diventato “bambina e bambino”, quarantanove (49) volte alunno è diventato “alunna e alunno”, quarantasei (46) volte studente è diventato “studentessa e studente”». Un esempio? Nel decreto sull’inclusione spicca: «Valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente…».
Il record, prosegue la rivista di Giovanni Vinciguerra, «è dentro il decreto sulla valutazione con 44 articolazioni di genere (per fortuna non c’erano le bambine e i bambini dell’infanzia, non compresi nella valutazione). Al secondo posto il decreto sull’inclusione con 32 articolazioni, seguito dal decreto della riforma 0-6 anni con 17 exploit tutti riservati ovviamente a bambine e bambini». E meno male che i sindacati, che sembrano a loro agio con la ministra-sindacalista, non si sono accorti d’una profonda ingiustizia: nei «già verbosissimi decreti» non ci sono distinzioni sul sesso dei docenti. Scelta che avrebbe imposto l’uso di professoresse e professori, maestre e maestri e così via. Domanda: al di là delle possibili proteste di chi davanti a un eccesso di precisazioni di genere potrebbe dichiararsi estraneo all’uno e all’altro sesso, è questo il famoso «rispetto» per gli studenti? Non sarebbe più rispettoso evitare loro di cambiare professori ogni anno o passare ore ed ore in edifici a rischio sismico e idrogeologico?
Politicamente corretto, la nuova religione della “sottomissione” al “non pensiero” del potere, scrive il 13 dicembre Giuseppe Reguzzoni su Tempi. Per la nuova religione non è vero ciò che è vero, ma ciò che si riesce a far apparire tale. Il nemico non è un’altra religione ma il pensiero stesso. Chi pensa è un potenziale nemico. Anticipiamo in queste pagine alcuni stralci del saggio Il liberalismo illiberale, dell’Editore XY.IT, in libreria in questi giorni. L’autore, Giuseppe Reguzzoni, è uno storico e giornalista, traduttore (tedesco, francese, inglese) anche di opere di papa Benedetto XVI. Collabora con l’Istituto Mario Romani dell’Università Cattolica di Milano. Il Politically Correct è il nuovo tabù e l’aura di timore che lo circonda è il nuovo senso del pudore, del tutto imposto ed eterodiretto. Preso alla lettera, “politically correct” richiama in qualche modo l’idea di “correct polity”, dunque una certa buona maniera di governare o, anche, di stare al mondo gli uni accanto agli altri, di costruire insieme la politéia, la comunità civile. (…) Il Politicamente Corretto è, nella prassi sociale di ogni giorno, un elenco implicito di divieti o, se si vuole, di dogmi indimostrabili. Il sacerdote del Politicamente Corretto non mira ad argomentare, ma a puntare il dito, con orrificato stupore, su chi osa mettere in questione la secolarissima sacralità del suo Credo. (…)
Già solo accennare alle grandi aree semantiche di cui si occupa questo moderno e laico tribunale dell’Inquisizione costituisce in qualche modo un reato: immigrazione, sicurezza, differenze di civiltà e di origine geografica e razziale, omosessualità, gender mainstreaming, temi identitari, domande esistenziali e fedi religiose sono oggi i nuovi “tabù”, ciò di cui è bene non parlare, anche se, inconsciamente, quando sopravvive un minimo di spirito critico, lo si vorrebbe fare. L’idea di tabù è stata sviluppata anzitutto dagli antropologi, come una sorta di proibizione rituale, implicita e inconscia, ma è stato Freud a evidenziare il nesso tra tabù e nevrosi. La nostra è una civiltà nevrotica, a tratti schizofrenica, che nega l’esistenza stessa del problema, confinandolo nei propri tabù. Il Politicamente Corretto è, appunto, il tabù rispetto alla ricerca e alla percezione della verità, tutta intera. C’è, tuttavia, chi di questi tabù usa consapevolmente per consolidare i propri disegni di potere. (…)
Il ministero orwelliano del condizionamento esiste e la sua forza sta nella sua apparente, superficiale, invisibilità. Come nel mondo immaginato da Orwell in 1984 la lingua, o meglio, la “neolingua” è strumento di potere. Solo che, a differenza che nel mondo distopico di Orwell, nel linguaggio politicamente corretto i termini sono in costante aggiornamento. Si dice e non si dice, attuando con efficacia forme di censura preventiva che ostacolano o impediscono ogni forma di pensiero critico personale, qui proprio come in 1984. (…)
Questi tabù, organizzati ectoplasmaticamente in quella realtà fluida e in continuo mutamento che è il Politically Correct, costituiscono la nuova religione civile della società globale. Qui sta il cambiamento in corso almeno da due decenni e coincidente con la crisi dei grandi sistemi politici di matrice ideologica, incluso il liberalismo e la sua pretesa di essere una sorta di via media. Qui sta il nocciolo della forma che il Politically Correct sta assumendo e il fatto che esso non sia ormai più solo un linguaggio, ma, appunto, un elemento di raccordo e coesione sociale, con tratti simili a quelli che Rousseau attribuiva alla sua religione civile.
Che la formulazione del modello del Politically Correct abbia avuto luogo prima negli Stati Uniti non è certamente un dato casuale. Rispetto all’Europa gli Stati Uniti, pur essendo un paese fortemente secolarizzato, restano tuttavia fortemente segnati da un ipermoralismo parabiblico, in cui Arnold Gehlen ha riconosciuto i tratti di «una nuova religione umanitaria». Dopo la Seconda Guerra Mondiale e, soprattutto, negli anni Sessanta del secolo scorso, il linguaggio puritano ha subìto una profonda mutazione a contatto con il linguaggio (neo)marxista veicolato dagli intellettuali della scuola di Francoforte o ispirato da loro, dapprima rifugiati negli Stati Uniti e poi installati nelle scuole e università occidentali. È stato soprattutto con le rivolte giovanili degli anni Sessanta che costoro hanno assunto il ruolo di sacerdoti del pensiero unico, esercitando un controllo progressivamente egemone sui media e sui sistemi scolastici ed educativi occidentali. Già le modalità con cui questo pensiero si è imposto presentano quei tratti di slealtà che sono caratteristici del linguaggio politicamente corretto, dal momento che la critica dell’autorità andava di pari passo con modelli di autoritarismo implicito: si contestavano le figure tradizionali dell’autorità, avvvalendosi dell’autorità che derivava dalle proprie cattedre e dai propri ruoli. Il politicamente corretto si presentava antidogmatico, imponendo però dogmi impliciti e indiscutibili, così come, nella sua versione sessantottina, si presentava come anticonformista, imponendo però nuove forme di conformismo radicale e disperato. In questo modo, sleale, il nuovo moralismo andava costruendo i suoi dogmi, e si avviava a trasformarsi in quella che Carl Schmitt definiva «la tirannia dei valori». (…)
D’altra parte è l’Occidente, nel suo insieme, dunque anche l’America, a divenire vittima di se stesso e dei propri complessi di colpa, evidenti nelle nuove forme di autocensura. Il bombardamento di slogan antirazzisti, multiculturali, antiomofobi ha assunto toni parossistici, quasi religiosi. Non si offrono ragioni, ma tabù indiscussi, e il solo sollevare questioni, anche minime, è considerato blasfemo. Il politicamente corretto, in quanto nuova religione civile, impone un credo indiscutibile e indiscusso. Nella nuova religione non si crede perché essa è ragionevole, ma solo per paura o per assuefazione. Lungo sarebbe l’elenco dei “dogmi” di questa nuova religione civile, più facile identificare nei grandi media, voce dei poteri forti, la nuova inquisizione, che sentenzia senza ascoltare e condanna attraverso mantra ossessivamente ripetuti. Per essa non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che si riesce a far apparire tale. Il nemico di tale tribunale non è un’altra religione civile, filosofica o rivelata, ma il pensiero stesso. Chi pensa, per il fatto stesso che pensa, è un potenziale nemico. Non affannatevi a pensare, a voler conoscere la realtà, lo facciamo noi per voi. Voi limitatevi a divertirvi o compiangervi e, soprattutto, adeguatevi.
La dittatura del politicamente corretto suppone delle società liberali o, se si preferisce, apparentemente liberali, dove sia almeno a parole garantita la possibilità di scegliere, magari cambiando canale tra reti, in realtà tutte omogenee al sistema. È il paradosso del liberalismo, che vive di presupposti che non è esso stesso in grado di generare, (…) è l’involuzione di un modello culturale e politico che, partito in nome della libertà, finisce per ritagliare quest’ultima a uso di chi ha il potere finanziario e politico. (…) Nel Politicamente Corretto tutto ciò che marca la differenza tra comunità e individui, finanche tra i due sessi, è percepito e indicato come un ostacolo imbarazzante. (…)
La laicità radicale, o laicismo negativo, mira finanche ad annullare i segni storici della presenza delle religioni in Occidente (dunque della religione cristiana) sostituendovi altri segni in linea con la propria visione del mondo. Alle comunità religiose è riconosciuto, al massimo, lo status di enti privati, senza alcuna pertinenza diretta con la realtà statuale. È quanto non ha mancato di constatare, e denunciare, papa Giovanni Paolo II lungo tutto il proprio pontificato: «Nell’ambito sociale si sta diffondendo anche una mentalità ispirata dal laicismo, ideologia che porta gradualmente, in modo più o meno consapevole, alla restrizione della libertà religiosa fino a promuovere il disprezzo o l’ignoranza dell’ambito religioso, relegando la fede alla sfera privata e opponendosi alla sua espressione pubblica. Il laicismo non è un elemento di neutralità che apre spazi di libertà a tutti: è un’ideologia che s’impone attraverso la politica» (Ai presuli della Conferenza episcopale della Spagna, in visita Ad limina Apostolorum, 24 gennaio 2005).
La campagna contro i crocifissi, sottoscritta anche da un altro Zagrebelsky, a nome del Consiglio d’Europa, non è che un elemento di questo complesso processo di sostituzione simbolica che pretende di investire la totalità del vivere civile e le sue espressioni non puramente individuali, come accade, esemplarmente, nella gestione del tempo e della sua dimensione pubblica. Per il momento la rimozione del calendario cristiano risulta ancora troppo complessa, ma val la pena di ricordare che essa è già stata sperimentata all’epoca della Rivoluzione francese e riproposta dai sistemi totalitari del XX secolo. La nascita di un calendario civile, con applicazione rigorosa di nuove forme di “precetto festivo” si colloca, a sua volta e in pieno, su questa medesima linea, dal momento che il calendario rappresenta la scansione ufficiale del tempo in una società. In Italia il 25 aprile, l’1 maggio e il 2 giugno hanno assunto funzioni che vanno ormai ben al di là della commemorazione civile di eventi storici importanti. Ci sono centri commerciali che sono aperti il 25 dicembre, Natale, ma non è possibile o è estremamente difficile che la stessa cosa avvenga il 25 aprile o il 2 giugno. Eppure, se il presupposto del laicismo radicale è che tutto è relativo e che, dunque, nessuna posizione debba essere considerata preminente, non si capisce bene su che cosa debba fondarsi la sacralità di tali ricorrenze “civili”.
Alle feste “comandate” del calendario civile, paragonabili alle solennità del calendario liturgico, si sommano le “feste di precetto” e le “memorie solenni”, come la giornata della memoria (ormai imposta in tutte le scuole, con cerimonie e iniziative culturali), l’8 marzo (festa della donna) o la festa della mamma o il 14 febbraio, san Valentino, festa degli innamorati. Queste ultime, laiche feste di precetto, tra l’altro, che pur non hanno il carattere di solennità nazionali, sono oggi elementi costitutivi di una sorta di calendario universale del Politicamente Corretto.
Tale calendario “civile”, non potendo annullare del tutto le festività religiose, tende a neutralizzarle. Così è avvenuto con il Natale cristiano, ormai scomodo sul piano dei dogmi della religione civile del Politicamente Corretto, che è stato trasformato in festa dei buoni sentimenti (con apertura dei negozi). D’altra parte, se internet è l’emblema della nuova società globale, quando si parla di calendario, è interessante osservare come il motore di ricerca Google ormai da anni scandisca il fluire dei giorni come una sorta di rubrica liturgica di questa nuova religione civile secolare, assumendo il ruolo di custode e guardiano della rete. Intorno al logo di Google abbiamo visto scorrere di tutto: dall’anniversario della nascita di Confucio, con tanto di costume mandarino stilizzato, a quella di Galileo, con allegato telescopio, e persino quello di Ludwik Zamenhof, ebreo polacco creatore dell’esperanto. Non sono mancati riferimenti alla nascita di Buddha, malgrado la scarsità di dati storici certi, e abbiamo potuto seguire quasi integralmente la scansione annuale delle principali festività ebraiche. Da qualche anno ci toccano anche gli auguri ai musulmani per l’inizio e la fine del Ramadan. Per par condicio il 25 dicembre ci si attenderebbe l’immagine di un piccolo presepe, ma non è mai stato così. Il massimo che ci è stato concesso è stato il grassone vestito di rosso, con tanto di renne al seguito, caricatura inventata dalla Coca Cola del vescovo greco anatolico Nicola di Myra.
Su Google sono costantemente e volutamente assenti i riferimenti al calendario cristiano in quanto cristiano, benché il motore di ricerca non abbia ancora rinunciato al calcolo degli anni dalla nascita di Cristo. I richiami alle feste cristiane sono “tabù”. Ma nella geografia politica dell’imbarazzo, Google non è che un elemento accanto a moltissimi altri, come il divieto esplicito del tradizionale augurio “Merry Christmas” sulle insegne di molti comuni inglesi o quello implicito nella stragrande maggioranza delle aziende europee ed americane, fino ad arrivare all’esclusione di presepi e alberi di Natale in alcune scuole statali italiane in nome della multiculturalità. La domanda che sorge spontanea è se davvero si tratti solo di imbarazzo o se, piuttosto, queste scelte non sottendano un disegno nascosto, non siano cioè l’espressione di una visione secolarista che si va imponendo come una nuova e non esplicita religio civilis, mascherandosi da laicità dello Stato che, addirittura, come in Zagrebelsky, dichiara di considerare pericoloso ogni contributo che le religioni possono offrire alla coesione sociale in quanto tale.
Le forze che agiscono dietro questo progetto sono molteplici e si muovono sulla base di processi anche molto differenti di autocoscienza. Sarebbe ingenuo, però, pensare a un movimento in tutto e per tutto spontaneo, di carattere culturale, quasi che la cultura e la mentalità dominante non abbiano nulla a che fare con le forme, indotte, del disciplinamento sociale. Un’analisi compiuta di questi processi è arrivata sinora più dalla letteratura distopica che dalla riflessione speculativa. Certo, la teologia successiva al Vaticano II non si è ancora confrontata in maniera seria con il tema del condizionamento socio-culturale come progetto di riscrittura della mentalità e della società. I sorrisini e le ironie quando si tocca il tema dell’influenza della massoneria sulla mentalità odierna la dicono lunga su questa profonda ingenuità (è davvero solo tale?). Eppure i testi e i documenti che mettono in guardia da un atteggiamento che cerca di mascherare l’ingenuità con la spocchia intellettuale non sono pochi. Una cosa è il complottismo, altra, e ben diversa, è la progettualità culturale sulla società, particolarmente quando essa non è esplicitata in programmi politici trasparenti, ma in forme di condizionamento legate ai soft power. (…)
Il cristianesimo non è una religione civile; il laicismo radicale, almeno implicitamente, sì. Si può discutere se e quanto le religioni possano contribuire alla religione civile di una nazione, ma, in una prospettiva cristiana, ciò implica che il termine “religione” sia inteso in senso quasi metaforico. E implica che la religione civile non si ponga in termini sostitutivi rispetto alle religioni storiche, ma ne accolga il contributo (…). Benedetto XVI, riassumendo una posizione che non può essere tacciata di integralismo fondamentalista, non dice che il cristianesimo è una religione civile, ma che esso ha una funzione civile. Non è la stessa cosa (…).
Per dirla con Carl Schmitt, si tratta di un processo di continua “neutralizzazione” dei riferimenti ideali. Alle religioni tradizionali si sostituisce la pura razionalità, sino ad arrivare a cercare un punto di coesione il più neutro possibile nell’economia e nella tecnica. Tra queste suggestioni di massa, quella che fluttua da un centro conflittuale all’altro, mantenendo la propria funzione mitica, è certamente l’idea di progresso. (…) In fondo, mentre il cosmopolitismo settecentesco era una dottrina filosofica, il globalismo contemporaneo ne è l’erede in forma “neutralizzata”. L’altro elemento, accanto al mito del progresso e della “neutralità della tecnica”, impostosi soprattutto dal Sessantotto, è quello dei diritti dell’uomo, interpretati evolutivamente proprio alla luce del mito del progresso, come ha acutamente dimostrato la professoressa Janne Haaland Matláry proprio in rapporto all’idea di dittatura del relativismo. Il concetto riprende un passaggio fondamentale dell’omelia di Benedetto XVI durante la celebrazione della Messa Pro eligendo pontifice, che ben riassume il carattere (pseudo) “religioso” di questa prospettiva. Il dialogo, per funzionare, implica l’esistenza di un vocabolario comune, in cui i termini fondamentali non vengano usati in maniera e con significati ambigui od equivoci.
Il relativismo etico dell’Occidente e il Politically Correct come sua implicita religione civile non sono in grado di realizzare questo dialogo dato che, nella migliore delle ipotesi, quel che ne deriva è solo una mera giustapposizione del diverso, una multiculturalità senza incontro e senza scambio. Anche i diritti dell’uomo, considerati in sé e per sé, non riescono a uscire dal rischio di un’interpretazione ambigua ed equivoca. A prescindere dal fatto che la maggior parte dei paesi islamici non riconosce la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, all’interno dello stesso Occidente è al centro di interpretazioni opposte che ne annullano il valore “universale”. Il punto è l’uso che oggi si sta facendo dei diritti dell’uomo. Da una parte sono divenuti la nuova Bibbia politica di una comunità sociale diversamente priva di qualunque riferimento ideale, dall’altra sono stati di volta in volta usati come la bandiera di un valore e del suo esatto contrario, per esempio, della difesa della famiglia tradizionale e della sua demolizione attraverso il riconoscimento dei cosiddetti matrimoni omosessuali. Nessuno in Occidente può oggi permettersi di andare contro i diritti dell’uomo, e allora si tenta di tirarli dalla propria parte, spostando il problema dall’applicazione dei diritti dell’uomo alla loro interpretazione.
La Dichiarazione ha una sua precisa collocazione storica e si tratta di un riferimento storico che ha qualcosa di miracoloso, di irripetibile. Si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale e dagli orrori del nazifascismo (quelli del comunismo erano ancora ipocritamente occultati). La Dichiarazione Universale nacque come reazione al relativismo politico e legale della Germania hitleriana e, più in generale, delle ideologie totalitarie, con un implicito riferimento all’idea che stava alla base del processo di Norimberga. Ai criminali nazisti che si appellavano all’obbedienza agli ordini ricevuti dall’alto, si ricordava che esiste un’altra obbedienza, ben più decisiva. Sulla base di questa idea, per la prima volta nella storia, un tribunale aveva emesso delle condanne non perché gli imputati erano nemici, ma perché avevano violato questa legge di natura, quella a cui si ispirò la Dichiarazione.
Ora, perché questa legge possa davvero essere tale, in forza di quel “sentire comune” di tutta l’umanità a cui essa fa riferimento, bisogna che non possa essere modificata arbitrariamente dagli attori politici. Ma è proprio questa la crisi che sta investendo i diritti dell’uomo. Se essi sono solo una convenzione, modificabile col cambiare delle opinioni, allora i diritti non sono più tali, perché possono a loro volta essere modificati. Perché i diritti dell’uomo siano tali, devono essere al di sopra degli stati, (…) essi non possono neppure essere in balìa dei nuovi poteri transnazionali che cercano di svuotarli dall’interno reinterpretandoli in direzione di quel mostro ideologico che è il politicamente corretto. Le grandi lobbies del potere transnazionale non potendo negare i diritti in quanto tali, tendono a dissolverli considerandoli solo come delle mere convenzioni, delle questioni di maggioranza all’interno di un’opinione pubblica da loro dominata o egemonizzata. (…)
La strategia sottesa è quella del soft power, vale a dire del condizionamento dell’opinione pubblica da parte di agenzie internazionali di opinione, con meccanismi acutamente descritti da Haaland Matláry nel suo volume sui «diritti umani traditi»: si comincia a imporre la trattazione di certi temi, mettendo in conto il rifiuto della maggioranza ancora poco “illuminata”; si pretende che se ne parli come di “diritti civili”, magari facendo riferimento a “casi pietosi” e con l’appoggio di importanti figure del mondo dello spettacolo o dello sport; ci si appella al sostegno del mondo scientifico, di volta in volta identificato con qualche personalità di comodo e si ottengono, alla fine, delle “direttive non vincolanti” emanate da organismi transnazionali (come – aggiungiamo noi – potrebbe essere anche il Parlamento europeo). A questo punto il gioco è fatto e si può intervenire all’interno di ciò che resta dello stato nazionale appellandosi alle moderne conquiste dei paesi civili e al tale pronunciamento della tale commissione per chiedere il “diritto” al matrimonio omosessuale, alla sperimentazione sugli embrioni, alla clonazione eccetera. Nel frattempo si dilata il vocabolario delle maledizioni politicamente corrette per far sì che gli avversari nemmeno vengano ascoltati: razzista, omofobo, oscurantista, rozzo. (…)
È chiaro che la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo è stata svuotata. Essa ha senso solo in quanto espressione del diritto naturale, cioè di quel diritto che viene prima di ogni forma di organizzazione statale e che è inviolabile: «Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati» (Art. 30). Mettere in questione il carattere universale di questi princìpi e il loro ancorarsi nelle «leggi non scritte e immutabili» del diritto naturale significa spianare la strada all’arbitrio e a nuove forme di totalitarismo. All’azione distruttiva del soft power Haaland Matláry oppone la necessità di riscoprire il valore fondativo e universale della ragione. La sua proposta di rivalutazione del diritto naturale indica in modo rigoroso un possibile percorso fondativo della categoria del “prepolitico” in un contesto culturale e sociale secolarizzato.
In una prospettiva cristiana, restano due questioni: quella di come l’avvenimento cristiano debba porsi di fronte a questa sorta di religione globale, incentrata sul mito del progresso e sulla relativizzazione dei diritti dell’uomo; quella del contributo alla coesione sociale che il cristianesimo è chiamato a portare nella vita delle nazioni e nelle relazioni internazionali.
Il punto non è solo il ruolo che le religioni possono svolgere all’interno delle società secolarizzate, ma, soprattutto, le condizioni perché queste ultime possano sopravvivere e non sprofondare in una violenza di tutti contro tutti. (…) Una corretta religione civile – sempre che si voglia ancora insistere su questa espressione di per sé ambigua – sarebbe, dunque, necessaria allo Stato liberale e democratico occidentale proprio in funzione della realizzazione di questi presupposti che esso non può darsi da solo, ma che può ricevere dalle forze più vive che esistono al proprio interno.
Senza negare l’evidenza di una società occidentale divenuta plurale (…), ma comunque bisognosa di riferimenti etici e ideali comuni, si tratta di relativizzare l’idea di religione civile, riconoscendole – con Benedetto XVI – un valore necessario, ma non sufficiente: «Il concetto di religio civilis appare così in una luce ambigua: se esso rappresentasse soltanto un riflesso delle convinzioni della maggioranza, significherebbe poco o niente. Ma se invece deve essere sorgente di forza spirituale, allora bisogna chiedersi dove questa sorgente si alimenta». Ecco, allora, le due tesi ratzingeriane, per una rilettura della laicità dello Stato e della religione civile a essa sottesa: «La mia prima tesi è che una religio civilis che realmente abbia la forza morale di sostenere tutti presuppone delle minoranze convinte che hanno trovato la “perla” e che vivono questo in modo convincente anche per gli altri. Senza tali forze sorgive non si costruisce niente. La seconda tesi poi è che ci devono essere forme di appartenenza o di riferimento, o semplicemente di contatto con tali comunità», espressione con cui si intende non solo la presenza di nuove comunità religiose, ma il contributo fattivo e vitale che le comunità possono dare, come «sale della terra» (che più avanti Ratzinger chiama anche «minoranze creative»), alla coesione sociale e civile, in rapporto con tutti i fermenti più vivi che operano all’interno della società. È evidente che per essere se stessa, l’esperienza cristiana chiede e necessita di non essere privatizzata e ridotta a puro elemento individuale e soggettivo. È altrettanto evidente che questa esperienza non deve temere di rapportarsi a un mondo divenuto plurale, rimanendo però se stessa sino in fondo. Diversamente, il concetto di religione civile resta «prigioniero in quella gabbia di insincerità e ipocrisia che è il linguaggio politicamente corretto».
Contro il fascismo di sinistra. L’occidente politicamente corretto è un élite vuota e secolarizzata che si crede eterna, dice Camille Paglia. “Il free speech era l’anima della sinistra degli anni Sessanta, poi è diventata una polizia del pensiero stalinista”, scrive Mattia Ferraresi il 6 Febbraio 2015 su "Il Foglio". “Quale visione della vita propone il liberalismo che sia più grande delle prospettive cosmiche delle grandi religioni?”, dice Camille Paglia.
New York. Camille Paglia combatteva il politicamente corretto quando ancora non esisteva. C’era la cultura perbenista e censoria che veniva dagli anni Cinquanta, ma non esisteva ancora l’invisibile polizia del linguaggio del “fascismo di sinistra”, come lo chiama lei, che tracciava il confine fra il legittimo e l’illegittimo nel discorso pubblico non sulla base di un ben perimetrato codice morale, ma intorno alle linee incerte della libertà individuale. Non è con la coercizione che il politicamente corretto si è insediato. E’ stato un docile golpe culturale nel nome dell’uguaglianza, articolato con il linguaggio accondiscendente dei diritti, non imposto con il manganello della buoncostume. E’ lo strumento di protezione degli indifesi, dei più deboli, delle minoranze oppresse, dicevano i suoi difensori, e l’argomento potrebbe essere ripetuto anche da Mark Zuckerberg per giustificare l’esclusione da Facebook dei testi che contengono la parola “frocio” (termine che compare in questo articolo al solo scopo di sfruculiare l’ottuso algoritmo).
Paglia è passata in mezzo a tutte le fasi della guerra del politically correct. Faceva il primo anno di università nello stato di New York quando gli studenti di Berkeley guidati da Mario Savio manifestavano per la libertà di parola, gettando i semi della controcultura; in tasca aveva sempre una copia di “Howl” (“la mia bibbia”, dice) il poema di Allen Ginsberg censurato per oscenità. Nel 1957 la polizia aveva perquisito – e contestualmente devastato – la libreria di San Francisco che con inaccettabile affronto aveva continuato a vendere il volume; nei primi anni Novanta, quando il politicamente corretto si è coagulato in un sistema di regole per lo più non scritte, diventando convenzione dopo essere stato pulsione, la femminista contromano era sulla copertina del New York magazine con uno spadone medievale davanti al Museo d’arte di Philadelphia: una “women warrior” a presidio della libera cittadella della cultura contro gli attacchi del politicamente corretto.
Non che lo schema del politicamente corretto oggi sia stato superato, anzi. Nella sua veste più minacciosa di “hate speech” – un politicamente corretto con il turbo – il canone che regola l’indicibile nel discorso pubblico è diventato pervasivo e meccanico, s’è infiltrato nella rete sotto forma di cavillosi termini d’uso che si accettano senza leggere; nelle università americane è sempre più frequente il fenomeno del “disinvito” di oratori che possono offendere la sensibilità di qualche gruppo minoritario; sul giornale di Harvard lo scorso anno una studentessa suggeriva di abbandonare la finzione della “libertà accademica” e di selezionare in modo finalmente esplicito quali eventi approvare e quali no sulla base della compatibilità ideologica con una certa tavola di valori che l’università di fatto promuove (e a parole nega). Il massacro islamista nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi ha rinfocolato il dibattito sulla libertà di espressione e sui suoi limiti. Per qualche settimana siamo stati tutti Charlie, poi l’occidente benpensante è tornato al suo business as usual: il New York Times non ha pubblicato le vignette di Maometto per non offendere i lettori musulmani, Facebook le ha censurate per non far arrabbiare il governo turco e l’editorialista David Brooks ha fatto notare un’indiscutibile verità: un giornale come Charlie Hebdo “non sarebbe durato trenta secondi” in qualsiasi università americana. Si sarebbero sollevate proteste indignate, minoranze offese avrebbero manifestato e finanziatori altrettanto offesi avrebbero protestato con argomenti molto più convincenti.
Lo stesso magazine che ritraeva Paglia fra armature medievali quasi quindici anni fa ha pubblicato di recente un saggio sul politicamente corretto di Jonathan Chait, opinionista di tendenza liberal, di cui il Foglio ha dato conto la settimana scorsa. Chait si scaglia contro la dittatura del politicamente corretto e per capire che ha messo il dito in una piaga insanguinata del dibattito basta leggere alcune delle violente reazioni all’articolo da parte di esponenti di minoranze e sottoculture che esigono protezione da parte della polizia del linguaggio. Il ragionamento dei critici suona così: Chait può permettersi di attaccare il politicamente corretto perché è un maschio-bianco-etero-ricco, se soltanto uscisse per un attimo dalla bolla di privilegio sociale in cui vive capirebbe che le regole per non offendere le minoranze sono un bene sociale imprescindibile. Questo tanto per dire dove può portare la foga iconoclasta del movimento anti-anti-politicamente corretto, che legge qualunque episodio come figura dell’universale dialettica fra oppressori e oppressi.
Il cuore del saggio di Chait, però, era il tentativo di dimostrare che il politicamente corretto non è figlio del liberalismo, ma ne è una perversione, un tradimento introdotto dalla sinistra radicale d’impostazione marxista e inclinazione totalitaria. Nello schema di Chait c’è una sinistra buona e liberale che disprezza la correttezza politica e innalza monumenti al “free speech”, e una sinistra cattiva che con un rasoio ideologico raschia via dal discorso pubblico ciò che è incompatibile con il suo pensiero, e usa come scusa la difesa delle minoranze.
La guerriera Camille Paglia prende a spadate questa rappresentazione, e in una conversazione con il Foglio ripercorre la genesi del politicamente corretto in seno (e non al di fuori) alla rivoluzione liberale: “La libertà di espressione era la vera essenza, l’anima della politica di sinistra degli anni Sessanta, che reagiva al conformismo e alla censura degli anni Cinquanta, alla quale si opponevano già prima gruppi radicali underground, i poeti Beat e gli artisti di San Francisco e del Greenwich Village. La libertà di espressione è sempre stato il mio principio e la mia motivazione centrale, parte dell’eredità dei filosofi dell’illuminismo che hanno attaccato con forza le autorità religiose e i privilegi di classe. Proprio per questo è stato incredibilmente scioccante per me il momento in cui i liberal americani hanno abbandonato il free speech negli anni Settanta e hanno inaugurato l’èra del politicamente corretto, per la quale soffriamo ancora oggi. Invece di difendere il vibrante individualismo degli anni Sessanta, la sinistra è diventata una polizia del pensiero stalinista che ha promosso l’autoritarismo istituzionale e ha imposto una sorveglianza punitiva delle parole e dei comportamenti”.
La sottesa analogia con la dinamica che dalla rivoluzione giacobina e ai suoi ideali di liberté ecc. conduce al terrore è certamente politicamente scorretta, e Paglia da sempre mischia maliziosamente il registro dell’analisi a quello della provocazione (solitamente quando l’interlocutore pensa si tratti di provocazione in realtà è il frammento di un ragionamento calmo e lucido), rimane da spiegare il perché, e forse anche il come. Perché la sinistra ha abbandonato le sue aspirazioni di libertà per rintanarsi nel fascismo di sinistra? “Per capirlo – dice Paglia – dobbiamo innanzitutto esaminare il fallimento della sinistra nel comunicare e capire la maggioranza dell’America, il mainstream. Il documentario Berkeley in the Sixties, uscito nel 1990, mostra una serie di errori strategici fatti dalla sinistra, che, ad esempio, ha deciso di associarsi a movimenti che promuovevano il disordine civile. Questo ha portato a una reazione culturale fortissima, la quale ha contribuito al risultato delle elezioni del 1968: Richard Nixon è diventato presidente, ed è nato un enorme movimento conservatore a livello nazionale”.
Così la destra è riemersa sulla scena politica grazie alle contraddizioni interne della sinistra, mentre i liberal scottati dal l’arrivo di Nixon “si sono infiltrati nelle università”. Erano i primi anni Settanta, ricorda Paglia, “proprio quando ho cominciato a insegnare”. Questa sinistra che si è riversata nell’accademia “ha fatto pressioni enormi sugli organi di governo dei college per introdurre cambiamenti di sistema che poi sarebbero diventati la struttura base su cui è stato costruito tutto l’edificio del politicamente corretto: sono nati dipartimenti autonomi e autogestiti di studi femminili, studi afroamericani, chicano eccetera. Questi programmi ispirati dalla ‘politica dell’identità’ erano basati innanzitutto sull’ideologia, non su standard di qualità in termini di ricerca. I professori venivano assunti in quanto true believer e il dissenso da un codice approvato non era tollerato. Ero orripilata dai rigidi dogmi e dalla mediocrità intellettuale di tutto questo: oggi è la routine dell’accademia americana”.
I dipartimenti umanistici sono stati occupati dai discendenti della sinistra illuminata e liberale, non soltanto dai radicali marxisti, i quali invece occupavano inespugnabili e tuttavia isolate roccaforti universitarie. “Nei decenni – continua Paglia – i pensatori indipendenti che cercavano di fare carriera nelle humanities sono stati cacciati dalle università. Ho avuto a che fare con questo fascismo dottrinario in tutti i modi possibili. Esempio: il mio primo libro, ‘Sexual Personae’, che criticava l’ideologia femminista convenzionale, è stato rifiutato da sette editori prima di essere pubblicato nel 1990, nove anni dopo che avevo finito di scriverlo. Per fortuna quello era un momento in cui si stava discutendo del politicamente corretto sui media per via di certi codici linguistici imposti da università tipo la University of Pennsylvania. Non mi è dispiaciuto quando il magazine New York ha deciso di dedicarmi la storia di copertina, anzi se devo dire la verità l’idea della spada è stata mia”.
A quel punto, però, i dettami del politicamente corretto avevano penetrato a tal punto la cultura che i giornali di sinistra accusavano Paglia di essere una conservatrice (“accusa isterica che non aveva alcun senso: avevo appena votato per l’attivista ultraliberal Jesse Jackson alle primarie democratiche, sono ancora registrata per il Partito democratico e ho sostenuto, anche finanziariamente, il Green Party”) e la ragione della reazione convulsa, spiega, è semplice: “La sinistra è diventata una frode borghese, completamente separata dal popolo che dice di rappresentare. Tutti i maggiori esponenti della sinistra americana oggi sono ricchi giornalisti o accademici che occupano salotti elitari dove si forgia il conformismo ideologico. Questi meschini e arroganti dittatori non hanno il minimo rispetto per le visioni opposte alla loro. Il loro sentimentalismo li ha portati a credere che devono controllare e limitare la libertà di parola in democrazia per proteggere paternalisticamente la classe delle vittime permanenti di razzismo, sessismo, omofobia eccetera. La sinistra americana è un mondo artificiale prodotto dalla fantasia, un ghetto dove i liberal si parlano solo con altri liberal. Penso che la divisione politica fra destra e sinistra sia moribonda e vada abbandonata, abbiamo bisogno di categorie più flessibili”.
Il “free speech” è un concetto morto nel cuore della sinistra, ma a morire, più tragicamente e meno concettualmente, sono anche i vignettisti che disegnano Maometto per rivendicare la libertà d’espressione. In America molti giornali mainstream non hanno voluto ripubblicare le vignette di Charlie Hebdo, cosa pensa di tale scelta?
“Dato che le vignette di Charlie Hebdo erano disponibili in rete, non capisco perché i grandi giornali avrebbero dovuto ripubblicarle, esponendo i loro staff a potenziali pericoli da parte di fanatici senza scrupoli. I direttori poi possono anche indulgere in gesti nobili e simbolici, barricati come sono dietro sistemi di sicurezza molto più sofisticati di quelli della redazione di Charlie, ma di solito a pagare il prezzo più alto sono gli inservienti, le guardie, i custodi”. Un’esibizione di prudenza che non ci si aspetterebbe da un’intellettuale venuta fuori dalla sinistra, ma a ben vedere Paglia ha passato tutta la vita a combattere una élite che sbandierava la libertà come valore supremo; la femminista che combatte il dogma dell’uguaglianza dei ruoli e la lesbica che difende la differenza sessuale come base antropologica dell’occidente: “Guarda, sono una militante della libertà di espressione e un’atea, ma rispetto profondamente la religione come sistema simbolico e metafisico. Odio profondamente le becere derisioni alla religione che sono un luogo comune dell’intellighenzia occidentale secolarizzata. Ho scritto che Dio è la più grande idea che sia venuta all’umanità. Niente dimostra l’isolamento della sinistra dalla gente quanto la derisione della religione, che per la maggior parte degli uomini rimane una caratteristica vitale della loro identità. La magnifica ricerca di significato, dunque religiosa e spirituale, degli anni Sessanta si è persa nella politica delle identità dei Settanta. Le vignette di Charlie Hebdo erano crude, noiose e infantili, insultavano il credo di altre persone senza nessuna vera ragione artistica. Il massacro è stata un’atrocità barbara e la libertà di espressione deve essere garantita in tutte le democrazie moderne. Ma quale visione della vita propone il liberalismo che sia più grande delle prospettive cosmiche delle grandi religioni?”.
Michel Houellebecq nel suo libro “Sottomissione” parla esattamente dell’assenza di un’alternativa secolare all’altezza dell’immaginario religioso, che finisce per affermarsi nella vuota libertà dell’occidente perché porta un surplus di significato. Paglia non ha letto il libro dello scrittore francese né lo farà. Nessuna antipatia particolare, soltanto “non leggo romanzieri contemporanei”. E qui Paglia s’infervora: “A meno che non abbiano una diretta esperienza da zone di guerra, gli scrittori odierni non hanno nulla da dirci sulla crescente instabilità del mondo di oggi. Cosa sa esattamente Houellebecq del presente a parte quello che tutti leggiamo sui media? Per capire il presente leggo sempre testi di storia e religioni comparate. Siamo in un periodo simile a quello del tardo impero romano, quando una élite sofisticata, secolare e con uno stile di vita sessualmente libero pensava che il suo mondo fosse eterno. Il suo vuoto spirituale era la sua condanna. Quella che è arrivata dalla Palestina era una religione di passione e mistero che valorizzava il martirio. L’occidente ha perso la strada, che cos’ha da offrire oggi? Può anche essere che il vecchio conflitto con il mondo islamico sia il fattore primario nel determinare la storia nel prossimo secolo. Ma non possiamo capire cosa sta succedendo senza tornare alle nostre radici culturali e ricostruire un senso di rispetto per la religione”.
Siamo sottomessi? Sì, all'autocensura. Un dossier sull'Impero (culturale) del Bene che spinge al conformismo e umilia il pensiero, scrive Stenio Solinas, Domenica 14/02/2016 su "Il Giornale". «Il campo del bene», «la sinistra morale», il «politicamente corretto»... Intorno a quella che viene considerata «la nuova battaglia ideologica», la Revue des deux mondes ha costruito un dossier di un centinaio di pagine come cuore del suo ultimo numero (febbraio-marzo 2016). In esso, storici, sociologi, critici d'arte e letterari, giornalisti e politici si accapigliano sul tema: c'è chi elogia il «pensare bene» e chi critica i benpensanti, di destra e di sinistra, chi se la prende con il progressismo e chi ne riscrive la storia, chi ironizza sul tartufismo ipocrita del «libero pensiero» e chi nega di voler «diabolizzare» l'avversario, anche se, sottintende, con il Diavolo non si discute, lo si combatte...Vent'anni fa, in quello che resta un classico in materia, La cultura del piagnisteo, Robert Hughes si era mostrato fiducioso: «Un'abitudine tipicamente americana» l'aveva definita.
«L'appello al linguaggio politicamente corretto, se trova qualche risposta in Inghilterra, nel resto d'Europa non desta praticamente alcuna eco». Mai profezia si è rivelata più avventata, nel piccolo come nel grande, nella politica come nella cronaca, nella tragedia come nella farsa. Giorni fa, nello spiegare l'invio di militari intorno alla diga di Mosul, in Iraq, il nostro ministro della Difesa ha detto che sarebbero andati lì «per curare i feriti» e il suo collega degli Esteri ha specificato che non andavano certo «per combattere»... L'idea del soldato-infermiere e/o portatore di caramelle è singolare e richiama alla mente la neo-lingua e il bis-pensiero del George Orwell di 1984: «La libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza», mentire con purità di cuore, «negare l'esistenza della realtà obbiettiva e nello stesso tempo trarre vantaggio dalla realtà che viene negata»...D'altra parte, «la guerra è pace» è in fondo poca cosa rapportata alle dichiarazioni con cui, poco tempo fa, il rettore di un college inglese ha deciso che «il ragazzo è una ragazza» e viceversa, e quindi a scuola gonne e pantaloni sono optional: il sesso non si dà, si sceglie. Se, indeciso, lo studente/la studentessa, si presentasse nudo/nuda alla meta, ovvero in classe, non è dato sapere se frequenterà le lezioni... E naturalmente, i guerrieri della pace e/o i pacifisti della guerra, gli uomini-donne e/o le donne-uomini fanno anche loro parte di quella corrente di pensiero che ha stabilito che immigrati e emigranti erano un retaggio del passato, di quando insomma non eravamo esseri umani: «migranti» rende meglio il concetto, qualsiasi cosa con esso si voglia dire. È l'onda lunga di quella che Hughes aveva definito la Lourdes linguistica, dove il male e la sventura svanivano grazie a un tratto di penna, ma è la stessa idea di natura umana che il pensiero progressista, ovvero «il campo del bene», ovvero «il politicamente corretto» guarda con sospetto. Niente è più irritante dell'avere una identità, di uomo e di cittadino. Come spiega lo storico Jacques Julliard alla Revue des deux mondes, corrisponde «alla caricatura dell'idea sartriana che l'uomo non è ciò che è, ma ciò che fa. Alla filosofia del progresso che era quella del XIX secolo, si è sostituita la filosofia del volontarismo individuale: la decostruzione di ogni identità individuale a beneficio di una libertà pura nella quale la filosofia greca avrebbe visto una sorta di hybris, di rivolta contro la natura che gli dei ci hanno dato. Ecco il fondamento filosofico ultimo della sinistra morale». Il fatto è, dice ancora Julliard, che l'uomo è un essere storico, e ciò che c'è di più presente in lui è il suo passato. Viene anche da qui quella strana «teologia negativa» per la quale si nega la propria identità per far emergere quella dell'altro. Così, nella Francia del laicismo scolastico, puoi avere dei programmi dove l'islam diviene obbligatorio, mentre il cristianesimo è facoltativo...La «cultura dell'eufemismo» vuole le eccezioni preferite alle regole, le minoranze alle maggioranze, le orizzontalità alle verticalità, e grazie a lei la contro-verità diventa una verità. Nel «campo del bene», spiega alla Revue des deux mondes il filosofo Jean Pierre Le Goff, l'emozione e i buoni sentimenti la fanno da padrone. Non si vuole cambiare la società con la violenza, e la classe operaia ha smesso da tempo di essere oggetto di interesse. Si tratta invece di rompere con «il vecchio mondo» estirpandone le idee e i comportamenti ritenuti retrogradi, in specie nel campo dei costumi e della cultura. Non ha un modello chiavi in mano di società futura, ma una sorta «di armatura mentale: svalutazione del passato e della nostra tradizione; appello incessante al cambiamento individuale e collettivo, reiterazione dei valori generali e generosi che porteranno alla riconciliazione e alla fratellanza universali. Da un lato i buoni, dall'altro i cattivi»…Relativista, antiautoritario, edonista, moralista e sentimentale. Anche libertario? Le Goff dice di no: «Esercita una polizia del pensiero e del linguaggio di un genere nuovo. Non taglia le teste, fa pressione e ostracizza». A sentire i difensori del «politicamente corretto», per esempio il direttore di Libération Laurent Joffrin, si tratterebbe di una balla. Essere progressisti vuol dire fondarsi sui valori universali di eguaglianza e giustizia per giudicare le situazioni contemporanee. Le idee progressiste, insomma, sono politicamente corrette proprio perché progressiste, e del resto, per restare sempre in Francia, non siamo di fronte a un affollarsi di pensatori reazionari, sulla stampa come alla televisione, sempre lì a dire che sono proscritti e intanto però a scrivere e a parlare senza impedimenti e con qualche lucro: libri, programmi, rubriche eccetera? Sono loro «il vero pensiero unico»...Le cose sono un po' più complicate, e trasformare una minoranza che dissente in maggioranza che ha potere rimanda ancora al bis-pensiero e alla neo-lingua orwelliani. Per quel che si sa, nessun professore universitario viene fischiato dai suoi studenti per essersi richiamato all'ideologia dei diritti dell'uomo e a quella del progresso, e quindi l'ideologia dominante è ancora quella lì ed è ancora saldamente al suo posto. Solo che è un disco rotto, non inventa più niente e quindi più che alla confutazione del pensiero altrui si dedica alla sua delegittimazione: non dice che è falso, dice che è cattivo o che, oggettivamente, fa il gioco del cattivo, del Male, del Diavolo. Non interessa se le opinioni possono essere giuste, conta che possano essere strumentalizzate contro il «campo del bene», «l'impero del bene»... Si arriva così all'assurdo di dichiararsi per la libertà di espressione, purché però la si pensi allo stesso modo. Naturalmente, c'è anche un benpensantismo a destra, un politicamente corretto che non è solo o tanto la retorica del definirsi politicamente scorretti, una sorta di esaltazione per il rutto intellettuale scambiato per schiettezza anticonformista. È una questione più delicata. In Francia l'hanno ribattezzata «droite no frontier», ovvero il sogno della libertà economica, il capitalismo libertario e senza confini che però non dovrebbe confliggere con i valori familiari e morali. Si esalta il mercato planetario di massa, ma non si ammette che dietro c'è «l'uomo nomade», che al mercatismo del mondo corrisponde quello dell'essere umano. In questo i due benpensantismi, di sinistra e di destra, finiscono per darsi la mano: il primo sogna la libertà illimitata di agire sul naturale umano e però fa finta di rifiutare la libertà economica del mondialismo; il secondo prende per buona quest'ultima, ma finge di credere che non lo riguardi nella sua quotidianità. Entrambi tartufi, politicamente corretti.
L'ossessione politicamente corretta ammazza la cultura e l'Università. Salisburgo, tolta la laurea ad honorem a Lorenz per il suo passato nazista. La lettera di protesta dei professori di Oxford: stanno distruggendo il confronto tra le idee, scrive Luigi Mascheroni, Domenica 20/12/2015, su "Il Giornale". E l'uomo incontrò il politicamente corretto. Pochi giorni fa l'università di Salisburgo ha revocato al grande etologo austriaco Konrad Lorenz, premio Nobel per la Medicina nel 1973 (morto nel 1989), la laurea honoris causa per il suo passato nazista. Studioso di fama mondiale per gli studi sul comportamento animale - e autore di uno dei testi più straordinari mai scritto sul valore della conoscenza e dell'informazione, L'altra faccia dello specchio - Lorenz si distinse fin dagli anni Trenta per la volontà di diffondere l'ideologia hitleriana. È curioso. Il passato nazista di Lorenz è noto da sempre (nel 1937 fece domanda per una borsa di studio universitaria facendosi raccomandare da accademici viennesi come simpatizzante del nazismo, nel '38 aderì al Partito dopo aver scritto sul curriculum che aveva messo «tutta la sua vita scientifica al servizio del pensiero nazionalsocialista», e nel '42 fu spedito sul fronte orientale e fatto prigioniero dai russi). Eppure Lorenz fu ritenuto meritevole del Premio Nobel nel 1973. E l'ateneo austriaco lo insignì del titolo onorifico nel 1983. Però, oggi, lo rinnega. Perché l'abiura non è stata fatta prima? Perché ora? Ha senso? L'onda lunga del politicamente corretto, nella corrente di risacca, finisce per travolgere la cultura del passato. Ma è quella del futuro che preoccupa di più. Lo tsunami scatenato da questo pericoloso atteggiamento sociale che piega ogni opinione verso un'attenzione morbosa al rispetto degli «altri», perdendo quello per la propria intelligenza, fino a diventare autocensura, rischia di fare immensi disastri. Ieri un gruppo di professori di «Oxbridge», cioè di Oxford e Cambridge, ha scritto una lettera aperta al Daily Telegraph per denunciare il politically correct che sta uccidendo progressivamente la libertà di pensiero ed espressione nelle università britanniche, indebolendone il ruolo di spazio privilegiato del confronto delle idee. Il casus belli è la campagna indetta per rimuovere la storica statua di Cecil Rhodes, ex alunno e benefattore dell'«Oriel College» (tanti ragazzi si sono fatti strada grazie ai suoi soldi), perché considerato l'ispiratore dell'apartheid in Sudafrica. Ma le sue colpe - fa notare qualcuno - non ne cancellano i meriti a favore del progresso. Un principio che può essere applicato anche a Lorenz in campo medico. O a Heidegger in campo filosofico. O a Céline in campo letterario. Ironia della sorte, e dimostrazione della stupidità insita nel politicamente corretto: l'ex studente che ha lanciato la crociata per la rimozione della statua, il sudafricano Ntokozo Qwabe, ha potuto studiare a Oxford grazie a una borsa di studio finanziata dalla Fondazione Rhodes.L'aspetto più inquietante della faccenda è che a farsi promotori dell'autocensura basata sulla correttezza politica, ad Oxford, non sono i professori, ma gli stessi studenti. Gli autori della lettera aperta, guidati dal sociologo Fran Furedi della University of Canterbury, da parte loro accusano le università inglesi di trattare i giovani come «clienti» che pagano rette salate (che è meglio non scontentare) e non come menti da formare e aprire al confronto. A Oxford un dibattito sull'aborto è stato annullato dopo che una studentessa ha lamentato che si sarebbe sentita offesa dalla presenza nell'aula di «una persona senza utero». Che, tradotto, significa «un uomo». Un comportamento da vera papera che avrebbe di certo incuriosito un etologo come Lorenz.
La triste ferocia omo-illiberale contro i cattolici. Non capisco perché i gay che (giustamente) manifestano per i propri diritti civili siano un fenomeno progressista e il Family day una "manifestazione inaccettabile", scrive Piero Ostellino, Giovedì 25/06/2015, su "Il Giornale". In un Paese civile - e l'Italia, controriformista e intollerante, indipendentemente dallo schieramento al quale ciascuno appartiene, purtroppo, non lo è - tutti dovrebbero poter manifestare liberamente le proprie convinzioni a favore delle proprie libertà, comprese quelle sessuali, senza essere criminalizzati. Non capisco, perciò, perché i gay che (giustamente) manifestano per i propri diritti civili siano un fenomeno progressista e il Family day - per dirla con il sottosegretario Scalfarotto troppo ruffiano verso la vulgata gender - una «manifestazione inaccettabile». I diritti civili dei gay sono i diritti dell'uomo teorizzati dall'Illuminismo e sanciti dallo Stato moderno e la famiglia è il primo nucleo della socializzazione nella nostra società. Difendiamo entrambi senza farne un caso politico o elettorale. Personalmente, non sono omofobo e mi vergognerei a discriminare gli omosessuali. Ma non sono neppure orgoglioso della mia eterosessualità, come alcuni di loro - peraltro per una comprensibile reazione polemica - affermano spesso di essere della loro omosessualità. Prendo il mondo come è senza indulgere a concessioni politicamente corrette o a dannazioni moralistiche. Dico quello che penso, sperando di pensare sempre quello che dico. Per me, ciascuno gestisce la propria sessualità - che è una scelta di libertà individuale - come meglio crede. Sono liberale proprio per tale mio atteggiamento nei confronti di chiunque professi un'opinione - salvo essere intollerante verso gli intolleranti, come predicava Locke - o verso comportamenti diversi dal mio. È un dato caratteriale, prima che culturale. Punto. Non avrei partecipato alla manifestazione del Family day perché non partecipo a manifestazioni di alcun genere, ma neppure, aristotelicamente, condivido certa propaganda gender che tende a confondere ciò che la natura ha creato con le propensioni personali o, addirittura, mondane. Un maschio è un maschio e una femmina una femmina, anche se in tema di diritti civili sono ovviamente sullo stesso piano e non lo sono secondo ciò che intendiamo per «naturale». Detto, dunque, che, in un Paese civile, ciascuno ha diritto di manifestare liberamente la propria opinione, voglio, però, aggiungere, che una cosa è, per me, la piena libertà dei gay di manifestare per i propri diritti civili in quanto diritti umani universali, un'altra sono certe loro pretese di affermare la propria condizione come postulato politico, come ormai sta avvenendo in nome di una malintesa idea di politicamente corretto. Non credo di essere, come eterosessuale, meno apprezzabile di un omosessuale, alla cui condizione conservo tutta la mia comprensione e tolleranza. Ma dico che se e è condannabile l'omofobia non vedo perché non lo debba essere l'ostilità, almeno in certi ambienti, verso l'eterosessualità, che è anch'essa una scelta, oltre che, diciamo, naturale, individuale. Punto. Tira, invece, una certa aria, da noi - frutto della conformistica esasperazione del principio di correttezza politica voluta da una sinistra priva di identità culturale che individua volentieri nell'adesione «a orecchio» alle parole d'ordine del conformismo una manifestazione di identità culturale. Aria che francamente trovo, in una democrazia liberale, del tutto superflua e parecchio stupida. Ho detto che non avrei partecipato al Family day, ma aggiungo subito di trovare non meno stupidi i Gay pride e la loro richiesta di legittimazione del matrimonio fra persone dello stesse sesso. Non sono un fanatico del matrimonio fra maschio e femmina, che considero solo un fatto attinente al costume e alla tradizione. Mi sono sposato, persino in chiesa! - perché così aveva voluto la mia futura moglie, cattolica e moderatamente praticante - ma penso che passerò il resto dei miei giorni con lei non perché l'ho detto a un prete, ma perché mi ci trovo bene... Punto.
L’UBBIDIENTE DEMOCRATICO di Luigi Iannone. L’intento di questo libro è quello di misurare quanto sia marcato nelle singole vite e nei percorsi collettivi il nostro grado di assuefazione al conformismo. Viviamo un mondo in cui siamo allo stesso tempo attori e registi di una enorme sinfonia pervasa dal politicamente corretto tanto che per rintracciarne gli echi non dobbiamo fare molta fatica. Basta soffermarsi sugli accadimenti più banali, sui fatti di cronaca o di costume, sul linguaggio della politica o dei media. È sufficiente indugiare con animo libero su ognuno di essi per rendersi conto quanto sia difficile farne a meno. “Luigi Iannone, scrittore non allineato dalle frequentazioni raffinate, con questo libro ci accompagna nei sentieri poco battuti, lontani dal politicamente corretto. L’autore si propone di ricostruire un mosaico ‘differente’ tra presente, passato e futuro, per ribaltare schemi, épater le bourgeois, non facendo concessioni alla morale comune, ordinaria, canonica, maggioritaria nell’establishment e nell’immaginario collettivo progressista.” dalla prefazione di Michele De Feudis.
Alcune anticipazioni de L’ubbidiente democratico <<(…) incantatori di serpenti, teologi del buonismo e della correttezza politica sono la stragrande maggioranza e condizionano la formazione delle coscienze. Da parte loro c’è un’ossessione continua perché, in genere, il politicamente corretto si compone di fantasmi che si agitano al solo proferire delle ovvietà: provate, provate a dire che Cécile Kyenge è stata fatta ministro per il colore della sua pelle; che le quote rosa (e, in subordine, le donne capolista) sono una stupidaggine, oltre che una forma di razzismo al contrario; che al Ministero delle Pari opportunità ci va sempre una donna per fare la foglia di fico; che Rosario Crocetta fece una campagna elettorale costruita anche sul fatto che in una terra ‘arcaica’ come la Sicilia si presentava a Governatore un omosessuale, mentre delle proposte programmatiche si sapeva poco o nulla; provate a dire che i milioni gettati via per liberare ostaggi italiani in Paesi a rischio potrebbero servire per il nostro welfare e coloro i quali (o le quali) girano in zone di guerra come novelli San Francesco e pudiche Santa Chiara, potrebbero qualche volta passare anche dalle mie parti, nella zona bassa dello Stivale. Troverebbero in tante zone del Sud gli stessi problemi e tanto, ma proprio tanto, da fare per poveri e diseredati. Provate a dire io non sono Charlie Hebdo, perché per quanto rispetti la satira e mi risultino ripugnanti le azioni terroristiche e bestiali le loro idee, faccio fatica ad essere blasfemo contro qualunque Dio. Provate a dire queste e tante altre banali verità, e vi subisseranno di ingiurie. Verrete subito cacciati dal consesso civile e additati nella migliore delle ipotesi come degli intolleranti. Ma provate a dirle voi. A me manca il coraggio e non le dirò>>.
Libri. “L’Ubbidiente Democratico” di Iannone: per distinguersi dalla ridente polis dei corretti, scrive il 20 settembre 2016 Isabella Cesarini su "Barbadillo". Si spalanca con un’affermazione di Carmelo Bene, durante una puntata del Maurizio Costanzo Show – 1994, l’ultimo libro dello scrittore Luigi Iannone. Corsivo che diviene principio guida dell’opera L’Ubbidiente Democratico, nell’esergo del genio salentino: “Non me ne fotte nulla del Ruanda. E lo dico. Voi no. Non ve ne fotte ma non lo dite”. Si tratta di una dichiarazione, all’interno della quale non si trovano i caratteri di quel “corretto” che attualmente siamo tutti obbligati a indossare. Iannone si inoltra all’interno di un campo minato che pochi hanno l’ardire di calpestare. Il suo soliloquio si fa dapprima parola e poi pagina scomoda, poiché lontana da quello spazio così abusato e gremito del politicamente corretto. Una città immaginaria solo nel nome, zeppa di tante bravissime persone, altrettanti buoni propositi, tutti così realizzabili, ma solo nell’evanescenza dell’incompiuto. E guai a non pensarla come gli abitanti di questa ridente città: marchio d’infamia e foglio di via. In assenza di cotanto calore, l’apolide si ritrova rapidamente isolato, ma certamente sereno in compagnia di quelle idee ritenute così scomode. Pensieri come lampi; zampilli che attraversano anche gli autoctoni della lieta cittadella, ma restano sconvenienti e dunque la scelta ricade sulla comodità di restare distesi sul proprio personale divano del tacere. E rimanendo nel tema morbido del salotto, lo stesso scrittore confessa il suo – e non solo – incubo ricorrente. La vicenda onirica si svolge nel salotto più famoso e corretto d’Italia: la casa immacolata di Fabio Fazio. Cortese sino alla nausea, accogliente nelle ospitate degli abitanti della città ubbidiente: Fiorella Mannoia, Corrado Augias che in un altro alloggio ancor più confortevole illumina d’immenso Piergiorgio Odifreddi e Federico Rampini. Ancora un passaggio sull’agiata villa di Lilli Gruber che invita Roberto Vecchioni, Jovanotti e compagnia lealmente cantando. Un ripiegamento onirico, nello specifico meglio noto come incubo, dove i buoni e i giusti si avvicendano nelle notti turbate dello scrittore. Al risveglio, il tedio risulta meno onirico, ma ugualmente corposo. Quello di Iannone è un percorso che svela acutamente molte annose questioni e ripetuti meccanismi. Il cantante Simone Cristicchi è uno di quei casi, che da un certo punto in poi, entra di diritto nella categoria dei ripudiati dagli ubbidienti. Portando in scena lo spettacolo dal titolo Magazzino18, legato all’ostico argomento dei martiri delle foibe e il dramma degli esuli di Fiume, Istria e Dalmazia, Cristicchi si fa velocemente indegno della residenza sotto la volta dei corretti. All’esterno di un tale phanteon di purezza, lo scrittore Iannone colloca una figura leggendaria che trattiene tutti i caratteri del mito: Hiroo Onoda. Non come l’icona di un eccesso idealistico, quanto la delicata e meritevole descrizione di una creatura, che da lontano, si rivolge direttamente alla nostra voce interiore. Accade in questo piccolo uomo, un’espressione dell’onore nell’aderenza a quella meravigliosa forma di amor patrio, stimato malamente come espressione desueta e oltremodo scorretta. Diverso il discorso per i nostri Presidenti della Repubblica, tutti, da un momento storico in poi, cittadini onorari della cittadella corretta. Non più latori del potere temporale, ma cavalieri senza macchia, custodi eterni del potere spirituale. Figure immacolate con vite prive di umani buchi neri: coerenza e sacralità. Dunque papi e non capi di Stato in odor di santità e non in tanfo di muffa. Iniziato dallo storico revisionista Ernst Nolte, allo spirito critico che si fa maniera di voler scomporre e sezionare anche il più ameno dei luoghi comuni, Iannone procede come un bulldozer verso le considerazioni scolastiche. Con uno sguardo nostalgico a quella che ritiene l’ultima degna del nome di riforma, nella persona di Giovanni Gentile, opera una non poco interessante distinzione tra scuola come istituzione e studio. Non necessariamente le due cose coincidono. L’autore stesso, si dichiara tanto avverso alla scuola, quanto devoto all’apprendimento e all’approfondimento. Caratteristica che si dovrebbe considerare virtù, anche in merito al fatto di essere stata patrimonio di molti nomi altisonanti. A fronte del fatto che personalità come Croce e Prezzolini non raggiunsero l’incoronazione in pianta di alloro, attualmente presunti rapper, assolvono il ruolo di oracolo. Il reietto dell’arcadica cittadella dell’ubbidiente, raggiunge l’apoteosi della sua posizione in una più che scontata affermazione: “Chi sbaglia, paga”. Un coro di indignati si leva davanti a una dichiarazione così poco chic, qualunquista e fuori da ogni apericena. E anche se il profano proclamatore, circoscrive il suo pensiero nella premessa, che alcuno deve essere trattato in maniera deprecabile, non risulta comunque socialmente accettabile. Ed è proprio in tale incrocio tra la tolleranza a oltranza e la volontà di ridurre al minimo gli effetti di ogni dramma che le due strade si confondono, sino ad annullarsi all’unisono. Al contrario, accolti con una certa deferenza sono coloro che Montanelli sintetizzava nel termine “firmatari”. Una categoria numerosa che pone la sua firma ovunque, contro o in favore, poco importa. L’atto apprezzabile prescinde la causa e premia l’atto: l’autografo. Nell’Eden degli ubbidienti, persino il tempo è differente: l’unico imperativo è nella rapidità. Elemento imprescindibile che qualifica ogni tipo di legame sentimentale, amicale o lavorativo. Ogni traccia di sequenzialità, qualsiasi tratto di gradualità, necessari alla civiltà, vengono prontamente inghiottiti dalla velocità che svilisce il naturale processo di crescita identitaria e comunitaria. L’autore ci porta, non privo di un tono amaro, finanche all’interno delle rovine di Pompei. Non vi è modo di uscire da un’impasse dove si gioca al rimbalzo di responsabilità tra ministri, soprintendenti, sotto, di lato o ad angolo, se non mediante un paradosso. Singolarità, che si dispiega nella sopravvalutazione di alcuna arte contemporanea, a scapito di meraviglie antichissime e intramontabili. Alla bellezza che naturalmente affascina, l’esempio in un’emozione provata di fronte alla grandezza di un Caravaggio, si preferisce cercare il significato ancestrale di un ortaggio steso a terra in qualche galleria d’arte nel mondo. Allora, il trionfo appartiene a quel lato deteriorabile, che si elegge a tutto, con le virgolette di occasione intorno alla parola arte. Nell’incontaminato mondo degli ubbidienti, lo scrittore ci guida altresì, nella spiegazione dell’uso di una certa tipologia di linguaggio. Il mansueto democratico adopera una lingua che si esaurisce tutta nel trionfo della premessa. Un’epifania che accoglie qualunque argomento, puntualmente preceduto da un mantra, una sorta di nenia: “premesso che non ho nulla contro…”. Un noiosissimo preambolo che scagiona preventivamente da qualsiasi accusa, eccezion fatta per quella di viltà. Poiché non vi è mai l’ardire e/o semplicemente l’onestà di dire ciò che intimamente si pensa. Troppo rischioso, eccessivamente inelegante e dannoso sino alla cacciata dal borghetto della compostezza. L’opera di Luigi Iannone figura un invito alla riflessione, all’ascolto di una voce dissenziente come arma di difesa dallo smottamento di informazioni che quotidianamente ci cade indosso. Un sovraccarico di notizie, dove difficilmente si trova la bussola per l’orientamento. Se risulta poco agevole farlo nelle strade, almeno si provi un tipo di ribellione, forse più adatta alla nostra società; insorgere verso quella diffusa e prepotente forma di conformismo che si fregia nel vezzo del mascheramento anticonformista. Lo spirito libero all’interno di una cittadina tutta edificata sulla compostezza democratica, tende ad apparire alla stessa maniera dello zio pazzo in Amarcord di Federico Fellini, nella splendida interpretazione di Ciccio Ingrassia. Iannone ci dona un sapiente parallelo cinematografico per descrivere la considerazione che abbraccia coloro che provano a non appiattirsi sulla melassa perbenista: i matti del paese. E se l’autore apre in Carmelo Bene, chi scrive si permette – solo dopo aver sollecitato la lettura di questo pungente pamphlet – di usarlo in conclusione da un estratto del Maurizio Costanzo Show – 1995: “Qualcuno ed era davvero anche lui un genio, ha detto che la democrazia è il popolo che prende a calci in culo il popolo, su mandato del popolo”.
Ecco come distruggere il politicamente corretto, scrive l'1/11/2016 “Il Giornale”. Ci voleva qualcuno che lo scrivesse e Luigi Iannone lo ha fatto: “provate a dire banali verità, e vi subisseranno di ingiurie. Verrete subito cacciati dal consesso civile e additati nella migliore delle ipotesi come degli intolleranti”. L’idea del giornalista e scrittore, frequentatore abituale del pensiero di Jünger e amico personale del defunto Ernst Nolte, è balenata a molti, ma ci voleva il suo libro per esprimerla appieno. Il titolo è L’ubbidiente democratico. Come la civiltà occidentale è diventata preda del politicamente corretto (Idrovolante Edizioni, pp. 138, Euro 13) e spiega come “incantatori di serpenti, teologi del buonismo e della correttezza politica sono la stragrande maggioranza e condizionano la formazione delle coscienze”. E via con esempi eclatanti su cose che tutti sanno ma è meglio tacere, per non rischiare gli insulti di cui sopra. Quindi, vietato dire che la Kyenge è diventata ministro grazie al colore della sua pelle, che le quote rose sono una forma di sessismo alla rovescia, un contentino da dare alle donne, un po’ come piazzare un filo di perle su un severo gessato da ministro. Guai a dire che certi delinquono, perché Caino non si tocca e se Abele se la passa male sono fatti suoi: i criminali vanno capiti. Guai a toccare il capo dello Stato, che pare il Santo Patrono del politicamente corretto. Che di questo si tratta, e basta. Di una dittatura soft, che ha messo da una parte i buoni e gli intelligenti – ossia gli ubbidienti al credo unico imposto dalla vulgata radical chic – e dall’altra i cafoni, gli ignoranti, gli imbecilli, i puzzoni. Ossia, quelli che provano ancora a ragionare con la propria testa e non si lasciano influenzare. L’importante, però, è tacere. Per non fare la fine degli abitanti di Gorino i quali, non avendo voluto gli immigrati, sono i mostri del momento. Quelli di Capalbio, che pure non li hanno voluti, invece se la sono cavata. Chissà perché… ma questa, in fondo, è tutta un’altra storia.
Questo libro è un catalogo delle opinioni vietate dal politicamente corretto. Pensate di essere liberi di esprimervi come vi pare? Provate a esporre tesi anticonformiste durante una cena, scrive Alessandro Gnocchi, Domenica 29/05/2016, su "Il Giornale". La libertà d'espressione è meravigliosa e noi tutti siamo convinti di poterla esercitare. Fino a quando scopriamo che le cose non stanno esattamente così. Infatti, per chi professa certe idee, non incendiarie ma comunque non allineate al pensiero unico, c'è la riprovazione del mondo culturale, che si esprime in due modi: il silenzio e l'insulto delegittimante. In libreria domina ormai il Saggio Unico, figlio del Pensiero Unico. È solare: su alcuni temi si può parlare in un solo modo, quello prescritto dal politicamente corretto. L'islam? È una religione di pace. Il libero mercato? Il vero responsabile di tutte le ingiustizie del mondo. L'accoglienza indiscriminata degli immigrati? Un dovere morale e una necessità per sostenere l'economia del Vecchio continente. A proposito, l'Europa? Una magnifica istituzione senza la quale saremmo ancora più poveri e perpetuamente in guerra come nel XX secolo. L'appartenenza al genere maschile o femminile? Uno stereotipo culturale da superare. Avere figli? Un diritto. L'adozione alla coppie omosessuali? Un diritto. L'eutanasia? Un diritto. Tutti abbiamo diritto a tutto. Abbiamo perfino diritto a dire che le cose elencate, o almeno alcune di esse, non ci trovano d'accordo. Ma se lo esercitiamo, ecco il nastro adesivo sulla bocca per impedirci di parlare e le accuse infamanti: ignorante, xenofobo, razzista, islamofobo, omofobo. Non se ne potrebbe almeno parlare, confrontarsi, dibattere? In teoria, sì. In pratica, no. Se non ci credete, guardate lo spazio occupato dalle idee anticonformiste nelle librerie, nei programmi televisivi, nei festival, nei convegni. È prossimo allo zero. Per questo, il libro di Camillo Langone "Pensieri del lambrusco. Contro l'invasione" (Marsilio, pagg. 180, euro 16; in libreria dal 3 giugno) è un'autentica rarità. L'autore, firma de il Giornale, mette in fila tutte le ideologie che considera rovinose per se stesso e per l'Italia. Ne esce un catalogo delle opinioni vietate dal politicamente corretto. Langone, spesso partendo dalla notizia di cronaca, a volte di cronaca culturale, colpisce senza paura proprio nei punti più controversi, e ci mostra che quando un'idea, perfino buona, viene trasformata in ideologia, produce disastri. Nel mirino ci sono i nuovi -ismi: l'ambientalismo, l'americanismo, l'animalismo, l'estinzionismo, l'esibizionismo, l'europeismo, l'immigrazionismo, l'islamismo... Pagina dopo pagina, gli intellettuali che vanno per la maggiore sono ferocemente dissacrati (vedi il teologo-non teologo Vito Mancuso alla voce ateismo). Al loro posto, autori che insegnano a pensare: Guido Ceronetti, Sergio Quinzio, Michel Houellebecq e altri. Cosa c'entra il lambrusco del titolo? Di fronte alla liquidazione dell'Italia, meglio rifugiarsi «nell'unico vero vino autoctono italiano» invece di ricorrere a «dozzinali vitigni alloctoni». Già, perché alla fine, il libro di Langone si e ci interroga su cosa significhi essere italiani ai nostri giorni. Per i nichilisti, nulla. Ma Langone non è un nichilista.
Dalle bandiere rosse ai dogmi del politicamente corretto, scrive Carlo Lottieri, Domenica 23/10/2016, su "Il Giornale". Quando crollò il muro di Berlino, in molti furono portati a pensare che l'età del socialismo fosse alle spalle e che il materialismo storico fosse destinato a finire nella spazzatura della storia. In parte, le cose sono andate così, se si considera che l'Unione sovietica si è dissolta velocemente, che la Cina è cambiata in profondità, che ormai gli ultimi fortini di quell'ideologia sono nelle mani di fratelli o nipoti di quelli che un tempo furono leader carismatici: da Fidel Castro a Kim Il Sung. Eppure il comunismo resta onnipresente, dato che larga parte della cultura contemporanea è pervasa da quella visione del mondo che ancora oggi esercita un potente influsso sulle categorie che utilizziamo per interpretare la realtà: sia nell'establishment di sinistra, sia nel populismo di destra. È sufficiente pensare al trionfo dello stupidario ecologista. È sicuramente vero che si farebbe fatica a trovare, nel pensiero di Karl Marx (proiettato verso il futuro e volto a esaltare il progresso industriale) una qualche legittimazione dell'ambientalismo dominante e delle nuove parole d'ordine: animalismo, coltivazione biologica oppure «chilometro zero». Eppure il legame tra il vecchio socialismo ottocentesco e questa nuova sensibilità è chiaro, poiché in entrambi i casi tutto si regge sulla condanna della società di mercato. Anche autori che oggi - a ragione - vengono considerati «di sinistra» (da John Maynard Keynes a John Rawls), definirono le proprie tesi alla ricerca di un'alternativa moderata e in qualche modo ai loro occhi «ragionevole» tra la pianificazione e il laissez-faire, tra l'egualitarismo assoluto e l'ineguale distribuzione conseguente alla lotteria naturale e allo svilupparsi degli scambi. Oggi il marxismo non ha più il peso che aveva quando Bertolt Brecht, Herbert Marcuse o Louis Althusser dominavano la scena culturale, ma le tradizioni ora egemoni si sono definite nel confronto con quelle idee e muovendo dall'esigenza di dare loro una risposta alternativa. Non c'è quindi da stupirsi se il dibattito pubblico e spesso la stessa legislazione tendono a considerare «ineguale» (e di conseguenza ingiusto) ogni rapporto contrattuale che abbia luogo tra soggetti che hanno posizioni economiche differenti. Il nostro sistema normativo - che prevede distinti diritti per i proprietari e per gli inquilini, per i datori di lavoro e per i dipendenti, per i produttori e i consumatori, ecc. - deriva il suo carattere fortemente discriminatorio dalla tesi secondo cui un dominio dell'uomo sull'uomo non si avrebbe solo quando qualcuno aggredisce o minaccia qualcun altro, ma anche quando due persone liberamente negoziano. Siamo tutti in una certa misura comunisti perché siamo tutti imbevuti dell'idea che una società dovrebbe eliminare le diversità, soddisfare ogni bisogno, innalzare i nostri gusti e allontanarci dall'egoismo, impedire che taluno guadagni miliardi e altri siano indigenti e senza lavoro. Non avremmo mai avuto alcuna legittimazione della coercizione statale, quando è strumentale a modificare l'ordine sociale emergente dalla storia e dalle interazioni sociali, senza il successo del pensiero socialista e senza un intero secolo di riflessione «scolastica» (con eresie, glosse e innesti di ogni tipo) attorno alle opere di Marx. Se il nazismo è ovunque condannato senza «se» e senza «ma», ben pochi esprimono la medesima riprovazione nei riguardi del socialismo: che pure ha causato un numero di morti innocenti perfino superiore. E questo si deve al fatto che le posizioni culturali mainstream sono in larga misura una revisione e una rilettura di temi di ascendenza socialista. S'intende certamente seguire altre strade, ma non è detto che gli obiettivi siano poi tanto diversi. Un dato da tenere ben presente è che se il marxismo è stato certamente una teoria a tutto tondo, sul piano storico-sociale esso è stato anche il catalizzatore di spinte tra loro diverse, ma accomunate dal voler esprimere un rifiuto radicale della realtà, identificata - a torto o a ragione - con la società capitalistica. Con argomenti variamente comunitaristi, egualitaristi, ecologisti, pseudocristiani e altro ancora, per molti anni gli spiriti rivoluzionari si sono ritrovati sotto le bandiere rosse essenzialmente per esprimere il più radicale rigetto delle libertà di mercato e di ogni ipotesi di un ordine economico-sociale senza una direzione prefissata. E se oggi, come sottolinea spesso Olivier Roy, circa un quarto dei terroristi islamisti francesi non ha genitori musulmani né ha radici nei Paesi arabi, questo probabilmente si deve al fatto che oggi il fondamentalismo incanala, in vari casi, un'analoga volontà nichilistica di distruggere ogni cosa. Le stesse librerie ci dicono, anche semplicemente osservando le copertine dei volumi in commercio, quanto il comunismo sia vivo e vegeto. In effetti, il successo di autori come Thomas Piketty, Naomi Klein, Thomas Pogge o Slavoj iek (solo per citare qualche nome à la page) può essere compreso unicamente a partire da un dato elementare: e cioè dal riconoscimento che l'Occidente è diviso al proprio interno da posizioni diverse, ma quasi ogni famiglia culturale si concepisce quale profondamente avversa alla proprietà, al libero scambio, all'anarchia dell'ordine spontaneo. Quando si consideri pure il «politicamente corretto», con il suo corredo di censure e proibizioni, è chiaro come si tratti in larga misura di una logica strettamente connessa a quel risentimento che ha alimentato, sin dall'inizio, l'egualitarismo socialista e la sua rivolta contro la natura. È chiaro che oggi nessuno si propone di spedire i dissidenti in Siberia e di disegnare piani quinquennali che governino dall'alto l'intera economia, ma il reticolato delle regole approvate dalle assemblee parlamentari delinea un quadro complessivo quanto mai illiberale: in cui si discrimina ogni libera scelta estranea al luogocomunismo e si pongono le basi per una società sempre più servile, assoggettata, priva di ogni capacità d'iniziativa. Carlo Lottieri
Bret Easton Ellis choc: il politicamente corretto uccide la nostra cultura. Lo scrittore americano e il critico Alex Kazami contro movimenti antirazzisti e nazi-femministe, scrivono Andrea Mancia e Simone Bressan, Martedì 4/10/2016, "Il Giornale". "Che diavolo è successo agli MTV Music Awards? Niente di inquietante o scioccante, nessuna Miley Cyrus strafatta che insulta Nicki Minaj sul palco, nessun tipo di provocazione e dunque nessun attimo di divertimento. Tutti invece, vanno d'amore e d'accordo nel celebrare quella falsa inclusività politicamente corretta che ormai è diventata terribilmente noiosa e che, probabilmente, è la causa del vertiginoso crollo nel numero di telespettatori che ha seguito lo show". A Bret Easton Ellis, lo scrittore americano autore (tra l'altro) di Less Than Zero e American Psycho, l'edizione 2016 dei Video Music Awards, organizzata lo scorso 29 agosto da MTV al Madison Square Garden di New York, proprio non è piaciuta. E durante l'ultima puntata del suo podcast ha letto integralmente un monologo del giovanissimo scrittore (e critico-provocatore) canadese Alex Kazami che spara a zero contro gli eccessi politically correct di una cerimonia ormai diventata un gigantesco spot per «Black Lives Matter», il movimento finanziato anche da George Soros che accusa le forze di polizia statunitensi di essere intrinsecamente razziste nei confronti della comunità afro-americana. Kazami, che non incarna esattamente lo stereotipo del vecchio trombone della destra conservatrice, visto che è un millennial di 22 anni dichiaratamente gay, è ancora più feroce di Ellis. "Il Black Lives Matter Sabbath che è stato rappresentato ai Video Music Awards 2016 rappresenta la fine della cultura per come la conosciamo. L'intero show è stato un'ode alla narrativa liberal secondo la quale, visto che i bianchi sono tutti cattivi, almeno una persona su due tra quelle inquadrate dalla telecamera deve essere una donna di colore, perché siamo costantemente angosciati dalla necessità di non terrorizzare una generazione di spettatori cresciuta con una dieta di spazi di sicurezza, auto-vittimizzazione e trigger warning (l'avvertimento che segnala la possibilità che un testo possa essere offensivo per qualcuno, ndr)". Una scelta, secondo Kazami, totalmente ipocrita e dettata soltanto da strategie commerciali: "MTV non vuole esporre il suo pubblico a un immaginario pop pericoloso, per paura di offendere qualcuno, a meno che questo immaginario non ricada sotto il mantello protettivo del politicamente corretto. Ma la musica pop deve essere offensiva, non politicamente corretta". "La maschera imposta allo show continua il giovane scrittore canadese è stata un melenso tentativo di dipingere ogni artista sul palco come un campione di bontà, indulgendo continuamente in riferimenti al movimento Black Lives Matter, alla brutalità della polizia, a Martin Luther King. Questo era il copione, il dogma a cui tutti hanno obbedito. Ed era palpabile il terrore che qualcuno potesse esprimere un'opinione contraria al dogma. È proprio questo che sta uccidendo la nostra cultura: la paura di essere puniti per non aver aderito integralmente a questa ideologia collettiva del politicamente corretto". Il principale obiettivo delle critiche di Ellis e Kazami, con ogni probabilità, è stata l'interminabile performance di Beyoncé (vincitrice addirittura di otto premi), che nella sua coreografia ha esplicitamente fatto riferimento agli afro-americani uccisi dalla polizia (con i ballerini che crollavano al suolo dopo essere stati colpiti da una luce rossa) e che sul red carpet ha sfilato insieme alle madri di Mike Brown, Trayvon Martin ed Eric Garner, i tre uomini di colore che con la loro morte sono diventati il simbolo di «Black Lives Matter» (e una scusa per la guerriglia urbana scatenata dal movimento in molte città americane). Ellis, in ogni caso, non è nuovo alle polemiche sugli eccessi del politicamente corretto e dei social justice warriors. Ad agosto, sempre sul suo podcast, se l'era presa con le "femministe isteriche" e "naziste del linguaggio" che avevano attaccato il critico musicale del Los Angeles Weekly, Art Tavana, per un presunto articolo "misogino" sulla cantante (e modella) Sky Ferreira. Per Ellis, queste femministe di nuova generazione sono diventate "nonnine aggrappate alle proprie collane di perle, terrorizzate dal fatto che qualcuno possa pensare qualcosa, su un qualsiasi argomento, che non sia l'esatta replica delle loro opinioni". "Queste piagnucolose narcisiste afferma Ellis utilizzano l'altissimo tono morale tipico dei social justice warriors, sempre fuori scala rispetto alle cose per cui si offendono. E si stanno trasformando in piccole naziste del linguaggio, con le loro regole di indignazione prefabbricata, invocando la censura ogni volta che qualcuno scrive, o dice, qualcosa che non aderisce completamente alla loro visione dell'universo". "Questa sinistra liberal che si auto-proclama femminista conclude l'autore di American Psycho è diventata così iper-sensibile da essere ormai entrata in una fase culturale di autoritarismo. È qualcosa di così regressivo e lugubre da assomigliare terribilmente a un film di fantascienza distopica, ambientato in un mondo in cui è permesso un solo modo per esprimersi, in un clima di castrazione collettiva che avvolge tutta la società".
Pro porno e pro prostituzione: ecco il femminismo di Annalisa Chirico in "Siamo tutti puttane", scrive “Libero Quotidiano”. "Siamo tutti puttane". Un titolo spiazzante quello che Annalisa Chirico, giornalista e compagna di Chicco Testa, politico di sinistra e dirigente industriale italiano, ha deciso di dare al suo ultimo libro. Ma già se si legge il sotto titolo ci si potrebbe fare un idea del concetto che sta alla base della lettura: "Contro la dittatura del politicamente corretto". Un libro che ha come bersaglio i perbenisti di sinistra e le femministe alla "Se non ora quando". La Chirico rivendica il sacrosanto diritto di farsi strada nella vita come ognuno può e vuole, e quindi, anche diventando una puttana. Un femminismo pro sesso, pro porno e pro prostituzione, sia per le donne sia per i maschi. Un dibattito a suo avviso che "ha diviso il Paese tra un popolo di sinistra moralmente irreprensibile e uno di destra, gaglioffo e sciocco". In un'intervista a Formiche.net del 7 maggio, la stessa giornalista alla domanda "È Berlusconi ad averla ispirata?", non risponde esplicitamente, ma il riferimento è chiaro. "Ho seguito da cronista il processo Ruby - afferma Chirico - dove nel tribunale di Milano, non di Riad o della Kabul talebana, trentatré ragazze sono state vivisezionate nella loro vita privata in qualità di semplici testimoni, senza alcun capo di imputazione a loro carico. Quando una democrazia smette di distinguere tra peccato e reato, si getta al macero l'abc della civiltà giuridica". Dunque nulla di male. Le famose "Olgettine", da Via Olgettina, le ragazze indagate dalla Procura di Milano per il caso Ruby, non hanno, a suo parere, la colpa di aver "conosciuto Silvio Berlusconi, il tycoon d'Italia, il capo di un impero mediatico, il presidente del Consiglio italiano". Un'occasione ghiotta di farsi notare e farsi apprezzare, per entrare nel mondo dell'apparire, della tv e dell'estetica da vendere. "E' stato un pornoprocesso, un rito a elevato tasso moraleggiante, oltre che erotico". Poi dal porno si passa all'erotico e a quelle foto di Paola Bacchiddu, il capo comunicazione della lista L’Altra Europa con Tsipras, che qualche giorno fa ha pubblicato una foto in bikini suscitando clamore. "Mi è sembrata la trovata goliardica di una ragazza intraprendente. In Italia ne sono nate le solite polemiche perché va di moda l’idea boldriniana che il corpo vada nascosto in un sudario di pietra. Per cui i concorsi di bellezza che si fanno in tutto il mondo da noi andrebbero proibiti. La donna invece è un soggetto che decide come usare il proprio corpo, sono le pseudofemministe a rappresentarla come un oggetto". Poi attacca Barbara Spinelli, candida la paladina delle donne e della guerra contro la mercificazione del loro corpo per Tsipras. "E' un esemplare del livello di oscurantismo che caratterizza il femminismo nel nostro Paese. Sono le donne che strumentalizzano le altre donne. La campagna talebanfemminista 'Se non ora quando' aveva l’unico obiettivo politico di colpire l’allora presidente Berlusconi, ci ha fatto credere che il suo indomito fallo fosse il principale assillo delle donne italiane". Infine la frecciatina a Renzi incalzata dalla giornalista di Formiche.net che gli chiede se la convince "il femminismo alla Renzi": "Non esiste un femminismo alla Renzi - ha risposto la Chirico - ma una strategia comunicativa renziana. Il premier ha capito che la sinistra del presunto primato morale era perdente. Perciò si è abilmente smarcato dalla linea dei suoi predecessori. E li ha rottamati".
Annalisa Chirico fra femminismo e provocazione, scrive Benedetto Marchese su “Città della Spezia”. L'autrice racconta a Cds il suo libro "Siamo tutti puttane" presentato anche nella rassegna "I grandi temi" di Bocca di Magra: "Quote rosa? Solo se c'è competenza". “Provocare significa sciogliere il proprio pensiero e lasciarlo libero di muoversi e concepire qualcosa per noi e per gli altri. Nella società di oggi c'è una cautela estrema che frena tutto questo”. Ospite nel salotto di Bocca di Magra di Annamaria Bernardini De Pace e della sua rassegna letteraria dedicata quest'anno proprio alla provocazione, la giornalista e saggista Annalisa Chirico sintetizza così il filo conduttore della manifestazione nella quale ha presentato il ultimo libro “Siamo tutti puttane” (sottotitolo “Contro la dittatura del politicamente corretto”), senza distinzioni di genere e ispirato dal Processo Ruby. “Seguendo le udienze – racconta a Cds la collaboratrice di Panorama e Il Foglio – mi sono resa conto che l'imputato non era più Berlusconi ma quelle ragazze le cui vita privata veniva vivisezionata e giudica di fronte al grande moralizzatore pubblico. Era diventato un processo al senso del pudore e il codice morale si stava sostituendo a quello penale, si parlava solo di gusti sessuali. Il mio libro – prosegue – è invece un grido di rivolta contro il moralismo e il politicamente corretto: ognuno ha il diritto di scegliersi la vita che vuole, e di lavorare per realizzare i propri sogni, anche rischiando di farsi del male”. Edito da Marsilio e pubblicato dopo i precedenti “Condannati preventivi” e “Segreto di Stato – il caso Nicolò Pollari”, il libro delinea anche il pensiero dell'autrice sul femminismo e il ruolo della donna nella nostra società. “Ho concluso il mio dottorato con uno studio sul corpo della donna – prosegue – e mi ritengo una femminista pro sesso, pro porno e pro prostituzione: ciascuna di noi può sentirsi Madonna o puttana ma non deve sottostare a delle regole. Sono critica verso le Taleban-femministe che hanno fatto di quel processo solo una battaglia politica contro Berlusconi per poi sparire subito dopo. Negli anni Settanta le femministe scendevano in piazza al fianco delle prostitute, oggi troviamo una parte di quella sinistra sui palchi a puntare il dito contro altre donne che ritengono degradate e che discriminano. Un movimento che è diventato braccio armato della politica e che è stato respinto, sempre nella stessa area, da coloro che quarant'anni fa avevano lottato per i diritti delle donne. Si sono occupate delle “Olgettine” ma non delle arabe o italiane che vivono segregate. Un problema che riguarda tutto l'Occidente che non si preoccupa di tutelare ad esempio le eroine di Kobane che vengono lasciate sole a combattere contro l'Isis”. Chirico, origini pugliesi e romana d'adozione, non si sottrae poi ad un commento sull'episodio avvenuto pochi giorni fa su una spiaggia di Fiumaretta con vittima una giovane ripresa con il compagno in un video che ha girato sugli smartphone di mezza Val di Magra ed è finito anche sui giornali. “Dobbiamo capire che le giovani d'oggi sono molto più disinibite e se da un lato queste cose possono accadere normalmente, dall'altro dovrebbe esserci un limite da parte di chi le pubblica o le condivide”. Attratta fin da piccola dalla politica e con un passato fra i Radicali di Pannella l'autrice rivela invece una distanza convinta dalla militanza: “Ne sono stata interessata, ora la seguo solo per mestiere, ho votato poche volte e mi sono astenuta sempre senza pentimento. Le quote rosa in politica? Scegliere donne competenti è importante – conclude – farlo solo per rispettare la parità è del tutto inutile”.
Chi è Annalisa Chirico, la paladina del femminismo liberale. La giovane scrittrice e opinionista ha pubblicato un libro dal titolo esplicito, “Siamo tutti puttane”, nel quale polemizza contro il femminismo radical-chic di certa sinistra e invoca la libertà per un nuovo femminismo, scrive I.K su "Gossip di Palazzo" venerdì 23 maggio 2014. 28 anni dalla penna tagliente, aspetto piacente che male non fa, autodefinitasi “liberale, tortoriana, radicale” sulle pagine delle sue biografie online, sul proprio sito personale e sul blog di Panorama "Politicamente scorretta" che gestisce personalmente, dottoranda in Political Theory a alla Luiss Guido Carli di Roma: Annalisa Chirico è una delle giovanissime opinion-maker della carta stampata e dell’editoria digitale che stanno mettendo a dura prova le giornaliste di una volta grazie ad una buona dose di sfacciataggine e femminile tracotanza. Sulla sua pagina Facebook ci sono moltissime foto con tutti i sostenitori e acquirenti famosi del suo nuovo libro, …La giovane scrittrice e fidanzata di Chicco Testa si scaglia contro le femministe post sessantottine. Autrice di due libri, uno contro l’abuso della carcerazione preventiva “Condannati preventivi” e l’altro sul caso Niccolò Pollari e i segreti di stato tra Usa e Italia, Annalisa Chirico è in questi giorni sulla bocca della politica e del costume italiano per la pubblicazione di un terzo libro dal titolo decisamente esplicito di “Siamo tutti puttane” nel quale, come ha spiegato in un’intervista a Dagospia, rivendica il diritto di ciascuno di farsi strada come meglio può senza dover per forza incappare in trancianti giudizi operati sulla base della morale altrui. Nello specifico mirino del libro della Chirico, lanciato in pompa magna anche grazie all’appoggio una campagna mediatica via Twitter (#SiamoTuttiPuttane è l'hashtag dedicato) con personaggi famosi quali cantanti, giornalisti provocatori come Giuseppe Cruciani e svariate partecipazioni televisive, sono finite le cosiddette taleban-femministe dell’intellighenzia di sinistra, guidate da Lorella Zanardo di Se non ora quando e dalla presidente della Camera Laura Boldrini: il libro, ha spiegato Annalisa Chirico, è nato proprio dall’indignazione che le montava dentro durante il processo alle olgettine, le ragazze prezzolate da Berlusconi per i famosi festini nella villa di Arcore gestiti da Nicole Minetti. A ogni udienza m'incazzavo di più: quelle ragazze, chiamate in qualità di testimoni, in realtà erano imputate, e non per reati del codice penale, ma per i loro costumi privati. Quelle toghe stavano violando i diritti di ragazze che avevano avuto la colpa estrema di accarezzare il potere cercando di inseguire i loro sogni. Embé? Chi siamo noi per giudicare i sogni degli altri? Le taleban-femministe giudicano. Annalisa Chirico ne ha per tutti, specialmente per quello che lei chiama "il boldrinismo" della politica: Io sono femminista, ma il loro è un femminismo perbenista che celebra il modello di donna madre e moglie. Hanno restaurato il tribunale della pubblica morale. Il berlusconismo non t'impone come vivere. Il pericolo del boldrinismo invece è che vuole importi come vivere. E in merito alla sua relazione con Chicco Testa, sessantaduenne ex presidente di Enel e giornalista su molte testate italiane? Annalisa Chirico si riconferma sprezzante del giudizio altrui: Non è l’uomo più vecchio con cui sono stata.
GLI ECCESSI DEL POLITICAMENTE CORRETTO.
Cicciottelle non di può dire, ma panciuti sì, scrive Giordano Tedoldi su “Libero Quotidiano" il 9 agosto 2016. Che la faccenda del politicamente corretto sia del tutto fuori controllo, e abbia prodotto l' esatto opposto di ciò che voleva prevenire, e cioè livore, aggressività, pretesto per giudicare sommariamente il «nemico» e inchiodarlo a una parola diventata oscuramente impronunciabile, lo dice la furibonda polemica sulle tre azzurre del tiro con l' arco, bravissime, ma che non sono riuscite a guadagnare il podio alle Olimpiadi di Rio, cedendo alle russe, e le cui gesta il Resto del Carlino, nelle sue pagine sportive, ha raccontato con il titolo «il trio delle cicciottelle sfiora il miracolo olimpico». Ora, poiché viviamo al tempo della pussy generation, come dice Clint Eastwood che ha coniato l' espressione in una sua recente intervista a Esquire (scandalizzando tutti perché, sai che scoperta, il vecchio Clint mostrava interesse per Donald Trump, ma dai, e noi che pensavamo fosse kennediano tendenza Veltroni…) cioè «la generazione delle femminucce» - e non staremo a spiegare o a difendere l' uso dell' espressione, attendendo pazientemente i soliti geni, che ci diranno che offende le donne anzi «il corpo delle donne» - allora ne consegue che «cicciottelle», riferito alle tiratrici olimpiche, è «una vergogna», e che i giornalisti che hanno così titolato sono responsabili della «morte di una professione», e che «sono da pestare» perché «fanno schifo». Questi commenti, così civili, indice di elevato pensiero e nobili sentimenti, sono alcuni nella nauseante marea di analoghi insulti, partoriti dagli indignati del politicamente corretto, presi a casaccio dalla rete, che ieri ne traboccava. E tutto perché l'anonimo giornalista - di cui ora la rete pretende il nome, ché si deve pubblicamente umiliarlo, e pretenderne scuse solenni, e casomai ottenerne anche la radiazione dall' ordine professionale, provvedimento che gli indignati del web sollecitano ogni ora per gli episodi più vari e contraddittori - ha detto che tre atlete sono «cicciottelle». Occorre rammentare alla scatenata pussy generation, quella per la quale, come dice Clint, «questo non si può fare, quello non si può dire, quell' altro nemmeno» (tutti divieti stabiliti da loro, beninteso) che quattro anni fa la rete non si scatenò affatto, per i «Robin Hood con la pancetta», come vennero chiamati dai giornali i tre arcieri italiani, non propriamente smilzi, che vinsero l'oro alle Olimpiadi di Londra. Allora, il fatto che i nostri tiratori fossero «cicciottelli», com' è del resto abbastanza normale in una disciplina dove non è richiesto il peso forma, semmai occhi di lince e grande capacità di concentrazione, non destò scandalo alcuno. Soprattutto non destò scandalo per gli arcieri, così come nulla hanno commentato, stavolta, le tiratrici italiane. Allora, nessun giornalista fece schifo, né venne indicato per essere pestato, né sotterrò la professione, né venne minacciato di radiazione, né se ne pretese con voce stentorea il nome come fosse un nazista imboscato da decenni. Come mai? Ma perché erano tre uomini. La pussy generation ha questa idea che esistano delle categorie di «diversi», più sensibili, più vulnerabili, che vanno curati come piantine stentate, anche malgrado i propositi e le volontà delle stesse presunte «vittime». Sappiamo quali siano tali categorie: gli omosessuali, i neri, i «migranti», le donne, in parte anche gli islamici. Di questi non si può che dire e scrivere ogni bene. Qualunque epiteto dal significato meno che esaltante, sia anche l'infantile «cicciottello» (ma seriamente: chi può dirsi offeso, essendo adulto, perché viene definito così?) mette subito colui che lo usa nei pasticci. E nel dire nei «pasticci» siamo politicamente corretti, perché ciò che in realtà accade è che viene coperto da una valanga di merda, escreta da loro, i buoni, i giusti, i politicamente corretti, la parte avanzata della società, insomma, la pussy generation, che si gonfia di boria grazie all' esibizionistica amplificazione e risonanza dei social. Fortunatamente, c' è ancora chi non ha perso il senno, e per criticare un titolo, criticabilissimo, ci mancherebbe, ricorre all' ironia, sottolineando che ci vuol coraggio a definire «cicciotelle» tre donne che sanno scoccare frecce con tanta precisione. Ma la media delle reazioni è l'insulto, la messa alla berlina, la gogna virale, tutte procedure che il politicamente corretto usa immancabilmente. E dunque ci chiediamo: come mai un esercizio critico così barbarico, che usa sempre questi metodi di aggressione, il vile tutti contro uno, viene tollerato? Perché accettiamo che il controllo sul linguaggio, nella discussione pubblica, venga affidato all' isteria del «popolo della rete» in quotidiana caccia di un capro espiatorio? Il quale popolo, altro che ricorrere a un «cicciottello», quando parte all' attacco, pretende la testa del nemico. Giordano Tedoldi.
Le "cicciottelle" divorano il direttore. Ecco come l'hanno rovinato, scrive “Libero Quotidiano” il 9 agosto 2016. Ha vinto il politicamente corretto, ha perso il buonsenso a favore della boria che tracimava dai profili Facebook per tutto ieri, dopo che era stato messo in giro il titolo del Quotidiano sportivo, supplemento sportivo del Resto del Carlino, sulle tre atlete italiane del tiro con l'arco, le "cicciottelle" che hanno portato a casa una medaglia di bronzo. Con una nota da parte dell'editore del quotidiano, Andrea Riffeser Monti, arriva il licenziamento in tronco del direttore del Qs, Giuseppe Tassi: "L'editore - si legge - si scusa con le atlete olimpiche del tiro con l'arco e con i lettori del Qs Quotidiano sportivo, per il titolo comparso sulle proprie testate relativo alla bellissima finale per il bronzo persa con Taipei. Lo stesso editore a seguito di tale episodio ha deciso di sollevare dall'incarico, con effetto immediato, il direttore del Qs Giuseppe Tassi". L'atteggiamento più dignitoso lo hanno avuto le tre atlete che non si sono volute intromettere nel carnaio di polemiche sterili. Da parte degli indignati di professione un coro di proteste sulla trita e ritrita questione del rispetto del corpo femminile, portata a bandiera quando conviene, dimenticata solo in casi di avversari politici da disintegrare. Chissà dove erano questi paladini del rispetto in quota rosa quando si faceva carne da macello delle ragazze coinvolte nei processi contro Silvio Berlusconi, giusto per citare un trascurabile caso fenomenologico degli ultimi anni. A poco è bastata la nota di scuse con la quale lo stesso direttore questa mattina aveva giustificato quel titolo, apparso tra le altre cose nell'edizione di prima battuta, poi corretto in un'altra forma nella successiva edizione. Ormai la palla di neve era diventata valanga, con un il carico da novanta aggiunto dal presidente della Federazione italiana Tiro con l'Arco, Mario Scarzella, che rivolgendosi proprio al direttore aveva drammatizzato fino all'inverosimile: "Dopo le lacrime che queste ragazze hanno versato per tutta la notte - aveva scritto Scarzella - questa mattina, invece di trovare il sostegno della stampa italiana per un'impresa sfiorata, hanno dovuto subire anche questa umiliazione". E l'umiliazione doveva essere lavata con un colpevole da lanciare alla folla assetata di sangue. Di sicuro quel licenziamento "con effetto immediato" avrà ridato dignità a tutto il genere femminile.
Le «cicciottelle» e noi ostaggi dell’ossessione dell’estetica, scrive Beppe Severgnini su “Il Corriere della Sera” il 9 agosto 2016. «Il trio delle cicciotelle sfiora il miracolo olimpico» era un titolo sbagliato. Anzi, peggio: era un brutto titolo. Ma se licenziassero tutti i giornalisti che hanno fatto un brutto titolo, o un commento inopportuno, le redazioni sarebbero deserte. Di certo, il sottoscritto non ci sarebbe. Anni fa, dopo averla incontrata, ho definito «cicciottina» Scarlett Johansson (su Sette): ai miei occhi era un complimento, la ragazza era uno splendido manifesto contro l’ossessione della magrezza. Oggi non lo scriverei. Anche per questo a Giuseppe Tassi, l’autore di quel titolo, rimosso dalla direzione del Quotidiano Sportivo, concederei l’attenuante della buona fede: l’impressione è che, in modo un po’ datato, volesse vezzeggiare le ragazze dell’arco dopo la bella prova di Rio. In fondo, molte testate hanno applaudito Teresa Almeida, portiere della squadra di pallamano dell’Angola, 170 centimetri per 98 kg («Fortissima, simpatica e portavoce dei “cicciottelli” di tutto il mondo», Huffington Post, 7 agosto 2016). Domanda: non sono più offensive le esternazioni di Matteo Salvini su Laura Boldrini, paragonata a una bambola gonfiabile? Non sono più indelicati i giudizi di Marco Travaglio su Maria Elena Boschi («Si occupi di cellulite, non di riforme»). Non sono più spiacevoli i commenti di Vincenzo De Luca su Virginia Raggi («Bambolina imbambolata»)? Eppure non risulta che sia partito il linciaggio virtuale. Meglio così, sia chiaro. I titoli giocati sull’aspetto fisico sono figli di questo clima. E di certe abitudini. Siamo onesti: dall’inizio delle Olimpiadi molte testate pubblicano, e molti tra noi guardano, le scollature delle atlete e gli addominali degli atleti. È un’estensione dell’insopportabile ossessione estetica che domina la pubblicità, i media e la società; e tiene in ostaggio le nostre vite. I social — gli stessi che oggi invocano la gogna per l’autore del titolo sulle «cicciottelle» — godono a umiliare ogni personaggio per qualsiasi imperfezione: dalla pelle di un’anziana cantante a Sanremo alla pancetta di Higuain all’esordio con la Juve. Riassumendo. È inopportuno giocare sull’aspetto: il collega Tassi ha sbagliato. Ma fra disapprovazione e linciaggio c’è un confine. E ogni giorno viene superato, con euforica ipocrisia.
“Frocio” non si dice. “Figlio di troia” sì, scrive Francesco Merlo il 26 gennaio 2016 su "La Repubblica". Dunque “frocio” non si può dire e “figlio di troia” sì? E “siciliano mafioso” non è razzismo, mentre “zingaro di merda” lo è? E se fosse ridicolo tutto questo affanno del perbenismo italiano nel compilare classifiche di legittimità dell’insulto? Non si può infatti applicare il politicamente corretto all’ingiuria, non esiste l’offesa sterile, non ci sono parolacce detergenti e anzi spesso il più turpe vaffanculo, quando è lanciato sotto stress e non quando diventa progetto politico, disinnesca il pugno. Le male parole come sfogo, come valvole liberatrici durante uno scontro sul campo di gioco, o sulla strada o persino in Parlamento, fanno muro ai ceffoni, disarmano gli istinti violenti, impediscono le botte, sono l’unico modo di darsele di santa ragione senza farsi male. E chissà se per Mandzukic è più offensiva la parola “zingaro” o la parola “merda”? Ed è più politicamente scorretto Sarri, che ha dato del finocchio a Mancini, oppure Mancini che aveva assolto se stesso quando aveva dato del “finocchio” ad un cronista? E’ infatti una giostra il mondo del politicamente corretto. Basta un piccolo cambio di scena e l’ingiuriante diventa ingiurato come nel film i Mostri dove Vittorio Gassman, pedone sulle strisce, si indigna e si ribella perché gli automobilisti, mentre gli sfiorano il sedere, gli gridano. E Gassman incede su quelle strisce a passo volutamente lento e abusa dell’asilo politico che gli offre il codice della strada: come Mancini, “ci marcia”. Ma poi quando sale sulla sua cinquecento il mostro Gassman sfreccia su quelle stesse strisce mostrando le corna ai pedoni. Più ancora della strada, lo sport è metafora di guerra, la vita combattuta con altre armi, non la politica astrusa e neppure la cultura dei privilegiati, ma il mondo dei sentimenti, materia forse non semplice ma sicuramente selvatica: il mondo del turpe eloquio. E però Konrad Lorenz tratterebbe De Rossi come uno dei suoi spinarelli e non certo come un razzista. Anche Freud sorriderebbe dinanzi alle accuse di omofobia a Sarri. Per non dire di Lévi-Strauss che si sentirebbe beato davanti a tanti selvaggi. Tanto più che, con un formidabile testa-coda, il politicamente corretto avvelena anche i selvaggi. Ieri, nelle tante trasmissioni radio, persino gli ultrà romanisti si sono impasticcati di politicamente corretto e, dando vita alla figura ossimorica dell’ultra per bene, dell’estremista formalista, per salvare il loro De Rossi hanno solennemente stabilito che non essendo Mandzukic uno zingaro non può sentirsi offeso dalla parola zingaro. Con questa logica se dici puttana a una puttana la offendi, se invece lo dici a una signora, va bene. L’importante infatti è non ledere i diritti della minoranza sfruttata (le puttane) anche a costo dell’onore della maggioranza (le signore). Insomma sei un gran maleducato, ma politicamente corretto; sei un vero facchino ma non sei un razzista. Applicando questa logica anche all’ingiuriato, solo un frocio si arrabbia se gli dicono frocio. Dunque se Mancini si arrabbia vuole dire che è frocio? La giustizia sportiva, per trovare delle attenuanti a Sarri, ha accolto questa stramba tesi degli ultrà e ne ha fatto una fonte di legge condannando l’allenatore del Napoli a solo due giorni di squalifica, e per giunta in coppa Italia, a riprova che la nostra giustizia sportiva coniuga le regole con l’humus, la legge con gli umori, in nome del popolo italiano politicamente corretto, vale a dire della curva sud che strologa di diritto, del bar sport dove il tifoso-fedele si traveste da laico. Come si vede, il politicamente corretto della plebe, che di natura è scorretta, è alla fine un pasticcio, è l’innesto del birignao nella suburra. Come se Marione Corsi, l’ex terrorista dei Nar, divo della più importante radio romanista (dice), conducesse “Che Tempo che fa” al posto di Fabio Fazio. Infine c’è la televisione che amplifica e rende caricaturale il politicamente corretto perché costringe a mentire, non conosce sfumature, insegna a parlare con la mano davanti alla bocca e dunque a occultare il corpo del reato, come ha ben spiegato ieri Spalletti, il nuovo allenatore della Roma. Alla Camera dei deputati sono stati vietati per regolamento gli zoom proprio per evitare la lettura del labiale e dunque le indiscrezioni rivelatrici, le schermate dei siti porno visitati mentre si discute della Finanziaria, l’ingrandimento del display del cellulare di Verdini terminale di traffici e commerci, le parolacce dette e scritte nei pizzini che gli onorevoli si scambiano tra loro. E certo non ci piace che sia stata oscurata la casa di vetro della democrazia. Ma una vota Dino Zoff raccontò che dovendo subire un rigore, il suo allenatore Trapattoni gli impartì un ordine in forma di consiglio: buttati a destra perché quello lì calcia i rigori sempre sulla destra. Al momento del tiro, Zoff per istinto avrebbe voluto andare a sinistra, ma prevalse l’obbedienza al Mister. Fu gol. E Zoff scomodò il cielo con una bestemmia e con un insulto secco e forte contro Trapattoni. Lo avesse ripreso la televisione, Zoff sarebbe passato alla storia del calcio come un insolente e un blasfemo, nemico di Dio e del proprio allenatore. Ecco dunque l’ultimo pasticcio del politicamente corretto: la televisione condanna alla trasparenza che però tanto più sembra fedele quanto più è infedele perché travisa mentre mostra, deforma mentre informa. E’ allora meglio nascondersi al politicamente corretto? Oppure è meglio comportarsi come profetizzava Italo Calvino? Conosco un omosessuale che vive in un piccolo paese e che all’insulto “frocio”, che ogni tanto gli capita di subire, reagisce con orgoglio.
Insultare una fascista (incinta) non è reato, scrive Gian Marco Chiocci il 2 febbraio 2016 su “Il Tempo”. Giorgia Meloni non ha bisogno di avvocati d’ufficio, la conoscete, sa difendersi da sola. Ma quel che la fogna di internet le sta vomitando addosso dopo l'annuncio del bebè in arrivo, imporrebbe una risposta dura e bipartisan che a distanza di 48 ore ancora non s'è vista. Madri, padri, figli di, parenti prossimi o trapassati: di insulti familistici la politica si alimenta ogni giorno ma non se n'erano sentiti rivolti a un feto. I cultori della doppia morale, della superiorità intellettuale, culturale ed esistenziale, ci regalano sovente perle di ironia che a parità di sarcasmo, se rivolte a un'immigrata, una lesbica, una politica di sinistra, scatenano reazioni veementi, rimostranze parlamentare, raccolte di firme e sit-in in girotondo. Prendete la Boldrini. Impegnata com'è a far rispettare l'articolo determinativo femminile, "la" presidente della Camera ha espresso solidarietà all'ex ministro solo quando Fabio Rampelli (l'ombra lunga di Giorgia) ha evidenziato la sua partigianeria nell'esprimere solidarietà solo a chi non la pensa come la leader di An. Va detto che anche le politicanti di centrodestra si sono fatte riconoscere. Hanno tergiversato fino a quando non s'è mossa la Carfagna, dopodiché qualcuna ha preso coraggio e s'è indignata. Insomma, se la Bindi è più bella che intelligente, giustamente il mondo s'indigna con Berlusconi. Ma guai a scandalizzarsi se esponenti democratici condividono su facebook Madonna Meloni che concepisce senza peccare oppure ritwittano quel gentiluomo di sua sobrietà di Vladimir Luxuria che cinguetta sperando di tramandare la specie («auguri e figli trans»). Ti sentirai rispondere che è satira, sarcasmo, ironia. Ma sì, minimizziamo. Ridimensioniamo l’accaduto. Lo facevano anche i katanga dell’autonomia operaia quando sprangavano i missini e si difendevano così: «Uccidere un fascista non è reato».
Un orrore sul sito dell'Annunziata: giusto insultare il figlio della Meloni, scrive “Libero Quotidiano” il 3 febbraio 2016. Sull'Huffington Post di Lucia Annunziata un intervento di rara violenza contro Giorgia Meloni. A firmarlo è Deborah Dirani, che si definisce "donna, prima. Giornalista, poi". Nel mirino la leader di Fdi-An, bersagliata da insulti e sfottò dopo aver rivelato di essere incinta. E la signora Dirani, de facto, spiega che la Meloni si merita questo tipo di linciaggio. Chiarissimo l'attacco del suo articolo: "Giorgia Meloni è incinta. Giorgia Meloni è una delle responsabili della degenerazione della politica del mio Paese. Di quella politica fatta di esclusione, di negazione dei diritti, di slogan populisti e di intolleranze culturali". Dunque, la Dirani aggiunge che la Meloni "è incinta e io sono ben contenta, dico sul serio". E subito dopo riprende a manganellare: "Ma la gravidanza non fa di lei una persona migliore, non la trasforma magicamente in una donna aperta al diverso da sé. Resta esattamente quella che è e raccoglie esattamente quello che tanto si è prodigata a seminare: intolleranza". Insomma, l'intolleranza raccolta dalla Meloni in questi giorni - ricordiamolo: insulti e sfottò al nascituro, qualcosa di vergognoso che non c'entra nulla con la politica - sarebbe dovuta alla presunta intolleranza del personaggio Meloni. Quale intolleranza? Si suppone il sostenere politiche di destra, una roba che la signora Dirani non può tollerare, tanto che nello stesso, improponibile e violento, commento si spinge a scrivere: "Buona gravidanza, Giorgia Meloni e... Speriamo che sia femmina (volevo aggiungere anche comunista!)".
Mancini e il politically correct che tarpa le ali alla libertà d'espressione. Froci, zingari, clandestini e handicappati non esistono più. La "neolingua" impone gay, rom, migranti e diversamente abili e ora invade anche i campi di calcio, scrive Francesco Curridori, Mercoledì 20/01/2016, su "Il Giornale". “Sarri è un razzista, uomini come lui non possono stare nel calcio. Mi son alzato per chiedere al quarto uomo del recupero. Lui ha iniziato ad inveire contro di me, dicendo ‘frocio e finocchio’ Sono orgoglioso di esserlo se lui è un uomo. Persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Ha 60 anni, si deve vergognare”. Con queste parole Roberto Mancini rischia di inguaiare Maurizio Sarri. I due allenatori hanno avuto un brutto battibecco al termine della partita di Coppa Italia e l’insulto scappato al coach del Napoli rischia di costargli caro. Secondo le norme della Figc chi ha “stop "un comportamento discriminatorio e ogni condotta che comporti offesa per motivi di sesso" rischia quattro mesi di squalifica che andrebbero scontati anche in campionato. Mancini ha rotto la regola aurea del calcio che può essere riassunta con la frase di un celebre film: “ciò che avviene dentro il miglio verde rimane dentro il miglio verde” e così il web si è diviso su Twitter tra chi scriveva #iostoconMancio e #iostoconsarri. Siamo all’apoteosi del politicamente corretto. Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center ha chiesto un incontro con il presidente del Napoli, Auelio De Laurentis e Carlo Tavecchio, presidente della Figc perché “uno sport così popolare non può permettersi messaggi di violenza". Siamo sicuri che molti di questi benpensanti di sinistra che si indignano per un “frocio” scappato in un campo di calcio, dove gli insulti e le bestemmie sono di casa, sono scesi in piazza a difesa della libertà d’espressione quando l’Isis ha fatto la strage di Charlie Hebdo. Fintanto che si insulta la Chiesa cattolica o qualcuno dipinge un Gesù Cristo immerso nella pipì tutto va bene ma se si dice frocio, zingaro, clandestino, cieco o handicappato allora apriti cielo. Nella neolingua dei benpensanti frocio deve chiamarsi “gay”, il clandestino “migrante”, cieco diventa "non vedente", zingaro “rom” e l’handicappato si trasforma in “diversamente abile”. Come se anche i cosiddetti “normodotati” non siano diversamente abili tra loro. Non tutti gli uomini “comuni” hanno le stesse abilità e anche chi non è in sedia a rotelle, nella maggior parte dei casi, ha abilità diverse se messo a confronto con Rocco Siffredi e Stephen Hawking. Chi vive in sedia a rotelle, chi non vede o chi non sente è, invece, portatore di uno o più handicap, ossia di svantaggi cui non si è ancora è posto il giusto rimedio con un adeguata opera di abbattimento delle barriere architettoniche. Eppure la sinistra cosa si accinge a fare? Una proposta di legge per aumentare le pensioni d’invalidità, al momento ferme a poco più di 200 euro? No, la preoccupazione di Sel è quella di cambiare la dicitura “handicappato” in “diversamente abile” dal testo di legge 104, come conferma al giornale.it da Erasmo Palazzotto, promotore della proposta di legge che arriverà in Parlamento presumibilmente a febbraio. Se si va avanti di questo passo si dovrà chiedere a Iva Zanicchi di cambiare la sua canzone da “dammi questa mano, zingara” a “dammi questa mano, rom”. Dire “frocio” fa scandalo proprio nel momento in cui il governo depenalizza il reato di ingiuria tanto che persino Vittorio Sgarbi, per protesta, ha abbandonato una trasmissione tivù senza insultare nessuno. A breve sarà impossibile anche dare del “cornuto” all’arbitro. Preparatevi al marito con una moglie “diversamente fedele”… Siamo alle comiche finali del politicamente corretto.
Sarri e il solito coro del "Politicamente corretto" a giorni alterni, scrive "Il Piccolo D'Italia il 20 gennaio 2016. Fonte: Fabrizio Verde, Francesco Guadagni e Alessandro Bianchi per L’Antidiplomatico. In occasione della partita di calcio tra Napoli e Inter, valevole per la qualificazione alla semifinale della Coppa nazionale, è entrata in azione la solita ipocrisia e doppia morale di marca italica. Evento scatenante, un litigio tra i tecnici delle due compagini calcistiche Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Quest’ultimo, allenatore dell’Inter, nel dopo partita ha lanciato accuse di razzismo nei confronti del tecnico toscano che allena la squadra partenopea, colpevole di averlo apostrofato con i termini ‘frocio’ e ‘finocchio’. Per Maurizio Sarri, che dichiara di non ricordare le parole esatte ma si è scusato a telecamere spente nello spogliatoio dell’Inter prima dell’accusa mediatica di Mancini, si è trattato di una caduta di stile, questo è fuor di ogni dubbio. Ma è l’intero contesto di abnorme colpevolizzazione dell’allenatore del Napoli ad essere oggettivamente fuori luogo. Innanzitutto bisogna ricordare che l’Italia è il paese dove in occasione di ogni partita di calcio vengono gridati i più beceri cori razzisti nei confronti della città di Napoli e dei suoi abitanti, nel generale disinteresse di giornalisti e addetti ai lavori, che fanno a gara nel minimizzare questi atti di razzismo, declassandoli a semplici sfottò da stadio, senza tener contro del retroterra culturale che vi è dietro a questi slogan beceri e razzisti. Si tratta degli stessi personaggi che da ieri cercano di ergersi a improbabili moralizzatori del mondo del calcio. Si tratta, si sa, del solito “politicamente corretto” creato ad arte. Che dire poi dello stesso Roberto Mancini che si è precipitato ai microfoni della Rai a denunciare indignato delle offese ricevute, dopo aver provato nello spogliatoio del Napoli a venire alle mani con il tecnico toscano? Si tratta dello stesso Mancini che nel 2000 intervenne in difesa del suo amico Sinisa Mihailovic, il quale aveva definito il centrocampista dell’Arsenal Vieira un «negro di merda», con queste testuali parole riportate dal quotidiano ‘La Repubblica’: «Nel corso di una partita l’agonismo esasperato può portare a momenti di tensione e di grande nervosismo. Credo che anche qualche insulto ci possa stare. L’importante è che tutto finisca lì». Lo stesso Mancini che da allenatore del Manchester City rischiò di finire alle mani con ben due suoi giocatori Adebayor e Tevez. Il primo accusato di fingere un infortunio poi rivelatosi vero, il secondo per divergenze tecnico-tattiche. Il litigio tra il tecnico di Jesi e l’attaccante argentino trovò il suo culmine quando Mancini affermò nei confronti di Tevez ‘l’elegante’ frase «go fuck your mother». Insomma, il tecnico che ieri si è tanto scandalizzato non ha nulla da invidiare alle tante teste calde che popolano il calcio mondiale. In ultima analisi è curioso notare come quegli stessi giornalisti che ieri si sono affrettati nel crocifiggere un allenatore per un insulto proferito in un momento di grande concitazione e nervosismo, siano gli stessi che da anni ignorano il più becero razzismo, le ruberie, i macroscopici brogli e quant’altro accade nel mondo del calcio. E, infine, un ultimo punto, il più importante perché non parliamo più di qualcosa attinente ad un gioco, è curioso notare come quegli stessi giornalisti che ieri si sono affrettati nel crocifiggere un allenatore per un insulto proferito in un momento di grande concitazione e nervosismo, siano gli stessi che ignorano e tollerano ogni giorno lo stupro di diritti, democrazia e della nostra Costituzione che avviene ogni giorno. Lo stato in cui versa un’Italia sempre più schiacciata della dittatura europea neoliberista dipende anche, e soprattutto, dal coro del “politicamente corretto” dei bombardatori umanitari a giorni alterni.
Quella sinistra "politicamente corretta" che da settant'anni deride e insulta i gay. Togliatti offendeva Gide mentre la rivista diretta da Berlinguer inseriva gli "invertiti" fra i nemici di classe. Fino alle scivolate di D'Alema e Bersani, scrive Cristina Bassi, Martedì 18/04/2017, su "Il Giornale". «A froci!», «finocchio», «culattoni», «checca squallida»: la destra, certo, si è spesso messa in (cattiva) luce quando si è trattato di insulti omofobi e battute da trivio. Post-missini e leghisti in testa. E se la Dc usa per decenni la maldicenza, pure Beppe Grillo scivola su un «At salut, buson!», rivolto a Nichi Vendola dal palco di Bologna (2011). Ma arrivano dalla sinistra progressista le invettive più insidiose contro i gay. A volte vaghe: «È mollezza borghese». Altre dirette: «Deviati», «pederasti», «invertiti». Altre ancora subdole: le unioni omosessuali? «È mai possibile che i problemi dell'Italia siano questi?», si chiede D'Alema nel 2006. «È meglio che un bambino cresca in Africa piuttosto che con due uomini o due donne», dichiara un anno più tardi Rosy Bindi, madre del ddl sui Dico. Dopo Stai zitta e va' in cucina, saga del sessismo a Palazzo, il giornalista di SkyTg24 Filippo Maria Battaglia pubblica Ho molti amici gay - La crociata omofoba della politica italiana (Bollati Boringhieri).
Partiamo dal dopoguerra. Nel 1950 Palmiro Togliatti sul mensile Rinascita si scaglia, sotto pseudonimo, contro André Gide che si è ricreduto sul comunismo. A sentirlo parlare, sostiene il segretario del Pci, «vien voglia di invitarlo a occuparsi di pederastia, dov'è specialista». E un anno prima: «Se quando ha visitato la Russia nel 1936 gli avessero messo accanto un energico e poco schizzinoso bestione che gli avesse dato le metafisiche soddisfazioni ch'egli cerca, quanto bene avrebbe detto, al ritorno, di quel Paese!». Mentre il mensile della Fgci Gioventù Nuova, diretto da Enrico Berlinguer, se la prende con Jean-Paul Sartre: «Un degenerato lacchè dell'imperialismo, che si compiace della pederastia e dell'onanismo». Riflette l'autore: il messaggio dell'apparato è che «tra i comunisti non c'è posto per gli omosessuali, invertiti e pederasti (usati spesso come sinonimi) sono solo gli avversari borghesi».
C'è l'espulsione dal Pci di Pier Paolo Pasolini «per indegnità morale» nel 1949. Francesco Rutelli che nel 2000 da sindaco di Roma ritira il patrocinio al Gay Pride perché si tiene nei giorni del Giubileo. E la reazione di Giancarlo Pajetta nella seconda metà degli anni '80. A Botteghe Oscure nota facce nuove: «Incuriosito, si avvicina, scoprendo che si tratta della prima delegazione gay accolta in via ufficiale nella sede comunista. E prima le puttane, e adesso i finocchi si sfoga, scuotendo la testa ma che c... è diventato questo partito?». Arrivando ai giorni nostri, ecco la sinistra «diversamente omofoba». Nel 2009 Bersani manifesta «forti perplessità» sulle unioni gay. È bene, spiega, regolare un fenomeno cresciuto «a dismisura». Però «poi non è che lo chiamo matrimonio omosessuale perché non sono assimilabili». Ancora: «È mai possibile che i problemi dell'Italia siano i Pacs e la Tav?, si domanda nel 2006 l'ex premier Massimo D'Alema (...). Prima di aggiungere, significativamente: Ci siamo fatti incastrare a discutere di questioni marginali rispetto ai problemi del Paese». Pochi mesi dopo aggiungerà che il matrimonio tra omosessuali «offenderebbe il sentimento religioso di tanta gente». Nel 1995 aveva dichiarato: la coppia omo non può «essere considerata una famiglia».
A sinistra la «tolleranza repressiva» ha lasciato il posto al silenzio imbarazzato: «C'è una generazione di gente brillantissima che viene dal Pci che non ha mai fatto coming out racconterà nel 2012 la deputata dem Paola Concia Donne e uomini, personaggi di primo piano di quel partito. Se avessero dichiarato pubblicamente la loro omosessualità avrebbero fornito carburante alla sinistra». Non solo: «Alcuni colleghi del Pd (...) ogni volta che mi vedono parlare con una donna, si strizzano l'occhio e dicono che ci sto provando (...). Pregiudizi che trovano conferma nel 2011 quando la deputata annuncia che si sposerà in Germania con la compagna. Che si dice in questi casi?, le domanda Rosy Bindi». Infine Vendola che confessa: «È stato forse più facile dire la mia omosessualità ai preti che al partito».
Da Che Guevara a Orlando, tutte le contraddizioni del mondo gay, scrive Adriano Scianca il 14 giugno 2016 su “Il Primato nazionale”. Il 14 giugno 1928 nasceva a Rosario, in Argentina, Ernesto Guevara de la Serna, destinato a passare alla storia, col nomignolo di Che, per l’apporto dato alla rivoluzione comunista cubana e per essere stato, dopo l’instaurazione del regime castrista, uno dei suoi principali esponenti. Di lui si è detto e scritto tutto. Non è neanche una novità sconvolgente quella per cui, nella visione guevarista dell’uomo nuovo, non ci fosse posto per l’omosessualità: che il Che sia stato l’artefice della creazione di veri e propri campi di concentramento per omosessuali, in cui finirono anche molti simpatizzanti per la rivoluzione, è cosa ben documentata. Eppure il brand guevarista va forte proprio in quei settori che vorrebbero fare l’esame del dna a chiunque sia anche solo in odore di “omofobia”. Beninteso, non vogliamo frettolosamente liquidare qui la rivoluzione cubana con un giudizio piccolo-borghese limitato ai suoi “crimini”, ma certo la contraddizione stride, e parecchio. Non è la sola, se restiamo in campo “lgbt”: al recente gay pride di Roma, per esempio, sono stati fotografati dei cartelli che inneggiavano al boicottaggio dei prodotti israeliani e alla libertà della Palestina. Ben fatto, la causa palestinese gode di tutta la nostra simpatia. Ma, anche qui, non si può non ragionare in punta di coerenza: Israele è uno Stato estremamente gay friendly, cosa che è difficile dire della controparte palestinese e del mondo musulmano in genere. È questo il motivo per cui, dopo la strage di Orlando, il pensiero dominante è andato in tilt: un musulmano, figlio di immigrati, che fa strage di gay. Come uscirne? Sel, in Italia, ha risolto la questione, dando la colpa al fascismo, ma questa è patologia psichiatrica e va lasciata quindi agli specialisti. Abbiamo detto del gay pride: non è forse quella una contraddizione ambulante? Uno sfoggio identitario per rivendicare diritti e uguaglianza. L’espressione di una sottocultura trasgressiva per reclamare l’accesso al perbenismo borghese. Un ostentato “siamo diversi da voi” per far capire alla gente “siamo uguali a voi”. Ora, questo micro-viaggio che parte da Che Guevara e arriva non a Madre Teresa, come la Chiesa immaginaria di Jovanotti, ma allo stragista di Orlando passando per i carri chiassosi del gay pride, cosa vorrebbe dimostrare? Nulla, se non che l’ortodossia politicamente corretta, che ha nelle rivendicazioni lgbt la sua punta di lancia più avanzata, è un sistema logico fallace e un sistema etico claudicante. E che la dittatura del pensiero unico è innanzitutto una dittatura del non pensiero. Adriano Scianca
Omofobia sinistra. Era il 1934 quando Klaus Mann, il figlio dello scrittore Thomas che ebbe una vita signorilmente intensa e signorilmente angosciata, scrisse un pamphlet contro la persecuzione dei “pederasti”. Persecuzione degli omosessuali da parte della sinistra. Sì, perché se oggi negli stereotipi c’è l’omofobia di destra e l’omofilia di sinistra, un tempo, e non fu molto tempo fa, c’era l’omofobia di sinistra e l’omofilia di destra. Klaus Mann denuncia “l’avversione nei confronti di tutto quanto è omoerotismo che nella maggior parte degli ambienti antifascisti e in quasi tutti gli ambienti socialisti raggiunge un livello intenso. Non siamo molto lontani dall’arrivare a identificare l’omosessualità con il fascismo. Su questo non è più possibile tacere”, scrive Giulio Meotti il 22 Luglio 2013 su “Il Foglio”. E ancora: “Come mai sui giornali antifascisti leggiamo parole come ‘assassini e pederasti’ abbinate quasi con la stessa frequenza con cui vengono abbinate sui fogli nazisti le parole ‘traditore del popolo ed ebreo’? La parola ‘pederasta’ viene usata come un’ingiuria”. Né in “Arcipelago Gulag” di Alexander Solzenicyn, né nei “Racconti della Kolyma” di Varlam Salamov, c’è una parola per raccontare la sorte degli omosessuali nei campi sovietici. Sono chiamati, semplicemente, “gli infamati”. In un’opera di divulgazione del commissariato sovietico di Pubblica sicurezza del 1923, intitolato “La vita sessuale della gioventù contemporanea”, si legge che l’omosessualità è “una forma di alienazione” che sarebbe scomparsa, naturalmente o meno, con l’avvento del comunismo. La morale sessuale della sinistra ha sempre oscillato fra la critica radicale delle istituzioni borghesi, a cominciare dal matrimonio, e quella delle “degenerazioni” del costume, segno della corruzione che veniva dalle classi dominanti e capitalistiche. Nel 1862 il proclama della “Giovane Russia” postulava l’abolizione del matrimonio “fenomeno altamente immorale e incompatibile con una completa eguaglianza dei sessi”. La critica di Engels (“Origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato”) indusse la prima generazione di rivoluzionari russi a considerare la famiglia come una “istituzione superata”. August Bebel scriveva che “il soddisfacimento dell’impulso sessuale è un affare privato di ciascuno proprio come il soddisfacimento di ogni altro impulso naturale”. Ma quando una militante bolscevica, nel 1915, stese un pamphlet favorevole al “libero amore”, Lenin rispose che questa era una concezione borghese, non proletaria. Parlando con Klara Zetkin, nel 1920, definì “completamente antimarxista e per di più antisociale la famosa teoria secondo cui, nella società comunista, la soddisfazione dell’istinto sociale e dell’amore è una cosa semplice e insignificante come bere un bicchier d’acqua”. Queste teorie e i conseguenti comportamenti si erano diffusi nella prima fase rivoluzionaria, negli ambienti intellettuali delle grandi metropoli, dominati dallo spirito dissacratore dei futuristi, che consideravano l’omosessualità solo un modo diverso di bere un bicchier d’acqua. A mano a mano che il potere sovietico si estese alle campagne, con la guerra civile e la Nep, la situazione mutò radicalmente. La famiglia tradizionale tornò a essere il modello e ogni “devianza” fu condannata.
Si cominciò con l’attacco di Bucharin alla diffusione fra i giovani di “gruppi decadenti e semiborghesi con nomi come Abbasso l’innocenza, Abbasso il pudore” e si finì con l’inserire nel codice penale la condanna ai lavori forzati per l’omosessualità. Gli intellettuali comunisti occidentali si adeguarono. Uno dei testi più noti di Bertolt Brecht, “Ballade vom 30 Juni”, presenta Hitler e Ernst Röhm come amanti di letto, usando l’accusa di omosessualità per screditare il nazionalsocialismo. Si arriverà, con il giornalista Georges Valensin, a dichiarare che nella Cina di Mao “l’omosessualità non esiste più” (l’Espresso, 20 novembre 1977).
Il Pcf si distinse nell’attacco a “intellettuali degenerati” come André Gide, l’autore di “Si le grain ne meurt”, l’autobiografia dove confessa come in una psicoterapia le “brutte abitudini” di bambino onanista all’Ecole Alsacienne o le crudeltà di adulto libertino inflitte alla madre. “Ce vieux Voltaire de la pédérastie”, scrisse di lui Ernst Jünger, che così sintetizzò il suo nichilismo scettico redento dall’eleganza dello stile. Gide l’alfiere dell’individualismo antiborghese, il custode del classicismo che disse “Je ne suis pas tapette, Monsieur, je suis pédéraste”. Ma anche il militante dell’antifascismo infatuato per breve tempo del comunismo e che, sontuosamente accolto nel 1936 a Mosca, ritornò in occidente per scrivere “Retour de l’Urss” e “Retouches à mon retour de l’Urss”, i libri in cui riferì quello che aveva visto realmente nella Russia staliniana. Divenne così “Gide, il traditore”, “il bieco reazionario”, “il servo dei padroni”, “il nemico della classe operaia”: questo il campionario di epiteti pubblicati a caratteri cubitali contro l’omosessuale antesignano. “Quelle sue calunnie, assurde e ignobili, contro il paese guida del comunismo internazionale, sono la bava avvelenata di un degno figlio della piccola borghesia, di un alleato dei nostalgici nazisti e delle camicie nere”, scrivevano i giornalisti dell’Humanité, il quotidiano del Partito comunista francese. E i loro colleghi della Pravda, organo del Partito comunista sovietico, rivolgendosi ai lettori militanti: “Sapete perché il signor Gide ce l’ha tanto con noi e con i nostri compagni? S’è indignato, poverino, ha provato un disgusto indicibile, quando si è accorto che i comunisti di Mosca non sono pederasti”.
Quando a Stoccolma, nel 1947, diedero al settantottenne Gide il premio Nobel per la Letteratura, Jean Kanapa arriverà a dire che dieci anni prima lo scrittore aveva provato disgusto per i bolscevichi “accorgendosi che essi non erano pederasti”. Nel 1949 Dominique Desanti lo descrisse vecchio di ottantun anni “con già sul viso la maschera della morte”, circondato da giovani ammiratori che avevano trovato nei suoi libri la stessa liberazione che altri trovavano a Place Pigalle. Nel coro di mostrificazione di Gide non mancherà la voce di Palmiro Togliatti, il segretario del Pci che sotto lo pseudonimo di Roderigo di Castiglia, dal giorno del suo ritorno in Italia, nell’ottobre 1943, a quello della sua morte a Jalta, nell’agosto 1964, svolse il suo magistero culturale sulle pagine di Rinascita. Nel maggio 1950, scriverà a proposito di Gide: “Al sentire Gide, di fronte al problema dei rapporti fra i partiti e le classi, dare tutto per risolto identificando l’assenza di partiti di opposizione, in una società senza classi, con la tirannide e il terrorismo, vien voglia di invitarlo a occuparsi di pederastia, dov’è specialista, ma lasciar queste cose, dove non ne capisce proprio niente”.
Il 20 febbraio 1951, all’indomani della scomparsa di Gide, l’Humanité pubblicherà un necrologio intitolato “Un cadavere è morto”. E’ lo stesso Kanapa che nel 1947 riassunse la posizione ufficiale del Partito comunista francese in un saggio intitolato “L’esistenzialismo non è un umanesimo”, in cui si arriva a sostenere che “il significato sociale dell’esistenzialismo è la necessità attuale per la classe sfruttatrice di addormentare i suoi avversari” e che Jean-Paul Sartre era un “pederasta che corrompe la gioventù”. In Italia si seguì un doppio binario. Gli omosessuali non venivano ammessi nel partito e quando venivano scoperti, come nel caso famoso di Pier Paolo Pasolini, venivano espulsi in base alla norma sulla “condotta esemplare” contenuta nello statuto comunista. C’è ad esempio il caso di Pietro Secchia, sul quale cominciarono a circolare voci soltanto dopo che, morto Stalin e fuggito il suo più stretto collaboratore, fu esautorato dal suo ruolo di capo dell’Ufficio quadri, quello che vigilava sulla vita, anche privata, di “compagni e dirigenti”. Sul piano pseudoscientifico pesarono a lungo le teorie biologiche di Andrei Lissenko, che sosteneva una specie di superiorità razziale del proletariato nel quale “fenomeni di devianza”, come l’omosessualità, potevano sussistere solo come il risultato della contaminazione di altre classi. Nel Partito comunista, di omosessualità non si parlerà a lungo. Nel convegno del 1964 dedicato a “Famiglia e società nell’analisi marxista” si accenna polemicamente, lo fa Umberto Cerroni, “alle false alternative teoriche del ribellismo sessuale”, mentre la ricognizione della “esperienza sovietica” di Luciana Castellina arriva a criticare “gli eterodossi, gli innovatori” come sostenitori “del ritorno a una tematica crepuscolare, in difesa del privato e dei suoi tenui sentimenti”. Ancora nel 1979 Antonio Roasio, uno dei fondatori del Partito comunista a Livorno, non trovava di meglio che criticare l’Unità per “l’eccessivo rilievo” dato all’omosessualità in un numero del quotidiano e che “comunque la si giudichi, l’omosessualità non può essere considerata un aspetto della libertà sociale”.
C’è poi la storia, quella vera, del “Che”, Ernesto Guevara. Una storia che in pochi raccontano oggi e che le stesse associazioni omosessuali militanti hanno sempre nascosto. Con il passaggio di poteri da Batista a Castro, nel 1959, Guevara venne nominato procuratore militare con il compito di reprimere “gli oppositori della rivoluzione”. Nei tribunali finiscono per espressa volontà del Che molti religiosi, tra cui l’arcivescovo dell’Avana, e moltissimi “maricones”, gli omosessuali. Il Che realizza campi di lavori forzati ed elabora i regolamenti dentro le galere del regime, che fissano le punizioni corporali per i più facinorosi, come i lavori agricoli eseguiti nudi. Alcuni reduci racconteranno di “maricones” uccisi personalmente, con colpi di pistola alla tempia, dal leggendario guerrigliero. Perché nella Cuba comunista tanto amata in occidente, il castrismo ha perseguitato gli omosessuali chiamandoli “pinguero” (marchetta) e “bugarrón” (uno che cerca sesso spasmodicamente). E se nella Cuba di Batista i gay stavano male e basta, fu tra il 1965 e il 1968, dopo la rivoluzione, che ci fu il trionfo delle Unidades militares de ayuda a la producción, veri e propri lager con guardie armate e filo spinato. Ci finivano dal “poeta finocchio” all’“attore effeminato”, tutti in divisa blu, sottoposti a marce durissime, cibo scarso, ma anche “cure” con gli elettrodi attaccati ai genitali. Il comandante Ernesto Guevara fu lì uno degli aguzzini.
Granma, l’organo ufficiale del Partito comunista cubano, nell’aprile 1971 scriveva per esempio che “il carattere socialmente patologico delle deviazioni omosessuali va decisamente respinto e prevenuto fin dall’inizio. E’ stata condotta un’analisi profonda delle misure di prevenzione e di educazione da rendere efficaci contro i focolai esistenti, inclusi il controllo e la scoperta di casi isolati e i vari gradi di infiltrazione. Non si deve più tollerare che gli omosessuali notori abbiano una qualche influenza nella formazione della nostra gioventù. Siano applicate severe sanzioni contro coloro che corrompono la moralità dei minori, depravati recidivi e irrimediabili elementi antisociali, ecc.”. L’omosessualità è trattata alla stregua di un virus patogeno. Nel 1979 gli atti omosessuali vennero decriminalizzati a Cuba, ma i gay continuarono a venire accusati di essere “oppositori del regime”, sbattuti in galera senza processo, mandati a morte in quell’isola magnifica che descrive Claudio Abbado. Il quotidiano Juventud rebelde pubblica una foto di un impiccato, un “gusano”, un verme, e sui pantaloni c’è scritto “homosexual”. Nel 1984 Néstor Almendroz e Orlando Jiménez Leal producono il documentario “Cattiva condotta”, dove raccontano la persecuzione del regime castrista contro i gay. Racconta lo scrittore Guillermo Cabrera Infante: “La persecuzione degli omosessuali dei due sessi fu una persecuzione di dissidenti. Gli omosessuali deviano dalle norme borghesi. I comunisti sostengono le coppie convenzionali, il matrimonio… L’omosessualità minaccia tutto ciò, perciò gli stati totalitari la temono”. Ancora l’articolo 303 del codice penale del 30 aprile 1988 punisce chi “manifesti pubblicamente” la propria omosessualità con pene che variano tra i tre mesi a un anno di prigione o una multa che va da cento a trecento cuotas per coloro che “infastidiscono in modo persistente gli altri con proposte amorose omosessuali”. In occidente, dove oggi vige l’omofilia militante e avanza la censura antiomofoba, l’omosessualità è stata sempre una questione di emarginazione. Nell’emisfero comunista, e nel pensiero della sinistra europea, l’omosessualità era destinata a scomparire. Assieme ai froci. Una “soluzione finale” contemplata in un articolo che Maksim Gorkij, la bandiera degli scrittori sovietici, l’amico di Lenin, il padre del realismo socialista, pubblicò il 23 maggio 1934 contemporaneamente sulla Pravda e sull’Izvestia, sotto il titolo “Umanesimo proletario”: “Nei paesi fascisti, l’omosessualità, rovina dei giovani, fiorisce impunemente; nel paese dove il proletariato ha audacemente conquistato il potere, l’omosessualità è stata dichiarata crimine sociale e severamente punita. Eliminate gli omosessuali e il fascismo scomparirà”.
SINISTRISMO E RADICAL-CHIC.
Radical chic. Locuzione: Che riflette il sinistrismo di maniera di certi ambienti culturali d'élite, che si atteggiano a sostenitori e promotori di riforme o cambiamenti politici e sociali più appariscenti e velleitari che sostanziali.
Ecco come smascherare i radical chic 2.0 (in 12 punti), scrive Francesco Maria Del Vigo il 26 agosto 2014 su "Il Giornale". Qualche giorno fa, sul Giornale, ho pubblicato una lista in nove punti sui tic dei radical chic on line. Questa è la versione integrale:
La foto del profilo non è (quasi) mai una loro foto. Sarebbe troppo nazionalpopolare. Mettono solo frammenti di film di qualche regista polacco mai distribuiti fuori dalla circonvallazione di Varsavia.
Quando scelgono una loro immagine deve essere schermata da almeno cinque o sei filtri, avere delle velleità artistiche e magari ritrarre solo una parte del viso. Espressione sempre preoccupata per i destini del mondo. Il sorriso è bandito come un retaggio del ventennio berlusconiano.
L’oroscopo è un vizio da portinaia. Ma se si tratta di quello di Internazionale no. Lo condividono su tutti i social come se fosse il Vangelo.
Le foto delle vacanze vanno bene solo se si è nel terzo mondo o in un campo profughi. Pose obbligatorie: sguardo corrucciato, camuffati da indigeni e nell’atto di solidarizzare con gli abitanti del luogo. Il colore (degli abitanti del luogo) deve essere intonato alla nuance dei sandali Birkenstock.
Su Twitter parlano tra di loro di cose che capiscono solo loro. Sublimazione del sogno radical chic: l’esposizione mediatica del salotto (ovviamente etnico) di casa propria.
Sì al selfie, ma solo se ha un significato sociale e politico. Possibilmente con un cartello in mano che sostiene la battaglia di qualche gruppo di contadini ugandesi. Ancora meglio se su iniziativa di Repubblica.it.
La Reflex. Più che uno strumento fotografico è un monile, una collana da appendere al collo. Condividono e scattano foto solo con voluminosissime – e costosissime – macchine fotografiche professionali. Preferiscono Flickr a Instagram, troppo plebeo.
Il meteo è il prolungamento della politica coi mezzi della natura. Se piove non è colpa del governo ladro, ma dello scioglimento dei ghiacci dovuto al capitalismo diabolico. Condividere (sui social) per educare.
Il cibo non esiste. Esiste solo il food. Da fotografare e condividere sui social solo a tre condizioni: che sia a km 0 (va bene anche se è stato coltivato nella rotatoria di Piazzale Loreto), etnico o equo e solidale.
La petizione on line è la nuova e comodissima forma di contestazione. Va bene per risolvere tutti i problemi: dal cambio degli stuoini nel condominio (meglio sostituirlo con un piccolo kilim) alla fame nel mondo. Basta un click. Tutto il nécessaire è su Charge.org.
Film, libri, giornali. Tutto in lingua straniera. Molto chic condividere video di serie tv in lingua originale non ancora trasmessi in Italia. Appena oltrepassano le Alpi diventano rigorosamente pacchiane.
Anche Youporn è troppo pop. Forse anche sessista, potrebbe addirittura essere di destra con quello sfondo nero… Meglio ripiegare su siti soft porn o intellettual-erotici. Ammesso anche spulciare tra le pagine osè di Tumblr.
Le 9 differenze tra tamarri e radical-chic, scrive il 4 novembre 2014 Enrico Matzeu. (Gli stilisti mi evitano, le pr non mi invitano ai party più glamour. Scrivo sull’Oltreuomo per vendicarmi di loro.) La giungla umana è fatta di tante specie diverse, di tanti tipi umani che vengono costantemente tenuti sotto osservazione da antropologi e ornitologi. Tra queste specie, due meritano di essere analizzate con cura certosina: i Tamarri e i Radical-chic. Due categorie che come i binari della transiberiana non si incontreranno probabilmente mai. Entrambe le categorie si schifano a vicenda ed entrambe vanno orgogliose delle loro variopinte peculiarità. Ho provato con cura e garbo a sottolineare le differenze tra gli zarri e gli snob, nei nove ambiti dove emerge al meglio la loro personalità. Le 9 differenza tra Tamarri e Radical-chic:
1. Abbigliamento. I Tamarri doc vogliono stare comodi e si infilano i pantaloni della tuta anche per il matrimonio del cugino di ottavo grado (ah no, lì indossano i pantaloni della festa in finto acrilico traslucido). Le donne non rinunciano ai leggings, mai, neanche quando i leggings rinuncerebbero volentieri a loro. Entrambi portano con ossessione i gilet imbottiti, come fossero costantemente a bordo della Costa Concordia. I radical-chic invece portano la giacchia in velluto a costine anche in spiaggia, con camicette alla coreana e le immancabili Clarks. Per le donne l’abito asimmetrico di qualche stilista giappo-svedese è d’obbligo nell’armadio.
2. Vacanze. I Tamarri amano il sole più di se stessi e se d’inverno passano il tempo libero stesi su un lettino abbronzante, d’estate preferiscono di gran lunga le sdraio di polipropilene di Rimini e Riccione. I più internazionali svernano invece a Ibiza o Mykonos, sfoggiando costumini con sospensorio annesso o bikini tigrati. I radical-chic temono il sole più dell’ebola e se una volta amavano Capalbio ora preferiscono di gran lunga il Museo d’Orsey di Parigi o al massimo qualche sperduta isola del Mediterraneo a mangiare crudité di pesce e piatti bio.
3. Borse. I Tamarri amano indubbiamente accessori griffati, evidentemente griffati. Le donne non rinunciano al bauletto Louis Vuitton (meglio se tarocco) e gli uomini al borsello di Gucci (meglio se rubato). Per i radical-chic le borse sono unisex. Sia uomini che donne infatti usano quasi esclusivamente borse in tela, meglio se di qualche festival filosofico-cinefilo-letterario, ai quali probabilmente non sono neanche mai stati.
4. Ristoranti. Per i Tamarri sushi is the new pizza. Si abbuffano come bambini del Biafra in un qualsiasi all you can eat del quartiere e più ordinano più si sentono dei giusti. I radical-chic hanno smesso di mangiare il sushi da almeno tre anni. Ora si dedicano alla cucina vietnamita, alle hamburgerie dove si ordina con l’IPad o da Eataly, dove un ordine costa come un IPad.
5. Tatuaggi. I Tamarri si tatuano con gusto tutto il corpo come fosse una tela impressionista (nel senso che fa impressione). Partono con un tribale sui bicipiti e finisce che si colorano anche la mano con il viso della nonna defunta. Le iniziali del proprio amato sono indispensabili e diventano un marchio a fuoco come per le vacche. I radical-chic invece si dividono tra quelli che vogliono il tattoo old school, con marinai e sirene (che neanche nei Pirati dei Caraibi), oppure puntano sui tatuaggi minimalisti, fatti di disegni stilizzati o schizzi di Mirò.
6. Occhiali da sole. Un Tamarro come si deve si distingue anche e soprattutto da un paio di occhiali da sole. Per la regola che più grosso ce l’hai (l’occhiale) più sei figo, al Tamarro tipo piace esagerare, con montature che invadono la faccia, peggio di Putin con l’Ucraina, e lenti specchiate che ti riflettono pure le adenoidi. Il radical-chic non rinuncia ai suoi Rayban, meglio se tartarugati, pieghevoli, vintage, in limited edition e con la cordicella al collo. Sia mai li perdano.
7. Musica. Da adolescenti la musica dance è per i Tamarri come l’insulina per i diabetici: questione di vita o di morte. Crescendo, si affezionano ai neo melodici italiani, possibilmente amici della De Filippi o con almeno un paio di date in America Latina. I radical-chic citano De André, Guccini e Battiato ogni tre per due, spesso confondendoli tra loro e odiano tutto ciò che è pop (talvolta addirittura i pop-corn). Frequentano club con musica dal vivo e non si perdono i concerti dei gruppi più indie del momento, anche di quelli che non conoscono.
8. Libri. Diciamocelo, i Tamarri leggono più volentieri le riviste scandalistiche (o scandalose) dei libri, però se proprio devono entrare in una libreria ne escono con la biografia di qualche calciatore, qualche libro di aspiranti motivatori e naturalmente il libro dell’Oltreuomo. I radical chic millantano sempre letture impegnate e impegnative e sui loro comodini ci sono pile e pile infinite di libri, tra i quali si leggono titoli di Kafka, Hesse e Tolstoj, ma in fondo, messo al contrario, un po’ nascosto c’è sempre una delle novità letterarie di Fabio Volo. I radical-chic in salotto hanno sempre l’ultimo libro fotografico di Oliviero Toscani. Ottimo soprammobile.
9. Sport. La palestra è per i Tamarri come la Mecca per i musulmani. Quando entrano però loro non si tolgono le scarpe perché devono sfoggiare le ultime sneakers giallo fluo con i lacci fucsia e le canotte ascellari. Bicipiti, tricipiti e addominali devono essere tonici e tirati più della pelle di un tamburo e sfoggiati sotto a camicie e t-shirt aderenti dal dubbio gusto. I radical-chic boicottano la palestra perché la ritengono anticostituzionale e preferiscono di gran lunga la corsa, possibilmente al Central Park di New York o il tennis, perché si possono indossare quei gonnellini tanto chic.
Radical chic. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Radical chic è un'espressione idiomatica mutuata dall'inglese per definire gli appartenenti alla borghesia che per vari motivi (seguire la moda, esibizionismo o per inconfessati interessi personali) ostentano idee e tendenze politiche affini alla sinistra radicale o comunque opposte al loro vero ceto di appartenenza. Per estensione, la definizione di radical chic comprende anche uno stile di vita e un modo di vestirsi e comportarsi. Un atteggiamento frequente è l'ostentato disprezzo del denaro, o il non volersene occupare in prima persona quasi fosse tabù, quando in realtà si sfoggia uno stile di vita che indica un'abbondante disponibilità finanziaria o improntato al procacciamento dello stesso con attività che, qualora osservate in altri, un radical chic non esiterebbe a definire in modo sprezzante, come volgarmente lucrative. Inoltre tale atteggiamento sovente si identifica con una certa convinzione di superiorità culturale, nonché con l'ostinata esibizione di tale cultura "alta", o la curata trasandatezza nel vestire e, talora, con la ricercatezza nell'ambito di scelte gastronomiche e turistiche; considerando, insomma, come segno distintivo l'imitazione superficiale di atteggiamenti che furono propri di certi artisti controcorrente e che, ridotti a mera apparenza, perdono qualsiasi sostanza denotando l'etichetta snobistica. La definizione radical chic fu coniata nel 1970 da Tom Wolfe, scrittore e giornalista statunitense. Il 14 gennaio di quell'anno, Felicia Bernstein, moglie del celebre compositore e direttore d'orchestra Leonard Bernstein, organizzò un ricevimento di vip e artisti per raccogliere fondi a favore del gruppo rivoluzionario marxista-leninista Pantere Nere (alcuni membri delle Pantere Nere furono invitati al ricevimento). Il party si tenne a casa dei Bernstein, un attico di tredici camere su Park Avenue (un ampio viale di Manhattan). Tom Wolfe scrisse un ampio resoconto sulla serata, descrivendo in modo molto critico gli invitati, rappresentanti dell'alta società newyorchese. Ne risultò un articolo di 29 pagine pubblicato sul New York Magazine dell'8 giugno 1970. In Italia, l'espressione fu ripresa da Indro Montanelli nel celebre articolo Lettera a Camilla, in forte polemica con la giornalista Camilla Cederna, quale ideale rappresentante dell'italico "magma radical-chic", superficiale e incosciente culla degli anni di piombo. In seguito, egli chiarì che la vera destinataria della lettera aperta era invece Giulia Maria Crespi, allora padrona del «Corriere della Sera» e amica della Cederna, con la quale i dissidi sarebbero sfociati, l'anno seguente, nell'allontanamento di Montanelli dal quotidiano di via Solferino, dove lavorava sin dal 1937. A parte l'adozione del neologismo, l'argomento era già stato affrontato da Montanelli in vari scritti, nei quali lamentava la frivola ideologia sfoggiata da certa borghesia ricca e pseudo-intellettuale lombarda, facendone anche un ritratto tragicomico nella pièce teatrale Viva la dinamite! (1960).
Cosa sono i radical chic? Scrive Luca Sofri il 29 agosto 2014 su "Il Post". In teoria non "sono": abbiamo trasformato noi un'espressione inventata da Tom Wolfe nel 1970 e che ormai è usata lontanissimo dal suo senso. Nella rituale e un po’ ammuffita terminologia del dibattito pubblico italiano prospera da decenni con minore o maggiore frequenza l’espressione “radical chic”, usata prevalentemente in modo offensivo e dispregiativo, per indicare la presunta incoerenza di persone che si dicono politicamente di sinistra ma hanno redditi maggiori di quelli che un luogo comune anacronistico attribuirebbe ai militanti di sinistra. Proprio perché il termine è usato quasi sempre per polemica e con intenzioni aggressive, la coerenza del suo uso non è di solito rilevante: è diventato un insulto come un altro. Ma la sua storia è interessante, così come quella della nebbia semantica in cui è poi finito ora che viene usato spesso a caso e per mille cose diverse tra loro. Il termine “Radical chic” è formato dalla parola inglese “radical” – che vuol dire “radicale” nel senso dell’intensità dell’attivismo e degli obiettivi politici – e da quella francese “chic”, “raffinato”. Nella definizione del dizionario Treccani è sia un aggettivo che un sostantivo, e indica: «che o chi per moda o convenienza, professa idee anticonformistiche e tendenze politiche radicali». L’Oxford Dictionary precisa (in inglese “radical chic” è un concetto, non una persona): si tratta «dell’ostentazione», molto alla moda, di idee e visioni «radicali e di sinistra». Radicale, per moda. Wikipedia esplicita un terzo elemento: al concetto di “radical chic” è associata anche la ricchezza. Il “radical chic” appartiene «alla ricca borghesia» o proviene «dalla classe media» e «per seguire la moda, per esibizionismo o per inconfessati interessi personali, ostenta idee e tendenze politiche affini alla sinistra radicale (come il comunismo) o comunque opposte al suo vero ceto di appartenenza». Spiegazione che si può sbrigativamente riassumere nella frase “fai il comunista con il maglione di cachemire” (sinistra in cachemire è una delle diverse varianti usate per concetti simili, come gauche-caviar o champagne socialist). La versione inglese di Wikipedia dice che il “radical chic” è un esponente della società, dell’alta società e della mondanità impegnato a dare di sé un’immagine basata su due pratiche: da una parte quella di definire sé stesso attraverso la fedeltà e l’impegno ad una causa, dall’altra a esibire questa fedeltà perché quella stessa causa è alla moda e qualcosa di cui si preoccupa (anche tra i ricchi). Per il termine “Champagne socialist” Wikipedia spiega una cosa uguale e simmetrica: non un ricco che si atteggia artificiosamente a persona di sinistra, ma uno di sinistra che è ricco e ha abitudini da ricco in contraddizione con i suoi pensieri. Nell’uso comune, in italiano, “radical chic” è usato per definire entrambi i casi. L’introduzione della definizione di “radical chic” viene attribuita storicamente allo scrittore e giornalista americano Tom Wolfe che sul New York Magazine del giugno 1970 pubblicò un lunghissimo articolo intitolato “Radical Chic, That Party at Lenny’s”. Wolfe fece un resoconto del ricevimento che qualche mese prima Felicia Bernstein, moglie del compositore e direttore d’orchestra Leonard, organizzò per raccogliere fondi a sostegno del gruppo rivoluzionario delle «Pantere nere». La festa si svolse a casa dei Bernstein, in un attico su Park Avenue, a Manhattan. Erano presenti molte personalità che provenivano dal mondo della cultura e dello spettacolo newyorchese e i camerieri in livrea (camerieri bianchi per non offendere gli ospiti afroamericani) servivano tartine al Roquefort. Dopo una breve introduzione, la prima parte del racconto di Tom Wolfe inizia così: «Mmmmmmmmmmmmmmmm». Sedici lettere, un’onomatopea per esprimere l’aria di appagamento che circolava in quella serata, ma anche che cosa Wolfe intendesse per “radical chic”: una specie di corrente, di moda, di milieu, un matrimonio pubblico molto ridicolo tra la buona coscienza progressista delle classi più ricche e la politica di strada, un corto circuito in cui alcuni rischiavano davvero, per le loro idee, e altri invece non rischiavano niente e in cui c’era l’illusione di una collaborazione e contaminazione tra diversi mondi e diverse classi sociali. La serata fu molto criticata: un editoriale del New York Times sostenne che aveva offeso e arrecato danno a quei neri e a quei bianchi che «lavorano seriamente per la completa uguaglianza e la giustizia sociale», Felicia Bernstein rispose pubblicamente difendendo la sua festa. Fatto sta che il termine usato da Wolfe per descrivere l’atteggiamento dei Bernstein si diffuse ben presto in tutto il mondo, e in Italia si radicò ancora più che altrove e prese a indicare, in maniera inesatta, una persona o un atteggiamento, diventando anche aggettivo. L’espressione fu ripresa sul Corriere della Sera il 21 marzo del 1972 da Indro Montanelli in un famoso articolo intitolato “Lettera a Camilla” e rivolto a Camilla Cederna, la giornalista italiana che si era occupata della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato dalla questura di Milano dove si trovava accusato innocente dell’attentato di Piazza Fontana nel 1969. Montanelli descrisse Cederna così. «C’è chi dice che, più delle bombe, ti sei innamorata dei bombaroli, e questo, conoscendo i tuoi rigorosi e severi costumi, posso accettarlo solo se alla parola “amore” si dia il suo significato cristiano di fratellanza […]. Fino a ieri testimone furtiva o relatrice discreta di trame e tresche salottiere, arbitra di mode, maestra di sfumature, fustigatrice di vizi armata di cipria e piumino, ora si direbbe che tu abbia sempre parlato il gergo dei comizi e non sappia più respirare che l’aria del Circo. Ti capisco. Deve essere inebriante, per una che lo fu della mondanità, ritrovarsi regina della dinamite e sentirsi investita del suo alto patronato. Che dopo aver tanto frequentato il mondo delle contesse, tu abbia optato per quello degli anarchici, o meglio abbia cercato di miscelarli, facendo anche del povero Pinelli un personaggio della café society, non mi stupisce: gli anarchici perlomeno odorano d’uomo anche se forse un po’ troppo. Sul tuo perbenismo di signorina di buona famiglia, il loro afrore, il loro linguaggio, le loro maniere, devono sortire effetti afrodisiaci. Una droga». Montanelli, con la sua sgradevole descrizione contribuì già allora in realtà a far scivolare il concetto originario di “radical chic” verso la confusione condivisa che sta oggi intorno a questa espressione. Che rapidamente fu fatta propria da chi a destra voleva accusare qualcuno di sinistra di scarsa coerenza e successivamente adottata nelle polemiche interne alla sinistra quando il mondo cominciò a cambiare e gli elettori di sinistra smisero di essere prevalentemente “proletariato” in senso stretto. Negli ultimi anni, con lo sviluppo di maggiori contraddizioni nella sinistra italiana di fronte a grossi cambiamenti, ma anche legata a tradizioni radicate, l’accusa è tornata a essere usata molto proprio a sinistra come contraltare di tutti i richiami alla “vicinanza al territorio”, “ai problemi della gente”, stimolata dai fallimenti delle dirigenze politiche della sinistra in questo periodo. E un generale antintellettualismo in grande crescita è stato un altro fattore che ha alleato nell’uso del termine sia leader della sinistra radicale che politici e stampa di destra, per attaccare da parti opposte gli esponenti della sinistra più riformista. Così oggi “radicalscìc” è diventato un insulto di uso comunissimo e destinato a persone dai redditi più vari e dalle posizioni più articolate. Con la contraddizione che oggi i principali destinatari dell’epiteto sono persone che hanno posizioni niente affatto radicali, anzi sono gli oppositori della sinistra radicale: l’uso più convincente del termine negli anni passati è stato quello destinato a Fausto Bertinotti, un uomo in effetti elegante e di modi garbati, coi pullover di cachemire e posizioni di estrema sinistra; mentre quando lo si dice per esempio a persone come Matteo Renzi, per niente radical e nemmeno straordinariamente chic, il senso è definitivamente stravolto.
Il corso per diventare un vero radical-chic. Sul web impazza una locandina che promette fantomatiche lezioni. L'obiettivo: incarnare perfettamente lo stereotipo nel minor tempo possibile, scrive il 6 Dicembre 2013 "Libero Quotidiano”. Il radical-chic. Una figura che accompagna gli "anni duemila". Rigorosamente di sinistra (ma critico con la sinistra stessa), snob ma finto alternativo, con la puzza sotto al naso, un po' terzomondista ma elitario, molto tollerante soltanto a parole, il radical-chic è odiato da tutti: da chi non lo è e da chi, invece, ne incarna lo stereotipo. Già, perché il radical-chic, essenzialmente, disprezza e denigra, ottenebrato da una sorta di nichilismo illuminante di cui lui, e solo lui, è dotato in abbondanza. Non è semplice essere un radical-chic. Ci vogliono anni di studio, le giuste frequentazioni, una certa inclinazione. Ma da oggi imparare è possibile. Almeno questo è quanto promette una locandina che circola sul web, e che nel tam-tam di Twitter e Facebook ha già avuto un certo successo. Si tratta del "Primo corso di Radical Chic". Sottotitolo: "L'unico corso con attestato riconosciuto a livello nazionali". La promessa: "Impara tutti i segreti per sc... le donne più insipide del sistema solare in sole 10 lezioni da dieci ore". L'omaggio: "I primi 10 iscritti riceveranno in omaggio la guida Diventa buddista in un'ora". I contenuti - Nel mirino, insomma, tutti gli stereotipi molto radical e altrettanto chic: quello appena citato buddismo, quello sulle donne (quelle radical-chic, sia chiaro) molto insipide e quello relativo all'ambizione (malcelata) dei radical-chic, ossia fare l'amore il più possibile (anche se le parole usata per indicare la "circostanza" è ben più volgare). La locandina entra poi nel merito del corso, in cui si imparerà "come curare al peggio barba e capelli", "come metterci ore a capire come vestirsi per sembrare uno che si butta addosso la prima cosa nell'armadio". S'apprenderà poi "l'importanza del velluto a costine e del cachemire", e verrò chiarito l'amletico dubbio: "Clarks o mocassini?". E ancora, verrete illuminati sull'"importanza dell'abbinamento aperitivo-bio e musica jazz", nonché su "tutti i vini buoni, i cantautori, teatri, viaggi da citare", e sempre in termini di viaggi due regioni non avranno più segreti grazie al corso di geografia "dettagliato di Toscana e Umbria". Altri temi utili per la formazione: "Pere e formaggio, parliamone" e "le migliori supercazzole da pronunciare per fare colpo al primo approccio". Quindi una lezione su "tutte le parole più impressionanti, quali: Flaubert, sushi, Moleskine e tante altre!". Infine un seminario su "come raggiungere in bicicletta le mostre di fotografia, presentazioni di libri e sale d'essai più scrause dell'intera Ue" e "come mettere in atto la rivoluzione del salotto di casa propria". Il tutto, conclude la locandina, con una "quota d'iscrizione promozionale a 5.000 euro per il primo ciclo di lezioni (Iva esclusa)".
Ebbene sì, siamo radical-chic, scrive Eugenio Scalfari il 10 aprile 2012 su “L’Espresso”. L'etichetta che la destra populista ci affibbia come un insulto, per noi è diventata un motivo d'onore. Perché si riferisce a una cultura laica, eterodossa e ironica. Che guarda a Voltaire, Keynes, Einstein e Roosevelt. Fino a qualche tempo fa per definire un tipo bizzarro e "con la puzza sotto il naso" rispetto alle mode e ai comportamenti altrui si usava la parola snob. Non c'era altro modo e altro termine. Sebbene l'origine di quella parole fosse "sine nobilitate" il significato semantico era cambiato, anzi si era capovolto. Lo snob una sua nobiltà l'aveva: disprezzava l'uomo medio, la cultura tradizionale, i luoghi comuni, l'oleografia del passato. Disprezzava anche i buoni sentimenti o comunque li metteva in gioco. Spesso gli artisti erano definiti snob quando rompevano le regole del consueto. Quello che fu marcato con questo termine con maggiore insistenza degli altri fu Oscar Wilde, un po' per il suo modo di pensare e di scrivere e molto per la sua dichiarata e ostentata omosessualità che gli costò la prigione e l'esilio. Ma anche Dalí, anche Ravel, i surrealisti e molte "avanguardie" furono giudicati esempi di snobismo e perfino Proust, "lo sciocchino del Ritz". Durante il fascismo e la sua cultura muscolare i giornali satirici descrivevano lo snob come un gentleman passatista con le ghette sulle scarpe e il monocolo all'occhio. Adesso però quella definizione è stata sostituita da un'altra: non si dice più snob ma invece radical-chic. Non è un sinonimo, c'è qualche cosa in più ed è una dimensione politica: il radical-chic è di sinistra. Di una certa sinistra. Per guadagnarsi quella definizione deve stupire e spiazzare anzitutto la vera sinistra che, per antica definizione, si identifica con l'ideologia marxista. Togliatti - tanto per dire - non è mai stato neppure lontanamente considerato un radical-chic né Berlinguer, né Amendola o Ingrao. Bertinotti? Lui sì, gli piacciono i salotti, gli piacciono i pullover di cashmere e va spesso in giro con Mario D'Urso che è uno "chic" riconosciuto. Ma i veri radical-chic sono gli amici e i consimili di Camilla Cederna. Dunque stiamo parlando di noi, che fondammo questo giornale 57 anni fa e ne facemmo quello che è ancora oggi, un giornale di ricerca costante della verità, di denuncia delle brutture e delle malformazioni del malgoverno, di difesa dell'etica pubblica e di impegno civile. Accoppiando però, nel linguaggio, nella grafica, nella scelta delle fotografie, una vena di ironia e di autoironia, una leggerezza di stile che nulla doveva avere del sermone da sacrestia. Vedi caso: il partito radicale nacque nelle stanze del "Mondo" e de "l'Espresso" nel 1956, visse sei anni e si sfasciò nel '62. Marco Pannella e i suoi amici, che ne facevano parte, decisero di continuare con lo stesso "logo" del cappello frigio, dandogli però un contenuto più libertario che liberale. I radical-chic sono una definizione coniata dalla destra populista e qualunquista che però ha trovato qualche corrispondenza anche nel marxismo ufficiale. Quando il gruppo de "Il Manifesto" fu espulso dal Pci, c'era contro di loro una vaga ma percepibile aura di puritanesimo luterano contro un'eterodossia che irrideva gli schemi ideologici e amava Lichtenstein, la musica di Schönberg e perfino - perfino - i salotti. Non erano affatto radical-chic quelli del "Manifesto" ma tali li considerò la segreteria del Pci che li buttò fuori. Quanto a cultura i radical-chic sono illuministi e voltairiani, tra i loro personaggi di culto campeggiano Einstein, Keynes e Roosevelt. La definizione di radical-chic all'inizio gli sembrò insultante ma adesso se ne sentono onorati vista la sponda da dove proviene.
Radical choc, scrive Annalena Benini il 15 Aprile 2011 su “Il Foglio”. Alberto Asor Rosa si è sbagliato: pensava di essere a una cena après-concert, in cui ci si ritrova nel proprio ambiente, sicuri di essere compresi nella teorizzazione mondana del colpo di stato. Purtroppo il professore stava sbadatamente scrivendo su un quotidiano, e in questi casi diventa “complicato far capire a chi è fuori dall’ambiente come simili bisogni apparentemente volgari siano assoluti” (lo scriveva Tom Wolfe nel 1970 in “Radical Chic. Il fascino irresistibile dei rivoluzionari da salotto”, a proposito della necessità dei rivoluzionari dell’East Side di avere un posto dove andare il fine settimana, in campagna o al mare, di preferenza tutto l’anno, ma necessariamente da metà maggio a metà settembre). L’urgenza di un golpe da salotto è pari, per intensità, almeno all’impresa della ricerca dei domestici (in “Radical Chic” dovevano essere bianchi, per non urtare i sentimenti delle Black Panther durante i party). Sono cose futili e grevi insieme, quindi allarmanti: bisogna pensare intensamente a Mario Missiroli, storico direttore del Corriere della Sera, quando diceva: “In Italia non si potrà mai fare la rivoluzione, perché ci conosciamo tutti”, per non prendere completamente sul serio le incitazioni al golpe contro Silvio Berlusconi di uno scrittore Einaudi. L’idea di avvalersi dei Carabinieri e della Polizia di stato (per congelare le Camere, sospendere tutte le immunità parlamentari e dare alla magistratura le sue possibilità e capacità di azione, stabilire d’autorità nuove regole elettorali), è geniale, perché consente di salire sul cellulare della Polizia e andare alla guerra civile con lo chauffeur, ristabilendo così la più profonda vocazione democratica senza seccature di parcheggio o di tassametro. Ci sarà però il problema di come vestirsi: non si può esagerare con le mise da teatro, troppo frivole, che potrebbero per sbaglio richiamare certe serate berlusconiane, ma non si può nemmeno arrivare vestiti tipo “boccone del povero”, con una qualche orribile accoppiata dolcevita-jeans (data anche l’età veneranda dei golpisti), quindi il consueto abbigliamento accademico è da preferire: un tweed, per esempio, ma se i Carabinieri marciano sul Parlamento dopo mezzogiorno, il tweed è già inadatto. Bisognerà accordarsi per un’ora sobria, ma non da levatacce di operai con le borse sotto gli occhi e cattivi caffè preparati da mogli scarmigliate: le dieci e mezzo del mattino, ecco l’ora perfetta per un golpe, dà un senso di attivismo e di zelo, ma rilassato, un po’ come gli orari delle lezioni all’università. Sarà elettrizzante e romantico (purché a debita distanza dal popolo e dalle provocazioni sulla sovranità dei cittadini e del Parlamento), sarà finalmente una cosa fatta come si deve, senza mezze misure, con la gente giusta, gli sguardi severi, le barbe curate, i baffi bianchi, foto intense nei risvolti di copertina, certi deliziosi cocktail après-golpe. Resta però quel piccolo tarlo, che già impensieriva i radical chic di Tom Wolfe nelle donazioni alle Black Panther: la rivoluzione non è fiscalmente detraibile.
Libri. “Radical Chic. Conoscere e sconfiggere il pensiero unico globalista” de La Via Culturale, scrive il 29 aprile 2017 Jaap Stam su "Barbadillo. Il 24 aprile è uscito “Radical Chic. Conoscere e sconfiggere il pensiero unico globalista” (ed. La Vela, pp 176, euro 12), l’ultimo libro di Alessandro Catto, blogger su Il Giornale e fondatore del blog “La Via Culturale”. Di seguito pubblichiamo un estratto del libro, che elabora una forte critica verso il pensiero unico. “Populismo, demagogia, fascismo, chiusura mentale, provincialismo: termini che ultimamente vengono utilizzati in maniera dozzinale contro chi cerca di porre un argine al processo di globalizzazione. E’ il paradosso di una democrazia accettata solamente quando corrisponde agli auspici di una classe autodefinita democratica e tollerante ma capace di occupare spazi informativi, tribune politiche e istituzioni in maniera impropria e di impedire un reale e aperto confronto sui rischi del presente. Sono i paradossi di chi, antifascista in assenza di fascismo, in un’astratta idra di internazionalismo del mercato giustifica e promuove le peggiori distorsioni ai processi democratici e ai diritti sociali dei popoli occidentali. In capitoli brevi, ironici e frizzanti si fa luce su un fenomeno, quello liberal, che sta subendo una profonda ridiscussione ma che ancora oggi non è pienamente conosciuto, nemmeno dai suoi contestatori. Il presente volume analizza la nascita, la crescita e lo sviluppo di una sinistra che spesso ha finito con l’adottarne lo stile e i contenuti, astraendosi pure dalla sua missione storica, quella della difesa delle fasce sociali più deboli e del lavoro. Radical Chic è il libro ideale per capire il vero retroterra politico e culturale del pensiero unico politicamente corretto. Dall’istruzione all’economia, dalla storia all’attualità, dalla geopolitica alla cultura, vengono sfatati in modo leggero e divertente tutti i miti pro-global ai quali siamo quotidianamente esposti e le loro pretestuose retoriche, sempre più incapaci di nascondere il distacco tra l’alto e il basso della nostra società, tra chi con il cosmopolitismo imperativo per tutti ci guadagna e chi, ogni giorno, perde diritti, spazi democratici e possibilità di emancipazione a casa propria”.
Ecco “Radical Chic”, il libro contro il pensiero unico politicamente corretto, scrive Alessandro Catto il 3 maggio 2017 su “Il Giornale". Si chiama Radical Chic ed è il nuovo libro de La Via Culturale. Edito dalla casa editrice La Vela, è il libro ideale per capire il vero retroterra politico e culturale del pensiero unico politicamente corretto. Dall’istruzione all’economia, dalla storia all’attualità, dalla geopolitica alla cultura vengono sfatati tutti i miti pro-global ai quali siamo quotidianamente esposti e le loro pretestuose retoriche, sempre più incapaci di nascondere il distacco tra l’alto e il basso della nostra società, tra chi con il cosmopolitismo imperativo per tutti ci guadagna e chi, ogni giorno, perde diritti, spazi democratici e possibilità di emancipazione a casa propria. Populismo, fascismo, chiusura mentale, provincialismo: nel volume si parla anche dell’abuso di questi termini, utilizzati in maniera dozzinale contro chi cerca di porre dei paletti alla retorica della globalizzazione. Il paradosso di una democrazia accettata solamente quando corrisponde agli auspici di una classe autodefinita democratica e tollerante ma capace di occupare spazi informativi, culturali e politici in maniera impropria, impedendo un reale e aperto confronto sui rischi del presente. Nel perenne paravento dell’antifascismo in assenza di fascismo, la storia di una pseudosinistra che spesso ha finito con l’astrarsi pure dalla sua missione storica, quella della difesa delle fasce sociali più deboli e del lavoro. Un libro di 170 pagine suddiviso in brevi e frizzanti capitoletti, di facile lettura e privo di approcci accademici o troppo complessi, fruibile da tutti e capace di fare veramente luce su di un fenomeno, quello liberal e politically correct, così importante nel presente dell’Europa ma ancora poco conosciuto, soprattutto da chi tenta di costruire una alternativa.
Quei radical chic della sinistra da salotto schierati dalla parte dei tassisti del mare…, scrive Franco Busalacchi il 2 maggio 2017 su "I Nuovi Vespri". Sarà perché mio nonno fu assassinato da un fascista, sarà perché mio zio ha fatto la resistenza in Lombardia con in tasca la tessera del PCI firmata da Palmiro Togliatti, ma io a questi nipotini di Bertinotti li manderei tutti, prima dell’alba, a raccogliere pomodoro nelle serre e nei campi in sostituzione di quei migranti il cui arrivo è per loro una benedizione. Sarà perché mio nonno fu assassinato da un fascista e mio zio (suo figlio) fece la Resistenza, muovendosi per tutta la Lombardia con in tasca una tessera del Partito comunista datata 1943, firmata da Palmiro Togliatti e rinnovata nei due anni successivi, rischiando di essere fucilato sul posto se l’avessero beccato; sarà per la conseguente aura che si è respirata sempre in casa mia, ma quando io sento uno di questi nostri comunisti con la barca e la erre moscia, mi incazzo come un animale. Tutti questi radical chic, nipotini di Bertinotti, il quale ancora, tra una rivoluzione in salotto e un’altra, percepisce una cospicua, aggiuntiva indennità come ex Presidente della Camera dei deputati, io li porterei una bella mattina, prima dell’alba, a raccogliere pomodoro nelle serre e nei campi in sostituzione di quei migranti il cui arrivo è per loro una benedizione. Sepolcri imbiancati che fanno del buonismo a buon mercato una bandiera con la quale coprono la loro ipocrisia. Tutti dalla parte dei tassisti del mare che speculano sulle disgrazie altrui. A questo si è ridotto il messaggio del Sol dell’avvenir: “Impossibilitati fare rivoluzione per mancanza tempo, auspichiamo e ribadiamo… Ci vediamo stasera da Giangi”. Ve li immaginate questi manichini azzimati capeggiare una sfilata (non una marcia, ovviamente) contro la Beretta, la Agusta, la Oto Melara, gruppi economici che vendono armi a quelli che sparano sulle popolazioni che sono costrette lasciare i loro Paesi? Per carità! Troppo complicato. “Primavera d’intorno brilla nell’atria e per li vampi esulta. E’ tempo di granite e di brioscine. Al bar si pontifica meglio davanti ad un Cuba libre ornato di un parasole in miniatura.
Se li sentisse Lèon Bloy!
Quel razzismo immaginario dei radical-chic. L’escalation della cacciata degli italiani è talmente evidente che i buonisti replicano solo con la solita accusa ad minchiam di razzismo, scrive Ennio Castiglioni il 28 Aprile 2017 su "Il Populista". Pascale Bruckner ci ha spiegato come esista un “razzismo immaginario”. Per soffocare la libertà, il dibattito si grida subito al razzismo e si trascinano le persone in tribunale come nei regimi totalitari. I Governi e le multinazionali ci vogliono così nascondere come sia in atto un piano per modificare profondamente l’occidente e far sparire gli italiani. Se vi sembra poco…Mentre dalla Libia, dove ci sarebbero tra 700mila e un milione di migranti, continua l’invasione con ben 37mila arrivi nei mesi più freddi dell’anno, il Governo con grande solerzia prepara l’accoglienza. È scritto a chiare lettere nel DEF (Documento di economia e finanza) 2016 l’intento di favorire, piuttosto che arrestare questo esodo mirato. Si cerca di reperire le risorse necessarie a sostenere un flusso migratorio di circa 310mila unità, con un profilo crescente per i prossimi 15 anni. L’escalation della cacciata degli italiani è talmente evidente che si può replicare solo con la solita accusa ad minchiam di razzismo. Se nel 1994 gli immigrati regolari erano 500mila, nel 2016 sono oltre 5 milioni e si vuole consentire l’ingresso ad altri 310mila all’anno per i prossimi 15 anni, nel 2031 ci saranno quasi 10 milioni di immigrati, il 17% della popolazione, mentre chi avesse la fortuna (o la sfiga) di campare fino al 2065 vivrà in un’Italia dove uno su tre sarà immigrato. Ormai le navi delle varie Ong non si limitano più al salvataggio in mare, ma si spingono nelle acque libiche dove regolarmente prelevano i migranti per trasportali sulle coste italiane. Il tutto con la complicità dei canali di informazione ufficiali e con un Governo che si guarda bene dal mobilitare la Marina Militare o la Guardia Costiera. Molti politici italiani, mentre si fingono commossi di fronte alle immagini di morte nel Canale di Sicilia continuano ad essere al servizio delle multinazionali, che versano enormi somme di denaro alle loro Fondazioni. Queste immense società dove il profitto e la speculazione finanziaria hanno ormai oscurato la figura dell’uomo e cancellato ogni questione morale, necessitano di un costante apporto di manodopera a basso costo, di giovani braccia da sfruttare. Se diamo un’occhiata oltre Oceano vediamo ben 97 società del settore tech, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Snap e così via, che hanno chiesto ai tribunali di bloccare l’esecuzione dei decreti presidenziali, voluti da Donald Trump, per regolare l’immigrazione. Avrebbero potuto avanzare al grido “Non toglieteci gli schiavi!” L’Italia, se non dovesse accadere qualcosa, ad esempio un Governo a guida Salvini, diventerà ben presto un Paese di braccianti africani, di religione islamica, da utilizzare per pochi euro all’ora. Chi dice questo viene accusato di essere uno sporco razzista? Beh, francamente, con la posta in gioco, chi se ne frega!
PARLIAMO DI LEGALITA'. LA REPUBBLICA DI ZALONE E DI FICARRA E PICONE.
Checco Zalone, La prima Repubblica è la colonna sonora di Quo Vado? Scrive Giulio Pasqui lunedì 21 dicembre 2015. Checco Zalone non solo ci ha aiutati a film sbanca-botteghino, ci ha abituati anche a colonne sonore, scritte e cantate dallo stesso, degne di nota. E Quo Vado?, il nuovo film prodotto da TaoDue e distribuito da Medusa, poteva farne a meno? Ovviamente no. Domenica 20 settembre, in occasione dell'ospitata a Che tempo che fa, il comico barese ha presentato La prima Repubblica. "E' una canzone che ho scritto per Adriano Celentano - ha detto, scherzando - è il mio mito di sempre. Ma c'è un problema: lui non lo sa. Ha un ritornello orecchiabile...". E in effetti alcuni passaggi del brano/colonna sonora ricordano tanto lo stile del Molleggiato e Fatti mandare dalla mamma. La Prima Repubblica viene definito come "un brano apocrifo che racconta con nostalgia quello che era il modo di vivere in Italia negli anni ‘80. Lo stile di vita di un paese che durante la Prima Repubblica viveva spensierato, godendo di un modo di fare diffuso in tutta la penisola. E’ un coro di persone felici che cantano allegramente la bellezza di quei momenti passati, non potendo scordare le consuete modalità che per un ventennio hanno caratterizzato l’Italia, diventando così il DNA del nostro Paese. Perché tutto cambia, ma in realtà nulla cambia veramente".
Checco Zalone, La prima Repubblica, Lyrics
La prima Repubblica
non si scorda mai
la prima Repubblica
tu cosa ne sai
Dei quarantenni pensionati
che danzavano sui prati
dopo dieci anni volati all'aeronautica
e gli uscieri paraplegici saltavano
e i bidelli sordo-muti cantavano
e per un raffreddore gli davano
quattro mesi alle terme di Abano
con un'unghia incarnita
eri un invalido tutta la vita
La prima Repubblica
non si scorda mai
la prima Repubblica
tu cosa ne sai
Dei cosmetici mutuabili
le verande condonabili
i castelli medioevali ad equo canone
di un concorso per allievo maresciallo
sei mila posti a Mazzara del Vallo
ed i debiti (pubblici) s'ammucchiavano
come i conigli
tanto poi
eran cazzi dei nostri figli
Ma adesso vogliono tagliarci il Senato
senza capire che ci ammazzano il mercato
senza Senato non c'è più nessun reato
senza reato non lavora l'avvocato
il transessuale disperato
mi perdi tutto il fatturato
ed al suo posto c'è un Paese inginocchiato
Ma il Presidente è toscano
ell'è un gran burlone
ha detto “eh, scherzavo”
piuttosto che il Senato
mi taglio un coglione
La prima Repubblica
non si scorda mai
la prima Repubblica
era bella assai
la prima Repubblica
non si scorda mai
la prima Repubblica
tu che ne sai
Ma davvero Quo Vado di Checcho Zalone racconta l'Italia di oggi? Il 1° gennaio arriva l'attesissimo nuovo film di Checco Zalone, "Quo vado?", atteso dai fan ma anche dagli esercenti dal momento che il suo ultimo film ha incassato la cifra record di 51 milioni di euro. Il nuovo film racconta la storia di Checco, un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita: vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza, rimanere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità, un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Un giorno però tutto cambia: il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province, Checco viene trasferito al Polo Sud. Il regista e attore barese ha scelto però di non fare promozione tradizionale e al posto del trailer sta diffondendo sulla sua pagina Facebook dei piccoli spot ironici autopromozionali. Il film comico spiega il Paese meglio degli studiosi secondo alcuni osservatori. Abbiamo chiesto a uno di loro, Ilvo Diamanti, che ne pensa, scrive Ilvo Diamanti il 15 gennaio 2016 su "L'Espresso". Ho assistito con attenzione “professionale” alla proiezione di “Quo vado?”, il film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante. Naturalmente, io non sono un critico cinematografico. E neppure un esperto. Lo ero, di più, da giovane, quando seguivo e, a volte, conducevo i cineforum, nella provincia veneta. Ma, poi, il lavoro e i viaggi (per lavoro: insegno in sedi universitarie diverse, lontane da dove risiedo) hanno preso il sopravvento. E ho ripiegato sui dvd e sugli streaming. Che ti seguono nei viaggi e in ogni trasferta. Anche se i film vanno guardati nelle sale cinematografiche. Al buio, in silenzio. Così, da qualche anno, anzi, da molti anni, al cinema ci vado saltuariamente. Spinto da mia moglie. Perlopiù, a vedere film diretti o interpretati da amici. Io, peraltro, ho perfino partecipato all’ultimo film di Carlo Mazzacurati. Amico carissimo (e indimenticato). “La sedia della felicità”. Dove, per venti secondi, ho recitato la parte di… me stesso. L’esperto che analizza la società (del Nordest). Così, ho accettato di vedere e commentare il film di Zalone con l’occhio dell’analista sociale. E politico. Come di fronte a un ritratto dell’italiano medio, dei suoi miti, dei suoi desideri, dei suoi valori. D’altronde, com’è noto, è già avvenuto in passato. La commedia all’italiana: ha raccontato l’Italia della ricostruzione e del miracolo. Con realismo e ironia. Ma ciò è avvenuto anche in tempi recenti. Basti pensare a Paolo Villaggio e al suo personaggio più noto: Fantozzi rag. Ugo. Io stesso, nell’ambito del mio corso di Comunicazione Politica, all’Università di Urbino, ho organizzato un seminario intitolato: “Politica e spettacolo”. Anzi, “Politica è spettacolo”. Dove ho invitato, fra gli altri, Antonio Albanese. Inventore e attore di alcune straordinarie maschere del nostro tempo. Delineate, oltre che interpretate, con la cura del sociologo. O dell’antropologo. Penso a Ivo Perego, idealtipo del piccolo imprenditore della provincia lombardo-veneta. O, per altro e diverso “verso”, a Cetto La Qualunque. Maschera esemplare del politico-politicante del Sud (ma non solo), buffo e un po’ buffone. Al proposito, Albanese rivelò ai miei studenti, che «nessuna parola e nessuna frase è mia. Ho raccolto registrazioni in occasione di diverse elezioni locali. Nel Sud. La sceneggiatura è loro. Dei Cettilaqualunque presenti sul nostro territorio». E che dire di Neri Marcorè (anch’egli invitato ai miei corsi). Autore di “imitazioni” di successo, imitate dagli stessi imitati. Come Maurizio Gasparri. Ma lo stesso discorso, oggi, vale per Maurizio Crozza. Come dimenticare l’indimenticabile maschera di Bersani? Più efficace dell’originale, purtroppo per l’interessato. Mi accorgo, ora, che il tentativo di spiegare il motivo per cui un in-esperto di cinema, come me, venga invitato a commentare un film, per quanto “eccezionale”, per numero di spettatori e volume di incassi, mi ha portato lontano. Tanto lontano, che ora rischio di perdermi. D’altronde, Francesco Anfossi, su “Famiglia Cristiana”, ha scritto che «Zalone e il regista Nunziante spiegano l’Italia meglio di Ilvo Diamanti o Giuseppe De Rita». Naturalmente, De Rita non ne ha bisogno, ma io ci tengo a imparare dai maestri. Tanto più se realizzano analisi di successo, come “Quo Vado?”. Così ho guardato il film cercando di capire quanto l’Italia di Nunziante e Zalone coincida con le mie rappresentazioni. E interpretazioni. Premetto che mi sono divertito. Ho riso molto. E ho provato a riflettere. Su quanto sia realistica e attuale «l’Italia malinconica e meschina di Checco Zalone», come la definisce Goffredo Fofi su “Internazionale”. L’Italia fondata sul “posto fisso”. («Cosa vuoi fare da grande»? Chiede il maestro al giovane Checco. E lui, prontamente: «Il “posto fisso”»). L’Italia che, mira, anzitutto, al pubblico impiego, nei servizi dello Stato. Checco Zalone, impiegato alla Provincia (chiusa per legge), disposto a girare per il mondo, fino in Norvegia, fino ai ghiacci del Polo Nord, pur di non rinunciare al “posto fisso”. Come gli ripete e gli “raccomanda” il suo amico e protettore politico, interpretato da Lino Banfi. L’Italia fondata sulla mamma e sulla famiglia. Ebbene, la prima impressione è che questa raffigurazione è, forse, puntuale, ma caricaturale. Ancora: valida soprattutto per alcuni settori sociali e territoriali (gli adulti, il Mezzogiorno). E, comunque, datata. Perché l’Italia dei giovani, è “precaria”. Non si ferma in un “posto fisso”. I giovani, appena possono, se ne vanno dalla famiglia. Si trasferiscono altrove. In Europa, nel mondo. Non per imposizione. Nessuno li caccia. In un Paese di figli unici, figurarsi... Partono per scelta e necessità. Perché 7 italiani - e 8 giovani - su 10 ritengono che, per fare carriera, per trovare un impiego adeguato alle loro aspirazioni, i giovani debbano andarsene. All’estero. Tuttavia, a guardare i sondaggi realizzati da Demos, che utilizzo regolarmente per le mie ricerche, l’Italia di Nunziante e Zalone pare meno manierista e fantastica di quel che si potrebbe pensare. Proviamo a scorrere alcuni dati. Fra le caratteristiche che orientano la scelta del lavoro, secondo gli italiani (aprile 2015), la più importante è (appunto…) «che sia sicuro, senza rischio di perderlo e rimanere disoccupati». La prima, per il 39% degli intervistati. La seconda, per un altro 22%. Se sommiamo i due principali requisiti del lavoro, dunque, oltre il 60% degli italiani attribuisce effettivamente al “posto fisso” un ruolo importante. Anche se tra i giovanissimi (15-24 anni) conta di più la “soddisfazione”. Potendo scegliere un’occupazione per sé o i propri figli, inoltre, il 29% preferirebbe «un lavoro alle dipendenze di un ente pubblico». (La quota sale a circa il 32% nel Sud.) Anche in questo caso, si tratta della scelta più apprezzata. Seguita dal «posto in una grande impresa» (22%). E dal lavoro in proprio o da libero professionista (18%, in entrambi i casi). Di nuovo, però, la gerarchia delle preferenze cambia fra i giovanissimi. Attirati soprattutto dalla libera professione. Infine la famiglia. Secondo il 36% degli italiani, è ancora il soggetto che tutela maggiormente i lavoratori. Più dello stesso sindacato, indicato dal 16% del campione. D’altronde, «cosa distingue maggiormente gli italiani dagli altri popoli»? Naturalmente la famiglia (28%). Poi, «l’arte di arrangiarsi» (17%). Anche perché, agli italiani, è possibile “arrangiarsi”, soprattutto grazie alla famiglia. È interessante osservare che il ruolo della famiglia è riconosciuto anche dai giovani. E dai giovanissimi. In misura maggiore della media. Il profilo che emerge da questi dati, dunque, rende il “ritratto dell’italiano medio” secondo Zalone meno caricaturale del previsto. L’Italia appare ancora ispirata dal mito del lavoro fisso, nei settori pubblici, statali. Attaccata alla famiglia. Soprattutto se facciamo riferimento alle generazioni adulte e, ovviamente, anziane. A maggior ragione (ma non solo) del Sud. Questo modello, però, si adatta molto meno ai più giovani. Abituati alla flessibilità, alla precarietà. Al nomadismo. Per motivi di studio e lavoro. Ma, ormai, anche per passione. Eppure anch’essi possono sperimentare la condizione di “professionisti dell’incertezza” perché alle spalle hanno una famiglia. Un genitore o (meglio) due con lo stipendio fisso. Impiegati, magari, nel settore pubblico. Un nonno o una nonna con la pensione. Con una casa di proprietà. L’Italia di Zalone riflette, dunque, i valori e i riferimenti economici e sociali che hanno accompagnato la nostra società, nel dopoguerra. Oggi erosi dall’incertezza e dalla crisi. Ma ben piantati nella nostra storia. E ancora resistenti. Appigli necessari per vivere e sopravvivere. A chi resta - i più anziani. E a chi se ne va - i più giovani. I quali sanno, comunque, di poter tornare. A casa. Dove c’è sempre qualcuno ad attendere.
L'Ora Legale. Scrive il 27.12.2016 Pierpaolo Festa. Ficarra e Picone ritornano nei cinema con L'ora legale, la commedia che hanno diretto e interpretato attesa in sala per gennaio. Possiamo adesso vedere il primo trailer del film appena lanciato in rete: Si tratta della sesta collaborazione cinematografica del duo di attori siciliani dopo Nati stanchi, Il 7 e l'8, La matassa, Anche se è amore non si vede e Andiamo a quel paese. L'ora legale è anche interpretato da Leo Gullotta, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo, Sergio Friscia, Antonio Catania, Eleonora De Luca, Ersilia Lombardo, Alessia D’Anna, Francesco Benigno e Alessandro Roja. Questa la trama del nuovo film: In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro siciliano. Un sindaco maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé. A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell'agone politico per la prima volta, sostenuto da una lista civica e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti, un'alternativa in occasione del suo primo voto. I nostri due eroi Salvo e Valentino sono schierati su fronti opposti: il furbo Salvo, manco a dirlo, offre i suoi servigi a Patanè, dato vincente in tutti i sondaggi; mentre il candido Valentino scende in campo a fianco dell'outsider Natoli a cui è legato, come peraltro Salvo, da un vincolo di parentela in quanto cognato. Al di là della rivalità, però, entrambi mirano ad ottenere un “favore” che potrebbe cambiare la loro vita: un gazebo che permetterebbe di ampliare la clientela, e quindi gli incassi, del piccolo chiosco di bibite posto nella piazza principale del paese. Il Popolo vive, o meglio si lascia vivere, in un perenne stato di precarietà e di illegalità. Le macchine in doppia fila, l'immondizia sparsa per strada, ambulanti e parcheggiatori abusivi, le buche, e, su tutto, l'assenza di controlli che rendono le giornate dei cittadini una costante via Crucis da affrontare con l'unica arma a loro disposizione: la lamentela. A poche ore dal voto, però, arriverà il fato, il caso, o forse il destino a dare al popolo la forza di reagire, consentendo ai cittadini uno scatto d'orgoglio che li porterà a ribaltare alle urne tutti i sondaggi pre elettorali. Pierpaolo Natoli verrà eletto a furor di popolo e con lui verrà eletta la legalità.
Sapranno però i nostri concittadini fare i conti con la tanto attesa legalità? "L'Ora legale", l'ultimo film di Ficarra e Picone, scrive Teresa Marchesi su "L'Huffington Post" il 28/10/2016. Pietrammare è un paese come tanti del Sud. Aduso a sindaci disonesti e intrallazzoni come Patanè (Toni Sperandeo) che si ricandidano al grido di “Vota Patané senza chiederti perché”. Ma se un bel giorno alle amministrative trionfasse la lista civica di un professorino che dichiara guerra a ogni forma di illegalità, senza distinzione? Chi ha votato per l’onestà è pronto a praticarla in proprio? L'Huffington Post è andato sul set di “L’ora legale”, che Salvo Ficarra e Valentino Picone stanno girando a Termini Imerese, guarda caso Comune commissariato. Il film esce a Gennaio e c’è da scommettere che non farà soltanto ridere. Vi mostriamo in esclusiva su HuffPost le primissime immagini di questo minikolossal (scusate l’ossimoro) che ha mobilitato più di 500 comparse e 105 “ruoli parlanti”, rigorosamente locali. Solo i molto distratti non hanno notato che anche l’ultimo film della coppia palermitana, “Andiamo a quel Paese”, era un’idea coi fiocchi, esente dal qualunquismo che affligge tante commedie ‘sociali’ italiane. L’idea stavolta è di piazzare sul banco degli imputati non i votati ma i votanti. “Perché tutti tuoniamo contro soprusi, intrallazzi e storture – sostengono - ma quando mai facciamo i conti con la nostra piccola dose quotidiana di illegalità e di soprusi, da cui puntualmente ci autoassolviamo?” Come dice Ficarra, “abbiamo deciso di indagare su noi stessi, che siamo parte e dalla parte del popolo, ma senza paraocchi”. Che siano popolo è chiaro dal viavai di civili che da due mesi costantemente si infila tra un ciak e l’altro, chiamandoli sempre Salvo e Valentino, mai per cognome. Sui social cazzeggiano proclamando che il loro segreto “è la disistima reciproca”, ma sul set, dopo quattro film da registi, sembrano un mostro a due teste, perfezionisti che neanche Kubrick, due entusiasti col montaggio già in mente. Per “L’ora legale” hanno rivoluzionato Termini Imerese, scelta simbolicamente come una delle potenziali meraviglie turistiche devastate da fallimentari insediamenti industriali. Qui la Fiat ha lasciato a spasso un buon 8 mila addetti. Hanno inventato fontane, aiuole, piste ciclabili, spazi inediti di civiltà che i pensionati locali hanno adottato davvero. Quando scompariranno si rischia l’insurrezione. Non c’è modo di cavargli di bocca la sorpresa finale del film, ma il messaggio, anticipa Picone, è che “non solo la legalità ma la ragionevolezza è una dura lezione”, perché noi cittadini “razzoliamo male anche davanti all’evidenza che ci converrebbe razzolare bene”. Nella storia Ficarra e Picone sono entrambi cognati del nuovo sindaco “onesto” (Vincenzo Amato), schierati però su fronti opposti, perché Salvo gestisce la danarosa e prepotente campagna per il sindaco uscente. Costretti alla convivenza dal loro comune chiosco in piazza, proprio come Stanlio e Ollio costruiscono la loro dialettica comica fisicamente e caratterialmente. Ma ci sono anche i siculissimi Leo Gullotta e Antonio Catania. E a co-firmare la sceneggiatura non ci sono esattamente dei Pinco Pallino di passaggio: l’Edoardo De Angelis appena consacrato da “Indivisibili”, il Nicola Guaglianone in piena ascesa dopo “Lo chiamavano Jeeg Robot”, l’inseparabile Fabrizio Testini di “Zelig”. Non tirano via, nemmeno sulla scrittura. Fortuna che “L’ora legale” esce ben dopo l’esito del Referendum. Si potrà ridere in pace senza fare illazioni di parte e senza litigare all’uscita. Perché di come votano loro il 4 dicembre certo non ne fanno mistero. Se sono bravi, dal film non si capirà.
L'ora legale, Ficarra e Picone con un film civile: "Noi vogliamo far ridere", scrive Chiara Ugolini il 13 gennaio 2017 su "La Repubblica". Il duo di comici siciliani firma una commedia che racconta la rivoluzione di un piccolo paesino del Sud dove un professore si candida per offrire un cambiamento dopo anni di corruzione. I suoi compaesani lo eleggono ma le cose non andranno come loro si aspettavano. "Con questa crisi che c'é, l'Italia l'onestá non se la può permettere". É una delle battute più amare della nuova commedia di Salvo Ficarra e Valentino Picone L'ora legale, dal 19 gennaio in sala in 650 copie. Un film che racconta la "rivoluzione" che avviene in un piccolo paese siciliano dove, dopo che per anni un politico locale corrotto Gaetano Patané (Tony Sperandeo) ha amministrato con un sistema di clientelismo, un professore di liceo (Vincenzo Amato) decide di candidarsi nel segno del cambiamento. Sembra una missione impossibile vincere eppure, complice un'inchiesta che colpisce Patané, il professor Natoli viene eletto e - nello stupore generale - comincia a mettere in pratica tutte le cose che aveva promesso in campagna elettorale: lotta all'abusivismo, alla corruzione, all'assenteismo. Tutti finiscono in qualche modo nel mirino: chi prende una multa, chi vede la cartella esattoriale crescere, chi - come il parroco del paese- si vede per la prima volta nella sua vita recapitare una lettera per il pagamento dell'Imu per il bed and breakfast che gestisce. Nel giro di poco una fronda anti Natoli si forma nel paese persino i suoi cognati, Ficarra e Picone (che firmano il film come registi), finiscono per passare dall'altra parte della barricata e diventeranno complici di quel gruppo di compaesani pronti a tutto pur di costringere Natoli alle dimissioni. "Siamo partiti dalla volontà di fare una fotografia di quello che vediamo - dice Salvo Ficarra - e di mettere in difficoltà i nostri personaggi perché, come accade sempre in commedia, i comici danno il meglio di sé quando sono in difficoltà. La grande difficoltà di questo film è il rispetto della legalità e delle regole. Io e Valentino interpretiamo due del popolo, due di una coralità di un centinaio di personaggi che vengono mostrati nel film perché il film racconta proprio la difficoltà dell'onestà". E onesto è sicuramente il candidato interpretato da Vincenzo Amato, il cui "percorso verso la legalità" è un percorso agli ostacoli. "È un percorso difficile perché il candidato diventato sindaco ha promesso la legalità e la applica - dice Valentino Picone - i cittadini rimangono increduli perché dicono non si è mai visto qualcuno che realmente fa quello che ha promesso in campagna elettorale e qui ogni personaggio reagirà in modo diverso a questa ventata di legalità". Seppur il gioco a trovare riferimenti al Movimento 5 stelle, all'ex sindaco di Roma Ignazio Marino e ad altre vicende di cronaca e politica nazionale è un gioco a cui non ci si può sottrarre, il duo di comici siciliani si sfila dal "chi è chi". Sebbene ammettano che la storia della fabbrica che inquina ricorda quella dell'Ilva "ma anche il petrolchimico di Gela" (ricorda Picone), che il personaggio di Salvo con la felpa con la scritta "cognato" è un riferimento a Salvini "che dopo aver invocato la secessione della Padania è arrivato in Sicilia con la scritta Sciacca" (dice Ficarra), gli attori-registi assicurano che hanno fatto di tutto per essere il meno possibile legati alla cronaca stretta. "Il fatto è che la realtà ci ha superato a destra, facendo le corna e col telefono in mano - scherza Ficarra - noi abbiamo lavorato due anni a questo film per cui nel momento in cui sono accaduti dei fatti che ricordavano le vicende del nostro film sembravano viaggiare in parallelo con la sceneggiatura. Per cui anzi ci siamo trovati a fare cambiamenti, mettere dei paletti perché a noi interessava il disegno finale non singoli eventi". La struttura della storia che avevano in mente era molto semplice, "tutti invochiamo la legalità - dice Picone - ma poi quando arriva questa legalità ci sta stretta perché dentro ognuno di noi c'è una parte di illegalità a cui ci siamo abituati e che abbiamo pure dimenticato di avere. Lo schema era talmente semplice che qualunque cosa accadesse nella realtà non andava a toccare il progetto iniziale". Una commedia distribuita da Medusa in 650 cinema e una trasmissione, Striscia la notizia con cui ripartono a febbraio, che raccoglie 8 milioni di spettatori. Gli ex comici di Zelig Ficarra e Picone sentono la responsabilità di parlare a così tanta gente? "Noi ci mettiamo noi stessi: semplicità e divertimento - dice Salvo Ficarra - chi ci vuole ascoltare ci ascolta". "Intanto non bisogna ricordare che sei di fronte a 8 milioni di spettatori perché altrimenti ti tremano le gambe - prosegue Valentino Picone - meglio non pensarci, essere naturali". "A dire la verità - conclude Ficarra - quando siamo a Striscia abbiamo la sensazione di essere noi quattro, noi due e un paio di cameraman". Del lavoro di Ficarra e Picone i critici parlano come "cinema civile" sebbene i due rivendicano principalmente la loro ricerca della risata, dell'umorismo. "Noi la risata la cerchiamo ad ogni costo - assicura Picone - il fatto è poi che dietro ad una qualunque risata, fosse pure uno che scivola su una buccia di banana, ci saranno i parenti di quello che sono dispiaciuti perché magari si è rotto una gamba, ma ci saranno tutti gli altri che guardano e che ridono. Il nostro obiettivo è sempre quello di far ridere poi se dietro c'è qualcosa che provoca sofferenza è quasi involontario".
LA MORALITA' DEGLI UOMINI SUPERIORI.
«Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei» (Gv 8,7).
Mentre Gesù istruiva nel tempio, gli scribi ed i farisei, condottagli una donna che avevano sorpreso in adulterio, gli avevano detto: “… Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?” (Gv 8,5).
Volevano con ciò tendergli un tranello. Infatti, se Gesù si fosse manifestato contrario alla lapidazione, avrebbero potuto accusarlo di andare contro la Legge. Secondo questa, infatti, i testimoni diretti della colpa dovevano iniziare a scagliare la pietra su chi aveva peccato, seguiti poi dal popolo. Se Gesù avesse invece confermato la sentenza di morte, l’avrebbero fatto cadere in contraddizione con il suo insegnamento sulla misericordia di Dio verso i peccatori.
Ma Gesù, che stava chinato tracciando con il dito dei segni per terra, dimostrando così la sua imperturbabilità, alzatosi disse:
«Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei»
Gli accusatori, a quelle parole, si ritirarono uno dopo l’altro, cominciando dai più anziani. Il Maestro, rivoltosi alla donna: “Dove sono? – disse -. Nessuno ti ha condannata?” “Nessuno, Signore”, rispose. “Neanch’io ti condanno: va’ e d’ora in poi non peccare più” (cf Gv 8,10-11).
«Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei»
Con queste parole, Gesù non si rivela certamente permissivo nei confronti del male, come l’adulterio. Le sue parole: “Va’ e d’ora in poi non peccare più”, dicono chiaramente qual è il comandamento di Dio.
Gesù vuole mettere a nudo l’ipocrisia dell’uomo che si fa giudice della sorella peccatrice, senza riconoscersi egli stesso peccatore. Sottolineando così, con le sue parole, la nota sentenza: “Non giudicate per non essere giudicati; perché col giudizio con cui giudicate, sarete giudicati” (Mt 7,1-2).
Parlando in questo modo, Gesù si rivolge anche a quelle persone che condannano gli altri senza appello, non tenendo conto del pentimento che può sorgere nel cuore del colpevole. E mostra chiaramente qual è il suo comportamento nei confronti di chi fallisce: aver misericordia. Quando quegli uomini si sono allontanati dall’adultera, “sono rimasti in due – dice Agostino, vescovo di Ippona -: la miseria e la misericordia” [Commento al Vangelo di Giovanni 33,5].
La fine della superiorità morale. Era il Dna dei Cinque stelle, scrive Angela Azzaro il 20 Dicembre 2016 su "Il Dubbio”. La parola onestà è costitutiva del Movimento, difficile sostituirla con un’altra senza perdere la propria identità. Ma i cittadini ci crederanno ancora? Il movimento Cinque Stelle fonda la sua nascita e il suo successo su due questioni: da una parte la crisi più che decennale della democrazia e la necessità di ridare valore alla rappresentanza politica; dall’altra il sentimento anti casta alimentato dalla necessità (vera o presunta) di una nuova classe dirigente non corrotta, che abbia una fedina penale pulita. La prima questione è stata risolta con il voto telematico che secondo molti non è bastato a costruire decisioni democratiche. I Cinque stelle non hanno una direzione o un segretario eletti, ma una serie di capi che si sono autoinvestiti e che decidono per tutti. Se la democrazia in poco tempo è diventata quindi un simulacro, un’imitazione approssimativa delle possibilità decisionali offerte dalla rete, la questione dell’onestà ha comunque fatto da collante tra eletti ed elettori. E’ stato il vero Dna di un movimento che si è contrapposto agli altri partiti rivendicando la superiorità morale: noi e loro, i cittadini e la casta, il movimento e la partitocrazia. E’ stata una narrazione che ha funzionato e che, davanti ai primi avvisi di garanzia, non ha per nulla scricchiolato. Gli elettori Cinque stelle hanno continuato a pensare che il movimento fosse la soluzione ad una crisi strutturale della società, conseguenza delle ruberie perpetrate dai politici. Il noi e loro ha un potere d’attrattiva che difficilmente può essere intaccato: costruisce comunità, senso di riscatto, valenza ideologica in un momento di crisi profonda delle ideologie. Ma i nuovi episodi che riguardano la giunta romana rischiano di far vacillare la narrazione grillina. La mettono in crisi nella sua struttura di fondo, in quella convinzione che tutti sono corrotti, tutti hanno rubato fuorché i Cinque Stelle. E’ l’inizio della fine della superiorità morale del movimento? Difficile dirlo oggi, quando il sentimento e la passione dei cittadini sono ancora vivi. Ma questa volta non si può non vedere le crepe anche profonde nell’immaginario costruito in questi anni. L’arresto di Marra, con l’accusa di corruzione, non è paragonabile all’avviso di garanzia per abuso d’ufficio ricevuto dal sindaco di Parma, Pizzarotti. C’è qualcosa in più, connesso alla parola più orribile per un grillino: la corruzione. Il dubbio si insinuerà forse anche nel più convinto sostenitore dei Cinque stelle ma soprattutto farà da sfondo a una narrazione che non potrà più sfidare gli altri contando sulla propria purezza. Per qualsiasi partito i fatti di oggi sarebbero una valanga, ma per i Cinque stelle sono qualcosa di più. La messa in discussione della loro stessa esistenza: è come se un partito comunista stesse in vita ammettendo che il comunismo non solo è morto ma ha fallito, come se un partito continuasse a chiamarsi democratico quando si vive in una dittatura. Certo, si può stare nelle contraddizioni. Quest’epoca politica ci ha abituati anche a questo. Ma da oggi sarà difficile per Grillo riproporre la stessa narrazione. L’onestà o è o non è, non ci sono vie di mezzo, aggiustamenti, passi indietro. Ci si può inventare di tutto, ma quella parola non ammette compromessi, mezzi termini. Il Movimento cinque stelle potrà sicuramente inventare nuove parole d’ordine, ma sarà difficile sostituire la parola fondante, cambiarla con un concetto qualsiasi. Lo sarà non perché impossibile. Ma perché vorrà dire fare un passaggio ulteriore, un passaggio forse fatale: non essere più speciali, unici, e diventare come tutti gli altri. Non si potrà allora più vincere le elezioni senza chiarire il programma (come è accaduto a Virginia Raggi) non si potrà contare solo sulle difficoltà delle altre forze, si dovrà contare sul proprio progetto politico.
Il "Corriere" si schiera Con Togliatti. Il quotidiano della borghesia dedica due pagine alla beatificazione del Migliore: "Cercava soluzioni condivise". Sì, condivise da Stalin...scrive Alessandro Gnocchi, Lunedì 17/02/2014 su "Il Giornale". Ideona del Corriere della Sera: rivalutare Palmiro Togliatti. Ieri La lettura, inserto culturale del giornale milanese, ha presentato ai suoi lettori una passante (due pagine) firmata da Francesco Piccolo sul segretario del Partito comunista. Come accade a tutti gli articoli che si spingono nei territori dell'assurdo, il pezzo è stato spacciato per una «provocazione». La tesi? La sinistra di oggi, in compagnia dei grillini, si trastulla nel mito della propria superiorità morale, ma dovrebbe imparare da Togliatti, che aveva una «ostinata propensione alla soluzione condivisa - che è l'essenza della democrazia parlamentare». Così il Migliore (singolare soprannome per uno che non si cullava nel mito della propria superiorità morale) diede vita al «migliore Partito comunista europeo, in senso democratico», capace di collaborare con gli altri alla stesura delle regole. Piccolo, pur avendo un lenzuolo a disposizione, non trova lo spazio per infilare almeno una riga su quello che gli storici scrivono da circa 25 anni sulle «scelte condivise» di Togliatti. «Condivise» soprattutto da Stalin, che gliele aveva imposte. Come testimoniano i documenti ritrovati da Viktor Zaslavskij ed Elena Aga Rossi all'inizio degli anni Novanta, fu infatti il tiranno sovietico a ordinare a Togliatti di archiviare, per il momento, le posizioni anti-monarchiche e di puntare invece a entrare nel governo Badoglio. La tanto celebrata «svolta di Salerno» del 1944 era stata decisa a Mosca, non era stata presa per «ostinata propensione alla soluzione condivisa» e aveva un duplice scopo. Non indebolire il fronte antifascista a guerra non ancora terminata e allargare l'influenza politica comunista in un Paese che mai l'Urss avrebbe potuto trattare come quelli dell'Europa Orientale. Lo stesso dicasi per la rinuncia alla lotta armata nell'immediato dopoguerra. Il disarmo (comunque tardivo) delle formazioni partigiane rosse rispondeva ancora una volta alle esigenze geopolitiche dell'Unione Sovietica, che non voleva rogne mentre era impegnata a spartirsi il Vecchio continente con gli Stati Uniti. La decisione di partecipare alla stesura delle nuove regole all'interno dell'Assemblea Costituente fu una necessità: il Pci temeva di essere tagliato fuori e doveva legittimare la propria presenza nelle istituzioni, dal momento che la rivoluzione era ormai esclusa. Questa mossa azzeccata diede poi la possibilità alla propaganda comunista di affermare che la Costituzione era nata dalla Resistenza. Motivo per cui ancora oggi è intoccabile. Anche in questo caso l'«ostinata propensione alla soluzione condivisa» c'entra poco. Ritrovarsi quindi Togliatti come una sorta di precursore delle larghe intese per le riforme è un salto mortale. Alla fine della lettura di Piccolo, si è imparato nulla su Togliatti. In compenso si capisce un po' di più l'Italia, un Paese dove il quotidiano della borghesia produttiva riesce a dedicare due pagine (nel 2014, tra l'altro, che dinamismo) alla rivalutazione di Palmiro Togliatti detto il Migliore. Clamoroso lo scoop: dietro lo stalinista si celava (benissimo, fino a quando è arrivato Piccolo) un vero democratico. Che sia questa la «contraddizione irrisolta» cui accenna qua e là l'articolo? A proposito, Piccolo è autore di libri (l'ultimo è Il desiderio di essere come tutti, Einaudi, dedicato a Enrico Berlinguer), autore di Fazio a Che tempo che fa e Sanremo, sceneggiatore di Nanni Moretti e Paolo Virzì. Possiamo quindi prenderlo come esempio di intellettuale inserito e influente. Anche questo ci dice qualcosa dell'Italia.
L'attentato-suicidio dei Gap raccomandato da Togliatti. Il Migliore impose di usare i giovanissimi nelle azioni contro i nemici. Come nel 1944 a Sesto San Giovanni...scrive Luca Fazzo, Venerdì 23/12/2016, su "Il Giornale". Chissà se Giangiacomo Feltrinelli, editore rivoluzionario, e i suoi seguaci che negli anni Settanta si diedero alla lotta armata, avevano studiato fino in fondo la storia dei Gap. La banda di Feltrinelli venne chiamata così, Gruppi di azione partigiana, in omaggio alla struttura clandestina, diretta emanazione del Partito comunista, che durante la guerra civile era stata la punta di diamante della Resistenza a Milano e nel suo hinterland. Era un mito, quello dei Gap, che aveva permeato profondamente il movimento del Sessantotto, e che fu importante nello spingere verso il terrorismo alcuni settori radicali dell'ultrasinistra: mito formato da ortodossia ideologica, e soprattutto da efficienza militare. Ma il tempo passa, la storia di quegli anni viene riscritta senza furori di parte. E anche il mito dei Gap ne esce ridimensionato. Del cinismo di alcune scelte dei Gap, come dimostra l'attentato di via Rasella a Roma, si è ampiamente dibattuto. Ma ora un libro di Marco Manuele Paolini costringe a rimettere in discussione anche il lato del mito che sembrava meno scalfibile: la capacità operativa, la compartimentazione ferrea. Al centro del libro di Paolini, Il ragazzo della Quinta (Mursia, pagg. 146, euro 14) ci sono un ragazzo e un attentato. Il ragazzo si chiamava Felice Lacerra, era nato nel 1927 a Sesto San Giovanni da una famiglia di immigrati, a quindici anni era già operaio alla Breda. L'attentato è quello che proprio a Sesto, la sera del 10 febbraio 1944, prende di mira la locale Casa del Fascio, dove è in corso la riunione per la nomina del fiduciario. L'azione in sé è maldestra, e provoca meno danni di quanto i gappisti si proponevano facendo irruzione con mitra e bombe a mano: due repubblichini uccisi, un altro paio feriti. Ma ben più disarmante è il pressapochismo nella preparazione dell'attentato, che avrà conseguenze catastrofiche per gli organizzatori. I Gap sestesi verranno smantellati quasi per intero dalle indagini successive all'attacco. Era un lavoro crudo, quello dei Gap. Non si trattava di combattere a viso aperto, in montagna, affrontando i reparti ben più armati della Rsi e degli occupanti tedeschi, ma di uccidere a sangue freddo, alle spalle. Lavoro necessario, ma che selezionava inevitabilmente un certo tipo di militante, pronto alla freddezza e ai sacrifici della clandestinità. «Raccomandiamo di non aver paura di mettere avanti i giovani, i quali hanno coraggio e audacia», scriveva Palmiro Togliatti. E in effetti i quadri dei Gap erano spesso sui vent'anni. Ma per l'attentato a Sesto si scelse di mettere in prima linea addirittura un sedicenne: Felice Lacerra. A lui venne affidato il ruolo più difficile: l'infiltrato. Si iscrisse al Pnf, iniziò a frequentare la Casa del fascio, si conquistò la fiducia dei camerati, gestendo un ruolo da agente doppio che avrebbe spezzato i nervi a gente ben più adulta di lui. Fu lui a segnalare ai Gap la data della riunione, e ad aprire dall'interno le porte al commando armato. Se già questa scelta appare azzardata, ancora più incomprensibile appare quella di non allontanare Felice da Sesto subito dopo l'attacco. La mattina dopo, il ragazzo andò a lavorare in Breda come se niente fosse, ovviamente venne arrestato, e si può immaginare quale trattamento gli fu riservato. Fece il nome di un partecipante all'irruzione, Luigi Ceriani il quale, fermato a sua volta, cantò ben più di Felice, facendo arrestare l'intero distaccamento sestese dei Gap. In carcere alcuni resistettero, altri parlarono. I due capi, Egisto Rubini e Oreste Ghirotti, si uccisero in cella per non cedere alle torture. In aprile viene arrestato Primo Grandelli, dei Gap di Milano che avevano collaborato all'azione con i sestesi. Incredibilmente, ha con sé un quaderno con i nomi di tutti i compagni che vengono arrestati in blocco. I Gap a quel punto non esistono praticamente più, e si dovrà attendere l'arrivo in città di Giovanni Pesce perché la struttura armata del Pci venga ricostituita. «Fu tutto uno sbaglio, dall'inizio alla fine», dirà Carlo Camesasca, il gappista che pochi mesi prima aveva partecipato all'uccisione del federale di Milano, Aldo Resega. D'altronde sono gli stessi Gap che l'8 agosto dello stesso anno in viale Abruzzi metteranno una bomba su un camion della Wehrmacht che distribuiva aiuti alimentari: non morì neanche un tedesco, ma restarono uccisi sei milanesi in coda per il cibo. La rappresaglia nazista fu la strage di piazzale Loreto. Insomma, altro che efficienza. Coraggio, indubbiamente, ma anche pressapochismo e decisioni sciagurate. E il giovane Felice Lacerra? Fu deportato a Fossoli, vicino Carpi, in un campo di concentramento dal volto umano. La mattina del 12 luglio, sessantasette prigionieri del campo vennero portati dalle Ss in un poligono, a Cibeno, e uccisi con un colpo alla nuca. Felice era uno di loro. Lo riconobbero i genitori quasi un anno dopo, esumato dalla fossa comune, dal libretto della mensa della Breda.
Il giorno nero dei governatori: «In galera, in galera!», scrive Errico Novi il 23 Dicembre 2016, su "Il Dubbio". Formigoni condannato a 6 anni, Scopelliti a 5. Per Lombardo si decide a gennaio. Nelle accuse, accolte dalla Corte d’appello di Reggio nel primo caso e dalla decima sezione penale del Tribunale di Milano nell’altro, risuona anche un assioma: le amministrazioni locali sono un modello di malaffare politico, e le carriere formidabili di politici che da quel trampolino si lanciano verso la scena nazionale portano fatalmente il segno della corruzione, delle clientele, dei sistemi consociativi più infetti. Scopelliti è alla condanna di secondo grado e gli sarà difficile ribaltare le accuse in Cassazione. È fuori dal Parlamento, ha tentato senza successo di diventare eurodeputato, è accusato di mafia in un altro procedimento. Formigoni è invece dirigente di un partito di governo, l’Ncd, presidente di commissione al Senato, ha ancora la possibilità di vedere riformata la sentenza in appello e già in questo giudizio di primo grado ottiene un risultato che il suo difensore Mario Brusa definisce «un’ottima cosa»: l’assoluzione dall’accusa di associazione a delinquere. Il che apre almeno uno spiraglio per mettere in discussione anche il capo d’imputazione accolto dai giudici di Milano, l’aver incassato «utilità» per circa 8 milioni di euro in cambio di favori a due colossi della sanità lombarda: Fondazione Maugeri e San Raffaele. Nel caso del “Celeste”, come è soprannominato da lustri, il venir meno della presunta organizzazione criminale apre la strada per affermare la tesi da lui sempre sostenuta: gli yacht e le vacanze in Sudamerica assicurategli da Pierangelo Daccò e Antonio Simone erano «cortesie tra amici». Ma anche Formigoni farà comunque una fatica enorme a rialzarsi. E la sua vicenda corrobora un’idea che si è fatta strada negli anni grazie anche ad altri casi come quello di Scopelliti o come l’incredibile vicenda di Del Turco: la carica di governatore è un passaggio maledetto, fatale, in cui spesso politici ambiziosi e molto popolari restano intrappolati, o che, come nel caso di Scopelliti, trasformano il successo in improvviso calvario processuale. A breve un altro ex presidente di Regione, il siciliano Raffaele Lombardo, potrebbe veder confermata in appello la condanna a 6 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte d’appello di Reggio presieduta da Adriana Costabile ha ritenuto colpevole Scopelliti di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico ma ha riformato la sentenza di primo grado: da 6 anni a 5 anni di carcere, con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Insieme con l’ex primo cittadino, condannati anche i tre componenti del collegio dei revisori dei conti: Carmelo Stracuzzi, Domenico D’Amico e Ruggero Ettore De Medici: 2 anni e 4 mesi di carcere, pena ritoccata rispetto a 3 anni e 6 mesi inflitti dal Tribunale. Accolta nella sostanza la ricostruzione dell’accusa: Scopelliti avrebbe dolosamente sperperato centinaia di milioni di euro, attraverso la destinazione impropria e clientelare delle risorse comunali. Il tutto attraverso la complicità dei tre coimputati e della dirigente Orsola Fallara, morta in circostanze mai del tutto chiarite nel 2010 dopo aver ingerito acido muriatico. Formigoni avrebbe assicurato finanziamenti straordinari alla Maugeri, attraverso un sistema di corruttele e favori, tenuto in piedi durante l’intero mandato di governatore con la complicità decisiva di due dei suoi coimputati: l’uomo d’affari Daccò (condannato a 9 anni e 2 mesi, con un lieve aggravamento rispetto alla stessa richiesta dei pm) e l’ex assessore regionale Simone (8 anni e 8 mesi come chiesto dall’accusa), entrambi suoi amici. Circa 40 milioni di euro di finanziamenti regionali annui alla Fondazione Maugeri, relativi alle cosiddette “funzioni non tariffabili”, in aggiunta ai rimborsi per gli accreditamenti. La sentenza pronunciata ieri sancisce condanne anche per gli imprenditori Carlo Farina (3 anni e 4 mesi) e Costantino Passerino (7 anni). Scompare l’associazione a delinquere. Cade ogni accusa invece per l’ex dg della sanità lombarda Carlo Lucchina, l’ex dirigente regionale Alessandra Massei, l’ex coinquilino di Formigoni Alberto Perego, l’ex moglie di Simone Carla Vites e l’ex segretario regionale Nicola Maria Sanese. Da una parte i pm che avevano dipinto Cielle come il contesto in cui «l’intensità dei rapporti tra gli associati è fondamentale per la nascita del vincolo corruttivo». Dall’altra e Formigoni e i suoi avvocati che hanno sempre spiegato le vacanze e la barca posseduta al 50 per cento dall’ex governatore (oggetto della confisca) come cortesie. Comunione e liberazione trasformata nell’ambiente naturale del malaffare. Nella tesi dei pm c’era anche questo. La decima sezione penale l’ha accolta in parte. C’è lo scambio corruttivo, non un’organizzazione costruita per attuarlo. Sullo sfondo oltre dieci anni di storia politica milanese, poiché parte dei reati sarebbe stata commessa già a partire dal 1997, quando Formigoni non era ancora governatore. Le confische complessivamente ordinate a carico dei 5 condannati ammontano a qualcosa come 53 milioni e 800mila euro. Il principale soggetto danneggiato, la Regione, è stata rappresentata in giudizio dall’avvocato Domenico Aiello, protagonista dello scambio di informazioni costato una condanna disciplinare al pm Alfredo Robledo. Si sono incrociate politica e sanità, egemonia culturale di Cl e rancore degli avversari. E in mezzo a tutto questo, un ex potentissimo, Formigoni, che insisterà anche in appello nel respingere tutte le accuse.
Si salvi chi può, scrive Piero Sansonetti il 23 Dicembre 2016, su "Il Dubbio". Certamente è un caso, però sembra proprio l’offensiva di Natale della magistratura contro i presidenti (ormai ex) delle regioni. Il più famoso di loro, il fondatore di Comunione e Liberazione Roberto Formigoni, è stato condannato in primo grado a sei anni di prigione. Beppe Scopelliti, ex potentissimo sindaco di Reggio Calabria e poi ex potentissimo governatore della Calabria, si è beccato cinque anni abbondanti in appello. Per Raffaele Lombardo, ex Presidente della Sicilia, bisognerà aspettare un po’: la sentenza d’appello arriverà a metà gennaio. Il Pm ha chiesto la conferma a una decina d’anni. Formigoni è stato condannato per corruzione, Scopelliti per abuso d’ufficio, Lombardo, in primo grado, per il reato sempre molto fumoso di concorso esterno in associazione mafiosa. Quanti governatori rischiano la galera? Il 30 per cento. Lui si difende. Dice: «Ma io non ho mai incontrato un mafioso in vita mia!». I magistrati rispondono: «Infatti, ti diamo concorso esterno, mica interno…». Scopelliti, se non interverrà la Cassazione ad annullare le condanne, finirà in carcere tra qualche mese, perché una condanna superiore ai tre anni non ammette condizionale. Formigoni può sperare nell’appello, ma rischia. E così rischia molto Lombardo. Se pensate che il predecessore di Lombardo ha scontato cinque anni di carcere, senza nemmeno il permesso di andare al letto di morte della madre, e che il governatore dell’Abruzzo, prima di essere assolto dalla Cassazione, ha trascorso diversi mesi in cella, per l’arresto preventivo, e ha trascorso dieci anni di inferno, e che il governatore del Veneto, Galan, sta scontando ai domiciliari una condanna per l’affare del Mose di Venezia, siamo a sei governatori, quattro del sud e due del nord, che hanno avuto a che fare o che rischiano di avere a che fare con le manette e con le sbarre alla finestra. Le Regioni in Italia sono venti, mica tante. Sei su venti è una bella media, precisamente una media del 30 per cento. (E non abbiamo voluto mettere nel conteggio alcuni governatori che hanno avuto la carriera stroncata dai procedimenti giudiziari, ma poi se la sono cavata, ottenendo l’assoluzione piena prima di finire in cella: per esempio Vasco Errani, in Emilia Romagna, o Antonio Bassolino, assolto da tutti i reati dopo cinque anni di campagne martellanti contro di lui e l’obbligo a ritirarsi dalla vita politica. Né abbiamo messo in elenco l’attuale governatore della Campania, De Luca, che di avvisi di garanzia e rinvii a giudizio né riceve abitualmente, tutti gli anni, e con egual frequenza ottiene assoluzioni. Se contassimo anche questi casi, arriveremo a quasi la metà delle regioni italiane). Ci sono due possibili conclusioni da trarre, visto che in nessun altro paese del mondo libero succede niente di simile. Due ipotesi in alternativa tra loro (o forse no). La prima è che la politica italiana abbia deciso, per qualche motivo che non conosciamo, di mandare al vertice delle Regioni gente poco racco- mandabile. La seconda è che la magistratura italiana abbia deciso di fa pagare ai presidenti delle regioni (ma spesso anche ai sindaci: vale per tutti il recente caso di Marta Vincenzi, sindaca di Genova condannata a 5 anni di prigione perché ha fatto piovere troppo forte sulla sua città) la difficoltà ad arrestare i deputati, per via di una fastidiosissima norma costituzionale che impedisce irruzioni con le manette in Parlamento (che invece, per esempio, sono possibili in Turchia). I presidenti delle regioni non godono dell’immunità dall’arresto, e poi sono coinvolti in un numero altissimi di atti amministrativi, nei quali compare la loro firma, e che spessissimo riguardano assegnazione di opere pubbliche o di altre attività che muovono quattrini. Talvolta, in questi casi, il confine tra illecito e lecito è molto labile, e reati come l’” abuso d’ufficio” sono ancor più labili e nebbiosi. L’esercizio dell’ufficio è un dovere, non è opzionale, e stabilire quando è abuso e quando no, non è cosa agevolissima. Un amministratore serio non resta con le mani in mano, che in fondo è il comportamento più semplice e senza rischi: con rischi enormi però sulla vita pubblica della propria città o della regione. Se si finirà per percepire, da parte degli amministratori, come rischiosa l’iniziativa politica ed economica, avremo tra poco un esercito di amministratori impauriti e immobili (un po’ come sta succedendo a Roma) e lo Stato va a scatafascio. Non conosco abbastanza bene il caso Formigoni per poter giudicare, ma l’impressione che ci sia un certo accanimento contro di lui non mi sembra del tutto campata in aria. Conosco meglio il caso calabrese, e sono convinto che Scopelliti ha governato in modo spavaldo e un po’ arrogante – e probabilmente ha meritato la punizione da parte degli elettori – ma non ha commesso reati. Del resto la Procura di Reggio, ai tempi di Pignatone – che pure non mi pare un tipo tenero – lo aveva considerato sempre innocente. Conosco il caso di Del Turco e credo che ormai sia evidente a tutti che fu un errore giudizio di quelli brutti. Ho seguito un pochino le vicende siciliane, e ritengo di poter dire con una certa tranquillità che né Lombardo né Cuffaro sono mafiosi. Né interni né esterni. Allora c’è un problema di inadeguatezza della classe politica regionale? Penso che questo problema ci sia, non ovunque, ma ci sia. La politica si deve porre il problema, altrimenti perde ancora credibilità, e nell’opinione pubblica si crea un collasso pericolosissimo. Dopodiché penso anche che bisognerebbe che la stessa politica avesse il coraggio di difendersi e lanciare l’allarme. C’è un pezzo di magistratura che è travolta da un complesso di superiorità e di “missione”, si sente mandata da Dio per radere al suolo la politica e lo sta facendo. Ieri Silvio Berlusconi ha definito Dell’Utri un prigioniero politico. Secondo me ha ragione. E non è il solo prigioniero politico. Se non si trova un modo per moderare l’eccesso di protagonismo della magistratura che porta a veri e propri, non infrequenti, fenomeni di persecuzione verso la politica, il pericolo di un corto circuito della democrazia diventa altissimo. Non è la prima volta – lo so – che questo giornale denuncia queste cose. Temo che non sarà l’ultima.
Che ci fa il pm Scarpinato nel dossier dell’indagato? Scrive Giovanni M. Jacobazzi il 23 Dicembre 2016, su "Il Dubbio". Un paladino dell’antimafia, con la passione per i dossieraggi, indagato per concorso esterno a Cosa Nostra. Dei magistrati simbolo nella lotta alla criminalità organizzata “accusati” di aver chiesto favori per parenti e amici ad un loro indagato. C’è di tutto nell’indagine della Procura della Repubblica di Catania, che al momento ha archiviato la posizione di alcuni alti magistrati siciliani. A partire dal procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, all’epoca dei fatti procuratore generale di Caltanissetta, del suo sostituto Sergio Lari, all’epoca procuratore nella città del Vallone, del sostituto Pg di Palermo Domenico Gozzo, già aggiunto a Caltanissetta, del procuratore aggiunto di Roma Lucia Lotti, ex procuratore a Gela, ed altri magistrati meno noti al grande pubblico. La vicenda nasce dalla perquisizione ordinata dalla Procura di Caltanissetta a carico di Antonello Montante, potente presidente di Confindustria Sicilia, presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta, membro dell’Agenzia nazionale per il sequestro e la confisca dei beni delle mafie. Montante è attualmente indagato a Caltanissetta per concorso esterno a Cosa nostra essendo stato chiamato in causa da ben cinque collaboratori di giustizia. Come rivelato ieri dal Corriere della Sera, nel suo pc sono state ritrovate delle “schede” a carico di magistrati che, nel periodo 2010- 2013, prestavano appunto servizio a Caltanissetta. Praticamente dei “promemoria” su figli, nipoti e amici delle toghe oggetto di “premure” per un lavoro, per un concorso pubblico, per una nomina. Interrogato dai pm catanesi, Montante ha avuto un improvviso “vuoto di memoria”, non ricordando nulla della sua meticolosa e puntuale attività di archivista svolta per anni. Un atteggiamento definito dai magistrati catanesi “reticente”. I quali hanno, però, manifestato “stupore per le richieste di aiuto” da parte dei loro colleghi nisseni a Montante. Il Csm, al quale sono stati trasmessi gli atti, dovrà valutare le loro condotte sotto l’aspetto dell’incompatibilità ambientale. E, se del caso, dovrà trasmettere le carte alla Procura generale della Corte di Cassazione affinché valuti gli aspetti disciplinari. Se la questione dell’incompatibilità ambientale è sostanzialmente superata, visto che la maggior parte delle toghe finite nel pc di Montante non presta più servizio a Caltanissetta, l’aspetto disciplinare è invece terreno molto scivoloso. Anche se non sono stati configurati reati, certamente il fatto che il nome del magistrato che rappresenta l’accusa nel processo d’Appello al generale Mario Mori e al colonnello Mauro Obinu per aver agevolato la mafia in quanto avrebbero omesso di catturare il boss Bernardo Provenzano, sia messo in relazione ad un soggetto che è accusato di essere legato alla cosca Serradifalco pone più di un interrogativo. L’immagine che esce da questa vicenda non è, certamente, delle più edificanti. La magistratura siciliana e nazionale per anni aveva evidenziato i rischi di delegittimazione contro Montante. I pentiti che lo accusano sono stati a loro volto accusati. Un gioco di specchi in cui è difficile capire a questo punto chi accusa chi. Più volte si è ribadita la necessità di una verifica profonda e radicale di tutto ciò che si definisce “antimafia”. Il “caso Saguto” a Palermo insegna. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.
I dossier di Montante sui magistrati siciliani: «Mi raccomandano familiari e amici». La Procura di Catania archivia e invia al Csm le carte trovate nell’archivio elettronico del presidente di Confindustria Sicilia. «Perplessità sugli appunti trovati all’imprenditore», scrive Giovanni Bianconi il 21 dicembre 2016 su “Il Corriere della Sera”. L’archivio elettronico del presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, paladino dell’antimafia poi indagato per mafia, è finito al Consiglio superiore della magistratura con i nomi di dieci giudici che avevano rapporti con lui, dei quali l’imprenditore ha annotato ogni appuntamento — istituzionale o meno che fosse —, nonché la corrispondenza su presunte richieste di raccomandazioni o appoggi vari. Qualcosa di simile a un’attività di dossieraggio, magari avviata per delegittimare eventuali inchieste o accuse a suo carico. La Procura di Catania, titolare delle indagini in cui sono coinvolte le toghe di Caltanissetta — la città di Montante dove hanno prestato servizio gran parte delle toghe inserite nel suo archivio — non ha trovato nulla di penalmente rilevante, ma ha inviato gli atti a palazzo dei Marescialli per eventuali valutazioni di competenza dell’organo di autogoverno. Ora la prima commissione del Csm dovrà decidere se archiviare il caso, come hanno fatto a Catania, o procedere a ulteriori accertamenti. Tutto nasce dalla perquisizione ordinata dalla Procura di Caltanissetta nel gennaio scorso, quando furono sequestrati i computer dell’imprenditore, da cui sono emersi i dossier su magistrati noti e meni noti: il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, all’epoca pg nella città del Vallone; l’attuale pg Sergio Lari, ex procuratore nello stesso ufficio; gli ex pg, presidenti di corte d’appello e presidente del tribunale Giuseppe Barcellona, Salvatore Cardinale e Claudio Dell’Acqua, l’ex procuratore aggiunto (oggi sostituto pg a Palermo) Domenico Gozzo, l’ex procuratore di Gela (oggi aggiunto a Roma) Lucia Lotti e altri. Gli appunti risalgono al periodo 2010-2013, quando Montante era solo un importante imprenditore impegnato, con le associazioni di categoria, nella battaglia antiracket e antimafia; poi nel 2015 s’è saputo che era indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. A parte gli incontri, quasi sempre in occasioni istituzionali, per ognuno di loro sono stati trovati promemoria su consegne di curriculum di familiari: figli, nipoti o parenti acquisiti. Oppure conoscenti. Nel caso del pg di Palermo, oltre alla già nota planimetria di una casa di parenti in vendita, Montante ha conservato una nota del 3 maggio 2012 con scritto «Scarpinato mi consegna composizione Csm con i suoi scritti per nuovo incarico... Procura generale Palermo + Dna», oltre a un foglio stampato con i nomi dei consiglieri accanto ai quali sono segnati, a mano, la corrente giudiziaria o il partito di riferimento, con relativi calcoli sul possibile esito del voto. In una e-mail si parla di un procedimento disciplinare a carico di Scarpinato (poi archiviato) per alcune frasi pronunciate in memoria di Paolo Borsellino, con un appello di personalità a suo sostegno che il magistrato avrebbe chiesto di far pubblicare su Il Sole 24 ore, quotidiano di Confindustria. Sul conto di Lari — che insieme al suo ex aggiunto Nico Gozzo ha avviato l’inchiesta per concorso esterno nei confronti di Montante, iscrivendolo sul registro degli indagati — l’imprenditore ha archiviato il curriculum di un agente della sua scorta morto, e un memorandum con scritto «pagato biglietto Lari per Roma Chianciano», riferito a un convegno dove l’aveva invitato. Un’annotazione del 2010 ricorda la consegna di una vecchia bicicletta «per restaurarla» (con tanto di fotografia); l’azienda della famiglia Montante produce biciclette. Nella cartella intestata a Gozzo sono segnati pochi incontri e un presunto sms del 2001 sul suocero e la sua azienda agricola, mentre dal file relativo all’ex presidente della corte d’appello Cardinale sono saltati fuori riferimenti alle qualificazioni professionali di figlia e nipote. C’è pure una raccolta a nome dell’ex procuratore di Gela Lucia Lotti, impegnata per otto anni su quella frontiera criminale agguerrita ma periferica, molto laterale rispetto al contesto siciliano e anche alle relazioni di alto livello intessute da Montante negli anni dell’esposizione antimafiosa; lì è annotata la comunicazione dei dati di un poliziotto impegnato nel 2010 negli esami per il concorso a commissario. Di tutto ciò i pm catanesi hanno chiesto conto a Montante, che a Caltanissetta rivendica la propria innocenza per l’accusa di mafia, mentre a Catania ha negato o affermato di non ricordare nulla o quasi di quanto ha diligentemente appuntato e conservato per anni. Un atteggiamento giudicato «reticente» dagli inquirenti, che nel provvedimento di archiviazione inviato al Csm hanno manifestato «stupore» per le «richieste di aiuto» avanzate dai magistrati al potente imprenditore, nonché «perplessità» per il meticoloso lavoro di archiviazione nei confronti delle toghe con cui era entrato in contatto.
La sinistra? Non volle regolare i conti con Stalin (e Kruscev). Uno studio svela come l'intellighenzia italiana non riuscì a vedere le lotte di potere dietro il XX Congresso del Pcus, scrive Francesco Perfetti, Giovedì 22/12/2016 su "Il Giornale". Venne pubblicato il 4 giugno 1956 dal quotidiano americano The New York Times il testo integrale del cosiddetto «rapporto segreto» presentato da Kruscev nella notte fra il 24 e 25 febbraio 1956 in una «seduta a porte chiuse» dopo che i lavori del XX Congresso del Pcus erano stati già conclusi con l'elezione degli organi dirigenti e la riconferma di Kruscev alla carica di segretario generale del partito. Lo stesso quotidiano, per la verità, aveva già fornito, verso la fine di marzo, qualche anticipazione sui contenuti del documento basandosi su una relazione dell'ambasciatore americano in Urss. E, da quel momento in poi, era scattato un meccanismo che, tra smentite e conferme, aveva avviato un terremoto nella sinistra internazionale. Palmiro Togliatti, il quale, stando a una testimonianza di Eugenio Reale, aveva avuto a disposizione il testo del rapporto per un'intera notte, parlandone con gli altri componenti della delegazione italiana al XX Congresso, aveva tagliato corto: «Non c'è nulla. Panni sporchi, pettegolezzi». E, rientrato in Italia, aveva dovuto barcamenarsi di fronte ai giornalisti con dichiarazioni generiche sul congresso le cui discussioni, disse, avrebbero dominato «la scena politica per un lungo periodo di tempo». Aveva, pure, aggiunto con un impeto di colorita oratoria polemica: «Le menti capaci e gli animi onesti lo hanno già compreso e sempre più lo comprenderanno i popoli. Gli sciocchi e i venduti latrano e continueranno a latrare; ma di essi la storia non terrà conto». Aveva cercato, insomma, di non entrare nel merito dei temi la denuncia del culto della personalità e dei crimini di Stalin sollevati in quella occasione e che, ora, finivano per creare disorientamento e suscitare discussioni non soltanto nelle file dei partiti comunisti ma anche della sinistra più in generale. Ma, ben presto, anche incalzato da Pietro Nenni, avrebbe dovuto prendere posizione con una celebre intervista pubblicata sulla rivista Nuovi Argomenti e parlare di «gravi errori» di Stalin, di «violazione della legalità socialista», di «degenerazione burocratica», di «applicazione di mezzi istruttori illegittimi e moralmente ripugnanti», sostenendo tuttavia che, malgrado tutto, il regime sovietico aveva conservato «il suo fondamentale carattere democratico». Che i comunisti dei paesi occidentali, cresciuti all'insegna del principio fideistico di una obbedienza assoluta e nell'adorazione della figura e del mito del «piccolo padre», dovessero trovarsi in difficoltà di fronte alla condanna del culto della personalità e all'annuncio della «destalinizzazione», è comprensibile. Ma, quello che era accaduto in Unione Sovietica con il XX Congresso del Pcus e con il «rapporto segreto» di Kruscev era stato, in realtà, un capitolo della lotta di successione scatenatasi dopo la morte del dittatore nel 1953. Il recupero di Lenin in opposizione a Stalin sottendeva l'idea che la dittatura staliniana, almeno a partire dalla metà degli anni Trenta, fosse stato frutto della «degenerazione» del sistema e non già connotato intrinseco dello stesso. Un grande storico francese, François Furet, ha dimostrato bene questo punto facendo notare come, durante gli anni del potere krusceviano, l'Unione Sovietica sarebbe passata dallo «stadio totalitario allo stadio poliziesco» senza, peraltro, che questa transizione significasse un abbandono o una modifica dei presupposti ideologici del potere comunista. Gli effetti del XX Congresso del Pcus si fecero sentire con forza all'interno dei partiti comunisti occidentali anche se, nella maggior parte dei casi, vennero riassorbiti dalla logica del realismo politico anche a fronte dell'evoluzione della politica estera sovietica in quel torno di tempo. Presso gli ambienti intellettuali legati, in Italia, all'eredità gobettiana e alla tradizione azionista i temi emersi dal «rapporto segreto» di Kruscev ebbero, invece, un maggiore impatto e generarono sorpresa e spaesamento soprattutto dal punto di vista ideologico. Tutto ciò emerge con chiarezza dalla lettura di un bel volume a cura di Antonio Maria Carena e intitolato Il rapporto Chruëv. La denuncia del culto della personalità (Aragno, pagg. 214, euro 15): un volume che comprende sia il testo del rapporto puntualmente e finemente commentato da uno studioso antistalinista proveniente dal comunismo come Angelo Tasca, sia alcuni interventi sul tema del «culto della personalità» scritti, all'epoca, da Leo Valiani, Riccardo Bauer, Franco Venturi e Aldo Garosci. Questi intellettuali avevano condiviso quella che un «azionista pentito» come Arrigo Benedetti avrebbe definito «l'illusione democratica» e, dopo la fine del Partito d'Azione, si erano impegnati a vario titolo nel progetto di riformare o, comunque, rinnovare la cultura politica della sinistra italiana. La pubblicazione del «rapporto segreto» di Kruscev, la condanna del «culto della personalità», la denuncia dei crimini dello stalinismo erano tutti fatti che, nel loro insieme, li mettevano in difficoltà perché ponevano loro il problema di individuare una «cultura di governo» per la «sinistra democratica» che potesse evocare un modello alternativo a quello rappresentato dall'esperienza totalitaria della Russia staliniana. Il loro imbarazzo è evidente, per esempio, nelle pagine di Leo Valiani il quale, dopo aver affermato che si poteva «rimproverare a Stalin di aver abusato delle sue vittorie, ma non certamente di aver vinto le battaglie del suo tempo», lasciava intendere come Lenin fosse stato «interamente immune» da degenerazioni e abusi. O anche in quelle di Aldo Garosci che, recepita la differenza tra «politica di Stalin» e «tolleranza» di Lenin, si poneva il problema di mantenere insieme «il dogma del carattere socialista della rivoluzione e della costruzione staliniana». Dal canto suo, Riccardo Bauer ribadiva la «definitiva e indiscutibile importanza storica della rivoluzione russa» che, malgrado «aspetti negativi, evidenti per quanti conoscono la fecondità delle libertà democratiche», era «una reale conquista di umana civiltà». E aggiungeva che gli avvenimenti succedutisi dopo la morte di Stalin rispondevano a un «diffuso fermento di libertà» che circolava a dimostrazione della «vitalità della evoluzione compiuta dal paese, la vitalità della sua rivoluzione». La verità è che nessuno di questi intellettuali, abbeveratisi alla fonte dell'utopia, aveva la capacità di percepire il fatto che le denunce del «rapporto segreto» di Kruscev e del XX Congresso del Pcus erano solo l'epifenomeno di una dura lotta di potere all'interno dell'Urss. E, ancora, che i crimini di Stalin non erano, già, il frutto di una degenerazione del sistema politico causata dalla mente tarata del dittatore, ma piuttosto l'esito dell'intransigentismo rivoluzionario di Lenin deciso a spazzare via senza pietà gli ostacoli che si frapponevano ai «passi cadenzati del battaglioni ferrei del proletariato».
Quando l'onirico Zavattini era la star dei giornali fascisti. Il celebre sceneggiatore iniziò la carriera sui quotidiani del Ventennio con articoli capolavoro, che oggi ci sogniamo, scrive Massimiliano Parente, Mercoledì 21/12/2016, su "Il Giornale". Uno pensa ai quotidiani e alle riviste e agli intellettuali dell'epoca fascista e si immagina un mortorio di regime, invece è sempre una sorpresa: il mortorio, al confronto, è oggi. C'erano non solo l'immaginifico D'Annunzio e il futurismo marinettiano. Basti pensare a quanto scrivevano Curzio Malaparte, Achille Campanile, Elio Vittorini, Luigi Pirandello, Ennio Flaiano, Leo Longanesi, Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia e tanti altri. E, tra i tanti altri di spicco, il futuro padre del neorealismo, Cesare Zavattini, di cui Bompiani ripubblica Al macero, raccolta di interventi, elzeviri, racconti, aneddoti, usciti tra il 1927 e il 1940 (sebbene lui avesse poco interesse a un libro del genere, perché pensava «io postumo non mi interesso»). Non solo uno sceneggiatore, non solo un giornalista nato («Giornalista si nasce: un uomo che cammina nella nebbia è, per voi, un uomo che cammina nella nebbia. Per me, invece, è un fatto di cronaca. Due anni fa caddi in una pubblica via. Prima di alzarmi estrassi il taccuino per segnarmi l'ora esatta e il luogo»), ma uno straordinario scrittore, un umorista sopraffino. Ditemi voi dove trovate, su un quotidiano di oggi democratico e non fascista, un articolo simile a quello in cui Zavattini, con stile paradossale, alla Jonathan Swift, elogia lo sterminio delle zanzare come passatempo prediletto, tenuto conto che «al dì d'oggi, la protezione delle bestie è un sentimento raro e cristiano più dell'amore verso gli uomini». L'animalismo estremo è storia vecchia. Oppure dove immagina un paese chiamato Senzastagione, che sembra molto l'Italia di oggi, e in cui le recensioni vengono scritte prima dei libri. «Qui da noi, per amore del vivere quieto, le recensioni precedono la pubblicazione, anzi la creazione delle opere letterarie. Il pregio dell'autore sta nel comporre un lavoro, il men possibile lontano dal giudizio del critico, stroncatore o no che sia». Esattamente come fanno i nostri letterati da Premio Strega o Campiello o Viareggio e chi più ne ha più ne scampi. A proposito di letterati, è fantastico Zavattini che spiega come stilare un almanacco letterario, «con l'angoscia nel petto per dover illustrare le gesta dei vostri avversari e sottacere le vostre». La soluzione è vendicarsi con le fotografie, perché «a un collega si può togliere le gambe, una spalla, il torace». La graduatoria degli autori? Strettamente legata al corso degli anni e mutevole, perché un almanacco letterario è un fatto di cronaca, non di Storia, per cui da un anno all'altro «da illustrissimo si scende a noto, e qui fino al nome e cognome, soli soletti. Ma viene una grande tristezza in questi casi». La ricetta è comunque questa, attualissima: «Un almanacco letterario si compila così: mescolando al transitorio il duraturo, accoppiando il grande al mediocre. Solo il tempo restituisce le proporzioni, fa tornare dal nulla strani personaggi e cambia in ombra a volte chi pareva memorabile». Zavattini imperversa su qualsiasi argomento, dalle bugie, in media settantadue al giorno per ogni persona (citando lo scienziato Stanin), inclusi i saluti e gli auguri (pensiamo a tutti i «come stai?», «bene»); al problema di conoscere l'ora esatta, proponendo di affidare il compito ai mendicanti (si fa l'elemosina e il mendicante vi dice l'ora esatta, preventivamente munito dallo Stato di un orologio di precisione), fino all'annosa questione dell'adulterio. Un adulterio tutto femminile e forse perfino femminista e per niente mussoliniano, istituito per legge. Infatti «Se tutti i mariti del globo fossero traditi e a loro fosse nota l'universalità dell'accaduto, nessuno di loro protesterebbe: poiché male comune non è male». Infine, nella società dell'uomo duro e forte e combattente, Zavattini butta lì una magnifica distopia, immaginando un mondo dove sono tutti malati, pura poesia. «Se al mondo fossero soltanto malati, quale dolcezza. Le strade piene di carrozzine con le ruote di gomma o di amache stese tra un muro e l'altro; tutti camminerebbero in punta di piedi e si vedrebbe spuntare qualcuno ogni tanto dagli angoli delle strade con una rosa in mano; i tram andrebbero adagio per non far prendere le scosse () e seduti sulle panchine dei giardini pubblici signori offrono l'un l'altro il proprio termometro, prego lo provi. Termometri incrostati di pietre preziose, termometri d'oro doublé». Ah, signore mie, che fantasia, che leggerezza, che profondità durante il fascismo!
Osvaldo Napoli: «Erano fascisti, cercavano un politico a caso», scrive Rocco Vazzana il 15 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". Osvaldo Napoli non è più parlamentare dal 2013. L’ultimo incarico politico che gli ha restituito visibilità nazionale risale al maggio scorso: candidato alla carica di sindaco di Torino nelle liste di Forza Italia. Si è classificato al quarto posto, dietro Chiara Appendino, Piero Fassino e Alberto Morano (sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia). Da allora, Napoli fa il consigliere comunale, lontano dai riflettori dei palazzi romani. Eppure ciò non gli impedito di finire vittima di un agguato rivendicato dai Forconi, un sedicente movimento dal basso, anti casta, molto vicino all’estrema destra. A due passi da Montecitorio, una decina di persone circonda l’ex parlamentare, improvvisando uno strampalato processo popolare: gli leggono deliranti capi d’accusa, lo afferrano dalle braccia, lo stratto-nano. Fino all’arrivo delle forze dell’ordine. «Erano squadristi, fascisti, delinquenti seriali» , ci racconta al telefono Napoli pochi minuti dopo l’accaduto. Il tono di voce è pacato e indignato allo stesso tempo. «Mi scusi ma ho poco tempo», dice, «mi stanno arrivando decine di telefonate».
Bene, andiamo subito al punto allora. Ci spiega cosa è successo?
«Stavo rilasciando un’intervista a Striscia la notizia quando sono stato attorniato da un gruppo di una decina di persone. Hanno semplicemente intuito che io facevo politica e si son messi a urlare: «a morte», «arrestiamo tutti i politici». Citavano un fantomatico articolo della Costituzione che dice che «il popolo può imprigionare i rappresentanti della politica»».
Quindi non stavano aspettando lei in particolare?
«Non sapevano nemmeno chi fossi, me l’hanno spiegato dopo i carabinieri, cercavano solo un “politico”. Poi un energumeno, un delinquente seriale, ha cominciato a prendermi da un braccio e a tirarmi con forza. A quel punto i carabinieri hanno capito qual era la situazione e un militare si è avventato sulla persona che mi voleva “arrestare” costringendolo ad allentare la presa su di me. Io ho colto la palla al balzo e, grazie al mio scatto da tennista, sono riuscito a entrare nel Palazzo in via degli Uffici del Vicario».
Ha temuto per la sua incolumità?
«Inizialmente no, infatti in un primo momento sorrido e dialogo con quelle persone, pensavo si trattasse di uno dei soliti scherzi televisivi. Ma quando ho capito che avevo davanti dei delinquenti ho dovuto ragionare per capire come liberarmi nel più breve tempo possibile».
Cosa le rimproveravano?
«Niente, davvero nulla. Invocavano solo la galera per i politici».
Questo episodio è figlio di un clima pesante che si respira nel Paese?
«No, secondo me no. Questi non c’entrano nulla con la povera gente che non arriva a fine mese. Io mi son trovato davanti a degli squadristi, fascisti che usano questi sistemi per riuscire ad avere visibilità».
Ha già sporto denuncia?
«Mi dicono che uno di quelli ha già quaranta denunce, è inutile che io ne faccia una in più. Bisognerebbe però capire chi c’è dietro, perché è evidente che non hanno agito in maniera autonoma, non sono culturalmente così preparati neanche per fare questo tipo di azione».
E chi potrebbe esserci? Si è fatto un’idea?
«No, nella maniera più assoluta».
Parla il leader dei Forconi: «A noi rivoluzionari non resta che ammanettare i parlamentari abusivi», scrive Giovanni M. Jacobazzi il 20 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". Antonio Pappalardo: «L’arresto del deputato Osvaldo Napoli? Il codice impone ai privati di intervenire di fronte a un delitto contro lo stato, come nel caso di questi parlamentari illegittimi». Il generale Antonio Pappalardo è un personaggio eclettico e fuori dagli schemi. I carabinieri con qualche anno di servizio ricordano bene quando, nel 2000, da presidente del Cocer, il Consiglio centrale di rappresentanza, una sorta di sindacato militare senza però i poteri del sindacato civile, si scontrò duramente, rimettendoci l’incarico, con l’allora premier Massimo D’Alema rivendicando per l’Arma un ruolo attivo nella «fondazione di un nuovo tipo di Stato e di una nuova Europa, che i partiti politici così come sono strutturati, e comunque lontani dai problemi dei cittadini, non riescono più a garantire». Oltre la Benemerita è stata, infatti, la politica la grande passione di Pappalardo. Eletto alla Camera con il Psdi nel 1992, attualmente è presidente del Supu, il sindacato unitario personale in uniforme, il cui scopo è il «perseguimento di fini improntati al concetto più ampio di giustizia e solidarietà sociale, di tutela dei diritti civili, contro qualsivoglia sopruso, da chiunque perpetrato». Con i vertici di viale Romania i rapporti sono sempre stati “effervescenti”. Fra i primi atti da parlamentare, una interrogazione al ministro della Difesa per conoscere come mai il tenente colonnello Antonio Ragusa, allora comandante del gruppo carabinieri Roma, era stato promosso al grado superiore senza averne titolo. Pappalardo è di nuovo balzato agli onori delle cronache la scorsa settimana quando, insieme al leader dei Forconi, il “movimento rivoluzionario” guidato dall’agricoltore pontino Danilo Calvani, ha cercato di arrestare l’ex onorevole Osvaldo Napoli in piazza Montecitorio.
Generale, ci spiega cosa sono questi Forconi?
«È un movimento di popolo sorto sul territorio. I partiti tradizionali hanno fallito. E anche i cinquestelle, in cui molti avevano riposto fiducia, si sono dimostrati degli arroganti e degli sprovveduti. Noi cerchiamo di aggregare chi non si riconosce in nessuno di questi soggetti».
E cosa volete fare?
«Una vera riforma dello Stato. Ma non con le persone, incompetenti, che stanno selezionando i grillini. Noi cerchiamo gente che conosca effettivamente i meccanismi della pubblica amministrazione».
Nel frattempo arrestate gli ex parlamentari?
«Sulla vicenda di Osvaldo Na- poli si è fatta confusione. Noi siamo contro l’attuale Parlamento. Composto da abusivi che devono andare via quanto prima. Se non vogliono essere arrestati».
Si spieghi.
«Questo Parlamento è stato eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale. I suoi componenti sono in flagranza di reato di usurpazione di pubblici poteri. È un’associazione a delinquere. I cittadini, davanti a questa situazione di illegalità, hanno il diritto di intervenire. Lo dice il codice di procedura penale. Si tratta dell’arresto effettuato dal privato in caso di delitti contro la personalità dello Stato. Il cittadino effettua l’arresto e, poi, consegna il fermato alle forze di polizia».
Va bene: ma non sarebbe meglio che intervenisse la magistratura?
«Certo! Infatti, dopo l’episodio della scorsa settimana siamo andati dal procuratore di Roma Giuseppe Pignatone per rappresentargli questa situazione di illegalità del Parlamento».
E cosa vi ha detto il procuratore della Repubblica Pignatone?
«Che valuterà attentamente la mia denuncia. È molto rammaricato per quanto accaduto. Lo Stato ha il dovere di intervenire».
Con la polizia com’è finita?
«Tutto bene. Non ci hanno fatto nulla. La nostra azione era legittima. La polizia e i carabinieri, va detto, sono in un momento di grande difficoltà. C’è una forte debolezza istituzionale».
Capirà che non è arrestando i parlamentari che si risolvono i problemi.
«Infatti, il presidente della Repubblica deve sciogliere quanto prima le Camere. E indire le elezioni in modo che venga ripristinata la legalità. È lui che ha una grande responsabilità».
I Forconi si presenteranno alle prossime elezioni politiche?
«Ci stiamo strutturando sul territorio. C’è un comitato di saggi, di cui faccio parte, che sta valutando le mosse future. Io, comunque, non mi candiderò».
Chi inserirete nelle liste?
«Faccio un appello alla società civile, al Consiglio superiore della magistratura, ai vertici delle Forze di Polizia: segnalateci persone capaci che vogliano darci una mano per cambiare il Paese».
INTERVISTA al dr Antonio Giangrande, autore di questo libro. Scrittore, sociologo storico, giurista, editore, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
Il degrado ambientale è ormai evidente nella Terra dei Fuochi; diverse sono le denunce per abbandono illecito di rifiuti e i livelli d’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo sono oggetto d’interesse da parte di molti studi. Cosa può dirci lei in riguardo?
«Io non parcellizzerei la questione. Bisogna uscire dallo schema ideologico dove tutto è dipinto come malaffare perpetrato dall’avversario politico di centro destra, così come tutto è malaffare quello che succede nel Sud Italia. Su questo i giornali del nord Italia ci sguazzano: ma di “Terre dei Fuochi” bisogna parlare. Ogni regione ha i suoi fusti interrati o i suoi rifiuti speciali sommersi. Così come ogni regione ha le sue denunce insabbiate. I livelli di inquinamento di ogni specie è allarmante, ma non serve la dietrologia e l’ipocrisia di un certo ambientalismo ideologico. Spesso la buona volontà dei cittadini si scontra con il pressapochismo e l’incapacità degli amministratori. Se non ci sono isole ecologiche, lo sfogo si tramuta in illegalità. Se non si considera il rifiuto o lo scarto una risorsa, allora è inutile parlare di lotta all’inquinamento. E poi l’inquinamento è causato da più fattori, oggi irrinunciabili».
In che modo definirebbe il rischio ambientale in corso in rapporto ad una prospettiva duratura nel tempo?
«Il rischio ambientale in Campania come in tutta Italia, va pari passo con il progresso industriale e con il benessere economico. Più si lavora, più si spende, più si inquina.»
Come definirebbe nello specifico il livello del rischio di inquinamento dell’acqua nella Terra dei Fuochi?
«L’acqua, sia essa di falda o di superficie, si inquina con le infiltrazioni dannose dovute a vari fattori, compreso l’inquinamento dell’aria, o del suolo. L’acqua è il naturale sbocco di ogni elemento chimico che la nostra società produce.»
Come definirebbe nello specifico il livello del rischio di inquinamento del suolo nella Terra dei Fuochi?
«Tutto quello che brucia in superficie, diventa cenere o fumo. In un modo o nell’altro tutto torna a terra, anche con la pioggia».
Come definirebbe nello specifico il livello del rischio di inquinamento dell’aria nella Terra dei Fuochi?
«Gas di scarico delle auto o delle ciminiere o dei camini sono pari ai miasmi dei fuochi dei rifiuti».
Molti giornali o riviste (istitutotumori.na.it, quotidianosanita.it, etc.) parlano della coincidenza dei tassi di mortalità nella Terra dei Fuochi in rapporto con l’inquinamento ambientale da rifiuti. In base alle sue conoscenze potrebbe parlarci di questo fenomeno? In che modo lo considera sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista di parere personale?
«Ogni inquinamento provoca tumori e l’Italia è piana di studi che dimostrano che in una certa zona, rispetto ad un’altra, vi è una incidenza di tumori. Prendiamo per esempio Taranto. Uno Studio recente del Ministero della Saluta ha dimostrato che Taranto, (quindi Ilva) è inquinata quanto Roma: ed è tutto dire».
Identificherebbe la questione ambientale nella Terra dei Fuochi in una fase di transizione verso la distruzione, ma ancora in stato di sicurezza, oppure, in una fase di distruzione già in atto, la catastrofe bussa alle nostre porte? Spieghi la motivazione della sua risposta.
«La questione ambientale nelle “Terre dei Fuochi” è una questione senza soluzione di continuità. Si pone rimedio solo se si ritorna all’età della pietra».
Identificherebbe la questione salute umana nella Terra dei Fuochi in una fase di transizione verso la distruzione, ma ancora in stato di sicurezza, oppure, in una fase di distruzione già in atto, la catastrofe bussa alle nostre porte? Spieghi la motivazione della sua risposta.
«La salute umana è in fase di involuzione: se da una parte ci sono progressi per la sua tutela, dall’altra ci sono aggressioni multiformi, tra cui quello dell’inquinamento. Non è solo l’inquinamento, però, che fa paura alla salute, ma la mancanza di servizi ed efficienza per la sua cura. L’inquinamento provoca il tumore, la mancanza di ospedali che lo curano provoca la morte».
Molteplici sono i dati che ci permettono di conoscere la questione Terra dei Fuochi, a partire dai mass media sino a studi portati avanti da diversi ricercatori (striscia la notizia, sentieri etc...). Spesso si parla anche di ricerche occultate o di risultati non dichiarati (Arpac...), quindi una mancanza di informazione da parte delle istituzioni. Quale parere può esprimerci in considerazione del fatto che a volte i dati ufficializzati dalle istituzioni vengono accusati di non essere corrispondenti alla realtà?
«I dati sono spesso manipolati da chi è portatore di partigianeria. Bisogna essere obbiettivi nei giudizi. I fatti son fatti e non bisogna vedere trame o complotti dietro ogni vicenda».
Se volessimo parlare di cambiamento da parte della società civile, quindi da parte di coloro che sono inermi ai rischi da inquinamento e che subiscono le conseguenze di azioni illecite; in che misura potremmo agire e verso quali direzioni: pubblicità informativa, programmi di prevenzione, mobilitazioni continue...?
«Nessuno è esente dal problema e tutti dovremmo darci da fare. I fatti son fatti e come tali son da tutti conosciuti e non servono cortei, marce, mobilitazioni. In democrazia si elegge qualcuno che abbia il potere di rappresentare la nostra aspettativa e portare avanti le soluzioni delle nostre problematiche. Se questo non succede è colpa dei cittadini. Ergo: chi è causa del suo mal pianga se stesso».
Da parte di associazioni no profit o da parte di enti territoriali finalizzati all’assistenza sociale, quali tipi di programmi d’azione potrebbero essere richiesti in nome di una ribalta verso il miglioramento delle condizioni di vita umana nonché ambientale?
«Io diffido delle associazioni che appartengono ad una certa area politica e quindi fanno politica e a quegli enti che usano l’assistenza sociale per fare politica. Si veda per esempio Taranto. Si scontrano i fautori per il diritto al lavoro (si parla di decine di migliaia di posti di lavoro) ed i fautori del diritto alla salute. Lì parla la politica, nessuno ascolta il lavoratore, che è il primo ad essere malato. L’unico programma di azione che deve essere adottato è che, spesso, chi inquina commette reato perseguibile d’ufficio. E poi. Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi. Inutile lamentarci dei "Caccamo" alla Cassazione. Carmine Schiavone ha detto: Roma nostra! "Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori. Lo strumento per addentrarsi nei gangli del potere sono gli esami di Stato ed i concorsi pubblici truccati».
Si parla molto di Terra dei Fuochi come punto principale di identificazione del rischio di inquinamento e relativi danni alla salute umana. Del resto della regione Campania o di altre regioni limitrofe non se ne parla molto da un punto di vista di espansione e dilagazione del fenomeno sopra detto. Secondo lei quanto i confini di tale problematica possono essere considerati estesi?
«“L’Italia è una terra dei fuochi”. Lo rivela l’Istituto Superiore della Sanità. Ma l’informazione balbetta. LE TERRE DEI FUOCHI è un passo del mio saggio d’inchiesta usato per molte tesi di laurea. “Ambientopoli. L’Italia dell’Inquinamento e del Dissesto Truccato” è il suo titolo. Nello specifico ho anche scritto “Tutto su Napoli e la Campania. Quello che non si osa dire”. Giusto per dimostrare che oltre la Terra dei Fuochi c’è di più!».
A MIA INSAPUTA. QUELLI CHE NON SANNO.
A mia insaputa": tutti i politici che non sapevano. Da Raggi a Scajola, da Fini a Emiliano, sono tanti, e di ogni partito, i politici che (a torto o a ragione) hanno dichiarato di non sapere, scrive Claudia Daconto il 6 febbraio 2017. Ci sono cascati in molti. Pur di allontanare da sé il sospetto di essere complici di azioni moralmente, politicamente o anche legalmente poco o per nulla trasparenti, o in alcuni casi, come dimostrato dalla giustizia, avendo ragione, politici di ogni schieramento hanno dichiarato di non essersi mai accorti di ciò che avveniva a un palmo del loro naso. Anche quando di mezzo c'erano collaboratori stretti e addirittura amici e familiari. In alcuni casi la giustizia ha dato loro ragione, in altri... no. Ecco una carrellata dei più clamorosi "è successo a mia insaputa".
Virginia Raggi e le polizze vita. È giovedì 3 febbraio 2017. Virginia Raggi siede davanti al procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Francesco Dall'Olio. Assistita dal suo avvocato Alessandro Mancori, il sindaco di Roma sta rispondendo alle accuse di abuso d'ufficio e falso ideologico che la Procura di Roma le contesta in merito alla promozione a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele Marra, ex capo del Personale dei comunali capitolini arrestato a dicembre con l'accusa di corruzione. L'interrogatorio andrà avanti per diverse ore, ben otto. È durante quelle lunghe ore che il sindaco scopre di essere stata nominata beneficiaria di due polizze vita da 30 mila e 3 mila euro da parte del suo fedelissimo Salvatore Romeo, dipendente del Comune in aspettativa e promosso capo della sua segreteria al triplo dello stipendio. Virginia trasecola. Giura di non saperne nulla. A gennaio e marzo del 2016 Romeo le avrebbe dunque intestato tutti quei soldi a sua insaputa. Benché ciò risulti tecnicamente plausibile, il fatto ha destato comunque molti sospetti e illazioni. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe che fosse presa per buona la causale “relazione sentimentale”, indicata dall'ormai ex capo segreteria del sindaco. L'alternativa, priva finora di qualsiasi riscontro sarebbe invece che Romeo, che negli anni scorsi ha sottoscritto numerose polizze per un totale di 130mila euro a beneficio di colleghi ed esponenti del M5S, abbia utilizzato il sistema delle polizze per mascherare finanziamenti al Movimento oppure per mettere a disposizione della Raggi del denaro in cambio di favori.
Claudio Scajola e la casa al Colosseo. Che il suo nome sia stato affiancato a quello di Virginia Raggi ha molto infastidito l'ex ministro Claudio Scajola. Alla notizia delle polizze “a sua insaputa”, in effetti a molti è venuto in mente il paragone con la vicenda della casa con vista Colosseo acquistata da Scajola per 600mila euro ma in realtà costata 1,7 milioni. “Forse mi hanno fatto un regalo a mia insaputa. Se trovo chi è stato...”, una frase pronunciata in conferenza stampa il 4 maggio 2010 per commentare il dono ricevuto dal faccendiere Diego Anemone, che ha segnato il destino politico di Scajola e dal quale l'allora ministro del governo Berlusconi non si è mai più liberato. In una nota trasmessa alle agenzie nei giorni scorsi, Scajola ha voluto ricordare che egli “si dimise senza aver avuto neppure un avviso di garanzia” dalla procura di Perugia che allora indagò sulla presunta corruzione. Nel processo apertosi in seguito a una nuova inchiesta della Procura di Roma, Scajola è stato assolto in primo grado e il reato prescritto in appello.
Umberto Bossi e la villa restaurata. Claudio Scajola non è stato certo l'unico politico a passare dei guai per una casa. Quando nel 2012 scoppia lo scandalo sull'uso dei fondi della Lega da parte dell'ex tesoriere Francesco Belsito, ad andarci di mezzo fu anche l'allora leader e fondatore Umberto Bossi. Secondo l'accusa, per coprire le spese personali dei suoi familiari, i soldi del partito erano stati utilizzati anche per ristrutturare la loro casa di Gemonio. “Io non so nulla di queste cose” tuonò allora un amareggiato Umberto Bossi minacciando di denunciare i responsabili di tali manovre. Belsito, che all'epoca fu arrestato per associazione a delinquere, truffa aggravata, appropriazione indebita e riciclaggio e che oggi è ancora sotto processo per appropriazione indebita e, insieme anche allo stesso Bossi e ad altre cinque persone, per truffa ai danni dello Stato, oggi si è riciclato nel Movimento Sociale Italiano. Per Umberto Bossi, invece, quella vicenda fu all'origine della fine della sua carriera politica e ai vertici della Lega.
Roberto Maroni e gli investimenti in Tanzania. Anche l'attuale governatore della Lombardia Roberto Maroni nel 2011 dichiarò di non aver mai saputo nulla di come Francesco Belsito gestisse i fondi della Lega. Soprattutto non sapeva che l'ex cassiere leghista avesse trasferito in vari paesi esteri, tra cui la Tanzania, quasi 60 milioni di finanziamento pubblico ottenuti tra il 2008 e il 2010. “Gli investimenti in Tanzania? - trasecolò l'allora ministro dell'Interno. Io non ne sapevo niente”. Un anno dopo, nel gennaio del 2012, Maroni dichiarerà durante un incontro a Somma Lombardo, in provincia di Varese, che gli investimenti della Lega Nord in Tanzania “sono stati un errore sul piano politico, un brutto danno d'immagine al quale dovremo rimediare”. Senza presumere che dietro quelle operazioni ci fosse qualcosa di irregolare, Maroni reclamò dei chiarimenti: “non penso che qualcuno nella Lega faccia delle cose non regolari – disse allora - ma un conto è il rispetto delle leggi e un conto è il rispetto dell'etica della Lega Nord”. Oggi il presidente lombardo è uno dei teste nel processo contro Francesco Belsito.
Francesco Rutelli e Luigi Lusi. Totalmente ignaro di essersi messo in casa un tesoriere infedele si dichiarò anche Francesco Rutelli. Ascoltato dagli inquirenti che indagavano sull'appropriazione di almeno 25 milioni di euro di fondi della Margherita da parte dell'ex cassiere Luigi Lusi, che allora affermava di essere stato spinto a effettuare alcune operazioni proprio dal presidente del partito, nell'aprile 2012 Rutelli ribadiva che le attività di Lusi erano state condotte “solo per il suo tornaconto personale, al di fuori di ogni mandato, e a totale insaputa mia e del gruppo dirigente della Margherita”. Il 31 marzo del 2016 l'ex senatore è stato condannato anche in appello a 7 anni. Una sentenza accolta con grande favore dall'ex sindaco di Roma, perché “riafferma – disse – l'onore della Margherita e mio”. Ma che tuttavia non ha potuto risarcirlo del tutto dell'enorme prezzo politico pagato per essersi fidato, a occhi chiusi, di ciò che faceva uno dei suoi principali collaboratori con il soldi del suo partito.
Gianfranco Fini e la casa di Montecarlo. Gianfranco Fini nel 2010, presidente della Camera, scoprì che una parte del patrimonio immobiliare del suo vecchio partito, Alleanza Nazionale, era finito nelle mani del fratello della sua fidanzata Elisabetta. E puntualmente dichiarò: “non sapevo che la casa di Montecarlo fosse stata ristrutturata e affittata a mio cognato”. La vicenda è nota: nel 2008 An “svende” per 300mila euro un appartamento donato al partito dalla contessa Anna Maria Colleoni. A comprarlo è una società offshore, la Printemps, che subito lo rivende per 330mila euro a un'altra società caraibica (pare intestata proprio a Elisabetta) che a sua volta lo affitta a Giancarlo Tulliani il quale risulterà proprietario di entrambe. Indagini recenti hanno tirato in ballo anche la figura del cosiddetto “re delle slot” Francesco Corallo, inquisito per vari reati tra cui il riciclaggio di denaro sottratto al fisco. Corallo infatti avrebbe acquistato l'immobile a prezzo pieno, 1 milione e 360 mila euro. Soldi finiti di nuovo a Tulliani che li avrebbe depositati su conti esteri intestati anche a suo padre Sergio. Intervistato nel dicembre scorso, Fini si dichiarò un uomo distrutto: “sono notizie delle quali non ero minimamente a conoscenza. Sono davanti a un bivio: o sono stato talmente fesso oppure ho mentito volutamente. In cuor mio so qual è la verità e non pretendo di essere creduto ma per me questo è un dramma familiare”.
Josefa Idem e l'Ici non pagata. Sempre per una casa ci ha rimesso il posto da ministro delle Pari Opportunità nel governo Letta anche l'ex olimpionica Josefa Idem dimessasi dalla carica il 24 giugno del 2013. “Non sapevo dell'Ici non pagata – dichiarò all'epoca a sua discolpa - Io non mi sono mai occupata personalmente della gestione di queste cose. Nella mia vita ho passato tre settimane al mese in canoa, dodici mesi l'anno. Ho sempre delegato ai tecnici chiedendo loro naturalmente di fare le cose a regola d'arte”. Una fiducia evidentemente mal riposta dal momento che per ben 4 anni la campionessa di canoa avrebbe omesso di versare la tassa sulla casa tentando di far passare una palestra come sua prima abitazione. Nello stesso periodo Idem finì nella bufera anche per un'assunzione sospetta da parte della società sportiva del marito avvenuta poco prima di essere riconfermata assessore a Ravenna. Accusati in concorso di truffa aggravata ai danni del Comune di Ravenna, per 8.642 euro di contributi previdenziali, il processo a carico della senatrice dem e del marito si è concluso con la prescrizione nel novembre del 2016.
Angelino Alfano e il caso Shalabayeva. Buio totale anche da parte dell'ex ministro dell'Interno Angelino Alfano sul cosiddetto “caso Shalabayeva”. Nessun esponente del governo, tantomeno lui, sarebbe stato infatti a conoscenza del fatto che il 28 maggio del 2013, in un blitz della polizia, era stata arrestata in una casa romana a Casal Palocco, la moglie del dissidente kazako, ricercato dal regime di Nazarbaev, Mukhtar Ablyazov, e rispedita il giorno dopo in Kazakistan insieme alla figlioletta di 6 anni. Uno scarico di responsabilità che ha gettato e continua a gettare molte ombre su Alfano, diventato nel frattempo ministro degli Esteri, e che una serie di circostanze hanno teso a smentire quando sosteneva che tutto fosse avvenuto “a sua insaputa”. Alma Shalabayeva e la figlia più piccola poterono tornare in Italia solo il 27 dicembre del 2013 in seguito all'intervento della Ue, all'appello dello stesso Ablyazov al premier Letta, all'apertura di un'inchiesta e all'iscrizione nel registro degli indagati dell'ambasciatore del Kazakistan in Italia e di altre due persone.
Michele Emiliano e le cozze pelose. E chi poteva immaginare che un compagno di partito come Gerardo Degennaro, ex consigliere regionale del Pd, titolare dell'impresa di costruzioni Dec, arrestato insieme ai fratelli e altre persone, nel marzo del 2013 per vari reati tra cui l'associazione a delinquere, che in cambio di soldi e altre utilità avrebbe ottenuto agevolazioni per ottenere appalti pubblici da parte del Comune di Bari guidato allora da Michele Emiliano, potesse essere un personaggio del genere? Non certo l'ex magistrato e attuale governatore della Puglia che alla vigilia di Natale 2012 ricevette, proprio dai Degennaro, un cesto natalizio contenente anche le celeberrime 50 cozze pelose, vanto della gastronomia locale. All'epoca Emiliano si pentì solo di non aver rimandato indietro l'omaggio natalizio ma non si dimise: “se qualcuno pensa di potermi mandare a casa solo per qualche chilo di pesce e cozze pelose, si sbaglia: rimarremo qui consapevoli degli errori commessi ma con la determinazione che solo le persone perbene riescono a mettere insieme”.
Beppe Grillo, il blog è un caso: non rispondo dei contenuti. Questa la tesi difensiva nei confronti di una querela per diffamazione presentata dal Pd. E i dem attaccano: «Ha un blog a sua insaputa?», scrive Emanuele Buzzi il 15 marzo 2017 su “Il Corriere della Sera”. Beppe Grillo? «Non è responsabile, né gestore, né moderatore, né direttore, né provider, né titolare del dominio, del blog, né degli account Twitter, né dei tweet e non ha alcun potere di direzione né di controllo sul blog, né sugli account Twitter, né sui tweet e tanto meno su ciò che ivi viene postato». Il Pd pubblica la memoria difensiva che il leader del Movimento ha fornito in una causa intentata dai dem nel 2016 e passa all’attacco. La nota d’accusa — scritta dal tesoriere del Pd Francesco Bonifazi — viene rilanciata da tutti i big del partito. «Ha un blog a sua insaputa?», commenta su Twitter Debora Serracchiani. Colui che ha registrato il dominio nel 2001 e che ne è tuttora detentore si chiama Emanuele Bottaro ed è finito in realtà già negli scorsi anni a processo per questioni relative al sito. Il gestore, ovviamente, si può ricondurre alla Casaleggio associati. Una rete a tutela del leader, già sommerso da diverse cause. Il post «incriminato» dal Pd riguarda il caso lucano che coinvolse il ministro Guidi. Un post non firmato. «La Guidi chiese l’avallo della Boschi che per blindarlo e assicurarsi che tutto andasse come doveva inserì l’emendamento incriminato nel testo del maxiemendamento su cui poi, con il consenso del Bomba, pose la questione di fiducia», si legge. E poi arriva il passaggio che ha scatenato la reazione dem: «Un meccanismo perfetto ai danni dei cittadini. Tutti collusi. Tutti complici. Con le mani sporche di petrolio e denaro. Ora si capisce perché il Pd ed il governo incitano illegalmente all’astensione sul referendum delle trivelle».
Il trucco di Grillo: querelato il suo blog, ma non pagherà lui, scrive di Enrico Paoli il 15 marzo 2017 su “Libero Quotidiano”. L' ultima, forse, le batte davvero tutte. Beppe Grillo, comico a tempo perso e leader a corrente alternata del Movimento 5 Stelle, non è responsabile di quanto esce sul suo Blog e dunque le cause pendenti contro di lui vanno discusse non a Genova, ma a Roma. Insomma Grillo, quel Grillo, non esiste. Esiste solo un blog, una rete, un Movimento con deputati e senatori, ma non lui. A dirlo non è uno dei tanti siti che animano il Web con notizie false, vere e verosimili, ma il tribunale di Genova, sulla scorta di una causa civile intentata dal Pd contro il leader dei pentastellati per alcune affermazioni contenute sul Blog relative all' inchiesta sui pozzi petroliferi in Basilicata. A far emergere la vicenda è il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi, che ha prontamente raccolto l'invito rivolto da Matteo Renzi in occasione dell'intervento di chiusura del Lingotto di Torino. «Ora vi racconto una storia simpatica, simpatica», scrive sulla sua pagina Facebook l'esponente dem, «un noto comico, che ha costruito la propria fama soprattutto con il suo Blog, i suoi profili Facebook e Twitter, un bel giorno decide di dire a 400mila iscritti e diversi milioni di elettori del Pd che sono "tutti collusi. Tutti complici. Con le mani sporche di petrolio e denaro". Trattandosi di un comico», sottolinea Bonifazi, «ho cercato di leggere tra le pieghe del messaggio la battuta ma, ahimè, ho trovato solo offese. Quindi ho cercato di tutelare la nostra immagine, non tanto per me quanto per la comunità che rappresento, attraverso un'azione legale. Dicono che loro sono per la legalità? Bene, lo dimostrino: si lascino processare». «Poi il comico ha anche una certa esperienza di tribunali...», chiosa sarcasticamente il tesoriere del Pd, riecheggiando le vicende giudiziarie di Grillo, dato che il comico è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo. Ma il caso sollevato da Bonifazi, che va ben al di là delle schermaglie politiche, pone una questione seria: se Grillo non risponde di ciò che viene pubblicato sul Blog, chi è il responsabile? «Leggendo la memoria difensiva con cui il comico rispondeva alla denuncia, ho creduto di essere di fronte al copione del suo nuovo spettacolo ma il mio avvocato ha confermato: è la sua memoria difensiva», spiega il parlamentare. «Il comico», scrive ancora Bonifazi riportando la memoria di Grillo, «non è responsabile, né gestore, né moderatore, né direttore, né provider, né titolare del dominio, del Blog, né degli account Twitter, né dei Tweet e non ha alcun potere di direzione né di controllo sul Blog, né sugli account Twitter, né sui tweet e tanto meno su ciò che ivi viene postato». Beppe Grillo non è. Il messaggio di Bonifazi viene ritwittato da numerosi dirigenti Dem, da Matteo Renzi, a Maria Elena Boschi, passando per Debora Serracchiani. «La tua difesa è ridicola, se vuoi parlare a milioni di persone abbine rispetto e assumiti la responsabilità delle cose che dici e scrivi di fronte a loro e di fronte alla legge. Noi andremo fino in fondo», annuncia alla fine Bonifazi. E siamo solo all'inizio. Enrico Paoli
Beppe Grillo non deve rispondere dei contenuti pubblicati sul suo blog come sostengono i suoi avvocati? Ecco verità e falsità scritte in proposito, scrive “Il Corriere del Giorno" il 20 marzo 2017. Di chi è il blog di Grillo? 3 cose vere e 5 false dette in questi giorni. Nel tardo pomeriggio del 14 marzo, il tesoriere del Partito Democratico Francesco Bonifazi ha pubblicato su Facebook una pagina della memoria difensiva presentata dagli avvocati di Beppe Grillo in una causa per diffamazione. Nel documento si legge che Grillo “non è responsabile, né gestore, né moderatore, né direttore, né provider, né titolare del dominio, del Blog, né degli account Twitter, né dei Tweet e non ha alcun potere di direzione né di controllo sul Blog, né sugli account Twitter, né sui tweet e tanto meno su ciò che ivi viene postato”. La questione ha avuto molto risalto ed è nato un dibattito su chi scrive i contenuti del blog di Beppe Grillo e su chi è chiamato a risponderne. Abbiamo verificato che cosa c’è di vero e di falso nella vicenda.
1. “Il blog di Grillo non è intestato a Grillo”. Vero. E neppure alla Casaleggio Associati. Una semplice ricerca sul registro italiano dei domini.it mostra che il dominio beppegrillo.it, creato il 15 marzo 2001, è intestato a Emanuele Bottaro,52enne residente a Modena che lavora per una società di comunicazione. Nel 2001 la Casaleggio Associati ancora non esisteva e Gianroberto Casaleggio non aveva ancora incontrato Beppe Grillo: i due si conosceranno nel 2004 e il sito andrà online nel gennaio 2005. Intervistato da Repubblica, Bottaro ha detto di conoscere personalmente Beppe Grillo «da vent’anni», di avere un rapporto di stima e di fiducia con lui e di avere registrato il dominio «per toglierlo dal mercato», prima che venisse creato il blog. Ha aggiunto che tra Grillo e lui non c’è alcun accordo scritto e di non aver mai guadagnato nulla dal suo possesso del dominio.
2. “Niente lega Grillo al blog a suo nome”. Falso. Come ha scritto Matteo G.P. Flora, esperto di reputazione online, esistono comunque diversi legami tra Grillo e il sito. Nell’atto costitutivo del M5S si legge che Beppe Grillo è il «titolare effettivo del blog raggiungibile all’indirizzo beppegrillo.it». In un post del marzo 2012, firmato “Beppe Grillo”, si legge inoltre che «la responsabilità editoriale del blog è esclusivamente mia». Inoltre, il titolare del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è indicato in Beppe Grillo dallo stesso sito, mentre il responsabile è la Casaleggio Associati. La questione è ulteriormente complicata dal fatto che la stessa privacy policy indica che i dati vengono condivisi con l’Associazione Rousseau, che è titolare del trattamento per quanto riguarda l’attività del “Blog delle Stelle”. Aspetto più tecnico: il codice sorgente del sito rimanda, nel campo “autore”, all’account verificato di Grillo su Google+.
3. “Il post incriminato è firmato da Grillo”. No, si tratta di un post senza firma né indicazione dell’autore. Pubblicato il 31 marzo 2016, il giorno stesso dell’annuncio delle dimissioni del ministro per lo Sviluppo economico Federica Guidi per lo scandalo Tempa Rossa – dimissioni accettate alcuni giorni dopo – il post si intitolava “#RenzieBoschiACasa”. Il testo chiedeva le dimissioni anche dell’allora presidente del Consiglio e del governo, accusandoli di coinvolgimento nello scandalo e di fare «l’interesse esclusivo dei loro parenti, amici, delle lobby e mai dei cittadini». Conteneva le frasi: «Tutti collusi. Tutti complici. Tutti con le mani sporche di petrolio e denaro». Per i contenuti del post, Francesco Bonifazi ha denunciato Beppe Grillo per diffamazione.
4. Oggi nessun post del blog di Grillo è senza firma. Lo ha detto Luigi Di Maio in un’intervista il 15 marzo (al minuto 38’20’’): è vero nella forma, ma nella sostanza, in molti casi, l’autore non è esplicitato in modo chiaro e univoco. I post sul blog di Beppe Grillo, infatti, appaiono spesso sotto una firma collettiva come “MoVimento 5 Stelle”, “Gruppo di Coordinamento Comuni 5 Stelle” o “MoVimento 5 Stelle Europa”, altre ancora firmati da Beppe Grillo o da altre singole persone esterne al M5S. Beppe Grillo, almeno negli ultimi tempi, firma raramente i post che compaiono sul blog. Tra gli ultimi cento, soltanto sei portano la sua firma. Circa un terzo dei rimanenti compaiono sotto l’autore generico “MoVimento 5 Stelle”.
5. Grillo è l’autore dei suoi post. Ci sono ragioni per dubitare che Beppe Grillo scriva in concreto i post che compaiono con la sua firma, almeno in passato, anche se non è chiaro fin dove si spinga il suo controllo sul contenuto. In un’intervista con Marco Travaglio pubblicata nel 2014, Gianroberto Casaleggio – il cofondatore del Movimento 5 Stelle scomparso nell’aprile 2016 – disse che tutti i post del blog erano «loro», intendendo suoi e di Beppe Grillo: «Ci sentiamo sei-sette volte al giorno per concordarli, poi io o un mio collaboratore li scriviamo, lui li rilegge, e vanno in Rete». Alcune inchieste giornalistiche sul funzionamento della Casaleggio Associati hanno raccontato, nel corso degli anni, che i post sono stati scritti a volte da Pietro Dettori, oggi responsabile editoriale presso l’Associazione Rousseau e già dipendente della Casaleggio Associati.
6. “Non è chiaro di chi sia la responsabilità del post”. Questo è vero, almeno in parte. L’avvocato Caterina Malavenda, esperta di cause sulla stampa, ha spiegato che il responsabile dei contenuti pubblicati da un blog è il gestore, che però non è obbligato a un controllo preventivo su tutti i suoi contenuti. Grillo ha detto di non essere il gestore, lasciando quindi il dubbio su chi effettivamente lo sia, e così facendo ha inoltre «scaricato l’eventuale colpa su un altro», cioè l’autore materiale di quel post pubblicato anonimo. La Polizia Postale dovrà cercare di identificare chi ha scritto il post e lo ha messo online e su di lui (o lei) ricadrà l’eventuale responsabilità in caso di condanna nella causa intentata dal PD.
7. “Non ci sono leggi per i reati commessi attraverso Internet”. Falso. Lo ha dichiarato l’esponente del M5S Paola Taverna ospite di Otto e Mezzo (al minuto 18’35’’). In realtà, diverse sentenze hanno chiarito da anni che, ad esempio, il caso della diffamazione tramite Internet è compreso in quanto previsto dall’art. 595 del codice penale, che punisce in modo più grave la diffamazione se essa è commessa «col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità». Quello su cui discutono i giuristi è invece fin dove si possa spingere la comparazione tra i blog e la stampa, oltre ad alcune situazioni particolari come, ad esempio, se il gestore di un blog debba essere ritenuto responsabile anche per i commenti in fondo ai suoi post. Falso. Lo ha detto Di Maio nell’intervista citata sopra (al min. 37’40’’) e lo ha scritto, anche se in modo più ambiguo, lo stesso post firmato da Grillo a commento di questa vicenda. «I post di cui io sono direttamente responsabile sono quelli, come questo, che riportano la mia firma in calce», ha scritto, aggiungendo che il PD ha «per il momento perso la causa». Tuttavia, il procedimento è ancora in corso e quella pubblicata da Bonifazi è solo la memoria difensiva presentata dai legali di Grillo. La causa non si è conclusa e il PD non ha quindi ancora perso né vinto.
I loro omessi controlli. Volevano condannarlo a sedici mesi per un articolo del 2012: però il direttore non era lui, scrive Alessandro Sallusti, Mercoledì 15/03/2017, su "Il Giornale". Uno dei giudici che nel 2012 condannò al carcere Alessandro Sallusti fece poi causa al direttore per «omesso controllo» su un articolo che lo riguardava pubblicato nei giorni seguenti all'arresto. Ieri il processo, incardinato al tribunale di Cagliari, doveva arrivare a sentenza. La pubblica accusa aveva chiesto per il direttore una condanna a 16 mesi di carcere. In aula Sallusti, con la memoria che qui riproduciamo, ha dimostrato che in quei giorni non era il direttore del «Giornale», in quanto si era dimesso. Il pm, cioè lo Stato, chiedeva quindi il carcere per un manifesto innocente. L'udienza è stata sospesa, non senza imbarazzo, e la sentenza rinviata. Signor presidente, questo processo è, diciamo così, figlio di un precedente procedimento a mio carico, concluso nell'ottobre del 2012 con la mia condanna a 14 mesi di reclusione e il conseguente arresto, cosa che ovviamente è stata per me un'esperienza non facile da affrontare. Le analogie tra allora e oggi sono diverse. Anche in quel caso un magistrato, il giudice Cocilovo, ritenendosi diffamato da un articolo pubblicato sul quotidiano che allora dirigevo, Libero, mi denunciò per omesso controllo e suoi colleghi pm chiesero per me, con alterne vicende nei vari gradi di giudizio, una condanna alla pena detentiva che alla fine ottennero. Proprio uno di quei magistrati che giudicarono con severità il caso Cocilovo, il dottor Bevere, in quei giorni ormai lontani mi denunciò, sentendosi offeso per un articolo pubblicato dal Giornale all'indomani della mia condanna definitiva. E ora un suo collega pm chiede nuovamente una pesante condanna detentiva, sedici mesi, nei miei confronti. L'articolo di cui si dibatte oggi ricostruiva, attraverso testimonianze dirette e autorevoli (un'ex parlamentare da sempre in prima linea in battaglie in difesa dei diritti civili) una presunta amicizia tra il dottor Cocilovo e il dottor Bevere (cioè tra il denunciante e uno dei giudicanti della prima vicenda) durante la loro permanenza al tribunale di Milano. Nel merito non vedo dove sia l'offesa grave da meritare una così severa richiesta di condanna. Due magistrati sono, se non necessariamente amici come peraltro spesso capita, sicuramente colleghi e come tali si muovono all'interno di rapporti potenzialmente amicali come succede in qualunque categoria professionale. Ma al di là del merito - una lettera di precisazione sarebbe stata probabilmente sufficiente a rimediare un possibile fraintendimento - mi colpisce che a distanza di quasi cinque anni dal mio arresto nessuno ritenga di dovere tenere conto delle motivazioni con cui, dopo circa un mese che ero ai domiciliari, l'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, commutò la mia pena da detentiva in pecuniaria. Come si evince chiaramente dal dispositivo del Quirinale che ha accompagnato la commutazione, quello del presidente non fu un gesto di clemenza né certo di simpatia nei miei confronti. Fu il rimedio - deciso anche nella veste di capo della magistratura - a una pena ritenuta oggettivamente sproporzionata per un reato d'opinione e di omesso controllo. L'appello di Napolitano, sia alla classe politica (per quello che compete alla parte normativa) sia a quella togata (per la parte tecnico-esecutiva), di evitare l'arresto di giornalisti per reati compiuti nell'esercizio della professione se non accompagnati da fatti di comprovata e grave malafede, è rimasto evidentemente inascoltato se è vero, com'è vero, che oggi la pubblica accusa, cioè lo Stato, chiede per me e per un mio bravo collega autore materiale dell'articolo in questione, Luca Fazzo, di nuovo il carcere per diffamazione e omesso controllo. L'omesso controllo, signor presidente, è un reato normato da una legge degli anni Trenta, solo leggermente rivista nel decennio successivo. Parliamo di anni in cui i giornali avevano poche pagine, a volte solo quattro, le redazioni erano composte da pochi giornalisti e la velocità delle notizie era, rispetto a oggi, quella di una lumaca rispetto a una gazzella. Oggi produciamo ogni giorno fino a cento pagine, tra le varie edizioni, e lavoriamo in tempo reale. Un altro mondo. Ma c'è ancora, come in questo caso, chi pretende dal direttore di accertare senza ombra di dubbio non solo la correttezza formale degli articoli, ma anche quella sostanziale, nonostante alcune sentenze della Cassazione sostengano che il direttore ha, sì, il dovere di vigilare sul rispetto dei principi etici generali e sui codici professionali, ma non ha potere investigativo sull'operato dei suoi collaboratori. Qui, in quest'aula, si chiede che io vada in carcere perché un'autorevole ex parlamentare - da noi interpellata all'epoca dei fatti - ha sostenuto una cosa assolutamente credibile e possibile (l'amicizia tra due magistrati). Che cosa avrei potuto controllare signor presidente? Quella parlamentare non solo non aveva mai dato segni di squilibrio né era nota per essere una millantatrice. Niente, signor presidente, anche se quel giorno fossi stato il direttore responsabile del Giornale non avrei potuto evitare, pur usando tutta l'attenzione, la pubblicazione di una notizia poi rivelatasi forse non esatta. Uso il condizionale perché in questa vicenda l'omesso controllo non l'ho compiuto io ma il querelante, il giudice Bevere, e il pm. Cioè due magistrati. Come si fa in un caso (Bevere) a denunciare, nell'altro (il pm) a chiedere il carcere per un omesso controllo quando si omette di controllare chi è il presunto colpevole? Il cui nome, per altro, era stampato in evidenza sul corpo del reato, cioè il giornale del giorno in cui è uscito l'articolo incriminato. E quel nome, signor presidente, non era il mio. Perché tre giorni prima di quella pubblicazione avevo rassegnato le dimissioni da direttore e lasciato l'azienda della quale, il giorno del presunto reato, non ero neppure dipendente. Mi ero dimesso, signor presidente, perché penso che un editore abbia diritto di decidere se tenere a capo del suo giornale un direttore privato della sua libertà. Noi, signor presidente, i nostri omessi controlli li paghiamo duramente e ne traiamo le conseguenze. Mi chiedo se anche i giudici che avviano una causa temeraria e i pm che «omettono controllo» subiscono lo stesso destino, diciamo 14 mesi di arresto e dimissioni, nel caso il loro operato danneggi per negligenza grave un cittadino non solo innocente ma che mai avrebbe potuto essere colpevole e quindi mai indagato, mai rinviato a giudizio, e mai processato con tutte le conseguenze e i costi economici per la comunità. La domanda è capziosa, perché è ovvio che non è così e non sarà così neppure questa volta. Come sostiene il loro capo Piercamillo Davigo, i magistrati non sbagliano mai, per definizione. A questo punto lei, signor presidente, potrà rimproverarmi: perché tutto questo non l'ha detto prima? Giusto. Se le dicessi: volevo vedere fino a dove potesse arrivare la sciatteria giudiziaria le mentirei, e quindi non lo faccio. Potrei dirle che sono frastornato dalle decine di atti giudiziari che invadono le redazioni. Ma la verità è che ho peccato di eccesso di fiducia nella serietà e nell'efficienza della magistratura, dando per scontato ciò che era contenuto nelle carte della procura invece di soffermarmi, cinque anni dopo i fatti - e questo già la dice lunga su tante cose - a riflettere sulla verità dei fatti. Una cambiale di fiducia evidentemente, ancora una volta, mal riposta. Spero che qualcuno, nel sistema giudiziario, mai come in questo caso autoreferenziale, avrà almeno la bontà di riconoscere l'errore, scusarsi e risarcire danni e spese - tanto paghiamo noi - che abbiamo dovuto sostenere per questa ingiusta imputazione. Ho già dato mandato ai miei legali di attivarsi in tal senso. La ringrazio per l'attenzione.
L’ITALIA E LE RIVOLUZIONI A META’.
L'Italia ha sempre nostalgia delle sue rivoluzioni a metà. Dal Risorgimento fino agli "Anni di piombo"» si è coltivato il mito. Danneggiando presente e futuro, scrive Francesco Perfetti, Sabato 18/02/2017, su "Il Giornale". Alle origini, almeno in Italia, ci fu Alfredo Oriani. Proprio lui, il «solitario del Cardello» com'era chiamato, gettò le premesse per una lettura critica della storia italiana che ne sottolineava il carattere di rivoluzione «incompiuta» o «tradita». Nelle sue due opere più famose, La lotta politica in Italia e La rivolta ideale, questo burbero, scontroso, solipsistico intellettuale romagnolo tradusse la propria insoddisfazione per l'esito, a suo parere deludente se non fallimentare, del processo risorgimentale in un sogno profetico: il completamento di quella rivoluzione a opera di una «aristocrazia nuova». Così, senza neppure rendersene conto, Oriani divenne il padre di una «ideologia italiana» che, attraverso manifestazioni diverse, avrebbe attraversato come un mutante tutta la storia italiana del Novecento. A Oriani guardarono, infatti, personaggi di ogni estrazione culturale e politica, di destra e di sinistra, esponenti di una sorta di «sovversivismo intellettuale» germogliato all'insegna del «ribellismo» e dell'illusione nella possibilità di trasformare, grazie all'opera di una «aristocrazia nuova», il mondo reale. Una «cultura politica della rivoluzione», insomma, destinata a diventare il tratto dominante, sia pure sottotraccia, della storia nazionale e che ha finito per bloccare la possibilità di affermarsi di una «cultura politica riformista». Nel suo ultimo e importante saggio dal titolo Ribelli d'Italia. Il sogno della rivoluzione da Mazzini alle Brigate rosse (Marsilio, pagg. 418, euro 19,50) lo storico Paolo Buchignani segue un lungo itinerario, tipicamente italiano, che dal Risorgimento giunge fino ai cosiddetti «anni di piombo» e che si sviluppa, appunto, all'insegna di un progetto culturale e politico rivoluzionario. Osserva Buchignani: «Questa cultura politica si manifesta sia come rivoluzione nazionale che come rivoluzione sociale, si declina a destra e a sinistra, nel fascismo e nell'antifascismo, si colora di rosso o di nero, si evolve in sintonia con i tempi e le circostanze, s'inabissa e riemerge, cambia pelle, accentua un elemento o l'altro a seconda dei casi, delle forze politiche, delle situazioni nelle quali si esprime, ma non si snatura». Questa cultura politica della rivoluzione cui fa riferimento Buchignani è camaleontica e tale suo camaleontismo discende dalla necessità di surrogare, in qualche modo con altre prospettive, i fallimenti ricorrenti dell'illusione rivoluzionaria. Ecco, allora, che entra in gioco la categoria del «tradimento della rivoluzione», anch'essa declinata in varie specificazioni, come terreno di coltura della «ideologia italiana». Ed ecco, ancora, che l'intera vicenda storica dell'Italia unita può essere letta all'insegna di questa categoria interpretativa: il Risorgimento, per esempio, ma anche i governi della Destra storica e della Sinistra storica, per non dire del fascismo, della Resistenza e, nel secondo dopoguerra, dei disegni eversivi della destra extraparlamentare, delle pulsioni operaistiche, della contestazione studentesca, del terrorismo brigatista. Il saggio di Buchignani è un contributo importante e maturo della più recente storiografia contemporaneistica italiana poiché mette bene in luce, con un approccio di tipo culturale, il denominatore comune, rappresentato dal «mito rivoluzionario», di esperienze politiche in apparenza profondamente diverse e contrastanti. Un esempio emblematico: il caso di Benito Mussolini e di Piero Gobetti. Buchignani muovendosi lungo la direttrice già individuata da Augusto Del Noce che ne aveva sottolineato la comune matrice culturale idealistica e in particolare gentiliana spiega il rapporto fra i due, e simbolicamente tra fascismo e antifascismo, ricorrendo sia al «mito rivoluzionario» sia alla categoria del «tradimento della rivoluzione». Entrambi erano convinti che la guerra fosse destinata a sfociare in una rivoluzione e in un rinnovamento radicale, ma poi Mussolini divenne, per Gobetti, il rivoluzionario «traditore», colui che, per giungere al potere e per consolidarvisi, sarebbe stato disposto a scendere a compromesso con le forze tradizionali, a cominciare dal giolittismo. Tuttavia, al di là degli esiti storici, fascismo e antifascismo risultano accomunati da una medesima sostanza intellettuale, l'idealismo di stampo gentiliano, e da una medesima categoria culturale e sociologica, il «mito della rivoluzione» cioè, incrinato dalla pratica del «tradimento» politico. Altri esempi, oltre al «Risorgimento tradito», sono quelli del «fascismo tradito», che diventò un Leitmotiv del fascismo movimento contrapposto al fascismo regime, e della «resistenza tradita». Al «fascismo tradito», in fondo, si collega non soltanto la lotta interna, durante gli anni del regime, tra rivoluzionari e conservatori, ma anche la trasmigrazione, nell'immediato secondo dopoguerra, di molti significativi esponenti della sinistra fascista nelle file comuniste, i cosiddetti «fascisti rossi», in nome del recupero delle genuine istanze rivoluzionarie del primo fascismo. Il mito della «resistenza tradita» fu coltivato, invece, per diversi decenni da quelle forze politiche (e dai loro eredi) che, in qualche misura, muovendosi all'insegna dell'idea dell'«unità della resistenza a guida comunista», avevano sempre sostenuto che la resistenza dovesse essere vista come il fatto rivoluzionario per eccellenza della storia dell'Italia unita e che avrebbe dovuto, quindi, produrre un tipo di società e di sistema politico diverso da quello effettivamente realizzato. Furono alfieri e portabandiera di questo mito della «resistenza tradita» gli azionisti di derivazione gobettiana e rosselliana, i socialisti massimalisti del Nenni frontista, certe frange di un liberalismo progressista, tutti in posizione subordinata ai comunisti, egemoni non soltanto di questo vasto schieramento, ma anche dello scenario politico-culturale del Paese grazie al controllo di molti centri nevralgici di produzione della cultura come giornali, case editrici, università e via dicendo. Questo stesso mito venne poi ripreso largamente dal movimento studentesco, dai gruppi extraparlamentari sessantottini e post-sessantottini e utilizzato proprio, in un singolare contrappasso, contro il partito comunista, accusato di aver tradito la resistenza e lo stesso antifascismo con la rinuncia all'idea della rivoluzione antiborghese e anticapitalista. E non è privo di significato che, sulla linea di una contrapposizione al «mondo moderno», abbia potuto maturare persino l'incontro con gruppi della destra radicale ed eversiva. La verità, come si desume dal bel libro di Buchignani, è che, a destra come a sinistra, il cuore pulsante di quella che è stata definita l'«ideologia italiana» è quella che si potrebbe chiamare la visione giacobina della storia con le sue implicite pulsioni di rinnovamento catartico della società e i suoi sogni di creazione di impossibili paradisi in Terra. Questa visione costituisce l'essenza del «mito rivoluzionario»: un mito che la categoria del «tradimento» rende proteiforme e sempre cangiante. E, purtroppo, pericoloso.
C'ERA UNA VOLTA LA SINISTRA. LA SINISTRA E' MORTA.
Cent’anni dalla rivoluzione d’Ottobre: il vangelo secondo Lenin. Intollerante anche verso i socialisti, il bolscevismo operò come una religione messianica. Le riflessioni di Marcello Flores sul mito sovietico in un saggio edito da Feltrinelli, scrive Sergio Romano il 3 giugno 2017 su "Il Corriere della Sera". Secondo una interpretazione largamente condivisa dalla opinione corrente, il XX secolo, fra il 1917 e la disintegrazione della Unione Sovietica, fu teatro di un lunga guerra fredda tra il comunismo e la democrazia liberale. Dopo la lettura del libro di Marcello Flores sulla rivoluzione russa La forza del mito, edito da Feltrinelli, molti arriveranno alla conclusione che uno dei maggiori conflitti del Novecento fu quello combattuto dai comunisti contro i socialisti europei nelle loro diverse incarnazioni nazionali. Tutta la politica di Lenin, dall’agosto del 1914, fu ispirata da un obiettivo: eliminare la concorrenza socialista, impedire che la causa rivoluzionaria finisse nelle mani dei socialdemocratici o, peggio, di altre forze politiche che, come gli anarchici, avevano creato attese e acceso l’immaginazione popolare. Sciolse l’Assemblea Costituente, eletta dopo gli avvenimenti dell’ottobre 1917, per sbarazzarsi di una istituzione in cui gli «esery» (i socialisti rivoluzionari) e i menscevichi avrebbero avuto un peso determinante. Creò una sorta di Inquisizione (la Ceka, per metà polizia, per metà tribunale rivoluzionario) a cui affidò il compito di eliminare fisicamente tutti coloro, anche a sinistra, che avrebbero cercato di ostacolare il suo disegno. Fondò la Terza Internazionale per imporre regole che avrebbero prescritto ai nuovi partiti comunisti di rompere i loro legami con i socialisti e di obbedire alle direttive di Mosca. La linea di Lenin fu adottata da Stalin in Spagna, nei rapporti con i socialisti e gli anarchici durante la guerra civile, e nei Paesi occupati dall’Armata rossa alla fine della Seconda guerra mondiale. Qui, in particolare, molti socialisti non ebbero sorte diversa da quella di coloro che rappresentavano la borghesia e il mondo contadino. Vi furono temporanee eccezioni quando Stalin si accorse che un «fronte popolare» con i socialisti, in alcuni Paesi, poteva ostacolare l’avanzata dei movimenti fascisti e schiudere ai comunisti la strada del potere. Ma Flores ricorda che la migliore definizione della socialdemocrazia, per l’Urss di Stalin, fu quella di Grigorij Zinoviev, presidente della Terza Internazionale: «Una variante di sinistra del fascismo». Per godere dell’approvazione di Mosca non bastava combattere contro fascismo e nazismo. Occorreva che all’Urss fosse riconosciuto l’esclusivo diritto di guidare la lotta o addirittura, come accadde nell’agosto 1939, di rovesciare la propria politica firmando con Berlino un trattato d’amicizia e un protocollo segreto per la spartizione della Europa centro-orientale. Fra i comunisti, come ricorda Flores, vi furono delusioni e ripensamenti, come quelli di André Gide, Arthur Koestler e Ignazio Silone. Ma questo non impedì che la rivoluzione d’Ottobre e la nascita dell’Unione Sovietica conquistassero gli animi e le menti di un numero incalcolabile di persone, seducessero altri grandi intellettuali, persuadessero milioni di elettori a votare per partiti che trasmettevano ai loro connazionali una immagine ingannevole della «grande patria socialista». Secondo il libro di Flores il mito sovietico deve la sua esistenza agli aspetti più crudi del capitalismo e della rivoluzione industriale, alla grande depressione del 1929, allo straordinario coraggio del popolo russo durante la Seconda guerra mondiale, alla convinzione che gli aspetti peggiori del regime servissero alla costruzione di un sistema nuovo in cui gli errori sarebbero stati corretti e la grande promessa della rivoluzione d’Ottobre sarebbe stata mantenuta. Ma la risposta non può essere soltanto politica o economica. Flores ricorda anche che in un libro del 1920, scritto dopo un viaggio in Russia, un filosofo inglese, Bertrand Russell, vide nel bolscevismo una duplice caratteristica: l’eredità della rivoluzione francese, a cui Lenin e i suoi fedeli facevano continuo riferimento, e un fenomeno simile all’ascesa dell’Islam dopo la profezia e l’insegnamento di Maometto. Nella sua versione leninista, quindi, il comunismo non è soltanto una teoria politico-economica nata dalle tesi di Marx, Engels e altri intellettuali fra l’Ottocento e il Novecento. È anche una fede che ha, come ogni religione, un profeta (Lenin), un ristretto gruppo di apostoli (i compagni della prima ora), il costruttore della Chiesa (Stalin) e una legione di monaci combattenti, pronti al martirio. Come in ogni religione anche nel comunismo il fedele deve accettare pazientemente gli insuccessi, i sacrifici, il martirio e gli errori di percorso. Tutti verranno generosamente ripagati dal compimento delle speranze e dall’avvento di una vita nuova in cui il credente sarà finalmente felice. Se questa lettura del bolscevismo è giusta, dovremo concluderne che il comunismo non fu una ideologia laica e che non furono laici i suoi maggiori esponenti, in Russia e altrove.
Trentin, escono i diari segreti. Critiche ai leader della sinistra: da Luciano Lama a Fausto Bertinotti. «Nella Cgil è in corso una guerra tra bande. Basse manovre da Lama...Quello di Bertinotti è un movimentismo senza obiettivi. Ha una meschina ambizione di protagonismo», scrive Marco Cianca l'8 giugno 2017 su “Il Corriere della Sera”. Il dolore di Bruno Trentin. Inaspettato e sconvolgente. «Avverto un’immensa fatica fisica e intellettuale, affettiva, tanto che mi pare a momenti di dovermi gettare ai margini di un sentiero e di morire, così, per esaurimento, per incapacità di esprimermi, per disamore per la vita e la lotta, e semplicemente perché non ho più voglia di battermi e di farmi capire», scrive a metà agosto del 1992. Sono passati quindici giorni da quel venerdì 31 luglio che ha segnato il momento più tribolato della sua vita da sindacalista. La firma di un’intesa nella quale non credeva, spinto dal timore che il fallimento della trattativa con il governo avrebbe avuto «effetti incalcolabili sulla situazione finanziaria del Paese». Aveva firmato, per «salvare la Cgil», e si era dimesso. «Che cosa sarebbe successo rifiutando l’accordo, con tutte le sue nefandezze? Nel mezzo di una catastrofe finanziaria, a chi sarebbe stata attribuita la svalutazione della lira?», annota. «Un inferno dentro di me», e intorno «tanti opportunismi». «Miseria di Amato», «miseria di Del Turco», «miseria degli altri sindacati», «miseria delle reazioni elettoralistiche di gran parte del Pds». Senso di solitudine, incomprensione, sofferta alterità ma anche gioia di vivere, voglia di scrivere, di leggere, di andare in montagna: questi sentimenti permeano le cinquecento pagine dei diari, dal 1988 al 1994, che l’Ediesse sta mandando in libreria. Riflessioni culturali e politiche si alternano ai giudizi sulle persone e alle notazioni di vita quotidiana, la coltivazione di fiori ad Amelia, le suggestioni alpine a San Candido, le passeggiate, le scalate, i tanti, tantissimi libri, i viaggi, l’amore per Marcelle Padovani, chiamata affettuosamente Marie. È lei a spiegare che la decisione di pubblicare i diari non è stata facile, «testi nudi e crudi, molto passionali ed unilaterali» ma che servono a «far capire meglio la figura, la personalità e l’importanza di Trentin». Iginio Ariemma, che da tempo svolge un intenso lavoro di scoperta e divulgazione di testi che riguardano l’ex segretario della Cgil, ha curato questa sorprendente pubblicazione. Sette anni che sconvolsero l’Italia e il mondo (la caduta del muro di Berlino, il disfacimento dei regimi comunisti, il cambio di nome del Pci, Tangentopoli, i bagliori di guerra in Kuwait e Iraq, la caduta di Craxi, l’ascesa di Berlusconi) visti con occhi attenti, impietosi e anche profetici. Nato in Francia nel 1926, figlio di Silvio, professore universitario che aveva scelto di andare in esilio per non sottostare al fascismo, uno dei fondatori di Giustizia e Libertà, Bruno fu subito ribelle. Il padre organizzava la resistenza ma avrebbe voluto che il figlio continuasse gli studi. Lui s’incise sulla coscia destra una croce di Lorena come omaggio al generale De Gaulle e a France Libre, formò una piccola banda e fu arrestato dalla polizia francese passando in guardina il sedicesimo compleanno così come il diciassettesimo lo trascorse in una cella italiana, dopo il ritorno in Patria con la famiglia nel ’43. La guerra partigiana, il Partito d’Azione, la laurea, l’ufficio studi della Cgil chiamato da Vittorio Foa, nel ’50 l’iscrizione al Pci, i metalmeccanici, l’autunno caldo, i vertici della confederazione. E poi segretario generale, dall’88 al ’94, appunto. Eccolo Bruno Trentin, crogiuolo d’idee, di rigore, di sensibilità e di esperienze, un eretico della sinistra, un libertario in mezzo a una folla di «ometti». È indicativa una frase su Robespierre: «Lo sento lontano culturalmente e anche psicologicamente e nello stesso tempo vicino umanamente quando lo riscopro così solo, così tormentato, così coerente (e incerto) nella sua ansia di vivere in accordo con la sua morale e le sue speranze». E Trentin, con una ghigliottina etica, politica e umana taglia tante teste. Giudizi sprezzanti, definizioni impietose, conclamata estraneità. Un elenco che farà sobbalzare. Guido Carli, Ciriaco De Mita, Bettino Craxi, Giuliano Amato, Paolo Cirino Pomicino, Napoleone Colajanni, Gianni De Michelis, Lucio Colletti, i dirigenti della Confindustria, Pierre Carniti, Franco Marini, Sergio D’Antoni, Giuliano Cazzola. Disprezzo per gli «intellettuali a pagamento» e «i vecchi saccenti senza vergogna e senza il minimo residuo di morale politica ed intellettuale». A proposito della Cgil: «Guerra per bande», «basse manovre di Lama e compagni prima dell’ultimo congresso», «tragico tramonto», «metastasi inestricabile», «miserabile scenario». Quando nell’88 parte la contestazione ad Antonio Pizzinato, evidenzia «un attacco torbido e cinico» ma rimarca «una reazione debole, patetica e astiosa» da parte dell’allora segretario. La voglia di fuga: «Ho maturato la mia intenzione di lasciare, non posso assistere a questo scempio e continuare a fare il mediatore e l’anima bella». Ma poi è lui a essere designato e «comincia la nuova storia della mia piccola vita». Si sente circondato: «tristi figuri», «satrapi», «ceto burocratico di intermediazione», «avventurieri da strapazzo». Riaffiora, carsica, «la voglia tremenda di mollare tutto» e il desiderio di gridare: «Non sono uno di questi». Nel partito vede «anime morte che si incrociano senza comunicare». La decisione annunciata da Occhetto di cambiare il nome del Pci è ammantata di «improvvisazione e povertà culturale». Alle critiche, «il segretario reagisce con la ciclotimia di sempre alternando depressione e psicosi del tradimento con minacce e tentativi di prepotenza». Più avanti gli attribuirà «un affanno camaleontico». D’Alema «appare più lucido ed equilibrato di altri» ma «i progetti non lo interessano se non sono la giustificazione di un agire politico», «ricorda in caricatura il personaggio di Elikon nel Caligola di Camus». Nel ’94, senza accennare al duello tra lo stesso D’Alema e Walter Veltroni, guarda con tormentato distacco «alla penosa vicenda e al modo isterico, personalistico e selvaggio con il quale si è svolto il ricambio nella segreteria, con il patetico ma irresponsabile comportamento di Occhetto». E l’altra sinistra? «Un’armata Brancaleone piena di cinismo e di vittimismo». A Bertinotti affibbia prima «un movimentismo senza obiettivi, disperatamente parolaio», poi «una meschina ambizione di protagonismo a qualsiasi costo», disceso nel «suo personale inferno di degradazione morale», «triste guitto», «ospite giulivo del Maurizio Costanzo show». A proposito di Rossana Rossanda annota «una risposta delirante e ignorante» e «penosi balbettii indignati». Parole di fuoco contro «i giovani rottami» del manifesto, «estremisti estetizzanti». A tutto questo variegato mondo «tra delirio estremista, gioco mondano e la lirica dannunziana» muove l’accusa di «disonestà intellettuale» e di «narcisismo laido e egocentrismo scatenato». Doloroso il rapporto con Pietro Ingrao, con «la retorica della pace e del catastrofismo cosmico», con «il suo rifugio in una sorta di profetismo didascalico che lo porta a rimuovere ogni vero confronto con il presente». Un’incomprensione che lo farà piangere. Nausea e disperazione. Denuncia «il machiavellismo volgare», «le ideologie rinsecchite» che diventano «gli orpelli delle più spregiudicate avventure personali e delle più invereconde forme di lotta politica», «le idee come grimaldelli» per la conquista del potere, «schieramenti senza programma». Malinconia, senso di stanchezza e di precarietà: «È come se gridassi e non uscisse un suono». Ma anche amicizie, affinità elettive e parole di elogio per figure, ad esempio, come Ciampi e Baffi, o per il sindacalista Eraldo Crea. E nel tormento dell’incomunicabilità e della diversità, a prevalere è il desiderio di elaborare un progetto, di indicare una via d’uscita. Superare il determinismo marxista e ripartire dalla rivoluzione francese «che non è ancora conclusa», dalla battaglia per i diritti, dalla società civile, da forme di autogoverno, dalla dignità e creatività del lavoro. Rifiuto di ogni statolatria e di soluzioni calate dall’alto, comprese tutte le strategie redistributive della sinistra che non vanno al nocciolo del problema e diventano l’alibi per governare. Contro la civiltà manageriale bisogna battersi per la socializzazione dei saperi e dei poteri. «Trasformare, qui ed ora, questo mondo nel quale viviamo e combattiamo». L’utopia del quotidiano, la chiama. La matrice è quella azionista ma la dicotomia tra giustizia e libertà, l’ircocervo di Benedetto Croce, Trentin la scioglie senza esitazione: la libertà viene prima. Nei diari c’è in incubazione «La città del lavoro». È morto il 23 agosto 2007. I conti con la sua eredità intellettuale sono ancora tutti da fare.
La sinistra ora lancia accuse di assistenzialismo. Da che pulpito viene la predica! Scrive Alessandro Catto il 29 maggio 2017 su "Il Giornale". Dopo l’uscita di Papa Francesco a favore del lavoro e contro il reddito di cittadinanza (questione eminentemente teologica, ndr) non sono mancati gli elogi da parte del mondo democratico e il continuo attacco, da parte di molti ambienti di centrosinistra, alla proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle. Quest’ultima, nonché le presunte coperture volte a renderla possibile, sono certamente da prendere con le pinze. Una idea che in ultima istanza appare di difficile applicazione in un paese, l’Italia, che col deficit non ha un buon rapporto e che rischierebbe con ogni probabilità di non potersela permettere. Tutt’altro valore invece hanno le resistenze morali, o presunte tali, verso la misura. In primis perché è veramente giunta l’ora di aprire un dibattito serio sul rapporto tra avanzamento della tecnologia e riduzione dei posti di lavoro, inerente soprattutto il concetto di occupazione per come siamo stati abituati ad intenderlo, valutando se davvero il rischio sia presente o se è tutto frutto di sensazionalismo, pure slegandoci da un certo feticismo per il lavoro in salsa novecentesca che poco ha a che fare con un progresso degno di questo nome. Ha davvero senso, nel 2017, parlare di lavoro come se ne parlava cinquant’anni fa? Risulta davvero così stupido chiedersi se la globalizzazione, la modernizzazione e la tecnologia non impongano, laddove la loro presenza è più forte, una discussione sulle prospettive del lavoro salariato, specialmente nelle posizioni più umili? E in tutto questo, è davvero così fuori dal mondo provare a valutare assieme una proposta, quella del reddito di cittadinanza, che oltretutto potrebbe permettere di spezzare molte situazioni di ricatto che si creano quando si è costretti ad accettare un lavoro a qualsiasi condizione pur di portare a casa qualcosa? Non sono certo un elettore pentastellato, ma mi sembra quantomeno sospetta questa repulsione a priori verso il tema, specialmente quando fatta da sinistra. Già, perché in tutto questo notiamo critiche urbi et orbi da parte di una porzione politica che ha il coraggio di lamentare il presunto assistenzialismo insito nella norma, quando per anni ci ha abituati a veder sciorinare il peggior assistenzialismo su misura. I fedelissimi che lavorano nello Stato senza che spesso ce ne sia alcun bisogno, le persone “sistemate” in qualche ministero, le assunzioni ad cazzum nella ricerca, il finanziamento di corsi prettamente inutili, gli sprechi, i burocratifici difesi a spada tratta dal sindacato del non-lavoro, le associazioni e associazioncine parastatali spesso finanziate da chi oggi si batte contro questa proposta, non hanno forse l’odore di un assistenzialismo ancora peggiore, perché mascherato da lavoro e capace oltretutto di appesantire ancor più il funzionamento del paese? Non è ridicolo sentir parlare di ciò una porzione politica che per decenni ha fatto del peggior assistenzialismo uno dei propri tratti di riconoscibilità, che dietro ad un distorto concetto di statalismo, divenuto spesso improduttivismo statale e culto della burocrazia, oggi si riscopre rappresentante del lavoro duro, vero, utile e retribuito? Non fa rabbia vedere un sindacato e pure un papato che tacciono spesso e volentieri sulle storture di una immigrazione completamente deregolamentata, esporsi oggi contro chi cerca di rimediare al danno della concorrenza al ribasso causata proprio dai tanti silenzi avuti in decenni di battaglie pressoché inutili o molto, molto comode da condurre, spesso più politiche che lavorative o spirituali? Non fa rabbia questo totale scollamento dalla realtà fatto da pulpiti improbabili? Io lo trovo un cortocircuito pazzesco e dai tratti ridicoli. Nel tutto critiche alla proposta ce ne possono essere a bizzeffe. Ma le eviti chi sull’assistenzialismo ha costruito il proprio bacino elettorale per decenni.
Sinistra, riparti dai diritti. Non dal lavoro, scrive Piero Sansonetti il 10 Marzo 2017 su "Il Dubbio". Il movimento operaio non c’è più, è sucida ignorarlo. L’ideale non è il lavoro, il lavoro è un mezzo. L’ideale è la giustizia sociale…Il nuovo partito della sinistra, nato dalla scissione del Pd (quello di D’Alema, Speranza e Rossi, per capirci) si chiama “Articolo 1”, e il riferimento è al primo articolo della Costituzione, cioè al lavoro. Il Pd dal quale si è scisso il nuovo partito, a sua volta, propone con Renzi il “lavoro di cittadinanza”, contrapponendolo al reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. E sul lavoro, sull’idea del lavoro come valore supremo, insistono naturalmente i sindacati, la Camusso, Landini, la Fiom. Sono solo parole, chiaro, ma in politica le parole contano molto. Tutta la sinistra italiana si ritrova su questa parola e solo su questa parola: il lavoro. Più o meno da 130 anni. Il motivo è evidente. La sinistra, non solo in Italia, è comunque figlia del movimento operaio. Sinistra, riparti dai diritti non dalla retorica del lavoro. E cioè di quel possente movimento politico, ricchissimo di articolazioni, che si fondava sull’enorme forza sociale e morale della classe operaia novecentesca per condurre epiche battaglie riformiste e egualitarie. Il problema è che oggi, se lo cercate, il movimento operaio non lo trovate più. È scomparso. È scomparso almeno vent’anni fa. E la stessa classe operaia, che ne costituiva il nerbo e la linfa, non esiste più in quanto “classe”, nei termini nei quali il significato profondo della parola “classe” era stato definito dal pensiero marxista e dalla parte più moderna e lucida della sociologia. Non esiste più, probabilmente, per una ragione che non ha a che fare soltanto con la fine delle ideologie e con il crollo del comunismo, che si era preso (o arrogato) il ruolo di interprete principale delle lotte operaie. Per una ragione legata all’imprevisto sviluppo della società e dell’economia determinato dalla forza cataclismatica delle tecnologie. L’indistruttibilità del movimento operaio – nel corso del secolo feroce e a volte reazionario che è stato il novecento – è dipesa interamente da quello strumento formidabile che maneggiava: il lavoro, e cioè l’elemento insostituibile del progresso e della produzione di ricchezza. Non ci vuole un novello Carlo Marx per intuire che quello strumento si è inceppato, forse si è spento. Non è più il capitale o l’impresa ad avere bisogno vitale di nuovo lavoro ma sono i lavoratori ad avere bisogno vitale dell’impresa. Il lavoro ha un peso sempre meno rilevante nel processo produttivo. I rapporti di forza – sul terreno della produzione – si sono spostati in modo clamorosamente massiccio e irreversibile. E si sposteranno ulteriormente. Il lavoro era la grande forza della sinistra ma non era il suo ideale ultimo. L’ideale della sinistra è sempre stata l’uguaglianza, o almeno l’equità, o la giustizia sociale. Il lavoro era un mezzo politico, un connotato di classe. In questi anni abbiamo assistito ad un corto circuito: la sinistra ha ceduto moltissimo terreno sul piano delle lotte per l’uguaglianza e ha mantenuto acceso, invece, il “lumicino” del lavoro. Sono convinto che da questo cortocircuito è nata non solo la crisi della sinistra – e non solo in Italia – ma anche lo sbandamento di tutta l’asse della lotta politica. La destra e la sinistra hanno finito per assomigliarsi sempre di più. Lo scontro tra loro è diventato uno scontro esclusivamente di ceto politico, non più di idee o di grandi interessi di massa. E in questo modo hanno preso il sopravvento i nuovi “signori”, che non c’entrano più con la politica tradizionale: i populismi, il mercato, il giustizialismo. La loro ideologia dilaga, sembra impossibile fermarla. Contesta il ceto politico in quanto ceto politico e contestandolo delegittima la politica. E ne prende il posto. E il potere. E l’idealità. E la capacità di attrarre e organizzare il consenso.
C’è un solo grande valore che può opporsi a questa deriva. È il valore del diritto e dei diritti. È pura illusione immaginare una ripresa della giustizia sociale attraverso il conflitto sociale. Così come è fantasia credere che la libertà possa affidarsi, mani e piedi legati, al mercato. La giustizia sociale, e la libertà, possono crescere solo se il Diritto riesce a imporre la sua superiorità rispetto ai valori del mercato e al populismo. Altrimenti sono destinate a diventare un aspetto del tutto residuale della modernità. Questa è la grande partita politica che è aperta, proprio qui in Italia, qui in Europa: tra una modernità concepita come “Stato di Diritto” e modernità intesa come “Stato del Mercato e della Pena”. Ma perché questa battaglia si svolga ad armi pari bisogna che la politica torni in campo. Possibile che la politica sia così cieca da non capire che gli stessi grandi ideali del passato (quelli liberali, quelli socialisti) oggi hanno un futuro solo se si ritrovano insieme a difendere il campo del Diritto? Dov’è l’uguaglianza senza il Diritto? Dov’è la liberà senza il Diritto?
E però appare chiaro che la politica da sola non ce la fa. Balbetta, spesso trema, fugge, tenta di blandire il populismo.
La politica ha bisogno di nuovi alleati, e può trovarli solo nella società, in nuove aggregazioni che mettano insieme ideali e interessi collettivi della modernità. Le professioni, i nuovi “corpi intermedi”. Che devono uscire però dalla antica subalternità: non proporsi più alla politica come “clienti”, o come “strumenti” di consenso. Ma come protagonisti, portatori di una idea di modernità che è loro propria e che pretendono, dalla politica, che diventi “strategia”.
Pd caos iscrizioni a Napoli: "Portate la tessera, i 10 euro ve li danno loro". 1 marzo 2017 video di Anna Laura De Rosa e Alessio Gemma su Rep/Tv. “Dovete portare tessera e codice fiscale, i 10 euro ve li danno stesso loro”. Sigaretta in bocca, occhiali e capelli bruni: la donna spiega come ci si iscrive al partito democratico a Napoli. Scene dal tesseramento a Miano, quartiere popolare dell’area nord. Piazza Regina Elena, a due passi dagli uffici del Comune. È l’ultimo giorno utile per strappare l’adesione al Pd in vista del congresso nazionale, più di un centinaio di persone fanno la spola dalle 17 fuori alla sede di un’associazione. I dieci euro sono la quota che il partito per rinnovare l’iscrizione. “Ve le da Michel dentro, se la vede lui”, aggiunge l’amica. Dietro alla scrivania, in una stanza piena di persone, fa capolino Michel Di Prisco, ex vicepresidente della Municipalità. Un capobastone noto tra le file del Pd, al centro delle primarie dello scandalo del 2011.
"10 euro per la tessera del Pd". Un nuovo scandalo travolge i dem. A Miano, quartiere popolare nel Napoletano, scoppia il caso delle tessere comprate. "I 10 euro ve li darà Michel all'interno", scrive Sergio Rame, Mercoledì 1/03/2017, su "Il Giornale". "10 euro e la tessera del Pd è comprata". Il video di Repubblica, girato con telecamera nascosta a Miano, quartiere popolare dell'area nord di Napoli, è una bomba che deflagra in un partito già fiaccato dagli scandali giudiziari e dalle divisioni interne. Nell'ultimo giorno utile per il tesseramento al Partito democratico si vedono chiaramente scene di compravendita delle tessere. "Solo la carta d'identità - dice una voce fuoricampo nel video di Repubblica - i dieci euro ve li danno loro". Una signora dà le indicazioni ai "militanti" del Pd per iscriversi e rinnovare la tessera del Partito democratico in vista del congresso nazionale dove Matteo Renzi, Michele Emiliano e Andrea Orlando si sfideranno per prendere la leadership del partito. In piazza Regina Elena, in un quartiere popolare ad alta densità di camorra, più di un centinaio di persone fanno la spola all'esterno della sede di un'associazione. C'è un via vai di persone. E di soldi. 10 euro è la quota che il Pd chiede per rinnovare l'iscrizione. "I dieci euro - spiega la signora nel video di Repubblica - ve li darà Michel all'interno. Se la vede lui". Michel è Michel Di Prisco, l'ex vicepresidente della Municipalità finito al centro dello scandalo delle primarie del 2011 per il Comune. "Entrate - dice ancora la signore - stanno dando 10 euro a persona. Non li cacciamo noi, non ci vanno in tasca. Vanno al partito". Tra gli organizzatori di questo sistema clientelare c'è anche un certo "don Gennaro". A lui spetta il compito di coordinare le operazione di tesseramento per "il partito di Michel, il nostro consigliere di quartiere". Dopo il caos scoppiato nel capoluogo campano, il Pd è corso ai ripari inviando Emanuele Fiano a Napoli in qualità di "osservatore". Dovrà vigilare sul tesseramento. "Nelle situazioni denunciate e circoscritte - spiegano fonti del Nazareno - si congela il tesseramento o lo si annulla se palesemente non in linea con le regole". Le regole del Pd prevedono che le verifiche siano fatte sul tesseramento, provincia per provincia. E il tesseramento è valido solo quando viene certificato dalle commissioni per il congresso. Graziella Pagano ex senatrice ed europarlamentare, è stata scelta dal segretario regionale campano, Assunta Tartaglione, per monitorare su Miano. "Gli episodi riportati dalla stampa sono di una gravità estrema - ha commentato la Tartaglione - inficiano il regolare svolgimento del tesseramento e ledono pesantemente l'immagine del partito".
Scandalo tessere comprate Pd nel caos verso le primarie. A Napoli iscrizioni pagate 10 euro. Orfini: espelleremo i responsabili. Presto aperto un fascicolo in Procura, scrive Pier Francesco Borgia, Giovedì 2/03/2017, su "Il Giornale". Scoppia il caso del tesseramento fittizio nel Pd campano. Tra Napoli e Castellammare, due casi che mostrano chiaramente come non tutte le regole sono state osservate. Sul sito di Repubblica è apparso un video in cui si vede una donna convincere alcune persone ad andare a rinnovare la tessera senza preoccuparsi per i soldi necessari («Dovete portare tessera e codice fiscali, i 10 euro ve li danno loro»). A Castellammare, invece, gli stessi responsabili del partito si sono accorti che qualcuno aveva pagato il rinnovo di 16 tessere con una sola carta di credito. A un anno dalle primarie dello scandalo (a Napoli per scegliere il candidato sindaco), torna di stretta attualità l'allegra gestione del partito. Il presidente «reggente» Matteo Orfini ha già inviato nel capoluogo campano un suo rappresentante (Emanuele Fiano) per verificare i fatti. E mentre «l'inviato» del Pd annuncia che segnalerà tutto ai magistrati, dalla procura trapela che è già stata aperta un'inchiesta. Orfini poi avanza una preoccupazione ulteriore: potrebbero esserci altri casi come quello emerso al circolo Pd del quartiere napoletano di Miano. «Se queste cose sono emerse - spiega Orfini - è proprio perché il nostro meccanismo di controllo funziona». Un osservatore verrà mandato anche dal Pd regionale diretto da Assunta Tartaglione. Si tratta di Graziella Pagano, ex senatrice ed europarlamentare. Alla fine dell'indagine interna il tesseramento verrà poi certificato dalle commissioni istituite per preparare il congresso. D'altronde i casi sono tanti. Non c'è solo Miano o Castellammare. A Bagnoli, per esempio, hanno annullato il tesseramento dopo che si era passati dalle 200 tessere del 2016 alle 500 di quest'anno. Problemi analoghi e analoghi sospetti anche a Pompei e a Torre del Greco, cui si aggiungono i quartieri di Pianura e Pendino. La Pagano, insomma, lavorerà fianco a fianco con l'uomo di Orfini. «Ben venga - commenta la Tartaglione - la decisione del partito di inviare un dirigente nazionale per verificare la regolarità del tesseramento a Napoli. Su questa come su tutte le altre possibili anomalie saremo inflessibili». Lo spettacolo che si ricava dal video pubblicato sul sito di Repubblica è tutt'altro che edificante, commenta Orfini. Che ora pensa anche all'ipotesi espulsione per i responsabili di tesseramenti non in linea con quanto previsto dal regolamento. «Io stesso ho cacciato persone a Roma», ricorda per poi avvertire che l'organizzazione del congresso non subisce alcun condizionamento. «Non ci sarà nessuno slittamento», rassicura. E l'indagine interna potrebbe allargarsi fuori regione. Come si augura, per esempio, la europarlamentare Pina Picierno. «Si leggono cose anche da altre realtà che destano preoccupazione - spiega la Picierno, originaria del casertano -. A impensierirmi sono le notizie che arrivano dalla Puglia, ad esempio. Dobbiamo essere seri e rigorosi». Il pasticciaccio napoletano offre, comunque, un assist ghiotto ad Andrea Orlando, candidato con Michele Emiliano a contendere la poltrona di segretario del Pd a Matteo Renzi. «Il discorso della rottamazione delle classi dirigenti evidentemente non si è realizzata - constata amaro Orlando -. Sono sempre gli stessi che gestiscono il partito». E pure uno «scissionista» come l'europarlamentare Massimo Paolucci, confluito in Democratici e progressisti, vede nel caos del tesseramento un segno inequivocabile: «Le clamorose schifezze che, ancora una volta, emergono a Napoli confermano che non ci sono le condizioni per continuare la nostra battaglia dentro il Pd».
Pd, tessere gratis a Napoli, Orlando: "L'avevo detto". Orfini: "Casi isolati, prenderemo provvedimenti". Il ministro della Giustizia e candidato alle primarie: "Organizzazione precaria, temo che si possa avere stessa situazione anche in altre realtà". Resi noti i dati ufficiali sugli iscritti: nel 2016 sono 405mila, scrive l'1 marzo 2017 "La Repubblica". I conteggi ufficiali, trapelati in serata, dicono che gli iscritti al Pd nel 2016 sono 405.041: è questo, secondo quanto riferisce il vicesegretario Lorenzo Guerini, il risultato dopo le comunicazioni delle federazioni regionali, in attesa delle verifiche e delle certificazioni delle Commissioni territoriali per il congresso e "al netto del tesseramento dei Giovani democratici che ha modi e tempi autonomi". Un dato che arriva nel pieno della bufera sul caso delle tessere del Pd gratis a Napoli. Nel 2014 gli iscritti erano 378.669, mentre nel 2015 sono stati 395.574. Ma restano le perplessità legate al caso partenopeo. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, candidato alle primarie dem, ricorda di aver messo in guardia sulla possibilità che si verificasse un problema del genere. "Avevo messo in evidenza il rischio che in una situazione organizzativa abbastanza precaria si potesse produrre questo tipo di effetti, e si stanno producendo" e "temo che questo rischio si manifesti anche in altre realtà. Apprezzo il fatto che si sia intervenuti tempestivamente e mi auguro che si continui così. Mi fido di chi oggi è chiamato a gestire questo passaggio così delicato" ha aggiunto. Su Facebook il presidente del Pd Matteo Orfini annuncia provvedimenti immediati: "Ieri si è chiuso il tesseramento del Pd. Purtroppo ci vengono segnalati anche casi - per fortuna isolati - di gestione poco trasparente. Il nostro congresso deve essere una grande festa democratica e non possiamo consentire che venga rovinato da comportamenti discutibili. Ovunque verranno segnalate anomalie provvederò a inviare commissari per il tesseramento e chiederò alla commissione di accompagnare il percorso congressuale per scongiurare ogni rischio. Per questo già nelle prossime ore assumerò i primi provvedimenti sui casi segnalati". Infatti a Napoli è già stato inviato Emanuele Fiano come un commissario per esaminare le irregolarità sui tesseramenti.
Pd, c'è anche un caso Puglia: boom di tessere, l'eurodeputata Picierno invoca verifiche. Nella regione di Michele Emiliano, secondo le prime proiezioni sono state registrate 33mila 500 tessere, in aumento rispetto allo scorso anno (quando si contarono 27mila iscrizioni), scrive Antonello Cassano il 2 marzo 2017, su "La Repubblica". Tesseramento chiuso, ma polemiche e colpi bassi sempre più pesanti tra le varie correnti di partito. A punto che dopo il 'caso Napoli' ora infuria anche un 'caso Puglia'. La campagna per le iscrizioni al Pd in regione, terminata il 28 febbraio, ha fatto un balzo in avanti nelle ultime 48 ore. In Puglia secondo le prime proiezioni sono state registrate 33mila 500 tessere, in aumento rispetto allo scorso anno (quando si contarono 27mila iscrizioni). Numeri in aumento a Bari città, dove si superano i 3mila tesserati, mentre a Foggia città si toccano le 1.300 tessere. Circa 3.500 i tesserati sia nella provincia di Brindisi sia in quella di Taranto. A Lecce città sono 1.700 le iscrizioni. Grandi numeri nella Bat, dove si registrano 6mila tesseramenti. In particolare a Barletta si registrano 1.700 tesseramenti (ma erano 3.500 lo scorso anno), di cui 700 tessere cartacee e circa 1.000 iscrizioni online. Ma nel giorno in cui il governatore Michele Emiliano (candidato alle primarie per la segreteria contro Matteo Renzi, Andrea Orlando e Carlotta Salerno) nel corso di una visita lampo nella sede del consiglio regionale della Toscana definisce il tesseramento "una prova muscolar-finanziaria che non funziona", in Puglia si susseguono gli scambi di accuse tra i renziani e i seguaci del governatore. E così dopo i casi segnalati nei giorni scorsi di circoli chiusi anzitempo e di tessere fotocopiate, le polemiche infuriano sull'alto numero di iscrizioni online. "Mille tessere online? In una sola città della Bat? Ditemi che è una bufala", esclama su Facebook il renziano Fabrizio Ferrante. A rincarare la dose ci pensano prima l'eurodeputata campana Pina Picierno, che chiede "verifiche in Puglia", e poi l'eurodeputata cerignolana Elena Gentile che denuncia: "A San Severo negli ultimi minuti prima della chiusura del tesseramento si sono presentati 150 immigrati irregolari che hanno chiesto di tesserarsi - accusa la renziana - Fossi il responsabile del tesseramento regionale comincerei a preoccuparmi". La risposta di Ruggiero Mennea, deputato al controllo delle tessere, non tarda ad arrivare: "Si tratta di 11 migranti spostati dal campo di Rignano a San Severo, polemica inutile. La mia amica Elena Gentile - afferma il consigliere, che durante una telefonata con il vicesegretario nazionale del Pd, Lorenzo Guerini, ha parlato di un corretto andamento delle procedure di tesseramento in Puglia - può stare tranquilla". Nel frattempo il Pd pugliese dà l'immagine di un partito balcanizzato e non a caso dall'altro fronte, quello pro Emiliano, c'è chi fa notare che proprio a Cerignola, nella terra di Elena Gentile, sia partito un esposto "perché nell'ultimo giorno disponibile per il tesseramento molta gente non avrebbe avuto la possibilità di iscriversi". Balcanizzazione in pieno corso anche a Lecce. Qui è la componente della segreteria regionale, Alessandra Giammarruto, che in un documento inviato al Nazareno e pubblicato dall'Huffington Post chiede la sospensione e il commissariamento dei poteri del segretario provinciale leccese Salvatore Piconese, dato nei giorni scorsi vicino agli scissionisti fuoriusciti dal Pd e al movimento 'Consenso' organizzato da Massimo D'Alema: "Le tessere - accusa Giammaruto - nella maggior parte dei circoli non sono state neppure consegnate. Diversi segretari hanno manifestato volontà di lasciare il partito e a Lecce città non è stato istituito alcun ufficio adesioni". Accuse che non piacciono per niente al segretario regionale dem Marco Lacarra: "Dichiarazioni prive di fondamento. Il segretario provinciale del Pd di Lecce ha comunicato la sua permanenza nel partito, prendendo le distanze dalla scelta di alcuni dirigenti scissionisti. Il tesseramento in Puglia è stato gestito nella massima trasparenza, anche a Lecce". La resa dei conti fra le correnti del partito è destinata a proseguire.
Quella nebulosa chiamata sinistra, scrive Concita De Gregorio il 18 febbraio 2017 su “La Repubblica”. E’ con sgomento, incredulità e malinconico divertimento che annoto di giorno in giorno su uno speciale taccuino le nuove iniziative (pre-elettorali? Precongressuali? Psichiche?) della galassia semigassosa nata dalla trasformazione della materia di quello che nel secolo scorso è stato il centrosinistra, con o senza trattino, non saprei più dire. Come in un esperimento nel laboratorio di chimica alle medie, si rintracciano anche particelle solide della sostanza originaria. L’ultima è di ieri, o dell’altro ieri, perdo il conto: Rivoluzione socialista indetta dai socialisti democratici di Michele Emiliano. Subito prima Campo Progressista di Pisapia che seguiva ConSenso di D’Alema, il quale certamente non dialoga con Dema di De Magistris, area Ada Colau e Varoufakis. Non lontano da Dema si collocava un tentativo in apparenza oggi disperso, ma forse solo silente, la Coalizione sociale di Michele de Palma per Maurizio Landini, Fiom. Sigla ormai arcaica, quest’ultima, che tuttavia resiste insieme a Rifondazione comunista di Paolo Ferrero, prossimamente a congresso. Un tributo si deve all’antesignana Possibile di Pippo Civati, attenzione merita il laboratorio Milano In di Cristina Tajani, ex Sel come tutti quelli ora in SI, in queste ore riuniti a Rimini. Al congresso di SI partecipa il solo segretario Nicola Fratoianni, non Arturo Scotto che un attimo prima delle assise ha ritirato la candidatura alla segretaria per passare con Pisapia. Mentre Rifare l’Italia ha portato Orfini ai vertici del Pd di Renzi, sulla faglia alla sua immediata destra si attendono le mosse del molto attivo Andrea Orlando, per ora senza sigla ma forse in contatto col lavoro sottotraccia di Franceschini e Serracchiani i quali pare abbiano l’obiettivo di “tenere unito” il Pd: bisogna solo capire unito sotto la guida di chi. A soffiare polvere magica sull’esperimento di trasformazione della materia contribuiscono figure ubique come Massimiliano Smeriglio, ex destra Sel, vicepresidente della Regione Lazio detto il re della Garbatella che ha partecipato negli stessi giorni alla campagna di tesseramento di SI in area Scotto, era al fianco di D’Alema al lancio di ConSenso, con Pisapia a Milano al lancio di Campo Progressista e con Emiliano in Rivoluzione socialista. Scrivo queste desolate righe in risposta a due lettori: Ugo Stalio, 76 anni (“Possibile che gli unici accordi siano su quanti seggi toccheranno in Parlamento? Che il loro calcolo sia quello?”) e Silvio Fossi, 86. Generazione che ha fatto l’Italia, pazienza se vi sembra retorico: leggete la lettera di Silvio da moschettiere del Duce a osservatore del M5S passando per sessant’anni a sinistra, oggi iscritto al Pd, e capirete. Parla di “soffio di fascismo tecnologico”: non tornerà col manganello, dice, ma dai mezzi di comunicazione. Parla di Trump, dice che ha seguito la diretta dell’assemblea Pd del 13 febbraio, domanda se “la sinistra non capisca la gravità delle conseguenze di una scissione, delle quali dovrebbe rendere conto a tutti gli italiani”. Il soggetto di questa frase tuttavia - “sinistra” - è composta attualmente dalla nebulosa qui descritta per sommi capi e certo con difetto di distinguo. In politica, come in tutto il resto nella vita, peggio che non capire c’è solo capire troppo tardi.
Un'assemblea senza anima avvicina la scissione del Pd. Nella riunione di sette ore parlano tutti i leader, renziani e di minoranza, Ma le parole più importanti arrivano alla fine, a telecamere spente, con Emiliano, Speranza e Rossi che accusano Renzi di "aver scelto la strada della scissione". Da oggi il M5S è il primo partito del Paese. I democratici sono ormai bruciati, scrive Marco Damilano il 19 febbraio 2017 su "L'Espresso". La svolta arriva alla fine, quando l'assemblea del Pd è ormai terminata da più di un'ora. Via i delegati, i curiosi, i contestatori, le telecamere, le guardie rosse, ecco la nota dei tre tenori, Michele Emiliano, Enrico Rossi e Roberto Speranza alle sette di sera, in tempo per i tg, con la parola esorcizzata, invocata, temuta, carezzata per tutta la giornata: «Renzi ha scelto la strada della scissione», scrivono i tre. E questa volta, a quanto pare, è davvero finita. Tra accuse reciproche: decisione già presa, avanspettacolo. L'annuncio dell'addio arriva dopo un'assemblea di sette ore, all'hotel Parco dei Principi immerso nei Parioli, tra stucchi dorati, lampadari, finti busti neo-classici. Di fronte ai recinti del bioparco si alterna al microfono il bestiario del partito che governa il Paese: i falchi, le colombe, le volpi, i leoni, le faine, i serpenti, le iene e le belle gioie. Il dolore, più volte tirato in ballo, i sentimenti e i risentimenti, le trappole, i trabocchetti. La sottosegretaria Maria Elena Boschi, silente e a lungo inquadrata dalla regia. Le convergenze parallele: attribuite da sempre al pugliese Aldo Moro per il centro-sinistra (ma lui, in realtà, non pronunciò mai questa frase), sembrano rivivere in formato per così dire minore alle cinque del pomeriggio, quando al microfono a sorpresa chiede di intervenire il presidente della Puglia Michele Emiliano. Al raduno del teatro Vittoria nel quartiere Testaccio era stato il più duro del trio contro Renzi: «Vi chiedo scusa di averlo votato». Per tutto il giorno c'è il mistero sulle sue reali intenzioni, gli spin renziani fanno sapere che è pronto a tradire Rossi, Speranza e Bersani (e Massimo D'Alema). E il governatore sembra confermare i sospetti. Si traveste da agnello. Sventola il ramoscello della pace. Afferma che se Renzi farà un passo indietro, lui ne farà altrettanti, «per fare cento passi in avanti». Fino alla mozione di fiducia: «Io dico: mi fido del segretario, di Renzi, ho fiducia nella sua capacità di guidare questa gente meravigliosa. Siamo a un passo dalla soluzione per portare dentro il partito una sfida dignitosa». Con un'avvertenza finale: «Se non troviamo un accordo tra di noi sarà poi difficile convincere gli italiani che siamo la forza da votare». Convergenze parallele, perché Renzi e Emiliano sembrano fino a quel momento avere un interesse in comune. Fare il congresso e le primarie. Senza uno sfidante vero e agguerrito, per l'ex premier rischiano di essere un flop: gazebo deserti, in una calda giornata che già invita al mare, la prova che come dice Bersani il popolo ha voltato le spalle al Pd. E per Emiliano le primarie contro Renzi sarebbero un formidabile palcoscenico mediatico per rafforzare la sua leadership nazionale, oggi ancora legata alla Puglia e al Sud. Nella tagliola sembrano finire gli scissionisti: Rossi, Speranza e i leader. Bersani, presente per l'ultima volta, D'Alema ormai uscito in mare aperto. «Io ho deciso, vi aspetto fuori, fatemi sapere», ha salutato i compagni prima di lasciare il teatro Vittoria. "Vi consegno stasera con la massima determinazione ma anche affetto e rispetto, consegno al segretario la possibilità vera e reale di togliere anche a me ogni alibi al processo di scissione: siete in grado di dare una mano a Renzi a risolvere un problema che è solo di metodo per evitare un esito negativo, condividere una strada che metta insieme un punto di vista dei tre candidati". Così in assemblea Michele Emiliano aggiungendo che "se stasera non troviamo un punto di equilibrio sarà difficile spiegare agli italiani che questo è il partito a cui affidare il futuro dell'Italia". Sull'ex leader Massimo e sui bersaniani piovono per tutto il giorno appelli, richiami agli affetti, minacce. Nella sua relazione Renzi non concede neppure un millimetro a chi vuole andare via: «Don Milani diceva che chi perde il tempo bestemmia. Noi negli ultimi due mesi abbiamo bestemmiato il tempo. Adesso basta discutere, fuori di qui ci prendono per matti». Accusa gli avversari interni di volere la sua fine politica: «Più brutta della parola scissione c'è la parola ricatto. Non potete pensare che per evitare la scissione io possa togliermi di mezzo. Avete il diritto di sconfiggermi con un vostro candidato, non di eliminarmi!». Fa sfilare i fantasmi del 1998 e del 2009, ovvero la caduta di Romano Prodi a Palazzo Chigi e quella di Walter Veltroni dalla segreteria del Pd, entrambe con la regia di D'Alema. Il vero nemico Innominato. E per la prima volta il rottamatore, il ragazzo dell'anno zero, del momento presente, chiama in suo soccorso il passato nobile del centrosinistra: Arturo Parisi e l'Ulivo, il Lingotto di Veltroni (da cui partì nel 2007 l'avventura del Pd), i valori della sinistra, l'identità, le primarie, «il potere che appartiene ai cittadini», il Pd che è l'unico «modello alternativo all'azienda-partito (M5S di Casaleggio) e al partito-azienda (Forza Italia di Arcore)». E ammette: «Il Pd è più forte dei destini personali dei leader». In carne e ossa, in sala, ci sono molti protagonisti di questa storia. Parlano tutti, contro la scissione, nel silenzio surreale dei contendenti: i bersaniani spediscono Guglielmo Epifani sul podio a parlare per tutti, i renziani ancora una volta dimostrano incapacità di intervenire fuori dalla propaganda, quando il gioco si fa duro. Al loro posto, la vecchia guardia: Piero Fassino, Dario Franceschini, Franco Marini, ex segretari di Ds, Pd, Ppi. Parla, rompendo un silenzio che durava da anni, Walter Veltroni. E nella sala finalmente si fa attenzione. Scuola di prim'ordine, l'ex segretario rompe l'indifferenza reciproca. La sua è una lezione di discorso politico, prendano nota e lo studino nei loro corsi i giovani del Pd renziano i cui concetti non durano un tweet. Ed è una lunga lettera ai compagni di sempre che oggi potrebbero andarsene. Non si interrompe un'emozione, una storia. E Walter si toglie qualche antico sassolino nei confronti del rivale di sempre, D'Alema: «Vogliamo dirci che se il governo Prodi fosse proseguito la nostra storia sarebbe stata diversa? E che senza le nostre divisioni Prodi sarebbe diventato presidente della Repubblica nel 2013?». Ma Veltroni ha qualcosa da dire, e molto, anche sulla conduzione degli ultimi anni: «Il Pd non può essere un monocolore culturale o un partito personale. Se la prospettiva è la proporzionale, i partitini e le preferenze, il ritorno a un partito che sembra la Margherita e uno che sembra i Ds, non chiamatelo futuro, la parola più giusta è passato». Standing ovation. E per un istante qualcuno sogna che possa essere lui, Veltroni, il reggente del Pd nella fase congressuale. Chi rompe e chi costruisce. Gianni Cuperlo paragona Renzi e i suoi antagonisti a James Dean in "Gioventù bruciata", due auto in corsa verso il burrone, ed è l'immagine più cruenta e vera della giornata: «Non siamo mai stati un gruppo dirigente». Franceschini squarcia un velo sul nuovo che avanza: «Nella prossima legislatura le alleanze saranno larghe, politicamente improbabili, ma i numeri hanno una loro forza, solo la nostra unità ci consentirà di tenere in mano il timone di queste coalizioni». Traduzione: se in futuro dovremo allearci anche con Forza Italia meglio restare uniti e grandi, piuttosto che piccoli e deboli. Siamo alle ovvietà. Ma intanto nei corridoi i colonnelli bersaniani attaccano Renzi, si aspetta la mossa di Emiliano che alla fine arriva. Fuori tempo massimo, però. La soluzione è a un passo. La fine del Pd anche. «La recita si è fatta scadente, abbassiamo il sipario», disse il capogruppo dc Mino Martinazzoli chiudendo alla Camera nel 1987 la legislatura del governo Craxi. Nessuno lo ha ripetuto, eppure sarebbe stato necessario. Non lo ha fatto la minoranza, persa nell'ansia di non finire sotto il bastone renziano. E non lo ha fatto Renzi, che ha dimenticato l'insegnamento dell'Uomo Ragno: da grande potere grandi responsabilità. In un'assemblea di sette ore in cui in pochissimi hanno saputo parlare fuori dall'acquario o dal bioparco per rivolgersi al paese, all'altezza della «crisi democratica», come ha detto Veltroni, che attraversa e strema le istituzioni in Occidente, riscrive la storia e la geografia, da Washington all'Europa. La sola domanda che ci faremo dopo questo brutto film sarà: “Mentre il mondo esplodeva, di che cosa parlava la sinistra italiana?” Il passato bussa alla porta, senza i partiti e i protagonisti del passato. Sarà una scissione, se tale sarà, senza anima e pathos. Nulla di paragonabile ai drammi novecenteschi, e neppure alla nascita della Quercia, quando - garantì Michele Serra in una poesia - «ho visto piangere Massimo D'Alema/ là, dentro il grembo della tribuna rossa». Piansero tutti anche nel 2007, a Firenze, quando Fabio Mussi lasciò i Ds che entravano nel Pd. Non ha pianto nessuno, in morte del Pd così come lo abbiamo conosciuto. Una gelida separazione, di chi non ha più nulla da dirsi, di chi non sopporta più la presenza reciproca, neppure il tono di voce. Ma molto ci sarà da soffrire nelle prossime settimane: elezioni amministrative, Rai, Parlamento, il vento della divisione fuori dall'assemblea del Pd rischia di travolgere molte imprese, compreso il governo Gentiloni. Fino ad arrivare alle prossime elezioni, quando saranno. Perché da stasera M5S è virtualmente il primo partito italiano. E se la destra si sveglia, sarà un disastro politico annunciato per il centrosinistra e, chissà, forse, per il Paese. Il Pd è un partito bruciato. Un bel risultato, in ogni caso, per chi si era candidato a guidare l'Italia per decenni.
Scissione del Pd: ecco cosa ha detto davvero Delrio nel "fuori onda". "Non ha fatto neanche una telefonata...", dice il ministro riferendosi all'immobilità di Renzi sulle ipotesi di rottura del Pd, scrive il 17 febbraio 2017 Panorama. "Non ha fatto neanche fatto una telefonata, su... Come cazzo fai in una situazione del genere a non fare una telefonata?": a dirlo, parlando con Michele Meta dell'atteggiamento di Matteo Renzi rispetto alle ipotesi di scissione del Pd, è il ministro Graziano Delrio. Un "fuori onda" carpito durante un incontro sul trasporto pubblico della Capitale. Delrio risponde a Meta che gli chiede: "Lui si adopera per contrastare sta roba, Matteo?" I due, al tavolo dei relatori, parlano appunto della scissione (la conversazione è stata colta da Ala News che poi l'ha diffusa). Parte Meta, che rivolto a Delrio chiede se all'Assemblea nazionale si consumerà la scissione ("Domenica riusciamo ad evitare...?") per poi aggiungere: "Ma quindi secondo te barano o fanno sul serio?". Delrio sembra pessimista: "No fanno sul serio". E all'obiezione di Meta che forse "una parte no", il ministro replica: "Una parte ha già deciso. Poi ci sono anche dentro i renziani che diminuiscono i posti da distribuire, no? Perché pensano poi che siamo...". E Meta: "Eh, sì...". "... Una cosa - riprende Delrio - che fa vantaggio. Non capiscono un cazzo, perché sarà una cosa come la rottura della diga in California. Hai presente? C'è una crepa... ç'acqua dopo non la governi più". "Lui si adopera per contrastare sta roba, Matteo?", chiede allora Meta. Delrio: "S'è intignato di brutto. Perché non è che puoi trattare questa cosa qui come un passaggio normale (audio incomprensibile) cioè tu devi far capire che piangi se si divide il Pd non che te ne frega, chi se ne frega... Non ha fatto neanche una telefonata, su, come cazzo fai in una situazione del genere a non fare una telefonata?".
Da "Lambretta rossa" a Blair e Ambra. La frattura è anche nelle citazioni. Boccia evoca Zucchero mentre un gruppetto intona le strofe della Angiolini. I renziani più giovani s'aggrappano a Clinton, scrive Domenico Di Sanzo, Lunedì 20/02/2017, su "Il Giornale". «Lambretta rossa la trionferà». Francesco Boccia cita Zucchero durante l'assemblea Pd, e già non è più «Rivoluzione Socialista». Il deputato, presente anche alla manifestazione di sabato al Teatro Vittoria di Testaccio dice: «Hanno convinto persino me a cantare Bandiera Rossa». Ma è acqua passata. E il distacco con il popolo dei democraticisocialisti lo marca lo stesso segretario uscente Matteo Renzi nel suo intervento di apertura: «Io non accetto che qualcuno pensi di avere il copyright della parola sinistra. Anche se non canto bandiera rossa penso che il Pd abbia un futuro che non è quello che altri immaginano, la sinistra non si fa con la rivoluzione socialista». Niente lotta di classe nell'assemblea del Pd renziano, nessuno scontro con il capitalismo, «si va avanti allegri e frementi». Allegri e frementi, dice Renzi, citando Linea d'ombra di Joseph Conrad. Cosa ben diversa dall'afflato marxista che si respirava al Testaccio. Sul palco, ma anche in platea e nei corridoi dell'Hotel Parco dei Principi, i renziani marcano la differenze. Giachetti evoca la parola «sinistra» quasi come se fosse un corpo estraneo, il ministro Poletti ripete nel suo discorso i termini «impresa», «successo» e «merito», spingendosi fino all'elogio di «chi si crea l'azienduccia». Un altro pianeta rispetto a Enrico Rossi, il «rivoluzionario socialista» di sabato che magnificava l'aumento della pressione fiscale. Oppure il Roberto Speranza del «chi ha di più paghi di più, chi ha di meno paghi di meno». La scissione, sempre in bilico, è tutta contenuta nei chilometri che separano il Testaccio dai Parioli. L'Hotel Parco dei Principi, ai Parioli appunto, teatro dell'assemblea nazionale del Pd di ieri è blindato. L'organizzazione rigida. E al buffet un caffè costa un euro e cinquanta. Un panino quattro euro. I delegati più giovani, quasi tutti di estrazione renziana parlano di Clinton e Blair. Un gruppetto, per scaricare la tensione della scissione imminente, canticchia pure T'appartengo di Ambra Angiolini ai tempi di Non è la Rai. Sui loro schermi non va in onda la «Rivoluzione Socialista». Nel pomeriggio si fa vedere in sala stampa il bersaniano Nico Stumpo, e minaccia la scissione quando «le luci dell'assemblea saranno spente». Passa un giovane delegato, chiede «Chi è?» e si allontana arrabbiato dicendo: «Ah Nico!». Lo spin doctor di Renzi Filippo Sensi, accenna sorrisi, passa pure la coppia renziana Francesco Nicodemo-Pina Picierno, tutti molto casual. C'è chi cita «In cammino», il nome della nuova mozione congressuale di Renzi, che assomiglia vagamente all'En Marche! del candidato alle presidenziali francesi Emmanuel Macron, ex socialista, altro bersaglio del popolo del Teatro Vittoria. Nel frattempo il ministro Graziano Delrio getta acqua sul fuoco del fuorionda e risponde: «Renzi vi ha annunciato che si dimette e vi dice se ce la fate battetemi! cos'altro doveva dire?». Gianni Cuperlo, però, ribatte: «Questi sono solo toni muscolari». A sinistra non piacciono i toni muscolari. La deputata Anna Ascani, renziana grintosa, si chiede come farà a spiegare al popolo del Partito Democratico una scissione basata solo sulle date del congresso. Davanti al Parco dei Principi si vedono tre militanti dei Giovani Democratici del II Municipio di Roma. Mostrano uno striscione tricolore, non rosso, con la scritta: «Restiamo Uniti». Stanno davanti all'Hotel dei Parioli fino al pomeriggio inoltrato, e chiedono di «evitare la scissione», un po' come i renziani di Pontassieve rimasti fuori dal Teatro Testaccio, in cammino.
Matteo Renzi contro Bandiera Rossa: "Non la canto e non parlo di rivoluzione socialista", scrive “Libero Quotidiano” il 19 febbraio 2017. Nell'infuocato intervento di Matteo Renzi all'assemblea Pd, nel quale ha annunciato di voler tirare dritto verso il congresso forzando di fatto la scissione, c'è anche tempo e modo per strappare (metaforicamente) la Bandiera Rossa, il celebre inno comunista. Dopo aver ringraziato Walter Veltroni "per essere qui, nei momenti di difficoltà lui c'è sempre stato", parte in quarta: "Vorrei discutere cos'è la sinistra oggi. È di sinistra Teresa Bellanova non per la provenienza che non è la mia ma per l'attenzione agli ultimi. È molto più di sinistra affrontare il tema dei diritti e dei doveri che non crogiolarsi in riferimenti ai simboli del passato. È più di sinistra fare provvedimenti del sociale". Dunque, a conclusione del climax, l'affondo: "Anche se non canto Bandiera Rossa e non parlo di rivoluzione socialista penso che il Pd abbia un futuro che non è quello che altri immaginano". Touché.
Scissionisti Pd, c'è già il nome del nuovo partito. Pd, Michele Emiliano frena sulla scissione: "Non abbiamo ancora sbattuto la porta", scrive “Libero Quotidiano” il 20 febbraio 2017. Un nome per il partito degli scissionisti c'è già: Nuova sinistra-diritti e lavoro. Gira sui foglietti volanti della riunione, convocata alla fine dell'assemblea del Pd tra Michele Emiliano, Roberto Speranza, Enrico Rossi in collegamento telefonico, Nico Stumpo, Francesco Boccia e Dario Ginefra. "Va mantenuto l'impianto di centrosinistra e ulivista", dice Speranza. Il nome, riporta Repubblica, potrebbe anche essere Centro sinistra-diritti e lavoro. Ulivo no, innanzitutto perché c'è il copyright e poi perché dieci anni dopo la caduta di Prodi sarebbe del tutto anacronistico. Certo, Nuova sinistra sembra quasi uno sfottò. Tant'è. Per quanto riguarda i numeri alla Camera vengono dati per sicuri 22 deputati bersaniani in uscita. Ai quali si uniranno i 16 che firmarono per la candidatura di Arturo Scotto alla segreteria di Sinistra italiana. Si arriverà quindi a un gruppo di 38 deputati. Al Senato Scotto non ha truppe. Ma i bersaniani sono tra i 12 e i 15, sufficienti per formare un gruppo autonomo e ottenere i finanziamenti destinati alle forze presenti alle Camere. Gli scissionisti del Pd sono già sul punto di scindersi? Paradossale, ridicolo, eppure è così. Già, perché tra chi si stacca dal Nazareno si comincia a sospettare su Michele Emiliano. Tutta colpa del tentativo di mediazione e dei tentennamenti di domenica, quando all'assemblea del partito ha provato a ricucire in extremis, nonostante le nette chiusure di Matteo Renzi su tutta la linea. Ed Emiliano, a ricucire, ci vuole provare ancora: "Io farò di tutto per evitare la scissione, aspetto fino a domani. La mia porta è sempre aperta, non ho le mani legate", ha affermato. Ed è in questo contesto, dunque, che gli esponenti della minoranza Pd, i bersaniani, che sono i più convinti dello strappo, covano sospetti sul governatore. "Emiliano è capace di tutto, ma se viene meno all'accordo perde ogni credibilità", afferma una fonte che sceglie l'anonimato a Il Messaggero. Un altro ribelle bersaniano argomenta spiegando che il governatore "non va catalogato, non è un politico di professione. Si muove tra i regolamenti, fa giravolte una dopo l'altra, ci possiamo aspettare di tutto". Insomma, gli scissionisti sono già spaccati, così come da miglior tradizione sinistra. E sempre Emiliano, di fatto, conferma il fatto che potrebbe anche evitare lo strappo sempre a Il Messaggero. "Abbandonare il Pd? A certe condizioni". E ancora, aggiunge: "La porta non è ancora chiusa, questo è chiaro, ma se Matteo non risponde, non apre uno spiraglio, non dà un segno di ascolto e di rispetto, non resta nei prossimi giorni che constatare questo atteggiamento e andare via. Se così sarà, è a Renzi che bisogna chiedere perché ha provocato questo". Ma la porta, appunto, non è ancora chiusa.
Silvio Berlusconi e Michele Emiliano, la cena con cui porre le basi per una possibile intesa, scrive “Libero Quotidiano” il 19 febbraio 2017. Nelle ore caldissime che con assoluta probabilità porteranno alla scissione del Pd, il Corriere della Sera rivela un retroscena piuttosto clamoroso. Una cena, alla quale hanno preso parte Silvio Berlusconi e Michele Emilano, uno dei leader della minoranza Pd nonché sfidante di Matteo Renzi per la segreteria. Un incontro al quale il Cavaliere è stato invitato dal governatore della Puglia: invito accettato. Secondo quanto si legge sul Corsera, Berlusconi desiderava sapere se il Pd sta davvero avviandosi alla scissione e avrebbe ottenuto garanzie sulla tenuta del partito. "E comunque non me ne andrò mai", ha detto Emiliano al Cavaliere. Eppure, negli ultimi giorni, la situazione pare essere capitolata: la scissione ci sarà e pure Emiliano potrebbe sloggiare. Resta però la cena. Quell'incontro di Berlusconi con un avversario che lo ha sempre rispettato: "Non l'ho dimenticato", ha affermato il Cavaliere. Per poi aggiungere: "Altri invece mi hanno deluso profondamente". Ogni riferimento a Renzi non è puramente casuale. Frasi precise e studiate, con le quali in un qualche modo sembrano essere state poste le basi per una possibile intesa in caso di necessità, leggasi nuove larghe intese, assai probabili in caso di voto, almeno sondaggi alla mano. Berlusconi, è noto, è pronto al dialogo. Sia che l'interlocutore sia Renzi sia, e soprattutto, se sarà Emiliano. Ma il Cav preferirebbe che il governatore scali il Pd e non se ne vada. La ragione è presto detta: con la scissione della sinistra, Renzi potrebbe ulteriormente spostarsi verso posizioni centriste, sovrapponendosi ulteriormente all'elettorato di Forza Italia.
Tredici partitini ma zero idee Le stelline della galassia rossa non sono d'accordo su nulla. Fratoianni è il nuovo segretario di Sinistra italiana, già Sel E guida un guscio vuoto, unito soltanto dal no a Renzi, scrive Massimo Malpica, Lunedì 20/02/2017, su "Il Giornale". Per dire qualcosa di sinistra contate fino a cinque. Anzi, meglio ancora fino a tredici. La prima cifra fotografa le anime della frastagliata galassia a sinistra del Pd. Al secondo numero, tredici, ci si arriva sommando anche - lo ha fatto ieri Repubblica mappando la nebulosa progressista - le componenti interne ai dem, alcune aggregate semplicemente da separate in casa. Il problema è che, mentre contate, scoprirete di essere i soli. Perché buona parte delle stelline di questa galassia, invece, non conta nulla. Tra scissioni e spaccature, il retaggio del Pci che fu s'è disperso come la molecola di una diluizione omeopatica. E di quest'ultima ha la stessa efficacia terapeutica per gli orfani di Berlinguer. L'ultima «novità» in questo variopinto insieme è l'elezione di Nicola Fratoianni a segretario di Sinistra Italiana, nata dalle ceneri di Sel (di cui il vendoliano Fratoianni era coordinatore) e già pronta a chiudere porte in faccia agli ex compagni che sbagliano. A tracciare la rotta era stato in apertura di congresso Fabio Mussi, sbarrando l'uscio al Pd renziano e strizzando l'occhio a una scissione Dem o almeno a una svolta al congresso. In fondo per Mussi la sinistra è come «un arcipelago». E chi vorrebbe costruire ponti, come l'ex capogruppo alla Camera di SI, Arturo Scotto, si ritrova fischiato e molla la nuova isola appena emersa dalle rosse acque dell'avvenire. Dove andrà? I radar dicono che il porto d'attracco di Scotto e di altri scontenti di Sinistra Italiana sia il «Campo Progressista» di Giuliano Pisapia. Ennesimo scoglio fondato - giura l'ex sindaco di Milano, «per unire» la sinistra. E per farlo la divide un po' anche lui, aggregando nel Campo l'ex Rifondazione e Sel Massimiliano Smeriglio e il leader di Centro democratico ed ex Udc Bruno Tabacci, ma seducendo pure Michele Emiliano. All'ultima presentazione c'era pure la Boldrini che però resta di Sel, cioè di SI, ma intende «fare il possibile per facilitare il dialogo tra le tante anime». Tante. Troppe. Con poche idee per aggregare e molte per dividersi. Spesso ringalluzzite dal «no» al referendum che ha restituito spiccioli mediatici a volti dimenticati. Perché almeno all'appello anti-Renzi rispondono tutti presente. C'è l'eterna Rifondazione Comunista con Paolo Ferrero, c'è Possibile di Pippo Civati, c'è DemA del sindaco di Napoli Gigi De Magistris. E prima di Renzi e dei renziani, c'è ancora un lungo elenco. A cominciare dal ConSenso dell'autoriciclato D'Alema fino al Campo aperto di Gianni Cuperlo, ieri all'attacco di Renzi. E poi i Democratici socialisti con Bersani, Rossi, e il quasi ex renziano Emiliano che puntano a scalare il partito, i Giovani Turchi, l'Area Dem di Franceschini e il Movimento lombardo del Pd che si esercitano in distinguo. Una raffica di sigle, una carrellata di leader più o meno improbabili. E poche idee al di là del no a Renzi.
Il "nuovo" della fronda Pd: Bandiera rossa e Ottocento. Tanta nostalgia e slogan riesumati dal passato alla kermesse degli scissionisti, niente bandiere Dem, scrive Domenico Di Sanzo, Domenica 19/02/2017, su "Il Giornale". «Bandiera rossa la trionferà, evviva il socialismo e la libertà». Roma, Italia, 19 febbraio anno 2017. L'evento della minoranza PD dal titolo eloquente di «Rivoluzione socialista» comincia così. All'ormai ex rottamatore fiorentino Matteo Renzi, la sinistra dem oppone i «tre tenori» Enrico Rossi, Michele Emiliano e Roberto Speranza. Restauratori del socialismo. E sono loro stessi a rivendicarlo con orgoglio. Comincia il governatore della Toscana, organizzatore dell'incontro e autore di un libro intitolato proprio Rivoluzione socialista: «Il nostro nemico è la destra» e giù applausi dalla platea, composta per lo più da sessantenni. Rossi, anche se in giacca e cravatta, si traveste da rivoluzionario: «Noi abbiamo bisogno di un partito partigiano, che stia dalla parte dei lavoratori. Il Pd sta scontando troppa contiguità e vicinanza con i potenti, se esalti Marchionne non puoi aspettarti il voto del precario». Anche se di giovani precari e popolo dei «voucher», altro tema molto in voga, se ne vedono pochi. Ad abbassare un po' la media dell'età c'è solo una piccola delegazione di Giovani Democratici, con barbe da hipster e maglioncino «alla Marchionne». Non ci sono bandiere del Pd, ad eccezione di un gruppetto di renziani, che si definiscono «responsabili», arrivati da Pontassieve, il paese dell'ex premier, per «ricucire lo strappo». Ma per loro al Teatro Vittoria di Testaccio non c'è posto. E infatti restano fuori. Dentro, intanto, continua la rievocazione del socialismo ottocentesco. Rossi vuole sconfiggere il «capitalismo parassitario» e parla di «critica razionale al capitalismo». Poi arriva Roberto Speranza che, tra una minaccia di scissione e l'altra, corteggia sindacalisti e insegnanti: «Bisogna ricomporre la frattura con il mondo della scuola e dialogare con la Cgil». Di professori sessantottini e iscritti al sindacato «rosso» nel pubblico ce ne sono tanti. Il deputato lucano confessa, suo malgrado, di «aver ricevuto anche lui una telefonata da Renzi», e subito si agita un militante: «Che t'ha detto Matteo?», urla. Il pantheon dei «socialisti rivoluzionari» riuniti al Teatro Vittoria è vasto. Vengono proiettate immagini della Resistenza, del '68, delle proteste antirazziste in America. Oltre ai classici della sinistra italiana, primo fra tutti l'intramontabile Enrico Berlinguer, gli oratori citano Nelson Mandela, Rosa Parks e Papa Francesco. In Europa, oggi i riferimenti sono il candidato dei socialisti alle prossime presidenziali francesi Benoit Hamon e il laburista britannico Jeremy Corbyn. Lo spauracchio vero, però, è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: «Esempio di una destra che è pronta a raccogliere consenso sfruttando e manipolando quel disagio che ha creato lei stessa». E Renzi diventa un «neoreaganiano», di destra pure lui. Il più adorato dal popolo di questa «nuova» sinistra è invece il governatore della Puglia Michele Emiliano. L'ex magistrato, da battutista consumato, esordisce scusandosi per «essere stato un sostenitore di Renzi». Emiliano scatena l'applauso più forte di tutti quando dice: «Di fronte a una situazione molto meno grave di quella in cui si trova oggi Matteo Renzi, Pier Luigi Bersani si è dimesso e ha consentito al partito di superare le difficoltà». Compagni in visibilio e Bersani costretto ad alzarsi per salutare. Accanto a lui impassibili Guglielmo Epifani e Massimo D'Alema. Tutti e tre ormai «padri nobili» della cosa socialista. Sale sul palco un operaio della Luxottica di Settimo Torinese: «Mi stupisce che ancora ci siano gli operai». Al solo pronunciare la parola tutti si scatenano. Grigorij Filippo Calcagno, 20 anni, segretario dei Giovani Democratici di Modena parla con passione di «uguaglianza, sinistra e socialismo». Il suo idolo? Enrico Rossi «il Bernie Sanders italiano». In fondo, ci si accontenta di poco.
Ladri di politica, scrive il 18 febbraio 2017 Alessandro Gilioli su "L’Espresso”. Non so se è solo mio o di pochi - o invece è diffuso - il senso di attonito straniamento rispetto allo spettacolo offerto in quest'ultima settimana da quelle parti politiche che erano nate (o almeno dicevano di essere nate) per rappresentare, in Italia, la parte più bassa e numerosa della piramide sociale: i ceti poveri, quelli impoveriti, quelli fragili, quelli sommersi dalla velocità e dalla voracità del capitalismo più recente. Attonito straniamento non solo rispetto al Pd - e alle sue improbabili, impresentabili, inguardabili cordate di potere - ma più in generale rispetto a tutto o quasi il teatrino che ci sta attorno, comprese le sinistre più o meno "radicali" che si accoltellano intorno alla questione se si può essere più o meno alleati di un altro partito in cui nel frattempo ci si accoltella attorno ad antiche oligarchie spodestate e a ex spodestatori già rampanti ma precocemente invecchiati nel somigliare alle stesse oligarchie che avevano spodestato.
E in tutto questo, niente di reale: niente che somigli a questioni vere, alla società fatta a coriandoli, al 'tutti contro tutti' diventato cifra del nostro vivere quotidiano, alle persone che a milioni hanno perso identità e prospettive, ideali e tranquillità. Che hanno perso allo stesso tempo l'oggi, il domani e il dopodomani. E sono rimaste sole. Sono rimaste sole perché c'è un dentro - i partiti, le loro surreali lotte intestine, i loro esponenti che si insultano sui media - e c'è un fuori, dove si parla d'altro e si teme altro, e si guarda a quei partiti come se fossero tutti alieni, pazzi, o tutt'al più appunto teatranti, intrattenitori. Che litigando ci fanno distrarre dalla nostra vita vera, dai nostri problemi veri, dal nulla in cui siamo stati cacciati. Dentro, ci sono i pochi tifosi di questo o di quello: con la giugulare gonfia e l'insulto rapido, con le proprie ragioni di setta e i propri amori tribali, con il proprio capo di riferimento che rappresenta da solo il bene e il giusto. Fuori, ci sono tutti gli altri: spaesati, stanchi, disillusi, distaccati, indifferenti, malfidenti, distratti. Alcuni - pochi - incazzati, come me: e timorosi che appena l'orchestrina finisce il concerto, lì sul Titanic, ci sarà da ammazzarsi per salire sulle scialuppe. Ma molti di più sono semplicemente i lontani, i lontanissimi da chi è rimasto dentro a parlarsi addosso. Poi finirà, in qualche modo. E "passerà questa pioggia sottile, come passa il dolore". Resta ancora da capire, però, cosa resterà dopo. Se le macerie renderanno fertile il terreno o se al contrario nulla vi crescerà più per anni. Se avrà di nuovo senso la politica come strumento per immettere buone cause nel reale e provare a creare valore nel mondo o se al contrario la politica ci sarà stata derubata irreversibilmente.
La sinistra vive di scissioni. Possibile, Dema, Sinistra Italiana, Campo progressista e ora il partito dei bersanian-dalemiani. Ecco tutte le scissioni che ha subìto il Pd, scrive Francesco Curridori, Giovedì 16/02/2017, su "Il Giornale". Pci-Pds-Ds-Pd a sinistra, Rifondazione-Pdci-Sinistra Arcobaleno-Fds-Sel-Si ancora più a sinistra. Nel corso degli ultimi 20 anni il centrosinistra italiano ha conosciuto più partiti che nei primi 50 anni di storia repubblicana. L’uscita dal Pd di Pier Luigi Bersani e della sinistra dem rischia di creare una frattura ben più importante della scissione di Palazzo Barberini dal Partito Socialista Italiano attuata da Giuseppe Saragat. Oggi ‘burattinaio’ dell’operazione è Massimo D’Alema, ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pds/Ds, il più feroce oppositore di Matteo Renzi. D’Alema, prima ha fondato i comitati del No al referendum e, poi, ha giurato: “Quando finisce questa campagna elettorale tornerò pienamente al mio lavoro, quello di presiedere la Fondazione culturale dei Socialisti europei a Bruxelles e quindi non mi occuperei della politica italiana". Ma si sa, i leaders della sinistra fanno promesse da marinaio. Anche Renzi aveva giurato più volte: “Se perdo il referendum, mi ritiro dalla politica” e, molto prima di lui Walter Veltroni con l’indimenticabile: “Quando smetto con la politica, vado in Africa”. Ora, invece, Renzi sta preparando la sfida all’Ok Corral con la minoranza e Veltroni, primo segretario del Pd, alquanto preoccupato, è intervenuto sul Corriere della Sera: “L’idea di dividersi è un incubo”. Eppure la scissione è dietro la porta, anzi per Bersani “è già avvenuta”, con gli elettori in occasione del referendum. Renzi sembra essersi rassegnato. “Non si fa una scissione sulla data del Congresso”, ha commentato in questi giorni. E, infatti, la rottura ha ragioni ben più pragmatiche e profonde. Da un lato la minoranza non ha un candidato unitario da contrapporre in così breve tempo a Renzi e dall’altro ha vissuto la sua segreteria come un’anomalia. A parte la parentesi di Dario Franceschini che nel 2009 ha svolto il ruolo di reggente dopo le dimissioni di Veltroni, il Pd non è mai stato guidato da un ex margheritino e la componente ex diessina ha sempre dettato la linea. E ora, se Renzi dovesse rivincere il Congresso, con l’attuale legge elettorale si troverebbe ridimensionata perché spetterebbe al segretario decidere le candidature e capilista bloccati. Ecco dunque la necessità della minoranza dem di uscire dal Pd e sperare, come ha detto D’Alema, di raggiungere quel 10% che, grazie a una legge proporzionale, consenta ai vari Bersani, Speranza ed Emiliano di avere rappresentanza in Parlamento. I numeri dicono che chi si è separato dal Pd, come Francesco Rutelli con la sua Api, non ha avuto grande seguito e che la sinistra radicale non supera il 5% dal lontano 2006. Sinistra Italiana, il soggetto politico che doveva servire per unire i vendoliani di Sel con i fuoriusciti del Pd, si sta dividendo ancor prima di essere nata. Il capogruppo alla Camera, Arturo Scotto, è pronto ad abbandonare l’intransigente Nicola Fratoianni per seguire il progetto di Giuseppe Pisapia del “Campo progressista” che guarda al Pd. Sarebbe da smemorati, poi, non citare ‘Possibile’ di Pippo Civati e il movimento Dema, Democrazia autonoma del sindaco Luigi De Magistris che nasce dalle ceneri del Movimento Arancione. In questo contesto nascono spontanee alcune domande. Come può il Pd possa risollevarsi se rielegge Renzi, il segretario che si è dimesso da premier dopo aver perso un referendum costituzionale 60 a 40? E come può un Bersani riproporsi agli italiani dopo che, all’indomani delle elezioni 2013, aveva commentato: “Siamo arrivati primi ma non abbiamo vinto"? E chi può tenere insieme Enrico Rossi, Michele Emiliano, Pisapia, Civati, De Magistris, Stefano Fassina e Fratoianni? In attesa di una risposta, siamo certi che arriverà prima una nuova scissione…
Tra sigle e scissioni, la storia della sinistra lunga un secolo. Dal primo Partito socialista a Sinistra ecologia e libertà, ripercorriamo nascita e divisioni di tutti i soggetti che hanno scritto la storia della sinistra italiana, scrive "Il Corriere della Sera" il 17 febbraio 2017.
1. Il primo Partito socialista (1892). La storia della sinistra italiana è ricca di esperienze, di nascita di nuovi soggetti come di scissioni e di spaccature. Proviamo a ripercorrere le principali vicende con i simboli dei partiti che si sono affacciati sulla scena politica nazionale. Il Partito socialista è la prima formazione organizzata della sinistra in Italia. Viene fondato a Genova e nel 1895 assume la sigla di Psi. Il fascismo nasce ufficialmente il 23 marzo 1919 a Milano. Benito Mussolini, ex dirigente del Partito Socialista Italiano e convertito alle idee del nazionalismo e della prima guerra mondiale, riuscì a fondere la confusa congerie di idee, aspirazioni, frustrazioni degli ex combattenti reduci dalla dura esperienza della guerra di trincea, in un movimento politico che all'inizio ebbe una chiara ispirazione socialista e rivoluzionaria che subito si contraddistinse per la violenza dei metodi impiegati contro gli oppositori.
2. Il Partito Comunista Italiana (1921). A Livorno la corrente rivoluzionaria del Psi, insoddisfatta per l’esito del congresso, lascia l’organizzazione e fonda il Partito comunista italiano.
3. Partito socialdemocratico (1947). La corrente moderata del Psi guidata da Giuseppe Saragat, in polemica con la linea di collaborazione con i comunisti, fonda il Partito socialdemocratico.
4. Partito socialista di unità proletaria (1964). Dopo i fatti di Ungheria (1956) i rapporti tra Psi e Pci peggiorano. I socialisti filo Pci fondano il Partito socialista di unità proletaria.
5. Partito di unità proletaria (1974). Nel Partito di unità proletaria per il comunismo confluisce il gruppo del Manifesto (radiato dal Pci) e altre sigle dell’estrema sinistra.
6. Partito democratico della sinistra (1991). A febbraio il Pci, sotto la guida di Achille Occhetto, si scioglie per dare vita a un nuovo partito di orientamento socialista e democratico, il Pds.
7. Rifondazione comunista (1991). I contrari alla fine del Pci, insieme ad altre sigle della sinistra radicale, a dicembre varano il Partito della rifondazione comunista.
8. Democratici di sinistra (1998). A febbraio il Pds e altre sigle di ispirazione socialista, cristiano sociale, comunista e repubblicana, danno vita ai Democratici di sinistra.
9. Comunisti italiani (1998). Una parte di Rifondazione comunista, favorevole al governo Prodi, rompe con il resto del partito e fonda in ottobre i Comunisti italiani.
10. Partito democratico (2007). Dalla fusione di Ds e Margherita (la sigla che aveva raccolto la tradizione della sinistra Dc) nasce con le primarie il Partito democratico.
11. Sinistra ecologia e libertà (2009). L’unione di Sinistra democratica, ex Ds contrari alla nascita del Pd, con un gruppo fuoriuscito da Rifondazione dà vita a Sel.
In vita e in morte del Partito democratico. La sola domanda che ci faremo dopo questo brutto film sarà: “Mentre il mondo esplodeva, di che cosa parlava la sinistra italiana?” Scrive Tommaso Cerno il 17 febbraio 2017 su “L’Espresso”. Partiamo da una citazione talmente celebre che finisce per essere sottovalutata, fino a quando - a forza di provarla sulla nostra pelle - si dimostra l’archetipo dell’essere italiano. Nel Principe, Nicolò Machiavelli scrive che il successo di un regnante - si direbbe oggi di un leader - dipende per metà dalla fortuna e per metà dalla virtù. Significa che non c’è al comando mai la pura casualità, né la pura follia, né la pura capacità. Quel che sta succedendo al Pd è, dunque, l’epilogo di una storia. Cominciata con una classe dirigente inadeguata, simboleggiata dalla figuraccia di Pier Luigi Bersani alle politiche 2013. E terminata con una classe dirigente altrettanto inadeguata. Simboleggiata da un Matteo Renzi irriconoscibile. E dalla nostra copertina che incide la data di nascita e di morte non della sigla “Pd”, ma del sogno che essa aveva animato. Perché il Partito democratico non perde elettori o dirigenti, cosa che capita in politica, ma perde peso e credibilità agli occhi di tutta la parte laica e progressista del Paese. Si scioglie nell’anima, non nella struttura. Poco importano le beghe fra correnti e la frattura, prima personale e solo poi politica, che si sta rapidamente consumando in queste ore, di fronte a ciò che resta: “Il fu Partito democratico”. Da quel 2007 a oggi sono passati dieci anni. E ora sappiamo che, comunque vada, ciò che uscirà dal congresso non è più ciò che ci era entrato: il Pd come l’avevamo conosciuto. Sulla crisi dei democratici è stato scritto e detto di tutto. Politologi, militanti, blogger, editorialisti e mezzi busti da talk show. Eppure c’è qualcosa di atavico, qualcosa di interiore di cui ti vergogni, c’è un riflesso automatico che cerchi di occultare e che invece si manifesta più nitido di tutto. Quando, fra dieci anni, lontani dai riflettori e dalle polemiche della cronaca, fuori dai tatticismi e dalle giravolte politiche, analizzeremo questo momento storico, dove sta cambiando “l’uomo” e il suo modo di stare al mondo, ci chiederemo: di cosa stava discutendo la sinistra italiana? Di cosa, mentre milioni di donne e uomini urlavano la propria rabbia e il proprio no al modo in cui abbiamo concepito la politica dalla caduta di Hitler e Mussolini in poi? Di cosa lor signori mentre un miliardario saliva sull’Air Force One con il plebiscito della classe più povera d’America? E di cosa mentre nel cuore dell’Europa democratica risorgevano gli spettri del nazionalismo e della xenofobia? Di mozioni, tessere, conferenze programmatiche, regole, documenti fotocopia e ancora mozioni. Di nulla. la parola d’ordine che nel 2007 aprì al sogno di una sinistra maggioritaria nel segno del Pd era “fusione”. A freddo magari. Tenuta insieme con lo scotch dell’antiberlusconismo, se vogliamo. Ma adesso la parola più pronunciata a sinistra è diventata “scissione”. Non è un caso. È un’inversione di polarità, un ribaltamento del processo culturale che ha tentato di archiviare le vecchie ideologie e di traghettare il cattolicesimo sociale e l’ex comunismo, pentito, nel socialismo europeo. E invece niente. Renzi sì, Renzi no, prigionieri di un referendum interiore che condanna la sinistra a perdere per i prossimi anni le elezioni. A vantaggio, deciderà il Paese, di un grillismo che - nemesi vuole - nasceva proprio nello stesso anno del Pd, nel 2007, con un grido “Vaffa” che si sta mutando in desiderio di governo. Dentro un processo, pur incidentato, di parlamentarizzazione che va nella direzione opposta ai democratici di nome, ma non di fatto. Oppure alla destra neo-berlusconista, guidata da chi saprà mostrarsi a ciò che resta del Cavaliere quel modello di “italiano medio” che Berlusconi, piaccia o no, ha saputo decifrare meglio del campo avverso. Diverte che in questa Chernobyl politica ci si diletti con le virgole e gli apostrofi. Diverte che la domanda sia: quanto durerà il governo? Come se un brutto film fosse più o meno brutto perché dura un quarto d’ora in meno o venti minuti in più. Nello spettatore elettore, ciò che lascerà sarà il medesimo senso di estraneità, di fastidio, di lontananza. E alla domanda: quanto è durato? La risposta sarà: che me ne importa. Ma la sinistra no. Lei sa come si fa. Sa ripetere il mantra dei tempi nuovi, quello che dice «dobbiamo ritrovare la fiducia dei nostri elettori, dobbiamo parlare a quella gente che ci ha voltato le spalle». Retorica. E pure di bassa lega. La verità è che l’Italia, soprattutto la sinistra italiana, vive un eterno 8 settembre. Abbiamo dentro l’archetipo che demolisce ogni progetto includente. Non possediamo l’anticorpo del governo. Quello che consente di distinguere fra un’idealità che deve volare sempre più alta e la responsabilità del compromesso, tale solo in virtù di un fine, chiudendo sulla citazione machiavellica: materializzare (almeno in parte) le promesse fatte.
Una questione di potere, scrive Michele Serra il 18 febbraio 2017. La grande speranza della sinistra post comunista, dalla Bolognina in poi, era che la morte dell'ideologia avrebbe reso più viva la politica. Più viva e più libera di abbracciare la realtà, di assomigliare alle persone e alla società così com'erano, di unire e di dividere non più sulla base delle differenti appartenenze, ma delle battaglie da fare. L'attuale crisi del Pd, forse sull'orlo del suo dissolvimento, non è grave perché mette a rischio le sorti di questo o quel gruppo dirigente, o addirittura quelle del partito stesso: i leader passano, i partiti anche, e perfino per i litigiosi eredi della grande tradizione comunista e cattolico-popolare vale il cinico ma salvifico detto "chi muore giace, chi vive si dà pace". La crisi del Pd è grave perché, con tutta la buona volontà, non si riesce a leggerla in chiave di autentico scontro politico, cioè di un conflitto provocato da visioni inconciliabili della società, dell'economia, dei diritti e dei doveri, degli interessi da tutelare e di quelli da combattere. E dunque il Pd minaccia di certificare, nella sua maniera al tempo stesso rissosa e impotente, che la grande speranza della Bolognina era in realtà una grande illusione. Alla morte dell'ideologia ha fatto seguito, a sinistra, anche la morte della politica, almeno della politica intesa come comprensibile e appassionante tentativo di interpretare la realtà e di modificarla. Al suo posto uno scontro di potere che riesce a stento, e forse solo per mantenere il decoro, a contenere qualche riverbero di politica vera (la disputa sui voucher? Ovvero su meno del due per cento del totale delle retribuzioni? Esiste al mondo un partito di massa disposto a spaccarsi su una questione del genere?); ma quel riverbero è così tenue da non riuscire a illuminare il clima da tragedia shakespeariana che occupa la scena, e del quale il pubblico riesce a intendere le minacce e i gemiti, non certo la sostanza drammaturgica. È una trama che sfugge. Una trama che appartiene solo agli attori, non agli spettatori. È una situazione - quel clima cupo, quell'astio, quel non parlarsi e "non telefonarsi" (Delrio) - che lascia di stucco i milioni di elettori che al Pd, nonostante tutto, fanno riferimento; ma quel che è peggio pare ingovernabile perfino dai suoi stessi artefici, non uno dei quali è riuscito, fin qui, a dare una spiegazione "popolare", ovvero comprensibile al grosso dell'opinione pubblica, di quanto sta accadendo sul piano delle scelte politiche, visto che su quello del potere (Renzi sì, Renzi no) tutto è fin troppo chiaro. Stucchevolmente chiaro. Ha ragione dunque Gianni Cuperlo, uno dei (pochi) leader che ha dato l'impressione di anteporre ai conti personali quelli con la comunità nazionale: la posta in palio è "mandare all'aria un quarto di secolo", l'intera storia della sinistra italiana dalla Bolognina fino ad oggi, dalla data di morte della ragione ideologica sacrificata nel nome della ragione politica che avrebbe dovuto prenderne il posto. A giudicare dall'attuale evanescenza della ragione politica, viene da immaginare la piccola vendetta postuma di chi riteneva l'ideologia la sola vera struttura portante di un partito di massa. Resta comunque una soddisfazione di stretta minoranza. Per la grande maggioranza degli italiani interessati alle sorti di quel campo politico il problema sta diventando ben altro. Il problema è cominciare a fare i conti - per la prima volta con una evidenza così spietata - non più con la morte dell'ideologia, ma con quella della politica. La politica come un libro da chiudere perché leggerlo è diventato troppo ostico e troppo diverso da quello che era stato per i padri e nonni, fonte di passione e di sacrificio, di errori magari tremendi ma quasi mai dettati da calcoli personali. Già oggi l'enorme serbatoio dell'astensionismo trabocca di ex elettori di sinistra. La classe dirigente del Pd e per primo - ovviamente - il segretario politico Matteo Renzi, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, mettano nel conto anche questa possibilità, molto realistica: l'insignificanza politica come prodotto della modestissima significanza delle loro lotte intestine. Un sacrificio rituale come fu quello della Bolognina (cambiare il nome per cambiare politica) può essere spiegato e metabolizzato, compreso il prezzo di una scissione della quale nessuno poté dire: non si capisce il motivo. La morte dei Pci fu, lei sì, un dramma storico in piena luce e a piena voce. Nessuno, a sinistra, se ne poté sentire escluso. Che ne possa sortire, un quarto di secolo dopo, questa rissa senza una vera regia, senza un vero copione e soprattutto senza pubblico, è veramente impressionante. La risposta al populismo è l'impopolarità?
Comunismo, quanto sei cambiato. A cent’anni dalla caduta del Palazzo d’Inverno l'ideologia della rivoluzione russa subisce profonde mutazioni. Scopre la democrazia, conquista studiosi. Ma al convegno per l’anniversario gli oratori sono sempre gli stessi, scrive Stefania Rossini il 15 febbraio 2017 su "L'Espresso". Lo spettro che da tanto tempo si aggira per l’Europa e che esattamente un secolo fa si era fermato nella lontana Russia per rimanerci settant’anni, snaturando se stesso e le sue istanze di emancipazione e libertà, non ha ancora trovato pace. Il suo nome, Comunismo, che suscitò tante speranze e impose tante delusioni, è oggi diventato quasi un insulto, ridotto a una variante del totalitarismo e pronunciato con il disprezzo che si dedica agli sconfitti. Eppure lo spettro non si dà per vinto e in questo inizio 2017, dominato da tentazioni autarchiche e autoritarie, si affaccia di nuovo senza timidezze nelle commemorazioni di quell’Ottobre rosso di cent’anni fa che sconvolse davvero il mondo. È, ovviamente, un comunismo diverso da quello duro e intransigente che mirava alla dittatura del proletariato. Oggi rispetta la democrazia, anzi corre in suo soccorso, si mischia con il femminismo e con le battaglie delle minoranze, esalta il primato delle differenze, trova il suo spazio in un mondo del lavoro completamente nuovo, parla di desiderio, di estetica e di «sviluppo libero delle individualità». Quasi a voler richiamare, con l’esperienza dei tempi mutati e degli smacchi subiti, quella stagione breve e fulminante seguita alla rivoluzione di ottobre, che suscitò l’entusiasmo delle migliori menti creative dell’epoca. Ha dei portavoce di prestigio internazionale come i francesi Etienne Balibar e Jacques Rancière o come lo sloveno Slavoj Žižek, ma lo zoccolo duro della riflessione teorica e della proposta politica è ormai da tempo tutto italiano. Sì, italiano, anche se può sembrare strano a chi è abituato a declinare il comunismo negli infiniti settarismi dei partitini di sinistra che ora si scindono e ora si ricompongono. O a chi l’ha visto spegnersi nelle dichiarazioni di quegli esponenti del vecchio Pci che assicurano di non essere mai stati veramente comunisti. Il primato italiano è sancito persino da una definizione, "Italian Theory", che va per la maggiore nelle più importanti università americane, le stesse dove per decenni aveva regnato la "French Theory", che aveva reso gigantesche le icone di Michel Foucault, Jean Braudillard e Jacques Derrida. Sarà un po’ per moda, sarà un po’ per i vezzi radicali di Yale e di Harvard, ma ormai sono gli italiani a dominare la scena, con libri e convegni che valorizzano soprattutto l’elaborazione teorica di radice operaista, quella che a partire dagli anni Novanta ha discusso di intellettualità di massa, di lavoro immateriale, dei nuovi modi di produrre, di globalizzazione, di moltitudini, di biopolitica. Tutti argomenti «per afferrare il proprio tempo con il pensiero» secondo il compito che Hegel attribuiva alla filosofia, è stato detto in uno di quei convegni. Un successo crescente a cui ha dato slancio la trilogia di Toni Negri ("Impero", "Moltitudine" e "Comune"), pubblicata in inglese tra il 2000 e il 2010 con l’allievo statunitense Michel Hardt che ha contribuito non poco a sciogliere un linguaggio specialistico in una narrazione più chiara. Gli altri nomi sono quelli di Paolo Virno, in realtà il primo a rompere il monopolio americano dei post-strutturalisti con "Radical Thought in Italy" scritto con Hardt già nel 1996; di Maurizio Lazzarato, il cui saggio, "Il governo dell’uomo indebitato" (Derive e approdi, 2013) ha fatto molto discutere anche in Italia; di Christian Marazzi, di Sandro Mezzadra, di alcuni altri e anche di Roberto Esposito, nome di spessore della filosofia italiana, che operaista non è, ma è l’ideatore del concetto di "Italian Theory" che estende indietro nei secoli, staccandola dalla tradizione europea per restituirla alla sua originale irregolarità. Il comunismo è comunque per tutti i post-operaisti, presenti o no nel pantheon dei radicali americani, non un residuo del secolo breve da dimenticare, ma uno strumento vivo per cercare di cogliere un presente sempre più mobile. Comunismo, dice oggi Negri «è appropriarsi della natura e produrre vita», e aggiunge: «Non sono comunisti quelli che invocano la violenza e concepiscono la lotta di classe come guerra, lo sono quelli che trasformano la cooperazione produttiva in contropotere politico». Il comunismo, dice oggi Franco Piperno «è un’attitudine umana che si ritrova ben prima di Marx. Sa conservare le differenze mentre l’uguaglianza è un prodotto della rivoluzione borghese, per cui se tu hai la stessa somma di denaro sei uguale a un altro perché puoi comprare le stesse merci». «Con questo allontanarsi della sinistra dal comunismo, e viceversa, la sinistra è diventata strumento ipocrita di un potere sempre più torvo», dice invece Franco Berardi, detto Bifo fin dagli anni Settanta, che da tempo insegue mete più creative e personali. Li guarda, ormai più perplesso che interessato, il grande vecchio dell’operaismo italiano, quel Mario Tronti che alla fine degli anni Sessanta accese gli animi e spronò gli spiriti con un saggio, "Operai e capitale", carico di concetti forti e di prosa sentimentale. E che oggi, dagli scranni del Senato, vota con rassegnata disciplina tutte le proposte del Pd renziano. Ma anche lui, come tutti gli altri, non ha mancato di essere presente alla "Conferenza sul comunismo", il grande meeting che si è tenuto a Roma nelle settimane scorse, che ha attirato migliaia di giovani attivisti da tutta Europa, dalle Americhe e persino dall’Australia per ascoltare decine di studiosi e teorici. A loro Tronti ha presentato la sua dolente riflessione sulla sconfitta dell’idea comunista, non più capace, a suo parere, di interpretare il presente, perché declinata in modo plurale e non organizzato. «Il comunismo è Lenin. Punto», ha detto pacatamente. Ma forse non si è accorto che da queste parti il comunismo è ormai un concetto quasi pop, dove alla pari con i problemi del lavoro frantumato, del capitale finanziario e dell’eventuale progetto politico vivono molte altre cose, legate ai gusti e alle inclinazioni di ognuno. Non a caso il termine più inflazionato è stato "soggettivazione". Lo hanno capito benissimo invece quanti sono passati dalla sala dei dibattiti alla Galleria Nazionale d’Arte moderna che, sotto il titolo "Sensibile comune", ha ospitato workshop, opere, film, dipinti, performance, discussioni e persino esperienze sensoriali, come quella del vino naturale. Qui anche Pellizza da Volpedo non è più lo stesso, e al posto del "Quarto Stato" con i lavoratori in marcia per i propri diritti, c’è il suo "Prato fiorito", con bambini che giocano in lietezza tra le piante. Qui Franco Piperno si è presentato con la sua "soggettività" di fisico per una lezione di astronomia sulla volta celeste, rivelando, tra l’altro, che a causa dei movimenti terrestri anche il cielo non è più quello di una volta e siamo tutti nati sotto il segno zodiacale precedente a quello dato certo per tradizione. L’accento teorico sul comunismo "sensibile", che ha cominciato ad affacciarsi negli anni Novanta, è imposto peraltro dal fatto che il lavoro posfordista, mobile e non più legato alla ripetitività, porta con sé gusti estetici, tonalità emotive, esperienza di vita. «È impossibile, per esempio, lavorare in call center se non conosci almeno un po’ le modalità retoriche», spiega Virno. Insomma questo inizio di centenario ci mostra una presenza rinnovata o, come dicono i più convinti, una necessità obbligata di comunismo. Se ne parlerà a lungo nel corso di un anno di commemorazioni. Ha già cominciato il settimanale tedesco "Zeit" che dedica la sua ultima copertina a Marx, anche se convinto soltanto in parte che il filosofo di Treviri avesse davvero ragione. Ma di fronte all’evidenza di una classe operaia tedesca precarizzata e atomizzata che ormai vota tutta a destra, le resistenze si piegano alla necessità e il giornale propone di tornare a studiare Marx e ad apprezzarlo come analista ed economista. E questo, dicevamo, è solo l’inizio.
Papà e mamma diventarono comunisti per sete di vendetta, scrive Carola Susani il 12 Febbraio 2017 su "Il Dubbio". Massimo Picchianti nasce comunista, in un villino di ferrovieri a Porta latina, le immagini di Lenin e di Stalin alle pareti. Negli anni Sessanta studia all’università di Mosca e matura il suo distacco dal comunismo, la sua critica verso il Pci e i comunisti italiani. Da quel momento, traduce, scrive articoli, sostiene i dissidenti. Parlare ad alta voce delle oscurità sovietiche, delle opacità dei nostrani sostenitori dell’URSS, diventa la forma stessa della sua vita. Amiamo legare la storia collettiva e la storia di chi la attraversa: per ricordare il 1917, l’anno delle rivoluzioni in Russia che tanto peso avranno nel novecento, da febbraio a ottobre, una volta al mese per nove mesi, racconteremo la sua storia. Quando ci incontriamo, a Parigi in un caffè di fronte a Parc Montsouris (il parco dove anche Lenin andava a passeggiare), Massimo zoppica, scoprirò che zoppica per via di un incidente russo. “Io sto qui, ci sono”, mi spiega, “per via di una catena di avvenimenti. La vita mia è legata alla Russia, se non ci fosse stata la rivoluzione russa di febbraio 1917, se la Russia in guerra non si fosse indebolita liberando i tedeschi dalla necessità di tenere su quel fronte grandi masse, se i tede- schi non avessero mandato truppe sul Carso, vent’anni dopo io non sarei neanche nato”. Non c’è vita che non sia legata a doppia mandata con la storia grande, anche nell’incoscienza di chi la vive, ma in quella di Massimo il legame è sempre in vista, hai l’impressione che lui non smetta di osservarlo. C’è una foto, l’ha scattata Ekaterina Nechaeva, bizantinista e fotografa russa, si chiama Ritratto di romano: Massimo taglia una forma di pane. Il chiaroscuro ne fa una figura monumentale. Per via di quella luce, del taglio di capelli, sembra un antico romano. Nella realtà Massimo è un romano per niente antico, più giocoso, sornione, iroso magari, sopra le righe, provocatorio, mai veramente severo. Parla della rivoluzione russa di febbraio, della speranza nella fine della guerra che accese in tutta Europa, delle sconfitte russe sul fronte. Per i suoi genitori, mi racconta, come per molti, la scelta di diventare comunisti ebbe come incubatore la prima guerra mondiale. “Immersi in quella carneficina, quando ne sono venuti fuori sono diventati comunisti”. Sua madre, Dora, era di Fagarè, una frazione di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, un villaggio, a due passi dal Piave. A Fagarè c’è un ossario con un monumento ai caduti completato nel 1937. La prima guerra mondiale arrivò a Fagaré dopo la rotta di Caporetto. “Mia madre me l’ha raccontato prima di morire, in dialetto stretto di quell’epoca. La sua era una famiglia di piccoli proprietari, avevano un pezzo di terra, ne affittavano un altro perché non bastava. I figli erano quattordici, Dora era la più piccola. Erano anche artigiani: costruivano strumenti da lavoro, giocattoli in legno, li vendevano alle fiere. Era una famiglia molto cattolica, mia madre era molto presa dalla religione. Possedevano dei cavalli. Lei da ragazzina li cavalcava. Ancora dal suo letto d’ospedale, li chiamava per nome. Per come li evocava, quei posti prima della guerra sembravano idilliaci. L’ansa del fiume, l’erba bagnata, i canali dove si immergevano i salici piangenti, gli uccelli migratori che si alzavano in volo. E lei sulle rive: una bambina a cavallo. I nomi dei fiumi nel dialetto di mia madre erano al femminile, il Piave era la Piave. Poi con la guerra, con la propaganda il nome si italianizzò, la Piave diventò maschio. La guerra si combatteva per Trieste. Ma Trieste prima della guerra era un porto pieno di gente che veniva da ogni posto, una città ricca, quasi fantastica per mia madre”. Anche se era in Austria, gli italiani, i regnicoli li chiamavano, ci andavano a lavorare: le ragazze a far le domestiche, i braccianti a costruir strade, ferrovie. Poi nel 1915 con la guerra tutto finì, i regnicoli vennero mandati via. La stella di Trieste si spense.
Dopo Caporetto, nel tardo autunno del 1917, masse di gente disperata arrivano al Piave: sono soldati in fuga dopo la rotta, è la ritirata, sono civili che abbandonano le case e i campi, sono sfollati in un inverno freddissimo. L’anno dopo, nel giugno del 1918 la cosiddetta battaglia del Solstizio investe San Biagio di Callalta. Per Dora si frantuma tutto insieme: l’infanzia, l’immobilità di un’esistenza apparentemente al riparo dalla storia, la fiducia in un Dio buono. Ha sedici anni, e quello che vede non se lo dimentica. “Il ponte era stato fatto saltare, come sempre fanno gli eserciti per bloccare il passo al nemico. Ma lei racconta soprattutto dei cavalli. Avevano portato via i cavalli, li avevano confiscati per mandarli in guerra. Quando c’è stata la battaglia, i cavalli sono morti. C’era una masseria che era stata trasformata in un posto di primo soccorso, mia madre andava lì a dare una mano. Mi raccontava di un medico siciliano che curava tutti, anche gli austriaci, cioè i sudditi dell’impero austroungarico, che poi magari parlavano friulano, tedeschi venivano chiamati”. Il medico siciliano che curava tutti a dispetto della guerra e che odiava quel macello, per Dora è stato una fonte di chiarezza nel buio. “Gli italiani si erano stufati della guerra e si arrendevano facilmente. Si racconta di un ufficiale tedesco portato sulle spalle dai soldati italiani che si erano arresi. Ma chi disertava, chi scappava, veniva ucciso dai suoi. Mia madre è lì che aiuta il medico, probabilmente se ne innamora: lui era uno che diceva che quella guerra era un crimine e criminali quelli che l’avevano voluta. In quella guerra mia madre ha avuto i suoi lutti, ha perso dei fratelli più grandi. Lei spontaneamente arriva a dire: Ma quale dio, non ci può essere nessun dio, se un dio ci fosse sarebbe un criminale pure lui”.
Come molti altri veneti sfollati, anche i Brunello vengono mandati a Sud, i Brunello vengono mandati in provincia di Caserta. “Mia madre si ricordava che i suoi compaesani veneti avevano molti pregiudizi verso i terroni, si sentivano più civili. Quell’Italia di cui si parlava tanto, in fondo neanche esisteva. Lei però non ne viene fuori con una reazione antimeridionale, anzi. L’unica persona a cui pensa con fiducia è un medico siciliano. Rompe con la famiglia perché vuole andare in Sicilia: forse il dottore è tornato lì. Il padre che fino alla fine della guerra ancora la coccolava, ora le dice: Va a remengo. L’esatto contrario di una benedizione: vai ramingo. Vai raminga”. Erano anni in cui si vedevano ragazze spostarsi da sole su e giù per il paese: c’erano quelle che lasciavano la campagna per andare in città alla ricerca di un lavoro, c’erano quelle che lasciavano i paesi alla ricerca di una libertà nuova. “Dora va a Messina. Laggiù però le dicono che il dottore non è più tornato. Di nuovo in Veneto, lo penserà nell’ossario, a Fagarè, fra i sedicimila ignoti. Intanto in Sicilia lo cerca negli ospedali, prova a mettersi sulla sua strada, cerca di diventare infermiera. Quando se ne va dalla Sicilia, si porta dietro i libri della scuola per infermieri che ha frequentato a Messina. Nel 1924 poi va a Roma”.
Dora ha 22 anni. A Roma, nel luglio del 1924 trova lavoro come operaia alla Cisa Viscosa. La scheda di assunzione, scarna (l’ho letta all’Archivio della Snia- Viscosa, salvato da un gruppo di cittadini nel 1995 e oggi riconosciuto di valore storico), riporta il nome, la data di nascita, il domicilio. Quando comincia a lavorare nella fabbrica, la Cisa Viscosa era stata inaugurata da un anno. Ancora oggi ci sono all’angolo fra Prenestina e Portonaccio i capannoni mezzi sfondati di cui si vede lo scheletro. La zona dove approda, il Pigneto- Prenestino, è una zona di depositi ferroviari e tranviari, ancora per metà campagna, dove sorgono industrie chimiche, chimico farmaceutiche. È la prima periferia al di là delle mura, approdo per gli immigrati. Alla Viscosa si trasformano lastre di cellulosa in seta artificiale, in rajon. Quell’anno, nel 1924, a dicembre, ci sarà uno sciopero durissimo per il salario. “Nel 1928 mia madre poi lavorerà alla Serono”. È uno stabilimento poco lontano, l’Istituto Farmaceutico Serono, fondato all’inizio del secolo, nel 1906. In quegli anni in cui nel quartiere sorgevano casette, dovevano sembrare minute e fatte di niente in confronto della Serono. Il complesso di edifici in cui va a vivere Dora, invece, è stato appena costruito ed è imponente e solido. “La sorella di mio padre, Enrichetta, aveva sposato un grande invalido amico di mio padre, Sandro. Uno che era saltato su una mina proprio negli ultimi giorni della guerra, con la presa di Trieste. Enrichetta e Sandro abitavano in una grande casa a via L’Aquila. Affittavano una stanza, e mia madre la prese”. Quel complesso, fra via L’Aquila e la Prenestina (leggo su Roma mosaico urbano. Il Pigneto fuori Porta Maggiore di Carmelo G. Severino) era stato costruito dalla cooperativa “Ciechi, invalidi di guerra”, belle case che ci sono ancora, con un cortile alberato. “Lì”, Massimo racconta, “mia madre ha conosciuto mio padre, Roberto. Mio zio Sandro, l’invalido era arrabbiatissimo con quelli che avevano voluto la guerra. Era restato invalido combattendo per Trieste: nel secondo dopoguerra, malgrado le foibe, quando Tito reclamerà la città, Sandro gliela avrebbe lasciata volentieri. Però dopo la rottura di Stalin con Tito anche Sandro si adeguerà e la reclamerà. Anche mio padre ce l’aveva contro la guerra”. Quando Dora e Roberto si incontrano Roberto è già comunista. “Mio padre con i suoi abitava a San Lorenzo, erano ferrovieri fiorentini”. San Lorenzo, fra la stazione Termini e la stazione Tiburtina è un quartiere popolare, con una presenza elevata di ferrovieri.
“Nel ‘17 c’era stata la rivoluzione russa. Quella di febbraio, il capo del governo rivoluzionario, Kerenskij aveva dichiarato: la guerra continua. Ma i russi sul fronte si erano indeboliti. I tedeschi decidono di approfittare della rivoluzione per mettere fuori gioco i russi”. Finanziato dai tedeschi, Lenin arriva con il treno speciale, raggiunge Pietroburgo. “Viene accolto dalla rivolta di marinai, di soldati che avevano iniziato la rivoluzione. Solo che questi che non erano i figli degli operai ma i figli dei contadini, guardavano con simpatia verso i socialisti rivoluzionari, che promettevano la terra. Lenin si allea con i socialisti rivoluzionari di sinistra, lui li chiamava compagni di strada (ma già meditava di liquidarli, tra le vittime dei bolscevichi ci saranno molti protagonisti dell’ottobre, come i marinai di Kronstadt). ‘ Pace terra libertà’ era il vecchio slogan dei socialisti rivoluzionari e prima ancora dei populisti. Mio padre guarda a questo Lenin come uno che vendicherà i morti, gli sfregiati, gli invalidi. Lo fa anche in contrasto con suo padre sindacalista socialista che diceva: uccidere intere famiglie come quella dei Romanov non ha niente a che vedere con la giustizia sociale. (Lo puoi trovare, mio nonno, Picchianti Enrico, nel Casellario politico centrale). Per mio padre, per mio zio Sandro, Lenin è prima di tutto quello che si oppone alla guerra. Mia madre che già aveva maturato dalla sua esperienza della guerra un orientamento ribellista non inquadrato quando incontra mio padre comincia a sperare anche lei nel comunismo. È stata l’esperienza straziante della guerra, i morti, la sensazione che per i potenti le vite loro non valessero i soldi del telegramma che ne annunciava il decesso, a spingerli verso quella speranza, verso il comunismo; è stata sete di vendetta. Mia madre poi ne aveva visti tanti mutilati e morti”. Nel 1937 Dora e Roberto si sposano e si trasferiscono in un villino di ferrovieri a Porta Latina. Massimo nascerà neanche un anno dopo, a gennaio del 1938.
La Rivoluzione d'ottobre fu il colpo di Stato di un'élite, che esordì chiudendo l'Assemblea costituente..., scrive Giampietro Berti, Domenica 5/02/2017, su "Il Giornale". Ricorre quest'anno il centenario della rivoluzione russa, uno degli avvenimenti più importanti del XX secolo. È quasi universalmente accreditata l'idea che si sia trattato in sostanza di un unico processo storico iniziato nel febbraio e conclusosi in ottobre. Niente di più falso, perché nel 1917 vi furono due rivoluzioni, quella liberale di febbraio e quella bolscevica di ottobre: due moti diversi, per non dire opposti, dato che la prima liberò la Russia dall'assolutismo, la seconda la portò al totalitarismo. Certo, tra i due eventi non vi fu di fatto soluzione di continuità, ma la loro natura segna un dualismo non sintetizzabile in un unico giudizio storico. Va detto subito che il rivolgimento del '17 avvenne a causa dall'implosione dello zarismo, consuntosi al suo interno. Tre anni di guerra avevano dissanguato il Paese, riducendo milioni di persone alla fame e allo stremo delle forze. L'ostinazione del governo nel volere continuare il conflitto, la sua ripetuta sordità a ogni richiesta di mitigare le condizioni disumane della popolazione e la sua incapacità nel far fronte ai più elementari bisogni sociali delegittimarono non solo la sua autorità politico-morale, ma anche quella sacro-imperiale dello zar. Perciò è del tutto ragionevole pensare che se non vi fosse stata la guerra, la rivoluzione non vi sarebbe stata. Va aggiunto che la società russa - da sempre dominata dai ceti piccolo- borghesi - era allora composta da circa 140 milioni di individui, di cui oltre cento erano contadini. Molti di questi non sapevano bene cosa stesse accadendo. La stragrande maggioranza della popolazione era ben lungi dal pensare e dal volere una trasformazione radicale dell'esistente, anche se, allo stesso tempo, il suo sostegno al potere costituito era per molti versi venuto meno. Tra il 23 e il 27 febbraio (secondo il calendario giuliano, 8-12 marzo per quello gregoriano) una sollevazione di popolo, in gran parte spontanea, provocò l'abdicazione dell'imperatore Nicola II, la fine della dinastia dei Romanov e dell'autocrazia. Il 23 febbraio ebbero inizio cruente manifestazioni di protesta a Pietrogrado, estesesi poi a Mosca e in altre località, che coinvolsero decine di migliaia di persone. Nel giro di pochi giorni il moto divenne inarrestabile, anche perché molti reparti dell'esercito, inviati per reprimere i disordini, fraternizzarono con la popolazione. Si formò un nuovo governo che varò alcune importanti misure, quali l'amnistia per i reati politici e religiosi; la libertà di parola, di stampa, di associazione, di riunione e di sciopero; l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza limitazione di condizione, di religione e di nazionalità; l'abolizione della polizia segreta; i diritti civili garantiti ai militari compatibilmente con il servizio prestato. Soprattutto fu decisa la cosa più importante, cioè la convocazione di un'Assemblea costituente da eleggersi a suffragio universale, mentre rimase sospesa la questione del futuro assetto istituzionale. Erano tutte decisioni politiche di carattere democratico-liberale che portavano definitivamente la Russia, sia pure con grave ritardo e sotto l'incalzare di eventi drammatici, all'abbandono di ogni retaggio feudale, inserendola nel novero dei regimi costituzionali. Due furono gli errori gravissimi fatti dai due governi provvisori, il primo presieduto da L'vov, il secondo da Kerenskij: non avere avviato l'ormai improcrastinabile riforma agraria e, ancor più, avere deciso per la prosecuzione della guerra. Fu soprattutto quest'ultima decisione che diede a Lenin e ai bolscevichi un grande vantaggio politico e morale. La loro parola d'ordine di un ritiro immediato dal conflitto li accreditò favorevolmente presso l'opinione pubblica, anche se siamo ben lungi dal registrare un vero consenso popolare alla loro azione e ai loro programmi. Nel 1917 in tutta la Russia i seguaci di Lenin risultavano 23.600 - totale degli iscritti al partito - a fronte del numero complessivo degli abitanti nel Paese: come abbiamo detto, 140 milioni circa. La rivoluzione d'ottobre è la conferma del fallimento scientifico del marxismo. Marx aveva previsto che la rivoluzione sarebbe scoppiata nei Paesi ad alto sviluppo capitalistico, dove esisteva una classe operaia di gran lunga maggioritaria, mentre in tutta la Russia gli operai non raggiungevano la quota di tre milioni, vale a dire che non superavano il 2,5% dell'intera popolazione (ma si tenga conto che molti erano contadini impiegati stagionalmente nell'edilizia e nella costruzione o nella manutenzione delle ferrovie). A Pietrogrado, la città dove i bolscevichi diedero inizio alla loro presa del potere, non erano più del 5% di tutti i lavoratori industriali, numero, a sua volta, del tutto insignificante rispetto a una popolazione complessiva di due milioni di persone. Attuata tra il 24 e il 25 ottobre (7-8 novembre) la rivoluzione bolscevica non ebbe pressoché alcun carattere cruento e fu il frutto di circostanze altamente fortuite. Occupate le installazioni chiave della capitale, l'ufficio delle poste e del telegrafo, l'ufficio centrale dei telefoni, il quartier generale del comando militare del governo, i bolscevichi assaltarono il Palazzo d'inverno. L'intera guarnigione dei soldati avente sede nel palazzo Mihajlovskij si arrese senza colpo ferire: gli effetti devastanti del conflitto bellico avevano pressoché distrutto la struttura militare-poliziesca dello Stato, incapace ormai di rispondere ai comandi della sua classe dirigente, dispersa e disorientata. Ha ripetutamente scritto Trotsky che a dare seguito a questa azione furono circa 25mila militanti bolscevichi. Sono dunque stati questi 25mila rivoluzionari a decidere come doveva essere la Russia per tutti i 140 milioni di russi. La rivoluzione d'ottobre non fu una rivoluzione di popolo, ma l'esito fortunato del colpo di mano di un piccolo partito, privo di un vero consenso popolare. Del resto, la prova più evidente è offerta dalla significativa vicenda dell'Assemblea costituente, la sola istituzione potenzialmente democratica allora esistente. È noto che il risultato elettorale, maturato il 12 novembre, quindi dopo il colpo di mano comunista, confermò in modo inequivocabile il carattere minoritario del bolscevismo, avendo questo ottenuto il 24,7% dei consensi. A tale proposito è bene precisare che chi allora votò per i bolscevichi era ben lungi dall'avere l'esatta conoscenza di quanto gli stessi bolscevichi avevano realmente intenzione di fare una volta giunti al potere. Ciò che allora si conosceva del loro programma non era certo ciò che fu posto in atto più tardi. Riunitasi per la prima volta il 18 gennaio 1918, l'Assemblea fu subito chiusa (lo stesso giorno!) - e mai più riaperta - per volontà di Lenin e compagni. Così, dopo secoli di schiavitù dell'assolutismo zarista si passò, quasi senza soluzione di continuità, alla schiavitù del totalitarismo comunista.
CROLLA LA GRANDE TRUFFA DELLA SINISTRA. Zero Hedge rilancia un’analisi marxista di Charles Hugh Smith che condanna senza appello la “sinistra”. Questa, limitandosi alla sola difesa dei diritti delle minoranze e salutando la globalizzazione come un’opportunità per tutti, ha completamente tradito il suo compito storico di contrapporre gli interessi del lavoro a quelli del capitale. Oggi tutte le istituzioni, la politica e le strutture pubbliche, lungi dall’essere state abolite dal capitale, che in realtà dello Stato ha bisogno, sono state volte a suo vantaggio. Ma la classe lavoratrice sembra sul punto di risvegliarsi e di accorgersi del tradimento. Scrive Charles Hugh-Smith dal blog Of Two Minds, il 23 gennaio 2017 così come riportato da Henry Tough il 24 gennaio 2017 su “Voci dall’estero”. La sinistra non è solo allo sbando – è al completo collasso perché la classe operaia si è accorta del tradimento della sinistra e del suo abbandono della classe operaia per costruire ricchezza personale e potere. La fonte dell’angoscia rabbiosa che scuote il campo progressista del Partito Democratico non è il Presidente Trump – è il completo collasso della sinistra a livello globale. Per capire questo crollo, dobbiamo rivolgerci (ancora una volta) alla comprensione profonda che Marx aveva dello Stato e del capitalismo. Non stiamo parlando del marxismo culturale che gli americani conoscono a livello superficiale, ma del nocciolo della sua analisi economica che, come notava Sartre, viene insegnata al solo fine di screditarla. Il marxismo culturale attinge anch’esso da Engels e Marx. Nell’uso moderno, il marxismo culturale indica l’aperto scardinamento dei valori tradizionali – la famiglia, la comunità, la fede religiosa, i diritti di proprietà e un governo centrale limitato – in favore di un cosmopolitismo senza radici e uno Stato centrale espansivo e onnipotente che sostituisce la comunità, la fede e i diritti di proprietà con meccanismi di controllo statalista che impongono la dipendenza dallo Stato stesso, e una mentalità secondo la quale l’individuo è colpevole di pensiero anti-statalista fino a prova contraria, determinata dalle regole dello Stato stesso. La critica di Marx al capitalismo è di natura economica: il capitale e il lavoro sono in eterno conflitto. Nell’analisi di Marx il capitale ha la meglio fino a che le contraddizioni interne del capitalismo non erodono dall’interno le sue capacità di controllo. Il capitale non domina solo il lavoro; domina anche lo Stato. Perciò la versione “statale” del capitalismo che domina a livello globale non è una coincidenza o un’anomalia – è l’unico esito possibile di un sistema nel quale il capitale è la forza dominante. Per contrastare il dominio del capitale sono sorti i movimenti politici socialdemocratici, per strappare alcune misure dalle mani del capitale e volgerle in favore del lavoro. I movimenti socialdemocratici sono stati ampiamente aiutati dal “quasi crollo” della prima versione del capitalismo statale [cartel capitalism] durante la Grande Depressione, quando la cancellazione del debito deteriorato avrebbe comportato la distruzione dell’intero sistema bancario e azzoppato la funzione principale del capitalismo, quella di far crescere il capitale stesso tramite un’espansione del debito. I padroni del capitale, decimati, capirono di avere un’unica scelta: resistere fino ad essere rovesciati dall’anarchismo o dal comunismo, oppure cedere un po’ della loro ricchezza e del loro potere ai partiti socialdemocratici in cambio di stabilità sociale, politica ed economica. In termini generali si direbbe che la sinistra favorisce il lavoro (i cui diritti sono protetti dallo Stato) mentre la destra favorisce il capitale (i cui diritti sono ugualmente protetti dallo Stato). Ma nel corso degli ultimi 25 anni di neoliberalismo globalizzato, i movimenti socialdemocratici hanno abbandonato il lavoro per abbracciare la ricchezza e il potere che gli venivano offerti dal capitale. L’essenza della globalizzazione è questa: il lavoro viene mercificato mentre il capitale mobile è libero di girare in qualsiasi angolo del mondo per cercare il costo del lavoro minore possibile. Al contrario del capitale, il lavoro è molto meno mobile, non è in grado di spostarsi fluidamente e senza frizioni come fa il capitale, alla ricerca di opportunità e di scarsità da sfruttare a proprio vantaggio. Il neoliberalismo – l’apertura dei mercati e delle frontiere – permette al capitale di schiacciare il lavoro senza alcuno sforzo. I socialdemocratici, nel momento in cui abbracciano l’idea dei “confini aperti”, istituzionalizzano l’apertura all’immigrazione; questa disintegra il valore della forza lavoro dato dalla sua scarsità sul mercato interno, e permette di abbassarne il prezzo grazie al lavoro degli immigrati, a tutto vantaggio del desiderio del capitale di abbattere i costi. La globalizzazione, la finanza neoliberale e le politiche di immigrazione determinano il crollo della sinistra e la vittoria del capitale. Ora è il capitale a dominare totalmente lo Stato e le sue strutture clientelari – i partiti politici, le lobby, i contributi alle campagne elettorali, le fondazioni di beneficienza che operano a pagamento, e tutte le altre strutture del capitalismo di Stato. Per nascondere il crollo della difesa economica del lavoro da parte della sinistra, i sostenitori della sinistra e la macchina delle pubbliche relazioni hanno sostituito i movimenti per la giustizia sociale alle lotte per acquisire sicurezza economica e capitale. Questo è riuscito alla perfezione, e decine di milioni di autoproclamati “progressisti” si sono bevuti la Grande Truffa della sinistra, secondo la quale le campagne di “giustizia sociale” in nome di gruppi sociali emarginati sarebbero la vera caratteristica distintiva dei movimenti progressisti e socialdemocratici. Questo giochetto da prestigiatore, questo abbraccio delle campagne per la “giustizia sociale” economicamente neutre, ha mascherato il fatto che i partiti socialdemocratici avevano intanto gettato il lavoro nel tritacarne della globalizzazione, dell’apertura all’immigrazione e della libera circolazione del capitale, che intanto era tutto contento dell’abbandono del lavoro da parte della sinistra. Nel frattempo i furboni della sinistra si sono ingozzati delle concessioni elargite dal capitale in cambio del loro tradimento. Vengono in mente i “guadagni” di Bill e Hillary Clinton per 200 milioni di dollari, e innumerevoli altri esempi di arricchimenti personali da parte di autoproclamati “difensori” del lavoro. Guardate il grafico seguente. Rappresenta la quota di PIL destinata al lavoro. Ora ditemi se la sinistra non ha abbandonato il lavoro in nome della propria ricchezza e potere personale. La sinistra non è solo allo sbando – è al crollo totale – ora che la classe lavoratrice si è svegliata e si è resa conto del tradimento e dell’abbandono da parte di chi si è occupato solo del proprio interesse personale. Chiunque lo neghi non si è ancora reso conto della Grande Truffa della Sinistra.
Inutile negarlo, la sinistra è finita, scrive Alfonso Maurizio Iacono il 4 gennaio 2017 su "Malgrado tutto". L’unico obiettivo che oggi, qualunque cosa se ne voglia pensare, appare sicuramente di sinistra è la proposta dei 5stelle del reddito di cittadinanza. Ma i 5stelle mescolano questa proposta con altre che, dal punto di vista di un’ipotetica sinistra, lasciano piuttosto perplessi. Tanti anni fa un grande storico, Arnaldo Momigliano, ebbe ad annunciare davanti a un congresso internazionale di filologi classici che di sicuro l’Impero Romano era caduto, questo era certo, ma quanto a sapere il tempo della sua caduta, allora la cosa si faceva difficile e incerta. A scuola si impara che il 476 dopo Cristo è la data cardine di questa caduta, ma se in una intervista impossibile si fosse chiesto ai romani di quell’anno se stavano cadendo, se erano decaduti, se stavano precipitando insieme alle macerie del crollo, sarebbero sicuramente rimasti stupefatti e avrebbero risposto che erano Romani e la loro storia non stava finendo affatto. Oggi, nell’anno di grazia 2017, la sinistra è crollata. Da quando, è difficile da stabilire, e se lo si chiedesse agli attuali politici che si dichiarano più o meno di sinistra, a cominciare da quelli del PD, si mostrerebbero incerti, forse dubbiosi, certamente in crisi, probabilmente in malafede, ma nessuno o quasi ammetterebbe la fine. Certo, qualcuno parlerebbe del fatto che ormai destra e sinistra sono categorie antiquate, qualcun altro direbbe che sì è in crisi ma non certamente finita, ma come i Romani del 476 dopo Cristo starebbero ancora lì a rosicchiarsi le ultime briciole di vecchi privilegi in nome di valori ritenuti eterni ma a cui non credono più. La sinistra è finita. Perfino nelle parole. Se esse talvolta (non sempre) corrispondono alle cose, l’attuale PD, sì, questo al governo, dopo la fine della Prima Repubblica si chiamava Partito Democratico di Sinistra, poi si chiamò Democratici di Sinistra, ora è Partito Democratico, una bizzarra sintesi più o meno annacquata e stinta dei vecchi PCI, PSI e DC. A sparire è la parola Sinistra. In nome di qualcosa di nuovo? Il fatto stesso che il nome sia diventato sempre meno specifico e sempre più generico tradisce sicuramente la fine di un fine. Ma, al di là del nome, quando la sinistra si sposa con la logica del profitto e della speculazione e con il crescere delle diseguaglianze, quando accetta il dominio incontrastato del privato sul pubblico con la scusa che il pubblico fa schifo, magari cercando timidamente e falsamente di indignarsi come uno che rispondesse semplicemente e debolmente con l’esclamazione: “Per Giove” a un pugno sferratogli in faccia e lo facesse per viltà e per convenienza, allora è finita. Lo è con Hilary Clinton come con Tsipras, per non parlare di Holland o di Renzi. C’era una cosa che caratterizzava le sinistre nelle loro diverse propensioni e manifestazioni, la critica e la lotta alle diseguaglianze. Risulta a qualcuno che quella critica e quella lotta siano ancora attuali? Eppure le diseguaglianze sono aumentate in tutte le forme, tra nazioni e paesi, tra cittadini e cittadini, tra cittadini e stranieri, tra persone e non persone, tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. L’unico obiettivo che oggi, qualunque cosa se ne voglia pensare, appare sicuramente di sinistra è la proposta dei 5stelle del reddito di cittadinanza. Ma i 5stelle mescolano questa proposta con altre che, dal punto di vista di un’ipotetica sinistra, lasciano piuttosto perplessi. Ma come mai quelli che si dichiarano ufficialmente di sinistra non ne discutono? Paura di disturbare i potenti che li proteggono? Inutile negarlo, la sinistra è finita. Prenderne coscienza sarà un bene perché rinasca. Ed è questo il mio augurio per l’anno nuovo. Non so come né quando, ma di una cosa sono sicuro. In mancanza di una sinistra degna di questo nome, la stessa democrazia è in pericolo e muta di forma e lo si vede con il crescere delle diseguaglianze, il dilagare del razzismo e l’avanzare di leader inquietanti che si affermano e dominano al di qua e al di là dell’Europa, ma anche nel suo seno.
La sinistra è in crisi e l'Europa svolta a destra. Per capire il futuro dell’Europa si deve guardare alla Francia dove la sfida per l’Eliseo tra Le Pen e Fillon potrebbe dare il colpo definitivo a quel che rimane delle forze progressiste, scrive Bernard Guetta il 12 gennaio 2017 su "L'Espresso". Lasciate perdere la tradizione: dite quello che vi pare alla sinistra francese ma soprattutto, innanzitutto, non auguratele buon anno. Se lo faceste, in tale augurio essa leggerebbe soltanto beffarda ironia e crudeltà, nel migliore dei casi qualcosa di derisorio perché di fatto ha già messo una croce sul 2017, l’annus horribilis nel quale i suoi scompigli e le sue divisioni interne le riservano una primavera di sconfitte, alle presidenziali e alle legislative. A ben guardare, potreste anche individuare tre socialisti che ci credono ancora e potrebbero spiegarvi che, in fondo, non è detto che vada proprio così, tenuto conto che gli elettori occidentali ormai provano un piacere sottile a contraddire i sondaggi, vedi Trump. La Francia, vi diranno, non vorrà saperne di scegliere tra il Front National di Marine Le Pen e quell’amico di Vladimir Putin, il grande favorito degli ambienti cattolici più integralisti, che è François Fillon, il candidato della destra. Del resto, non siamo del tutto lontani dalla verità, perché desiderio dei francesi sarebbe stato quello di vedere candidato alla presidenza Alain Juppé, uomo moderato e riflessivo, aperto, filoeuropeo e ultima incarnazione di quella destra gollista che, come De Gaulle, teneva un piede a sinistra e l’altro a destra. Al secondo turno delle presidenziali, Juppé avrebbe inflitto una batosta a Marine Le Pen raccogliendo i consensi degli elettori di destra, di sinistra e del centro. Così avrebbero dovuto andare le cose, e invece alle loro primarie i militanti di destra non ne hanno voluto sapere di questo ex Primo ministro che assomiglia loro così poco, troppo moderato ma non abbastanza liberale e troppo ostile all’abolizione delle tutele sociali. Gli hanno preferito Fillon, più reazionario e più euroscettico, più incarnazione ideale del notaio di provincia, più liberale. Ormai il dado è tratto. Adesso, non soltanto la Francia dovrà scegliere tra la destra dura e pura e l’estrema destra, ma oltre a ciò il risultato del 7 maggio non è nemmeno del tutto sicuro. Sì, avete letto bene: non è più del tutto inverosimile che Marine Le Pen riesca ad avere la meglio perché, avendo come avversario François Fillon, si presenterà nelle vesti di portavoce degli esclusi della globalizzazione, e molti elettori di sinistra non vorranno dare i loro voti a un Thatcher francese nemmeno per mettere i bastoni tra le ruote all’estrema destra. L’astensione della sinistra rischia dunque di regalare l’Eliseo al Front National. Ma come? Nemmeno un pericolo simile indurrebbe la sinistra a serrare i ranghi? Prima la Brexit, poi Trump e infine Le Pen? Davvero la sinistra francese lascerebbe correre, restando immobile, incapace di scuotersi, di trascendere sé stessa, di trovare un candidato in grado una volta per tutte di ribaltare una situazione così allarmante? Restano quattro mesi al primo turno delle presidenziali, ancora molto tempo. Parecchie cose potranno cambiare da qui ad allora, ma già dalla prima settimana dopo quest’ultima linea assunta dalla destra le cose si sono messe male. È tutta questione di aritmetica. La sinistra ha nove candidati. Il 22 e il 29 gennaio sette di loro prenderanno parte alle primarie della Belle alliance populaire, vale a dire il PS e i suoi alleati. François Hollande, troppo impopolare per ripresentarsi, non vi parteciperà e la battaglia divamperà quindi tra il Primo ministro uscente Manuel Valls, uomo d’ordine e di grande rigore economico, i due rivali della sinistra socialista Benoît Hamon e Arnaud Montebourg, l’intellettuale della mischia Vincent Peillon, filosofo ed ex ministro dell’Istruzione, e gli outsider ambientalisti e radicali di sinistra. Il vincitore - inequivocabile, esperto, dinamico - dovrebbe essere Valls, ma è inevitabile che i tre dibattiti che precederanno questo primo turno riservino sorprese e può anche darsi che a vincere sia Hamon o Montebourg o Peillon, ovvero uno degli outsider, tenuto conto che prima dei dibattiti della destra nemmeno Fillon era stato preso sul serio. L’asso nella manica di Valls consiste nel fatto di poter essere un candidato di sinistra che la destra moderata potrebbe preferire a Marine Le Pen al secondo turno elettorale. Quello di Hamon e di Montebourg è di essersi dimessi dal governo non appena François Hollande ha dirottato la sua politica verso destra, esasperando la base socialista con la concessione di aiuti massicci all’industria. Peillon ha dalla sua il vantaggio di poter proporre una sintesi tra la destra e la sinistra socialiste. Quanto agli outsider, il loro asso nella manica è di essere pressoché sconosciuti, perfino ai militanti, e di poter dunque offrire agli elettori l’occasione di trasformare gli ultimi in primi. L’unica certezza è che il 29 sera non resteranno che tre candidati di sinistra: quello della Belle alliance e i due che si sono rifiutati di prendere parte alle primarie, Emmanuel Macron e Jean-Luc Mélenchon. Macron è un politico in rapida ascesa in Francia, giovane ministro di bella presenza nel quale possono riconoscersi la destra e la sinistra, giovani e anziani, la provincia e Parigi. Ha studiato dai gesuiti, è stato membro del PS dal quale è uscito l’estate scorsa per fondare un suo movimento, En marche, che conta già oltre centomila affiliati. Non ha ancora 40 anni, ha sposato una delle sue ex professoresse, figlia di produttori di cioccolato, di 25 anni più grande di lui. Cresciuto ad Amiens, quintessenza della provincia borghese, è però un puro prodotto delle Grandes Écoles, è passato dalla banca Rothschild alla segreteria generale dell’Eliseo e quindi al ministero dell’Economia e delle Finanze. Promotore di una legge che snellisce il Codice del Lavoro, è adorato dai grandi proprietari d’azienda, ma ancor più dai giovani imprenditori con i quali parla correntemente di digitale e di nuova rivoluzione industriale. Ancora acerbo, con minore esperienza ma nettamente più affascinante e altrettanto filoeuropeo, Macron è la versione giovanile di Juppé della sinistra, ma con tutto ciò che egli rappresenta è in rottura con l’insieme della classe politica le cui azioni sono al minimo storico. In Francia come dappertutto. Mélenchon è il suo esatto contrario. Ex trotskista oggi 65enne, Mélenchon è stato un veterano del PS dal quale è uscito sbattendo la porta per portare a termine con successo una sorta di offerta pubblica d’acquisto del PC e della sinistra più a sinistra. È un oratore del XIX secolo, sfavillante, hugoliano, intriso di cultura francese e di storia del movimento operaio, e gli piace fare a pezzi la stampa, Bruxelles, l’imperialismo americano e tutti i partiti. È un uomo che sui suoi meeting sa far soffiare il vento del Grand Soir, l’idea di un’onda rivoluzionaria. Ciò nonostante, egli non è rivoluzionario. Molto più moderato di quanto appaia, è un socialdemocratico ma, a differenza dei socialisti francesi e dei socialdemocratici tedeschi e scandinavi, è imbevuto di una giusta collera nei confronti dell’ingiustizia e resta fedele alle radici operaie della sinistra europea. La sfida di Macron consisterà nel far vincere la sinistra federando i moderati tanto dei progressisti quanto dei conservatori, sconfiggendo François Fillon al primo turno e sbaragliando Marine Le Pen al secondo. Qualora non ci riuscisse, Mélenchon potrebbe ottenere in ogni caso un buon risultato che gli consenta di ricostituire, all’opposizione, una sinistra vicina alle nuove sinistre di Spagna e Grecia, Podemos e Syriza. Per il momento, però, la sinistra francese è perdente, ai margini, come del resto tutte le sinistre in Europa. Divisa tra la Belle Alliance, Macron e Mélenchon che raggiungono il 15 per cento delle intenzioni di voto, la sinistra non potrà che perdere al primo turno e lasciare che destra ed estrema destra si disputino la presidenza. Perché? Che sta succedendo alla sinistra, e non soltanto in Francia ma ovunque? La risposta è che il rapporto di forze tra capitale e lavoro si è capovolto quasi del tutto dagli anni Ottanta a oggi. Nel dopoguerra, la situazione era favorevole alla sinistra. La ricostruzione assicurava la piena occupazione. La minaccia sovietica e la potenza dei partiti comunisti europei avevano il loro peso sullo scacchiere politico. Ogni cosa induceva governi e proprietari d’azienda a concessioni sociali. Ogni sciopero o quasi si concludeva con nuovi aumenti salariali, nuove estensioni delle tutele garantite a operai e subordinati. Il dopoguerra è stato l’epoca d’oro della sinistra ma, una volta giunta a termine la ricostruzione, ha risuscitato la disoccupazione; il crollo sovietico ha affrancato il capitale dalla paura delle rivoluzioni; la riduzione delle distanze ha permesso al capitale di delocalizzare la produzione in paesi dai salari irrisori e dalle tutele inesistenti, e l’ascesa delle nuove potenze industriali ha condannato il settore pubblico e quello privato a ridurre drasticamente i costi salariali a fronte di una concorrenza di giorno in giorno più aggressiva. Non soltanto adesso l’industria non è più a corto di manodopera e non teme più il Comunismo, ma oltre a ciò, cascasse il mondo, deve abbassare i prezzi dei costi occidentali. Il rapporto di forze avvantaggia ormai il capitale che può fare spallucce con noncuranza davanti alle regolamentazioni sociali dei vecchi paesi industriali, perché può sempre sottrarsi a esse investendo nei paesi emergenti. Di conseguenza, gli Stati nazione non possono più trovare un punto d’accordo tra gli interessi dei lavoratori e del capitale, perché l’imperativo assoluto è mantenere l’occupazione all’interno delle loro frontiere, per ridurre la disoccupazione e i deficit di bilancio. La sinistra, in parole povere, non è più in grado di imporre il progresso e i compromessi sociali che erano la sua stessa ragion d’essere e le attiravano i voti dei salariati. La sinistra non ha tradito. È disarmata e lo sarà a lungo, perché non può invitare i suoi elettori a guardare i nuovi rapporti di forza che si sono venuti a creare senza confessare nel contempo la propria impotenza, e perché continua a indebolirsi sempre più, di elezione in elezione, visto che le soluzioni che le si prospettano - e ce ne sono - sono in ogni caso lontane o difficili da difendere. Una delle soluzioni è l’Europa. Uniti, gli Stati europei potrebbero ritrovare il loro ruolo di arbitri, perché l’ascesa di una potenza pubblica di dimensione continentale potrebbe imporre al capitale di negoziare un nuovo compromesso sociale e agli altri Stati-continente le condizioni di transazioni commerciali eque e reciprocamente vantaggiose. Unite da un potere esecutivo e da un potere legislativo comuni, le nazioni e le sinistre europee potrebbero realizzare ciò che oggi non sono in grado di fare. Peccato che l’unità dell’Europa di questi tempi non sia più un’ambizione in grado di appassionare e coinvolgere, e che in ogni caso non lo sia nelle corse elettorali. Assimilata alle politiche di risanamento di bilancio, l’Unione è diventata impopolare, è percepita alla stregua del cavallo di Troia della globalizzazione, e la sinistra incontra dunque difficoltà sia a perorarne il rafforzamento sia a dire ai salariati che ormai pensioni e assicurazioni malattia devono essere finanziate dalle imposte e non più dagli oneri sociali delle imprese. Proprio quando le entrate dei proprietari d’azienda e l’evasione fiscale delle grandi imprese sfiorano livelli osceni mai raggiunti in precedenza, la sinistra non può annunciare ai suoi elettori che, contrariamente alle industrie pesanti di ieri, le industrie innovative contemporanee - quelle dedite alla ricerca e alle tecnologie del futuro, quelle del nostro comune avvenire - non hanno ancora le spalle sufficientemente solide per garantire il perpetuarsi del modello sociale europeo. A meno di precipitare al medesimo livello di rifiuto di François Hollande – che negli ultimi tempi egli si è arrischiato ad avere, bruscamente e inspiegabilmente -, la sinistra non potrà invocare dall’oggi al domani la necessità di aiutare l’industria per salvaguardare le tutele sociali. La sinistra, francese ed europea, è dunque a un punto morto. Potrà riprendersi e uscirne soltanto attingendo a uno stesso tempo a Macron e a Mélenchon, all’indignazione dell’uno e alla volontà dell’altro di superare le frontiere del passato e riunire sotto un’unica bandiera tutti i sostenitori del compromesso sociale, tutti i fautori di un nuovo compromesso per un nuovo secolo. Impossibile? No, soltanto difficile. Siamo ancora lontani da quel traguardo ma - se non vogliamo essere costretti a scegliere tra thatcherismo e nazionalismo, tra destra dura e pura ed estrema destra, tra violenza sociale e insolvenza dei nostri paesi - sarà indispensabile passare proprio da lì e ricominciare a parlare alla sinistra per reinventarla, partire dalla realtà per trasformarla, riportare in auge l’utopia e rimettere l’immaginazione al potere.
Pd, la nuova carica dei 102: tutti gli indagati, regione per regione. Sindaci, governatori, consiglieri ed esponenti del partito sul territorio: ecco perché Renzi ora attacca i pm, scrive "Il Fatto Quotidiano" il 3 maggio 2016. “Questione morale”. Sui blog degli elettori Pd quelle due parole pronunciate da Enrico Berlinguer nel 1981 tornano frequenti. Insieme con le polemiche sulle inchieste che toccano esponenti dem. Un’espressione che torna di attualità con la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Lodi, Simone Uggetti.
PIEMONTE. Gli ultimi a finire a processo sono stati il sindaco di Vercelli Maura Forte e il consigliere regionale Giovanni Corgnati. Sono accusati di aver falsificato firme per le candidature alle Provinciali del 2011. Oggi finirà davanti al tribunale vercellese Davide Sandalo, ex presidente del Consiglio comunale di Casale Monferrato (Alessandria), sottoposto ai domiciliari il 3 dicembre scorso con l’accusa di concussione per induzione. Molti politici sono incappati in indagini su irregolarità alle elezioni. Per uscirne, non pochi patteggiano. Lo hanno fatto i politici di Verbania per accuse di irregolarità alle amministrative 2014 contestate anche all’ex vicesindaco Giuseppe Grieco e l’ex presidente del Consiglio comunale Diego Brignoli. Patteggiamenti anche nella vicenda delle firme false a sostegno della candidatura di Sergio Chiamparino alle regionali del 2014: il 2 marzo a Torino 9 tra funzionari ed eletti hanno ottenuto pene tra i cinque mesi e un anno. Tra di loro il consigliere regionale Daniele Valle, che ha patteggiato sei mesi. Andrà a dibattimento Rocco Fiorio, presidente della V circoscrizione di Torino, coinvolto anche nell’inchiesta sulle “giunte fantasma” insieme ad altri 9 eletti, tra cui la deputata Pd Paola Bragantini, indagata per truffa aggravata. Sul suo compagno Andrea Stara pesa una richiesta di condanna a tre anni per peculato nell’ambito dei rimborsi regionali. I pm lo indagheranno anche per aver calunniato la sua ex segretaria, su cui aveva scaricato la colpa dei rimborsi.
LOMBARDIA. Tre i casi chiusi: nel luglio 2013 finisce la vicenda dell’ex sindaco di Trezzano sul Naviglio, Tiziano Butturini. Arrestato nel 2010 per corruzione in un’inchiesta che coinvolge esponenti della ’ndrangheta, patteggia 2 anni e 5 mesi. Gennaio 2015, Filippo Penati assolto a Monza dall’accusa di finanziamento illecito, mentre per corruzione e concussione (un giro di tangenti) si avvale della prescrizione. Aprile 2015, spese pazze in Regione: rinviato a giudizio il capogruppo Luca Gaffuri e condannati con rito abbreviato Carlo Spreafico (2 anni) e Angelo Costanzo (1 anno e 6 mesi). Cinque i fronti ancora aperti. A Rho l’ex consigliere Luigi Addisi viene arrestato nell’aprile 2014 per riciclaggio e abuso d’ufficio con l’aggravante di aver favorito la ’ndrangheta. L’inchiesta è in corso, Addisi è ai domiciliari. Nel gennaio 2015 viene indagato il consigliere regionale Massimo D’Avolio (abuso d’ufficio). Da sindaco di Rozzano gestisce la partita milionaria del teleriscaldamento e autorizza il pagamento della partecipata Ama ad alcune società di cui sua moglie risulterebbe fra i soci. Gennaio 2016, arrestato il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin: è indagato a piede libero per favoreggiamento e falso. A gennaio il sindaco di Como, Mario Lucini, viene indagato (violazione alle norme edilizie e turbativa d’asta) per l’appalto sulle paratie del lungolago. A marzo tocca al sindaco di Pero Maria Rosa Belotti: abuso d’ufficio.
LIGURIA. Già l’inchiesta Mensopoli del 2007 aveva toccato i collaboratori più stretti dell’allora sindaco Marta Vincenzi (non indagata) e due ex consiglieri Ds. Per le spese pazze, quasi mezzo consiglio regionale del mandato di Claudio Burlando è stato indagato: molti rappresentanti del centrosinistra, uno del Pd. È Antonino Miceli – ex capogruppo – rinviato a giudizio per peculato e falso. Quindi le alluvioni. Per quella del 2011 l’allora sindaco Marta Vincenzi è imputata di omicidio colposo, disastro colposo, falso e calunnia. Il processo è in corso. Per quella del 2014 Raffaella Paita – allora assessore alla Protezione civile – ha ottenuto il rito abbreviato. C’è poi l’inchiesta savonese sulla centrale a carbone di Vado che secondo i pm avrebbe causato 440 morti: indagata tutta la giunta Burlando. Inchieste clamorose, come Parcopoli, sulle Cinque Terre. L’ex presidente del Parco, Franco Bonanini (Pd, poi passato al centrodestra) è stato condannato in primo grado a 7 anni e dieci mesi.
VENETO. L’ex sindaco di Venezia del Pd, Giorgio Orsoni, è imputato di finanziamento illecito ai partiti. Secondo l’accusa, avrebbe ricevuto, tramite i fondi neri del Consorzio Venezia Nuova, 560 mila euro per la campagna elettorale delle comunali nel 2010. Arrestato il 4 giugno 2014 nell’inchiesta sul Mose, Orsoni era stato scarcerato una settimana dopo; la sua richiesta di patteggiamento era stata respinta. Nella stessa inchiesta era indagato il tesoriere del Pd, Giampietro Marchese, con l’accusa di finanziamento illecito ai partiti per aver ricevuto circa mezzo milione dal consorzio del Mose per “plurime campagne elettorali” dal 2006 al 2012. Marchese ha patteggiato 11 mesi e 20mila euro di multa.
EMILIA ROMAGNA. Spese pazze: sono 13 gli ex consiglieri regionali Pd a processo a Bologna, accusati di peculato. Secondo i pm, i politici avrebbero utilizzato, tra il 2010 e il 2011, i fondi dei gruppi per spese “non inerenti”: tra gli scontrini, anche quelli per un bagno pubblico, pranzi e cene di lusso, viaggi da centinaia di euro con autista e persino per sexy shop. Imputati tra gli altri l’ex capogruppo Marco Monari e l’eurodeputato Damiano Zoffoli. A Rimini i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Andrea Gnassi, l’accusa per lui, che si ricandida a giugno, è associazione a delinquere e truffa nell’inchiesta sul fallimento di Aeradria, società che gestiva l’aeroporto. Anche a Bologna il sindaco ricandidato Virginio Merola è sotto inchiesta per omissione d’atti d’ufficio, in un fascicolo sul mancato sgombero di un’occupazione in via di Mura di Porta Galliera. Si deciderà a giugno, con un processo bis in appello, la sorte di Vasco Errani, ex governatore per il quale la Cassazione aveva annullato (con rinvio) una condanna per falso ideologico, nella vicenda Terremerse, assolto in primo grado.
TOSCANA. A Firenze, nel processo sull’urbanizzazione dell’area di Castello, nell’ottobre del 2015, la Corte di appello ha condannato l’ex assessore comunale all’Urbanistica Gianni Biagi a due anni e mezzo per corruzione insieme a Salvatore Ligresti. A un anno e un mese è stato condannato Graziano Cioni, ex assessore alla sicurezza. Sempre l’urbanistica protagonista nel processo Quadra che ha portato, nel novembre 2013, a 19 condanne fra le quali quella per Alberto Formigli, ex capogruppo Pd in Consiglio comunale: in primo grado, tre anni e 9 mesi con accusa di corruzione e peculato. A dicembre 2016 arriva, in Cassazione, la condanna definitiva a un anno e mezzo per omicidio colposo per l’ex sindaco Leonardo Domenici. I fatti si riferiscono alla morte di una giovane ricercatrice precipitata, la notte fra il 14 e 15 luglio 2008, da un bastione del Forte Belvedere. Dal dicembre 2015 è iscritto nel registro degli indagati il sindaco di Siena Bruno Valentini. Le ipotesi di reato sono falso in atto pubblico, abuso di ufficio e truffa. Le indagini, che coinvolgono altre 8 persone, riguardano la costruzione di un campo da baseball a Monteriggioni dove l’esponente dem è stato primo cittadino tra il 2011 e il 2014. A Livorno indagati per la gestione dell’azienda dei rifiuti l’ex sindaco Alessandro Cosimi e gli assessori Bruno Picchi e Walter Nebbiai.
LAZIO. Il Pd di Roma e del Lazio è stato straziato da Mafia Capitale. Il primo giudizio è arrivato nei confronti di Daniele Ozzimo, ex assessore dem: lo scorso 7 gennaio è stato condannato in primo grado a 2 anni e 2 mesi per corruzione. Ha annunciato l’appello. Nell’inchiesta sono finiti altri democratici. Tra i 46 imputati c’è anche Mirko Coratti, accusato di corruzione: prima dello scandalo era presidente dell’Assemblea capitolina. Indagati anche Maurizio Venafro, ex capo di gabinetto di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, e Andrea Tassone, ex presidente del X municipio, quello ad alta densità mafiosa di Ostia. Pierpaolo Pedetti, ex consigliere Pd, è anche lui accusato di corruzione e turbativa d’asta. L’indagine sulle spese pazze della Regione tra il 2010 e il 2013 è stata chiusa lo scorso dicembre. Riguarda 14 ex consiglieri dem: tra loro l’attuale sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, i parlamentari Giancarlo Lucherini, Bruno Astorre, Claudio Moscardelli, Francesco Scalia e Daniela Valentini, Enzo Foschi e Marco Di Stefano. Lo stesso Di Stefano è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio, truffa e falso per presunti illeciti legati a un mega affare immobiliare. Luigi Lusi, ex senatore romano del Pd, è stato condannato in primo grado a 8 anni per appropriazione indebita, per aver messo le mani sui rimborsi elettorali della Margherita, di cui è stato tesoriere (2002-2012). Ignazio Marino rischia due processi: scontrini e onlus.
MARCHE. La Procura di Ancona ha chiesto 66 rinvii a giudizio per l’inchiesta delle spese pazze in Regione. Praticamente tutto l’ex Consiglio. Le spese contestate a esponenti di destra e sinistra ammontano a 1,2 milioni di euro. Indagati l’ex governatore Gianmario Spacca (eletto con il Pd, poi avvicinatosi al centrodestra), l’ex presidente del Consiglio Vittoriano Solazzi (ex Pd), nonché assessori dell’attuale giunta come Angelo Sciapichetti.
UMBRIA. L’inchiesta della Procura di Terni sullo smaltimento del percolato dalla discarica di Vocabolo Valle vede fra gli indagati il sindaco della città Leopoldo Di Girolamo. Fabio Paparelli, vicegovernatore, è a processo per stabilizzazioni sospette di personale della Provincia.
ABRUZZO. Tangenti per i lavori all’oratorio Don Bosco de L’Aquila dopo il terremoto del 2009. Con questa accusa nel novembre 2015 è finito ai domiciliari l’ex vicesindaco della città Roberto Riga. L’inchiesta riguarda appalti per 28 mila euro.
PUGLIA. Il nome più noto è l’ex assessore regionale della giunta Vendola, poi diventato senatore, Alberto Tedesco: deve ancora affrontare un processo, negli altri – sempre del filone sanità – è stato prosciolto. L’ex sindaco di Brindisi Mimmo Consales è stato messo ai domiciliari il 6 febbraio scorso con l’accusa di aver intascato tangenti. L’ex presidente della provincia di Taranto, Gianni Florido, e il suo assessore all’ambiente Michele Conserva, sono accusati di pressioni sui dirigenti della Provincia per la concessione all’Ilva dei Riva dell’autorizzazione a smaltire i rifiuti nelle discariche interne alla fabbrica. Nella stessa inchiesta, con l’accusa di favoreggiamento, è finito un altro assessore della giunta Vendola, il tarantino Donato Pentassuglia. Altre inchieste: il consigliere regionale Michele Mazzarano è sotto processo per finanziamento illecito ai partiti per aver ricevuto 70 mila euro da Gianpaolo Tarantini, l’imprenditore che avrebbe organizzato le serate per Silvio Berlusconi. Ancora: il consigliere regionale Fabiano Amati, condannato in appello a 6 mesi per tentato abuso d’ufficio; Gerardo De Gennaro, ex consigliere regionale, coinvolto in un’inchiesta su sei grandi opere edilizie a Bari, e, ultimo in ordine di tempo, il consigliere regionale Ernesto Abaterusso condannato a un anno e 6 mesi (primo grado, il pm aveva chiesto l’assoluzione) per truffa all’Inps.
BASILICATA. Il governatore Marcello Pittella è imputato in Rimborsopoli – è stato già condannato dalla Corte dei conti insieme, tra gli altri, al deputato Vincenzo Folino – ed è indagato per corruzione elettorale nell’inchiesta sul dissesto di Potenza, il buco da quasi 24 milioni. Trentacinque gli indagati sul crac del municipio, tra cui gli ex assessori Giuseppe Ginefra e Federico Pace. Tra i rinviati a giudizio con l’accusa di aver percepito indebitamente rimborsi dal fondo per le attività istituzionali ci sono anche il sottosegretario alla Sanità Vito De Filippo e l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Braia.
CAMPANIA. Il governatore Vincenzo De Luca è, nell’ordine: imputato di associazione a delinquere e tentata concussione per il progetto Seapark di Salerno (il pm ha chiesto l’assoluzione) e di abuso d’ufficio per la realizzazione del Crescent; indagato di concussione per induzione per la trattativa intorno alla sentenza del giudice civile che lo ha mantenuto in carica nonostante la legge Severino ne imponesse la sospensione dopo una condanna in primo grado nella vicenda del mai realizzato termovalorizzatore di Salerno (condanna annullata in appello). Tre suoi stretti collaboratori sono indagati: l’ex segretario Nello Mastursi, ritenuto uno dei registi della trattativa sulla sentenza; il consigliere per la Sanità, Enrico Coscioni, accusato di tentata concussione; il consigliere per l’Agricoltura, Franco Alfieri, raggiunto da un avviso di garanzia per omissione di atti d’ufficio per non aver acquisito beni confiscati a un clan criminale al patrimonio di Agropoli, di cui è primo cittadino. A Napoli Antonio Bassolino è uscito indenne da quasi tutti i processi sui rifiuti. Ne pende ancora uno che lo vede imputato di peculato. Più grave la posizione processuale dell’ex sindaco di Villa Literno ed ex consigliere regionale Enrico Fabozzi, condannato in primo grado a 10 anni per concorso esterno in associazione camorristica. Due sindaci devono difendersi in inchieste su appalti pilotati: Giosy Ferrandino (Ischia), sotto processo per le presunte tangenti di Cpl Concordia sulla metanizzazione dell’isola, e Giorgio Zinno (San Giorgio a Cremano), raggiunto da un avviso di conclusa indagine.
CALABRIA. Concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione elettorale e voto di scambio. Sono tra i reati contestati a politici dem investiti nel 2014 dall’inchiesta Rimborsopoli e da alcune indagini antimafia. L’ex sottosegretario Sandro Principe è finito ai domiciliari nell’inchiesta “Sistema Rende”: voti in cambio di appalti e posti di lavoro ai clan. Per corruzione elettorale e voto di scambio politico-mafioso è indagato il consigliere regionale Orlandino Greco. Ha trascorso 9 mesi ai domiciliari l’ex assessore regionale Nino De Gaetano, nell’inchiesta Rimborsopoli per la quale sono indagati anche Nicola Adamo, ex consigliere regionale, l’ex presidente del Consiglio Antonio Scalzo, l’ex assessore Carlo Guccione e l’ex vicegovernatore Vincenzo Ciconte. Il consigliere regionale Michelangelo Mirabello è rinviato a giudizio per concorso in bancarotta.
SICILIA. È indagato a Enna Mirello Crisafulli, per abuso di ufficio e occupazione abusiva di suolo pubblico per l’apertura della facoltà di medicina dell’Università romena Dunarea di Jos Galati. Ha ricevuto il 10 dicembre scorso un avviso di garanzia per una distrazione di fondi destinati all’università Kore. A Roma Crisafulli deve rispondere con il ministro Alfano di abuso di ufficio per il trasferimento del prefetto di Enna Fernando Guida. Insieme a Elio Galvagno, ex deputato regionale, Crisafulli infine è stato condannato a due mesi per un blocco dell’autostrada Pa-Ct nel 2010: per entrambi il tribunale ha pronunciato la prescrizione per una truffa da 9 milioni di euro all’Ato rifiuti. A Marsala sta per essere processato per voto di scambio il consigliere comunale Vito Daniele Cimiotta, a Trapani è a giudizio il deputato Nino Papania per associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio alle amministrative del 2012 di Alcamo: cibo e promesse di lavoro in cambio del voto. Per le spese pazze del gruppo parlamentare Pd all’Ars le indagini sono state chiuse per peculato nei confronti di 5 deputati regionali. Sorpreso a intascare una mazzetta di 10 mila euro il loro ex collega Gaspare Vitrano è stato condannato a sette anni per concussione.
SARDEGNA. Il segretario regionale, nonché europarlamentare ed ex governatore, Renato Soru, è accusato di evasione fiscale: avrebbe sottratto al fisco più di due milioni. Per lui anche una contestazione di false comunicazioni sociali in un procedimento (è indagato) nato da accertamenti sulla sua Tiscali. Francesca Barracciu, dopo il rinvio a giudizio per peculato, ha dovuto lasciare la poltrona di sottosegretario alla Cultura del governo Renzi: avrebbe speso in modo improprio i fondi ai gruppi del Consiglio regionale, così come una trentina di esponenti Pd. Tra loro il senatore Silvio Lai e i deputati Siro Marrocu e Marco Meloni. C’è un primo condannato: l’ex sindaco di Porto Torres Beniamino Scarpa, in primo grado, si è beccato 4 anni e mezzo.
Da Il Fatto Quotidiano del 21 Aprile 2016. Aggiornato da Redazione web del 3 maggio 2016. A cura di Maddalena Brunetti, Francesco Casula, Michela Gargiulo, Andrea Giambartolomei, Vincenzo Iurillo, Giuseppe Lo Bianco, David Marceddu, Ersilio Mattioni, Lucio Musolino, Tommaso Rodano, Ferruccio Sansa e Andrea Tornago.
LA DIFFERENZA TRA LA POLITICA DEI MODERATI E L'INTERESSE PRIVATO DEI COMUNISTI.
Altro che scissioni! Leone sconfisse Moro e Moro votò per Leone, scrive Francesco Damato il 24 Febbraio 2017. La Democrazia cristiana non conobbe divisioni da risentimento o da dissenso fino a quando il sistema politico fu abbattuto dal giustizialismo. Un parallelo storico con quanto sta accadendo nel Pd. Noi vecchi cronisti della politica abbiamo la sciagurata abitudine o tentazione di paragonare ciò che accade e che ancora possiamo raccontare a ciò che abbiamo già visto e riferito in passato. Forse non è giusto perché nulla mai si ripete nelle stesse circostanze. E le circostanze sono un elemento non certo trascurabile nella valutazione delle cose e degli uomini. Ma poi si finisce sempre per cadere, ripeto, in tentazione. Ci sono caduto qualche giorno fa nella buvette di Montecitorio col povero, incolpevole Guglielmo Epifani, mandandogli di traverso – temo – un caffè che ha improvvisamente interrotto di gustarsi per correre letteralmente via. Ho dunque chiesto al povero Epifani, esponente tanto autorevole e fidato della corrente o area di Pier Luigi Bersani da essere poi intervenuto a suo nome nella discussione di domenica all’assemblea nazionale del Pd sulla convocazione del controverso congresso, che cosa avrebbe detto da giovane, anzi da giovanissimo, studente di filosofia non so in quale Università, se il contrasto cronico fra i due cosiddetti cavalli di razza della Dc Amintore Fanfani ed Aldo Moro – fosse sfociato nella scissione del principale partito italiano. Attorno al quale gravitavano gli equilibri politici del Paese come più di quarant’anni dopo, fatte le debite differenze di natura sociale e politica, interna e internazionale, sarebbe accaduto al Partito Democratico fondato nel 2007 fondendo i resti della Dc e del Pci. Già al nome di Fanfani l’ex segretario generale della Cgil, ma anche ex segretario del Pd, sia pure di transizione, fra le dimissioni di Pier Luigi Bersani e l’elezione di Matteo Renzi nel 2013 con la doppia procedura del congresso e delle primarie, mi ha guardato storto. Ho avvertito la sensazione che Epifani mi volesse contestare il paragone, implicito nella mia domanda, tra Fanfani e Renzi, per quanto toscani e alquanto decisionisti entrambi, diciamo la verità. Ma si è forse trattenuto dal farlo per non dover difendere Fanfani, che nella cultura italiana di sinistra è stato visto prevalentemente a destra, a dispetto dei suoi trascorsi dossettiani, e della famosa comunità “del Porcellino”, per la sua infelice e comunque sfortunata guida della campagna referendaria contro il divorzio nel 1974. Epifani si è perciò limitato a difendere in qualche modo la Dc rispetto al Pd nella versione e guida renziana. «La Dc – mi ha detto – aveva un sistema diverso e forte di regole». A questo punto sono stato io a trattenermi dalla tentazione di ricordargli che nella Dc si era troppo a lungo tollerata, anche ai tempi di Fanfani, l’abitudine di fare i congressi usando la manica larga con i tesseramenti, per cui le correnti si misuravano spesso con i morti che continuavano a votare con i vivi. Mi sono trattenuto non tanto per non mettere in imbarazzo Epifani ma per rispettare quelle volte in cui mi capitò di votare per la Dc apprezzando la linea di Moro, prima che l’unificazione socialista, peraltro destinata a fallire, non mi avesse fatto cambiare scelte o abitudini elettorali. Ho preferito perciò ripiegare, con Epifani, su un altro argomento o motivo di riflessione sulla “enormità”, secondo me, di una scissione da “sentimento”, come una volta è sfuggito di dire a Massimo D’Alema parlando dei metodi renziani di gestione del partito, e non solo di linea politica. E ho cominciato a ricordare all’ex segretario del Pd una vicenda risalente alla fine del 1971, quando lui aveva poco più di 21 anni e mezzo, come ho potuto rilevare consultando sull’elenco dei deputati i suoi dati anagrafici: le elezioni presidenziali che portarono al Quirinale Giovanni Leone. Ma Epifani mi ha interrotto bruscamente, lasciando a metà la tazzina di caffè e correndo spero – ad un appuntamento dimenticato, con un gesto comunque infastidito di saluto. Ebbene, quella vicenda continuo a ricordarla o raccontarla a voi da testimone. La Dc, guidata in quel momento dal fanfaniano Arnaldo Forlani, di cui era vice segretario Ciriaco De Mita, della corrente di sinistra chiamata “Base”, entrambi protagonisti di un convegno all’insegna del cambio di generazione svoltosi a San Ginesio, ridente località delle Marche ora purtroppo devastata dal terremoto, arrivò all’appuntamento parlamentare per la successione a Giuseppe Saragat con la candidatura di Fanfani. Che furbescamente si era collocato in una posizione che riteneva vantaggiosa: quella di presidente del Senato. Moro, il suo storico antagonista nella Dc, era ministro degli Esteri di un governo di centrosinistra guidato da Emilio Colombo. Per ben 6 votazioni, fra il 9 e il 12 dicembre, i parlamentari e i delegati regionali democristiani scrissero sulle loro schede il nome di Fanfani senza riuscire ad eleggerlo: né da soli né con l’appoggio di altri. Che poi erano sulla carta solo i repubblicani, essendo i socialdemocratici impegnati a sostenere la conferma di Saragat e i socialisti e i liberali defilati votando i loro candidati cosiddetti di bandiera: rispettivamente, Francesco De Martino e Giovanni Malagodi. Seguirono, fra il 13 e il 14 dicembre, quattro votazioni di cosiddetta decantazione, con i democristiani costretti ad astenersi per non far più contare i loro “franchi tiratori” e convincere Fanfani a rinunciare spontaneamente alla candidatura. Un solo democristiano si rivoltò alle direttive votando dichiaratamente per Moro: l’ex presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. All’undicesima votazione, il 15 dicembre, Fanfani pretese e ottenne dal suo partito un ultimo tentativo sul proprio nome. Ma non riuscì a raccogliere più di 393 voti: 112 meno dei 505 necessari per l’elezione, pari alla maggioranza assoluta dell’assemblea costituita dai deputati, senatori e delegati regionali. “Nano maledetto, non sarai mai eletto”, era stato d’altronde già scritto sulla scheda da un “franco tiratore”. Si passò allora nella Dc alla ricerca di un altro candidato con i soliti incontri al caminetto e infine con la riunione congiunta dei gruppi parlamentari, mentre nell’aula di Montecitorio si svolgevano votazioni inutili, alle quali i democristiani dovevano partecipare astenendosi per non essere tentati di fare di testa loro, votando magari per il ministro degli Esteri. Dal quale i comunisti erano attratti, per quanto l’indimenticabile Giorgio Amendola avvertisse i cronisti nel Transatlantico che «tutti ci hanno chiesto voti, fuorché Moro». All’assemblea congiunta dei “grandi elettori” democristiani, svoltasi la sera del 21 dicembre, il segretario del partito Forlani si presentò con una sorpresa agli occhi e alle orecchie dei suoi colleghi di corrente e dei “dorotei” di Mariano Rumor e Flaminio Piccoli: la contestazione degli umori contro Moro. «E’ un uomo che è stato più volte ministro, per quattro anni segretario del partito, per altri quattro presidente del Consiglio, è oggi il ministro degli Esteri: non vedo una sola ragione per la quale non potrebbe essere degnamente il nostro candidato alla Presidenza della Repubblica», disse Forlani. Moro non era presente all’assemblea. Molti applaudirono, molti altri rimasero immobili. Non restava che votare, a scrutinio naturalmente segreto. Ma qualcuno osservò che s’era fatto ormai troppo tardi e propose di votare l’indomani. Forlani commise l’errore di non avvertire il pericolo di una manovra contro di lui. Ma neppure di questo i fanfaniani gli furono grati. Vidi personalmente, alla fine della riunione, il deputato di Taranto Gabriele Semeraro – un omone alto così – avvicinarsi al segretario e dirgli: “Traditore”. Pallido, Forlani tirò dritto. Nella notte chi si voleva muovere si mosse, alle spalle del segretario del partito. E concordò con i liberali, i socialdemocratici, i repubblicani, qualcuno disse anche con i missini, non con i socialisti, e tanto meno con i comunisti naturalmente, l’appoggio alla candidatura di Giovanni Leone. Per non farla molto sporca dorotei e fanfaniani proposero poi all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari e dei delegati regionali tre nomi Rumor, Piccoli e Leone avvertendo che sull’ultimo era stata accertata la disponibilità dei liberali, repubblicani e socialdemocratici a votarlo. Carlo Donat-Cattin invece propose Moro, dopo avere inutilmente cercato di convincerlo a farsi votare senza aspettare la designazione del partito, mentre i “grandi elettori “dello scudo crociato sfilavano davanti alle urne di Montecitorio senza deporre la scheda, cioè astenendosi. «Per fare i figli bisogna fottere», aveva detto Carlo agli amici nei corridoi della Camera per spiegare la sua posizione, lamentandosi del rifiuto oppostogli da Moro a rompere la disciplina e lealtà di partito. Quella mattina, mentre si votava nei gruppi democristiani, Moro non si fece vedere da nessuno. Rimase orgogliosamente chiuso nell’ufficio del consigliere della Camera Tullio Ancora, un amico al quale, a furia di ammirare Moro, dicevano per scherzo i cronisti, era venuto un ciuffo di capelli bianchi sulla fronte, come all’ex presidente del Consiglio. «Se si fosse abbassato a stringere qualche mano in Transatlantico – mi disse poi il comune amico Nicola Lettieri ce l’avremmo fatta». Moro perse lo scrutinio con meno di cinque voti di differenza su Leone, per il quale si votò poi in aula il 23 dicembre, alla ventiduesima volta dall’inizio della corsa al Quirinale. Ma gli mancò un solo voto – quello di un deputato monarchico campano arrivato in aula troppo tardi ai 504 necessari per l’elezione. Fu annunciata un’altra votazione, la ventitreesima, per il giorno dopo, vigilia di Natale. Quella mattina passai dalla casa di Lettieri, vicino Ponte Milvio, per andare insieme alla Camera e farmi raccontare come fosse andata una riunione di corrente svoltasi la sera prima. Mi disse di avere invitato i suoi colleghi a votare scheda bianca per protesta contro la “slealtà” dei dorotei e dei fanfaniani. Che avevano peraltro mandato Rumor a casa di Moro per manifestargli il “dispiacere” di non averlo potuto appoggiare a causa del significato politico “improprio” che aveva finito per assumere una sua candidatura, troppo gradita al Pci. «Mi avete confezionato un abito su misura», aveva risposto freddamente il ministro degli Esteri. Tu oggi che farai?, chiesi a Nicola mentre prendevo un caffè offertomi dalla moglie. «Naturalmente voto contro», mi rispose. Come se Moro lo avesse sentito, squillò il telefono. Dall’altro capo del filo c’era proprio lui, il ministro degli Esteri, che disse, testualmente e forte, tanto da sentirlo bene anche io: «Nicola, ti raccomando. Si vota tutti Leone perché lui non c’entra con quello che è stato fatto contro di me. Non fate scherzi». Leone quella mattina fu eletto con 518 voti, 13 in più dei 505 necessari. E fu proprio lui dopo sei anni e mezzo, al Quirinale, anche a costo di doversi poi dimettere da presidente della Repubblica, sia pure per altri motivi ufficiali, a raccogliere gli appelli di Moro dalla “prigione” delle Brigate rosse perché venisse salvato dalla condanna a morte comminatagli dai terroristi. In particolare, Leone predispose la grazia per Paola Besuschio, che era nell’elenco dei 13 detenuti di cui le Brigate rosse avevano reclamato lo scambio con il loro ostaggio. Purtroppo con una tempestività della quale Leone non si diede pace sino alla morte, i terroristi uccisero Moro la mattina del 9 maggio 1978, poche ore prima che il capo dello Stato potesse firmare la grazia. E Fanfani – sì, lui, il vecchio antagonista di Moro – potesse parlare alla direzione nazionale della Dc per rimettersi alle decisioni autonome del presidente della Repubblica. La Dc non conobbe scissioni da risentimento o dissenso fino a quando il sistema politico non fu terremotato dal giustizialismo. E non ne conobbe neppure l’altro, grande partito: il Pci. Dove Pietro Ingrao nel 1969 rimase disciplinatamente nel partito quando i suoi compagni del Manifesto ne furono espulsi. E rimase anche nel Pds- ex Pci quando Cossutta se ne andò per creare Rifondazione Comunista. Egli restò, sia pure ancora per poco, in quel “gorgo” evocato da Gianni Cuperlo domenica scorsa davanti all’assemblea nazionale del Pd per cercare di trattenere dalla scissione le altre minoranze, pur essendo anche lui critico con Renzi. Non pensarono mai ad una scissione nel Pci neppure i cosiddetti miglioristi di Giorgio Napolitano ed Emanuele Macaluso quando dissentirono da Enrico Berlinguer sui rapporti con i socialisti e sulla “diversità” dei comunisti orgogliosamente rivendicata dal segretario, sino al rischio di un pericoloso isolamento.
IL TRAVESTITISMO.
L'amnesia selettiva della "Stampa" che dimentica i direttori sotto il fascismo. Il quotidiano celebra i 150 anni con un inserto. Ma oscura perfino Curzio Malaparte, scrive Tony Damascelli, Mercoledì 15/02/2017, su "Il Giornale". Lo smemorato piemontese ha cambiato indirizzo da Collegno a Torino, via Lungaro, al civico 15. Cose che possono capitare quando si celebrano eventi storici e, stranamente, vengono dimenticati, cancellati dai ricordi e dalle citazioni, nomi e personaggi illustri che quella storia hanno scritto. Prendete, ad esempio, la Stampa di Torino, con sede appunto in via Lungaro. Ha festeggiato i propri 150 anni con una pubblicazione supplemento che ripercorre fatti, eventi, firme di un secolo e mezzo, partendo dagli esordi fino ai contemporanei. Il titolo dell'opera è Il Mondo che ci aspetta. Nell'attesa del mondo e delle sue novità, è stato interessante rileggere nomi illustri che hanno fondato e illuminato le pagine di questo giornale che rimane la bandiera sul pennone più alto di una città, di una Regione, di un certo tipo di lettore, dopo la chiusura maligna de La Gazzetta del Popolo. Bello, dunque, ripercorrere non soltanto la cronaca del secolo e mezzo attraverso i nomi di chi ha dovuto gestire, dirigere il giornale. Non tutti i nomi, in verità, risultano riportati dal supplemento. Anzi, è singolare come per il periodo che va dal '26 al '45 la Stampa non abbia avuto direttori, forse non sia nemmeno uscita dalla tipografia. Era il tempo del fascismo, epoca dura eppure dagli archivi risulta che si siano avvicendati alla direzione del foglio torinese ben cinque direttori: Andrea Torre dal 30 novembre del '26 all'11 febbraio del '29, quindi Curzio Malaparte, dal 12 febbraio del '29 al 30 gennaio del '31, Augusto Turati, dal 31 gennaio del '31 al 12 agosto del '32, Alfredo Signoretti, dal 13 agosto del '32 al 25 luglio del '43; quindi, caduto il fascismo, il Ministero di cultura popolare approvò le nomine di Vittorio Varale dal 28 luglio del '43 al 9 agosto dello stesso anno, Filippo Burzio dal 10 agosto del '43 al 9 settembre fatidico e, sotto la R.S.I. furono direttori Angelo Appiotti, Concetto Pettinato e Francesco Scardaoni. Nessuno di questi ha trovato spazio nel supplemento, nemmeno tra le righe di una didascalia, come è accaduto per altri. Credo se ne sia persa la memoria, spontaneamente costretti. Salutato il Duce, sono stati salutati anche i direttori. Pratica che si è ripetuta quando due anni fa venne data alle stampe, dalla RCS, una pubblicazione sui presidenti della Juventus: tutti, tranne Vittorio Chiusano, colpevole di aver fatto parte dell'epoca Giraudo-Moggi-Bettega. La memoria fa brutti scherzi, non soltanto a Collegno.
"Vi racconto due o tre cose sulla Stampa e l'Avvocato". "A dire il vero non mi avevano invitato, ma non mi ero offeso e, il giorno prima, attraverso un amico, ho sollecitato un invito", scrive Tony Damascelli, Venerdì 17/02/2017, su "Il Giornale". Jas Gawronski, nipote di Alfredo Frassati. La memoria a Torino fa brutti scherzi, dimentica le date, i direttori del Ventennio, i fondatori e anche i nipoti.
Lei era presente al Lingotto ai festeggiamenti per i 150 anni de La Stampa?
"A dire il vero non mi avevano invitato, ma non mi ero offeso e, il giorno prima, attraverso un amico, ho sollecitato un invito. Il fatto è che La Stampa, in quanto tale, è nata non 150 ma esattamente 122 anni fa, assorbendo la Gazzetta Piemontese quella sì nata 150 anni fa. Mi sembrava un po' audace l'idea di stiracchiare la vita de La Stampa di qualche decennio in più, ma capivo l'interesse del giornale ad apparire più radicato e con più antiche tradizioni. Pensavo, tuttavia, che almeno avrei assistito a una celebrazione del vero fondatore, mio nonno Alfredo Frassati".
E invece?
"A parte un sentito ricordo di Paolo Mieli, nulla. E fuori dal Lingotto, la mattina, all'inaugurazione di una mostra, un ottimo intervento del professor Castronovo".
Come spiega questi vuoti di memoria?
"Non me lo spiego, ma Gianni Agnelli sembrava avvalorare la tesi che La Stampa, sebbene nata in continuità, fosse cosa diversa dalla Gazzetta Piemontese. L'Avvocato, infatti, intervenne allo scoprimento di una lapide che mia madre volle sulla casa di Piazza Solferino dove La Stampa è nata, in occasione del vero centenario. Purtroppo l'Avvocato non c'è più".
E quindi, secondo lei, la storia de La Stampa va riscritta?
"Non riscritta, ma sfrondata da varie inesattezze. Del resto ci ha pensato mia madre, Luciana Frassati, che ha dedicato sei grandi volumi alla storia del giornale. Nella prefazione l'insigne storico Gabriele De Rosa parla de La Stampa come cosa nuova nella storia del giornalismo italiano... indubbiamente fu il capolavoro di Alfredo Frassati".
Con l'Avvocato, le capitava di parlare de La Stampa?
"Sì, sovente. Era una sua passione e lo considerava il miglior giornale italiano, una eccellenza civile e morale. Non mi ha mai offerto la direzione, ma sondava la mia opinione sulle nomine che intendeva fare e lo intuivo quando cominciava a chiedermi più spesso le mie impressioni su questo o quel giornalista. Ogni tanto gli ricordavo che se non ci fosse stata quella insana complicità fra Mussolini e suo nonno forse oggi sarei io il proprietario e il direttore de La Stampa!".
Insana complicità?
"Mio nonno si oppose sin dall'inizio al fascismo dimettendosi da Ambasciatore a Berlino e denunciando il delitto Matteotti. Mussolini, che aveva maturato un profondo astio nei suoi confronti, nel 1925 costrinse Frassati prima a lasciare la Direzione poi a vendere il giornale al Senatore Agnelli".
Come reagiva l'Avvocato a questa ricostruzione storica?
"Prendeva in giro mio nonno per la sua proverbiale parsimonia, lui parlava di tirchieria, ma quando esagerava gli ricordavo che, a differenza del suo, mio nonno non si era mai fatto fotografare in orbace! Ma, pur nella differenza dei caratteri, aveva una certa stima di Frassati, riconoscendogli il merito di aver apportato importanti innovazioni nella stampa italiana, a partire dall'articolo di fondo in prima pagina fino ai vari supplementi oggi così di moda".
Che rapporto aveva Agnelli con i giornalisti?
"Ne era attratto, ma non aveva grande stima della categoria, esclusi quelli fra i più importanti che conosceva bene. Oggi forse si sentirebbe un po' spaesato, perché per anni lui e la sua azienda hanno fruito di una impermeabilità alle critiche dei giornali di cui oggi non potrebbe più godere".
Ma se Lei fosse oggi il Direttore de La Stampa che farebbe?
"Metterei in pagina i cinque ritratti dei direttori del Ventennio, dimenticati nel supplemento celebrativo. La storia è storia e non bisogna vergognarsi".
“Gli italiani buoni non sono mai esistiti”, scrive il 16/02/2017 Bruno Giurato su “Il Giornale” in ricordo di Piero Buscaroli, morto il 15 febbraio 2016. Altro che Piero il terribile: cortese, cortesissimo, spunta in cima alle scale della casa nel centro di Bologna, lo sguardo da Re Leone. Al telefono aveva detto: «È passato a trovarmi un reduce della RSI. Aveva perso la guerra e alla fine era in pace. Io non l’ho fatta perché ero troppo piccolo, ed è finita che ho dovuto odiare al posto loro. Per sessant’anni». Ma a 82 anni Buscaroli più che di combattere ha voglia di raccontare, intrattenere, perfino ridere: «Gli dei mi avevano assicurato che nel 2012 sarei morto. Invece dicono tutti che sto bene, se lo dicono loro… Mi hanno trovato un po’ di diabete. Raccontava un amico napoletano, Oderisio Piscicelli Taeggi, ufficiale del Regio Esercito: il diabete è la malattia più deliziosa del mondo. È una schermaglia quotidiana con la glicemia». Storia, giornalismo, musicologia: Buscaroli ha scritto «in guerra». «Il mio Beethoven ha corretto più di 150 dati storici. Per decenni mi sono domandato se avrei avuto la forza di prendere per il collo questo gigante. Mi sono chiuso nella casa in campagna, a Monteleone, per quattro anni: mangiavo e dormivo quando capitava. Una volta ebbi un collasso, se ne accorsero in tempo per fortuna». Ma Dalla parte dei vinti (Mondadori, 2010) è una controstoria italiana, risentita, sì, però piena di dati, episodi, cose. E ora La bancarotta dei vincitori (uscirà in primavera per Minerva edizioni, pare gli abbiano assicurato la massima libertà e il minimo di editing). C’è il revisionismo «alla Buscaroli», ma anche i pezzi dal Vietnam, pieni di vitalismo e curiosità; e i ricordi dei maestri. Oltre all’animo eracliteo da Polemos signore di tutte le cose, emerge la gioia sottile di raccontare.
Nel libro emerge un Leo Longanesi inaspettato: uomo dalle idee «ferme e forti».
«Non ci demmo mai del tu. Ma era lo stesso con il suo grandissimo amico Giovanni Ansaldo, cui una volta domandai: ma come mai, con la dimestichezza che avevate avete continuato a darvi del lei fino alla fine?. Rispose: Con tutto quello che si sapeva l’uno dell’altro, se ci si dava del tu che troiaio veniva fuori!. Su Longanesi le confesso una cosa esplosiva».
Prego.
«Appena prima di morire voleva andarsene in America con una ragazza lunga, di belle fattezze, che chiamavamo la Cannavòta. Aveva raccolto molti soldi, era pronto. Forse non avrebbe avuto il coraggio di lasciare la moglie, che aveva annusato qualcosa, e i figli. Era disgustato dall’Italia».
Come lei…
«Ho rifatto i conti con il passato almeno tre volte. Gli italiani buoni non sono mai esistiti. O meglio, gli italiani buoni non parlano. E sono pochissimi».
Anche sotto il fascismo?
«Già allora l’Italia era quella di adesso. Nessuno degli intellettuali, da Benedetto Croce a Marconi, ebbe il tempismo o l’astuzia di dire a Mussolini: stai facendo una porcata con le leggi razziali».
E chi si salva?
«Un episodio. A Imola, quello che poi divenne il comandante delle Brigate Nere di mestiere faceva il direttore di un ospizio. I soli ricchi ebrei a Imola erano la famiglia Fiorentino: padre e madre riuscirono a scappare, lasciando lì il padre della moglie, il generale Gallicchi. Fu aiutato da questo gerarca, e accolto nell’ospizio».
Un italiano buono, e zitto…
«Appartenere a una parte o all’altra dipende da un momento, dal Caso. Mio padre era fascista, per disciplina come disse, con frase bellissima, Edda Ciano. Senza farsi tante domande. Anch’io lo sono, per disciplina».
Ma non è stato tenero con l’Msi.
«Negli anni ’50. Un gruppo di politici e intellettuali che volevano rifondare la destra invitarono Longanesi e me. C’erano De Marzio, Tedeschi, Guglielmi. E Arturo Michelini, che aveva scarpe bianche, di una bellezza… Mentre parlavano di vecchi ideali, guardavo Longanesi, abbacinato dalle scarpe. Poi sbottò: Ma lei! Come si fa a parlare di destra con quelle scarpe lì?».
Non apprezzava Almirante. Chissà Fini…
«Il peggiore di tutti. Una volta mi invitò a Faenza. Fece due comizi tutti uguali, comprese le congiunzioni. Un nulla totale».
I politici di oggi?
«Bersani dice cose serie, sensate, ma non lo voto. Berlusconi è stato una delusione, anche se l’altra sera da Santoro ha fatto una cosa divertentissima, sul piano della farsa».
Torniamo ai buoni e ai belli di cui parla nel libro: Vincenzo Cardarelli.
«Montale, che non gli fu amico, scrisse che era stato lo scopritore del vero Leopardi, quello dello Zibaldone e delle Operette morali. Ma quando lo conobbi, a Roma, negli anni ’50 era un fagotto. Stava al primo caffè di via Veneto, aveva sempre freddo. Era nato naufrago, abbandonato dal padre. Longanesi l’aveva scaricato crudamente, e lui l’aveva capito. Una volta avrebbe dovuto portarselo dietro alla mostra che organizzava al Sistina, ma lo lasciò lì. Longanesi era capace di freddezze assolute. Quando Longanesi morì Cardarelli disse: È l’ultimo dispetto che potevi farmi».
E veniamo a uno che la nomea di evitabile l’ha avuta per decenni, Mario Praz.
«La casa della vita era il più grande libro italiano dopo Lemmonio Boreo di Soffici. Ma quell’anno, era il ’59, il premio andò a Il Gattopardo. Scrissi una recensione, me ne ringraziò, e iniziò il nostro rapporto. Antidemocratico d’istinto. Timido, piede caprino, occhio torto. Una volta andai da lui, vidi una magnifica libreria, gli chiesi di copiarla. Mi disse: Pensi che l’ho copiata dal duca di Bedford. È questa qui».
La sua passione per il collezionismo?
«Io credo nelle cose, non credo negli uomini».
Regalò una moneta d’argento a Nguyen Cao Ky, primo ministro sud-vietnamita dal ’65 al ’67…
«Inviai a Ky un esemplare delle due lire d’argento del 1923, col fascio littorio e la scritta Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora. Avevo una mia idea della guerra in Vietnam. Convinsi, con fatica, Tedeschi e Giovannini a spedirmici come inviato».
Quale idea?
«Stavo con i vietnamiti del Sud, gravati dalla divisa americana. Capii che il vero coraggio stava dalla loro parte: considero i sudvietnamiti come la RSI».
Il suo incontro con Ky…
«Sapeva che non avrebbero vinto. Come premio i generosi americani gli diedero una pompa di benzina. Gli americani sono il peggio, peggio dei russi. E ora sono contento perché rimarranno fregati dai cinesi».
In Vietnam incontrò Susanna Agnelli…
«Egisto Corradi e io credevamo fosse arrivata come crocerossina. E invece era lì, puntualizzò, come inviata da una lega di società di Croce rossa. Approfittava dei mezzi di trasporto degli americani ma stava con i vietcong. Piena di snobismi, raccontava delle serate con Moravia e la Maraini chiamandoli Dacia e Alberto. Mi venne alla mente la delicata poesia di Dacia: Ti orinerò sulle mani, mio tanto amico…».
Per lei la guerra è continuata.
«Ho cercato di fare tutto il male possibile ai miei nemici. Sono stato uno dei migliori agenti dei servizi segreti tedeschi, spagnoli, portoghesi e giapponesi. Senza prendere soldi, solo per odio verso l’altra parte. Ma mi sono anche gratuitamente divertito».
Come?
«Nel 1970, quel farabutto di Willy Brandt volle fare un regalo in danaro al Vaticano, in occasione della sua visita a Roma. Quando i tedeschi cercarono di capire le reazioni, raccontai che un importantissimo vescovo lituano faceva notare che si aspettava molto di più da una potenza come la Germania. Tutti credettero all’esistenza di questo vescovo…».
C'ERA UNA VOLTA LA DESTRA.
"Mio fratello Giorgio Pisanò cronista e detective scomodo". La sua inchiesta sulla Guerra civile non faceva sconti e non era ideologica. Per questo fu escluso dai "salotti", scrive Paolo Pisanò, Venerdì 31/03/2017, su "Il Giornale". Il talento vero di Giorgio Pisanò (1924-1997) non era quello dello storico accademico ma quello del giornalista investigativo di prim'ordine. Pisanò era soprattutto un cronista-detective provvisto di un intuito formidabile e di quella capacità innata di analisi-sintesi che spinge irresistibilmente alcuni (pochi) più che altri a cogliere in uno scenario complesso e ambiguo gli elementi essenziali per afferrarne la chiave interpretativa e renderli comprensibili al di là di ogni ragionevole dubbio. Questa sua intima caratteristica non gli era sempre benefica perché lo metteva necessariamente in rotta di collisione con coloro (tanti) che per le più disparate ragioni tendono a privilegiare l'interpretazione a priori (pregiudiziale) degli scenari complessi e ambigui per sovrapporvi una dimostrazione di comodo che tutto è tranne che qualcosa di attinente alla realtà. Ma la testardaggine da verità del segugio ostinato riusciva ad avere la meglio sui pregiudizi di convenienza e le inchieste di Pisanò hanno lasciato il segno più volte nella prima repubblica: dalla difesa di Raoul Ghiani nel caso Fenaroli con annesso scandalo Italcasse (1958) allo scandalo Lockheed (1980); dallo scandalo Anas (1970: la clamorosa denuncia di tangentopoli, rivelata in nuce vent'anni prima di mani pulite) allo scandalo dei petroli (1980); dalla prima inchiesta sull'assassinio di Enrico Mattei (1963) a quella sulla morte dal banchiere Roberto Calvi (1982), per citarne solo alcune. Ovviamente, ostinandosi a cantare fuori dal coro, Giorgio Pisanò non poteva pretendere di entrare nei salotti buoni (vulgo, niente editoria paludata per lui: doveva stamparsi tutto da sé), cosa della quale s'infischiava altamente perché questo tributo inevitabile al suo modo di essere non gli negava l'ammirazione e la stima di tanti e perfino di colleghi avversari politici ma capaci di apprezzarne il valore al di là delle ideologie divergenti.
Come scriveva Dario Di Vico sul Corriere della Sera dell'11 novembre 1996 sotto il titolo «Che bravo quel Pisanò»: «Giorgio Pisanò? È uno dei più bravi giornalisti italiani. Non ha mani ricevuto premi per la semplice ragione che è fascista. Di quelli dichiarati. Mai pentiti. Questo non gli impedisce di essere un ostinato cacciatore di notizie. A scrivere questo clamoroso elogio dell'ex direttore del Candido non è stato né Vittorio Feltri, né Pietrangelo Buttafuoco e nessun'altra delle penne della destra, ma addirittura un avversario politico. Quel Marco Nozza, inviato del Giorno e capofila per molti anni dei giornalisti antifascisti e democratici milanesi. Nozza ha tributato la standing ovation al vecchio Pisanò dopo aver visto in tv un'ennesima prova del suo fiuto giornalistico: uno speciale sull'oro della Banca d'Italia trafugato dai nazisti».
Sull'essere fascista di Giorgio Pisanò (sull'essere fascista tout court dalla seconda metà del secolo scorso) ci sarebbe da scrivere un saggio corposo e non è questa la sede, ma resta il fatto che Pisanò, trent'anni prima, non aveva indagato e scritto la Storia della Guerra Civile da fascista: l'aveva indagata e scritta da italiano capace di un'inchiesta colossale in condizioni proibitive e consapevole del bene supremo di una memoria nazionale riconoscibile e rispettabile da tutti in quanto rispettosa dei fatti realmente accaduti. Una memoria nazionale non umiliata da un avvilente catechismo storiografico, imposto per manicheismo istituzionale, che ancora oggi oltraggia necessariamente una parte cospicua della collettività in funzione di quell'«antifascismo, inteso come ideologia di Stato» che il primo, vero, grande storico accademico del fascismo, Renzo De Felice, avrebbe cominciato a contestare a viso aperto dal 1987. Se così non fosse stato, se cinquant'anni or sono Giorgio Pisanò avesse condotto la più grande inchiesta della sua vita non da italiano ma da fascista, possiamo essere certi che un altro suo collega, irriducibile avversario politico ma testardo al pari di lui nel pretendere il rispetto della verità storica come base irrinunciabile della convivenza civile, Giampaolo Pansa, mai avrebbe scritto, come invece fece nel 2011: «C'è stato qualcuno, qualche temerario coraggioso, a cominciare da Giorgio Pisanò, che ha rifiutato di sottomettersi al gioco imposto dai vincitori. Ha cominciato a far parlare i parenti di chi era stato ucciso dai partigiani, a raccogliere le testimonianze dei superstiti della RSI, a cercare documenti e a ricostruire la storia di chi si era battuto a fianco di Mussolini. Senza personaggi come Pisanò e pochi altri il sottoscritto non sarebbe mai stato in grado di percorrere la strada che ha percorso, libro dopo libro». Nessuno ha mai smentito i contenuti delle opere di Giorgio Pisanò.
La biografia di Mussolini nonostante si pensasse che fosse una biografia su Claretta: invece è un racconto di fatti storici, scrive Claudio Siniscalchi, Mercoledì 1/03/2017, su "Il Giornale". Nel 1945 l'editore milanese Lucchi pubblica un resoconto della relazione tra Benito Mussolini e Clara Petacci. In copertina si annunciano «scandalosi particolari». Carta povera. Stampa modesta. Come il racconto. L'autore, Angelo Colleoni, ripercorre la storia del «furioso erotomane» (Mussolini), dalla gioventù socialista a Claretta (senza dimenticare le altre numerose amanti). La povera Clara «peccò, ma riscattò i suoi peccati con la morte». Alla «coppia boccaccesca», per concludere, toccò un triste destino. Nel 2017 la Yale University Press pubblica il saggio dello storico australiano Richard J.B. Bosworth, Claretta. Mussolini's Last Lover. Certo non si possono fare paragoni. Ma ciò che era giustificabile, in errori e svianti interpretazioni, al Colleoni del 1945, non può essere perdonato al Bosworth del 2017. Il lettore si aspetta una biografia di Claretta. Invece deve sorbirsi una incomprensibile introduzione in cui si salta di paolo in frasca, dal Movimento sociale italiano ai figli del Duce; da donna Rachele alla Dc; dalle lettere di Churchill ai falsi mussoliniani delle sorelle Panvini e i falsi diari pubblicati da Marcello Dell'Utri; da Berlusconi a Monti. E poi si attacca con le scorribande del «grande predatore». Il «furioso erotomane» Benito, anche quando era giovane socialista rivoluzionario frequentava bordelli. La carriera politica del Don Giovanni romagnolo è scandita dalle amanti: dalla marxista ebrea Angelica Balabanoff all'aristocratica ebrea Margherita Sarfatti. E poi il «grande eiaculatore» semina figli ovunque. Legittimi con Rachele. Illegittimi con Fernanda Oss Facchinelli, Ida Dalser, Bianca Ceccato, Angela Cucciati, Ines De Spuches, Magda Brard (probabilmente uno), Alice Pallottelli (probabilmente due), Romilda Ruspi. Pure Claretta avrebbe avuto un figlio, se fosse riuscita a portare a termine la gravidanza. Del resto, Bosworth ricorda, anche Gheddafi e Bokassa avevano appetiti sessuali smisurati. Come li avevano Marinetti e d'Annunzio. Si va avanti così, sino alla fine della storia di Clara e Benito. Negli ultimi anni Bosworth fra gli studiosi del fascismo di lingua inglese si è affermato come il più noto. Gli si deve una corposa monografia su Mussolini, per larghi tratti imbarazzante, edita nel 2002 (tradotta in Italia da Mondadori). Lo studio della biografia di Claretta è un riassunto, male assortito, di quanto si è scritto per lungo tempo in Italia, dal 29 agosto 1943, quando Il Messaggero e Corriere della sera pubblicarono la storia della relazione del Duce con la giovane Clara, oltre agli imbrogli e agli intrighi della famiglia Petacci. Nel frattempo Badoglio aveva fatto arrestare Clara, i genitori e la sorella. Per grosse linee quel ritratto al negativo viene fatto proprio da Bosworth. Definire Clara la Ducessa in fondo è ripetere lo stereotipo già usato in senso dispregiativo dai fascisti, che odiavano la ragazza, e che addirittura volevano eliminarla quando si presentò a Salò. Di recente sono stati resi pubblici lettere, diari e svariati materiali di Claretta, comprese le missive di Mussolini scritte durante i giorni di Salò. Un fondo che consente di uscire dalle secche dei luoghi comuni. Ma Bosworth ha preferito seguire la strada dell'harem di Mussolini, delle alcove, delle amanti a ciclo continuo. Della sua predisposizione alla brutalità sessuale. A lungo chi si è occupato di storia del fascismo ha dovuto misurarsi con l'opera del britannico Denis Mack Smith. Il grande storico e collaboratore del Giornale Rosario Romeo auspicò che ogni libro dovesse essere accompagnato da una indicazione. Come nei film: riferimenti a personaggi e fatti storici realmente accaduti, debbono intendersi frutto del caso. Raccomandazione che andrebbe adottata in caso di traduzione italiana del saggio di Bosworth.
Fasci allo sfascio: così è ridotta la destra. Storace e Alemanno si fanno il partitino. La Russa e Fini sono spariti. Della fu An, resta solo Meloni. Ma all’ombra di Salvini. Se la sinistra piange, l'altra metà della politica di certo non ride, scrive Susanna Turco il 9 marzo 2017 su “L’Espresso”. Eguagliare in tempismo Corrado Passera sembrava impossibile, eppure ci sono andati vicini. Lui, il banchiere, battezzò disgraziatamente la sua “Italia unica” - nella disattenzione generale - proprio quando s’eleggeva Sergio Mattarella al Quirinale. Loro, Gianni Alemanno e Francesco Storace, 59 e 58 anni, i due ex colonnelli della Destra sociale di An, hanno celebrato la loro riunificazione, dopo sette anni di lontananza e tre di riavvicinamento, giusto nel weekend in cui la scissione nel Pd raggiungeva il suo apice di tragico pathos mediatico. Bersani e Speranza dicevano addio a Renzi mentre all’Hotel Marriott l’ex sindaco di Roma e l’ex governatore del Lazio venivano acclamati segretario e presidente di un nuovo Movimento nazionale per la Sovranità, con tanto di fiamma nel simbolo. E, in nome di una “unità” necessaria alla sopravvivenza ancor prima che a una qualche vittoria, tendevano invano la mano speranzosi a Giorgia Meloni, ex cugina povera in An, oggi cugina ricca e leader di Fdi. Proponendo se stessi - dopo l’Msi e An, il Lazio Gate e Mafia Capitale, il Pdl e la dissoluzione del tutto in coriandoli d’astio - quale nucleo e incipit di un mitologico “Polo sovranista” del centrodestra, qualsiasi cosa voglia dire. E uno si domanda: ancora? Certo, vi è da dire che la proposta sarebbe la stessa che Meloni rivolge a Salvini e Berlusconi. E comunque è chiaro che una qualche dannazione sembra perseguitare i lacerti di quel che fu la destra. Costretti quasi da una brama dantesca a correre in cerchio e mimare sempre una nuova eventuale disfida tra fratelli coltelli, a dispetto della storia, dei processi, dei risultati elettorali sempre più esigui. Come se ci fosse ancora un mutuo da pagare, anche quando ormai la stagione della conquista del potere è passata da un pezzo; e il patrimonio della destra può dirsi ormai pacificamente dilapidato. Forse poi ecco, più che la smania di poltrone in senso stretto - mai comunque da sottovalutare - arrivati sin qui sembra in effetti essere la coscienza a non dar pace. Basta ascoltare Francesco Storace quando, con il fare pratico-nostalgico di una Tina Pica, invoca i «benedetti sei milioni di voti di Alleanza nazionale»; dichiara «bando al correntismo esasperato», che fu invece una delle cifre fondanti del partito di via della Scrofa; o ancora, guaisce di come la destra da almeno vent’anni si sia fatta scippare le sue parole d’ordine «prima da Bossi, poi da Berlusconi, poi da Grillo, ora da Salvini». Potente sintesi, rotonda la tautologia che la segue: «Basta! Diciamo-noi-le-cose-che-dobbiamo-dire-noi». Ma sì, diciamole. È chiaro che da un quadro così, una tipa svelta come Giorgia Meloni si tenga lontanissima. Adducendo una volta come scusa gli screzi di ordine ereditario (quelli all’interno della danarosa Fondazione di An), un’altra volta divaricazioni di alleanza («alle comunali a Roma hanno appoggiato Alfio Marchini»), e arrivando comunque a dichiarare con la sfrontatezza che non le manca, a “In mezz’ora”, che Alemanno e Storace «non sono alleabili perché sono diversi da noi». Diversi in cosa, è presto detto. A domandarlo in giro, disincantati ex parlamentari missini non hanno difficoltà a fare i conti in tasca ai furono colonnelli: Maurizio Gasparri e Altero Matteoli, stabili alla corte di Fi, chissà se alla fine saranno ricandidati, viste le loro molte legislature e la penuria di posti; Ignazio La Russa è sparito dai radar, soprattutto dopo che a Milano Fratelli d’Italia non ha raggiunto neanche il 2,5 per cento e il suo fedelissimo è stato sostituito dall’assessora Beccalossi a vigilare sulla città; Adolfo Urso, che pure ai Fdi s’era avvicinato, pare aver capito che il partito è chiuso come una fortezza; quanto a Gianfranco Fini, è sufficiente la parola “cognato” a negare ogni possibile resurrezione politica. Dicono, insomma, non resti che Giorgia Meloni, lepenista e salviniana, a poter sperare nella sopravvivenza. Lei, che avendola quasi sfiorata con il 3,66 alle europee 2014, la soglia del 4 per cento potrebbe superarla. Grazie non solo all’inseparabile Fabio Rampelli, ma anche a personaggi che hanno già suscitato plurimo interesse della magistratura, come il deputato Pasquale Maietta, già presidente del Latina calcio. Ma tant’è: il totale fa più dello 0,6 per cento accreditato al duo Alemanno Storace. Sarebbe insomma tutto chiaro, ma è appunto qui che invece la faccenda si riaffosca. Perché dopo oltre un ventennio, per incredibile che paia, il pur ineleggibile Berlusconi si apparecchia a fare quel che ha sempre fatto con la destra: la politica del discount, il sottoprodotto del supermercato, per articolare l’offerta sugli scaffali e soddisfare il consumatore. Se dunque non sarà con Meloni, sarà con Alemanno e Storace, perché no. Gli uni contro gli altri potendo. È quel che fece nel 2005 all’allora governatore della regione Lazio, quando gli scagliò addosso la Mussolini di Alternativa sociale; così fece poi contro An, con l’obiettivo di sostituire a Fini La Destra di Storace e Santanché; così, in qualche modo, ha fatto con gli stessi Fratelli d’Italia delle origini, tutt’altro che ostacolando la nascita di un altro partitino a destra che soddisfacesse le smanie anti-Cav senza troppi danni, proprio quando Fini era in declino e Alemanno se ne andava invece verso la deriva montian-europeista (periodo breve); così ha fatto pure l’anno scorso, contribuendo per quel che poteva a far inciampare Meloni prima del ballottaggio. Un divide et impera che è pronto nel cassetto anche stavolta. Nel turno trumpista e sovranista che vede Alemanno addirittura ringraziare pubblicamente il presidente degli Usa. Fatto notevole, per uno che ha inaugurato la sua carriera da leader facendosi manganellare ed arrestare pur di impedire il passaggio all’amerikano George Bush padre, per l’anniversario dello sbarco ad Anzio.
Meglio Starace di Storace, scrive Piero Sansonetti l'1 giugno 2017, su "Il Dubbio". «Spàrati» ha detto il leader della destra radicale a Gianfranco Fini, un esempio fulminante di quanto il linguaggio d’odio abbia invaso la politica. Francesco Storace – ex rampollo, nel Msi, di Almirante e poi di Gianfranco Fini – l’altro giorno ha rilasciato un commento sul suo vecchio compagno d’armi che mi ha lasciato impietrito. Ha detto a Fini: «Spàrati». Fini e Storace vengono tutti e due dal “Fronte della Gioventù” che negli anni ottanta era la potente organizzazione dei giovani neofascisti. Fini era il capo, Storace uno dei suoi luogotenenti. Poi Fini diventò il numero 2 di Almirante, e infine prese lui la guida del partito. E promosse Storace, Gasparri, Alemanno e altri giovani di quella generazione, appena un po’ più giovane della sua. Storace da quel momento assunse il ruolo di personaggio della politica nazionale, anche se per diversi anni continuò a veleggiare all’ombra del capo. Fu deputato, ministro, governatore. Poi, come sapete, Nel 2010 Fini ruppe con Berlusconi, e Storace ruppe con Fini. «Spàrati» disse Storace, novello maramaldo. In politica è così: le biografie umane e le biografie politiche si intrecciano, ma anche si spezzano e si dividono. È naturale, è giusto. Bisogna vedere come si spezzano. E bisogna vedere se è giusto che la politica cancelli il senso dell’umanità, della civiltà. «Spàrati». Che commento è? Che struttura umana c’è dietro? All’inizio della sua carriera, Francesco Storace veniva preso in giro per via del suo nome. Che assomigliava tanto, e differiva solo per una vocale da quello di Starace, uno dei gerarchi più noti di Mussolini. Starace si chiamava Achille, fu portato alla gloria e al potere da Mussolini ma poi abbandonato. Era il segretario del partito nazionale fascista, inventò, pare, il saluto romano e il salto nel cerchio di fuoco e il sabato fascista. Nel 39 però fu allontanato e mandato a ricoprire un incarico minore, il capo della milizia volontaria; poi, due anni dopo, fu allontanato anche da lì e si ritirò a vita privata. Nell’anonimato. Con due lire da parte, senza stipendio, in un appartamentino alla periferia di Milano. Lo aiutava la figlia. Anonimato ma fino a un certo punto. Il 28 aprile del 1945 Milano era stata liberata da poco. Starace, come ogni mattina, scese in strada in tutta a fare jogging. Qualcuno lo riconobbe e lo indicò ai partigiani. Catturato, portato al Politecnico, processo sommario e nel giro di un’ora condanna a morte. Lo portarono su un camion scoperto in giro per tutta Milano, alla gogna, e poi fu scaricato a piazzale Loreto, davanti ai cadaveri di Mussolini, di Pavolini di Bombacci e degli altri gerarchi, appesi a testa in giù alla pensilina del benzinaio. Gli puntarono i fucili contro e gli chiesero, sbeffeggiandolo: «Ora cosa hai da dire al tuo duce?». Starace, che dal duce era stato abbandonato tanti anni prima, levò il braccio nel saluto romano e gridò, solenne: «Onore al duce!». Loro spararono e lo uccisero, poi appesero anche lui per i piedi. Nessun paragone, per carità. Però bisogna dire che nella storia ci sono esempi molto diversi tra loro di quello che è il senso della riconoscenza verso chi ti ha promosso, ti ha aiutato. Il senso del dovere, dell’umanità. Poi c’è un’altra questione: la facilità ad ossequiare chi ha successo e cambiare drasticamente atteggiamento verso chi è caduto a terra. Mi ricordo, da quando andavo a scuola, che Manzoni parlava di servo encomio e di codardo oltraggio. Diceva, mi pare, che erano due facce di una moneta sola. E mi ricordo anche della storia di un certo comandante Maramaldo. Era un capitano di ventura vissuto nella metà cinquecento, diventato famosissimo per avere ucciso il capitano Ferrucci, fiorentino, che era stato già sconfitto e giaceva ferito in modo grave. Ferrucci, prima di spirare, pronunciò contro di lui, che lo uccideva, una frase diventata celeberrima: «Vile, tu uccidi un uomo morto». E da allora maramaldo vuol dire quello: vincitore vigliacco. In questi giorni, sul caso Fini, di maramaldi è pieno il dibattito pubblico. Mica solo Storace: basta dare un’occhiata ai giornali di destra, che una volta, tanti anni fa, Fini lo osannavano. La asperrima durezza delle parole (anzi: della parola) di Storace ripropone un tema che a me sembra attuale e molto vivo. Quello del linguaggio dell’odio in politica. «Spàrati» è un esempio fulminante – e macabro – di questo linguaggio. Su questo tema, tra l’altro, si sta preparando un evento di notevole importanza: il G7 delle avvocature che si terrà in settembre a Roma (sotto gli auspici della Presidenza italiana del G7, come si dice con la formula ufficiale). Torneremo a parlarne nei prossimi giorni. Intanto vi annunciamo che si terrà, che parteciperanno i rappresentanti delle avvocature delle sette principali potenze occidentali, che avrà per titolo «Sicurezza e linguaggio dell’odio». È un tema secondario del dibattito pubblico? Secondo me no. Per una ragione semplice: che l’odio sembra avere preso il posto del conflitto nello svolgersi del confronto o della battaglia politica e anche di quella intellettuale. La “sostanza” del conflitto, che nei decenni passati è stato altissimo – e che si svolgeva sulla differenza netta delle idee, dei punti di vista, dei programmi – è stato sostituito dalla sua “forma”, e cioè dall’odio puro e semplice, allo stato brado, senza oggetto, senza obiettivo, fine a se stesso. E che infatti si esprime e si avvita nel linguaggio. Creando persino nuova semantica, nuove espressioni, nuovi automatismi, nei quali il conflitto esplode senza più il proprio contenuto, ma semplicemente esagerando, riproducendo e moltiplicando il proprio apparire. Il conflitto perde il suo carattere rivoluzionario, o riformista, o reazionario, e diventa estetica pura. L’odio è sempre stato una parte del conflitto. Ancora pochi anni fa un poeta e una mente raffinata come il poeta Edoardo Sanguineti sosteneva la giustezza dell’odio di classe. La sua necessità. Era una posizione molto discutibile e sulla quale, infatti, si aprì un dissenso forte anche a sinistra. Però l’odio di classe di Sanguineti era un aspetto del conflitto, della lotta, un attributo: non era l’essenza del conflitto, e non giustificava se stesso in quanto “passione” ma in quanto prodotto di uno scontro politico. Oggi l’odio non è più al servizio della politica, non è più un soldato: è lui il signore. E sta diventando il signore anche della cultura. Con la conseguenza della scomparsa dell’intellettualità. Sostituita da un piccolo esercito composto da polemisti e da una pattuglietta estremista di magistrati. E della scomparsa del pensiero, sostituito dall’anatema, dall’insulto. Naturalmente a chi denuncia il trionfo dell’odio e della sua lingua si può opporre una obiezione molto robusta. Trent’anni fa si uccideva, nel fare lotta politica, oggi no. Questo sicuramente è vero ed è il segno di un grande avanzamento della civiltà liberale. Non solo non si uccide più nella lotta politica, ma si uccide molto meno anche nella vita sociale e persino la malavita è diventata molto, molto meno violenta. Però i due fenomeni (la caduta della violenza e la caduta del pensiero e della intellettualità) a me non paiono in nessun modo né paralleli né collegati. L’aumento dell’odio nel linguaggio comune e nel linguaggio politico non mi sembra un fenomeno di compensazione della mancata violenza. Mi sembra piuttosto un surrogato del pensiero e della polemica culturale. Ignorare questo fenomeno, contentandosi del fatto che la quantità di violenza è in netta decrescita, potrebbe essere un abbaglio grave. Il linguaggio dell’odio, proprio perché chiude la possibilità di crescita di una nuova generazione intellettuale, rischia di diventare un palla al piede per la nostra civiltà. Un blocco. Cosa possiamo fare per rimuoverlo? E per rimettere in moto un processo virtuoso di ricerca e di polemica politica e intellettuale? E quindi per restituire alla nuova generazione la possibilità di costituirsi in generazione intellettuale, uscendo dalle sabbie mobile dell’invettiva? Gli avvocati, convocando su questo tema il loro G7 si offrono come protagonisti. È un atto di coraggio. Sono un pezzo del ceto intellettuale e possono portare un contributo molto importante. Però si devono muovere anche i giornalisti e anche i politici. Finché continueranno a pensare che il modo migliore per fare lotta politica è quello di tirare monetine addosso all’avversario, è del tutto inutile parlare di cultura, o anche di battaglia politica. E dovremo accontentarci di avere Scansi e Davigo al posto di Pasolini e Leo Valiani.
"Soldi in cambio di leggi". Fini ora teme le manette. L'ex vicepremier e i decreti sui giochi nel mirino Il gip: favori a Corallo e grandi flussi di denaro, scrive Massimo Malpica, Venerdì 17/02/2017, su "Il Giornale". Il timore di Gianfranco Fini, mentre i fantasmi della casa di Montecarlo tornano nottetempo a bussare alla sua finestra, è che qualcuno, soprattutto in procura, possa non ritenerlo un «coglione». La colorita autodefinizione più va avanti la storia, più sembra strategicamente sensata. Sacrifica l'immagine di colui che fu la terza carica dello Stato. Ferisce il suo amor proprio. Ma ne salvaguarda la fedina penale, raccontando di un big della politica che non si accorgeva degli affari strani di parenti e congiunti. Ma non è detto che basti. L'ordinanza con cui la procura ha sequestrato preventivamente una manciata di milioni di euro in cash e case ai Tullianos, infatti, si sofferma intorno al ruolo dell'ex presidente della Camera. Fini per gli inquirenti è il trait d'union tra il capo del colosso del gioco Atlantis, Francesco Corallo, e la sua nuova famiglia, quella portatagli in dote da Elisabetta Tulliani. È lui, Fini, che per primo lega con quell'imprenditore considerato da sempre vicino ad An, durante un viaggio a Saint Marteen, quartier generale caraibico di Corallo, nel 2004. È lui, stando all'interrogatorio di Amedeo Laboccetta, che dopo quel viaggio, nel 2005 aiuta Atlantis a dirimere controversie con i monopoli. E sempre Fini - siamo nel 2007 - avrebbe cercato di spingere il «cognato» Giancarlo, provando a fargli fare da intermediario per un affare immobiliare con Corallo, affare così discutibile che lo stesso Laboccetta boicotta il progetto. E una volta di più è lui che a dicembre 2008, in occasione del primo compleanno di Carolina, figlia sua e di Elisabetta, invita Corallo nella foresteria di Montecitorio. Sono passati pochi mesi dalla celebre cessione della casa di Montecarlo da An alla Printemps ltd, la società offshore dietro alla quale si celava Tulliani, perfezionata per una cifra buona solo per l'acquirente, tanto che gli inquirenti hanno accertato che a pagare non furono i Tullianos ma proprio Corallo, che aveva già provveduto a mettere a disposizione del delfino della family e di Lady Fini i suoi consulenti della Corpag - Walfenzao&co - per costruire la rete di off-shore e preparare il colpaccio immobiliare nel Principato. Fini, dunque, per la procura è l'anello di congiunzione tra Corallo e i suoi parenti acquisiti. Ma gli inquirenti ritengono che il suo ruolo non si limiti a questo. Il rilievo delle sue cariche istituzionali - prima vicepremier, poi presidente della Camera - fa di lui il vero «obiettivo» delle attenzioni rivolte ai Tullianos da Corallo, e il gip lo lascia desumere in maniera esplicita: «Che l'obbiettivo di Corallo fosse altro dai Tulliani - scrive - si desume per tabulas: Corallo è il titolare di un'impresa colossale, i Tulliani una famiglia della piccolissima borghesia romana». Fini invece, «all'epoca», era una «figura istituzionale di elevato rilievo», e dunque gli intrecci tra questi tre poli innescano interessi di «estrema delicatezza», anche perché le tracce di dazioni di denaro, osserva il gip, vengono lasciate «in occasione dell'adozione di provvedimenti di legge di estremo favore per Corallo». Non un solo decreto ma almeno due, il 39/2009 e il 78/2009. La storia mette in fila anomalie di ogni genere, dalle «gravissime interferenze» sui Monopoli alle «inverosimili sottrazioni» alle casse dello Stato, fino alle norme pro-Atlantis approvate, «sintomatiche di condizionamento della vita parlamentare in ragione di flussi di denaro di grande consistenza». Una storia dalle «implicazioni inquietanti», e che al giudice sembra sia stata svelata solo in minima parte, potendo riservare «imprevisti» e sviluppi «piuttosto tumultuosi». Quanto basta per togliere la decantata «serenità» all'ex leader, già scottato nell'amor proprio, ora anche indagato. E sempre più nel fuoco della procura.
Noi, cronisti diffamati per la nostra inchiesta sul clan Fini-Tulliani. "Il Giornale" aveva portato prove e testimoni. Ma ci accusavano: "Siete macchina del fango", scrive Massimo Malpica, Giovedì 16/02/2017, su "Il Giornale". Spargifango. E spione. Di certo non giornalista. Mi hanno detto di tutto in quei mesi passati con Gian Marco Chiocci a inseguire l'affaire immobiliare di Montecarlo, a scavare nella storia di quella casa donata ad An da una contessa e finita nelle mani del cognato del leader di An, Gianfranco Fini, allora presidente della Camera. Eravamo diffamatori, non giornalisti. Manovalanza addetta a spalare letame da lanciare nel ventilatore, autisti della famigerata «macchina del fango». Eppure la storia per noi era chiarissima. Accertato che in quella casa ci viveva il «cognato» Giancarlo, recuperati alla Conservatoria del Principato i contratti di compravendita che mostravano lo «schermo» off-shore utilizzato per nascondere il nome dell'acquirente, pensavamo che il più fosse fatto. Sapevamo che sarebbe stato quasi impossibile «stanare» il giovane Tulliani dal nascondiglio societario messo in piedi nella lontana isola di Saint Lucia, ma abbiamo continuato a raccogliere prove ed elementi che cozzavano con le «versioni ufficiali» erogate con il contagocce e tanta arroganza dall'allora terza carica dello Stato. Che sosteneva di aver saputo che il cognato viveva lì «qualche tempo dopo la vendita» dell'appartamento, manifestando tra l'altro «sorpresa e disappunto» alla sua compagna Elisabetta. E promettendo di dimettersi se fosse stato provato che Tulliani Jr era proprietario dell'appartamento. Lo abbiamo fatto. Raccogliendo meticolosamente prove e testimonianze. Rintracciando il dipendente del mobilificio di Roma, sulla via Aurelia, che, prima anonimamente e poi con nome e cognome, ci disse di aver visto Fini e signora presentarsi in negozio per scegliere la cucina da installare nella casa di Montecarlo e tornare per seguire il progetto e organizzare la spedizione. Abbiamo pensato che un colpo così avrebbe forse aperto una crepa nell'omertà del presidente della Camera. Sbagliavamo. Per Fini - anzi, per il suo portavoce - quella che in seguito si sarebbe dimostrata semplicemente la verità era invece un «delirio diffamatorio». E per quasi tutti gli altri, purtroppo anche per molti colleghi, la vera notizia su cui concentrarsi erano le dimissioni del dipendente del mobilificio, Davide Russo. Che avesse rinunciato a un incarico per amore di verità, a quanto pare, era inaccettabile. Doveva essere stato pagato per farlo. Lui si ritrovò assediato dai giornalisti, che invece di chiedergli se davvero aveva visto Fini comprare la cucina, gli chiedevano conto del perché avesse deciso di raccontarlo a noi. È andata avanti così fino alla fine, l'inchiesta sulla casa di Montecarlo. Da un lato noi del Giornale che battevamo il Principato, inseguivamo a Bergamo gli eredi della contessa Colleoni, volavamo a Santo Domingo e poi a Saint Lucia per accertare la genuinità di una lettera che legava Tulliani a quelle società off-shore. Dall'altro Fini e i finiani intenti a negare tutto, anche l'evidenza, e ad attaccarci, anche personalmente. Hanno continuato a farlo anche quando le prime perquisizioni negli uffici di Corallo avevano portato alla luce i rapporti con i Tullianos. C'era da farsi qualche domanda, ma da Fini è arrivato il solito silenzio. Ingigantito, poco dopo, dalla sua rapidissima scomparsa dalle scene.
E ora ecco che l'indagine sul re delle slot mette a nudo la verità. La verità è che non era Fini il diffamato, semmai noi, derubricati da cronisti a pennivendoli asserviti a una vendetta politica. La verità è che Fini, nella migliore delle ipotesi, è un «coglione», come dice lui stesso. Difficile dargli torto: andava in tv a dire di non sapere nulla, mentre sua moglie mandava fax a Corallo e Corallo faceva piovere milioni di euro nei conti correnti del cognato e del suocero. E nella peggiore delle ipotesi - quella dei pm - è un riciclatore in concorso con la sua dolce metà e il resto della famiglia. Ma questo dovranno dirlo i magistrati.
Gianfranco Fini, da dove arrivano i milioni di euro che girano a casa sua, scrive Franco Bechis il 16 febbraio 2017 su “Libero Quotidiano”. Gianfranco Fini è un uomo generoso. Molto generoso. E romantico. Non è il solo uomo a riempire di attenzioni la propria donna. C’è chi manda fiori, chi compra un anellino, chi qualche altro monile, o un vestito. Lui per la sua Elisabetta Tulliani davvero non ha badato a spese. Come accadde quel 15 aprile 2013. Mancava giusto un mese al 41° compleanno della sua compagna. Fini si era da poco messo in pantofole. La legislatura era finita da un po’, si erano tenute le elezioni che avrebbero portato al governo Letta. Fini aveva provato a restare in campo con un suo partitino alleato con Monti. Non ce l’aveva fatta. Si era illuso di essere centrale: aveva provato a buttare giù Berlusconi con una spallata non riuscita, e quando a farlo fuori pensarono mercati e potenti del mondo, era convinto di essere tra i vincitori. Andò male, e dovette cominciare una vita da pensionato. Intendiamoci, pensionato d’oro, perché da ex presidente della Camera oltre al vitalizio che cominciava a correre, conservava ancora qualche privilegio. E da poco aveva ricevuto una maxi liquidazione per la lunga carriera politica: 260 mila euro. Ovvio che volesse festeggiare con la madre delle sue figlie, Carolina e Martina. Così chiamò Elisabetta e disse: «Controlla un po’ il tuo conto Unicredit... Ci sarà una sorpresina». E che sorpresa! Quel 15 aprile era partito dal conto di Fini presso il Banco di Napoli, agenzia interna della Camera, un bonifico di 800 mila euro. Generoso e assai risparmioso. Poco tempo dopo Elisabetta trasferì dal conto Unicredit a un altro suo conto aperto su Mps 700 mila euro. E con parte di quei soldi comprò una casetta per il week end in montagna, a Rocca di Mezzo (l’Aquila). Bastò metà di quella somma. Con meno di 150 mila euro Elisabetta si è poi comprata anche un negozietto a Roma. C’è anche questa piccola storia familiare fra le pieghe dell’ordinanza di sequestro preventivo alla famiglia Tulliani firmata dal gip di Roma, Simonetta D’Alessandro, portando all’iscrizione di Elisabetta nel registro degli indagati per il reato di riciclaggio e di Fini per concorso in quel reato. Piccolo squarcio nella vita benestante dell’ex presidente della Camera. Piccolo perché a casa Fini (nel comprensorio uno accanto all’altro vive il suocero Sergio Tulliani e ha casa il cognato Giancarlo), i milioni in questi anni a leggere la documentazione giudiziaria circolavano come noccioline. La sola Elisabetta è stata beneficiaria di bonifici per 2,5 milioni (compreso il generoso cadeau del compagno). Di questi 1,7 milioni le sono arrivati indirettamente grazie a Francesco Corallo, il re delle slot machine al centro dell’inchiesta. C’è lui dietro alla famosa (e mai provata finora nei particolari) operazione casa di Montecarlo, che ha portato in cassa a Elisabetta (e anche a beneficio di Fini che vive con lei) 739 mila euro, attraverso due bonifici effettuati dal fratello: uno da 290 mila euro il 24 novembre 2015 e uno da 449 mila il 10 dicembre 2015. Più di mezzo milione le è arrivato dal padre e veniva dalla provvista Corallo, e altro mezzo milione in due tranche (la metà di una somma condivisa col fratello) da una società costituita in un paradiso fiscale (la Jayden Holding ltd) foraggiata da Corallo. Nell’inchiesta salta definitivamente fuori la verità sulla casa di Montecarlo: l’operazione è stata fatta non solo dal cognato - come si era scritto - ma da Elisabetta, che alla fine si godrà anche il 50% della clamorosa plusvalenza per la vendita avvenuta nel 2015. Alla verità ci si arriva non per una riapertura della vecchia inchiesta, ma per l’inchiesta che la procura di Milano stava conducendo su Corallo. I documenti sulla casa di Montecarlo vengono trovati nella memoria di un hard disk sequestrato a Corallo a fine 2014 e in analogo sequestro compiuto a casa di Giancarlo Tulliani nel dicembre 2016. Materiale freschissimo, che inchioda i protagonisti e rende impossibile il fatto che Fini non conoscesse l’operazione dal primo giorno: è a casa sua che arrivano i soldi alla fine. L’inchiesta è all’inizio, e difficilmente si potrà chiudere solo sul filone del riciclaggio e dell’autoriciclaggio (di questo sono accusati Elisabetta e Giancarlo per la vendita monegasca). Perché da Corallo sono arrivati ai Tulliani più di 4 milioni in pochi anni. A che titolo? I magistrati scrivono che è stata creata documentazione fittizia per motivare quei pagamenti, con consulenze mai fatte e che non avrebbero mai potuto fare i Tulliani. Allora perché Corallo pagò, e addirittura versò a Elisabetta e Giancarlo 2 milioni per fare diventare i due suoi soci nella holding del gioco d’azzardo (dovevano prendere il 10% per quella cifra, poi il progetto fu scartato ma loro si tennero i soldi e li investirono in case)? I magistrati individuano un favore che vale quella cifra: il pressing fatto da uomini di Fini sull’allora direttore dei Monopoli di Stato, Giorgio Tino, per ritirare una contestazione che avrebbe messo ko le società di Corallo. Spiegano che l’imprenditore aveva rapporti amicali con Fini, non con i Tulliani, e che fu l’ex presidente della Camera a presentargli la famiglia. Ma non ci sono prove - a parte quelle logiche - che i fatti siano collegati: i finiani fecero quel favore e l’imprenditore lo ripagò con la generosità verso i Tulliani.
Altero Matteoli su Gianfranco Fini: "Si è fatto soggiogare da Elisabetta Tulliani, è tutta colpa sua", scrive Salvatore Dama il 17 febbraio 2017 su “Libero Quotidiano”. «È una vicenda che mi mette tristezza. Non tanto per l’avviso di garanzia, su questo non posso che augurare a Fini di chiarire la sua posizione. Io ne faccio una questione politica». Altero Matteoli, senatore di Forza Italia, è stato per tanti anni responsabile dell’organizzazione di Alleanza Nazionale. Da quell’osservatorio privilegiato ha assistito alla metamorfosi finiana. Cominciata con i primi distinguo ideologici e finita con l’addio a Berlusconi. «Gianfranco era un uomo di destra che, a un certo punto, ha iniziato a parlare di cose che con la destra non c’entravano nulla».
Sulla fecondazione, sulla cittadinanza agli immigrati, sui diritti civili: vi avvisava sempre a cose fatte. Fece così anche con la casa di Montecarlo?
«Guardi, io sono stato uno dei sei o sette dirigenti di vertice di An, eppure non ho mai saputo dell’esistenza di quella casa».
Come è possibile?
«Io sapevo che la contessa Colleoni aveva lasciato al nostro partito una casa, molto bella, in via Paisiello a Roma e un terreno a Monterotondo».
E di Boulevard Princesse Charlotte 14?
«Non ho mai saputo nulla. Ne ho parlato con La Russa e Gasparri, anche loro erano all’oscuro. Quella casa è stata occultata da Fini sin dall’inizio. Ed è una cosa che non riesco a perdonargli. Io ho una storia e, purtroppo, un’età. Ricordo momenti drammatici».
I tempi del Msi?
«An aveva soldi a disposizione, tant’è vero che c’è una Fondazione che ha ereditato quel patrimonio. Ma quando eravamo Movimento sociale, avevamo difficoltà enormi. Ricordo Almirante che firmava le cambiali per poter pagare le sedi. Quando ero il segretario provinciale del Msi a Livorno, ci diedero lo sfratto. Andai da lui chiedendo un aiuto e mi disse: “Soldi? Se vuoi ti do un pacco di cambiali”. Ecco, io vengo da questa storia qui ed è per questo che non riesco a perdonare chi si è preso un bene del partito».
Fini ha detto: “Sono un coglione, non un corrotto”.
«Gli auguro di poterlo provare anche in sede processuale. Però a me non basta che dica che è un coglione. Io voglio che restituisca i soldi della casa di Montecarlo alla Fondazione di An. Se avesse novant’anni, uno direbbe ok, si è rincitrullito. Ma a sessanta no, è troppo presto».
C’è chi sostiene che Fini agiva sotto l’influenza di Elisabetta Tulliani.
«Senta, io nella vita ho avuto problemi familiari. Mi sono separato e risposato. Non riesco a colpevolizzare una moglie per gli errori del marito. Io esprimo un giudizio su di lui, non sulla signora Tulliani. Se sono innamorati, evviva, beati loro. Ma non dovevano prendersi la casa di Montecarlo. Per come sono fatto io, non riesco a capire come uno possa farsi soggiogare dalla moglie. Grande rispetto per la signora, eh, ma stiamo parlando di un uomo che è stato segretario di un grande partito arrivato fino al 15,7%, ministro degli Esteri, presidente della Camera... Glielo dico in toscano: come fa uno così a farsi mettere sotto da una donna? Non riesco a giustificare Fini. L’errore è stato il suo».
Nessuna attenuante.
«Venire a sapere che c’era una proprietà e scoprire che qualcuno l’ha praticamente regalata alla famiglia della sua donna... cosa vuole, io lo trovo insopportabile».
Da quanto tempo non vede Fini?
«Da quando c’è stata la rottura l’ho incrociato un paio di volte ai funerali di amici in comune. Nulla più di questo. Le nostre strade si sono divise quando lui ha deciso di rompere e far cadere il governo Berlusconi».
Se fosse rimasto, oggi sarebbe il leader del centrodestra?
«Ritengo di no. Era un bluff e prima o poi sarebbe venuto fuori. Questa caduta così in basso dimostra che evidentemente lo avevamo sopravvalutato. E dire che, quando Fini è stato eletto la prima volta segretario del Msi, io capeggiavo una lista che era contro di lui perché non lo ritenevo all’altezza...».
Tutte le destre d’Italia (alle prese con Berlusconi). In un panorama confuso e senza leader riconosciuti, è partita la caccia agli alleati, scrive Bruno Manfellotto il 4 gennaio 2017 su "L'Espresso". Ventiquattr’anni dopo, Silvio Berlusconi non ha ancora finito il suo lavoro: badare alle sue aziende e pensare al partito, due facce di una stessa medaglia. Anche in questo il passato non passa, e incombe “La grande Restaurazione” (l’Espresso n.1). Oggi come ieri il destino imprenditoriale di Arcore transita per Roma, lambisce governo ed equilibri di sistema, corre parallelo alla vicenda politica. E ne mima umori e toni: con Vincent Bolloré il Nostro prima tratta, poi rompe e sceglie la carta bollata, ma solo per riprendere i negoziati sul futuro di Mediaset lungo l’asse di interesse nazionale Telecom-Mediobanca-Generali; intanto con i cinesi in corsa per il Milan sorride, media, alza il prezzo, ma quando sta lì lì per colorare di giallo i rossoneri, s’inventa un predellino e ricomincia daccapo: B. è sempre B., in azienda e in politica. Qui però le cose, se possibile, sono perfino più complesse. Rimettere insieme i cocci dell’ex Polo delle libertà è impresa ardua, e se in Francia (ad aprile) o in Germania (a settembre) la sfida elettorale si giocherà tra moderati ed estremisti - François Fillon contro Marina Le Pen; Cdu-Csu di Angela Merkel versus AfD di Frauke Petry - qui la destra si è frantumata in un panorama confuso dal quale non spunta un leader riconosciuto. Per ora ad alzare la voce è l’estrema destra, storicamente tenuta sempre ai margini della scena. Per il resto, tutto è sfilacciato. Di Forza Italia ce n’è più d’una. C’è il cerchio rosa che blinda Palazzo Grazioli e il suo inquilino; c’è Giovanni Toti impegnato a fare da ponte con l’esuberante Matteo Salvini; c’è la fronda dell’ex pupillo Raffaele Fitto, ansioso di rottamare il Capo; e c’è il fronte dei fuorusciti, gli ex fedelissimi Denis Verdini e Angelino Alfano, incerti tra un forno e l’altro, e tra giocare in proprio o riannodare i fili del dialogo. Una volta, poi, l’ex Cav. regnava su una coalizione obbediente; oggi Salvini vuol ballare da solo (con Giorgia Meloni): B. non è più il sole intorno a cui tutto il sistema gira, com’è stato per un ventennio. Un caos. È come se la destra, archiviata l’alleanza laici-cattolici fulcro del moderatismo all’italiana, cercasse una nuova identità. Nell’attesa, liberi tutti. Già, ma per andare dove? E perché? Il fatto è che molto è cambiato da quando sulla scena sono apparsi nuovi protagonisti. Matteo Renzi, per esempio, ha immaginato un Pd capace di attirare voti di centro, magari strappando a Berlusconi i consensi di chi lo vedeva come il campione dell’antisinistra: del resto, al posto dei “comunisti” era arrivato un leader post democristiano per il quale non c’erano cose di destra o di sinistra, ma solo cose da fare… E invece la sconfitta nel referendum, voluto per sancire la svolta, ha spezzato il suo disegno: ora la minoranza del partito sente di nuovo il vento nelle vele, e la destra più radicale si è intestata la vittoria convincendosi che il “no” sia figlio diretto della protesta e dello scontento, le sole parole scritte sui loro vessilli. Per questo Salvini & Meloni parlano ora come gli azionisti di riferimento del postberlusconismo, pur sapendo che c’è un grosso ostacolo sulla loro strada: Beppe Grillo, il terzo incomodo. Intendiamoci, il movimento Cinque Stelle è costruzione ben più complessa, miscela geniale uscita dagli alambicchi del profeta Casaleggio, ma certo gli apprezzamenti per il premier ungherese Viktor Orbán, l’uomo dei muri, e per il campione dell’antieuropeismo Nigel Farage, o le parole nette contro gli immigrati hanno poco a che vedere con le radici ambientaliste e di sinistra, e poco c’entrano con il campo dei moderati. Profumano piuttosto di destra protestataria, e anche per questo concorrono a frenare l’espansione lepenista di Salvini. Che dunque ha bisogno di alleati (ogni tanto lui e Grillo si annusano…), come del resto Berlusconi. Ma mentre il primo insegue sogni maggioritari, il secondo si batte per il ritorno al proporzionale: pensa sia l’unico sistema capace di sterilizzare Grillo e di ridimensionare Salvini e Meloni, premessa per ricompattare una destra moderata e preparare l’unico governo possibile in un sistema tripolare, quello di larghe intese. Restano le domande di fondo: chi verrà dopo di lui? E guarderà a Merkel o a Le Pen? Stefano Parisi s’era messo in testa di rispondere. B. ha lasciato fare, poi lo ha fermato, poi lo ha prudentemente rilanciato, un po’ per non rompere con gli ex alleati, un po’ perché convinto che la destra abbia oggi una sola identità riconoscibile: Berlusconi; e che abbia un solo leader: Berlusconi. Per questo si sbatte ancora. Aspettando che Strasburgo gli restituisca l’agibilità politica. Per ricominciare. Ventiquattr’anni dopo?
C'era una volta il Movimento Sociale Italiano. Oggi ricorrono i 70 anni del Movimento Sociale Italiano, fondato e guidato per molti anni da Giorgio Almirante, scrive Francesco Curridori, Lunedì 26/12/2016, su "Il Giornale". Sono ormai passati 70 anni da quel lontano 26 dicembre 1946 quando Giorgio Almirante, Pino Romualdi e Augusto De Marsanich si riunirono nello studio di Arturo Michelini per fondare il Movimento Sociale Italiano. La destra italiana, da quel momento fino all’avvento della Seconda Repubblica, ha avuto l’ostracismo della "conventio ad excludendum" che teneva fuori l’Msi da ogni ipotesi di alleanze di governo, sia a livello nazionale sia locale. Il Movimento Sociale del 1948 si dichiarava, infatti, erede dell’ultimo fascismo, quello della Repubblica di Salò e faceva suo il programma del Partito Fascista Repubblicano enunciato sulla Carta di Verona. I postfascisti prendevano, perciò, ufficialmente le distanze dal "fascismo-regime" nel nome del motto almirantiano "Non rinnegare, non restaurare", ma si riconoscevano nel fascismo-movimento, il cosiddetto fascismo delle origini, e le sue teorie anticapitaliste. La stella polare era il discorso che Benito Mussolini tenne nel 1919 a piazza San Sepolcro a Milano, quando diede vita ai Fasci di Combattimento. Ma veniamo alla storia della destra del dopoguerra. La prima volta che la fiamma si presentò sulle schede elettorali fu per le amministrative del 1947 quando si presentò alle elezioni amministrative ed elesse tre consiglieri in Campidoglio, mentre alle politiche del 1948, l’Msi guidato da Giorgio Almirante, ottenne il 2% alla Camera e l’1% al Senato. Augusto De Marsanich, nel 1950, prese il posto di Almirante alla guida del partito e cercò di imprimere una svolta moderata al Movimento Sociale così da accelerare il suo ingresso nella vita democratica del Paese. Due anni più tardi, l’alleanza con i monarchici per le elezioni amministrative, portò l’Msi alla vittoria in sei comuni del Sud: Napoli, Bari, Foggia, Benevento e Salerno. Alle elezioni politiche del 1953 il Msi vide triplicarsi i suoi voti passando dal 2 al 5,8% e il congresso di Viareggio dell’anno successivo all’elezione a segretario di Arturo Michelini. Una scelta nel segno della continuità e della moderazione per proseguire quell’opera di ‘inserimento’ che iniziò a dare i suoi frutti con l’appoggio esterno ai governi Zoli e Segni. Fu il voto determinante dato al governo di Ferdinando Tambroni a provocare le manifestazioni di protesta a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza, che impedirono al Movimento Sociale di celebrare nel capoluogo ligure il suo sesto Congresso. In quegli anni i militanti missini furono affascinati dalle teorie di Julius Evola e la corrente spiritualista guidata da Pino Rauti lasciò il partito per fondare Ordine Nuovo. Rauti, poi, nel 1969, con il ritorno di Almirante alla segreteria, si iscrisse di nuovo al Msi, mentre Ordine Nuovo prese una deriva estremista e terrorista. Hanno inizio gli anni di piombo e la strage di piazza Fontana del 2 dicembre 1969 viene attribuita all’estrema destra, ma Almirante, con la ‘politica del doppiopetto’, riesce a tenere lontano il Movimento Sociale da una deriva estremista e nel 1972 dà vista al MSI-Destra Nazionale alleandosi con i monarchici di Alfredo Covelli e Achille Lauro. Le elezioni politiche del 1972 segnano il massimo storico per il partito che ottiene l’8,7% dei consensi ed elegge 55 deputati e 26 senatori. Il Congresso del 1977, però, provoca la prima frattura con l’ala moderata di Ernesto De Marzio che lascia il Msi e fonda ‘Democrazia Nazionale’, un’An ante litteram che scompare nel giro di due anni. Nel frattempo le teorie del francese Alain de Benoist prendono piede anche in Italia e la ‘Nouvelle Droit’ trova voce grazie allo storico Franco Cardini, al politologo Marco Tarchi e all’intellettuale Umberto Croppi, mentre Rauti diventa il leader della ‘sinistra missina’. Gli anni ’70, nel mondo postfascista, sono ricordati soprattutto per eventi tragici come il rogo di Primavalle del 1973 e l’uccisione del militante greco, Mikis Mantakas, avvenuta sempre a Roma nel 1975, mentre la stage di Bologna del 1980 segna simbolicamente la fine degli anni di piombo. Si arriva, poi, al dicembre 1987 quando Almirante, poco prima di morire, lascia la guida del partito al suo ‘delfino’ Gianfranco Fini che traghetta il partito nella Seconda Repubblica. Alle elezioni amministrative del 1993 il Movimento Sociale, grazie a Tangentopoli, viene definitivamente sdoganato dagli elettori: oltre il 40% a Roma e a Napoli con Fini e la Mussolini, sconfitti con onore da Francesco Rutelli e Antonio Bassolino. Sul resto, dal Congresso di Fiuggi in poi, non è più storia dell’Msi ed è meglio calare un velo pietoso…
E per i 70 anni del Msi va in mostra l'orgoglio neofascista. Per l'anniversario della nascita del partito la Fondazione An organizza un'esposizione di cimeli, giornali, foto e manifesti. Tra saluti romani e ritratti del Duce, scrive Paola Fantauzzi il 7 ottobre 2016 su "L'Espresso". Lontana dalle divisioni del presente, le abiure di convenienza, le giravolte di potere e i litigi sul simbolo, la diaspora di An - deflagrata al punto da arrivare fino in Forza Italia - si ritrova unita sotto la fiamma primigenia: quella tricolore del Movimento sociale italiano. Quel Msi, inizialmente Mo.s.it, che fin nel simbolo (il trapezio isoscele a simboleggiare una bara) e nell’acronimo (“Mussolini sei immortale”) già chiariva il senso di tutta una storia. Si intitola “Nostalgia dell’avvenire”, come lo slogan coniato da Giorgio Almirante a fine anni ’60, la mostra che la fondazione Alleanza nazionale ha organizzato per i 70 anni dalla fondazione del partito (26 dicembre 1946). Mezzo secolo di neofascismo, esibito dal prossimo 20 ottobre al 10 febbraio nella sede di via della Scrofa con orgoglio e senza complessi di sorta. Perché del resto, piaccia o no, questo è l’album di famiglia della destra italiana: reduci repubblichini dalla fresca impronta antisemita come padri fondatori, il gene della sconfitta cucito addosso (“Siamo nati in un cupo tramonto”), la nostalgia del Ventennio e l’idea di rivincita, i saluti romani che in Germania tuttora costano l’arresto, le camicie nere in campagna elettorale a imitare tristemente le squadracce di prima della marcia su Roma; gli assalti alle università occupate durante la contestazione giovanile, le violenze di piazza, la morte data e subita durante gli anni di piombo; le istigazioni all’illegalità di dirigenti-capipopolo più che politici, gli ufficiali golpisti e piduisti puntualmente eletti in Parlamento, la vicinanza - se non proprio contiguità - con ambienti implicati nelle trame eversive o stragiste, la campagna per reintrodurre la pena di morte; i cortei studenteschi, uguali identici a quelli di tre decenni prima, che a fine anni ’80, in nome dell’italianità, ancora manifestavano a Trieste contro e la minoranza slovena e a Bolzano contro la maggioranza tedesca. Di tutto questo ovviamente, malgrado le intenzioni non agiografiche professate dagli organizzatori, si trova traccia solo a saper “leggere” storicamente cosa c’è dietro le foto in bianco e nero di quegli anni, dalle piazze gremite ai comizi di Almirante al sostegno, in nome dell’anticomunismo, alle tremende Falangi cristiano-maronite libanesi (così come ai peggiori regimi militari che fecero carta straccia dei diritti umani). Certo, il Msi non fu esclusivamente questo. Fu un partito popolare capace di sfondare al Sud e rivaleggiare per consenso con gli odiati comunisti nelle borgate del sottoproletariato urbano. Fu uno dei primi a porre il tema del presidenzialismo (sebbene prevalentemente per il dna autoritario) ed ebbe al suo interno qualche sparuta voce giovanile che a fine anni Settanta scoprì coi campi Hobbit che l’universo di riferimento non necessariamente cominciava e finiva a Predappio, ponendo (senza grande ascolto va detto) le questioni dell’ambientalismo e del terzomondismo con slogan tipo “né Marx né Coca-cola, né banche né soviet”. Soprattutto ebbe, nelle ultime pagine di storia, la sua grande occasione col declino della Prima Repubblica: la questione morale (“l’Italia onesta in piazza con la destra”), le manifestazioni a sostegno di Mani pulite (“Tangentocrazia ti spazzeremo via”), gli attacchi alla Lega secessionista in nome dell’unità della patria (“Bossi fa avanspettacolo”): tutti temi frettolosamente archiviati e sacrificati sull’altare del potere e dell’alleanza con Silvio Berlusconi, che ha finito per rendere non più così distinguibili la presunta diversità degli inflessibili ex camerati dai disinvolti yuppies forzisti. Tutta una serie di ragioni che spiegano, forse, come mai la destra italiana ancora stenti a trovare, come in Francia, quella via “legalitaria e repubblicana” indicata troppo tardivamente da Gianfranco Fini per essere credibile agli occhi dell’opinione pubblica senza affogare nella miseria elettorale che ha travolto Futuro e libertà. E non è un caso, se si guarda Oltralpe, che il punto di riferimento resti semmai il Front national di Marine Le Pen, altra fiamma tricolore identica a quella del Msi. A conferma di quanto certe radici non sia possibile davvero reciderle del tutto. Soprattutto se non c’è l’intenzione.
Mario Ajello per “il Messaggero” il 7 ottobre 2016. Un pezzo di storia d'Italia visto dall' angolo visuale chiamato Msi. La destra celebra la propria vicenda tornando alle radici, al partito-mamma, alla fase in cui il potere era ancora lontano e l'elogio - ben raccontato - delle origini di un mondo che poi diventerà An e andrà al governo diventa un modo per ripensarsi e magari per ricominciare. Già il titolo di questa mostra è evocativo e si rifà a un vecchio slogan del Msi degli anni 60-70: «Nostalgia dell'avvenire» La star, visto il tema, non può che essere Giorgio Almirante. Ma soprattutto l’esposizione illustra una storia corale: occhio, per esempio, alle foto di piazze strapiene di militanti della destra in decenni in cui nessuno di quella parte politica avrebbe mai potuto immaginare di diventare prima o poi sottosegretario. Almirante uber alles, ma anche Michelini, Romualdi, Rauti, Tatarella, e poco Fini se non altro perché questa bella rassegna si conclude con la svolta di Fiuggi, ossia prima che Gianfranco fosse il simbolo dello sdoganamento della destra e della nuova stagione targata An. 70 anni di fiamma tricolore e di «fiammeggiante passione ideale» scorrono attraverso immagini, documenti, ritagli di giornale, poster, volantini, filmati, cimeli. Il curatore è lo storico Giuseppe Parlato. Il luogo è la Fondazione An in via della Scrofa - dove c' erano le Botteghe Oscure della destra - e la durata della mostra va dal 20 ottobre al 10 febbraio, il Giorno del Ricordo istituito nel 2004 per commemorare le vittime delle foibe. La «Nostalgia dell'avvenire» viene celebrata in un momento critico per la destra di provenienza missina. Tra divisioni, rimpianti, difficoltà di prospettive e beghe anche di tipo legale. Con quelli del Nuovo Msi che rivendicano l'uso della fiamma tricolore: e un gruppo di militanti si sono presentati sotto via della Scrofa con cartelli di protesta gridando «abusivi» contro i camerati di un tempo. Mentre l'ufficiale giudiziario bussa alla porta delle Botteghe Nere minacciando il pignoramento se la Fondazione An non paga le spese legali della causa giudiziaria in corso dal 2006. Occhio, però, c' è Fini che si affaccia da una foto ingiallita in prima pagina del Secolo d' Italia, risalente al giorno in cui Gianfranco vinse il ballottaggio per la segreteria del Msi contro Rauti. Almirante in tutte le salse. Lui sotto la pioggia durante un comizio. Lui insieme a Pinuccio Tatarella. Lui durante un congresso. Il suo nome stampato sulla jeep usata da un gruppo di militanti (in camicia nera) nel corso di una delle tante campagne elettorali. Per non dire della bellezza anche grafica di alcuni manifesti elettorali e delle campagne di reclutamento. Alla presentazione della mostra, gli ex colonnelli di An e di Fini ci sono e lui invece no. A riprova del passato (recente) che non passa. Ecco Ignazio La Russa, Gianni Alemanno, Maurizio Gasparri, Italo Bocchino. Mentre Marcello Veneziani, direttore scientifico della Fondazione An, insiste sull' aspetto pop, ossia sulla partecipazione dei giovani a quella stagione della destra e sul racconto anche antropologico di un tipo umano e politico chiamato il missino, piuttosto che sul versante ufficiale. «Che cosa spingeva un ragazzo a voltare le spalle al proprio tempo e ai suoi tabù e a scegliere di entrare nel Movimento sociale italiano?». Questa, secondo Veneziani, è la vera domanda da porsi oggi. Quando la fiamma non c' è più ma resta, in chi l'ha vissuta, l' orgoglio di una storia.
Settant’anni «dalla parte sbagliata». Istantanee dal Movimento sociale. «Nostalgia dell’avvenire» e divisioni nel partito che conquistava 2,5 milioni di italiani, scrive Pierluigi Battista il 18 ottobre 2016 su "Il Corriere della Sera". Chissà se domani, giovedì, all’apertura a Roma della mostra dedicata alla storia del Movimento sociale nato settant’anni fa, Gianfranco Fini e i suoi colonnelli dell’ex An saranno capaci di non guardarsi in cagnesco, almeno per una volta. Se sapranno riconoscere in quei settant’anni di fotografie, di volantini, di manifesti, di prime pagine delle riviste (quasi cento, tantissime) e dei giornali esposti nella mostra voluta dalla Fondazione Alleanza nazionale e ideata da Marcello Veneziani, le ragioni di un passato comune. O almeno di un’appartenenza a una comunità che nel frattempo si è spaccata con un’animosità rancorosa senza pari, di radici che affondano nella profondità temporale di biografie oramai divise. Difficile, molto difficile. Anche perché la stessa storia di un partito, come dice il curatore della mostra Giuseppe Parlato della Fondazione Ugo Spirito-Renzo De Felice, che ha vissuto prevalentemente sulla coesione di un sentimento, non è fatta per addolcire le asprezze di una rottura personale prima ancora che politica. Eppure è la prima volta che le icone missine vengono messe in mostra per illustrare il senso di una storia. Con il rischio della museificazione, come l’interno della tipica sezione del Msi ricostruita a grandezza naturale sin nei dettagli in questa mostra per rievocare anche fisicamente un carattere e un’atmosfera. Ma un rischio che forse vale la pena correre per conoscere un pezzo importante della vicenda politica italiana repubblicana. Certamente, però, un «come eravamo», per quelli che si sono riconosciuti nella storia oramai conclusa del Movimento sociale, che non potrà forse più declinarsi in un «come saremo», in una comunità sentimentale oramai dilaniata. Ha un senso, oggi nel 2016, restituire visivamente la traiettoria di un partito che è stato in tanti decenni la cornice emotiva di circa due milioni e mezzo di italiani che, ostinatamente, testardamente, sentimentalmente come sostiene appunto Giuseppe Parlato, si sono riconosciuti in un simbolo, la fiamma tricolore, in un linguaggio, in un concerto di voci talvolta dissonanti, in una ritualità che oggi è più difficile decifrare. Facile dire: i fascisti, o i neofascisti. Il Msi, alla sua nascita, fu il rifugio dei vinti, di chi era dalla «parte sbagliata» e che voleva continuare ad esserlo. Poi fu un modo, come scrive Marcello Veneziani nella prefazione al ricco catalogo curato da Simonetta Bartolini, di «voltare le spalle» al pensiero dominante, «mainstream» come si direbbe oggi, giocando con la marginalità, con l’esilio in Patria, con il recinto infetto, in un’opposizione sentimentale e morale prima ancora che politica al «sistema» che poi sarebbe l’Italia «nata dalla Resistenza». Le prime parole dell’inno missino del 1946 suonavano così: «Siamo nati in un cupo tramonto». In questo paradosso, in questo nascere, che dovrebbe essere l’alba, subito piegato al tono lugubre e triste del tramonto, della fine, della sconfitta, della morte, c’è tutta la febbrile sentimentalità di un partito che in questa mostra fa riaffiorare un ribollire di passioni, tutte espresse e frustrate dentro un «ghetto» infrequentabile dal mondo della «parte giusta», sempre sotto il segno della contraddizione. «Nostalgia dell’avvenire» è il titolo di questa mostra che riprende un celebre slogan di Giorgio Almirante, sentimentalmente e iconograficamente la figura centrale di questi settant’anni messi in mostra. Una contraddizione, l’ennesima. Ma quante contraddizioni in un partito in cui i tradizionalisti si mischiavano ai rivoluzionari, i clericali reazionari ai libertini trasgressivi, i fautori nientemeno che di un sistema di caste ai sindacalisti che invocavano le radici di sinistra del fascismo per una completa «socializzazione» dell’economia. Ed ecco allora in questa mostra in cui il Msi tutto «legge e ordine» si mischia con i moti di Reggio Calabria, le battaglie di strada per «Trieste italiana» con i giochi di palazzo con la Dc voluti dalla segreteria di Arturo Michelini ma frustrati dai moti antifascisti del luglio ’60 per il congresso del Msi a Genova. Ecco le piazze piene dei comizi dei leader che raccontano di un’Italia in cui i partiti, e anche il partito che della «nostalgia dell’avvenire» aveva fatto una bandiera, riempivano le piazze di un popolo che non c’è più. Ecco lo sguardo rivolto all’indietro, con le celebrazioni della nascita di Mussolini e le peripezie del corpo tumulato del Duce e gli scontri interni tra le componenti, con le scissioni negli anni Cinquanta dell’«Ordine nuovo» di Pino Rauti (in una dicotomia mai sciolta tra «almirantiani» e «rautiani», un po’ come quella tra «amendoliani» e «ingraiani» in un grande partito altrettanto ideologico come il Pci), e quella degli anni Settanta di «Democrazia Nazionale». Ecco gli anni Settanta, con i morti e lo scontro duro con i «rossi», e il progressivo assottigliarsi della classe dirigente con la morte di Almirante e di Pino Romualdi. E l’astro nascente di Fini con il sostegno della vecchia guardia di Pinuccio Tatarella. E i volti dei dirigenti che compaiono nel filmato curato da Mauro Mazza. E le prime pagine del Secolo d’Italia conservate dai missini come reliquie di un mondo che si sentiva assediato e che oggi appare sepolto, con gli eredi che dopo l’epoca di Fiuggi e di An, si barcamenano tra le sigle per lo più ridotte a minoranza di testimonianza o poco più, con rapporti umani sempre più deteriorati. Con molta nostalgia, certo. Ma quale avvenire?
70 anni fa iniziava la gloriosa avventura del Movimento Sociale Italiano, scrive Antonio Pannullo lunedì 26 dicembre 2016 su “Il Secolo d’Italia”. Esattamente settant’anni fa nasceva il Movimento Sociale Italiano. Ma la nascita del Msi viene preceduta da alcuni fatti, il più importante dei quali si svolge a Roma nel maggio del 1946. Tra i moltissimi gruppi e gruppetti fascisti, ve n’è uno, guidato da Pino Romualdi, detto “il dottore”, che si chiama Far, Fasci di azione rivoluzionaria, al cui vertice si forma un organismo chiamato il Senato, che cerca in qualche maniera di coordinare la nebulosa fascista superstite, in Italia, ma soprattutto a Roma. A fine luglio, il Senato affronta in una riunione a Roma il problema di cosa fare in futuro. Romualdi propone di abbandonare l’Uomo qualunque di Guglielmo Giannini, che aveva riscosso un qualche successo elettorale, e di formare un movimento che catalizzi tutti i fascisti dispersi. La sua tesi passa di misura, così si individuano in Giorgio Almirante e in Giacinto Trevisonno le persone che avrebbero potuto rivestire responsabilità nel nuovo movimento, in quanto Romualdi era ricercato, tanto che poi, nel 1948, fu arrestato e rimase otto mesi in carcere. Insomma, era deciso. Il 3 dicembre ci fu un’altra riunione in via Barberini, a casa del papà del futuro segretario del Msi Arturo Michelini, Renato. Alla riunione partecipano rappresentanti dei giornali fiancheggiatori e i leader di alcuni gruppi politici, tra i quali il Mius, Movimento italiano di unità sociale, di cui faceva parte, tra gli altri, proprio Almirante. Si stabilì di creare un nuovo soggetto politico, come si direbbe oggi, che si chiamerà Movimento Sociale Italiano. Seguirono altre riunioni, con molti e diversi partecipanti, fino ad arrivare a quella decisiva. Il 26 dicembre, dopo altri numerosi – e faticosi – contatti preliminari tra le varie e variegate organizzazioni e associazioni che vi confluivano, e preparato dal giornale Rivolta Ideale (diretto da Tonelli, uno dei membri del Senato), si costituì a Roma il Movimento Sociale Italiano (siglato all’inizio Mo.S.It.), il cui primo atto fu di rivolgere un appello agli italiani per la ricostruzione e presentare i dieci punti programmatici. Tra questi dieci punti, è fondamentale ricordarlo ancora, ve ne era uno dedicato specificamente alla pacificazione nazionale, peraltro sempre respinta dai comunisti. Già il 29 furono affissi per la città manifesti con entrambi i documenti. Si varò lo statuto provvisorio che prevedeva otto organismi. Giacinto Trevisonno fu nominato segretario della giunta esecutiva, mentre a Carlo Guidoboni fu dato il compito di organizzare il nucleo giovanile del nuovo partito, il Fronte giovanile, “nonno” del Fronte della Gioventù, poiché si era convinti, e con ragione, che l’anima del Msi sarebbero sempre state le nuove generazioni, e così in effetti fu sempre. Mentre erano ancora vive l’epurazione, la persecuzione e le vendette cielleniste contro i fascisti, affluirono nel nuovo partito della fiamma tricolore combattenti della Repubblica Sociale Italiana, reduci dai campi di prigionia, epurati, e soprattutto giovani e giovanissimi che la guerra non l’avevano fatta. Si calcola che nel 1945 fossero decine di migliaia i fascisti in carcere a vario titolo, e questo mentre in Italia si parlava di nobili valori, di democrazia, di libertà. Dopo pochissimi mesi, se non settimane, il Msi era già una realtà solida, strutturata, organizzata, radicata sul territorio. Il partito si articolò subito in sezioni comunali e federazioni provinciali. Mancavano i mezzi ma si supplì con il volontarismo, reso ancora più eroico per il fatto che si doveva combattere contro l’ostracismo, la congiura del silenzio della stampa, il carcere, la disoccupazione, la violenza di piazza, anche armata, la penosissima carenza di mezzi economici. Ma soprattutto si doveva combattere contro almeno una parte dei vincitori e la loro arroganza. Il 5 febbraio del 1947 venne redatto uno statuto provvisorio del Fronte giovanile. Il 10 uscì – numero unico – la prima pubblicazione dell’organizzazione giovanile missina, Che l’inse!, dal grido del Balilla. Il 9 febbraio si tenne nella sede del Msi, in corso Vittorio Emanuele 24, il primo giornale parlato, ossia una commistione di comizio, dibattito, confronto tra il pubblico e gli esponenti del partito. Ideato da Almirante e attuato da Mario Cassiano. Il 20 febbraio si costituirono le sezioni Appio-Tuscolano, Italia Nomentano-Città Giardino, Savoia e Colle Oppio, la quale in realtà già era utilizzata in precedenza da combattenti della Rsi e profughi istriani e dalmati, tanto che poi si chiamerà, e si chiama ancora oggi, “Istria e Dalmazia”. Le prima sezione aperte in provincia? Quelle di Guidonia Montecelio e Morlupo. Nel febbraio si costituirono anche i Nuclei universitari del Msi. Oltre a Rivolta Ideale, che Tonelli aveva continuato a mettere a disposizione del Msi, il partito si dotò di un suo modesto organo ufficiale, la Circolare settimanale, due o quattro – poi otto – fogli dattiloscritti su cui veniva raccontata la vita del nuovo Movimento. Sulla Circolare appariva anche la rubrica dei giovani del Fronte, Fanfara. La prima sede del Msi fu aperta in corso Vittorio Emanuele 24, nei cui locali vennero ideati e attuati i cosiddetti giornali parlati, specie di conferenze a ingresso libero dove si esponevano e si commentavano le tesi del Msi o i fatti del giorno e si apriva un dibattito aperto a tutti. Nelle sezioni si costituirono i Gop, gruppi di organizzazione e propaganda, raggruppamenti scelti, antenati dei futuri GO (Gruppi Operativi) di via Sommacampagna degli anni Settanta, “invenzione” di Teodoro Buontempo e Franco Tarantelli. In aprile poi nacquero i nuclei sociali di Prati-Trionfale, Gianicolense-Ostiense, Trastevere-Testaccio, Prenestino, Labicano, Monti-Trevi, Pinciano, Borgo-Ponte e il primo nucleo studentesco, che fu costituito al liceo Dante Alighieri in Prati. Il primo segretario della giunta provinciale di Roma, nata nel gennaio di quell’anno, fu l’avvocato Nestore Sciarretta. Della giunta provvisoria faceva parte, tra gli altri, l’avvocato Mario Niglio, ancora vivente e che ci ha raccontato alcuni di questi episodi. Enzo Erra poi, in un’intervista con Almirante su Intervento, degli anni Ottanta, ci racconta come nacque il simbolo: un mutilato, incontrando Almirante sulle scale nella sede, gli propose di utilizzare la fiamma, simbolo dei combattenti, e gliela abbozzò su un foglio. Fu utilizzata già nelle amministrative romane. Malgrado la commovente penuria di mezzi, al 31 maggio esistevano già 300 sezioni del Msi in tutta Italia con quasi diecimila tesserati. Negli anni successivi Almirante sottolineò sempre il grande ruolo di Rivolta Ideale, “che ha parlato quando gli altri tacevano”. La ragione del successo del Msi e segreto della sua stessa sopravvivenza, fu la immediata diffusione capillare in tutta Italia e il suo radicamento sul territorio, frutto probabilmente dell’esperienza del Partito nazionale fascista che i primi missini portarono con loro. Inizia così la pluridecennale storia del Msi. Nel 1952 poi iniziò l’avventura gloriosa del Secolo d’Italia, per decenni organo ufficiale del Msi e poi di Alleanza nazionale e oggi della Fondazione che ne custodisce gli ideali e la memoria. Il quotidiano fu sempre tenuto in altissima considerazione da tutti i segretari del partito ma soprattutto dai lettori, che non gli fecero mai mancare l’appoggio in occasione delle numerose campagne di autofinanziamento lanciate dal Mai proprio dalle colonne di questo giornale. Tali sottoscrizioni hanno consentito alla comunità di disporre del patrimonio oggi amministrato dalla Fondazione Alleanza nazionale. Ma questa è un’altra storia, che racconteremo presto.
Acca Larentia, quando i giovani fascisti persero l’innocenza, scrive Paolo Delgado il 7 gennaio 2017 su "Il Dubbio". I ragazzi di estrema destra degli anni 70 “persero l’innocenza” 39 anni fa a Roma, in via Acca Larentia dove c’era una sede del Msi: lì il 7 gennaio un gruppo di sinistra sparò a cinque di loro, uccidendone due. Anche quest’anno si chiederà, da destra, verità su quegli omicidi; speculari a chi, da sinistra, chiede la stessa verità per altri morti come Fausto e Iaio. Come se avesse senso, 40 anni dopo, mettere in galera chi, da una parte e dall’altra, combatteva una guerriglia strisciante. I ragazzi di estrema destra degli anni 70 “persero l’innocenza” 39 anni fa a Roma, in via Acca Larentia. In realtà non è chiaro cosa s’intenda con questa definizione confusa e un po’ ambigua, adoperata tuttavia innumerevoli volte a proposito della strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e degli effetti che produsse sui giovani militanti rivoluzionari di sinistra. Ma se si allude a una cesura che provocò la perdita totale di fiducia nello Stato e nella rappresentanza istituzionale della propria parte politica, nei partiti insomma, e che indusse in alcuni scelte drastiche e sanguinarie, allora la piazza Fontana della destra giovanile fu davvero via Acca Larentia. Una piazzetta rialzata, neppure 300 mq, separata da via delle Cave da una scaletta da un lato e dall’altro isolata dalla strada parallela da una fila di piloni. Uno spiazzo chiuso al traffico che è “via” solo di nome, nel quale campeggia dal 1945 la sezione che allora era del Movimento sociale italiano. Era schierato davanti ai piloni il commando dei Nuclei per il contropotere territoriale, sigla sconosciuta che sarebbe ricomparsa solo qualche mese dopo, nel marzo 1978, per inneggiare al sequestro Moro con un volantino fatto ritrovare a Trento e poi nei primi sei mesi del 1979 a Bergamo, con una serie di azioni antifasciste. Cinque o sei giovani a volto semiscoperto, armati di pistole e di una mitraglietta Skorpion che era stata regolarmente acquistata sette anni prima in un’armeria di Sanremo dal cantante Jimmy Fontana, per essere poi rivenduta da quest’ultimo a un funzionario di polizia, che tuttavia ha sempre negato l’acquisto. La stessa mitraglietta è stata ritrovata, dieci anni dopo la mattanza, in un “covo” delle Brigate rosse, portata probabilmente in dote da un militante passato alla principale organizzazione armata di sinistra dopo l’eccidio del 7 gennaio 1978, col quale le Br non avevano evidentemente nulla a che fare. Nella sezione del Msi, la sera del 7 gennaio 1978, c’erano cinque militanti, tutti giovanissimi. Il commando apre il fuoco appena escono per recarsi a un concerto della band di destra “Amici del vento” in Prati: tre riescono miracolosamente a rientrare nella sezione, due ragazzi restano a terra. Franco Bigonzetti, vent’anni, che aveva aperto la porta ed era quindi stato il primo a uscire e a essere colpito a morte, Francesco Ciavatta, diciotto anni, aveva provato a fuggire ed era stato fulminato a pochi metri dalla sezione. Agonizza per qualche minuto, poi spira anche lui. Suo padre si suiciderà poco tempo dopo, ingoiando una bottiglietta d’acido muriatico sulla panchina di un giardinetto della Capitale. Dei tre superstiti uno, Vincenzo Segneri, è ferito a un braccio, gli altri due, Maurizio Lupini e Giuseppe D’Audino, sono illesi. Il gruppo di fuoco non è mai stato identificato. Nel 1987, sulla base della testimonianza di una Br pentita, sono state arrestate cinque persone, assolte tre anni dopo. Tutti liberi tranne uno, Mario Scrocca, impiccatosi in cella pochi giorni dopo l’arresto. Anche quest’anno, come in ogni 7 gennaio, si leveranno alte le voci che da destra chiedono verità su quegli omicidi, speculari a quelle che, da sinistra, chiedono la stessa verità, la stessa individuazione tardiva dei colpevoli, per gli assassini di Fausto e Iaio a Milano o di Valerio Verbano a Roma. Come se avesse senso, a quarant’anni di distanza, mettere in galera i ragazzi che, da una parte e dall’altra, combattevano allora una guerriglia strisciante, spesso una vera “guerra per bande”, inspiegabile e criminale solo a guardarla con gli occhi del presente. O come se ci fosse qualche mistero da chiarire, qualche incognita da svelare sul perché di quegli omicidi. Basterebbe invece sfogliare i quotidiani del mese precedente, che riportano praticamente ogni giorno la notizia di un’aggressione contro passanti considerati “di sinistra” sulla base della lunghezza dei capelli o dell’abbigliamento al centro di Roma. La città era divisa a macchie di leopardo già da anni: c’erano quartieri in cui era pericoloso passare per i rossi e zone precluse ai neri. Ma il centro, sino a quel momento, era rimasto abbastanza neutrale. L’occupazione da parte dei fascisti, alla quale i giornali davano enorme risalto, costituiva un’alterazione sensibile degli equilibri, e del resto proprio dopo Acca Larentia Pino Rauti, il dirigente del Msi più vicino all’area giovanile e ribelle, chiese ufficialmente una “tregua” ed è un fatto che le aggressioni al centro cessarono. Non c’è molto d’altro da spiegare. Se le cose si fossero fermate lì, la tragedia non sarebbe stata altrettanto traumatica. Uccisioni e ferimenti tra militanti di destra e sinistra non erano magari all’ordine del giorno ma quasi. Però non finì lì. Decine, forse centinaia di militanti di destra convergono su Acca Larentia. Tra loro c’è Stefano Recchioni, un ragazzo di 18 anni che suona nella rock band di destra Janus e che è in attesa di partire per il servizio militare entro una decina di giorni. La tensione, nella piazzola, è altissima e cosa provochi la nuova tragedia resterà per sempre un mistero. Sta di fatto che a un certo punto la polizia schierata in forze inizia a tirare lacrimogeni. Il capitano Edoardo Sivori apre il fuoco, la pistola s’inceppa, se ne fa passare un’altra, continua a sparare. Vicino a Recchioni ci sono Bruno Di Luia, storico militante e picchiatore tosto del neofascismo romano, e Francesca Mambro, una delle prime ad arrivare perché il fratello Mariano frequenta abitualmente Acca Larentia. Lo vedono cadere, ferito alla testa. Morirà due giorni dopo in ospedale. Il ministro degli Interni Cossiga si prodigherà subito per evitare ogni accusa al capitano Sivori, oggi generale, che del resto non verrà mai inquisito. Circoleranno perizie di dubbio valore che lo scagionerebbero. Lo stesso Cossiga, decenni più tardi, riconoscerà di aver fatto il possibile e anche qualcosina in più per proteggere il capitano Sivori, incluso il farlo espatriare poco dopo il fattaccio. Il Msi comunque non muove un dito per mettere il capitano sotto accusa. Quando i giovani militanti, furiosi, vanno a cercare Almirante, che è invece all’estero, vengono invece ricevuti da Pino Romualdi, fondatore del partito. Li affronta e respinge senza mezzi termini. Polizia e carabinieri costituiscono uno dei principali bacini elettorali del partito: perdere quella massa di voti è fuori discussione. Ma non c’è solo questo. Da anni il partito neofascista ha fatto del supporto e dell’esaltazione delle forze dell’ordine il perno della sua politica. Non è probabilmente solo per opportunismo che la sua leadership non vuole e forse non può attaccare direttamente un carabiniere. La difficoltà, del resto, non deve riguardare solo i dirigenti. Tra tutti i militanti presenti in via Acca Larentia al momento dell’uccisione di Stefano Recchioni, una sola, Francesca Mambro, avrà il coraggio di presentarsi in questura per denunciare Sivori.
Molti non se la sentono di mettersi contro le forze dell’ordine e contro il partito. Altri però evitano la denuncia perché sono già oltre quella fase, già pronti, come arriverà a essere presto anche Mambro, a uno scontro con lo Stato, ma anche col Msi, ben più estremo. Il trauma del 7 gennaio ‘ 78 arriva infatti al termine di una fase che non è esagerato definire come “il ‘ 77 nero”. I giovani neofascisti di fine decennio, a differenza dei fratelli maggiori, somigliano ai loro nemici. Formano band rock. Discutono di musica, fumetto e cultura alternativa. Celebrano il nuovo corso nel primo Campo Hobbit, che si svolge proprio nel ‘ 77. Revocano in dubbio lo schieramento a favore dell’ordine e si reinventano come rivoluzionari. Mettono in discussione il primato sino a quel momento assoluto dell’anticomunismo e vagheggiano anzi alleanze tra il radicalismo di destra e quello di sinistra contro il comune nemico: lo Stato borghese. I fascisti “rivoluzionari” e antisistema scelgono di marcare la differenza adottando un simbolo alternativo alla fascia tricolore, la croce celtica, che Almirante tenterà invano di proibire. Allo stesso tempo cresce un’insofferenza contro il partito che usa i giovani come servizio d’ordine, come truppa indispensabile per rendere agibili le piazze e le strade, salvo poi scaricarli per difendere una linea politica tutta centrata sulla difesa dell’ordine. Dopo la sua uccisione molti ricorderanno una frase tragicamente profetica di Stefano Recchioni: «I dirigenti ci usano come carne da macello». Come il ‘ 77 rosso è segnato dallo scontro frontale con il Pci, quello neofascista vede una progressiva presa di distanza, simile ma non identica dal Msi. Il partito della fiamma tricolore, a differenza del Pci, non è un partito di potere ed è ormai tagliato fuori anche da quella partecipazione frequente alle amministrazioni locali, in alleanza con la Dc, che era stata invece frequente negli anni 50 e 60. Non può permettersi una rottura clamorosa con la propria area giovanile come quella che sceglie invece il partito di Berlinguer. Dunque li sconfessa ma in maniera “morbida”. Smette di pagare gli affitti delle sezioni più ribelli e incontrollate, come quella di Monteverde che formerà il nucleo centrale dei Nar, o come quella del Fuan di via Siena che diventerà il centro del ‘77 nero. Ma la distanza diventa sempre più incolmabile ed esplode dopo gli spari di Acca Larentia. I giovani fascisti si scontrano per giorni con la polizia, ed era successo pochissime volte in passato: a Reggio Calabria, nel 1970- 71, durante la più lunga rivolta urbana dell’intero occidente post- bellico, poi a Milano, il 12 aprile 1973, quando era stato ucciso l’agente Antonio Marino. In quell’occasione era stato lo stesso Msi a denunciare i responsabili. Stavolta i giovani fascisti ingaggiano vere battaglie, e non solo a Roma. Per la prima volta il nucleo dei futuri Nar spara non sui compagni ma sulle forze dell’ordine. Nel mirino però, ancora più degli agenti, c’è l’estabishment del Movimento sociale italiano.
C’ERANO UNA VOLTA I LIBERALI.
"La società aperta non è spalancata, i suoi nemici credono di avere la Verità". Il filosofo liberale spiega il concetto politico chiave del pensiero di Popper, le sue mistificazioni, i rapporti con la religione e il cristianesimo, la necessità di non tollerare gli intolleranti e i violenti, scrive Gianluca Barbera, Mercoledì 29/03/2017, su "Il Giornale". Dario Antiseri, classe 1940, filosofo liberale e cattolico tra i più autorevoli e maggiormente tradotti nel mondo, nella primavera del 1964 ebbe l'opportunità di conoscere a Vienna il grande filosofo di origine austriaca naturalizzato britannico Karl Popper, padre della teoria della «falsificabilità» (Logica della scoperta scientifica, 1935), rivoluzionaria in campo scientifico e densa di conseguenze anche in altri ambiti, nonché teorico della «società aperta» (La società aperta e i suoi nemici, 1945), opera chiave della politologia contemporanea, e in particolare del pensiero liberale, che tuttavia ha atteso decenni prima di venire pubblicata in Italia per le ragioni approfondite da Bruno Lai nel saggio Popper in Italia. Le disavventure di un filosofo politico (Armando, Roma, 2001).
«Società aperta»: un concetto ormai tanto usato e spesso abusato. Come si configura nel pensiero di Popper?
«La società aperta è la società che è aperta a più valori, a più visioni del mondo filosofiche e religiose, a più proposte politiche, e quindi a più partiti, alle critiche più incessanti e severe dei diversi punti di vista. La società aperta è aperta al maggior numero possibile di idee ed ideali diversi e magari contrastanti. La società aperta, pena la sua autodissoluzione, è chiusa solo agli intolleranti e ai violenti. In altri termini: la società aperta è aperta, ma non spalancata. E siccome sappiamo che la libertà non si perde tutta in una volta, il prezzo della libertà è l'eterna vigilanza...».
Certo, la libertà non è un dato anagrafico... e si può perdere. Società aperta e libertà vivono e muoiono insieme. Chiarita l'idea di società aperta, risulta chiaro anche il suo contrario, cioè l'idea di «società chiusa». E ben si comprendono le argomentazioni critiche che Popper rivolge contro Hegel e Marx, «falsi profeti» e nemici della società aperta...
«Nella società aperta è sempre Popper a parlare gli uomini hanno imparato ad assumere un atteggiamento in qualche misura critico nei confronti dei tabù e a basare le loro decisioni sull'autorità della propria intelligenza, dopo una discussione. E se la società aperta trova il suo primo, anche se non unico presupposto nella fallibilità della conoscenza umana, il primo fondamento della società chiusa sta esattamente nella presunzione di quanti si reputano legittimi possessori di verità assolute, interpreti del giusto ed ineluttabile senso della storia o illuminati da una indiscutibile visione di società perfetta. Costoro saranno divorati dallo zelo di imporre questa loro presunta Verità assoluta, e la loro politica sarà inevitabilmente come insegna la storia di ieri, ma anche quella di oggi una politica di carnefici. La società chiusa è una società magica, collettivistica, crudele. È una società bloccata e pietrificata, è sempre l'esito di una tenace follia per tornare e restare nella gabbia della tribù».
Platone edifica uno dei monumenti della storia del pensiero politico, La Repubblica, fondandolo su una domanda capitale: «A chi spetta governare?». Questo è l'interrogativo che si pone Platone e che Popper contesta. Questa domanda le pare mal posta? I teorici della politica non hanno risposto e non rispondono forse a tale domanda?
«La domanda non solo è mal posta, ma è addirittura irrazionale, e questo per la semplice ragione che essa ci manda alla ricerca di ciò che non esiste. Non esiste un individuo, un ceto, una razza, una classe... che sia venuta al mondo con l'attributo della sovranità sugli altri. La giusta domanda afferma Popper è un'altra: Come controlliamo chi comanda?, cioè: Come possiamo organizzare le istituzioni in modo da evitare che governanti cattivi o incompetenti facciano troppo danno?. È questa la domanda sottesa alla società aperta. La democrazia consiste nel mettere sotto controllo il potere politico. È questa la sua caratteristica essenziale».
Restando sempre in argomento, a lei, filosofo cattolico, debbo necessariamente porre questa domanda: come mettiamo insieme la laicità di uno Stato che non vogliamo più assoluto e la tradizione fondata sulle nostre radici giudaico-cristiane? Per essere ancora più chiari: non c'è una stridente antinomia tra la concezione cristiana della vita e la laicità dello Stato?
«Lei, dunque, mi chiede se l'essere cristiano sia compatibile con la laicità dello Stato. Ebbene, a chi sembra dubitarne e a quanti si ostinano a negare tale compatibilità, io mi permetto di rivolgere quest'altra domanda: lo Stato laico cioè la Società aperta o Stato di diritto sarebbe stato possibile senza il messaggio cristiano? Attraverso di esso ha fatto irruzione nella storia degli uomini l'idea che il potere politico non è il padrone della coscienza degli individui, ma che è la coscienza di ogni uomo e di ogni donna a giudicare il potere politico. Per il cristiano solo Dio è il Signore, l'Assoluto. Lo Stato non è l'Assoluto: Káisar (Cesare) non è Krios (il Signore). E con ciò il potere politico è stato desacralizzato, l'ordine mondano relativizzato e le richieste di Cesare sottoposte al giudizio di legittimità da parte di coscienze inviolabili, di persone fatte ad immagine somiglianza di Dio. La secolarizzazione con un mondo non più sacro e con un uomo che, per quanto possa illudersi, non è Dio, è una chiara conseguenza del messaggio evangelico. Il messaggio cristiano libera l'uomo dall'idolatria: il cristiano non può attribuire assolutezza e perfezione a nessuna cosa umana. È, dunque, per decreto religioso che lo Stato non è tutto, non è l'Assoluto».
Queste sue argomentazioni paiono mal conciliarsi con larghi strati di popolazioni europee ormai dimentiche delle radici cristiane nelle quali affonda la loro tradizione...
«Questo è il vero dramma dell'Europa dilaniata da un irrefrenabile cupio dissolvi. E resta valido l'ammonimento di Rosmini: Chi non è padrone di sé, è facilmente occupabile. Senza le idealità cristiane l'Occidente non esisterebbe e non potrà seguitare ad esistere. Certo, la Grecia ha passato all'Europa l'idea di razionalità come discussione critica, per cui, per dirla con Percy Bysshe Shelley, noi tutti siamo greci, ma è anche vero, come ha scritto Wilhelm Röpke, che soltanto il Cristianesimo ha compiuto l'atto rivoluzionario di sciogliere gli uomini, come figli di Dio, dalla costrizione dello Stato. Fu per semplice osservanza della verità che Benedetto Croce volle precisare in Perché non possiamo non dirci cristiani che il Cristianesimo è stata la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto. E ne La società aperta e i suoi nemici è un ateo come Popper a riconoscere del tutto apertamente che gran parte dei nostri scopi e fini occidentali, come l'umanitarismo, la libertà, l'uguaglianza, li dobbiamo all'influenza del Cristianesimo. I primi cristiani ritenevano che è la coscienza che deve giudicare il potere e non viceversa. E la coscienza, come ultima corte di giudizio nei confronti del potere politico, in unione con l'etica dell'altruismo, è diventata la base della nostra civiltà occidentale. Non si può dare torto a Thomas S. Eliot quando afferma che se il Cristianesimo se ne va, se ne va tutta la nostra cultura. E allora si dovranno attraversare molti secoli di barbarie».
La scienza non risponde per principio alle domande più importanti per l'uomo. La filosofia non salva. Dunque, in che direzione possiamo rivolgere lo sguardo?
«Se permette, tento di risponderle con le parole di Norberto Bobbio: La grande filosofia è scomparsa, non c'è nessuna conquista filosofica che valga. E procedimenti di ricerca che permettono un sapere totale (che è poi l'onniscienza, il sapere di Dio, sarete come Dio') con la stessa certezza e la stessa pratica efficacia con cui la scienza ha conquistato di volta in volta un sapere parziale, nessuno sinora li ha trovati. Ora, però, se è vero che non c'è nessuna riconquista filosofica che valga, esiste ed è esistita urgente, sempre pressante, la domanda filosofica che è richiesta di senso. E richiesta di senso chiarisce Bobbio significa bisogno di dare un senso alla propria vita, alle nostre azioni e alla vita di coloro verso i quali dirigiamo le nostre azioni, alla società in cui viviamo, al passato, alla storia, all'universo intero. È così che Bobbio torna alla domanda metafisica fondamentale: Perché l'essere e non il nulla? Perché ci sono cose, uomini, animali, piante, stelle, galassie, in una parola il mondo e non invece il non-mondo? Insomma: Perché l'universo e non il non-universo? Tale interrogativo, ad avviso di Bobbio, è una richiesta di senso, che rimane senza risposta, o meglio rinvia ad una risposta che mi par difficile chiamare ancora filosofica».
Se è difficile chiamare ancora filosofica la risposta alla domanda filosofica, questa risposta di che natura è... e dove trovarla?
«Quel che io penso senza per altro presumere che la mia idea sia la giusta interpretazione del pensiero di Bobbio è che la risposta alla richiesta di senso sia una risposta di natura religiosa. Wittgenstein: Pensare al senso della vita significa pregare; Credere in un Dio vuol dire vedere che la vita ha un senso; Il senso della vita, cioè il senso del mondo, possiamo chiamarlo Dio. La scienza dà risposte parziali e la filosofia pone solo domande senza dare le risposte. Ma, proprio perché le grandi risposte non sono alla portata della nostra mente, l'uomo rimane un essere religioso, nonostante tutti i processi di demitizzazione, di secolarizzazione, tutte le affermazioni della morte di Dio, che caratterizzano l'età moderna e ancor più quella contemporanea».
Lei ha scritto: «Da tutta la scienza non possiamo estrarre un grammo di morale». Le chiedo: come è allora possibile fondare quei valori supremi per i quali, come diceva Kierkegaard, «si può vivere o morire»?
«Se poniamo attenzione alle diversità, esistite nel passato ed esistenti oggi, delle concezioni circa il bene e il male, ma se soprattutto volgiamo lo sguardo alla storia delle vicende e dei conflitti umani, dovremmo allora ripetere con Pascal che il furto, l'incesto, l'uccisione dei figli o dei padri, tutto ha trovato posto tra le azioni virtuose; singolare giustizia, che ha come confine un fiume! Verità di qua dei Pirenei, errore di là. La realtà è che i valori e le norme etiche sono proposte di ideali di vita, di azioni corrette, di leggi giuste, di istituzioni valide ecc. e non proposizioni indicative. L'etica non de-scrive; essa pre-scrive. L'etica non spiega e non prevede; l'etica valuta. Difatti non esistono spiegazioni etiche. Esistono soltanto spiegazioni scientifiche; e valutazioni etiche. Né si danno previsioni etiche (o estetiche). L'etica non sa. L'etica non è scienza. L'etica, per usare un'espressione di Uberto Scarpelli, è senza verità. Tutta la scienza e qualsiasi altra teoria descrittiva, magari metafisica, non può logicamente produrre etica. E non lo può perché da proposizioni descrittive non è possibile dedurre asserti prescrittivi. È questa la nota legge di Hume, in base alla quale ben si comprende, appunto, che da tutta la scienza non è possibile spremere un grammo di morale. Dunque, il pluralismo in etica è una realtà inoppugnabile, ieri come oggi...».
Professor Antiseri, diciamolo chiaramente: pluralismo etico non è sinonimo di quello spettro che è il «relativismo»?
«Le direi che su di un argomento del genere occorre la massima cautela. In realtà è ben vero che, allorché si parla di pluralismo etico, ad esso si abbina subito, in senso dispregiativo, il concetto di relativismo, intendendo con esso che tutte le etiche sono sullo stesso piano, che una vale l'altra e che tutte valgono zero. Va da sé che, intesa in questo senso, l'idea di relativismo è fattualmente falsa, per il semplice motivo che il pluralismo non rende i sistemi etici uno uguale all'altro: ogni sistema etico è diverso dall'altro. Ama il prossimo tuo come te stesso non è la stessa cosa dell'occhio per occhio, dente per dente; non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te non è la stessa cosa di chi grida uccidi l'infedele, stermina l'altra razza, sopprimi la classe borghese facendo attenzione che non bisogna accarezzare la testa di nessuno, potrebbero morderti la mano: bisogna colpirli sulla testa senza pietà...».
Dunque: il pluralismo etico ci «condanna» a essere liberi, liberi e responsabili di ciò che scegliamo e di ciò che facciamo...
«Sì, è così. Predicare l'etica è difficile, fondarla è impossibile, ripete Wittgenstein ricalcando, mutandola, l'espressione di Schopenhauer: Predicare l'etica è facile, fondarla è difficile. Ecco, dunque, dove tutte le etiche sono uguali; per nessuna di esse si è in grado di trovare un fondamento razionale, ultimo e definitivo. Siamo costretti a scegliere. E scegliere ad occhi aperti impone di valutare le conseguenze delle nostre scelte. Il pluralismo dei sistemi etici è una sfida alla coscienza di ogni uomo e di ogni donna. Le nostre scelte non ci giustificano, ci giudicano».
Che errore aver dimenticato Benedetto Croce! Scrive Luciano Lanna il 7 gennaio 2017 su "Il Dubbio". DUE SAGGI DI CORRADO OCONE SPIEGANO IL MOTIVO DI QUESTA GRAVE MARGINALIZZAZIONE DEL GRANDE FILOSOFO, DI CUI RICORREVANO I 150 ANNI DALLA NASCITA. Si è appena concluso il 150enario della nascita di Benedetto Croce, e bisogna dire che anche in questa occasione davvero pochi si sono interrogati sulle ragioni dell’oblio che ha avvolto in Italia l’opera e il profilo del grande filosofo, storico e intellettuale. Tra chi lo ha fatto, si segnala l’impegno di Corrado Ocone, filosofo e saggista di ultima generazione che nella circostanza dell’anniversario ha mandato in stampa ben due lavori sul tema specifico: Attualità di Benedetto Croce (Castelvecchi, pp. 57, euro 11,50) e Il liberalismo del Novecento (Rubbettino, pp. 267, euro18,00), di cui gran parte è proprio dedicata alla riflessione crociana. Due lavori esplicitamente “polemici”, nel senso che intendono contestare e criticare le tesi storiografiche e teoriche vigenti che oggettivamente sono la causa del silenzio e della marginalizzazione della fortuna teorica, e non solo, di Croce. In particolare, Ocone confuta sia il pregiudizio sulla presunta “inautenticità” del liberalismo crociano sia quello sull’irrilevanza dell’ultima fase dell’attività intellettuale del pensatore napoletano. Due pregiudizi, viene sottolineato, che stanno sostanzialmente all’origine del “paradosso Croce”, quello per cui il pensatore che – con Giovanni Gentile – aveva innovato la filosofia italiana ai primi del Novecento, che aveva introdotto i filoni culturali europei d’avanguardia nel nostro dibattito teorico, che aveva fatto conoscere da noi Marx e Sorel, che era stato il promotore del Manifesto degli intellettuali antifascisti. In pieno regime, che era stato senatore e ministro della Pubblica Istruzione con Giolitti, che dopo la caduta del fascismo fu due volte ministro, che divenne presidente del Partito liberale, che fu uno dei cosiddetti Padri costituenti e che rifiutò sia di diventare il primo presidente della Repubblica italiana che di venire nominato senatore a vita, venne – strana eterogenesi dei fini. Sia da subito inspiegabilmente escluso dal circuito egemonico– culturale della Prima Repubblica. «Nel secondo dopoguerra Croce è stato considerato, dalla cultura dominante in Italia, per lo più un pensatore “retrivo” e “provinciale”. Ma era – sottolinea Ocone – un’evidente distorsione dei fatti, dettata sostanzialmente da motivi politici: dal predominio, nel nostro Paese, di un blocco di potere culturale, per una parte marxista (seppure spesso di diversa tipologia) e per una parte di ispirazione azionista…». Proprio mentre l’ultimo Croce si collocava in una eccezionale sintonia con il meglio della cultura libe- rale e antitotalitaria internazionale – da Orwell a Koestler, da Camus alla Arendt, da von Hayek e Popper, da Talmon a Huxley – in Italia gli ultimi suoi anni di attività intellettuale, quelli che vanno dal 1942 al 1952, vengono considerati solo la produzione di «un vecchio e stanco pensatore, non più capace di mettersi in sintonia con il suo tempo, tutto volto a un passato che non ci sarà più». Spiega Ocone: «Il nuovo blocco di potere culturale, in parte sollecitato dagli interventi e dalla politica di Palmiro Togliatti, quello che allora si sedimentò e che avrebbe governato per tanti anni editoria, informazione, accademia», fu all’origine della censura nei confronti di Croce. Gli stessi allievi del filosofo napoletano passarono tout court nelle file dell’azionismo quando non del partito comunista. E Croce finì come un isolato, precisa ancora Ocone, «non perché fermo ai vecchi tempi, ma perché rispetto ai presunti innovatori era più moderno e vedeva più lontano». Non a caso, gli ultimi scritti crociani si rivelano, ancora oggi, di un’attualità straordinaria, individuando tutti la minaccia del totalitarismo proprio mentre l’anziano intellettuale mette in guardia dagli inganni del liberalsocialismo e dell’azionismo. Così, nel 1947, Croce pubblica il saggio L’Anticristo che è in noi, in cui, tra l’altro identifica nel ragionare per astrazioni intellettuali, per ideologia, uno dei tratti distintivi del totalitarismo. In un saggio del 1943 – Una parola desueta: l’amor di patria – sottolinea la radice liberale del patriottismo opponendola alle patologie del nazionalismo e della statolatria. E nel 1949, sul settimanale “Il Mondo”, pubblica La città del Dio ateo, un saggio tutto incentrato sull’interpretazione del romanzo antitotalitario 1984 di George Orwell, sottolineando che lo Stato totalitario andasse «studiato in sé, fuori di ogni equivoco di fini umanitari sia di politica internazionale». A questo pregiudizio – quello di un Croce fuori del suo tempo, e quindi da mettere teoricamente da parte rispetto agli sviluppi dell’attualità politica post– bellica – Ocone aggiunge l’altro, quello che lo escluderebbe dal circuito dei veri pensatori liberali. È infatti ancora opinione diffusa tra gli studiosi che quello di Benedetto Croce sia stato non solo un liberalismo atipico e inautentico ma che esso sia maturato molto tardi, dopo i tormenti della Grande Guerra, quasi a sconfessione di un pensiero precedente e anzi fortemente ispirato agli autori del realismo politico, da Machiavelli a Marx, da Sorel a Treischke. A parte che altri grandi pensatori liberali novecenteschi, su tutti Raymond Aron e Isaiah Berlin, sono partiti dallo stesso background teorico, resta il fatto che è proprio su una considerazione non illuministica e astratta del reale che nasce il più profondo e proficuo liberalismo del Novecento. Due sono, infatti, secondo Ocone, le coordinate di una vera posizione teorica autenticamente liberale: la critica al razionalismo astratto, all’intellettualismo ideologico, all’illuminismo omologante, al positivismo; la messa in scacco di ogni “filosofia della storia”, di ogni pretesa di conoscere le leggi della dialettica storica e di poterne prevedere il decorso e gli sviluppi. E da questo punto di vista – leggiamo in Il liberalismo del Novecento – cinque, e solo cinque, sono i veri teorici novecenteschi del liberalismo. Non Bertrand Russell, non John Rawls, non Norberto Bobbio ma, invece, Karl R. Popper, Michael Oakeshott, Friedrich A. von Hayek, Isaiah Berlin e, primo tra tutti, proprio Benedetto Croce. «Primo – sottolinea Ocone – per motivi cronologici, ma anche sostanziali, cioè relativi alle sue idee». Machiavelli e Vico sono, oltretutto, le matrici del liberalismo di Croce. La libertà, secondo il filosofo, infatti non nasce da una precettistica astratta ma si lega alla Storia e al realismo politico, a una visione complessa e non riducibile dell’essere umano, al rifiuto di qualsiasi schematizzazione ideologica a una direzione. Sulla scorta di Machiavelli, nessun ordine ideologico racchiude la realtà, il conflitto è ineliminabile dalla vita, esso è il senso dei “distinti”, del pluralismo crociano. La vita non ama essere imbrigliata, vive e prospera nel conflitto, nell’antagonismo, nella diversità. Si spiega, da questo punto di vista, anche la connessione tra liberalismo e patriottismo, seguendo la lezione risorgimentale, che significava – secondo Croce – «opporre il principio di individualità alle tendenze universalizzanti, omogeneizzanti, cosmopolitiche, razionali in senso astratto che avevano dominato nel Settecento in Europa. Cosa è infatti la Nazione se non un’individualità storica, un gruppo di individui che ha elementi in comune forgiatisi attraverso il tempo in un modo specifico e determinato diverso da quello di altri gruppi?». Già il suo sistema filosofico la “filosofia dello spirito” elaborata nel primo decennio del Novecento, era soprattutto un’affermazione del principio di individualità: nell’arte come nella lingua, nella logica come in economia o nella politica: «Non è perciò un caso che Croce abbia aspramente criticato l’Illuminismo di cui vedeva un’appendice nel positivismo, affermando le ragioni della creatività contro quelle della regola, della libertà contro ogni determinismo, della Vita contro la Ragione» . Ecco perché, ad avviso di Ocone, riprendere il filo interrotto del pensiero crociano può significare, oggi, la ripresa di una tradizione italiana di pensiero interrottasi con il predominio della cultura ideologica degli ultimi decenni: «Significa – allora, e in sintesi – affermare un concetto di razionalità che non coincide con quello del razionalismo, con i vecchi e nuovi positivismi, ma nemmeno con il prospettivismo, l’irenismo e l’indifferentismo etico del cosiddetto postmoderno; significa credere sì nel valore della verità, ma di una verità che è sempre contestuale, storica, concreta, provvisoria, imperfetta; significa credere nei principi di un liberalismo fondato sull’autonomia morale dei singoli e sulla libera competizione fra le idee e i diversi modi di vedere e sentire le cose».
LA RIVOLUZIONE CULTURALE DA TENCO A PASOLINI.
Luigi Tenco, Pier Paolo Pasolini: quando la tragedia sveglia le coscienze. Il suicidio di Luigi Tenco (1967) e l’omicidio di Pier Paolo Pasolini (1975): la gravità di questi due eventi scosse tante persone, ma soprattutto colpì anche parte di quel blocco conservatore indicato come “maggioranza silenziosa”, scrive Gianni Martini il 3 dicembre 2012. Si è parlato di “torpore coscienziale”, condizione politico-culturale che caratterizzava, negli anni ’60 e ’70, larghi strati della popolazione. “Maggioranza silenziosa”, così veniva definito questo “blocco sociale” trasversale che dalla piccola e media borghesia arrivava a toccare anche i ceti popolari. Ritengo importante soffermarmi su questo “muro sociale” conservatore perché la sua presenza impalpabile e, appunto, silenziosa, giocò un ruolo significativo. Più che di arretratezza politica penso si trattasse di una ben più grave arretratezza culturale che si esprimeva in una mentalità chiusa e refrattaria alle novità. Sarebbe quindi sbrigativo ed erroneo liquidare come “di destra”, compattamente, quest’area sociale. Infatti, anche una parte della sinistra popolare, allora legata al P.C.I, condivideva nei fatti le stesse posizioni conservatrici che non esitarono a condannare l’arte d’avanguardia, i capelloni dei primi anni ’60, gli omosessuali. Eppure, in quegli anni ci furono almeno due fatti che, sul piano del costume, scossero la società civile, arrivando forse a smuovere un po’ anche le “maggioranze silenziose”: 1967 suicidio di L. Tenco e 1975 omicidio di P. Pasolini. La sociologia ci insegna che quando nella società civile si verifica un “evento traumatico” si possono determinare cambiamenti nei comportamenti sociali più o meno diffusi, in relazione all’entità dell’evento stesso. L. Tenco si suicidò nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 1967, mentre era in corso il festival di Sanremo. Nel drammatico messaggio che lasciò scritto sulla carta intestata dell’albergo si leggeva un’attestazione d’amore per il pubblico italiano, ma al tempo stesso una profonda delusione per il passaggio in finale di una canzonetta insulsa come “Io tu e le rose” e una finta canzone di protesta come “La rivoluzione”. L’opinione pubblica fu scossa soprattutto perché non ci si aspettava che il Festival di Sanremo potesse essere sconvolto da una tragedia simile. La morte di L. Tenco fece irrompere nella spensieratezza del tempio della canzonetta disimpegnata e leggera, del bel canto popolare, un’altra realtà: il fatto che si potessero scrivere canzoni frutto di un’ispirazione più autentica, canzoni che parlassero della vita concreta, non idealizzata e mistificata. Che le cose stessero iniziando a cambiare – con grida di scandalo di ben pensanti e reazionari di ogni risma – lo si era in realtà già capito da qualche anno, visto che il Festival di Sanremo aveva ospitato alcuni complessi di “capelloni” e canzoni di protesta. Comunque quasi tutta la stampa batté la strada del “cantante solo, incompreso, forse depresso e inacidito per il mancato successo”. Certamente il mondo della canzone, dopo quel tragico fatto, non fu più lo stesso. Nel 1972 nacque a Sanremo il Club Tenco e nel 1974 vi si tenne la prima “Rassegna della canzone d’autore”. Il Club Tenco (presieduto e fondato da A. Rambaldi), per statuto, si impegna a promuovere e diffondere un nuovo tipo di canzone, fuori dalle strategie delle case discografiche e della musica di consumo. Una canzone rivolta alla parte più sensibile e impegnata della società civile, già frutto di una vitalità socio- culturale, segno attuale dei tempi. E veniamo alla drammatica vicenda di P. Pasolini, ucciso barbaramente nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975. Gli occulti mandanti e le circostanze dell’omicidio non furono mai del tutto chiarite. Anche in questo caso l’impatto fu notevole soprattutto sulle componenti della società civile più sensibili e culturalmente attive. Buona parte della stampa, dopo aver riconosciuto o semplicemente riportato con distacco il valore dell’impegno artistico e intellettuale di Pasolini, si soffermò soprattutto sugli aspetti da “cronaca nera”. La stampa più retriva e moralista trattò il caso come “maturato negli ambienti omosessuali”. Per il resto ci si limitò con poche eccezioni a descrivere le scelte di vita di Pasolini. Si perse così (volutamente, sia chiaro), l’occasione per una discussione non solo sulla statura artistica di Pasolini ma su ciò che, come giornalista, scriveva su quotidiani e riviste importanti come “Il corriere della sera”, “Il tempo”, “Panorama”, “Rinascita”, “Il mondo” ecc, oltre a dichiarazioni rilasciate in interviste, anche televisive.
Quella rivoluzione chiamata Luigi Tenco. Fascinoso, anticonformista, ombroso. Ma anche ironico e traboccante di creatività, capace di sfidare la morale con canzoni che facevano pensare. Cinquant'anni fa, il 27 gennaio 1967, il cantautore pose fine alla sua vita con un colpo di pistola. Lasciando però una grande eredità alla nostra canzone, scrive Alberto Dentice il 26 gennaio 2017 su "L'Espresso". Se non fosse mai andato al festival di Sanremo, oggi Luigi Tenco avrebbe 78 anni, la stessa età di Celentano e chissà, forse sarebbe anche lui un insopportabile gigione. Invece, il 27 gennaio del 1967, 50 anni fa, con un colpo di pistola Tenco pose fine alla sua vita tormentata assicurandosi un posto nel paradiso dei “forever young”, accanto a Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain e altre leggende del rock morte giovani e preservate perciò dagli acciacchi del tempo e dell’età. Che si sia trattato di suicido, di un fatale incidente come capitò a Johnny Ace (leggenda del R&B fulminato nel 1954 da un colpo partito per sbaglio mentre giocava con la sua pistola) o di omicidio eseguito su commissione di oscuri mandanti come quello di Pier Paolo Pasolini, il dibattito è ancora aperto. Una mole impressionante di libri e di inchieste giornalistiche ne hanno evidenziato a più riprese l’inconsistenza: si legga in proposito la nuova aggiornata biografia di Aldo Colonna, “Vita di Tenco” (Bompiani), che arriva ad adombrare una responsabilità del vicino di stanza, Lucio Dalla. La versione del suicidio sembrerebbe a tutt’oggi accettata con rassegnata perplessità dalla stessa famiglia del cantautore, rappresentata dai due figli del fratello, Valentino Tenco, e dalla loro madre. Suicidio o omicidio? Non è un dubbio da poco. Cambiando il finale, sarebbe tutto un altro film. E il mito dell’artista “maudit” che si toglie la vita per protestare contro l’ottusità e la corruzione che infestano il tempio della musica leggera ne uscirebbe ridimensionato. Dell’eredità spirituale e artistica di Tenco, nel frattempo ha continuato a occuparsi, nel segno dell’indipendenza e di una mission creativa scevra da compromessi con il famigerato “mercato”, la Rassegna a lui dedicata, fondata proprio a Sanremo da Amilcare Rambaldi, gran signore e appassionato conoscitore di musica popolare. Il Premio Tenco aprì le porte nel 1974, nel pieno della stagione d’oro della canzone d’autore. Poi nel ’95 Rambaldi ci ha lasciato e la manifestazione ha cominciato a perdere un po’ dell’allegria e dello spirito dilettantesco, nel senso migliore del termine, che ne avevano caratterizzato gli esordi. Le mitiche serate post festival trascorse all’osteria assistendo alle sfide in ottava rima tra Guccini e Benigni sono un ricordo. Anche il Tenco ha aperto le porte al nuovo e ha esteso il concetto di canzone d’autore fino ad abbracciare l’hip hop, la canzone dialettale, la world music e il pop all’insegna di quella contaminazione tra i generi che siamo portati a considerare il suggello della contemporaneità. L’orgoglio della diversità artistica è rimasto un punto fermo anche per Enrico De Angelis, il direttore artistico che ne ha guidato le sorti fino a poche settimane fa, coadiuvato da un ristretto comitato di esperti e appassionati. Per celebrare i 50 anni dalla scomparsa, l’edizione 2016, la quarantesima, ha previsto un gran finale tutto dedicato a Luigi Tenco. Titolo: “Come mi vedono gli altri… quelli nati dopo”. Sul palco fra gli altri anche l’istrionico Morgan che per Tenco ha una vera adorazione. Gli ha dedicato il prossimo album e una canzone: «Luigi Tenco / scappato eternamente / oltre lo spazio, le luci e il tempo / perché lui si sente /vivo / fatalmente/ solo nel momento in cui non è». Ma quanti lo ascoltano, quanti fra i giovani musicisti e i cantanti oggi conoscono Tenco? La risposta forse arriverà il 28 gennaio ad Aosta, quando sul palco del Teatro Splendor in ricordo del cantautore saliranno altri giovani protagonisti della canzone d’autore. Fra gli altri proprio il toscano Motta, cui è stato assegnato il recente premio Tenco. E che mentre si appresta a cantare il suo “Una brava ragazza”, ammette di conoscerlo poco. Ma appunto, chi era Luigi Tenco? Certo è che quel gesto estremo, notava anni fa Lietta Tornabuoni su La Stampa, «lo aveva confermato per quel che Tenco era sempre apparso all’euforico, quattrinaio e prepolitico mondo della musica leggera dei primi anni Sessanta: un guastafeste». E chissà se Carlo Conti e Maria De Filippi decideranno di commemorare l’anniversario al prossimo Sanremone. Perché la sua ombra continua a dividere come quella di un angelo sterminatore. Le cronache del tempo tramandano il ritratto di un anticonformista dal carattere ombroso e introverso ma assai consapevole del proprio fascino, jeans e maglione nero d’ordinanza, lo sguardo sprezzante del giovane arrabbiato a mascherare una profonda fragilità. Insomma, è uno che se la tira. Oltretutto il Nostro è un lettore accanito, adora Pavese e in una canzone, “Quasi sera”, cita addirittura versi di Bertolt Brecht. Quanto basta perché alla fama di intellettuale si sommi quella più sospetta di comunista. Oggi non ci farebbe caso nessuno, ma nell’Italia pre-sessantotto che vuole essere ricca, spregiudicata e ottimista basta questo per essere guardato con diffidenza, specie nell’ambiente ridanciano e superficialotto della discografia. All’immagine del pessimista introverso da sempre fa da contraltare quella del Tenco amante della vita, traboccante creatività e perfino spiritoso, bravissimo a raccontare barzellette, con un debole per le zingarate. Dalle testimonianze di chi l’ha conosciuto, insomma, Tenco risulta essere stato tutto e il contrario di tutto. Ma sulla sua missione ha idee chiarissime: «Anche la canzone può servire a far pensare». Convinto che si debba cantare l’amore con un linguaggio nuovo, fare a pezzi i luoghi comuni, la rima baciata, il verso tronco, la retorica imperante. Sì: «Mi sono innamorato di te», ma solo «perché non avevo niente da fare». Nei primi anni Sessanta, ovviamente, non è il solo artista impegnato a rinnovare il linguaggio della canzone. Tenco è meno musicista di Bindi, meno romantico di Paoli, non ha l’aplomb aristo-maledetto di De André, ma proprio lui, genovese d’adozione (è nato a Cassine in provincia di Alessandria) è il più politico del gruppo. Nel 1962, “Cara maestra”, il “j’accuse” contro l’ipocrisia di certi precetti morali impartiti a scuola e in chiesa, gli era valso due anni di esilio dalla tv. Intanto, nella musica e non solo in quella, sta cambiando tutto. L’avvento di Bob Dylan, dei Beatles, dei Rolling Stones ha impresso al mondo un’accelerazione bestiale. Tenco, appena sbarcato alla Rca, la sua nuova casa discografica, scopre il Piper Club, il tempio romano del beat e dei capelloni, dove oltre ai Rokes, all’Equipe 84, a Patty Pravo si possono ascoltare i Primitives, i Bad Boys e molti altri gruppi rock blues inglesi sconosciuti ma bravissimi. E perfino divinità del Rhythm’ n’Blues come Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave. Tenco a differenza di Bindi, di Paoli, di Endrigo, di Lauzi, che hanno la bussola puntata verso la Francia di Brassens, guarda più all’America. Nasce come sassofonista, viene dal jazz e ha trovato in Paul Desmond il suo modello. Come se non bastasse, sussurra «Quando il mio amore tornerà da me…» con lo stesso timbro vellutato di Nat King Cole e in questo come in altri suoi lenti da mattonella farciti con overdose di violini - pensiamo a “Lontano, lontano” o a “Ti ricorderai” - riesce a toccare come pochi le corde della malinconia. Proprio al Piper, però, il Nostro deve rendersi conto che il conflitto, ormai, non è più fra destra e sinistra, quanto piuttosto una questione generazionale. Da una parte i giovani, dalla parte opposta tutti gli altri. Lui a 25 anni si sente già vecchio, e quando nel 1966 scoppia la polemica contro i capelloni, è tra i primi a schierarsi: «Gli argomenti preferiti di certa gente sono che i capelloni non lavorano, che non si lavano, che sono ignoranti; bene, a questo punto io mi proclamo un capellone, mi sento uno di loro». L’ondata dei beat, delle canzoni di protesta lo vedrà in prima linea, anche se, a onor del vero, il contributo di Tenco alla causa, “Ognuno è libero”, non si distingue per originalità. Chissà cosa pensano davvero di lui i giovani che oggi nei dischi infilano cover delle sue canzoni per accattivarsi la giuria del premio Tenco. I cinquant’anni dalla morte cadono mentre De Angelis si dimette dal Club denunciando che l’iniziale «professionalità» si sta trasformando in «professionismo», e gli eredi litigano con i gestori del museo-omaggio di Ricaldone, rei di aver esposto una gigantografia del cantante. E intorno a Tenco tira aria di maretta.
«Ecco perché Tenco fu ucciso» Il libro-inchiesta riapre il caso, scrive Monica Bottino, Sabato 23/02/2013, su "Il Giornale". «Quando molti giornalisti mi chiedono se esiste il delitto perfetto, io gli rispondo di sì: è l'omicidio Tenco». Il criminologo Francesco Bruno ne è convinto. Nella notte del 27 gennaio 1967, durante il Festival di Sanremo, avvenne quello che a 46 anni di distanza resta ancora uno dei grandi misteri italiani. Mistero, sì. Nonostante due sentenze della magistratura dicano che Luigi Tenco si è suicidato, sono tanti e insoluti i dubbi su quella notte. E non solo. A tentare di far luce su quello che è per molti un «cold case» sono due giornalisti d'inchiesta: Nicola Guarnieri e Pasquale Ragone che hanno pubblicato il libro «Le ombre del silenzio. Suicidio o delitto? Controinchiesta sulla morte di Luigi Tenco» (edizioni Castelvecchi), proprio con la prefazione del professor Bruno. Un lavoro ponderoso che è il risultato di quattro anni di ricerche nei faldoni giudiziari, alla riscoperta di interviste dell'epoca con le persone che a vario titolo furono coinvolte nella vicenda. E nuove testimonianze. A rendere straordinario il libro non c'è solo la capacità degli autori di raccontare una storia vera come fosse un noir, ritmandola di colpi di scena e rivelazioni clamorose, ma anche e soprattutto la pubblicazione di testimonianze e materiali inediti rinvenuti nell'aula bunker della corte di Assise di Sanremo. Un lungo lavoro di ricerca che gli autori hanno portato avanti scavando tra archivi e faldoni, fino a scovare per la prima volta il foglio matricolare e alcune lettere di Luigi Tenco, documenti finora mai pubblicati. Il lettore viene assalito da molti dubbi di fronte a un quadro inquietante e alle troppe incongruenze che emergono dalle carte stesse. Alla fine emergono anche altre domande: perché Tenco doveva morire? Quali segreti custodiva? E la richiesta degli autori alla magistratura, sulla base delle nuove prove emerse, è quella di aprire nuovamente il caso. Intanto è bene sapere che Luigi Tenco in quei giorni aveva paura. Di più. Temeva per la sua vita, dopo che poco tempo prima del festival, nei pressi di Santa Margherita due auto lo avevano stretto e avevano tentato di mandare la sua fuoristrada. Era stata la terza volta che attentavano alla sua vita, confidò a un amico. Fu a quel punto che decise di acquistare una pistola Walther Ppk7.65, abbastanza piccola da tenerla nel cruscotto della macchina. Secondo gli autori non fu questa la pistola che uccise Tenco perché non uscì mai dalla macchina. Nella stanza 219 del Savoy la polizia dirà di aver rinvenuto una Bernardelli, molto simile alla precedente, ma naturalmente non quella. Inoltre nel primo verbale stilato dalla polizia «alle ore tre» (e pubblicato nel libro) si parla di proiettili, di medicinali, ma non di arma. La pistola non fu repertata. Perché? Forse perché non c'era? Ma andiamo avanti. È assodato che il cadavere fu condotto all'obitorio subito dopo il ritrovamento dai necrofori, che poi furono richiamati e costretti a riportarlo nella stanza dove fu rimesso nella posizione che aveva al momento del ritrovamento, per consentire alla polizia di scattare le fotografie e di eseguire i rilievi non fatti prima. Non fu eseguita l'autopsia. Il cadavere di Tenco non fu svestito né lavato, ad eccezione del viso. Non fu nemmeno fatto lo «stub», ovvero il test che prova se una mano ha tenuto la pistola che ha sparato. Nulla. Perché? A distanza di molti anni, a fronte di molti dubbi, nel 2006 la salma di Tenco fu riesumata. Gli esami furono - secondo gli autori - incompleti anche in questo caso. Ma ci furono esperti che si dissero convinti che la pistola che aveva ucciso Tenco avesse un silenziatore, poiché la ferita sul cranio non era a stella, ma rotonda. Ma il silenziatore non fu mai trovato. Inoltre nel 2006 non furono fatti accertamenti sui vestiti, gli stessi che l'uomo indossava al momento della morte e che avrebbero almeno dovuto avere le tracce dello sparo. Il lettore verrà condotto attraverso uno dei misteri irrisolti con dovizia di particolari e una documentazione ricca, sebbene un piccolo appunto (magari in vista di una ristampa) va fatto per la poca chiarezza delle immagini fotografiche stampate sulla carta ruvida, e in bianco e nero anche nella ricostruzione. Resta il fatto che il libro-inchiesta non solo pone questioni, ma fornisce al lettore anche una possibile chiave di lettura degli avvenimenti che culminarono in quella notte maledetta. C'è la pista argentina, per dirne una, ma si parla anche di mafia marsigliese, e di eversione di estrema destra. E anche del potere delle case discografiche a Sanremo. Non possiamo svelare di più, per non togliere il piacere di una lettura coinvolgente che attraversa fatti e personaggi della nostra storia. «Gli esami svolti nel 2006 dall'Ert non chiariscono tutti i punti oscuri e la tesi del suicidio non combacia con diversi elementi», scrive ancora Bruno nella prefazione. La soluzione al mistero è ancora lontana. Ma questo libro è un passo avanti.
Pier Paolo Pasolini e il mistero di Petrolio nel film La macchinazione di David Grieco. Arriva in sala il 24 marzo la pellicola che racconta la stesura del libro e la morte misteriosa dello scrittore. Nel ruolo del protagonista, Massimo Ranieri. Mentre il regista fu assistente alla regia di PPP, scrive il 14 marzo 2016 "L'Espresso". «A un certo punto avrò bisogno del tuo aiuto, Alberto», parla così al telefono con Moravia il Pasolini di David Grieco, nella clip in anteprima del film La macchinazione, dal 24 marzo nelle sale: «Non so neanche io cosa sto scrivendo, vado avanti come posseduto da un demonio, ho già superato le 400 pagine e forse arriverò a 2000». «Per ora posso dirti il titolo: Petrolio», continua la conversazione tra Moravia e Pasolini, cioè Massimo Ranieri, a cui è toccato il delicato compito di raccontare gli ultimi giorni di vita dell’intellettuale, impegnato nel montaggio di Salò e le 120 giornate di Sodoma e nella stesura del romanzo uscito postumo, atto di accusa che riprende il libro Questo è Cefis, uscito nel 1972 ma subito scomparso dagli scaffali, in cui un informato autore sotto pseudonimo ricostruisce «l’altra faccia dell’onorato presidente», l'altra faccia di Eugenio Cefis, presidente dell’Eni dopo la morte di Mattei e poi della Montedison, indicato come «il vero capo della P2». Salò, Petrolio, la relazione con Pino Pelosi, giovane sottoproletario romano che ha legami con il mondo criminale della capitale. Il 2 novembre 1975, Pasolini morirà a Ostia. E Grieco, già assistente del cineasta e poeta, con il suo film si pone la domanda: «Chi ha ucciso Pier Paolo Pasolini?»
Il vero mistero su Pasolini è capire come il film di David Grieco abbia trovato posto in un cinema. Quanto volete per smettere? Per lasciare in pace Pier Paolo Pasolini? Tutto questo tempo sprecato per farlo diventare uno dei misteri d’Italia non sarebbe meglio adoperato per leggersi qualche poesia, magari sul vincitore dello Strega che nessuno ricorda l’anno dopo, peggio del vincitore al Festival di Cannes? Scrive Mariarosa Mancuso il 25 Marzo 2016 su "Il Foglio". Tanto tempo sprecato per farlo diventare un mistero d’Italia, ripetiamo volentieri, perché le cose sono andate al contrario: a furia di fare inchieste per stanare scomode verità, il caso si è ingigantito e l’intrigo si è complicato invece di sbrogliarsi. Fino al paradosso: il cugino Nico Naldini, di anni 87, uno che non ha mai voluto sentire parlare di congiure o di complotti (“incidente di percorso in una vita sregolata”, ha detto più volte) non viene invitato né agli anniversari né alle celebrazioni. Tutti hanno detto la loro, incluso Walter Veltroni. Massimo Ranieri ha la parte del poeta nel film di David Grieco “La macchinazione”, ora nelle sale: è bastato per aggiungersi alla lista dei deliranti. Dopo aver indossato un giubbotto scamosciato e girato la scena di una partita a calcio in borgata ha preso anche lui il numeretto e a gran voce ha chiesto la verità su Pasolini. Uno che si faceva tingere i capelli di nero dalla mamma, racconta il film, e non si capisce se lo scandalo sta nel nerofumo, o nella tintura casalinga con la boccetta comprata sugli scaffali del supermercato. Il complotto, o la congiura, o il grande mistero pasoliniano si estende nel film di David Grieco fino a comprendere la banda della Magliana (da “Romanzo Criminale” in poi si porta con tutto). Il mistero più grosso – su cui mancano le indagini – è sapere come mai un film come questo sia stato scritto, girato, distribuito in sala, senza che nessuno facesse la minima obiezione. Cinematografica, almeno, se non di sostanza fanta-criminale. Interessanti anche i retroscena: David Grieco avrebbe dovuto collaborare con Abel Ferrara, per il suo “Pasolini” presentato alla Mostra di Venezia nel 2014 (lo stesso anno del ripassino su Giacomo Leopardi inflitto da Mario Martone). Qualcosa andò storto, e per il gusto della scissione che caratterizza i cultori di Pier Paolo Pasolini - oltre che la sinistra italiana – ora si è fatto un film tutto suo (fa coppia con il volume – sempre firmato David Grieco – uscito da Rizzoli con il titolo “La macchinazione. Pasolini. La verità sulla morte”). La macchinazione è tanto arzigogolata che abbiamo vergogna perfino a raccontarla, tra Eugenio Cefis (“lo considero il demonio dell’Italia d’oggi”, testuale nel film), una sala da biliardo in periferia, il furto con richiesta di riscatto delle bobine di “Salò - Le 120 giornate di Sodoma”, pagine di “Petrolio” che correggono “bomba alla stazione Termini” in “bomba alla stazione di Bologna”. Però garantiamo che a vederlo è peggio.
Pier Paolo Pasolini, la storia e il mistero irrisolto della morte, scrive il 29 Ottobre 2015 Emilia Abbo. Pier Paolo Pasolini avvolto in un mistero. Andiamo a ripercorrere la storia del poeta e nello specifico il caso irrisolto della morte. Pasolini venne brutalmente ucciso all’idroscalo di Ostia la notte fra il primo ed il 2 novembre 1975, e pertanto in questi giorni si celebra il quarantesimo anniversario da quel tragico evento. La mattina del 31 ottobre, ad esempio, il ministro della cultura Dario Franceschini sarà a Pietralata, un quartiere che era molto caro allo scrittore. Significative personalità, anche vicine affettivamente allo scrittore (come ad esempio il suo biografo e cugino Nico Naldini, il suo vecchio amico Giancarlo Vigorelli, nonché l’italianista Guido Santato, che ne fu il più attento studioso) partono dalla convinzione che Pasolini divenne, in un certo senso, regista della sua stessa morte, a causa della vita sregolata e rischiosa che conduceva, e che includeva la frequentazione dei cosiddetti ‘ragazzi di vita’ delle periferie romane.
Il movente biografico: i “ragazzi di vita”. Attraverso la pubblicazione di un diario giovanile, uscito col titolo Il romanzo di Narciso (1946-7), Pasolini rivela ai lettori la propria omosessualità. Quando scriveva queste pagine lo scrittore bolognese viveva in Friuli, nei pressi di Casarsa (la località di cui sua madre era originaria) dove si era rifugiato all’indomani dell’otto settembre 1943, quando aveva rifiutato di consegnare le armi ai tedeschi. Il 1945 era stato un anno molto difficile per Pasolini, per via della perdita del fratello Guido (che era entrato nelle file del partigianato). Dopo la laurea, conseguita quello stesso anno con una tesi sul Pascoli, Pasolini trova un posto come insegnante nella scuola media di Valvassone, ma il 15 ottobre del 1949 verrà denunciato per corruzione di minorenni, perdendo la cattedra. Anche i dirigenti regionali del PCI, per i quali Pasolini collaborava dal 1947 sulle pagine del settimanale Lotta e lavoro, lo espelleranno dal partito. Per sfuggire allo scandalo, Pasolini si rifugia con la madre a Roma, dove giunge nel gennaio 1950. Il distacco dal mondo contadino friulano, che verrà da lui sempre mitizzato (non a caso, Pasolini compose poesie in dialetto casarsese), si accompagnerà ad una nuova presa di consapevolezza. Alla sua amica Silvana Mauri Ottieri confiderà infatti di sentire ormai sulla pelle il segno di Rimbaud o di Campana o di Wilde, e quindi di essere destinato ad un senso di emarginazione e condanna da parte della società. Giunto nella capitale, la madre prende servizio presso una famiglia come domestica, e Pasolini si adatta a fare il correttore di bozze ed a vendere i suoi libri nelle bancarelle rionali. Grazie al poeta Vittorio Clemente, nel dicembre 1951 trova un altro impiego come insegnante a Ciampino. Tuttavia, lo scrittore non riesce a fare a meno di frequentare l’ambiente periferico ed adolescenziale delle borgate, che divenne fonte di ispirazione per il suo romanzo Ragazzi di Vita (1955). Per questo libro Pasolini (accanto alla casa editrice Garzanti) venne processato, e solo grazie all’intervento di eminenti letterati come Giuseppe Ungaretti e Carlo Bo (che evidenziarono un senso di umana pietà misto a crudo realismo) lo scrittore venne assolto. Analoga sorte ebbe il romanzo Una vita violenta (1955) che intendeva essere una continuazione del suo progetto ‘sottoproletario’, portato avanti anche nei film Accattone (presentato al festival di Venezia del 1961) e Mamma Roma (interpretato nel 1962 da Anna Magnani). Anche in questi capolavori cinematografici i ragazzi delle borgate romane non hanno alcuna speranza di affrancamento o redenzione, e la morte diviene l’unica via d’uscita ad un destino di corruttiva miseria e disperazione. La frequentazione di piccoli malavitosi causerà a Pasolini altri problemi giudiziari. Nel giugno 1960, ad esempio, Lo scrittore verrà accusato di aver favoreggiato due ragazzi coinvolti in una rissa, e nel novembre dell’anno seguente vedrà il suo appartamento perquisito, poiché sospettato di una rapina a mano armata in un bar di San Felice Circeo. Il responsabile dell’omicidio Pasolini fu subito ritenuto il diciassettenne reo confesso Giuseppe Pelosi (soprannominato ‘Pino la rana’), già noto alle forze dell’ordine per vari furtarelli, e che venne dichiarato colpevole di omicidio doloso nella sentenza di primo grado. Alla sua versione dei fatti venne aggiunto il ‘concorso con ignoti’, poi inspiegabilmente smentito dalla corte d’appello il 4 dicembre 1976. Tuttavia, questa sentenza non é mai stata ritenuta davvero definitiva, anche perché nel corso del tempo si sono innalzate molte voci (fra cui quella della scrittrice Oriana Fallaci e del regista Marco Tullio Giordana) a sostegno dell’omicidio di gruppo, che lasciava spazio ad altri moventi oltre a quello di un diverbio fra un ‘ragazzo di vita’ ed il suo esigente cliente. Il fatto che il poeta, quella notte, fosse stato vittima anche (o soltanto) di terzi venne validato da vari indizi, come ad esempio l’esile corporatura di Pelosi, che al momento dell’arresto (avvenuto subito dopo il delitto) non aveva significative ferite o segni di colluttazione sugli abiti. La leggerezza e friabilità dell’arma del delitto (che fu identificata con una tavola di legno che serviva ad indicare il numero civico di un’abitazione) sarebbe stata incompatibile con le ferite che vennero selvaggiamente inferte, e che si addicevano ad un oggetto assai più pesante e contundente. Nel caso Pasolini, del resto, vi sono state, e fin dall’inizio, delle gravi negligenze, ed un articolo sull’Europeo del 21 novembre 1975 illustra chiaramente come la scena criminis venne inquinata. La polizia, accorsa sul posto verso le sette di mattina, non disperse la folla di curiosi, e non vennero nemmeno indicati i punti esatti dei vari ritrovamenti. La macchina di Pasolini rimase esposta ad una pioggia insistente, e dopo aver svolto le prime indagini venne rottamata. Sul luogo del delitto non giunse nemmeno un medico legale, e sull’adiacente campetto di calcio, che poteva offrire segni di plantari e pneumatici, venne giocata una partita. Alcuni oggetti (come ad esempio la camicia e gli occhiali che quella sera Pasolini indossava) vennero esposti al museo di criminologia di Valle Giulia, ed anche se in seguito sono stati analizzati con tecniche più moderne e sofisticate (lo stesso comandante del Ris di Parma, Nicola Garofalo, ha coordinato le perizie) i risultati rimangono comunque secretati, e non pienamente attendibili a causa delle negligenze che si verificarono nelle quarantotto ore che seguirono il delitto. Anche le più fresche testimonianze non ebbero il credito che meritavano. Assai emblematica rimane quella di un pescatore (immortalata in un prezioso film-documentario di Mario Martone) che sostenne di avere visto, quella tragica notte, una seconda auto accanto all’Alfa Romeo di Pasolini, ed udito voci di diverse persone, oltre al grido disperato dello scrittore che invocava sua madre. Presente agli atti è la versione della cugina del regista, Graziella Chiarcossi, secondo la quale il maglione che venne ritrovato sul sedile posteriore dell’auto non apparteneva a Pasolini. Ma non solo. Il proprietario della trattoria ‘Biondo Tevere’ ritenne che, quella sera, il poeta era in compagnia di un giovane che non aveva le stesse caratteristiche fisiche del diciassettenne di Guidonia. Inoltre, un ex-appuntato dei carabinieri, che indagava in borghese, mise in evidenza il coinvolgimento di due ragazzini siciliani (soprannominati ‘fratelli braciola’), che frequentavano lo stesso circolo ricreativo di Pelosi, e che morirono di malattia negli anni Novanta. Come se non bastasse, nel maggio 2008 lo stesso Pelosi decise di ritrattare, e sostenne, durante una trasmissione televisiva, che la sua unica responsabilità fu quella di avere investito accidentalmente il corpo già inerte di Pasolini, laddove il delitto vero e proprio venne materialmente eseguito da tre individui adulti. Aggiunse di aver taciuto fino a quel momento per non esporre i suoi ormai defunti genitori a ritorsioni. Nonostante questo, la vicenda non prese una vera e propria svolta, tanto che l’avvocato Nino Marazzita parla ancora oggi di ‘inerzia colpevole’ da parte degli inquirenti (Tusciaweb.it, 26 aprile 2014) e l’avvocato Guido Calvi (anch’egli incaricato dalla famiglia Pasolini all’epoca del delitto) ritiene che si sia voluta spegnere la voce del poeta con l’arma della diffidenza e con ‘risposte sconcertanti’ (Corriere.it, 4 maggio 2010).
Il movente cinematografico: le bobine di Salò. Fra le varie teorie sulla morte di Pasolini merita attenzione anche quella che si profilò grazie alla testimonianza del regista Sergio Citti, il quale asserì che, poche settimane prima dell’omicidio, Pasolini subì la sparizione di due bobine cinematografiche (quelle che in gergo sono chiamate ‘pizze’), ovvero di due copie del suo ultimo film, intitolato Salò. Citti sostenne che quella fatidica sera del primo novembre Pasolini doveva vedere dei loschi individui, ovvero i probabili autori del furto, e seppur questo incontro richiedesse un notevole coraggio, Pasolini era disposto ad affrontarlo lo stesso poiché ci teneva a recuperare l’insostituibile lavoro di montaggio, che era stato effettuato con la tecnica del ‘doppio’, ovvero girando le stesse scene anche da un’inquadratura diversa. Le bobine di questo film, furono probabilmente sottratte per il loro contenuto scabroso. Pasolini stesso sapeva che questa pellicola avrebbe suscitato reazioni anche per il suo significato sottilmente ideologico, poiché si creava una correlazione fra le tematiche dei romanzi di Sade e la dominazione di massa capitalistica (identificata al kantiano ‘male radicale’). Mentre girava questo suo ultimo film, forse Pasolini avvertiva l’avvicinarsi della sua morte. Non a caso, volle accanto a sé figure amiche, come l’attrice Laura Betti (nel ruolo di doppiatrice) e poi anche l’affezionato Ninetto Davoli e lo stesso Sergio Citti, per il quale fu questo film a rendere reali quelle paure che il regista aveva già allontanato con stoico distacco: La morte compie un fulmineo montaggio nella nostra vita: ossia sceglie i suoi momenti veramente significativi <…> e li mette in successione, facendo del nostro presente, infinito, instabile ed incerto, un passato chiaro, stabile, certo e dunque linguisticamente ben descrivibile (Pier Paolo Pasolini, Empirismo Eretico).
Il movente letterario: “Lampi su Eni”. Un’interessante teoria è quella legata alla cosiddetta ‘questione Eni‘, poiché direttamente riconducibile al lavoro letterario che l’autore, al momento della sua morte, stava svolgendo con la casa editrice Einaudi. Nel romanzo-inchiesta (rimasto incompiuto) Petrolio, che venne pubblicato postumo nel 1992 (e del quale restano 522 pagine) si delinea una lotta di potere che avviene nel settore petrol-chimico. La finzione del romanzo è riconducibile ad un reale fatto di cronaca, ovvero alla morte del presidente dell’Eni Enrico Mattei, che avvenne nel 1967, quando l’aereo su cui si trovava a bordo perse quota sulla campagna pavese. Pasolini giunse, con trent’anni di anticipo, alle stesse conclusioni del magistrato Vincenzo Calia, che chiese l’archiviazione del caso nel 2003. Per Pasolini la morte di Mattei non fu causata da un fatale incidente, ma semmai da un sabotaggio, da ricondursi agli intrighi dell’ambizioso personaggio che nel suo romanzo rappresenta Eugenio Cefis, il quale divenne presidente della Montedison nel 1971, dopo aver co-fondato l’Eni assieme allo stesso Mattei. Anche la scomparsa del giornalista Mauro de Mauro, che stava preparando un dossier per il regista Francesco Rosi (il quale decise di girare un film sul caso Mattei) potrebbe essere legata a qualche scottante notizia non dissimile dalla teoria portata avanti in Petrolio. Pasolini ebbe come sua fonte il libro Questo é Cefis, l’altra faccia dell’onorato Presidente, pubblicato nel 1972 sotto lo pseudonimo Giorgio Steimez, e che venne subito ritirato dalla circolazione, ma del quale Pasolini aveva una versione in fotocopia grazie al suo amico Elvio Facchinelli. Per Pasolini Mattei non era un un anacronistico utopista-statalista, ma piuttosto un lungimirante imprenditore, pieno di entusiasmo e di positive risorse, che aveva già evitato la vendita dell’Agip negli anni Quaranta. Mattei proponeva ai paesi arabi ed africani (principali produttori di greggio) condizioni più vantaggiose rispetto a quelle proposte dai trust anglo-americani del petrolio, mettendosi quindi in aperta competizione con le cosiddette ‘sette sorelle’, ovvero con le potenti multinazionali nella cui orbita atlantica Cefis voleva invece ricondurre l’economia della nostra nazione. Tuttavia, fu un capitolo in particolare, intitolato ‘Lampi su Eni’, che venne indicato come probabile movente della morte dello scrittore. Il 2 marzo 2010 il senatore Marcello Dell’Utri (all’epoca ancora in attesa di sentenza definitiva) sostenne, durante una conferenza stampa, di aver visto coi suoi occhi le pagine in questione, che si riteneva non fossero mai state scritte, e nelle quali sarebbero state fornite informazioni più specifiche sull’omicidio Mattei. Aggiunse che questo capitolo, altrimenti detto ‘appunto 21’, sarebbe stato sottratto dallo studio di Pasolini, ed avrebbe fatto la sua comparsa, nei giorni a venire, alla XXI fiera milanese del libro antico. Anche se questo in realtà non avvenne, su iniziativa dell’onorevole Walter Veltroni (il quale scrisse una lettera aperta all’allora ministro della giustizia Angelino Alfano) un nuovo fascicolo venne aperto sul caso Pasolini. Tuttavia, nulla di nuovo emerse a riguardo, anche se i legami di Cefis con la loggia massonica della P2 (che era implicata in quella ‘strategia della tensione’ della quale Pasolini parlava senza remore) davano adito ad altri nuovi ed inquietanti scenari.
Il movente giornalistico: il coraggio “corsaro”. Comprendere il delitto Pasolini é quindi impossibile se si prescinde dall’ideologia dello scrittore, che viene apertamente espressa nei suoi Scritti corsari (1972) dove, senza troppa arte diplomatica, vengono compiute dissacratorie incursioni nel mondo politico-istituzionale, ed anche nella società nel suo complesso. In questi scritti (che raccolgono soprattutto gli articoli giornalistici che Pasolini scrisse per il Corriere della Sera ed Il Tempo) la marxista critica al capitalismo (ed il conseguente rimpianto per la civiltà pre-industriale) vengono espressi in modo unico ed originale, sia per lo stile (assolutamente chiaro, lineare, coerente, inequivocabile) e sia per i costanti riferimenti alla propria esperienza. Pasolini traspone in schietti pensieri teorici (ed anche in polemici commenti) le sue personali e soggettive impressioni, i dettagli e le situazioni che vede e vive intorno a sé. Questi scritti sono quindi corsari sia per la coraggiosa genuinità dell’autore e sia perché evocano, seppur indirettamente, un mondo romanzesco ed avventuroso, creato per appassionare le giovani generazioni. Pasolini evidenzia come, negli anni Settanta, i giovani abbiano invece perso ogni vitale entusiasmo, ogni segno particolare, e si siano borghesemente omologati. Nella sua tendenza a contrapporre i tempi, Pasolini rievoca i capelloni degli anni Sessanta, che nulla avevano a che fare con quelli del decennio seguente, che hanno ormai perso la potenzialità semantica dei loro gesti ed atteggiamenti, ed anche ogni espressività e coloritura gergale. Secondo l’autore, si é dunque verificata una ‘mutazione antropologica’, poiché i giovani, nella loro ‘ansiosa volontà di uniformarsi’, non solo sono diventati simili nella loro ‘sottocultura’ esteriore, ma anche nel modo di parlare e di pensare (dal centro alla periferia, dal nord al sud, dallo studente all’operaio), cosicché anche le ideologie si confondono, ‘secondo un codice interclassista’. Pasolini ritiene che il maggior errore delle nuove generazioni sia stato quello di non aver mantenuto un dialogo coi loro padri, e quindi di non aver potuto (dialetticamente e non solo) superare i loro limiti, le loro colpe. Lo spirito di ribellione ha spinto i giovani a mettersi nelle mani di un ‘nuovo fascismo’ (definito consumistico-edonistico) assai peggiore del precedente, poiché deforma sottilmente le coscienze e mercifica i corpi. Per Pasolini, il fascismo mussoliniano dei padri era un fenomeno soprattutto ‘pagliaccesco’, poiché una volta tolte le uniformi e le divise tutti tornavano identici a prima, coi loro stessi valori e le loro stesse idee. Questo tipo di fascismo diventa per lui anche archeologico, poiché gli obsoleti comizi in piazza nulla avevano a che fare coi messaggi pubblicitari del nuovo bombardamento ideologico televisivo, che si instilla nell’anima in modo subdolo, imponendosi nel profondo: E’ in Carosello onnipotente che esplode in tutto il suo nitore, la sua assolutezza, la sua perentorietà il nuovo tipo di vita che gli italiani ‘devono’ vivere (Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, ed. Garzanti, 2015, p. 59). Pasolini riteneva che la manipolazione pubblicitaria rappresentasse la fine del linguaggio umanistico, e quindi che un nuovo modo di esprimersi (tecnico, pragmatico, standard) stesse prendendo piede. Lo slogan Jeans Jesus. Non avrai altri jeans all’infuori di me esemplifica il modo in cui la nuova civiltà ‘consumistica-edonistica’ ha strumentalizzato quella dimensione spirituale che prima apparteneva alla Chiesa. Seppur per Pasolini quest’ultima non sia incolpevole nella sua opulenza e nella sua lunga storia di potere, non merita comunque di venire spodestata da una tirannia che non ha alcun rispetto per quel messaggio che egli stesso volle rappresentare, in tutta la sua sublime semplicità, nel film Il Vangelo secondo Matteo (1964). Per Pasolini i giovani stanno dunque vivendo il più repressivo totalitarismo che si sia mai visto, poiché l’apparente libertà democratica che si respira non è stata ottenuta attraverso una rivoluzione popolare (come è avvenuto, ad esempio, nella Russia del 1917) ma è stata imposta dall’alto coi suoi modelli da seguire: Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza. L’uguaglianza non è stata infatti conquistata, ma è una falsa uguaglianza ricevuta in regalo (idem, p.60). Se il mondo contadino pre-industriale si basava su necessità primarie (come il pane che era già una benedizione ad averlo) la nuova società dei consumi, nel suo bisogno di perseguire il superfluo, non solo ha immiserito il paesaggio circostante (nel quale sono ormai scomparse le lucciole) ma anche la capacità di recepire, di sentire. Se quest’ultima fosse rimasta intatta, anche ‘una Seicento o un frigorifero, oppure un week-end ad Ostia’ potrebbero essere interpretati con poesia e passione, nello stesso modo in cui Leopardi interiorizzava ‘la natura e l’umanità nella loro purezza ideale’. Pasolini amava profondamente quel senso di ingenua spensieratezza che caratterizzava i non acculturati, e che ora vede soltanto umiliati. Simbolo di questa antica felicità dei ragazzi del popolo diviene il garzoncello del fornaio: Una volta il fornarino, o cascherino-come lo chiamiamo qui a Roma-era sempre, eternamente allegro: un’allegria vera, che gli sprizzava dagli occhi. Se ne andava in giro per le strade fischiettando e lanciando motti. La sua vitalità era irresistibile. Era vestito molto più poveramente di adesso: i calzoni erano rattoppati, addirittura spesse volte la camicia uno straccio. Però tutto ciò faceva parte di un modello che nella sua borgata aveva un valore, un senso. Ed egli ne era fiero. Al mondo della ricchezza egli aveva da opporre un proprio mondo altrettanto valido. Giungeva nella casa del ricco con un riso naturaliter anarchico, che screditava tutto: benché egli fosse magari rispettoso. Ma era appunto il rispetto di una persona profondamente estranea. E insomma, ciò che conta questa persona, questo ragazzo, era allegro. (idem, p.61). Secondo Pasolini, anche lo stragismo di quegli anni (fra cui l’attentato di Piazza Fontana a Milano del 12 dicembre 1969) è espressione della nevrosi che deriva dal conformismo. Per Pasolini i veri responsabili degli atti terroristici non erano dei giovani sbandati e senza validi punti di riferimento, ma semmai il sistema governativo nel suo complesso, poiché il fatto stesso di far parte del tessuto politico implica il corrompersi, il divenire conniventi. Pasolini, nel famoso articolo del 1974 Che cos’è questo golpe? afferma di conoscere i nomi dei veri responsabili delle stragi, ma di non poterli rivelare poiché (in quanto personalità estranea ai giochi di potere) non ha ‘né prove né indizi’, ma solo la certezza del suo intuito di uomo intellettuale, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentati di un intero quadro politico (idem, p.89). Pasolini riconduceva il termine stragismo anche alla pratica dell’aborto, che ritiene una tragedia demografica ecologica, ovvero uno minaccia alla sopravvivenza dell’umanità. Pasolini evidenzia che nell’ambito del ‘nuovo fascismo’ un figlio che nasce non è più considerato un dono di Dio, ma soltanto un fastidio, poiché prevale il timore dell’essere in troppi nella spartizione dei beni di consumo. Piuttosto che rinunciare ai propri capricci, si preferisce eliminare chi è più debole ed indifeso. Per Pasolini l’aborto è una colpa morale, un qualcosa che riguarda non la politica ma la coscienza individuale. La logica dell’eugenetica non ha nulla a che fare con la democraticità dello stato prenatale, con la sua piena ed incondizionata aderenza alla vita: Non c’è nessuna buona ragione pratica che giustifichi la soppressione di un essere umano, sia pure nei primi stadi della sua evoluzione. Io so che in nessun altro fenomeno dell’esistenza c’è un altrettanto furibonda, totale essenziale volontà di vita che nel feto. La sua ansia di attuare la propria potenzialità, ripercorrendo fulmineamente la storia del genere umano, ha un qualcosa di irresistibile e perciò di assoluto e gioioso. (idem, p.111). Sono parecchi gli articoli in cui Pasolini permalosamente se la prende coi suoi critici o detrattori, e che sono, a loro volta, intellettuali (spesso di sinistra come lui) e anche di tutto rispetto, come ad esempio Umberto Eco, Giorgio Bocca, Italo Calvino, Giuseppe Prezzolini, Franco Rodano, Maurizio Ferrara. Secondo Pasolini, anche il mondo intellettuale era chiuso nel suo ristretto snobismo: Io so bene, caro Calvino, come si svolge la vita di un intellettuale. Lo so perché in parte è anche la mia vita. Letture, solitudini al laboratorio, cerchie in genere di pochi amici e molti conoscenti, tutti intellettuali e borghesi. Una vita di lavoro e sostanzialmente per bene. Ma io, come il dottor Hyde, ho un’altra vita. Nel vivere questa vita, devo rompere le barriere naturali (e innocenti) di classe. Sfondare le pareti dell’Italietta, e sospingermi quindi in un altro mondo: il mondo contadino, il mondo sottoproletario e il mondo operaio (idem, p.52). Per Pasolini l’unico suo vero impegno diviene quello preso col lettore, che ritiene all’altezza di accettarlo nel bene e nel male, di accompagnarlo nelle sue più smodate ed indomite incursioni: Io non ho alle mie spalle nessuna autorevolezza: se non quella che mi proviene paradossalmente dal non averla e dal non averla mai voluta; dall’essermi messo in condizione di non aver niente da perdere, e quindi di non essere fedele a nessun patto che non sia quello di un lettore che io considero del resto degno di ogni più scandalosa ricerca (idem, p.83).
Alberto Moravia, durante la celebre orazione funebre in onore di Pasolini, mise in evidenza che era stato innanzi tutto perso un poeta, ovvero un qualcuno che nasce di rado nel corso dei secoli.
"<…> Piange ciò che ha
fine e ricomincia. Ciò che era
area erbosa, aperto spiazzo, e si fa
cortile, bianco come cera,
chiuso in un decoro ch’é rancore;
ciò che era quasi una vecchia fiera
di freschi intonachi sghembi al sole,
e si fa nuovo isolato, brulicante
in un ordine ch’é spento dolore.
Piange ciò che muta, anche
per farsi migliore. La luce
del futuro non cessa un solo istante
di ferirci: é qui, che brucia
in ogni nostro atto quotidiano,
angoscia anche nella fiducia
che ci dà vita, nell’impeto gobettiano
verso questi operai, che muti innalzano,
nel rione dell’altro fronte umano,
il loro rosso straccio di speranza."
(Pier Paolo Pasolini Il pianto della scavatrice, 1956)
Ninetto Davoli: "Il mio Totò segreto". I ricordi dell'attore che recitò negli ultimi film del Principe girati da Pasolini: "Pier Paolo mi disse che avrebbe potuto superare Chaplin", scrive Ilaria Urbani il 14 aprile 2017 su “La Repubblica”. "Totò senta...". "Dite Pasolini...". "Antonio si sciolga, faccia una "totolata"". Gli sembra ancora di averli davanti agli occhi sul set di "Uccellacci e uccellini". Ninetto Davoli, dopo mezzo secolo, ha ancora vivido il ricordo del confronto tra la più grande maschera del '900 e il regista corsaro. E nel racconto dell'ex ragazzo di borgata della baraccopoli Borghetto Prenestino, scoperto da Ppp, sembra di rivedere anche padre e figlio Innocenti in quell'infinito cammino in bianco e nero sul set di una pellicola considerata dallo stesso Pasolini "disarmata, fragile". E di ritrovare pure frate Ciccillo e frate Ninetto. Davoli, dalle borgate al set del capolavoro poetico e picaresco, svolta colta nella carriera del Principe. Un incontro epifanico con quell'attore che Ninetto fino ad allora vedeva al cinema con gli amici. Un sodalizio che proseguì ne "La terra vista dalla luna" da "Le streghe" e in "Che cosa sono le nuvole?", dal film ""Capriccio all'italiana", l'ultimo girato da Totò prima di morire il 15 aprile 1967.
Davoli, cosa ha significato per lei Totò?
"Avevo 16 anni, Totò è stato fondamentale per iniziare quest'avventura, mi ha incoraggiato davanti alla cinepresa, ha alleggerito questa esperienza. Successe tutto all'improvviso, era così surreale trovarmi a recitare con il grande Totò, uno che andavo a vedere al cinema come Stanlio e Ollio. Ma questa volta non dovevo pagare per vederlo, era lì con me, ed ero pagato per recitare con lui. Mi davano 100mila lire, a uno povero come me. Facevo il falegname, a casa eravamo in sei in una sola stanza, vivevamo con 5mila lire alla settimana".
Totò come si rapportava sul set con questo giovane esordiente?
"Come me veniva dalla povertà, lui dai quartieri scalcinati di Napoli, io dalle borgate romane, ideologicamente la pensavamo uguale. Il nostro fu uno scambio di semplicità, una vera complicità. Secondo Pier Paolo ci somigliavamo. Considerava Totò uno di strada come me, un non -intellettuale, anche se lo rispettava molto, gli dava del lei: "Totò senta", "Antonio ascolti"... ".
E Totò nei confronti di Pasolini?
"Anche Totò gli dava del voi: era intimorito da Pier Paolo, non improvvisava come faceva in genere, ma rispettava la sceneggiatura. Pier Paolo gli diceva: Antonio si sciolga, faccia una "totolata". C'era grande stima".
Pasolini racconta di aver scelto Totò per quella perfetta armonia tra l'assurdità clownesca tipica delle favole e l'immensamente umano...
"A Pier Paolo piacevano i film di Totò e diceva che avrebbe potuto superare Charlie Chaplin se l'avessero saputo "usare meglio", nel senso se avesse fatto più film d'autore".
Nel '66 Pasolini scrisse un film sull'utopia, "Le avventure del Re magio randagio", che lei doveva interpretare con Totò, ma poi non si fece in tempo e che poi ha ispirato un film di Sergio Citti...
"Sì, ma quella di Pier Paolo era una storia diversa, non c'entra con quella di Citti. Totò doveva essere il Re magio e io il suo aiutante. Con un dono partivamo da Napoli alla ricerca di Cristo che stava per nascere. Attraversavamo Roma, Milano, Parigi, New York e poi arrivavamo a Betlemme, ma trovavamo Cristo già morto. Dopo la scomparsa di Totò, Pasolini voleva Eduardo (il titolo diventò "Porno-Teo-Kolossal", ndr), ma poi è successo quello che è successo...".
Oggi chi è in grado di raccogliere l'eredità di Totò e Pasolini?
"Non esiste nessuno con quella potenza e quel coraggio. Totò e Pier Paolo vengono celebrati soprattutto da morti, ricordiamo che Totò veniva massacrato dai critici. Sono accomunati da un destino simile. Trovo giusto celebrare Totò a 50 anni dalla morte, ma mi chiedo perché non prima? Totò andrebbe studiato di più nelle scuole, così come Pier Paolo ed Eduardo".
Totò. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. «Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo Paese, in cui però per venire riconosciuti in qualcosa, bisogna morire.» (Franca Faldini, citando le parole del compagno Totò). «Ma mi faccia il piacere!», « ... bazzecole, quisquilie, pinzellacchere!» (Modi di dire di Totò).
Antonio De Curtis, in arte Totò. Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfiro-genito Gagliardi de Curtis di Bisanzio (brevemente Antonio de Curtis) (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un artista italiano. Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe della risata», è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiani. Si distinse anche al di fuori della recitazione, lasciando contributi come drammaturgo, poeta, paroliere, cantante. Nato Antonio Vincenzo Stefano Clemente da Anna Clemente (Palermo, 2 gennaio 1881 - Napoli, 23 ottobre 1947) e dal marchese Giuseppe De Curtis (Napoli, 12 agosto 1873 - Roma, 29 settembre 1944), fu adottato nel 1933 dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas di Tertiveri. Maschera nel solco della tradizione della commedia dell'arte, accostato a comici come Buster Keaton e Charlie Chaplin, ma anche ai fratelli Marx e a Ettore Petrolini. In quasi cinquant'anni di carriera spaziò dal teatro (con oltre 50 titoli) al cinema (con 97 pellicole) e alla televisione (con 9 telefilm e vari sketch pubblicitari), lavorando con molti tra i più noti protagonisti dello spettacolo italiano e arrivando a sovrastare con numerosi suoi film i record d'incassi. Adoperò una propria unicità interpretativa, che risaltava sia in copioni puramente brillanti sia in parti più impegnate, sulle quali si orientò soprattutto verso l'ultima fase della sua vita, che concluse in condizioni di quasi cecità a causa di una grave forma di corioretinite, probabilmente aggravata dalla lunga esposizione ai fari di scena. Spesso stroncato dalla maggior parte dei critici cinematografici, fu ampiamente rivalutato dopo la morte, tanto da risultare ancor oggi il comico italiano più popolare di sempre. Franca Faldini, sua compagna, diventata giornalista e scrittrice dopo la morte dell'attore, scrisse nel 1977 il libro Totò: l'uomo e la maschera, realizzato insieme a Goffredo Fofi, in cui raccontò sia il profilo artistico sia la vita dell'attore fuori dal set, con l'intento principale di smentire alcune false affermazioni riportate da scrittori e giornalisti riguardo alla sua personalità.
Totò nacque il 15 febbraio 1898 nel rione Sanità (un quartiere considerato il centro della “guapperia” napoletana), in via Santa Maria Antesaecula al secondo piano del civico 109, da una relazione clandestina di Anna Clemente con Giuseppe De Curtis che, in principio, per tenere segreto il legame, non lo riconobbe, risultando dunque per l'anagrafe "Antonio Clemente, figlio di Anna Clemente e di N.N." Nato Antonio Clemente, ma conosciuto nel suo quartiere con il nomignolo di "Totò", che gli fu attribuito dalla madre.
Il marchese Giuseppe De Curtis, il padre di Totò che, inizialmente, non lo riconobbe come figlio naturale.
Anna Clemente, la madre, che tentò di introdurlo come sacerdote. «Meglio ‘nu figlio prevete ca ‘nu figlio artista», affermava.
Solitario e di indole malinconica, crebbe in condizioni estremamente disagiate e fin da bambino dimostrò una forte vocazione artistica che gli impediva di dedicarsi allo studio, cosicché dalla quarta elementare fu retrocesso in terza. Ciò non creò in lui molto imbarazzo, anzi intratteneva spesso i suoi compagni di classe con piccole recite, esibendosi con smorfie e battute. Il bambino riempiva spesso le sue giornate osservando di nascosto le persone, in particolare quelle che gli apparivano più eccentriche, cercando di imitarne i movimenti, e facendosi attribuire così il nomignolo di «'o spione». Questo suo curioso metodo di "studio" lo aiutò molto per la caratterizzazione di alcuni personaggi interpretati durante la sua carriera.
Terminate le elementari, venne iscritto al collegio Cimino, dove per un banale incidente con uno dei precettori, che lo colpì involontariamente con un pugno, il suo viso subì una particolare conformazione del naso e del mento; un episodio che caratterizzò in parte la sua "maschera". Nel collegio non fece progressi, decise di abbandonare prematuramente gli studi senza ottenere perciò la licenza ginnasiale. La madre lo voleva sacerdote, in un primo tempo dovette quindi frequentare la parrocchia come chierichetto, ma incoraggiato dai primi piccoli successi nelle recite in famiglia (chiamate a Napoli «periodiche») e attratto dagli spettacoli di varietà, nel 1913, ancora in età giovanissima, iniziò a frequentare i teatrini periferici esibendosi – con lo pseudonimo di "Clerment" – in macchiette e imitazioni del repertorio di Gustavo De Marco, un interprete napoletano dalla grande mimica e dalle movenze snodate, simili a quelle d'un burattino. Proprio su quei palcoscenici di periferia incontrò attori come Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo e i musicisti Cesare Andrea Bixio e Armando Fragna.
Durante gli anni della prima guerra mondiale si arruolò volontario nel Regio Esercito venendo assegnato al 22º Reggimento fanteria, rimanendo di stanza dapprima a Pisa e poi a Pescia. Venne quindi trasferito al CLXXXII Battaglione di milizia territoriale, unità di stanza in Piemonte, ma destinate a partire per il fronte francese. Alla stazione di Alessandria, il comandante del suo battaglione lo armò di coltello e lo avvertì che avrebbe dovuto condividere i propri alloggiamenti in treno con un reparto di soldati marocchini dalle strane e temute abitudini sessuali. Totò a quel punto, terrorizzato, fu colto da malore (secondo alcune voci improvvisò un attacco epilettico) e venne ricoverato nel locale ospedale militare, evitando così di partire per la Francia. Rimasto in osservazione per breve tempo, quando fu dimesso dalle cure ospedaliere venne inserito nell'88º Reggimento fanteria "Friuli" di stanza a Livorno; proprio in quel periodo subì continui soprusi e umiliazioni da parte di un graduato; da quell'esperienza nacque il celebre motto dell'attore: «Siamo uomini o caporali?».
Dopo il servizio militare avrebbe dovuto fare l'ufficiale di marina, ma, non digerendo la disciplina, scappò di casa per esibirsi ancora come macchiettista; venne scritturato dall'impresario Eduardo D'Acierno (diventò poi celebre la macchietta de Il bel Ciccillo, riproposta nel 1949 nel film Yvonne la nuit) e ottenne un primo successo alla Sala Napoli, locale minore del capoluogo campano, con una parodia della canzone di E. A. Mario Vipera, intitolata Vicolo, che aveva sentito recitare al Teatro Orfeo dall'attore Nino Taranto, al quale chiese se poteva "rubargliela".
All'inizio degli anni Venti il marchese Giuseppe De Curtis riconobbe Totò come figlio e regolarizzò la situazione familiare sposandone la madre. Riunita, la famiglia si trasferì a Roma, ove Totò, con la disapprovazione totale dei genitori, fu scritturato come "straordinario" - cioè un elemento da utilizzare occasionalmente e senza nessun compenso - nella compagnia dell'impresario Umberto Capece, un reparto composto da attori scadenti e negligenti. Si affacciò così alla commedia dell'arte e guadagnò un particolare apprezzamento del pubblico impersonando sul palco l'antagonista di Pulcinella. Tuttavia, il giovane si sacrificava non poco per raggiungere il teatro: dal momento che non aveva i soldi neanche per un biglietto del tram, doveva partire da Piazza Indipendenza per arrivare a Piazza Risorgimento, che si trovava dall'altra parte della città; a tal proposito, nella stagione invernale, chiese qualche moneta all'impresario Capece che, in modo esageratamente brusco e inaspettato, lo esonerò e lo sostituì all'istante con un altro "straordinario". L'episodio fu un duro colpo per Totò, che rimase esterrefatto e dopo aver raccolto i suoi effetti si allontanò a malincuore dal teatro.
In quel breve periodo di disoccupazione Totò piombò nello sconforto totale ed il suo morale si alzava solo quando riusciva a racimolare qualche soldo esibendosi in piccoli locali; nel corso di quelle esperienze, decise di puntare al genere teatrale a lui più congeniale: il varietà (variété, nella declinazione francese). Progettò di presentarsi al capocomico napoletano Francesco De Marco (famoso per delle stravaganti esibizioni teatrali), ma all'ultimo minuto ebbe un ripensamento, probabilmente a causa dell'insicurezza. L'attore iniziò a ponderare l'idea di esibirsi da solo e dunque decise di mantenere come modello d'ispirazione Gustavo De Marco (omonimo, ma non parente del capocomico Francesco), che Totò, esercitandosi davanti allo specchio, riusciva ad imitare senza particolari sforzi. Appena sentitosi pronto, decise di tentare al Teatro Ambra Jovinelli, che al tempo era la massima rappresentazione dello spettacolo di varietà, dove erano passati artisti come Ettore Petrolini, Raffaele Viviani, Armando Gill, Gennaro Pasquariello, Alfredo Bambi e lo stesso De Marco. Emotivamente teso, si presentò al titolare del teatro, Giuseppe Jovinelli, un uomo rude conosciuto e rispettato per un suo passato scontro con un piccolo boss della malavita locale. Il breve colloquio andò inaspettatamente bene e Totò, per sua gioia e incredulità, venne preso. Debuttò con tre macchiette di De Marco: Il bel Ciccillo, Vipera e Il Paraguay, che ebbero un buon successo di pubblico e un impensabile entusiasmo da parte di Jovinelli. Il comico firmò un contratto prolungato col titolare, che lo usò spesso in varie parti dello spettacolo e che organizzò addirittura un finto match tra lui e il pugile Oddo Ferretti. Il consenso del pubblico ottenuto al teatro non compensava però lo stile di vita dell'artista: la paga era molto bassa e non poteva neanche permettersi abiti eleganti e accessori raffinati (ai quali lui teneva molto) o un taglio di capelli caratteristico, con le basette come quelle di Rodolfo Valentino. In quell'arco di tempo fece appunto amicizia con un barbiere, Pasqualino, il quale, avendo conoscenze in campo teatrale e impietosito dalle ristrettezze economiche del giovane, riuscì a farlo scritturare da Salvatore Cataldi e Wolfango Cavaniglia, i proprietari del Teatro Sala Umberto I. Totò rinnovò il suo corredo teatrale (che fino a quel momento era composto da un singolo abito di scena sempre più consumato): una logora bombetta, un tight troppo largo, una camicia lisa con il colletto basso, una stringa di scarpe per cravatta, un paio di pantaloni corti e larghi a zompafosso, calze colorate e comuni scarpe basse e nere. La sera dell'esordio l'attore diede il meglio di sé, lasciandosi andare in mimiche facciali, piroette, doppi sensi e le immancabili macchiette di Gustavo De Marco. Tra grida di bis ed applausi, l'esperienza al salone Umberto I segnò per Totò l'affermazione definitiva nello spettacolo di varietà.
Tra il 1923 e il 1927 si esibì nei principali caffè-concerto italiani, facendosi conoscere anche a livello nazionale. Grazie ai maggiori guadagni, poté finalmente permettersi di vestire abiti eleganti e di curare maggiormente il suo aspetto fisico, con i capelli impomatati e le desiderate basette alla Rodolfo Valentino; fu un periodo roseo soprattutto per quanto riguarda le donne, con le quali ebbe una serie di avventure (per lo più con sciantose e ballerine), tanto che acquisì presto la fama di vero «sciupafemmene». Prima di iniziare un suo spettacolo, sbirciava sempre tra il pubblico alla ricerca della "bella di turno" alla quale dedicare la sua esibizione, che il più delle volte, dopo varie serate, lo raggiungeva nel suo camerino durante l'intervallo o al termine dello spettacolo.
Nel 1927 fu scritturato da Achille Maresca, titolare di due diverse compagnie; Totò entrò a far parte prima della compagnia di cui era primadonna Isa Bluette, una delle soubrette più in voga del periodo, e poi, dal 1928 di quella di Angela Ippaviz; gli autori erano "Ripp" (Luigi Miaglia) e "Bel Ami" (Anacleto Francini). Nella prima compagnia conobbe Mario Castellani, destinato a diventare in seguito una delle sue "spalle" più fedeli ed apprezzate. Nel 1929, mentre si trovava a La Spezia con la compagnia di Achille Maresca, venne contattato dal barone Vincenzo Scala, il titolare del botteghino del teatro Nuovo di Napoli, che fu mandato dall'impresario Eugenio Aulicio per scritturarlo come "vedette" in alcun spettacoli di Mario Mangini e di Eduardo Scarpetta, tra cui Miseria e nobiltà, Messalina e I tre moschettieri (dove impersonò d'Artagnan), accanto a Titina De Filippo. Messalina rimase particolarmente impresso negli occhi del pubblico, in quanto Totò improvvisò una scenetta in cui si arrampicò su per il sipario e fece smorfie e sberleffi agli spettatori, i quali andarono totalmente in visibilio.
Le soddisfazioni professionali dell'attore non andavano però di pari passo con quelle sentimentali. Nonostante il suo successo con le donne e le numerose avventure, si sentiva inappagato. Fino a quando non irruppe nella sua vita Liliana Castagnola, che Totò vide su alcune fotografie in un provocante abito di scena, rimanendone subito colpito. La sciantosa, fino a quel momento, era stata costante oggetto delle cronache mondane: fu espulsa dalla Francia con l'accusa di aver indotto due marinai al duello, e un suo amante geloso si tolse la vita dopo averle sparato due colpi di pistola, uno dei quali l'aveva ferita al viso lasciandole un frammento di proiettile che le causava forti dolori e per i quali assumeva tranquillanti. A causa della cicatrice, sebbene lieve, ella adottò la pettinatura "a caschetto" che le copriva guance e fronte. La donna giunse a Napoli nel dicembre 1929, scritturata dal Teatro Nuovo, e incuriosita dal veder recitare l'artista napoletano si presentò una sera ad un suo spettacolo. Totò non si lasciò sfuggire l'occasione e iniziò a corteggiarla mandandole, alla pensione degli artisti dove lei abitava, mazzi di rose con un biglietto d'ammirazione, al quale lei rispose con una lettera d'invito. Furono questi gli inizi di un'intensa (seppur breve e tormentata) storia d'amore. Sebbene fosse una donna fatale sia sul palcoscenico sia nella vita reale, la Castagnola aveva per l'artista napoletano un sentimento sincero e passionale, cercando una relazione stabile e sicura. Dopo il primo periodo iniziarono i problemi legati alla gelosia: Totò non sopportava l'idea che Liliana, durante le sue tournée, fosse corteggiata dagli ammiratori e questo lo portò a temere eventuali tradimenti, situazione che diede origine a continui litigi. Entrambi furono poi vittime di malelingue e pettegolezzi, la donna entrò in un profondo stato di depressione e la loro relazione si deteriorò. Liliana, accrescendo un senso di attaccamento morboso al suo uomo, pur di restargli accanto propose di farsi scritturare nella sua stessa compagnia; ma Totò, sentendosi oppresso dal comportamento della donna, fu più volte sull'orlo di lasciarla, fino a quando decise di accettare un contratto con la compagnia della soubrette "Cabiria", che lo avrebbe portato a Padova.
L'epilogo fu che Liliana, sentitasi abbandonata dall'amato, si suicidò ingerendo un intero tubetto di sonniferi. Fu trovata morta nella sua stanza d'albergo, con al suo fianco una lettera d'addio a Totò: «Antonio, potrai dare a mia sorella Gina tutta la roba che lascio in questa pensione. Meglio che se la goda lei, anziché chi mai mi ha voluto bene. Perché non sei voluto venire a salutarmi per l'ultima volta? Scortese, omaccio! Mi hai fatto felice o infelice? Non so. In questo momento mi trema la mano... Ah, se mi fossi vicino! Mi salveresti, è vero? Antonio, sono calma come non mai. Grazie del sorriso che hai saputo dare alla mia vita grigia e disgraziata. Non guarderò più nessuno. Te l'ho giurato e mantengo. Stasera, rientrando, un gattaccio nero mi è passato dinnanzi. E, ora, mentre scrivo, un altro gatto nero, giù per la strada, miagola in continuazione. Che stupida coincidenza, è vero?... Addio. Lilia tua»
Totò, che ritrovò il corpo esanime della donna il mattino seguente, ne rimase sconvolto: il peso della responsabilità, il non aver capito l'intensità dei sentimenti di lei e i rimorsi per aver pensato «ha avuto molti uomini, posso averla senza assumermi alcuna responsabilità», lo accompagnarono per tutta la vita, tanto che decise di seppellirla nella cappella dei De Curtis a Napoli, nella tomba sopra la sua, e decretò che, qualora avesse avuto una figlia, invece di battezzarla col nome della nonna paterna Anna (secondo l'uso napoletano), le avrebbe dato il nome di Liliana, cosa che poi effettivamente fece con la figlia Liliana De Curtis. Totò volle inoltre conservare un fazzoletto intriso di rimmel che raccolse la mattina del ritrovamento del corpo di Liliana, con il quale probabilmente ella si asciugò le lacrime in attesa della morte. In merito all'impegno già preso, la sera stessa partì per la tournée con la compagnia a Padova. Era il marzo del 1930. Tornato a Roma il mese successivo, si esibì nuovamente in numerosi spettacoli alla Sala Umberto I, dove ripropose il suo repertorio di macchiette e nuove creazioni, impersonando anche Charlot, come umile omaggio a Chaplin. Tornò poi a lavorare con l'impresario Maresca, dove iniziò una nuova tournée riproponendo i successi degli anni precedenti. Sempre nel 1930, anno dell'avvento del sonoro, Stefano Pittaluga, che produsse con la Cines La canzone dell'amore (il primo film italiano sonoro), era alla ricerca di nuovi volti da portare sul grande schermo. Le doti comiche di Totò non gli sfuggirono e dato che era in procinto di produrre un film, chiamato Il ladro disgraziato, gli fece fare un provino. La pellicola non vide mai la luce, anche per il fatto che il regista avrebbe voluto che Totò imitasse Buster Keaton, idea che all'attore non garbava. Momentaneamente accantonata l'eventualità di entrare nel cinema, nel 1932 diventò capocomico di una propria formazione, proponendosi nell'avanspettacolo, un genere teatrale che continuò a diffondersi in Italia fino al 1940. In tournée a Firenze conobbe l'allora sedicenne Diana Rogliani (la giovane età della ragazza suscitò inizialmente qualche riluttanza da parte di Totò, dalla quale ebbe una figlia che, in onore della compianta Castagnola, battezzò Liliana. Gli anni Trenta furono un periodo di grandi successi per il comico che, malgrado il guadagno non molto alto, si sentiva affermato: portò in scena, insieme alla sua prima spalla Guglielmo Inglese (più avanti fu Eduardo Passarelli), numerosi spettacoli in tutta Italia. Sulla traccia di copioni spesso approssimativi, Totò ebbe modo di dare sfogo alle risorse creative della sua comicità surreale, con mimiche grottesche e deformazioni/invenzioni linguistiche, interpretando anche Don Chisciotte e travestendosi addirittura da soubrette; imparò così l'arte dei guitti, ossia quegli attori che recitavano senza un copione ben impostato (molte macchiette le ripropose poi nel suo repertorio cinematografico: "Il pazzo", "Il chirurgo", "Il manichino”), arte alla quale Totò aggiunse caratteristiche tutte sue, pronto a sbeffeggiare i potenti quanto a esaltare i bisogni e gli istinti umani primari: la fame, la sessualità, la salute mentale. Naturalmente, come si confà allo stile di Totò, tutto espresso con distinti doppi sensi senza mai trascendere nella volgarità. A plasmare questa sua forma d'espressione, fu il fatto di aver vissuto per anni in povertà, difatti lui stesso era del pensiero che "la miseria è il copione della vera comicità..." che "non si può essere un vero attore comico senza aver fatto la guerra con la vita". Acquisì quindi una sua originale personalità recitativa, diventando uno dei maggiori protagonisti della stagione dell'avanspettacolo.
Nel 1933 si fece adottare dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas, per ereditarne così la lunga serie di titoli nobiliari. L'anno successivo mise su casa a Roma insieme alla figlia Liliana e alla compagna Diana Rogliani (per la quale nutriva un'ossessiva gelosia), che sposò nell'aprile del 1935. Fu in quel periodo che alcune personalità importanti tentarono di imporlo nel cinema: tra di loro Umberto Barbaro e Cesare Zavattini, che cercò infatti di inserirlo nella parte di “Blim" nel film Darò un milione di Mario Camerini - ruolo andato poi a Luigi Almirante. Non realizzandosi questi progetti, il vero debutto avvenne nel 1937 con Fermo con le mani!: il produttore Gustavo Lombardo, fondatore della Titanus, scritturò Totò dopo averlo notato mentre era a pranzo in un ristorante di Roma. La direzione fu affidata al regista Gero Zambuto. Il film però non ebbe gran successo; concepito con mezzi molto scarsi, l'intenzione primaria era proporre al pubblico italiano un'alternativa del personaggio di Charlot, di Chaplin. Nel 1938 Totò fu vittima di un infortunio: ebbe un distacco di retina traumatico e perse la vista dell'occhio sinistro, cosa di cui erano al corrente soltanto i familiari stretti e l'amico Mario Castellani. Nonostante l'incidente, trovò la forza di riaffacciarsi per un breve periodo al teatro d'avanspettacolo, la cui epoca, per lui gloriosa, giunse purtroppo al termine. In quel frattempo, causa il fatto che si sentiva come soffocato dal matrimonio e causa anche la sua opprimente gelosia nei confronti della giovane consorte (si dice che la tenesse perfino chiusa nel camerino mentre lui si esibiva, la sua vita coniugale entrò in crisi. Decise dunque di ritornare scapolo e si accordò con Diana per la separazione. In Italia non c'era la possibilità di divorzio, così dovettero chiedere lo scioglimento all'estero, in Ungheria, per far sì che fosse poi annullato in Italia. Dopo l'annullamento, i due continuarono comunque a vivere insieme, trasferendosi in Viale dei Parioli, insieme alla figlia e ai genitori di lui.
Dopo Fermo con le mani!, del quale Totò non si ritenne molto soddisfatto, ci fu, nel 1939, un secondo tentativo, che ebbe inizialmente problemi per i costi di produzione: Animali pazzi di Carlo Ludovico Bragaglia, dove Totò interpretò un doppio ruolo. Pure questo suo secondo film non fu del tutto riuscito, sebbene l'attore sfruttò al massimo le sue potenzialità "marionettistiche". Alla fine del 1939, andò in tournée a Massaua e Addis Abeba, in Etiopia, accompagnato da Diana Rogliani, Eduardo Passarelli e la soubrette Clely Fiamma, presentando lo spettacolo 50 milioni... c'è da impazzire!, scritto insieme a Guglielmo Inglese e già mostrato al pubblico italiano anni prima. Una volta rientrato in patria interpretò la sua terza pellicola, San Giovanni decollato, che fu sceneggiata, tra gli altri, da Cesare Zavattini, al quale venne affidata la regia dal produttore Liborio Capitani. Zavattini però non se la sentì e il compito passò ad Amleto Palermi. Il film fu un successo di critica: alcuni commenti sulla rivista Cinema e su L'Espresso elogiarono proprio la recitazione di Totò, la sua capacità espressiva, i suoi giochi di parole e i suoi movimenti snodati. Zavattini, che nutriva ammirazione artistica verso l'attore, scrisse per lui il soggetto Totò il buono, che non diventò mai un film ma servì allo sceneggiatore per la realizzazione del film Miracolo a Milano (1951), di Vittorio De Sica, con il quale instaurò uno dei sodalizi più celebri del neorealismo cinematografico italiano. Il quarto film fu L'allegro fantasma sempre di Amleto Palermi, dove a Totò vennero affidati tre ruoli differenti. Girato nell'autunno del 1940 (uscito poi a ottobre del '41), fu l'ultimo film che interpretò prima del suo ritorno a teatro.
Questi primi esperimenti cinematografici surreali non ottennero il successo di pubblico che Totò aveva invece sul palcoscenico. Quando tornò a teatro, alla fine del 1940, l'avanspettacolo era già tramontato, sostituito dalla "rivista", un genere teatrale sorto a Parigi e dal carattere (almeno nel primo periodo) esclusivamente satirico - per quanto concesso dal regime fascista - presentato sotto forma di azioni sceniche ricche di allusioni e di accenni piccanti. In quel periodo l'Italia era da poco entrata in guerra e la ferrea censura del fascismo era attentissima a qualsiasi battuta ambigua o accenno negativo sul Governo di Mussolini. Totò debuttò al teatro Quattro Fontane di Roma insieme a Mario Castellani (da quel momento la sua "spalla" ideale) ed Anna Magnani (primadonna), con i quali instaurò un solido rapporto artistico e umano. La rivista era Quando meno te l'aspetti di Michele Galdieri, uno tra i grandi scrittori di riviste teatrali degli anni Quaranta. Totò strinse con Galdieri un sodalizio durato nove anni, con spettacoli scritti anche dall'attore stesso e messi in scena dagli impresari Elio Gigante e Remigio Paone; tra le riviste più note: Quando meno te l'aspetti, Volumineide, Orlando Curioso, Che ti sei messo in testa? e Con un palmo di naso. Causa la guerra, furono tempi difficoltosi anche per il teatro, per la mancanza di mezzi di trasporto, il divieto di circolazione delle auto private e soprattutto per i bombardamenti, in particolare a Milano, dove gli spettacoli venivano spesso interrotti e gli attori erano costretti ad allontanarsi verso il rifugio più vicino, senza avere il tempo di togliersi gli abiti di scena. Fu il periodo in cui Totò venne scritturato dalla Bossoli Film per riaprire una fessura nel cinema e prendere parte ad una nuova pellicola che comprendeva nel cast anche il pugile Primo Carnera, Due cuori fra le belve (ridistribuito dopo la guerra col titolo Totò nella fossa dei leoni), del regista Giorgio Simonelli, che venne girato con animali autentici. Nel maggio del '44, la rivista Che ti sei messo in testa (che avrebbe dovuto chiamarsi Che si son messi in testa?, un chiaro accenno ai tedeschi occupanti) creò problemi al comico napoletano, che dopo le prime rappresentazioni al teatro Valle di Roma, venne dapprima intimorito con una bomba all'entrata dal teatro, poi denunciato dalla polizia, insieme ai fratelli De Filippo, con un telegramma dal Comando Tedesco indirizzato al teatro Principe, che Totò non lesse mai; venne avvertito però da una telefonata anonima. Per evitare l'arresto, Totò, dopo aver allertato i fratelli De Filippo, si rifugiò con la ex moglie Diana e la figlia a casa di un amico in via del Gelsomino nei pressi della via Aurelia, all'estrema periferia ovest di Roma, mentre i De Filippo si nascosero in via Giosuè Borsi. Passati alcuni giorni Totò dovette comunque lasciare l'abitazione, per il fatto che molti suoi ammiratori lo avevano riconosciuto e quindi il nascondiglio non era più sicuro. Tornò a Roma, dove erano rimasti i genitori, e si segregò in casa fino al 4 giugno, il giorno della liberazione della capitale (secondo varie testimonianze avrebbe anche notevolmente contribuito ai finanziamenti della Resistenza romana).
Il 26 giugno riprese a recitare: tornò al teatro Valle con la Magnani nella nuova rivista Con un palmo di naso, in cui diede libero sfogo alla sua satira impersonando il Duce (sotto i panni di Pinocchio), e Hitler, che dissacrò ulteriormente dopo l'attentato del 20 luglio 1944, rappresentandolo in un atteggiamento ridicolo, con un braccio ingessato e i baffetti che gli facevano il solletico, e mandando l'intera platea in estasi. «Io odio i capi, odio le dittature... Durante la guerra rischiai guai seri perché in teatro feci una feroce parodia di Hitler. Non me ne sono mai pentito perché il ridicolo era l'unico mezzo a mia disposizione per contestare quel mostro. Grazie a me, per una sera almeno, la gente rise di lui. Gli feci un gran dispetto, perché il potere odia le risate, se ne sente sminuito.»
Nel 1945, dopo alcune esibizioni nella capitale, a Siena e a Firenze, portando in scena la rivista Imputati, alziamoci! (in cui faceva la caricatura di Napoleone), Totò fu avvicinato al termine dello spettacolo da un partigiano che, indispettito da una sua battuta di risposta che accomunava ironicamente fascisti e partigiani, lo colpì al viso con un pugno. Totò, corso immediatamente al commissariato per denunciare il fatto, decise poi di lasciar correre senza sporgere querela. In quel periodo il sodalizio artistico con Anna Magnani si interruppe, quando l'attrice si rivelò al grande pubblico internazionale interpretando il ruolo della popolana Pina nel film Roma città aperta, diretto dal suo compagno Roberto Rossellini. Totò invece proseguì per la sua strada continuando col cinema e con il teatro e incidendo anche il suo unico disco 78 giri come cantante, interpretando canzoni non sue: Marcello il bello nel lato A e Nel paese dei balocchi - dove venne coadiuvato da Mario Castellani - nel lato B.
Totò fu membro della Loggia massonica "Fulgor" di Napoli dal luglio 1945 e, in seguito, della Loggia "Fulgor Artis" di Roma, da lui stesso fondata. Entrambe le Logge appartenevano alla "Serenissima Gran Loggia Nazionale Italiana" di Piazza del Gesù. Dopo la morte del padre (avvenuta nel settembre del '44), Giuseppe De Curtis, tra il 1945 e gli anni successivi Totò alternò teatro e cinematografia, dedicandosi anche alla creazione di canzoni e poesie, ma anche ad una buona lettura, diligendo in particolar modo Luigi Pirandello. Interpretò la sua sesta pellicola, Il ratto delle Sabine, con il regista Mario Bonnard, film che venne accolto da alcune critiche avverse, come quella di Vincenzo Talarico, che stroncò l'attore "augurandosi che rientrasse al più presto nei ranghi del teatro di rivista." Poi ci fu I due orfanelli, scritto da Steno e Agenore Incrocci e diretto da Mario Mattoli, con il quale Totò interpretò altri tre film tra il '47 al '49: Fifa e arena, Totò al giro d'Italia (il primo film in cui compariva il suo nome nel titolo) e I pompieri di Viggiù (tutti di buon successo e incasso); inoltre, era il tempo della rivista C'era una volta il mondo di Galdieri, composta da sketch rimasti famosi, come quello del Vagone letto, con Totò al fianco di Isa Barzizza, la soubrette che debuttò nel film I due orfanelli e che proprio lui volle nella rivista, e Mario Castellani, la fedele "spalla" teatrale che lo accompagnò anche nel cinema, prendendo parte a quasi tutte le sue pellicole proprio per volere di Totò che, quando non c'erano ruoli disponibili, lo imponeva come aiuto-regista. La rivista C'era una volta il mondo ebbe tanto successo che venne presentata anche a Zurigo, recitata in italiano ma acclamata ugualmente dal pubblico svizzero per la genialità comica degli sketch. Spesso gli spettacoli di rivista di Totò si concludevano con la classica "passerella", col comico che correva tra il pubblico con una piuma sulla bombetta, al ritmo della fanfara dei Bersaglieri (scenetta riproposta nel film I pompieri di Viggiù). Nell'ottobre 1947, durante le repliche della rivista, la madre di Totò morì. Malgrado il grande dolore per la perdita di entrambi i genitori, l'attore non mischiò il lavoro con la vita privata, continuando ad essere il comico Totò nello spettacolo e il malinconico Antonio De Curtis al di fuori. Aprì anche una piccola parentesi come doppiatore, prestando la voce al cammello Gobbone nel film La vergine di Tripoli. Prima di riaffacciarsi al cinema, partì per alcune tournée a Barcellona, Madrid e altre città spagnole, dove recitò in spagnolo (senza avere padronanza della lingua) con Mario Castellani nella rivista Entre dos luces (Tra due luci), improvvisando una canzone non-sense a metà tra spagnolo e napoletano. Tornato in Italia, ebbe anche una piccola esperienza nel campo pubblicitario, facendosi fotografare a pagamento sulla rivista Sette che promuoveva i profumi Arbell.
Da quando entrò nel mondo del cinema, gli furono proposti moltissimi film, molti dei quali non venivano nemmeno realizzati, spesso per problemi di produzione o per sua rinuncia. Alcuni venivano girati contemporaneamente, in tempi ristrettissimi (la maggior parte in due o tre settimane) e su set spesso improvvisati, tanto che a volte era proprio la troupe che raggiungeva Totò nelle città in cui recitava a teatro. L'attore, complice la pigrizia, era sempre molto precipitoso quando gli venivano proposti dei progetti, ed essendo profondamente istintivo spesso non voleva conoscere nulla della pellicola che andava ad interpretare, affidandosi quindi alle sue qualità creative. Così, come sul palcoscenico, dava libero sfogo all'improvvisazione: il copione rappresentava solo un timido canovaccio per l'attore, che concepiva sul momento le gag e le battute; così tuttavia nacquero anche alcune delle sue scene cinematografiche più famose. «Era imprevedibile [...] recitava a braccio», testimoniò Nino Taranto; «Certe sue folli improvvisazioni durante la recitazione erano geniali e insostituibili» espresse invece Vittorio De Sica. Secondo alcuni commenti, invece - come quelli di Carlo Croccolo, Giacomo Furia e Steno - Totò si rinchiudeva nel suo camerino a provare e riprovare le sue battute prima dello spettacolo o delle riprese, rileggeva il copione e modificava i passaggi che non lo convincevano, insieme all'amico Mario Castellani e agli attori coinvolti.
Le differenze tra teatro e cinema crearono inizialmente non pochi disordini per l'attore, che, essendosi formato con lo stile teatrale e quindi con un'unica esecuzione dal vivo, dopo i primi ciak tendeva a perdere la concentrazione. Doveva perciò essere colto "al volo" per poter recitare al massimo; quindi la troupe doveva prima preoccuparsi di sistemare le luci e di preparare la scena con una controfigura, facendo anche qualche prova. Quando tutto era pronto, si poteva far intervenire Totò. Un'altra delle differenze tra le due forme d'arte, di cui il comico risentì molto inizialmente, fu il fatto di non riuscire a comunicare direttamente con il pubblico, uno dei particolari che più amava del teatro. Proprio per questo, di solito, i registi (in particolare Bragaglia, con il quale instaurò un solido rapporto artistico) e i membri della troupe lo spronavano dopo lo stop con un applauso, in modo da dargli maggiore carica ed entusiasmo. Un altro inconveniente furono gli orari: Totò, abituato agli orari teatrali, non si alzava mai prima di mezzogiorno, essendo poi un assertore della teoria che l'attore "al mattino non può far ridere”, girava nel cosiddetto orario francese, dalle 13 alle 21. Si stancava poi per le lunghe pause e attese che il cinema comporta, e inoltre, essendo molto superstizioso, si rinchiudeva in casa e non lavorava mai di martedì e di venerdì, 13 o 17. Fattori che creavano non pochi problemi per le riprese. Complicazioni particolari ci furono per Totò al giro d'Italia, dove erano coinvolti molti ciclisti famosi dell'epoca come Bartali, Coppi, Bobet, Magni; l'attore, non arrivando in orario, creava difficoltà. Nella stagione 1949/1950 ottenne l'ultimo successo a teatro con la rivista Bada che ti mangio!, costata ben cinquanta milioni, che debuttò al teatro Nuovo di Milano nel marzo del '49, dopodiché Totò si allontanò dal palcoscenico per dedicarsi esclusivamente al cinema. Dopo I pompieri di Viggiù, lavorò anche con Eduardo De Filippo nel suo film Napoli milionaria, che accettò di interpretare senza compenso, in segno dell'affettuosa amicizia che lo legava ad Eduardo. I due attori, sebbene avessero progettato di realizzare insieme altri film, non ebbero più modo di incontrarsi sul set, apparendo solo in episodi diversi de L'oro di Napoli di Vittorio De Sica ed in un breve cameo ne Il giorno più corto.
Nel 1950 Totò rinunciò alla proposta di avere un ruolo, insieme al francese Fernandel, nel film di produzione italo-francese Atollo K, dove avrebbe avuto l'opportunità di recitare insieme a Stan Laurel e Oliver Hardy, la famosa coppia comica conosciuta in Italia come Stanlio e Ollio.
Tra il 1949 e il 1950, oltre a Napoli milionaria, interpretò ben altri nove film, tra i quali alcune parodie: Totò le Mokò, Totò cerca moglie, Figaro qua, Figaro là, Le sei mogli di Barbablù, 47 morto che parla, tutti diretti da Carlo Ludovico Bragaglia, poi L'imperatore di Capri di Luigi Comencini, Tototarzan e Totò sceicco (dove s'invaghì dell'attrice Tamara Lees) di Mario Mattoli, Yvonne la nuit di Giuseppe Amato, Totò cerca casa di Steno e Mario Monicelli, un'efficace parodia del neorealismo sulla crisi degli alloggi, che suscitò un po' d'indignazione da parte della censura. Questi film, in misura diversa, ebbero un buon successo di pubblico, ma non di critica, che già dalle pellicole precedenti cominciò a non gradire lo stile surreale di Totò. Commentando in modo ironico queste avversità da parte dei critici, il principe osservò che probabilmente si era "guastato col crescere".
La morte dei genitori fu l'avvio di uno squilibrio familiare: nel 1951 Diana Rogliani, in seguito a un violento litigio, se ne andò di casa e si sposò; altrettanto fece, appena maggiorenne, e contro la volontà di Totò, la figlia Liliana, unendosi in matrimonio con Gianni Buffardi, figliastro del regista Carlo Ludovico Bragaglia. Totò restò solo, e in quel breve lasso di tempo scrisse la nota canzone Malafemmena, che concepì durante una pausa di lavorazione del suo nuovo film Totò terzo uomo, a cui seguirà Sette ore di guai. La canzone fu apparentemente scritta per la ex moglie Diana, alla quale era ancora molto legato, ma i giornali dell'epoca affermarono che Totò l'avesse dedicata a Silvana Pampanini, l'attrice con la quale recitò in 47 morto che parla e che, in quel periodo, corteggiava mandandole mazzi di rose e scatole di cioccolatini. Arrivò perfino a chiederle di sposarlo, uno dei motivi per la brusca separazione con la Rogliani), ma l'attrice lo respinse.
Nonostante le oscurità e le delusioni, il 1951 fu un anno importante per la carriera cinematografica dell'attore. Dopo il successo di Totò cerca casa, venne richiamato da Steno e Mario Monicelli per interpretare il ruolo del ladro Ferdinando Esposito in Guardie e ladri, al fianco di quell'attore che fu uno dei suoi amici più affezionati e una delle sue migliori "spalle", capace di rispondere colpo su colpo alle improvvise e "aggressive" battute di Totò, Aldo Fabrizi. Per Guardie e ladri Totò era all'inizio riluttante, il ruolo offertogli era finalmente reale, diverso dai suoi precedenti personaggi e inserito in un contesto decisamente più drammatico. Il film ebbe inizialmente problemi con la censura, ma appena uscito nelle sale fu un successo unanime: alti incassi, grande apprezzamento di pubblico e plauso inatteso da parte della critica. Nello stesso anno interpretò, sempre per la regia di Monicelli e Steno, Totò e i re di Roma, l'unico film che lo vide recitare con Alberto Sordi. L'anno seguente fu premiato con un nastro d’argento per la sua interpretazione in Guardie e ladri, e l'opera venne presentata al Festival di Cannes 1952, dove si aggiudicò il premio per la migliore sceneggiatura, l'anno in cui l'attore collaborò a Siamo uomini o caporali?, la sua biografia (che si ferma nel 1930 - dopo il suicidio di Liliana Castagnola) curata da Alessandro Ferraù ed Eduardo Passarelli.
Proprio nel 1952 Totò rimase colpito da una giovane sulla copertina del settimanale "Oggi", Franca Faldini. Le mandò subito un mazzo di rose con un biglietto: «Guardandola sulla copertina di “Oggi” mi sono sentito sbottare in cuore la primavera», poi le telefonò per invitarla a cena, la ragazza accettò solo quando Totò ebbe modo di farsi presentare. La Faldini, appena ventunenne, era da poco tornata dagli Stati Uniti, dove aveva preso parte al film Attente ai marinai! con Dean Martin e Jerry Lewis. Dopo essersi frequentati per circa un mese annunciarono il loro fidanzamento. Sebbene restassero insieme fino alla morte dell'artista, la loro relazione, che non arrivò mai al matrimonio, fu più volte sull'orlo di essere troncata, per il fatto di essere due persone caratterialmente molto diverse; un motivo, tra l'altro, fu la differenza di età di trentatré anni. La situazione di convivenza senza un legame matrimoniale creò scandalo all'epoca, tanto che, pochi anni più avanti, i due, stanchi di essere tormentati dai paparazzi e dai giornalisti (che li definivano "pubblici concubini"), furono costretti a fingere di essersi uniti in matrimonio all'estero, un espediente che comunque non funzionò sino in fondo.
Franca Faldini comparve anche nel cast di alcuni film del compagno. Il primo a cui partecipò fu Dov'è la libertà?, di Roberto Rossellini, che avendo apprezzato Totò in Guardie e ladri, lo scritturò per il suo film. La lavorazione non ebbe il percorso previsto. Venne girato nel 1952 e uscì nelle sale due anni dopo, per il fatto che nel corso delle riprese Rossellini si disinteressò della pellicola e si allontanò spesso dal set. Molte sequenze furono quindi girate dal regista Lucio Fulci e sembra che ci fossero state anche delle collaborazioni con Mario Monicelli e Federico Fellini. Insieme alla Faldini, girò poi Totò e le donne, nuovamente diretto da Steno e Monicelli, dove Totò recitò per la prima volta con Peppino De Filippo, con il quale formò in seguito una delle coppie più popolari del cinema italiano. Dopo che Steno e Monicelli si divisero, entrambi realizzarono, ciascuno per proprio conto, altri film con Totò. Il primo sfruttò la sua comicità surreale, il secondo proseguì sull'umanizzazione del personaggio (cominciata proprio con Guardie e ladri). Il primo grande risultato raggiunto da Steno fu Totò a colori - gran successo e incassi altissimi - uno dei primi film italiani a colori, girato col sistema "Ferraniacolor", in cui vennero riproposti alcuni dei suoi sketch teatrali, come quello di Pinocchio o del Vagone letto con Castellani e Isa Barzizza. Durante le riprese del film Totò iniziò ad avere diversi problemi, a causa delle potenti luci usate sul set, che gli causarono problemi alla sua vista già precaria e addirittura una lieve infiammazione ai capelli, finendo per svenire a causa dei forti dolori accusati all'occhio destro, il solo da cui vedeva dopo il distacco di retina del 1938 all'altro occhio. Continuò comunque a lavorare. Nel 1953, in seguito ad alcune illustrazioni di Totò il buono disegnate dallo sceneggiatore Ruggero Maccari su Tempo illustrato, furono (con l'ovvio consenso dell'attore) stampati e distribuiti degli albi a fumetti di Totò, rappresentato naturalmente in forma caricaturale, raccolti in una collana chiamata semplicemente Totò a fumetti, che illustrava storie liberamente ispirate ad alcune sue esibizioni teatrali. La collana venne pubblicata dalle Edizioni Diana di Roma.
Nel 1954, un suo brano musicale, Con te, dedicato a Franca Faldini, fu presentato al Festival di Sanremo, classificandosi al 9º posto nella graduatoria finale. La canzone venne interpretata da Achille Togliani, Natalino Otto e Flo Sandon's. Nello stesso anno, i giornali annunciarono che Totò avrebbe interpretato un film muto scritto da Age e Scarpelli, purtroppo il progetto fu presto annullato per il rifiuto dei produttori. Girare un film del genere sarebbe stata una grande soddisfazione per il comico, che affermò: «Il mio sogno è girare un film muto, perché il vero attore, come il vero innamorato, per esprimersi non ha bisogno di parole»; e fu proprio durante una vacanza sulla Costa Azzurra, in un periodo imprecisato degli anni cinquanta, che ebbe un'occasione unica di conoscere nientedimeno che il maestro del muto Charlie Chaplin, quando il suo yacht si ritrovò per caso accanto all'imbarcazione dell'artista inglese. Ma Totò, da sempre bloccato dall'insicurezza e dai complessi d'inferiorità, e pensando poi che l'altro non lo avrebbe riconosciuto per la sua poca popolarità all'estero, rinunciò a salutarlo.
Tra il 1953 e il 1955 interpretò diciassette film, lavorò nuovamente con Steno in L’uomo, la bestia e la virtù (dall'omonima commedia di Luigi Pirandello), dove nel cast era presente anche Orson Welles, poi con Mattòli ne Il più comico spettacolo del mondo (uno dei primi film italiani tridimensionali), e nella trilogia scarpettiana: Un turco napoletano, Miseria e nobiltà e Il medico dei pazzi. Fu anche chiamato dall'amico Aldo Fabrizi che lo volle per il film Una di quelle, al fianco di Peppino De Filippo, Lea Padovani e lo stesso Fabrizi; la pellicola (ridistribuita successivamente col titolo di Totò, Peppino e… una di quelle), dal tono drammatico e sentimentale, non ottenne il successo sperato. Si incontrò nuovamente anche con Monicelli, con il quale girò Totò e Carolina, film uscito nelle sale dopo un anno e mezzo dal termine della lavorazione perché massacrato dai tagli della censura, che era infastidita principalmente dai palesi riferimenti comunisti e dal fatto che Totò interpretasse un poliziotto, e per di più in un atteggiamento che tendeva a ridicolizzarsi.
Totò, di spirito caritatevole, per tutta la sua vita compì molteplici gesti d'altruismo, che includevano sostegno e offerte di viveri ai più bisognosi. Con l’avanzare dell’età si dedicò sempre più spesso a numerose opere di beneficenza: la vita privata dell’attore, negli ultimi anni, si limitava a sporadiche apparizioni in pubblico ma anche (seppur non avendo guadagni eccelsi per il fatto che pretendeva sempre poco dai produttori a un’intensa attività di benefattore, aiutando ospizi e brefotrofi, donando grandi somme alle associazioni che si occupavano degli ex carcerati e delle famiglie degli stessi. Avendo poi una particolare predilezione per i bambini, dopo la morte del figlio Massenzio Totò andava spesso a trovare, insieme a Franca Faldini, gli orfanelli dell'asilo Nido Federico Traverso, di Volta Mantovana, portando con sé regali e giocattoli. Inoltre, in merito al suo amore per gli animali, per raccogliere cani randagi acquistò e modernizzò un vecchio canile, L'ospizio dei trovatelli, che lui stesso visitava regolarmente per accertarsi che i numerosi ospiti a quattro zampe (si parla di più di 200 cani) avessero le cure necessarie. Le spese totali per l'assistenza e il mantenimento del canile arrivarono a costargli circa cinquanta milioni.
Fondò poi la società di produzione D.D.L., con sede legale al suo domicilio, collegata a Dino De Laurentiis e all'amministratore di Totò, Renato Libassi. Ebbe l'opportunità di lavorare con Alessandro Blasetti e anche Camillo Mastrocinque, con il quale girò molte pellicole di successo. La sua vita privata però, non scorreva tranquilla come quella di spettacolo: Franca Faldini, in seguito ad un parto drammatico, diede alla luce il figlio di Totò, Massenzio; il bambino, nato di otto mesi, morì dopo alcune ore.
Superato il dolore della perdita del figlio, al quale Totò reagì malissimo rinchiudendosi in casa per settimane, nel 1956 ritornò sul set interpretando a catena quattro film di Camillo Mastrocinque, che raggiunse il punto più alto del suo sodalizio con l'attore dirigendolo in Totò, Peppino e la... malafemmina (in cui si colloca la nota scena della “lettera”) e ne La banda degli onesti, scritto da Age e Scarpelli e interpretato insieme a Peppino e Giacomo Furia. Ma la tentazione di ritornare a teatro lo vinse, e, spronato anche dall'impresario Remigio Paone, recitò nella rivista A prescindere (che prendeva il nome da un suo modo di dire), che debuttò al teatro Sistina di Roma alla fine del '56, e che venne portata in tournée in tutta Italia. Nel mese di febbraio del 1957, a Milano, Totò venne colpito da una broncopolmonite virale, e nonostante i pareri dei medici che gli dissero di riposare, tornò sul palco dopo alcuni giorni, ciò gli causò uno svenimento appena prima di entrare in scena. I medici gli prescrissero almeno due settimane di assoluto riposo, ma Totò ritornò ugualmente a recitare esibendosi a Biella, Bergamo e Sanremo, dove cominciò ad avvertire i primi sintomi dell'imminente malattia alla vista. Il 3 maggio la situazione precipitò: mentre recitava al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo si avvicinò alla Faldini (che aveva sostituito l'attrice Franca May e recitava sul palco insieme a lui) sussurrandole che non vedeva più; contando perciò solo sulle sue abilità e sull'appoggio degli altri attori, fece in modo di accelerare la conclusione dello spettacolo. Nonostante lo sconforto e la totale cecità, cercò di resistere e, per non deludere il pubblico ritornò sul palcoscenico - con un paio di spessi occhiali da sole - la sera del 4 maggio e, in due spettacoli, del 5. L'interruzione della rivista fu comunque inevitabile. Inizialmente i medici attribuirono la cecità a un problema derivato dai denti, ma alla fine gli fu diagnosticata una corioretinite emorragica all'occhio destro. L'impresario della compagnia, Remigio Paone, non credendogli, richiese una visita fiscale e avrebbe preteso anche che Totò tornasse a recitare. Totò in un primo tempo fu completamente cieco, e anche dopo dei lievi miglioramenti e una volta riassorbita l'emorragia non riuscì più a riacquisire integralmente la vista. Dovette abbandonare definitivamente il teatro, continuando però con il cinema: in quell'anno restò quasi inattivo e interpretò solo un film, Totò, Vittorio e la dottoressa di Mastrocinque, ma le sue capacità recitative, malgrado la malattia, non si affievolirono mai. L'unico problema era il doppiaggio, quando alcune scene dei film non venivano girate in presa diretta, non poteva doppiarsi poiché non era in grado di vedersi sullo schermo e non poteva sincronizzare le battute con il movimento labiale; in tali occasioni, veniva doppiato da Carlo Croccolo. Per problemi economici fu costretto a vendere alcune proprietà, e successivamente decise di soggiornare per qualche giorno a Lugano, pensando di trasferirvisi definitivamente per motivi fiscali, ma ritornò a Roma e si spostò in un appartamento in affitto in Viale dei Parioli con Franca Faldini, che gli rimase sempre vicino, insieme a suo cugino Eduardo Clemente, che gli faceva da segretario e factotum, e al suo autista Carlo Cafiero, che di solito lo accompagnava sul set.
Sebbene non si conosca con certezza il pensiero politico di Totò, si sa da fonti accertate che era fermamente contrario a qualsiasi forma di dittatura e supremazia (anche per le sue esperienze personali e per i suoi sbeffeggiamenti del potere), e sembra che, a detta di Franca Faldini, fosse di idee fondamentalmente anarchiche. A smentire ciò, è una fotografia del tedesco Eugenio Haas risalente al 1943, scattata sul set di Due cuori fra le belve e pubblicata sulla rivista "Film", e che raffigurava l'attore con la "cimice", ossia il distintivo del Partito nazionale fascista. Si suppone che Totò sia stato in qualche modo costretto a posare per quella foto, la cui intenzione sarebbe stata quella di "punire l'audacia del comico", poiché scherniva e derideva il regime fascista nei suoi spettacoli teatrali, che difatti gli causarono molte complicazioni durante la guerra. Pur tenendo molto al suo titolo nobiliare, pur conducendo uno stile di vita sfarzoso, e pur essendo stato definito più volte un monarchico, Totò, secondo la Faldini, non pretendeva da nessuno di essere chiamato "principe", la sua mania per la nobiltà rappresentava per lui una sorta di riscatto dalla sua difficile vita giovanile. Ma il suo «Viva Lauro!», esclamato durante Il Musichiere, venne naturalmente mal interpretato. Essendo un periodo delicato, in prossimità delle elezioni politiche, non era tollerabile che un personaggio conosciuto come Totò osannasse il capo di un partito politico, ma l’unico motivo della sua esclamazione era dovuto al fatto che Lauro avesse provvisto di case e alimenti gli abitanti dei "bassi" (le dimore più povere) di Napoli. Totò apprezzò solamente il gesto, essendo fortemente attaccato alla sua città natale. Pur non coltivando molto interesse per l'ambito televisivo, nel '58 accettò l'invito come ospite d'onore nel programma Il Musichiere condotto da Mario Riva, con il quale aveva lavorato anni prima in alcuni film e riviste teatrali. Durante la trasmissione Totò si lasciò scappare un «Viva Lauro!», riferendosi ad Achille Lauro, l'allora capo del Partito Monarchico Popolare; questa sua sgradita, seppur scherzosa, considerazione politica, gli costò un allontanamento dal piccolo schermo (salvando alcune interviste in privato) sino al 1965, quando duettò con Mina a Studio Uno.
Dopo il forzato distacco dalla televisione, riprese a lavorare nel cinema. Sempre nel '58 recitò con l'attore francese Fernandel in La legge è legge e, tra le altre pellicole, prese parte al celebre film I soliti ignoti di Mario Monicelli, interpretando lo scassinatore in pensione Dante Cruciani e recitando, tra gli altri, con Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. In quel periodo gli venne assegnato il Microfono d'argento e in seguito una Targa d'Oro dall'ANICA, per il suo contributo al cinema italiano e per la sua lunga carriera artistica.
Nel '59 la sua salute peggiorò, durante la lavorazione del film La cambiale ebbe una ricaduta e non lavorò per due settimane, prima di concludere le riprese. Seguendo i consigli medici si concesse alcuni mesi di riposo, e dopo essersi ripreso inviò una sua canzone, Piccerella Napulitana, al Festival di Sanremo 1959, che però fu scartata, insieme ad un'altra di Peppino De Filippo. Totò accettò comunque di occupare il posto come presidente della giuria al Festival, in seguito alle insistenze di Ezio Radaelli, rifiutando tra l'altro un cospicuo pagamento giornaliero; però, in seguito a un disaccordo col resto della commissione, abbandonò prestissimo l'incarico.
Proprio all'apice del successo, l'agenzia artistica statunitense Ronald A. Wilford Associates di New York (agenzia di quel Ronald Wilford che avrebbe poi fondato e diretto la Columbia Artists Management International, considerata una delle agenzie più potenti del mondo) desiderava scritturarlo per uno spettacolo da rappresentare in America, insieme a Maurice Chevalier, Marcel Marceau e anche Fernandel. Naturalmente Totò non se la sentì e preferì rimanere in Italia a continuare in modo più "rilassante" con la cinematografia, rifiutando così, anche se malvolentieri, un'offerta importante e un altissimo compenso.
Nel 1961 gli venne comunicato che era vincitore della Grolla d'oro alla carriera, con la motivazione: «Al merito del cinema, per aver da lunghi anni onorato l'estro e il genio del Teatro dell'Arte». Ma la sua salute e i suoi impegni non gli permisero di partecipare alla premiazione a Saint-Vincent e la Grolla fu assegnata ad un altro attore.
Nonostante la malattia, Totò (da sempre fumatore) continuava a fumare fino a novanta sigarette al giorno. Cercò comunque di non rallentare troppo la sua già allora consistente produzione di film; e per il timore di perdere il lavoro e l'affetto del suo pubblico, cominciò ad accettare qualsiasi copione: aprì una parentesi con il regista Lucio Fulci ne I ladri e tornò con Steno nel film I tartassati, nuovamente al fianco di Aldo Fabrizi, a cui si aggiunse in un ruolo secondario l'attore francese Louis de Funès. Sebbene fosse quasi completamente cieco (vedeva solo dai lati degli occhi), tanto da dover indossare un pesante paio di occhiali scuri che toglieva soltanto per le riprese, si muoveva sul set con assoluta disinvoltura ed era come se tornasse, solo per un attimo, a vedere; cosa che proprio lui affermò: «Appena sento il ciak, vedo tutto. È un effetto nervoso».
Tra i tanti film interpretati negli anni Sessanta, oltre ai numerosi con Peppino e alcuni con Fabrizi, di buon successo furono Totòtruffa 62 di Camillo Mastrocinque, Gli onorevoli e la commedia amara I due marescialli di Sergio Corbucci, poi I due colonnelli di Steno (ricordato per la scena della “carta bianca”) e Risate di gioia di Monicelli, che segnò una tappa importante per Totò, dato che fu l'unica volta che recitò sul set insieme all'amica e compagna storica di teatro Anna Magnani. Non mancarono poi le parodie, come Totò contro Maciste, Totò e Cleopatra e Totò contro il pirata nero di Fernando Cerchio, che altro non furono che delle comiche rivisitazioni mitologiche dei film Peplum, a cui si aggiunsero Che fine ha fatto Totò Baby? (esplicita parodia di Che fine ha fatto Baby Jane?) di Ottavio Alessi e Totò diabolicus di Steno, quest'ultimo una parodia del genere giallo-poliziesco dove Totò concepì una delle sue prove recitative più complesse e riuscite, dando volto e fattezze a ben sei personaggi differenti.
In aggiunta, la fama che Totò vantava tra il pubblico, da sempre sfruttata dai produttori, venne usata come una sorta di veicolo pubblicitario o di lancio per cantanti quali Johnny Dorelli, Fred Buscaglione, Rita Pavone, Adriano Celentano, e per piccoli attori come Pablito Calvo che, già interprete di Marcellino pane e vino, recitò poi in Totò e Marcellino. Esplorò anche il filone notturno-sexy insieme a Erminio Macario in Totò di notte n. 1 e Totò sexy, due tra i film più fiacchi della sua carriera.
Nel gennaio del 1964 venne pubblicizzata la notizia dell'uscita del suo centesimo film, annunciato come il suo primo interamente drammatico, Il comandante. Diretto da Paolo Heusch e scritto da Rodolfo Sonego (sceneggiatore di fiducia di Alberto Sordi), richiese complessivamente otto settimane di lavoro, più del doppio rispetto alla media dei film di Totò. La notizia diede luogo a festeggiamenti e riconoscimenti, Totò ricevette perfino la "Sirena d'oro" e agli incontri internazionali del cinema venne accolto da un applauso interminabile, poche settimane dopo fu intervistato da Lello Bersani, per Tv7, e da Oriana Fallaci, per L'Europeo. Ma nonostante tutto, il film, che in realtà era l'ottantaseiesimo, si rivelò un insuccesso. Poi, presso l'editore Fausto Fiorentino di Napoli, pubblicò il famoso libro di poesie 'A livella, che in origine si chiamava Il due novembre, per la quale vinse anche un premio.
Nel 1965 conobbe un giovane Pasquale Zagaria che, interprete d'avanspettacolo, era stato consigliato dal titolare del teatro Jovinelli di rivolgersi a Totò al fine di trovare lavoro nel cinema. In quell'occasione Totò gli suggerì di cambiare il suo nome d'arte, che era Lino Zaga, spiegando che i diminutivi dei nomi portassero bene e quelli dei cognomi portassero male. Da allora il giovane attore si conferì lo pseudonimo di Lino Banfi.
«Ho girato diversi film mediocri, altri che erano veramente brutti, ma, dopo tutta la miseria patita in gioventù, non potevo permettermi il lusso di rifiutare le proposte scadenti e restarmene inattivo... » Al culmine della sua carriera, anche se poco prima della morte, arrivarono proposte importanti da cineasti come Alberto Lattuada, Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini. Col primo girò, nel 1965, il film La mandragola, nel ruolo di Fra' Timoteo, che interpretò in modo brillante. Il secondo lo avrebbe voluto per il film Il viaggio di G. Mastorna, dove erano previsti nel cast anche Mina, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Lavorare con Fellini era sempre stata una delle maggiori ambizioni di Totò, ma la pellicola purtroppo non fu mai realizzata. L'incontro con Pasolini, invece, fu uno dei più importanti e inaspettati dell'intera carriera cinematografica di Totò. La prima opera realizzata insieme fu Uccellacci e uccellini, che Totò accettò senza condividere appieno il suo personaggio e la poetica del regista; ormai il suo intento principale era produrre opere di qualità, per la ricorrente paura d'essere dimenticato dal pubblico. Pasolini lo scelse perché rimase affascinato dalla sua "maschera", che riuniva perfettamente "l'assurdità e il clownesco con l'immensamente umano". Per la prima volta Totò, durante la lavorazione di un film, si sentì in qualche modo smorzato, per volere di Pasolini che lasciava poco spazio ai suoi lazzi e alle sue improvvisazioni, rispetto a come era solitamente abituato con gli altri registi. Uccellacci e uccellini, opera di grande forza poetica, fin dall'inizio fu oggetto di discussioni e controversie, anche se fu quasi unanime il riconoscimento della grande interpretazione di Totò, che, lodato dalla critica, conseguì una menzione speciale al Festival di Cannes e il suo secondo nastro d’argento, e, per esprimere la sua soddisfazione, ringraziò la giuria dei critici cinematografici italiani attraverso una breve dichiarazione scritta. Prima di ritornare con Pasolini, ottenne un ruolo in Operazione San Gennaro di Dino Risi, accanto a Nino Manfredi. Nel 1967 girò con Pasolini il cortometraggio La terra vista dalla luna, episodio del film collettivo Le streghe, tratto dal racconto di Pasolini mai pubblicato Il buro e la bura; poi Che cosa sono le nuvole?, un episodio del film Capriccio all'italiana, dove l'attore prese parte anche a un altro corto di Steno: Il mostro della domenica.
Furono le sue ultime pellicole. Venne chiamato anche da Nanni Loy per Il padre di famiglia, di nuovo con Manfredi, in un ruolo di un anziano anarchico che vive vendendo calzini e mutande ai compagni della sinistra; film destinato a collocarsi fra i tanti progetti non realizzati da Totò, poiché girò la prima scena (per ironica casualità, quella d'un funerale) e morì due giorni dopo.
Totò incontrò la televisione già nel 1958, insieme a Mario Riva nel programma Il Musichiere. Fece ritorno solo nel 1965, invitato da Mina nella trasmissione Studio Uno, partecipando a due puntate: nella prima, subito accolto da un lunghissimo applauso, presentò la sua canzone Baciami, lasciando cantare Mina mentre lui interveniva facendo da contrappunto alle parole della canzone con qualche sua classica battuta. Nella seconda puntata, nel 1966, ripropose invece un vecchio sketch (Pasquale) con Mario Castellani. La scenetta venne poi incisa, insieme alla poesia 'A livella, in un disco 33 giri dell'attore. Nel suo ultimo periodo di vita, mise in lavorazione alcuni caroselli e una serie per la tv chiamata TuttoTotò, comprendente nove telefilm a cura di Bruno Corbucci e diretti da Daniele D'Anza. La serie, nata da un'idea di Mario Castellani, doveva essere inizialmente diretta da Michele Galdieri (l'autore di molte riviste di Totò), ma morì prima che iniziasse la lavorazione. La maggior parte dei copioni di questi telefilm apparivano troppo deboli, e soltanto alcuni di questi, con testi discreti, diedero modo a Totò di esibirsi in alcuni suoi numeri, riproponendo alcuni dei suoi famosi sketch teatrali. L'attore appariva però provato e lavorava non più di quattro ore nel pomeriggio, ma nonostante tutto era ancora in grado di padroneggiare la scena. Il ciclo andò in onda dopo la sua morte, dal maggio al luglio del '67, per poi essere replicato dieci anni più tardi. Positiva fu l'accoglienza del pubblico, più fredda quella della critica, che sottolineava come la comicità di Totò non apparisse al meglio a causa della realizzazione frettolosa e approssimativa.
Alcuni giorni prima della sua morte, Totò disse di chiudere in fallimento e che nessuno lo avrebbe ricordato, dichiarò di non essere stato all'altezza delle infinite possibilità che il palcoscenico offre (riferendosi chiaramente alla sua vera e unica passione, il teatro) e si rimproverò del fatto che avrebbe potuto fare molto di più. Morì nella sua casa di Via dei Monti Parioli, 4; alle 3:25 del mattino (l'ora in cui era solito coricarsi era le 3:30 circa) del 15 aprile 1967, all'età di 69 anni: venne stroncato da un infarto dopo una lunga agonia, tanto sofferta che lui stesso pregò i familiari e il medico curante di lasciarlo morire. Proprio la sera del 13 aprile confessò al suo autista Carlo Cafiero: «Cafiè, non ti nascondo che stasera mi sento una vera schifezza». Secondo la figlia Liliana, le sue ultime parole furono: «Ricordatevi che sono cattolico, apostolico, romano», mentre a Franca Faldini disse: «T'aggio voluto bene Franca, proprio assai.»
Nonostante l'attore avesse sempre espresso il desiderio di avere un funerale semplice, ne ebbe addirittura tre. Il primo nella capitale, dove morì. La sua salma fu vegliata per due giorni dalle principali personalità dello spettacolo e non, giunte da tutta Italia per commemorarlo e rimpiangerlo. Fu accompagnata da più di duemila persone nella chiesa Sant'Eugenio, sul Tevere, dove si svolse la cerimonia funebre. Tra le personalità dello spettacolo presenti, all'interno della chiesa si notarono Alberto Sordi, Elsa Martinelli, Olga Villi, Luigi Zampa e Luciano Salce; parteciparono anche i registi che lo avevano sempre ignorato, e i critici che lo avevano avversato e considerato un artista inconsistente e volgare. Sulla sua bara furono poggiati la famosa bombetta con cui aveva esordito e un garofano rosso, la cerimonia si limitò a una semplice benedizione a causa delle difficoltà create dalle autorità religiose, perché con Franca Faldini l'attore non era sposato, addirittura fu fatta uscire di casa mentre il prete benediceva la salma di Totò.
Il secondo si svolse a Napoli, la sua città natale alla quale era particolarmente legato e la sua gioia più grande sarebbe stata proprio ritornare lì, così fu: Il 17 aprile di pomeriggio il feretro partì verso la città, scortato da circa trenta vetture. La città sospese dalle 16 alle 18,30 ogni attività, fu interrotto il traffico, i muri delle strade furono riempiti di manifesti di cordoglio, le serrande dei negozi vennero abbassate e socchiusi i portoni degli edifici in segno di lutto. Tra gli altri personaggi dello spettacolo ed amici stretti, ad attendere il feretro, c'erano i fratelli Nino e Carlo Taranto, Ugo D'Alessio, Luisa Conte, Dolores Palumbo. A causa della grande affluenza, il furgone che trasportava la salma impiegò due ore per raggiungere la chiesa di Sant'Eligio, dove si svolsero i funerali di fronte alla folla traboccante, valutata in circa 250 000 persone, tra bandiere, stendardi e corone.
L'orazione funebre venne tenuta da Nino Taranto: «Amico mio, questo non è un monologo, ma un dialogo perché sono certo che mi senti e mi rispondi, la tua voce è nel mio cuore, nel cuore di questa Napoli, che è venuta a salutarti, a dirti grazie perché l'hai onorata. Perché non l'hai dimenticata mai, perché sei riuscito dal palcoscenico della tua vita a scrollarle di dosso quella cappa di malinconia che l'avvolge. Tu amico hai fatto sorridere la tua città, sei stato grande, le hai dato la gioia, la felicità, l'allegria di un'ora, di un giorno, tutte cose di cui Napoli ha tanto bisogno. I tuoi napoletani, il tuo pubblico è qui, ha voluto che il suo Totò facesse a Napoli l'ultimo "esaurito" della sua carriera, e tu, tu maestro del buonumore questa volta ci stai facendo piangere tutti. Addio Totò, addio amico mio, Napoli, questa tua Napoli affranta dal dolore vuole farti sapere che sei stato uno dei suoi figli migliori, e che non ti scorderà mai, addio amico mio, addio Totò.»
Dopo il rito funebre, le autorità furono costrette a far uscire la salma da una porta secondaria, all'interno della basilica si susseguirono scene di panico e anche svenimenti; ci furono quattro feriti, due donne e due agenti, in seguito all'enorme scompiglio causato. Il corpo di Totò venne così scortato da motociclisti della polizia al Cimitero del Pianto, ove ad attendere c'erano Franca Faldini, la figlia Liliana con il marito, Eduardo Clemente e Mario Castellani, che per via della straripante folla decisero di non assistere alla funzione religiosa e raggiunsero direttamente in auto il cimitero. Totò fu sepolto nella tomba di famiglia accanto ai genitori, al piccolo Massenzio e all'amata Liliana Castagnola.
Il terzo funerale lo volle organizzare un capoguappo del Rione Sanità, nel suo quartiere, che si tenne il 22 maggio, cioè pochi giorni dopo il trigesimo; ad esso aderì un numero altrettanto vasto di persone, nonostante la bara dell'attore fosse ovviamente vuota. Eduardo De Filippo, con un partecipato articolo, lo ricordò dalle pagine del quotidiano Paese Sera nel giorno della sua scomparsa.
«Non è una cosa facile fare il comico, è la cosa più difficile che esiste, il drammatico è più facile, il comico no; difatti nel mondo gli attori comici si contano sulle dita, mentre di attori drammatici ce ne sono un'infinità. Molta gente sottovaluta il film comico, ma è più difficile far ridere che far piangere.»
Secondo un sondaggio del 2009, condotto dal giornale online quinews.it con mille intervistati equamente distribuiti per fasce d'età, sesso e collocazione geografica (Nord, Centro, Sud e Isole), Totò risultava essere il comico italiano più conosciuto ed amato, seguìto rispettivamente da Alberto Sordi e Massimo Troisi. I suoi film, visti all'epoca da oltre 270 milioni di spettatori (un primato nella storia del cinema italiano), molti dei quali rimasti attuali per satira e ironia, sono stati raccolti in collane di VHS e DVD in svariate occasioni e vengono ancora oggi costantemente trasmessi dalla tv italiana, riscuotendo successo anche tra il pubblico più giovane. Inoltre talune sue celebri battute, espressioni-mimiche e gag sono divenute perifrasi entrate nel linguaggio comune.
Umberto Eco ha espresso così l'importanza di Totò nella cultura italiana: «In questo universo globalizzato in cui pare che ormai tutti vedano gli stessi film e mangino lo stesso cibo, esistono ancora fratture abissali e incolmabili tra cultura e cultura. Come faranno mai a intendersi due popoli [cioè cinesi e italiani] di cui uno ignora Totò?»
Liliana De Curtis, la figlia del comico, è tuttora attiva per mantenere vivo il ricordo del padre. Molti italiani, ancor oggi, si rivolgono a Totò inviando lettere e biglietti alla sua tomba, per confidarsi, chiedere favori e addirittura grazie, come fosse un santo. La notorietà di cui Totò gode in Italia è andata anche oltre i confini nazionali: ad esempio in America, dove il comico Jim Belushi lo ha definito un «clown meraviglioso». L'attore George Clooney, intervistato in Italia in occasione del remake de I soliti ignoti, Welcome to Collinwood (2002), in cui lui interpretava il corrispettivo ruolo di Totò, ha altresì dichiarato: «Era un vero poeta popolare, un fantasista espertissimo nell'arte di arrangiarsi e di arrangiare ogni gesto ed espressione» precisando inoltre che, secondo il suo parere, tutti i comici più celebri come Jerry Lewis, Woody Allen o Jim Carrey devono qualcosa all'attore italiano. «Non era certo solo un comico, proprio come Buster Keaton. I suoi film potrebbero essere anche muti: riesce sempre a trasmettere il senso della storia. Grazie ai vostri sceneggiatori e alla sua mimica, dai suoi film traspare un personaggio a tutto tondo: astuto, ingenuo e anche vessato dalle circostanze della vita. Per questo continuerà a essere imitato, senza speranza di eguagliarlo. C'è sempre suspense nella sua recitazione: si aspetta una sua nuova battuta, una strizzatina d'occhi, ma resta imprevedibile il suo modo di sviluppare una storia.»
«Tengo molto al mio titolo nobiliare perché è una cosa che appartiene soltanto a me... A pensarci bene il mio vero titolo nobiliare è Totò. Con l'altezza Imperiale non ci ho fatto nemmeno un uovo al tegamino. Mentre con Totò ci mangio dall'età di vent'anni. Mi spiego?» Dopo l'adozione nel 1933 da parte del marchese Francesco Maria Gagliardi Focas, cavaliere del Sacro Romano Impero (D. M. di riconoscimento 6 maggio 1941), Totò intraprese lunghe e costose battaglie legali, portate avanti con determinazione, per il riconoscimento di nobiltà, anche grazie all'aiuto di esperti avvocati e araldisti. Totò riteneva di appartenere a un ramo decaduto dei nobili de Curtis, quello dei conti di Ferrazzano, sebbene tale discendenza non sia mai stata dimostrata. Il 18 luglio 1945 e il 7 agosto 1946 il Tribunale di Napoli, IV sez., emanò sentenze che gli riconobbero diversi titoli gentilizi, che vennero registrati a pag. 42 vol. 28 del Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, tenuto presso l'archivio della Consulta Araldica (Roma, Archivio Centrale dello Stato): Principe, Conte Palatino, Nobile, trattamento di Altezza Imperiale. Con sentenza 1º marzo 1950 del Tribunale civile di Napoli, il cognome di Totò venne rettificato in "Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio", anche se sul pronao della cappella della sua tomba, nel Cimitero di Santa Maria del Pianto a Napoli, l'incisione recita solo Focas Flavio Comneno De Curtis di Bisanzio - Clemente. Di fatto, dalla sentenza del 1946, Totò acquisì i titoli e i nomi di: Antonio Griffo Focas Flavio Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, altezza imperiale, conte palatino, cavaliere del Sacro Romano Impero, esarca di Ravenna, duca di Macedonia e di Illiria, principe di Costantinopoli, di Cilicia, di Tessaglia, di Ponte di Moldavia, di Dardania, del Peloponneso, conte di Cipro e di Epiro, conte e duca di Drivasto e Durazzo. In seguito al riconoscimento nobiliare, Totò fece coniare delle medaglie d'oro dal peso di 50 grammi l'una ritraenti il suo profilo, come fosse un imperatore romano, e che amava regalare ai suoi amici più intimi. Sembra che ben cinque denunce siano state sporte contro l'attore (anche da privati cittadini) per "abuso di titoli nobiliari".
Immortale Totò, principe della risata e imperatore solitario. Morì 50 anni fa, ebbe 3 funerali, vita furibonda e grandi amori, scrive Giorgio Gosetti il 15 aprile 2017 su l' "Ansa". Cosa si può dire ancora di Totò, per gli amici Antonio De Curtis ma per l'anagrafe Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio, scomparso il 15 aprile di 50 anni fa nella sua casa romana di Viale Parioli a soli 69 anni di una vita furibonda e frenetica? Tanto fu applaudito ed esecrato in vita, specie dalla critica, tanto suscitò passioni ed amori nel pubblico e nelle donne, tanto fu un'anima solitaria come solo i grandi comici sanno essere e tanto visse sempre nell'angoscia di non essere ricordato se non per la sua maschera farsesca. Dopo una consacrazione postuma che lo ha innalzato ai vertici della popolarità e dell'arte, dopo le mille e mille righe a lui dedicate da studiosi (Umberto Eco) e artisti (Pasolini scrisse che la "sua maschera riuniva perfettamente l'assurdità e il clownesco con l'immensamente umano") cosa resta da dire?
Figlio illegittimo del Barone Giuseppe De Curtis e di Anna Clemente, Antonio "N.N." Clemente detto Totò nasce il 15 febbraio 1898 nel cuore della "guapperia" napoletana al Rione Sanità in quella casa modesta che oggi sarebbe il suo museo ed è invece lasciata nell'incuria a rischio di crollo. Malinconico e solitario, poco versato per gli studi e complessato per il suo stato di "figlio di nessuno" (il padre lo riconobbe dopo i 20 anni), Totò si rifugia fin da bambino dietro la maschera del comico e dell'istrione, le sole armi con cui si fa amare da compagni e grandi. Esordisce sui palcoscenici periferici di Napoli già nel 1913, ma è solo dopo la Grande Guerra (sotto le armi ma lontano dal fronte) che abbraccia il suo destino sul palcoscenico della Sala Napoli scritturato da Eduardo D'Acierno.
Il padre riunisce la famiglia a Roma e qui Totò, nella totale disapprovazione dei genitori, comincia la sua vera gavetta da "straordinario" di compagnia, aggregato a diverse formazioni, spesso lasciato senza lavoro e senza soldi, solo a fatica in grado di farsi largo nel mondo della commedia dell'arte e dell'avanspettacolo. Il fortuito incontro con Giuseppe Iovinelli, l'impresario dell'Ambra Iovinelli di Roma e l'inaspettato successo delle sue macchiette ne fanno rapidamente un divo della scena comica. Non scorderà mai però la fatica degli esordi: "La miseria - diceva - è il copione della vera comicità... Non si può essere un vero attore comico senza aver fatto la guerra con la vita". Simile in questo a Charlot, che spesso additò a modello, desolato come Buster Keaton a cui fin troppo spesso veniva accostato per la gestualità straniata, Totò fu però soprattutto un formidabile autodidatta, capace di cogliere nei tic della gente comune i tratti che poi elevava a gesti comici (da bambino lo chiamavano 'o spione per la sua attenzione al lato buffo degli altri), anarchico nel lavoro quanto meticoloso nella costruzione di sé e delle sue maschere. Nel pantheon dei grandi interpreti "del corpo" assomma i tratti di Eduardo e Tati, Chaplin e Keaton, ma non viene mai meno a una originalità senza limiti che, lo faceva applaudire anche dagli stranieri (dalla Svizzera alla Spagna), mentre solo la pigrizia e la timidezza provinciale gli preclusero i palcoscenici più grandi, compreso quello americano dove venne invano invitato. La sua eredità non viene ben descritta dai numeri, comunque impressionanti: 97 lungometraggi interpretati a passo di carica dopo l'esordio nel 1937 con "Fermo con le mani", voluto da Goffredo Lombardo che cercava volti nuovi per il cinema; oltre 50 spettacoli tra commedia, rivista, avaspettacolo nell'arco di tempo che va dal 1928 al 1957 quando l'aggravarsi di una acuta malattia agli occhi lo rese praticamente cieco. In parallelo ci sono poi le prove da cantante (con un successo speciale per "Malafemmena"), le apparizioni televisive (memorabile "Studio Uno" con Mina), le poesie (la raccolta di "A' livella"), i fumetti, le pubblicità, le apparizioni a sorpresa. Ma il cuore di un successo che ancora oggi lo fa primeggiare su ogni altro protagonista della scena italiana (a grande distanza da Alberto Sordi e Massimo Troisi) viene da una genialità interpretativa che sempre lo fece autore di se stesso, in una dimensione sospesa tra osservazione del reale e astrazione surrealista, satira e farsa, intuizione verbale (celeberrimi i modi dire che sono entrati nel lessico comune) e costruzione fisica (la maschera-automa, il guitto e il poeta, il pulcinella e il nobile).
Benché abbia avuto al cinema pigmalioni come Cesare Zavattini e De Sica, poi grandi sodali come Carlo Ludovico Bragaglia, Steno e Monicelli o perfetti complici del suo genio (da Corbucci a Mattoli a Mastrocinque), solo a fine carriera ebbe l'onore dei maggiori autori italiani: lo voleva Fellini per mai realizzato "Viaggio di G. Mastorna", lo scelse Pasolini (da "Uccellacci e uccellini" a "Che cosa sono le nuvole"), lo chiamarono Risi, Bolognini, Lattuada. Eppure nell'immaginario popolare vive soprattutto per i film interamente modellati su di lui, da "Miseria e nobiltà" a " Totò le mokò", da "I pompieri di Viggiù" a "47 morto che parla" fino ai vari episodi di " Totò e Peppino" in coppia con l'amico De Filippo. Fece scalpore anche nella vita privata, segnata da grandi passioni e dolori: dal suicidio della prima moglie, la sciantosa Liliana Castagnola, fino alla tormentata e appassionata storia con Franca Faldini. Si fece adottare, nel 1933, dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas, in rincorsa a quel prestigio aristocratico che gli sembrava riscattare le sue origini; si sentiva davvero erede del sacro romano impero e della corona di Costantinopoli, anche se le battaglie legali gli fruttarono spesso denunce e delusioni. Come in una pièce di Pirandello ebbe l'onore di 3 funerali: il primo a Roma, vegliato per due giorni dai più grandi di cinema e teatro; il secondo a Napoli in un bagno di folla con 250.000 anime straziate dietro al feretro; il terzo nel cuore di Spaccanapoli dove un guappo locale organizzò la cerimonia intorno a una bara vuota. Ma a quel punto la sua arte volava ormai da giorni nel firmamento dei geni.
Totò, 50 anni senza il Principe della risata: 5 film da vedere su YouTube. Antonio De Curtis moriva il 15 aprile del 1967, scrive il 14 aprile 2017 su Panorama. "Sono un osso duro, io! Sono tutt'ossa!", diceva Totò alias Felice Sciosciammocca nel film Un turco napoletano. Antonio De Curtis, in arte Totò, era infatti tutto nervi e ossa, viso scavato e un'espressività prepotente e trascinante. Un osso duro della risata. Morto il 15 aprile 1967 a 69 anni, attore, cantante, poeta e tanto altro, Totò è stato il "Principe della Risata" ma anche drammaturgo dal fulgente animo tragico. Coi suoi lazzi, i doppi sensi e la mimica incalzante conquistava. Ma sapeva anche far increspare il cuore. Nel cinquantesimo anniversario della sua morte, Napoli festeggia la sua icona con la mostra Totò Genio, un grande mosaico che rappresenta l'arte di De Curtis in tre luoghi diversi (fino al 9 luglio): il Museo Civico di Castel Nuovo (Maschio Angioino), Palazzo Reale e il Convento di San Domenico Maggiore.
Per rivederlo nella sua verve irresistibile, ecco cinque film da vedere completi su YouTube.
1) Totò, Peppino e la... malafemmina (1956) di Camillo Mastrocinque. Totò in grande forma in questa commedia, accanto a Peppino De Filippo. Indimenticabile la scena cult della lettera dettata da Totò e scritta da Peppino, ripresa da Roberto Benigni e Massimo Troisi in Non ci resta che piangere.
2) Uccellacci e uccellini (1966) di Pier Paolo Pasolini. Anche film d'autore per Totò, che accettò il ruolo pur con qualche riserva sul suo personaggio proprio per ascrivere il suo nome ai film di qualità. Un grande intellettuale come Pasolini "sdogana" il Principe della Risata facendogli conseguire una menzione speciale al Festival di Cannes. Per l'attore è il suo ultimo film da protagonista.
3) I due marescialli (1961) di Sergio Corbucci. Commedia all'italiana che unisce Totò e Vittoria De Sica nell'Italia in guerra del 1943. Il primo è un ladruncolo, vestito da prete, l'altro un maresciallo, che si scambiano vestiti e ruoli.
4) Miseria e nobiltà (1954) Mario Mattoli. La celebre scena di Totò che mangia gli spaghetti con le mani appartiene a questa commedia. Il comico napoletano ancora una volta Felice Sciosciammocca, il personaggio immaginario del teatro partenopeo creato da Eduardo Scarpetta. Nel cast anche Sophia Loren e Valeria Moriconi.
5) Totò contro Maciste (1962) di Fernando Cerchio. Parodia dei film peplum, fa parte di una serie di rivisitazioni mitologiche in chiave comica di cui Totò fu protagonista.
Qualunquista, anarchico, gotico: a ognuno il suo Totò. All'epoca i critici non amavano i suoi film. Apprezzati invece da certi scrittori, da Zavattini a Soldati. La rivalutazione ripartì in pieno post-68, con un volume di Goffredo Fofi. Che rende merito al più grande comico italiano di cui il cinema abbia lasciato testimonianza, scrive Emiliano Morreale il 14 aprile 2017 su "L'Espresso". Totò fa ormai parte dell’arredamento domestico degli italiani: le sue foto nei ristoranti del centro Sud, la sua immagine nei canali televisivi a riempire le fasce orarie più bisognose. Eppure a rivedere e ristudiare i suoi film possono arrivare sorprese: basti pensare ai volumi che gli ha dedicato, alcuni anni fa, Alberto Anile, ritrovando un Totò inedito, alle prese con la cultura del suo tempo, con la politica, con la censura. I critici, si è detto, all’epoca non amavano i suoi film. Che erano spesso modesti, ma non sempre: non solo quelli di Steno e Monicelli, che lo declinavano in versione più “neorealista” (“Guardie e ladri”, “Totò cerca casa”), ma anche certi che più direttamente assecondavano il suo genuino versante farsesco: Mattoli, Corbucci, Mastrocinque. In compenso, Totò era amato da certi scrittori: quelli di derivazione futurista o surreale, che in lui vedevano la marionetta umana (il giovane Zavattini, Campanile, Palazzeschi), ma anche acuti osservatori come Soldati o Flaiano. I fortunati, all’epoca, dicevano che il vero Totò era quello teatrale, che dal vivo potevano apprezzarsi al meglio le sue qualità. Probabilmente è vero; forse per questo uno dei suoi film più memorabili è “Totò a colori” (1952), centone di suoi numeri di varietà, lievitati e portati a perfezione da anni di improvvisazioni. E non a caso hanno avuto fortuna negli anni varie antologie dei “numeri” più famosi, che sono in fondo una forma legittima di mostrare i suoi film. Cerimonia al cimitero di Poggioreale dove il sindaco ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Totò. Presente anche Elena de Curtis, nipote dell'artista, che ha detto: "E' qui con noi, si starà facendo una marea di risate". "Sono davvero entusiasta per la qualità delle iniziative, la partecipazione, la grande emotività" ha aggiunto de Magistris accompagnato dall'assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, dal presidente della II Municipalità, Ivo Poggiani, dal Comandante della Polizia Municipale, Ciro Esposito, dal Questore di Napoli, Antonio De Iesu."Sono passati 50 anni ma Totò è qui, nella città, tra i napoletani", conclude de Magistris.
La sua rivalutazione ripartì in pieno post-’68, con un volume di Goffredo Fofi. Ma alla fine della carriera c’era stato, come è noto, l’incontro con Pasolini. Il quale, forse più ancora che in “Uccellacci e uccellini”, fece risplendere il suo genio negli episodi a colori, “La terra vista dalla luna” e “Che cosa sono le nuvole” (in cui, Iago tinto di verde, recita una delle morti più strazianti viste al cinema, depositato in una discarica da Domenico Modugno). Rimane infine il rimpianto di non averlo potuto vedere nei panni di San Giuseppe da Copertino, il “santo cretino” che volava, in “C’era una volta” di Francesco Rosi (il produttore Ponti bocciò l’idea). Ognuno, ovviamente, ha il suo Totò preferito. Personalmente, mi piace ricordare il versante nero, gotico, di “Totò Diabolicus” o “Che fine ha fatto Totò Baby?”. Del resto, Mario Monicelli sosteneva che Totò gli faceva un po’ paura: la sua faccia era un teschio, come la maschera di Pulcinella; anche la critica americana Pauline Kael scriveva dei «suoi occhi stanchi, che hanno visto tutto». Un aspetto colto magnificamente da Alberto Lattuada, che nella “Mandragola” (1965) lo fa monologare nelle catacombe. "Ma mi faccia il piacere", "Cà nisciuno è fesso". I napoletani parlano con le battute di Totò, usate quasi senza accorgersene nel quotidiano per descrivere una situazione o una persona.
Qualunquista e anarcoide, aristocratico e plebeo distruttore delle convenzioni, Totò è senza dubbio il più grande comico italiano di cui il cinema abbia lasciato testimonianza, ed è l’ultimo “comico primario” di un’Italia povera, mosso dal bisogno di cibo e di sesso. È forse difficile, per chi è nato dopo la sua morte, cinquant’anni fa, inserirlo nel mondo da cui proveniva, forse perfino capirlo. Mi viene quasi il timore, per un attimo, che un giovane oggi possa apprezzare Totò, ma non ridere davvero con lui.
Totò, 50 anni dopo i critici continuano a stroncarlo: “Il suo è stato brutto cinema con brutti film”. "All’interno di questi film che sono oggettivamente brutti, esclusi pochi costruiti con più abilità, ci sono pero dei momenti, parlo di cinque minuti, dove Totò dimostra la sua genialità”, spiega al FQMagazine Paolo Mereghetti. "Lui ha sofferto tantissimo il fatto che non gli offrissero film di alta qualità, ma quando li ha fatti è stato molto bravo perché ad esempio con Pasolini, che lo ha persino fatto diventare buono", afferma Roberto Escobar, critico del Sole 24Ore, scrive Davide Turrini il 13 aprile 2017 su “Il Fatto Quotidiano. “Totò genio artistico senza pari, ma i film che interpretava erano (e rimangono) brutti”. Il rapporto non riconciliato tra la critica cinematografica e i quasi cento film del “principe della risata” – di cui il 15 aprile 2017 ricorrono i 50 anni dalla morte – continua. E senza troppe novità. Nell’infinita giaculatoria di mea culpa, dove tutti hanno rivalutato il comico, la maschera, l’uomo De Curtis, ecco che per titoli come Totò sexy, Totò e i re di Roma, 47 morto che parla, Totò Vittorio e la dottoressa, alcune opere a caso su almeno tre quarti dei titoli da lui interpretati, stellette, pallini, voti in pagella, schede di rivalutazione non sono mai riapparse, anzi. “Alcuni film di Totò sono francamente brutti, fatti in fretta, talvolta ne girava sei all’anno come un matto. E all’interno di questi film che sono oggettivamente brutti, esclusi pochi costruiti con più abilità, ci sono pero dei momenti, parlo di cinque minuti, dove Totò dimostra la sua genialità”, spiega al FQMagazine Paolo Mereghetti, critico cinematografico del Corriere della sera ma soprattutto autore del Dizionario dei film (Baldini&Castoldi) dove appena una ventina di titoli su novantasette interpretati dal comico napoletano raggiungono la sufficienza (Totò, Peppino e la malafemmina e Totò a colori sono gli unici con 4 stellette ndr). “E’ lo stesso discorso che si può fare per Gary Cooper e Humphrey Bogart: non tutti i film con Bogie sono capolavori, ma lui era un grande attore anche nei film brutti. Non c’è nulla di che stupirsi, sul dizionario si cerca di giudicare un film nella sua complessità e i risultati sono questi. Ultimamente c’è stata una specie di vulgata critica che per una battuta comica di livello si è messa a salvare l’intero film. Parlo in generale di commedie italiane squinternate. Chiaro, si può ridere a una battuta di Franchi e Ingrassia anche se i loro film venivano fatti oggettivamente coi piedi. Identico discorso che si può applicare ai lavori interpretati da Totò”. “Insisto: come cinema in senso stretto quello fatto da Totò è stato un brutto cinema”, spiega Roberto Escobar, critico del Sole 24Ore e autore di una ricca monografia su Antonio De Curtis (Totò – Il Mulino). “E dirò di più. È un paradosso, ma i più bei film interpretati da Totò in realtà tradiscono Totò. Lui ha sofferto tantissimo il fatto che non gli offrissero film di alta qualità, ma quando li ha fatti è stato molto bravo perché ad esempio con Pasolini, che lo ha persino fatto diventare buono, non era più e solo una maschera, ma un grande attore”. “E comunque lo scrivo da sempre: per fortuna i film che ha interpretato sono brutti, perché Totò è più dei suoi film” – continua Escobar, “Come diceva Goffredo Fofi: il film ideale di Totò è un’antologia, non un superfilm con montate le parti migliori delle sue decine di film, ma la persistenza nella memoria di un continuum di immagini e emozioni. Quando i miei colleghi critici di un tempo, come Guido Aristarco, lo stroncavano, potevano sì stroncare i film ma non si rendevano conto di avere di fronte agli occhi un diamante”. “Pensare che le intenzioni fossero quelle di girare dei grandi film, equivarrebbe a dare ai produttori dell’epoca intenzioni che non hanno avuto. Totò, il più grande comico italiano veniva utilizzato soltanto per fare soldi al botteghino e veniva usato bene solo in rari casi, cito L’oro di Napoli o Uccellacci e uccellini”, afferma Alberto Anile, autore del libro fresco di stampa Totalmente Totò. Vita e opere di un comico assoluto (edizioni Cineteca di Bologna). “Totò non ha potuto essere come Chaplin, autore totale dei suoi film dalla recitazione alla musica, è stato autore e regista dei suoi spettacoli. Copioni, personaggi sketch interi, non solo battute, che poi portò nei film interpretati. Infine, come racconto nel libro grazie alle dichiarazioni di Vincenzo Talarico e Franca Faldini, negli anni sessanta, quando Totò era già stanco e disilluso del mondo del cinema, sbucò un testo per un film muto da lui scritto che Ponti e De Laurentiis bocciarono. Avrebbe potuto portare al cinema storie scritte e ideate da lui, ma non avvenne per via dell’insipienza dei produttori”.
Totò, un mito con Napoli sempre nel cuore, scrive Franco Insardà i 16 Aprile 2017 su "Il Dubbio". L’antropologo Marino Niola ci spiega il legame speciale tra Totò e Napoli: «Il mito è un alimento dell’immaginario in cui ci si riconosce subito». Napoli e Totò, un rapporto ancestrale, passionale, sincero che ha legato il Principe De Curtis alla città in modo indissolubile quando era in vita, fino a fargli dire «sto morendo, portatemi a Napoli» e oggi, a cinquant’anni dalla morte ne ha fatto un mito partenopeo come San Gennaro e Pulcinella. Il suo essere fisico e metafisico, in perenne bilico tra l’allegria e la tristezza ne hanno fatto un’icona nella quale si riconoscono tutti: il sottoproletario, l’aristocratico, il borghese. Marino Niola, professore di Antropologia dei simboli all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, collaboratore di Repubblica (ha una rubrica settimanale sul Venerdì), del Nouvel Observateur e di altre testate straniere, da studioso e da napoletano ha analizzato a fondo il rapporto tra Totò e i napoletani.
Professor Niola, ci spiega questo legame così profondo?
«Totò è stata una grande maschera di Napoli. Una maschera interclassista nella quale ognuno poteva e può riconoscersi. Ciascuno ci trova una parte di se, e spesso è quella parte che non quadra troppo. Il suo personaggio era sghembo come il suo corpo. La sua faccia era un “qui pro quo”, esattamente come il suo “qui pro quo” linguistico. Questo spiega la facile riconoscibilità per cui ciascuno trova qualcosa che lo riconduce al proprio intimo e in cui si identifica. Anche questo è tipico di Napoli, perché è una città di “qui pro quo”, di segni a forte definizione in cui ci si riconosce subito, ma che è difficile conoscere».
Quanto ha dato Napoli a Totò e quanto Totò a Napoli?
«La città gli ha dato sicuramente l’humus culturale, umano, affettivo, sentimentale da cui poi nasce la sua comicità. E lui ha restituito alla città sempre, in un modo o nell’altro, nei suoi film, nelle sue poesie, nelle canzoni questo affetto per Napoli. C’era un feedback continuo. Nel suo rapporto con Napoli non c’era quella rabbia di Eduardo che lo rendeva antipatico a molti napoletani. Parliamo di due icone, ma tra loro c’è questa enorme differenza: Eduardo era più una icona borghese, mentre Totò era interclassista. Totò non voleva insegnare niente a nessuno, Eduardo dava continue lezioni».
La folla immensa di piazza del Carmine per l’ultimo saluto a Totò in questi cinquant’anni è aumentata ed è un amore che si alimenta quotidianamente.
«Perché di Totò, come per tutte le grandi icone dello spettacolo moderno, è rimasto il suo corpo immateriale. I suoi film passano continuamente in tantissime tv in tutt’Italia. Questo fa sì che anche le persone giovani, le quali quando Totò è morto non erano neanche in mente dei, ricordino le sue battute. Senza contare il merito incredibile di essere riuscito a rendere famoso nel mondo un posto, che altrimenti sarebbe rimasto sconosciuto ai più, come Cuneo».
L’arte di arrangiarsi, spesso geniale, è una delle caratteristiche dei personaggi di Totò che ritroviamo da sempre a Napoli.
«Anche in questo c’è un rispecchiamento: Totò nasce povero e si arrangia continuamente nella vita e nei suoi film torna questo personaggio che non ha mai dimenticato la fame. Tante è vero che l’elemento dell’indigenza è presente in molte scene, nelle quali sogna in modo semplice, da persona del popolo, un alimento per nulla sofisticato: lo sfilatino. L’aspetto, quindi, dell’arrangiarsi, del sotterfugio, del piccolo imbroglio è presente, ma i suoi personaggi non sono mai delle carogne. Utilizza degli espedienti perché gli servono per sopravvivere, per pagare la scuola alla figlia ad esempio. Si tratta di motivi nobili che ne fanno un povero cristo, mai il delinquente. Ha rappresentato in pieno il tipo umano che usciva dalla guerra: povero, pieno di voglia di vita, irriverente e disincantato quanto basta, che dava alle cose il giusto valore. E infatti da questo atteggiamento ne deriva una continua lezione di saggezza».
Totò e il cibo è un altro dei connubi della sua maschera. La scena degli spaghetti di Miseria e nobiltà è diventata un’icona di moltissime trattorie in ogni parte del mondo. Come lo spiega?
«È la fame atavica del popolo. Totò diventa il paradigma, il simbolo del rapporto tra il popolo e la fame. E il cibo è proprio questo e lui è una grande maschera, proprio come Pulcinella che tradizionalmente non fa altro che sognare montagne di maccheroni. Consideriamo anche che molti dei film sono stati girati tra la fine della guerra e il ’ 57-’ 58, anni decisivi in cui l’Italia comincia a voltare pagina, si lascia alle spalle la fame ed entra nel miracolo economico, ma il ricordo della fame è ben presente».
Pulcinella, Totò, Troisi, Maradona, Pino Daniele: perché Napoli ha bisogno di avere delle figure di riferimento, direi quasi dei miti?
«Intanto direi che tutti avrebbero bisogno di queste figure, ma non lo sanno, Napoli è una città che non ha dimenticato come il mito sia un alimento dell’immaginario che aiuta a ricostruire continuamente l’identità. Basti pensare che i napoletani si chiamano ancora con il nome della fondatrice mitica: la sirena Partenope. Il che vuol dire che il mito è nel cuore e negli occhi e queste figure rappresentano la collettività. Dopo la sirena Partenope è arrivato San Gennaro, poi Masaniello, fino a Maradona che incarnava l’uno e l’altro: un po’ Masaniello e un po’ San Gennaro, un difensore della città e un simbolo della Napoli che vince e che può fare miracoli. Non a caso nel film “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo il poeta paragona una finta di Maradona allo scioglimento del sangue di San Gennaro».
L’arte di Totò è paragonabile a quella di Chaplin, Groucho Marx o è assoluta e inimitabile?
«Ciascuno di loro ha una cifra inimitabile, però ce li ricordiamo tutti. Sul piano dell’arte Totò è grande quanto gli altri e se avesse avuto alle spalle lo star system americano si parlerebbe di lui allo stesso livello di Chaplin, di Buster Keaton e degli altri grandi comici Usa. Il fatto che sia partito da una cinematografia come quella italiana, soprattutto da una cinematografia minore, e sia arrivato a essere il simbolo vuol dire che parliamo di un campione assoluto».
Come mai il suo linguaggio, i suoi modi di dire sono entrati nel parlare comune e spesso risolvono con una battuta imbarazzi, sentimenti e stati d’animo?
«Totò non chiedeva troppo per essere capito, la sua battuta faceva capire che lui ti aveva capito, c’era una perfetta sintonia. Ci si può calare in quella battuta come in un vestito che veste alla perfezione e diventa della persona, interpretandone il sentimento. Non a caso alcune battute come “siamo uomini o caporali”, “ma mi faccia il piacere”, “ogni limite ha una pazienza” sono diventati modi di dire comuni della lingua italiana».
Il titolo del suo ultimo libro Il presente in poche parole rimanda a un modo di dire alla Totò… “Ho detto tutto”, ripetuto ossessivamente con Peppino De Filippo in Totò, Peppino e la malafemmina…Lei, nei suoi libri, analizza la credulità popolari, le manie, le perversioni legate al cibo e alla cucina: sarebbe stata un’occasione ghiottissima per la comicità di Totò?
«Assolutamente sì. Sulle diete, ad esempio, cominciava già a giocarci. Faceva spesso battute sulla linea, sul dimagrimento. Anche se lui esalta sempre la donna in carne, la maggiorata, la donna che a Napoli si chiama “ciaciona”, come nel film “Signori si nasce” quando bacia il seno di una procace e giovane Angela Luce, o quando chiede a Sophia Loren in “Miseria e nobiltà” di essere accolto nel suo seno. In lui persino le donne sono quasi da mangiare. Anche in questo è come Pulcinella: il cibo e il sesso sono due facce dello stesso desiderio».
Totò e le donne: un altro rapporto molto stretto.
«Strettissimo. La sua vita è punteggiata da donne decisive. E Napoli è assolutamente donna».
I personaggi di Totò sono spesso irriverenti, non politically correct, forse è per questo che arrivano alla gente. Affronta anche temi scomodi: le case chiuse, il regime nazifascista, la morte e interpreta ancora una volta il sentimento popolare e risolve con uno sberleffo o una battuta che rimarrà per sempre nella mente. È questa la sua forza?
«Arrivano alla gente perché Totò in alcune cose non è stato costretto a censurarsi, mentre gli argomenti scomodi li ha affrontati con garbo. Quando non poteva affrontarli esplicitamente li risolveva, come in “Totò e i re di Roma”, con un “poi dice che uno si butta a sinistra…”. Si è salvato dall’onda del politicamente corretto e da questa forma di stupidità profonda che si annida nel politicamente corretto, risolvendo con uno sberleffo situazione pesanti e complicate. Dimostrando che non c’è bisogno di esasperare certe situazioni, ma che in certi momenti una battuta dà a tutti una via di uscita».
In occasione dei cinquant’anni della sua morte il mondo del cinema lo sta ricordando adeguatamente?
«Gli sta in parte restituendo, in ritardo, quello che gli ha tolto quando era vivo. Non dimentichiamo che molti dei lodatori attuali di Totò, come campione della comicità popolare, sono gli stessi che in quegli anni dicevano delle baggianate spaventose suoi sui film, figlie di una critica occhiuta e ideologica».
C’è qualche erede di Totò?
«No. No. No. Una sarebbe potuto essere Massimo Troisi che fondeva in se qualche aspetto di Totò e qualche altro di Eduardo. Più di Totò che di Eduardo, ma era un Totò generazionale che ne aveva quindi una parte. Oggi non vedo eredi».
“A proposito di politica, ci sarebbe qualche coserellina da mangiare?” Napoli celebra Totò al Rione Sanità, scrive Imma Pepino il 29/04/2017 su “I Siciliani”. “Mi scusi, mi sa dire dov’è che hanno messo la statua di Totò?”. “Signurì è facile, deve andare diritto. Non il primo cortile, il secondo”. Il secondo cortile è l’interno di un palazzo antico: il palazzo dello Spagnuolo, come recita la targa in legno sul corrimano della scala. La statua di Totò – realizzata da Giuseppe Desiato, in collaborazione con la Fondazione San Gennaro – non si trova qui però. L’indicazione che però mi è stata fornita dal pescivendolo all’ingresso del Borgo Vergini non è del tutto sbagliata, o meglio ha una sua logica: proprio a palazzo dello Spagnuolo dovrebbe essere realizzato il museo dedicato alla memoria di Antonio De Curtis – come deliberato nel 1996 dalla Giunta regionale. Il progetto, voluto anche dai cittadini del quartiere che diede i natali all’artista, è però fermo da vent’anni – come denunciato il 15 Aprile scorso, all’inaugurazione delle celebrazioni, dai rappresentanti della Terza municipalità (di cui il Rione Sanità fa parte) e in particolare da Francesco Ruotolo, consulente alla memoria della Municipalità stessa, che ha affisso in alcuni luoghi simbolo del rione dei manifesti di denuncia rivolti a sindaco e presidente della regione affinché “Totò non muoia una seconda volta”. Un signore di mezz’età, anche lui deluso visitatore del museo fantasma, si sofferma a descrivermi il degrado in cui versa anche la casa in cui nacque l’artista. Mi dirigo verso Piazza San Vincenzo, il cuore del quartiere. Dopo aver percorso qualche metro giungo in Largo Vita: qui campeggia il monolite raffigurante la sagoma di De Curtis. La statua è molto bella, moderna nelle forme. Si trova poco distante dal viale di ingresso dell’ospedale San Gennaro, chiuso dalla giunta regionale De Luca. Il presidente, contestato proprio in occasione dell’inaugurazione della statua, aveva avvalorato la sua decisione pronunciando un solenne e istituzionale: “Signo’ ma l’avete fatta la pastiera?”. Potrei percorrere Calata delle fontanelle e ritornare a Materdei, ma decido di dare un’occhiata anche alla casa di Totò. La strada per arrivare è lastricata di opere dedicate all’artista, come il busto posto all’angolo di Salita Capodimonte. Il vecchio appartamento, in Via Santa Maria Antesaecula, è stato acquistato da un privato e si trova in condizioni di totale abbandono. “La proprietaria ha levato pure gli infissi alle finestre, però se entrate ci sta ancora la finestra del suo bagno che si vede dal cortile” mi dice, invitandomi a entrare, un vicino dell’appartamento accanto a quello di Totò. Un pezzo di memoria storica privatizzato e sottratto alla collettività. Tra il museo fantasma di palazzo dello Spagnuolo e la casa saccheggiata. Un patrimonio che potrebbe portare al riscatto di questo quartiere, e che invece rimane incastrato da anni tra il disinteresse delle istituzioni e il marchio impresso dalla camorra. Il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Totò sarebbe una buona occasione per spostare l’attenzione dal centro città “vetrina” a un quartiere popolare in cui l’impegno delle istituzioni arriva solo quando c’è da fare una passerella o raccattare un applauso, un voto. Il Rione Sanità non può ripartire solo dall’illustre concittadino ma da tutti i cittadini, da tutte le pance, da tutte le coscienze. Perché è “la somma che fa il totale!”.
È morto Gianni Boncompagni, il rivoluzionario della tv italiana, scrive "la Repubblica il 16 aprile 2017. Il conduttore radiofonico, paroliere, autore televisivo e regista aveva 84 anni. In una carriera di oltre mezzo secolo, con i suoi programmi ha cambiato la faccia del piccolo schermo.È morto a Roma Gianni Boncompagni. Aveva 84 anni. Conduttore e autore radiofonico e televisivo, regista, nel corso di una carriera lunga circa mezzo secolo è stato l'ideatore di numerosi programmi che hanno segnato la storia della televisione italiana. Tra i grandi innovatori dello spettacolo insieme a Renzo Arbore, ha dato vita a show rivoluzionari come Alto gradimento, Bandiera gialla, Pronto, Raffaella?, Domenica In, Non è la Rai, Carramba. Boncompagni era nato ad Arezzo il 13 maggio del 1932. A dare la notizia della morte sono state le figlie Claudia, Paola e Barbara: "Dopo una lunga vita fortunata, circondato dalla famiglia e dagli amici se n'è andato papà, uomo dai molti talenti e padre indimenticabile". La camera ardente sarà allestita martedì 18 aprile a Roma, alle 12, nella sede Rai di via Asiago 10. "A tutti i maggiori degli anni 18, a tutti i maggiori degli anni 18, questo programma è rigorosamente riservato ai giovanissimi". Poi la sigla con la voce di Rocky Roberts. Boncompagni e Renzo Arbore aprono così Bandiera Gialla, è il 1965, la Rai è quella di Ettore Bernabei che solo quattro anni prima aveva fatto indossare i collant neri coprenti alle gemelle Kessler. Bandiera Gialla per primo, nella storia della radio italiana, porta una ventata beat, apre le porte a Patty Pravo, Lucio Battisti e alla swingin' London, all'umorismo e alla goliardia. La liturgia radiofonica va a gambe all'aria, i giovani scoprono di essere giovani e soprattutto scoprono che c'è spazio anche per loro, per divertirsi. Un trend che la coppia svilupperà e amplificherà con Alto gradimento (1970), fucina dell'improvvisazione e del sommo cazzeggio nonsense. "La nostra amicizia è nata quando avevamo all'incirca 25 anni - ricorda Arbore - un'amicizia non conclusa ora che eravamo più vicini agli Ottanta che ai Settanta, come diceva sempre lui con il suo straordinario spirito toscano. Per me è stata un'amicizia provvidenziale, spero lo sia stato anche per lui. Ci conoscemmo ai tempi di quando frequentavamo il corso di maestro programmatore, eravamo compagni di banco. Aveva una visione moderna della vita, un senso d'umorismo all'avanguardia. Una visione che lo ha portato a rivoluzionare la radio e la tv. Spero di essergli stato utile con il mio atteggiamento più riflessivo e romantico, ma altrettanto teso a rivoluzionare la radio e la tv". Nel 1977 Boncompagni debutta in tv con Discoring. Poi arriva Pronto, Raffaella? (1984), condotto da Raffaella Carrà, di cui è stato pigmalione e con la quale ha avuto una lunga relazione sentimentale. Tocca poi a Pronto, chi gioca? (1985) condotto da Enrica Bonaccorti e a tre edizioni di Domenica in. Nel 1991 il passaggio a Mediaset, con Primadonna condotto da Eva Robin's e soprattutto Non è la Rai, il programma che ha per protagoniste decine di ragazze adolescenti, alcune destinate ad continuare la carriera nella tv e nel cinema, come Claudia Gerini, Alessia Merz, Antonella Elia, Laura Freddi, Lucia Ocone, Romina Mondello, Sabrina Impacciatore e soprattutto la "primadonna" Ambra Angiolini che diventa l'idolo dei teenager. E che oggi lo ricorda con questo messaggio: "Se n'è andato il giorno di Pasqua ....è stato un genio anche nel salutarci. Grazie da una ragazzina normale che tu hai fatto in modo che crescesse con il coraggio di essere diversa da tutto, nel bene e nel male. Sei ovunque". Torna alla Rai, nel 1996-97 firma due edizioni di Macao (la prima con Alba Parietti, poi esclusa), la cui seconda edizione chiude per bassi ascolti. Ugualmente sfortunata l'esperienza di Crociera. Nel 2002 il rilancio con il Chiambretti c'è di Piero Chiambretti, tra informazione e varietà, poi tra il 2007 e il 2008 dirige e conduce Bombay su La7. Padre della tv leggera e imprevedibile, Boncompagni firma anche delle hit musicali: Ragazzo triste, portata in classifica da Patty Pravo e Il mondo, successo mondiale lanciato nel 1965 da Jimmy Fontana, nonché tutte le hit di Raffaella Carrà, da Tuca tuca a Tanti auguri e ancora A far l'amore comincia tu. "Bandiera gialla", ricordava, " segnò un cambiamento culturale. Abbiamo lanciato i Beatles contro i Rolling Stones, i complessi li abbiamo battezzati tutti. Approfittando della scarsa conoscenza dell'inglese mettevamo anche canzoni con doppi sensi, allora inconcepibili per la radio, tipo Got My Mojo Working di Jimmy Smith, che voleva dire 'porto il mio cosino a lavorare'". Ma poi, con un po' di malinconia, aggiungeva: "Oggi non s'inventa più niente. Gli stadi si riempiono con nomi orrendi, non ci sono mica i Beatles e loro, i giovani del cavolo, cantano canzoni senza senso. Quelli degli anni Sessanta erano spaventosi ma l'Italia era molto indietro. Quando dico che per certi cantanti ci vogliono gli arresti domiciliari così non fanno danni non deve ridere. Deve darmi retta". Interrogato, pochi anni fa, su quale fosse lo stato della tv, aveva detto: "Oggi guardo molto Sky, Maurizio Crozza su La7, History Channel o i film. Sulla Rai solo L'eredità, forse perché mi sento molto bravo nel dare le risposte. Ma la tv in generale verrà vista sempre meno, anzi nei prossimi dieci anni scadrà. A guardarla ormai sono solo donne anziane semianalfabete, quelle che votano Berlusconi. I ragazzi non sanno neanche cosa sia. La tv di oggi è Internet, con tutto quello che comporta. Sopravviverà per lo sport, che ci sarà sempre".
Non è la Rai, Gianni Boncompagni: "Detestavo Bonolis, lo sostituii con Ambra", scrive Lara Gusatto il 26 marzo 2015 su "Tvzap". Intervistato in occasione della prima puntata della serie tv 1992 l’autore e regista racconta i retroscena dello storico programma Mediaset. “Ricordo solo che da Mediaset all’inizio mi ammollarono Bonolis che aveva già il contratto, ma io lo detestavo allora come lo detesto oggi. Non gli feci fare niente e dopo un anno misi Ambra al posto suo”. A parlare e raccontare i retroscena dello storico programma Non è la Rai è il suo creatore Gianni Boncompagni dalle pagine de “Il fatto quotidiano”. Complice la serie tv Sky 1992 dove compaiono diverse scene dello show cult di Mediaset che all’epoca rappresentò un vero caso nella storia della televisione, il quotidiano ha intervistato il Deus ex machina di Non è la Rai, il suo primo programma realizzato per il Biscione. E Boncompagni oltre a esprimere il suo parere nei confronti di Paolo Bonolis, che condusse la seconda edizione dello show dopo Enrica Bonaccorti, racconta di come nacque il programma: “Berlusconi voleva farmi fare a tutti i costi Pronto Raffaella? e io gli dicevo che era impossibile perché era un programma basato sulle telefonate e Mediaset non aveva ancora la diretta”. E su Ambra e il famoso auricolare rivela “Tutti credevano che io suggerissi le battute, invece le dicevo delle cose tremende, irriferibili, e lei doveva fare finta di nulla”.
Boncompagni, il grado zero della tv. Era interamente e intimamente votato allo spettacolo e alla leggerezza, scrive su l'"Ansa" Massimo Sebastiani il 16 aprile 201719. Nel giorno in cui il mondo cristiano celebra la resurrezione di Cristo, Gianni Boncompagni è morto. Se si fosse trattato di un gesto volontario, potremmo pensare all’ennesimo sberleffo dissacrante di un uomo che detestava la vecchiaia, il dolore, la sofferenza ed era interamente e intimamente votato allo spettacolo e alla leggerezza. Aretino come il più celebre Pietro, e come lui maestro di satira e pasquinate fin dai tempi della radio - letteralmente decostruita con programmi come Bandiera Gialla e soprattutto Alto gradimento - Boncompagni, autore e regista più che conduttore, è stato un protagonista della tv molto lontano sia dal professionismo impeccabile dei ‘bravi presentatori’ come Mike, Baudo o Corrado, sia da una concezione ‘biologica’ della televisione come quella di Costanzo, in cui il corpo del conduttore è tutt’uno con lo schermo e il programma. Al contrario, secondo un’intuizione confermata anche dal discorso critico dei suoi detrattori più feroci, è sempre stato il vuoto il vero centro di gravità permanente della tv di Boncompagni. Un vuoto rivendicato dal teorico (involontario) della tv di puro intrattenimento, ripetitiva e insensata, realizzata, come certi B-movie poi diventati di culto, presto e male. Un vuoto attraverso il quale, a saper vedere, non sarebbe stato difficile scorgere il ‘pieno’ di una rivelazione sociologica sulla società ‘affluente’ (le file delle mamme a Cinecittà per promuovere la carriera delle figlie, l’esibizionismo, il gusto per l’azzardo e la ricchezza facile con i celeberrimi fagioli di Raffaella Carrà). L’unico, ancora fino ad oggi, a poter passare indifferentemente (per lui e per il broadcaster) da Mediaset alla Rai mantenendo quasi inalterati successo, caratteristiche e perfino flop. L’unico a poter fare una tv di successo senza star e senza format. Per chi crede nella società dello spettacolo, cioè per chi non trova alcuna accezione negativa nell’espressione coniata da Guy Debord per mettere in guardia dal trionfo dell’immagine sulla realtà nella società capitalistica, l’intrattenimento è uno solo e non c’è alcuna differenza tra tv commerciale e servizio pubblico. Non c’è dunque alcuna ragione per soffrire il passaggio da una all’altra. A chi lo ha etichettato come inventore del nulla dovrebbero tremare i polsi al pensiero dell’immane e vertiginosa opera creativa che in questo modo gli viene attribuita. D’altra parte, il successo definitivo dell’artigiano del vuoto sugli intellettuali più occhiuti e infastiditi viene certificato da Umberto Eco che, all’apice del proprio successo popolare, si scomoda per affrontare il ‘caso Ambra’, reginetta con auricolare delle giovani fanciulle in fiore di ‘Non è la Rai’, che da quel momento chiamerà il semiologo di Alessandria ‘collega’. E ad ospitarlo nuovamente in Rai, con un’altra versione di vuoto televisivo, ‘Macao’, sarà, ironia delle cose, proprio un intellettuale cresciuto alla scuola situazionista di Debord, l’allora direttore di Raidue Carlo Freccero, oggi membro del cda di viale Mazzini.
Non è la RAI, un programma-spazzatura forse irripetibile…, scrive il 24 aprile 2009 Luigi Ruffolo. Uno dei momenti più alzabandierofili e significativi partoriti dall’incontro tra la televisione padana e quella romana è stato sicuramente rappresentato da Non è la RAI. Col suo leggendario studio popolato da cento adolescenti anseriformi tutt’indaffarate a esporsi al pubblico ludibrio con i soliti pseudoballetti da osteria, o starnazzando giochi telefonici palesemente truccati e canzoni ultradeficienti. In sostanza, patetici pretesti per mostrare alle non ancora internettizzate genti un po’ di sana selvaggina, di quella barely legal, primo pelo vero o presunto. Ci sono state indubbiamente tante altre trasmissioni all’insegna del tettaculismo più indefesso in grado di scarcerare nell’aere kitsch, edonismo, tamarraggine e insignificanza in dosi altrettanto elefantesche. Ma forse nessuna è stata così sfacciatamente studiata e costruita attorno a un unico, primigenio elemento. Ovvero l’ego-pisello del suo triste demiurgo. Un omuncolo di mezza età-mezza calzetta che per fare lo sbruffone decide di esagerare vistosamente, arrivando là dove nessuno aveva osato. A infrangere con spigliatezza tabù secolari, mietendo nel silenzio assenso delle italiche abitazioni fiumi di consensi e di spermatozoi innocenti. Non è la RAI ha probabilmente rappresentato l’espressione più sublime e genuina di un certo trash televisivo dell’era postcaroselliana, un picco difficilmente ripetibile nell’epoca del reality a tutti i costi. Sfruttando forse l’ultimo spiraglio spazio-temporale a disposizione, prima dell’avvento della pedoparanoia di massa. Prima che il Moige e i suoi astrusi proclami attecchissero e aderissero quatti quatti alle pareti mentali della popolazione in modo apparentemente inscrostabile, costringendo eserciti di regazzini innocenti a passare le loro esistenze murati vivi nelle scuole con la scusa del mostro impermeabilizzato e dotato di fallo bionico sempre in agguato. Come dimenticare le inguardabili magliette, l’orripilante merchandising, le inascoltabili compilation contenenti veri e propri inni generazionali paragonabili per certi versi a quelli sfornati dal duo Pezzali-Repetto. Come scordare il moto ipnotico delle acerbe tette rimbalzanti, i teneri visini indifesi perennemente macerati dalle finte lagrime, la castità quasi irreale della Trevisan (che infatti, dopo essere stata protagonista del meno svestito dei calendari dopo quello delle Orsoline, ripudiata da un Piersilvio in cerca di più fresche prede, non fece carriera). Quella soffusa, quasi sognante atmosfera ai confini del softporno che avrebbe trovato piena realizzazione solo anni dopo nel cult movie “Vacanze da spiare” (protagoniste della complessa trama Francesca Gollini, Ilaria Galassi e Marzia Di Maio). E poi la processione delle fan-cazziste affamate di provini e proposte indecenti, accompagnate al macello da genitori ben più esaltati di loro. E gli inquietanti striscioni “Ambra c’è” delirati da folle di piccoli aspiranti falegnami scatenati all’uscita degli studi sul Palatino; i cori inneggianti all’aria fritta mista al vuoto cerebrale impersonificati dall’arrivista teleguidata per antonomasia; e dalle altre, sciattissime e scimunitissime lolite di quinta categoria servite di contorno.
Morto Gianni Boncompagni. Un grande, che si vantava di fare «la tv del vuoto pneumatico». Di sé, con coraggio e cinismo, diceva di essere il rappresentante, il venditore, il piazzista della tv commerciale. Una condizione tanto rischiosa quanto onesta, scrive Aldo Grasso il 16 aprile 2017 su "Il Corriere della Sera". Se in radio sono stati la coppia più innovativa della storia della Rai, in tv Gianni Boncompagni e Renzo Arbore erano il diavolo e l’acqua santa. Insieme, in via del Babuino, avevano partecipato al concorso per «maestro programmatore di musica leggera». È lì che si erano conosciuti, due giovani provinciali (uno veniva da Foggia, l’altro da Arezzo) con tanta voglia di sfondare: insieme hanno fatto «Bandiera gialla», «Per voi giovani» e «Alto gradimento»…In tv erano molto diversi, lo sapevano e ci scherzavano sopra. Boncompagni era pur sempre l’autore di programmi come «Pronto, Raffaella?» (1983) e «Pronto, chi gioca?» (1985), «Non è la Rai» (1991), «Casa Castagna» (1995-96), «Macao» (1996)…A onor del vero, abbiamo faticato non poco prima di convincerci che anche Gianni era un grande: grande perché diverso dal nostro modo di intendere la tv, perché era «l’altra faccia» della tv generalista, perché, nonostante le critiche, faceva una tv coraggiosa, così spavalda da non meritarsi la ricompensa di un elogio, di una ricerca o il coronamento di un’inquietudine. Di fronte alla retorica della tv di qualità, della tv per pochi, della tv educativa (la tv perbene esiste solo in presenza della tv permale), solo Boncompagni ha avuto il coraggio di rappresentare la realtà in cui viviamo, nella sua banalità, nella sua vacuità. Di sé, con coraggio e cinismo non comune, diceva di essere il rappresentante, il venditore, il piazzista della tv commerciale. Una condizione tanto rischiosa quanto onesta. Diceva di essere un mercenario che non credeva in niente. Nemmeno nei soldi, dato che non ne aveva più bisogno. La sua frase che più mi ha colpito è questa: «La tv, tranne casi specialissimi, è tutta spazzatura». Scherzava, mica tanto, sostenendo di fare la televisione del vuoto pneumatico, la televisione del nulla. Una tv vacua, ruffiana e opportunista soprattutto nei confronti dello sponsor: «La tv difficile da fare è quella vuota, non quella intelligente. Per fare il vuoto ci vuole fantasia, creatività». Per molto tempo la sua immagine è stata associata a «Non è la Rai», a tutte quelle ragazzine in mezzo alle quali troneggiava come un satiro danzante della mitologia greca. «Le belle fanciulle – ripeteva con un sorriso malizioso - sono la mia vita. Accanto ai giovani, ai giovanissimi mi sento invaso da un senso di benessere, di fresco benessere che null’altro e nessun’altra cosa mi dà. E allora vivo con loro, parlo la loro lingua, ho i loro desideri, ne so interpretare gli umori e le fantasie…». Una trasmissione come «Non è la Rai» non aveva nessun contenuto se non un’innocua vena estetica del tipo «All’Ambra delle fanciulle in fiore». Una tendenza un po’ voyeuristica, certo, ma innocente, molto innocente. «Dei miei programmi – ha detto in un’intervista – salvo soprattutto “Macao”, molto moderno per l’epoca. E poi “Pronto Raffaella?”, che aprì le trasmissioni del mezzogiorno e dopo una settimana raggiunse i 14 milioni di spettatori. Un boom oggi incredibile. Fu merito anche del gioco del barattolo con i fagioli: lo copiai da una di queste terribili tv private. Capii subito che avrebbe funzionato e Raffaella si fidò». In Boncompagni spesso prevaleva un disincanto e una mancanza di fede nella tv che generava un salutare e divertito avvicinamento al mezzo; a volte invece era un po’ sopraffatto dalla goliardia e allora si lasciava sedurre dalla velleità narcisistica di comportarsi come un bambino discolo che dice le parolacce per stupire gli adulti. Riposi in pace.
Gianni Boncompagni. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Giandomenico Boncompagni, meglio conosciuto come Gianni (Arezzo, 13 maggio 1932 – Roma, 16 aprile 2017), è stato un conduttore radiofonico, paroliere, autore televisivo e regista televisivo italiano. Nato in Toscana da padre militare dei ruoli amministrativi e madre casalinga, a 18 anni si trasferì in Svezia, dove visse dieci anni svolgendo vari lavori, diplomandosi all'Accademia svedese di grafica e fotografia, e iniziando l'attività di conduttore radiofonico per la radio svedese. Durante questa esperienza, ottenne un'intervista dal sociologo Danilo Dolci che riscosse molto successo. In Svezia si sposa con un'aristocratica e ha da lei tre figlie, tra cui l'autrice televisiva Barbara. La moglie lo lascerà di lì a breve, e lui chiederà e otterrà la patria potestà, crescendo le figlie da ragazzo padre in Italia. Tornato in Italia, vinse nel 1964 il concorso RAI per programmatore di musica leggera, ed iniziò a lavorare nella radiofonia RAI dove ebbe un grandissimo successo assieme a Renzo Arbore, nei programmi culto a cavallo tra gli anni sessanta e settanta come Bandiera Gialla e Alto gradimento, determinanti per la diffusione della musica beat in Italia. La coppia creò un nuovo modo di fare intrattenimento, basato sul non-sense, sulla creazione di tormentoni, sull'improvvisazione e l'imprevedibilità. Nel 1965 debuttò anche come cantante, con il nome d'arte di Paolo Paolo, incidendo per la RCA Italiana. Sua è anche la voce nella sigla della Guapa. Sempre nel 1965 scrive insieme a Gianni Meccia il testo per Il mondo, successo mondiale di Jimmy Fontana, che gli frutta solo nel primo anno dieci milioni, con cui si compra la prima casa; tra le altre canzoni scritte da Boncompagni ricordiamo anche Ragazzo triste per Patty Pravo. Fa parte della prima serie del programma quotidiano del mattino Chiamate Roma 3131 insieme a Franco Moccagatta e Federica Taddei, 1969. Nel 1977 Boncompagni approda sugli schermi tv della RAI, dove conduce il programma musicale Discoring, anche questo di straordinario successo: fu uno dei primi programmi musicali destinato a un pubblico esclusivamente giovanile, con un proprio gergo, e con le ultime tendenze del momento sia musicali sia nell'abbigliamento. Da allora le esperienze televisive si susseguirono continuamente: Superstar e Drim nel 1980 e poi, per quasi 10 anni in coppia con Giancarlo Magalli come autore, Sotto le stelle e Che Patatrac nel 1981, Illusione, musica, balletto e altro nel 1982 e Galassia 2 nel 1983. Oggi è conosciuto soprattutto come autore e regista di trasmissioni di grande successo popolare: Pronto, Raffaella? che consacrò la sua ex compagna Raffaella Carrà (1983/1985) che vinse nel 1984 il titolo di Personaggio televisivo femminile a livello europeo consegnato dalla European TV Magazines Association e per la quale scrisse spesso i testi di alcune delle sue più famose canzoni. Proseguì con Pronto, chi gioca? che lanciò la carriera televisiva di Enrica Bonaccorti (1985/1987). Dal 1987 al 1990 curò l'ideazione e la realizzazione di Domenica In, dove sdoganò Edwige Fenech, già famosa come icona sexy grazie ai film scollacciati degli anni '70, e Marisa Laurito che grazie a lui consolidò la sua fama televisiva. Fu proprio a Domenica In che nacque l'idea a basso costo del cruciverbone e del pubblico di ragazzine figuranti, dotate di talento o semplicemente carine e petulanti, che preludevano quelle che saranno poi protagoniste di Non è la RAI. Risale infatti al 1991 il passaggio alle reti Fininvest (oggi Mediaset) con Non è la RAI: l'ennesimo programma di culto con Enrica Bonaccorti, in onda da quell'anno fino al 1995. In quelle quattro edizioni Boncompagni è stato sempre al centro delle attenzioni dei media a causa degli scandali legati al programma condotto dalla ancora minorenne Ambra Angiolini. Lo stesso anno realizzò anche Primadonna con Eva Robin's, Bulli & pupe (estate 1992) e poi Rock 'n' Roll (1993), praticamente degli spin-off nati dal successo della trasmissione pomeridiana. Il suo alter ego in quel periodo era Irene Ghergo, coautrice dei suoi programmi. A Non è la RAI lanciò appunto il personaggio di Ambra, che all'epoca fu un vero e proprio fenomeno di costume, ma dalla fucina del programma pomeridiano furono moltissime le personalità del mondo dello spettacolo che ebbero il loro debutto e che in seguito si distinsero in vari campi dello spettacolo: da Claudia Gerini a Laura Freddi, da Sabrina Impacciatore a Nicole Grimaudo, da Antonella Elia a Miriana Trevisan e Francesca Gollini. Nella stagione 1995/1996 collaborò ad un ultimo programma in Mediaset con il programma pomeridiano Casa Castagna, presentato da Alberto Castagna. Tornato in RAI, nel 1996 e 1997 diresse Macao, con Alba Parietti nella prima edizione e nella seconda con "PI" (personaggio creato graficamente per sopperire all'abbandono della Parietti), tutto sommato una variante del modulo di Non è la Rai, con comici, canzoni, ritornelli e un pubblico di figuranti-protagonisti, dove per la prima volta usò anche personaggi maschili. Nel 1998 realizza per Rai 2 il programma di prima serata Crociera condotto da Nancy Brilli; gli ascolti sono molto bassi e la trasmissione viene soppressa dopo una sola puntata. Ha inoltre fatto parte della Commissione Artistica del Festival di Sanremo 1998 ed ha collaborato con Piero Chiambretti per Chiambretti c'è. Nell'estate 2003 ha curato la trasmissione dell'access prime time di Rai 1 Telefonate al buio, condotta da Mara Venier. Il 9 giugno 2004 firma la regia televisiva per Rai 2 e Rai International del concerto di Elton John allo Stadio di Reggio Calabria, in Omaggio a Gianni Versace. Nella stagione 2005/2006 avrebbe dovuto curare Domenica In, abbandonando tuttavia la trasmissione dopo la prima puntata. Nell'autunno 2008 è tornato a lavorare come autore per Raffaella Carrà nella nuova edizione di Carràmba che fortuna. Il 23 ottobre 2006 Gianni Boncompagni è tornato in TV con un nuovo programma, dal titolo Bombay, trasmesso dall'emittente La7. Esattamente come nei suoi precedenti programmi, Bombay presentava scenografia minimale e pubblico composto da ragazze cantanti e vocianti; lo studio era diviso in due parti: una, molto grande, ospitava la sala regia, affollata di ragazze, ed un'altra, molto piccola, completamente tappezzata di rose gialle, rappresentava il vero set televisivo, al cui interno venivano ospitati personaggi bizzarri che discutevano su temi d'attualità sprofondando in dialoghi dell'assurdo. Ha partecipato dal 25 maggio 2011 come giurato di Lasciami cantare!, talent show canoro di Rai 1. Dal 2012 ha curato una rubrica fissa su Il Fatto Quotidiano dal titolo "Complimenti". Gianni Boncompagni era ateo: nell'intervista a Claudio Sabelli Fioretti, pubblicata su Io Donna, supplemento al Corriere della Sera del 4 maggio 2012, ha dichiarato: "Io sono sempre stato ateo e morirò ateo". Muore il 16 aprile 2017 a Roma all'età di 84 anni e 11 mesi.
Boncompagni fu tra quelli che misero in circolazione la voce che Mia Martini portasse sfortuna, determinandone un lungo periodo di lontananza dalla musica. In un'intervista a Epoca del 5 marzo 1989 la stessa Mia Martini ricordava: «La delusione più cocente me la diede Gianni Boncompagni, un amico per l’appunto. Una volta fui ospite a Discoring, lui era il presentatore. Appena entrai in studio sentii Boncompagni che diceva alla troupe: ragazzi, attenti, da adesso può succedere di tutto, salteranno i microfoni, ci sarà un black out». In un'altra intervista con Enzo Tortora la Martini definì Boncompagni "detestabile".
VI SCONGIURO. Lo strano caso di Mia Martini cantante «portasfortuna». Epoca 05/03/1989. Mia Martini. La cantante che è la sorella di Loredana Berté, è stata a lungo perseguitata dalla fama di jettatrice una diceria che l’ha costretta a interrompere la carriera per sei anni. E’ tornata alla ribalta a Sanremo con la canzone “Almeno tu nell’Universo”. "Jettatrice", Menagramo”, “portajella”. Il pregiudizio, l'ignoranza e la malafede hanno schiacciato per anni la vita Domenica Berté, in arte Mia Martini. Nel mondo scaramantico e superficiale della canzone, quella fama significa isolamento, difficoltà di ogni genere. Ma adesso, prendendo tutti in contropiede, la cantante è tornata alla ribalta, partecipando al Festival di Sanremo con un brano, “ALMENO TU NELL’UNIVERSO”, composto per lei da Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi. Tutto come se niente fosse? Non proprio. Anche se Mia Martini, quarantadue anni di Bagnara Calabra, non lo ammette apertamente, il suo calvario è stato lungo e sofferto. «Tutto è cominciato nel 1970», racconta. «Allora cominciavo ad avere i miei primi successi. Fausto Taddeu, un impresario soprannominato “Ciccio Piper” perché frequentava il famoso locale romano, mi propose una esclusiva a vita. Era un tipo assolutamente inaffidabile e rifiutai. E dopo qualche giorno, di ritorno da un concerto in Sicilia, il pulmino su cui viaggiavo con il mio gruppo fu coinvolto in un incidente. Due ragazzi persero la vita. “Ciccio Piper” ne approfittò subito per appiccicarmi l’etichetta di “porta jella”» Da allora l’aneddotica si fece sterminata. Mostra della Canzone, 1973. All’Hotel De Bains di Venezia, dove alloggia Mia Martini, scoppia un incendio. I colleghi e gli addetti ai lavori non lo dicono, ma tutti pensano che la colpa sia dell’effetto Martini. A dieci anni di distanza, un altro incidente stradale. Sull’autostrada MilanoBrescia, la vettura su cui viaggia la cantante è coinvolta in un tamponamento a catena. Muore l’impresario Pierluigi Premoli, Mia Martini rimane ferita. «All’inizio ridevo di questa fama», afferma la cantante. “Poi mi accorsi che non soltanto i nemici e gli invidiosi, ma anche le persone che amavo si lasciavano condizionare da questa mia “fama”. La delusione più cocente me la diede Gianni Boncompagni, un amico per l’appunto. Una volta fui ospite a DISCORING, lui era il regista. Appena entrai in studio sentii Boncompagni che diceva alla troupe: ragazzi attenti, da adesso può succedere di tutto, salteranno i microfoni, ci sarà un black out. Chiesi ai responsabili della mia casa discografica di allora, di intervenire. Se ne guardarono bene, giustificandosi col fatto di dovere mantenere buoni rapporti con la Rai». Il fardello si fece via via sempre più pesante. «Finché ero una cantante di successo», racconta Mia Martini, «mi sembrava soltanto un gioco fastidioso. Ci scherzavo su. Se capitavo in un casinò e c’era qualcuno che mi stava antipatico, mi mettevo dietro a lui per farlo innervosire. Così vince il tuo avversario, gli dicevo. Poi la cosa divenne sempre più seria». Fatalità? Complotto? «Forse tutte e due», risponde Mia Martini. «Ho riflettuto a lungo su queste vicende e sono arrivata alla conclusione che fatalmente ci fu un complotto». Ma non basta. Anche la vita si accanì con Mia Martini. Il rapporto quasi decennale con il cantautore Ivano Fossati andò in pezzi. La rescissione del contratto con la Ricordi le costò 200 milioni. E ancora pettegolezzi, ancora polemiche. Mia Martini non resse. Sei anni fa il ritiro dalle scena. Pur essendo considerata una delle migliori interpreti della musica leggera italiana, con alle spalle successi come “Piccolo uomo” e riconoscimenti internazionali, la sorella di Loredana Berté si trasferì in campagna, a Calvi dell’Umbria dove vive tutt’oggi. Cosa l’ha spinta, adesso a rituffarsi nella mischia? «E’ cambiato il mondo della canzone e sono cambiata anch’io», spiega. «Oggi tutto è più veloce ha il ritmo di uno spot pubblicitario. Spero che non ci sia più tempo per certe bassezze. Poi mi ero stancata di cantare per pochi amici. E Sanremo era il palcoscenico ideale per dire sono tornata». Un nuovo album quasi pronto titolo “Martini Mia”, canzoni scritte per lei da Dario Baldan Bembo, Enzo Gragnaniello, Maurizio Fabrizio. Una composta da lei stessa con un titolo più che allusivo “Spegni la testa”, Una nuova casa discografica, la Fonit Cetra. E ancora la sigla della serie “Amori”, fra poco in onda su Canale 5. Mia Martini ricomincia sul serio. Qualche timore? «Ho adoperato questi anni per crescere», commenta serena la cantante «spero che gli altri abbiano fatto altrettanto». Sopra Mia Martini oggi. In alto come era nel 1975 a 27 anni. La cantante che è la sorella di Loredana Berté, è stata a lungo perseguitata dalla fama di jettatrice una diceria che l’ha costretta a interrompere la carriera per sei anni. E’ tornata alla ribalta a Sanremo con la canzone “Almeno tu nell’Universo”.
Chiambretti intercetta l’auricolare di Ambra e sente la voce di Boncompagni, scrive il 16/04/2017 "La Stampa”. Una delle leggende più celebri della televisione italiana è senza dubbio quella dell’auricolare che Ambra Angiolini indossava durante la conduzione del programma di Canale 5 Non è la Rai. Il mito vuole che l’autore Gianni Boncompagni utilizzasse un collegamento radio per suggerire ogni parola ad Ambra, così un giovane Piero Chiambretti ha provato a svelare l’arcano.
“Le dicevo cose tremende”: Boncompagni e Ambra, gli auricolari che fecero la storia. Era l’inizio degli anni 90 quando Gianni Boncompagni decise di mettere al timone di Non è la Rai una giovanissima Ambra Angiolini, preferendola a Paolo Bonolis. Il legame tra i due scorreva sul filo invisibile di un paio di auricolari, che hanno poi fatto la storia della tv, scrive il 17 aprile 2017 Eleonora D'Amore su "Fanpage". Nel 2015, in occasione della messa in onda della prima puntata della fiction "1992" di Stefano Accorsi (nella quale viene più volte citato), il Fatto Quotidiano ha intervistato Gianni Boncompagni, storico autore e regista di "Non è la Rai". A poche ore dalla sua morte, è impossibile non fare un tuffo nel passando, ripercorrendo gli albori di quella tv teen, che in poco tempo divenne il punto di riferimento di milioni di adolescenti. È vero che c'era un'emulazione pazzesca. Le ragazze erano tutte vestite uguali, e naturalmente gli sponsor facevano a gara per darci i vestiti. Però nessuna ragazzina poteva dire una cosa del genere, manco sapevano cosa volesse dire lo spirito critico. E non avevano nemmeno sensi di colpa: si divertivano e basta. E fu proprio negli studi del Palatino in Roma che nacque il mito dell'auricolare. Di fatto, Boncompagni decise di affidare l'intero programma ad una giovanissima Ambra Angiolini, alla quale si legò indissolubilmente tramite un paio di auricolari. La leggenda della prima conduzione a distanza prese vita a poco a poco, sebbene entrambi smentissero ciclicamente. Poi l'ammissione. Ed è così che il noto regista ne spiegò la genesi, appena due anni fa: "Non ricordo bene come andò. Ricordo solo che da Mediaset all'inizio mi ammollarono Bonolis che aveva già il contratto, ma io lo detestavo allora come lo detesto oggi. Non gli feci fare niente e dopo un anno misi Ambra al posto suo, con gli auricolari. Tutti credevano che io suggerissi le battute, invece le dicevo delle cose tremende, irriferibili, e lei doveva fare finta di nulla". Già allora, però, fu verificabile quanto le parole di Boncompagni non fossero solo un elemento di disturbo per la ‘radiocomandata' Ambra. Piero Chiambretti si prese la briga di intercettarli, dimostrando quanto il collegamento continuo contaminasse al conduzione stessa.
Barbara Carfagna shock: "Isabella Ferrari in Rai a 16 anni perchè amante di Boncompagni. Giovedì 20 Aprile 2017. Barbara Carfagna, volto del Tg1, al veleno su Facebook contro Isabella Ferrari e Marco Travaglio, con un lungo e polemico post su Gianni Boncompagni, che fa il paragone con la vicenda delle famose "cene eleganti" di Berlusconi e al caso Ruby. Coinvolta anche Claudia Gerini. Così inizia la Carfagna: "Quanto cambia chi è la persona che lo compie nel racconto di un comportamento? Tutti amavamo e piangiamo la morte di Boncompagni. Io me lo ricordo a qualche festa da D'Agostino in cui si parlava di Berlusconi. Anche lui aveva avuto amanti minorenni e le aveva piazzate con successo, anche nella TV di Stato". "Una di queste amate e piazzate in Rai a 16 anni, era lei. Isabella Ferrari. Qui Insieme a uno dei più grandi accusatori di Berlusconi per le vicende Ruby e Noemi. Però Boncompagni lo abbiamo sempre visto tutti solo come un creativo Pigmalione. Lei e la Gerini come due miracolate per averlo avuto accanto, brave belle e intelligenti; una oggi pure sofisticata intellettuale, in Teatro con Travaglio". Per la Carfagna quello di Boncompagni è stato, in chiusura: "un comportamento oggi condannato, ma negli anni '80 accolto e finanziato pure con i soldi pubblici".
Barbara Carfagna: Isabella Ferrari in Rai a 16 anni? Era amante di Boncompagni. Barbara Carfagna: da Isabella Ferrari al botta-risposta con Marco Travaglio, scrive "Affari italiani" il 21 aprile 2017. "Quanto cambia chi è la persona che lo compie nel racconto di un comportamento? Tutti amavamo e piangiamo la morte di Boncompagni. Io me lo ricordo a qualche festa da D'Agostino in cui si parlava di Berlusconi. Anche lui aveva avuto amanti minorenni e le aveva piazzate con successo, anche nella TV di Stato. C'era anche Freccero che chiosava: "la vita è come il film 'La Società degli uomini'". E, come spesso accade, aveva ragione. Una di queste amate e piazzate in Rai a 16 anni, era lei. Isabella Ferrari. Qui Insieme a uno dei più grandi accusatori di Berlusconi per le vicende Ruby e Noemi. Però Boncompagni lo abbiamo sempre visto tutti solo come un creativo Pigmalione. Lei e la Gerini come due miracolate per averlo avuto accanto, brave belle e intelligenti; una oggi pure sofisticata intellettuale, in Teatro con Travaglio. Una parte la fecero fare pure a lui, Bonco sul palco con Ingroia Ruotolo e Di Pietro. Perché alla fine questo è stato l'esito di un comportamento oggi condannato, ma negli anni '80 accolto e finanziato pure con i soldi pubblici. Lui vedeva chiaramente questi paradossi, anzi li sottolineava in interviste ficcanti e ne rideva".
"Vedo che una valorosa "collega" della Rai ha approfittato della morte di Bonco per farsi un po' di pubblicità gratuita, nel solco della lunga tradizione esibizionistica della mosca cocchiera che salta sul carro funebre credendo di guidarlo, quella per cui ai matrimoni c'è sempre qualcuno che vuol essere la sposa e ai funerali qualcuno che vuol essere il morto", scrive Marco Travaglio a Dagospia. "Ricordo alla "collega" smemorata e male informata che le polemiche (almeno le mie) e il processo a Berlusconi per le sue frequentazioni con minorenni non hanno mai riguardato il suo sacrosanto diritto di fare quel che gli pareva nella sua vita privata: ma (per le polemiche) la sua possibile ricattabilità di uomo di governo e di Stato e (per i processi) l'accusa - poi caduta - di avere indotto una minorenne a prostituirsi, cioè a fare sesso a pagamento (reato che il suo stesso governo aveva deciso di punire con pene più severe di prima)".
"Ho già detto di essere d'accordo con Travaglio sui differenti ruoli tra Berlusconi e Boncompagni, infatti la considerazione nel mio post (che, ricordo, non è mia ma dello stesso Boncompagni a una festa) era sul paradosso, per lui, di trovarsi sul palco con gli accusatori di Berlusconi per la frequentazione di 16/17enni e per aver dato inizio alla tv delle veline (il libro Papi di Travaglio -come sottolineato da Facci- precede il caso Ruby); innovazione sociale a cui non negava di aver partecipato attivamente e nelle cui varie evoluzioni, anni dopo Non è la Rai, era finito per un breve periodo indagato insieme a Sabani (poi prosciolto prima del processo ma mai riabilitato: morì isolato tra mille sofferenze morali, aiutato solo da Maurizio Costanzo e dal suo avvocato Antonio De Vita). Vicenda giudiziaria che seguii raccogliendo anche gli sfoghi di Sabani, abbandonato da tutta la comunità dello spettacolo e privato del consenso del pubblico, che lo additava anche dopo il proscioglimento. Da parte mia, figuriamoci, nessun giudizio. Ho avuto una vita piena, libera e amo chi fa altrettanto. Non so neanche se a 16/17 anni i giovani debbano essere considerati come bambini di 8. Per quanto riguarda la Volpe e l'Uva, se l'Uva è "Non è la Rai" nel post precedente quello che cita Travaglio raccontavo di aver passato direttamente le selezioni senza averle fatte (cantavo nel coro di Nora Orlandi e serviva una ragazza dai capelli rossi). Non mi presentai e scelsi un esame universitario. Così come non colsi altre opportunità di ventenne forse più allettanti nel settore dello spettacolo e della moda. Come dico nel post, precedente la polemica, non credo per questo di essere migliore né di aver fatto le scelte giuste. Anzi, rifletto che oggi si potrebbe fare tutto senza il rigore forse eccessivo di un tempo. Le consiglierei, per correttezza, di aprire ai commenti la sua bacheca quando accusa qualcuno senza conoscerne la storia. Preciso per il Corriere che non sono entrata al tg1 nel 2004 (il 2008 fu l'anno dell'assunzione definitiva voluta da Mimun ma giunta con Riotta dopo 12 anni di precariato) ma nel 1998 sotto la direzione di Giulio Borrelli e dal 1995 in Rai dopo varie collaborazioni come cantante nei cori di Nora Orlandi e violinista. Il mio non era un attacco, tantomeno alla Ferrari che, da donna intelligente, mai ha negato l'apporto di un uomo così creativo e anticonformista incontrato nella prima parte della sua vita.
Le (giovani) amanti di Boncompagni favorite in tv, Claudia Gerini replica: «Nessuno mi ha mai piazzata». L’attrice risponde all’attacco della giornalista del Tg1 Barbara Carfagna che aveva definito lei e Isabella Ferrari «miracolate» per averlo avuto accanto: «Parole superficiali e parallelismo illogico con Berlusconi, io non ho mai ricevuto bonifici», scrive Chiara Maffioletti il 21 aprile 2017 su "Il Corriere della Sera". Claudia Gerini nemmeno sapeva di essere stata chiamata in causa dal volto del Tg1 Barbara Carfagna. Ma, dopo aver letto quanto scritto dalla giornalista (che ha definito «miracolate» lei e Isabella Ferrari per aver avuto accanto il regista e autore tv), assicura: «Non mi sento toccata per niente da queste parole. In primo luogo perché non sono vere. Mi pare una riflessione molto superficiale oltre che un parallelismo che non ha senso». Il riferimento è a Berlusconi, dal momento che la giornalista nel suo post ha scritto: «Quanto cambia chi è la persona che lo compie nel racconto di un comportamento? Tutti amavamo e piangiamo la morte di Boncompagni. Io me lo ricordo a qualche festa da D’Agostino in cui si parlava di Berlusconi. Anche lui aveva avuto amanti minorenni e le aveva piazzate con successo, anche nella Tv di Stato».
Ma l’attrice, con grande serenità, commenta: «Sono due vicende che non hanno niente a che vedere. E’ vero che Gianni ha avuto compagne anche molto più giovani, ma non si è mai trattato di prostituzione o altro. Io non sono stata piazzata da nessuna parte e quello che ho ottenuto l’ho ottenuto con le mie forze. Non ho mai dovuto fare nessuna parcella perché stessi zitta, non ho mai ricevuto bonifici. Mi pare davvero un paragone senza nessun senso».
Botta e risposta al veleno tra la Lucarelli e la Mosetti: "Hai fatto carriera grazie ai festini". Una battuta di Selvaggia Lucarelli ha scatenato una vera e propria "guerra" a colpi di social con Antonella Mosetti. Le due, dopo essersi accusate a vicenda, hanno chiesto l'intervento dei loro legali, scrive Anna Rossi, Venerdì 21/04/2017 su "Il Giornale". Si sa che tra Selvaggia Lucarelli e Antonella Mosetti non è mai stato tutto rose e fiori, ora un post della giornalista ha riaperto la faida tra le due. Tutto è iniziato ieri, quando a quattro giorni dalla morte di Gianni Boncompagni, Selvaggia Lucarelli ha scritto sul suo profilo Facebook una battuta provocatoria: "Tutti a dire 'Che bravo Boncompagni' (ed era bravo), ma ricordatevi che la Mosetti è colpa sua". Nel messaggio la blogger alludeva chiaramente alla partecipazione di Antonella a Non è la Rai. Il messaggio e l'ironica allusione non è passata inosservata e immediatamente ha scatenato la reazione della Mosetti. "Na sfigata senza uguali... falla sparlare, solo quello sa fare", ha risposto indispettita Antonella. Ma le offese non si sono fermate e tra i commenti, la Mosetti si lascia scappare "invece la nullità (riferita alla giornalista, ndr) è il prodotto delle raccomandazioni politiche e non solo". Ma a questa sottile insinuazione Selvaggia Lucarelli non ci sta e parte il botta e risposta al veleno. "Mortacci oh, tutte 'ste raccomandazioni e solo il giudice a Ballando? Manco la giuria di qualità a Sanremo al posto di Greta Menchi? E che cazzo". E ancora la Mosetti risponde: "Mi ha vista a Matrix e ha rosicato. Aspetto di trovarmela davanti, sto leone da tastiera. I festini la Lucarelli li ha sempre fatti in privato e lo sanno in molti nel settore spettacolo. Io brutto cesso, i festini non li ho mai fatti altrimenti a quest'ora sarei stata da altre parti, tipo le tue. Ci vediamo presto e ai tuoi sostenitori di immondizia, ci penseranno i miei legali". E poi, riferendosi al suo amico-imprenditore Daniele Pulcini (coinvolto nello scandalo Mafia Capitale, ndr) e ai presunti festini, la Mosetti rincara la dose: "Aggiungo cara cessone Lucarelli che te e la tua amica avete fatto di tutto per mettermi in cattiva luce ma non ci siete riuscite proprio perché non sono una che fa schifezze a differenza vostra e l'essere amica da 20 anni di una persona che passa un momento molto difficile, mi fa solo che onore e non solo a me ma a tutti i suoi storici amici. Sono una delle poche che non ha nulla da nascondere anzi... Mi dispiace per voi ma è solo amicizia. Baci cari e di cuore vero. A presto". La discussione tra le due è ancora molto lunga, tra offese, rimpalli di colpa, insinuazioni e interventi di avvocati le due donne se ne sono dette di cotte di crude sui social. Il tutto davanti a centinaia di utenti che tenevano le parti un po' di una e un po' dell'altra.
MAI NULLA CAMBIA. 1968: TRAGICA ILLUSIONE.
Cronaca del 1968 mese dopo mese. Viaggio nell'anno che ha cambiato la storia: la battaglia di Valle Giulia, verso le elezioni. Johnson rimuove Westmoreland. Una frana a Genova fa 19 morti, scrive Edoardo Frittoli il 9 marzo 2018 su "Panorama".
Gennaio 1968
5-6 gennaio. Il 27 novembre 1967 Palazzo Campana, sede dell'Università degli Studi di Torino, era stato occupato da un gruppo di studenti in segno di "protesta contro l'autoritarismo accademico", come fu scritto nei comunicati del comitato di agitazione. Esattamente un mese dopo, il 27 dicembre, il Rettore Prof. Mario Allara fa sgomberare gli studenti ribelli per mano della Pubblica Sicurezza. Due giorni dopo un nucleo di studenti forza la porta di un ingresso secondario su Via Principe Amedeo e dichiara nuovamente lo stato di occupazione. Le denunce alla Procura sono 64 più 15 dirette a studenti del Politecnico venuti in aiuto ai compagni di Palazzo Campana. Nel comunicato diffuso all'inizio di gennaio del 1968 dagli studenti in lotta si denuncia l'autoritarismo dell'istituzione universitaria in quanto colpevole di "sfornare lavoratori succubi, impreparati e qualunquisti". L'ultima parte del testo preannuncia una lotta che durerà nel tempo, nonostante le denunce del Rettore: si annuncia il "rilancio dell'agitazione cercando collegamenti per estenderla a tutti gli studenti di Torino ed alle altre Università". Gli studenti definiscono lo strumento dell'occupazione "pieno diritto degli studenti ed individua nella disobbedienza civile, nel rifiuto di sottoporsi al controllo dell'autorità accademica, nell' approfondimento del dibattito gli strumenti ore consentire la formazione politica, il rafforzamento e la crescita del movimento studentesco". Tra i leader dell'occupazione dell'Università di Torino ci sono l'economista Guido Viale, Luigi Bobbio (figlio di Norberto) e Marco Revelli, figlio del partigiano Nuto Revelli. Le cronache dei quotidiani sono occupate dall'omicidio del conte Cesare d'Acquarone (42enne proprietario della società di trasporti aerei "Aeralpi", dedicata ai voli su Cortina per il jet set). Il figlio dell'ex Ministro della Real Casa è stato ucciso dalla suocera Sofia Bassi Celorio nella loro lussuosa residenza di Acapulco con cinque colpi di pistola calibro 32. A Praga viene eletto Alexander Dubçek. Succede al leader stalinista Antonin Novotny. La sua visione riformista si traduce nei primi mesi di governo in una serie di provvedimenti di rottura con il regime allineato a Mosca: libertà di stampa, amnistia per i prigionieri politici. Era cominciata la "primavera di Praga", l'effimera stagione di libertà celebrata in tutto il paese sino alla repressione sovietica dell'agosto successivo.
9 gennaio. Non si placa la tensione nel conflitto arabo-israeliano a pochi mesi dalla guerra dei Sei Giorni. L'artiglieria giordana colpisce alcuni territori della valle di Beit'Shean occupate dai coloni israeliani. Tel Aviv risponde impegnando l'aviazione.
10 gennaio. Una forte perturbazione porta la neve in tutta la penisola. Nevica anche a Roma. Il mondo riceve un'anticipazione di quanto vivrà nell'estate dell'anno seguente. La sonda americana Surveyor 7 tocca la superficie della Luna ed inizia ad inviare, appena 42 minuti dopo aver toccato il suolo, le prime immagini della superficie pietrosa del satellite. La sonda ha impiegato 65 ore per coprire la distanza dalla Terra alla Luna. In Parlamento si discute di riforma dell'Università. La commissione composta dai partiti di maggioranza mette all'ordine del giorno l'incompatibilità tra insegnamento e cariche parlamentari di fronte al Ministro dell'Istruzione, il democristiano Luigi Gui.
12 gennaio. Palazzo Campana, Università di Torino. Il rettore Mario Allata reagisce categoricamente alla nuova occupazione iniziata tre giorni prima, dichiarando agli organi di informazione che "tutti i disordini verranno denunciati alla Magistratura". Il Rettore preannuncia anche una denuncia per "vilipendio alla Religione" poiché nei cassonetti dei rifiuti sono stati trovati alcuni crocifissi rimossi dalle pareti delle aule universitarie. Durante la conferenza scoppiano disordini tra i rappresentanti del movimento e la Polizia.
15 gennaio. Un terrificante sisma di magnitudo 6,4 colpisce nella notte la Sicilia occidentale. Molti comuni della zona del Belice subiscono danni gravissimi. Gli abitati di Gibellina, Poggioreale e Montevago sono completamente rasi al suolo. I soccorsi saranno lenti e difficoltosi, le vittime circa 400, 10.000 i feriti e 90.000 gli sfollati.
18 gennaio. La cronaca rosa riempie le pagine con la prima udienza per una separazione eccellente: quella tra il torero Luis Miguel Dominguìne l'attrice italiana Lucia Bosè.
23 gennaio. All'Università di Torino sede delle occupazioni iniziate nel novembre dell'anno precedente il Rettore Allara incontra una delegazione di studenti che minacciano una nuova occupazione. Il giorno stesso anche l'Università di Pisa entra in stato di agitazione. Il Senato Accademico di Torino respinge le richieste del movimento, pur annunciando la sospensione dei provvedimenti disciplinari per i fatti dei giorni precedenti. Alle 21 un gruppo di studenti occupa nuovamente Palazzo Campana, che sarà sgomberato alle 23,30 dall'irruzione della Questura di Torino. E' la quarta occupazione in due mesi.
24 gennaio. Il giovane drammaturgo cecoslovacco Vaclav Havel visita l'Italia appena dopo l'elezione di Dubcek. Presenta agli intellettuali italiani un "memorandum" satirico sugli anni dello stalinismo nel suo paese, diffondendo le idee della "primavera di Praga".
27 gennaio. Nel Belice una nuova violenta scossa di terremoto provoca nuovi crolli, che causano la morte di 4 soccorritori. Gibellina, Montevago e Salaparuta sono dichiarate "zone proibite". Saranno ricostruite in luoghi diversi dai siti originari. Viene scarcerato ad Atene l'intellettuale e musicista Mikis Teodorakis. Era stato arrestato nell'agosto del 1967, quattro mesi dopo il golpe dei Colonnelli. Diventerà uno dei leader dell'opposizione al regime militare greco. Nel cantone svizzero dei Grigioni le abbondantissime precipitazioni nevose dei giorni precedenti causano il distacco di enormi valanghe che causano oltre 10 vittime.
29-31 gennaio. Guerra del Vietnam. Inizia la grande offensiva dei Vietcong e dell'esercito di Hanoi contro la capitale del Sud, Saigon. Il 31 gennaio 70.000 soldati nordvietnamiti guidati dal generale Giap lanciano l'offensiva del Tet (dal nome vietnamita del nuovo anno lunare) che interessa oltre 100 città e paesi del Vietnam del Sud. Presi di sorpresa, gli Americani e l'esercito sudvietnamita riusciranno a respingere le forze comuniste del Nord che tennero le posizioni per due giorni solamente, ma l'opinione pubblica americana e mondiale si rese conto della difficilissima situazione della guerra. La richiesta di Westmoreland di ulteriori 200.000 uomini fece crollare la fiducia degli americani nella vittoria imminente e il consenso al presidente Johnson, che ordinerà nei giorni successivi la sospensione dei bombardamenti sul Vietnam del Nord. Il 30 gennaio a Firenze 3.000 studenti sfilano in corteo contro la Polizia e i Carabinieri che erano intervenuti per lo sgombero dell'Ateneo nel quale si era svolta un'assemblea che avrebbe dovuto decidere l'occupazione. Alle 12,30 in piazza San Marco scoppiano tafferugli e il Reparto Celere interviene lanciando le camionette in caroselli. Uno studente viene investito e ferito in modo non grave, diversi agenti rimangono contusi.
Febbraio 1968
1 febbraio. È la serata inaugurale della 18ma edizione del Festival di Sanremo, che si svolge ancora al Casinò della cittadina del Ponente ligure. Gli ospiti stranieri più attesi sono gli americani Louis Armstrong ed Eartha Kitt. Tra gli esordienti italiani due futuri big: Albano Carrisi e Riccardo Fogli. Conduce il festival Pippo Baudo, anche lui sul palco per la prima volta affiancato da Luisa Rivelli, attrice e poi conduttrice e giornalista fino agli anni '90. Tre giorni dopo la vittoria andrà alla coppia Sergio Endrigo-Roberto Carlos con "Canzone per Te". E' passato un anno dalla tragica morte di Luigi Tenco. Anche per questo motivo la giuria, della quale fa parte anche Renzo Arbore, aveva scartato il brano del "big" Domenico Modugno per il tema del suicidio contenuto nei suoi versi. I cantautore parteciperà alla gara in coppia con Tony Renis con una canzone scritta da quest'ultimo. Il rettore dell'Università di Firenze, il glottologo Giacomo Devoto presenta le proprie dimissioni in quanto il Prefetto Manfredi de Bernart avrebbe rifiutato su sua proposta l'incontro con una rappresentanza degli studenti. La voce del Rettore sarà l'unica fuori dal coro, in quanto dichiarerà alla stampa che in occasione degli scontri di piazza dei giorni precedenti "La Polizia ha ecceduto in piazza Lamarmora. La repressione è stata ingiustificata, anche se le autorità possono invocare l'attenuante del blocco del traffico"(…) Le dimissioni verranno respinte nei giorni seguenti dal Ministro dell'Istruzione Luigi Gui.
7 febbraio. Iniziano le Olimpiadi invernali di Grenoble, inaugurati da Charles De Gaulle. Ricordate come i giochi di Jean Claude Killy, vedranno l'Italia protagonista nel bob con il "rosso volante" Eugenio Monti (due ori) e nel fondo con Franco Nones (oro nella 30 km).
In Spagna negli ambienti monarchici e conservatori si comincia a considerare concreta l'ipotesi di una restaurazione monarchica a favore di Juan Carlos, delfino di Francisco Franco.
13 febbraio. Il processo ai responsabili della strage di Baveno si trasferisce dalla Germania al Tribunale di Milano, riportando alla memoria degli italiani una delle più efferate stragi naziste. La strage fu compiuta all'indomani dell'8 settembre 1943 dalle SS della divisione "Adolf Hitler" ed ebbe come vittime 57 cittadini ebrei che si erano rifugiati sul Lago Maggiore in fuga da Milano a causa dei bombardamenti alleati. Le rogatorie di oltre 180 testimoni dell'eccidio porteranno a luglio alla condanna all'ergastolo di 5 ufficiali delle SS. Tuttavia la corte di Berlino, accolto il ricorso, dichiarerà la prescrizione nel 1970.
14 febbraio. A Roma vengono occupate ben 6 Facoltà: Lettere, Architettura, Fisica, Magistero, Statistica, Economia e Commercio. Il Rettore, il giurista Pietro Agostino D'Avack (1905-1982) minaccia l'intervento della forza pubblica. A Pisa le lezioni sono sospese per ordine del Preside dopo una colluttazione tra uno studente ed un docente durante le agitazioni dei giorni precedenti. Mentre gli studenti occupano i principali atenei d'Italia, la riforma universitaria si arena in Parlamento per il muro a muro tra la maggioranza del Governo di centro-sinistra guidata da Aldo Moro e l'opposizione di PCI e MSI agli estremi opposti. La mancata discussione della riforma è alla base dello sciopero di metà febbraio degli assistenti universitari. Gli effetti dell'offensiva nordvietnamita del Tet portano ad un'ulteriore "escalation" della presenza militare americana in Vietnam. Sono pronti a partire immediatamente altri 10.500 uomini. Ma Johnson dichiara davanti ad un gruppo di studenti di avere ferma intenzione di aprire negoziati ufficiali con Hanoi.
15 febbraio. Torino, Palazzo Campana. Durante la ripresa delle sessioni dopo il periodo di occupazione esplode una bomba carta in un'aula. Fortunatamente non vi sono vittime. All'Università La Sapienza di Roma, occupata dagli studenti dal 2 febbraio, il clima anticipa quello dei futuri scontri del marzo successivo: all'esterno degli edifici si sono radunati gruppi di studenti di destra armati di casse di mele marce, che vengono scagliate contro le finestre delle aule dove si tengono le assemblee. Il giornalista Alberto Ronchey è uno dei primi ad avere l'opportunità di incontrare gli occupanti, nonostante la diffidenza dei gruppi nei confronti della stampa e della televisione. Emerge un quadro sostanzialmente spontaneista, diviso in gruppi e gruppuscoli che tentano di darsi un'organizzazione più solida. I miti alle pareti sono Che Guevara, Ho Chi Minh, ma anche Don Lorenzo Milani. Sono esclusi i rimandi alla politica nazionale ed alle figure storiche del Partito Comunista Italiano, che proprio in quei giorni di agitazione è impegnato a formalizzare molte espulsioni dalle sezioni giovanili proprio per la tendenza indipendente e spontanea del nascente Movimento Studentesco. A Berlino Ovest viene fermato Peter Brandt, figlio del Cancelliere della Germania Federale Willi Brandt. Stava distribuendo volantini per l'adesione ad una manifestazione contro la guerra in Vietnam.
19 febbraio. A più di un mese dal sisma del Belice, tra le rovine di Gibellina vengono estratte altre 25 salme. Molti sono ancora i sinistrati che sono costretti a vivere in vagoni ferroviari. Anche in Grecia un violento terremoto si abbatte sulle isole dell'Egeo radendo al suolo l'intero abitato di Agiostrati.
22 febbraio. A La Sapienza di Roma gli studenti sfondano il portone servendosi di un tavolo come ariete. Vengono travolti i commessi e nove di loro rimangono contusi. Il Rettore D'Avack chiede l'intervento della Polizia che si presenta in forze (150 agenti) procedendo all'arresto di 79 occupanti. A Milano viene occupato l'Istituto di Anatomia della facoltà di Medicina, per protesta contro le eccessive bocciature agli ultimi appelli. Gli studenti milanesi accusavano la presunta illegalità degli esami svolti di fronte ad un solo docente, senza la necessaria presenza di un secondo testimone (docente o assistente). L'assemblea accusa i professori di voler sfoltire il sovraffollamento della Facoltà con bocciature indiscriminate. A Belluno dove sui svolge il processo per la catastrofe del Vajont vengono rinviati a giudizio per disastro colposo e omicidi colposi plurimi i due ingegneri della SADE Alberico Biadene e Dino Tonini, irreperibili il giorno della sentenza istruttoria. Fu proprio Biadene a richiedere il rialzo dell'invaso della diga. Nel 1971 la sentenza di Cassazione condannerà l'ingegnere ad una pena leggera: 5 anni di cui 3 condonati. Sarà rilasciato prima dei termini per buona condotta. Ospite della trasmissione televisiva "Su e Giù" condotta in prima serata da Corrado, Sandie Shaw (nota come la "cantante scalza") sfida la censura televisiva sfoggiando una minigonna cortissima durante la sua esibizione.
25 febbraio. La piemontese Sonia Maino sposa a New Delhi Rajiv Gandhi, figlio di Indira. Le nozze saranno celebrate con rito civile, data la differenza di culto tra gli sposi. 3000 invitati prendono parte al ricevimento presso il Ministero degli Esteri. In Parlamento emergono alcuni malumori tra i deputati più tradizionalisti. La protesta degli studenti universitari dilaga in tutti i principali atenei del Paese: A Roma vengono occupati gli istituti di Genetica e Matematica. Contemporaneamente gli studenti di estrema destra dell'organizzazione "La Caravella", l'organo del Fuan romano, organizzano per il giorno successivo una manifestazione contro gli occupanti. La tensione, alla vigilia dei fatti di Valle Giulia, cresce rapidamente. Anche la Facoltà di Lettere di Trieste è occupata da circa 200 studenti, mentre a Pisa la protesta si estende alla Facoltà di Lettere e Filosofia. A Torino nella notte esplode un'altra bomba carta nei pressi dell'abitazione del Rettore Allara.
28 febbraio. A Roma si dimette il Preside della Facoltà di Lettere Alberto Ghisalberti in polemica con il Rettore D'Avack per la chiusura totale di quest'ultimo nei confronti delle richieste degli studenti e delle possibili soluzioni proposte a livello di Facoltà. La manifestazione del Fuan non raggiungerà La Sapienza, ma si fermerà a Palazzo Chigi e sotto le finestre della casa del Rettore in Piazza di Spagna. Interviene la Polizia, 5 fermati.
29 febbraio. Il Ministro degli Esteri Amintore Fanfani in un discorso alla Camera insiste sull'urgenza di negoziati sulla risoluzione del conflitto in Vietnam. Lo stesso Ministro aveva incontrato i rappresentanti nordvietnamiti alla Farnesina nei giorni precedenti, indicando la propria soddisfazione per l'impegno italiano nella difficile mediazione. Il comunista Ingrao spinge sull'acceleratore, invitando Fanfani ad allinearsi ai Paesi scandinavi nella condanna incondizionata dell'azione di bombardamento americana sul Vietnam del Nord. Ancora scontri a Roma tra gli occupanti e gli studenti di estrema destra, che riescono ad entrare nelle aule occupate gettando dalla finestra i volantini e i materassi degli studenti barricati all'interno. Nascono tafferugli con feriti. Intervengono anche i docenti per cercare di calmare gli animi, ma la Facoltà di Giurisprudenza e quella di Scienze Politiche vengono rioccupate la sera stessa. All' Università Statale di Milano un'assemblea decide l'occupazione delle Facoltà di Lettere e Filosofia durante un'assemblea nell'Aula Magna concessa agli studenti dal rettore, il fisico Giovanni Polvani (ex Direttore del CNR classe 1892). Due giorni dopo il matrimonio, Sonia Gandhi tiene gli italiani con il fiato sospeso dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. Si tratterà di un attacco di appendicite.
Marzo 1968
1 marzo. Roma: Battaglia di Valle Giulia. Una parte dei 3.000 studenti di un corteo proveniente da Piazza di Spagna si scontra con la Polizia a protezione della Facoltà di Architettura a Valle Giulia. Seguono due ore di battaglia, con bilancio finale di 197 feriti, di cui 150 membri delle Forze dell'Ordine. Accanto agli studenti di sinistra partecipano agli scontri i giovani di estrema destra di Avanguardia Nazionale e La Caravella.
2 marzo. Al Consolato degli Stati Uniti di Torino esplode un ordigno che fortunatamente non fa vittime. Torna uno stato di relativa calma negli atenei dopo gli scontri di Roma.
4 marzo. Al Madison Square Garden di New York il pugile italiano Nino Benvenuti batte alla terza sfida lo sfidante Emile Griffith, facendo suo il titolo mondiale dei pesi medi. A Milano viene nuovamente occupata l'Università Statale, questa volta senza incidenti.
6 marzo. Finisce ufficialmente la legislatura. Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat inizia le consultazioni in vista dello scioglimento delle Camere. Rimangono da discutere due riforme-chiave: quella dell'Università e quella delle pensioni.
7 marzo. A Milano la protesta studentesca si estende alle scuole superiori. Sono occupati i licei classici Berchet e Parini. In quest'ultimo, dove due anni prima era stato fondato il periodico "La Zanzara" il preside Davide Mattalia solidarizza con gli studenti e viene sospeso dal Provveditore. Il consiglio dei docenti punta il dito contro la Professoressa di italiano Maria Teresa Torre Rossi, che a detta dei colleghi avrebbe "sobillato" gli studenti parlando della Cina di Mao durante le lezioni.
15 marzo. A Praga si suicida il generale Janko, che aveva cercato di rimettere alla guida del paese lo stalinista Novotny. In Russia iniziano i primi lavori che porteranno alla nascita dello stabilimento auto di Togliattigrad, dove la FIAT ha esportato oltrecortina il know-how e la tecnologia per produrre su licenza la "124" che diventerà una delle vetture più diffuse nell'Unione Sovietica. A Varsavia il regime stalinista di Gomulka si prepara a soffocare la protesta degli studenti universitari, diffusa dagli effetti della Cecoslovacchia di Dubcek.
16 marzo. Alla Facoltà di Legge dell'Università di Roma si verificano gravi scontri per intervento di squadre di militanti missini guidati da Giorgio Almirante, che tentano di sgomberare le aule occupate 4 giorni prima dal Movimento Studentesco. Lo scontro è durissimo. Rimane gravemente ferito Oreste Scalzone (frattura di una vertebra dorsale per il lancio di un armadio). Gli assalitori sono estranei al mondo universitario ed arrivano da tutta Italia armati di aste e bastoni. I missini, dopo una violentissima sassaiola si barricano all'interno della Facoltà. Lo stesso Almirante rimarrà contuso negli scontri. Alla fine interviene la Polizia che fa irruzione nelle aule. Viene denunciato il missino Giulio Caradonna. Molti i fermati.
17 marzo. Un articolo comparso sul quotidiano "La Stampa" indica che i consumi degli Italiani sono ancora abbondantemente sotto la media dei paesi industrializzati del mondo occidentale: l'apporto calorico pro capite è di sole 2.750 calorie al giorno, contro le 3.290 del Regno Unito, soprattutto per la povertà della dieta. Si mangiano appena 33 kg. di carne l'anno mentre negli Usa il consumo era di 85 Kg. Gli italiani bevono solo 63 litri di latte l'anno, gli Inglesi 148. Il pasto degli italiani è ancora dominato da farinacei e legumi.
18 marzo. Il Presidente del Consiglio Aldo Moro e il Segretario della Democrazia Cristiana Mariano Rumor parlano a Bologna di fronte ai giovani del partito. Il tema centrale è la protesta nelle Università. Nei confronti delle rivendicazioni dei giovani, Moro esprime apertura, ma solo nel rispetto delle Istituzioni. Rumor invita gli studenti a credere nelle intenzioni programmatiche del centro-sinistra riguardo il sostegno alla riforma universitaria.
19 marzo. Novità nella comunicazione elettorale dei partiti in vista delle politiche 1968. Per la prima volta la multimedialità a servizio della politica. I Repubblicani affidano al regista Ugo Gregoretti i loro spot elettorali, mentre i Socialisti riunificati realizzano un "video-cabaret" elettorale. La DC realizza tre distinti documentari programmatici. Uno di questi è dedicato alla protesta nelle Università italiane.
20 marzo. A Genova si leva la protesta per la candidatura nelle liste del PCI-PSIUP dell'ex partigiano Francesco Moranino "Gemisto", che era stato graziato nel 1965 per gli omicidi compiuti il 26 novembre 1944 a Portula (Biella). Il comandante partigiano aveva assassinato Emanuele Strasserra, genovese, giunto in missione per conto dei Servizi Segreti alleati ed eliminato assieme ad altri 4 compagni di missione.
21 marzo. Tragedia a Genova: sulle alture della città una gigantesca franainveste un palazzo di sei piani in Via Digione. Nonostante gli avvertimenti dei condomini sul pericolo di crolli, la tragedia annunciata avviene dopo 18 giorni di pioggia intensa. I morti saranno 19.
Dopo i fatti di Roma, a Milano riprende l'agitazione nelle Università. Si registrano scontri alla Cattolica, la prima Facoltà d'Italia ad essere occupata nel 1967, dove vengono alle mani i rappresentanti del Movimento Studentesco con gli studenti di "Alleanza Cattolica". Al liceo classico Berchet vengono rubati e bruciati i registri di classe.
22 marzo. Il Presidente Usa Lyndon Johnson annuncia una svolta nella strategia militare in Vietnam con la destituzione del Generale Westmoreland dopo l'offensiva del Tet e lo stallo delle operazioni americane.
26 marzo. Il bandito sardo Graziano Mesina viene arrestato ad un posto di blocco ad Orgosolo. Mesina era evaso nel 1966 dal carcere di Sassari e durante i due anni di latitanza fu autore di ben 7 sequestri di persona. Per un soffio era fuggito ad un'imboscata dove erano rimasti uccisi due agenti di Pubblica Sicurezza. Giuliano Mesina passerà 8 anni in carcere prima di fuggire nuovamente nel 1976.
28 marzo. Unione Sovietica: in un incidente aereo muore l'eroe nazionale Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio nel 1961.
All'Università di Madrid scoppiano violenti scontri tra le forze dell'ordine e gli studenti in lotta, mentre alla Cattolica di Milano gli studenti sperimentano il metodo di protesta non violento dello sciopero della fame. Dopo alcuni giorni di occupazione, la Facoltà di Lettere della Sorbona, a Parigi, viene chiusa per ordine del Rettore. Il Consiglio dei Ministri guidato da Aldo Moro rende noto che il Pil italiano è cresciuto del 5,9% nell'ultimo anno.
30 marzo. Ai cancelli della Fiat Mirafiori ed al Lingotto scoppiano duri scontri ai picchetti in occasione di uno sciopero indetto dai sindacati dei metalmeccanici. Ai cancelli ci sono questa volta anche gli studenti di Palazzo Campana, che al grido di "Viva Mao Tse-Tung" si scontrano violentemente con la Polizia ingaggiando una fitta sassaiola che proseguirà anche per i viali di Torino.
16 giugno 1968. La poesia dell'autore da "Le ceneri di Gramsci.
Il Pci ai giovani. Di Pier Paolo Pasolini.
I versi sugli scontri di Valle Giulia che hanno scatenato dure repliche fra gli studenti.
Mi dispiace. La polemica contro il Pci andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, cari.
Non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati: peggio per voi.
Adesso i giornalisti di tutto il mondo (compresi quelli delle televisioni) vi leccano (come ancora si dice nel linguaggio goliardico) il culo. Io no, cari.
Avete facce di figli di papà.
Vi odio come odio i vostri papà.
Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio cattivo.
Siete pavidi, incerti, disperati (benissimo!) ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati: prerogative piccolo-borghesi, cari.
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti.
Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da subtopie, contadine o urbane che siano.
Quanto a me, conosco assai bene il loro modo di esser stati bambini e ragazzi, le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui, a causa della miseria, che non dà autorità.
La madre incallita come un facchino, o tenera per qualche malattia, come un uccellino;
i tanti fratelli;
la casupola tra gli orti con la salvia rossa (in terreni altrui, lottizzati);
i bassi sulle cloache;
o gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, ecc. ecc.
E poi, guardateli come li vestono: come pagliacci, con quella stoffa ruvida, che puzza di rancio furerie e popolo. Peggio di tutto, naturalmente, è lo stato psicologico cui sono ridotti (per una quarantina di mille lire al mese): senza più sorriso, senza più amicizia col mondo, separati, esclusi (in un tipo d’esclusione che non ha uguali);
umiliati dalla perdita della qualità di uomini per quella di poliziotti (l’essere odiati fa odiare).
Hanno vent’anni, la vostra età, cari e care.
Siamo ovviamente d’accordo contro l’istituzione della polizia.
Ma prendetevela contro la Magistratura, e vedrete!
I ragazzi poliziotti che voi per sacro teppismo (di eletta tradizione risorgimentale) di figli di papà, avete bastonato, appartengono all’altra classe sociale.
A Valle Giulia, ieri, si è così avuto un frammento di lotta di classe: e voi, cari (benché dalla parte della ragione) eravate i ricchi, mentre i poliziotti (che erano dalla parte del torto) erano i poveri. Bella vittoria, dunque, la vostra! In questi casi, ai poliziotti si danno i fiori, cari. Stampa e Corriere della Sera, News- week e Monde vi leccano il culo.
Siete i loro figli, la loro speranza, il loro futuro: se vi rimproverano non si preparano certo a una lotta di classe contro di voi!
Se mai, si tratta di una lotta intestina.
Per chi, intellettuale o operaio, è fuori da questa vostra lotta, è molto divertente la idea che un giovane borghese riempia di botte un vecchio borghese, e che un vecchio borghese mandi in galera un giovane borghese.
Blandamente i tempi di Hitler ritornano: la borghesia ama punirsi con le sue proprie mani.
Chiedo perdono a quei mille o duemila giovani miei fratelli che operano a Trento o a Torino, a Pavia o a Pisa, /a Firenze e un po’ anche a Roma, ma devo dire: il movimento studentesco (?) non frequenta i vangeli la cui lettura i suoi adulatori di mezza età gli attribuiscono per sentirsi giovani e crearsi verginità ricattatrici;
una sola cosa gli studenti realmente conoscono: il moralismo del padre magistrato o professionista, il teppismo conformista del fratello maggiore (naturalmente avviato per la strada del padre), l’odio per la cultura che ha la loro madre, di origini contadine anche se già lontane.
Questo, cari figli, sapete.
E lo applicate attraverso due inderogabili sentimenti: la coscienza dei vostri diritti (si sa, la democrazia prende in considerazione solo voi) e l’aspirazione al potere.
Sì, i vostri orribili slogan vertono sempre sulla presa di potere.
Leggo nelle vostre barbe ambizioni impotenti, nei vostri pallori snobismi disperati, nei vostri occhi sfuggenti dissociazioni sessuali, nella troppa salute prepotenza, nella poca salute disprezzo (solo per quei pochi di voi che vengono dalla borghesia infima, o da qualche famiglia operaia questi difetti hanno qualche nobiltà: conosci te stesso e la scuola di Barbiana!)
Riformisti! Reificatori!
Occupate le università ma dite che la stessa idea venga a dei giovani operai.
E allora: Corriere della Sera e Stampa, Newsweek e Monde avranno tanta sollecitudine nel cercar di comprendere i loro problemi?
La polizia si limiterà a prendere un po’ di botte dentro una fabbrica occupata?
Ma, soprattutto, come potrebbe concedersi un giovane operaio di occupare una fabbrica senza morire di fame dopo tre giorni?
e andate a occupare le università, cari figli, ma date metà dei vostri emolumenti paterni sia pur scarsi a dei giovani operai perché possano occupare, insieme a voi, le loro fabbriche. Mi dispiace.
È un suggerimento banale;
e ricattatorio. Ma soprattutto inutile: perché voi siete borghesi e quindi anticomunisti.
Gli operai, loro, sono rimasti al 1950 e più indietro.
Un’idea archeologica come quella della Resistenza (che andava contestata venti anni fa, e peggio per voi se non eravate ancora nati) alligna ancora nei petti popolari, in periferia.
Sarà che gli operai non parlano né il francese né l’inglese, e solo qualcuno, poveretto, la sera, in cellula, si è dato da fare per imparare un po’ di russo.
Smettetela di pensare ai vostri diritti, smettetela di chiedere il potere.
Un borghese redento deve rinunciare a tutti i suoi diritti, a bandire dalla sua anima, una volta per sempre, l’idea del potere.
Se il Gran Lama sa di essere il Gran Lama vuol dire che non è il Gran Lama (Artaud): quindi, i Maestri - che sapranno sempre di essere Maestri - non saranno mai Maestri: né Gui né voi riuscirete mai a fare dei Maestri.
I Maestri si fanno occupando le Fabbriche non le università: i vostri adulatori (anche Comunisti) non vi dicono la banale verità: che siete una nuova specie idealista di qualunquisti: come i vostri padri, come i vostri padri, ancora, cari! Ecco, gli Americani, vostri odorabili coetanei, coi loro sciocchi fiori, si stanno inventando, loro, un nuovo linguaggio rivoluzionario!
Se lo inventano giorno per giorno!
Ma voi non potete farlo perché in Europa ce n’è già uno: potreste ignorarlo?
Sì, voi volete ignorarlo (con grande soddisfazione del Times e del Tempo).
Lo ignorate andando, con moralismo provinciale, “più a sinistra”.
Strano, abbandonando il linguaggio rivoluzionario del povero, vecchio, togliattiano, ufficiale Partito Comunista, ne avete adottato una variante ereticale ma sulla base del più basso idioma referenziale dei sociologi senza ideologia.
Così parlando, chiedete tutto a parole, mentre, coi fatti, chiedete solo ciò a cui avete diritto (da bravi figli borghesi): una serie di improrogabili riforme l’applicazione di nuovi metodi pedagogici e il rinnovamento di un organismo statale.
I Bravi! Santi sentimenti!
Che la buona stella della borghesia vi assista!
Inebriati dalla vittoria contro i giovanotti della polizia costretti dalla povertà a essere servi, e ubriacati dell’interesse dell’opinione pubblica borghese (con cui voi vi comportate come donne non innamorate, che ignorano e maltrattano lo spasimante ricco) mettete da parte l’unico strumento davvero pericoloso per combattere contro i vostri padri: ossia il comunismo.
Spero che l’abbiate capito che fare del puritanesimo è un modo per impedirsi la noia di un’azione rivoluzionaria vera.
Ma andate, piuttosto, pazzi, ad assalire Federazioni!
Andate a invadere Cellule!
andate ad occupare gli usci del Comitato Centrale: Andate, andate ad accamparvi in Via delle Botteghe Oscure!
Se volete il potere, impadronitevi, almeno, del potere di un Partito che è tuttavia all’opposizione (anche se malconcio, per la presenza di signori in modesto doppiopetto, bocciofili, amanti della litote, borghesi coetanei dei vostri schifosi papà) ed ha come obiettivo teorico la distruzione del Potere.
Che esso si decide a distruggere, intanto, ciò che un borghese ha in sé, dubito molto, anche col vostro apporto, se, come dicevo, buona razza non mente...
Ad ogni modo: il Pci ai giovani, ostia!
Ma, ahi, cosa vi sto suggerendo? Cosa vi sto consigliando? A cosa vi sto sospingendo?
Mi pento, mi pento!
Ho perso la strada che porta al minor male, che Dio mi maledica. Non ascoltatemi.
Ahi, ahi, ahi, ricattato ricattatore, davo fiato alle trombe del buon senso.
Ma, mi son fermato in tempo, salvando insieme, il dualismo fanatico e l’ambiguità...
Ma son giunto sull’orlo della vergogna.
Oh Dio! che debba prendere in considerazione l’eventualità di fare al vostro fianco la Guerra Civile accantonando la mia vecchia idea di Rivoluzione?
Paolo Pietrangeli ricorda la battaglia di 50 anni fa: «Valle Giulia, i sogni, le mattonate». Cantautore-regista, il 1° marzo del ‘68 era lì a fare a botte. I suoi ricordi, il suo bilancio amaro. Giuliano Ferrara era nel Pci e nel Movimento. Scalzone in Svezia per rimorchiare, scrive Fabrizio Paladini l'1 marzo 2018 su "Il Corriere della Sera".
«Il primo marzo/ sì me lo rammento/ saremo stati/ mille e cinquecento».
Chi se lo rammenta è Paolo Pietrangeli, 73 anni, storico regista televisivo del Maurizio Costanzo Show, di Amici, di C’è posta per te. Oggi è anche candidato alle elezioni con Potere al popolo. Suo papà Antonio fu acclamato sceneggiatore e regista di film come Lo scapolo, Io la conoscevo bene. Ma soprattutto Paolo Pietrangeli è conosciuto per le sue canzoni di lotta e di protesta. Contessa, Il vestito di Rossini, Valle Giulia sono pezzi che tra il 1968 e il 1977 hanno cantato tutti quelli che volevano cambiare il mondo. Valle Giulia prende spunto proprio dalla battaglia tra studenti e polizia che esattamente 50 anni fa si scatenò a Villa Borghese, sotto la facoltà di Architettura. «Noi studenti dei licei ci radunammo a piazza di Spagna. L’idea era quella di raggiungere gli universitari per poi occupare Architettura. Feci tutto quel pezzo del corteo con Luciana, che allora era la moglie di Bruno Trentin. Arrivati a Valle Giulia lei sentenziò: Ma cosa vuoi che succeda, sarà tutto tranquillo, ci sono i socialisti al governo. Appena pronunciata quella frase, iniziarono i disordini. C’erano poliziotti e carabinieri dappertutto. Ma all’inizio le cariche erano abbastanza blande».
E poi?
«È accaduto che per la prima volta gli studenti, i figli di papà, non hanno avuto paura e non sono fuggiti. Anzi, hanno reagito».
Eravate armati?
«Sassi presi nelle aiuole e rami spezzati per fare bastoni. Questa fu una cosa nuova che alla Polizia non piacque per nulla. Ci diedero insomma un sacco di botte e moltissimi dei fermati vennero portati nella caserma di via Guido Reni e in Questura dove arrivò la seconda razione».
Lei venne picchiato?
«Io no ma, adesso lo posso confessare tanto dopo 50 anni sarà prescritto: tirai un mattone dall’alto e colpii in testa un agente, uno dei pochi che non aveva l’elmetto. Si sparse la voce che alcuni poliziotti erano gravemente feriti e io mi sentivo un po’ in colpa, mi chiedevo: vuoi vedere che ho fatto male a qualcuno? Pensa un po’ che rivoluzionario irriducibile ero».
E dopo la mattonata che ha fatto?
«Ero lì con la mia fidanzata Grazia, che poi sarebbe diventata la mia prima moglie e madre di mio figlio, che si slogò la caviglia alla prima carica. Non poteva camminare e quindi la misi sulle spalle come un sacco di patate e giù a scappare verso Villa Borghese. Arrivai a casa mezzo morto. Aprii l’acqua bollente e mi feci un bagno caldo».
Al calduccio come i figli di papà che Pier Paolo Pasolini attaccò difendendo i poliziotti figli del popolo?
«Quella poesia mi fece incazzare. Conoscevo Pasolini perché veniva spesso a casa nostra, al quartiere Trieste, per parlare con mio padre di progetti comuni. Ma a differenza di tanti attori e registi che mi salutavano per educazione, affetto o convenienza, lui niente, non diceva nemmeno Ciao. Io aprivo la porta e lui: Dov’è tuo padre? Allora andai da mia madre e le dissi: Mamma, ma chi è quel frocio? Lei mi assestò un salutare sganassone e io imparai la lezione».
Lei già cantava?
«La prima chitarra me la regalò mio padre, alla fine degli anni Cinquanta. Fu Dario Fo che veniva sempre ospite da noi a dire a papà: Paolo ha una bella voce, compragli una chitarra. Iniziai con le filastrocche. In verità non ho mai scritto canzoni, ma solo raccontato fatti con un po’ di musica».
I leader del movimento studentesco li conosceva?
«Con Giuliano Ferrara stavamo tutti e due nel Pci e, un po’ di nascosto, nel Movimento che il partito non vedeva di buon occhio. Oreste Scalzone era da poco tornato dalla Svezia dove - secondo me - era andato per rimorchiare. Franco Piperno era più grande e faceva il capetto. Poi c’erano gli Uccelli e io li detestavo. Una volta andarono a casa dello sceneggiatore Franco Solinas e gli riempirono la casa di escrementi perché lui era ricco e comunista».
Fantasia al potere?
«Durante le occupazioni si organizzavano corsi alternativi. Io proponevo cose tipo Studiare meglio il latino o I nuovi percorsi di filologia romanza e non partecipava nessuno, mentre c’erano quelli sul sesso libero che erano sempre pieni. Del resto, questo è il mio destino: ogni volta che mi piace qualcosa state sicuri che sarà un clamoroso insuccesso».
Di questo ‘68 che è rimasto?
«Eravamo sicuri, che fosse l’alba, che poi sarebbe tutto cambiato. Invece non era l’alba ma il tramonto. Lo spiraglio che avevamo visto non si stava aprendo ma chiudendo. L’industria culturale, per prima, sigillò tutto. Il peso fu opprimente, poi arrivò la violenza degli anni 70».
Il sogno ha lasciato qualche segno?
«Qualche segno e molte sconfitte. Non si è realizzato nessun sogno né personalmente né collettivamente. Ma ha lasciato molte amicizie e un modo di sentire comune. Ma se ancora oggi, 50 anni dopo, stiamo a discutere di colore della pelle, mi viene da piangere».
1968, Valle Giulia non è che il debutto, scrive Paolo Delgado l'1 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Ogni movimento ha bisogno di una sua mitologia. Nel movimento che spazzò l’Italia per dieci anni il capitolo eroico di quella ricostruzione non priva di verità ma neppure di agiografia fu il primo marzo 1968: “la battaglia di valle Giulia”. Ogni movimento ha bisogno di una sua mitologia, deve attrezzare il suo proprio calendario, celebrare ricorrenze, allestire liturgie. Nel movimento che spazzò l’Italia per dieci anni e passa mezzo secolo fa il capitolo eroico di quella ricostruzione non priva di verità ma neppure di agiografia fu il primo marzo 1968, il battesimo del fuoco fu “la battaglia di valle Giulia”. La chiamarono così i giornali del Pci, L’Unità, uscito in edizione straordinaria quando per le strade di Roma ancora risuonavano le sirene della polizia e le celle di San Vitale erano ancora piene di studenti fermato negli scontro della mattinata, di fronte alla facoltà di Architettura, e Paese Sera, che usciva di norma tre volte al giorno e non ebbe quindi bisogno di forzare le rotative con un’edizione speciale. Anni dopo, ripercorrendo i fatti, Oreste Scalzone, all’epoca uno dei principali leader del movimento studentesco nella capitale, avrebbe adoperati toni dissacranti, segnalando che in fondo la battaglia era stata poca cosa, soprattutto se paragonata a quel che sarebbe poi esploso nelle strade di tutta Italia: «Un’ora scarsa di lanci di sassi e qualche carica contro la polizia. Cosa anche questa modesta ma che ebbe grande impatto». La narrazione epica in voga negli anni ‘ 70, costruita sulle note della celebre canzone dedicata alla “battaglia” da Paolo Pietrangeli era probabilmente esagerata. La minimizzazione di Scalzone lo è altrettanto. In quella assolata mattina di tardo inverno romano si produsse davvero una lacerazione, quegli scontri durati un paio d’ore nei prati intorno a Valle Giulia segnarono davvero uno scarto, un passaggio d fase, un salto di qualità. In un certo senso non è esagerato dire che il ‘ 68 cominciò quel giorno. Nell’università di Roma, la più grande d’Italia, la mobilitazione studentesca iniziata nel novembre 1967 a Torino, nella sede delle facoltà umanistiche di Palazzo Campana, e poi dilagata quasi ovunque era arrivata tardi. Mentre le cronache degli sgombri delle facoltà occupate da parte della polizia e delle nuove occupazioni diventavano quotidiane alla Sapienza e nelle facoltà aldi fuori della città universitaria, tra le quali Architettura, non si muoveva una foglia. L’onda d’urto arrivò solo il 2 febbraio ‘ 68, con l’occupazione di Lettere e poi, una via l’altra di tutte le altre facoltà. L’occupazione si prolungò per un mese esatto, poi il rettore D’Avack si decise a chiedere l’intervento della polizia, o meglio a consentirlo perché una circolare ministeriale diramata dopo le prime occupazioni aveva chiarito che a decidere sarebbe stata la forza pubblica salvo esplicito parere contrario dei rettori. Anno bisestile: l’università fu sgombrata il 29 febbraio. Una manifestazione di protesta organizzata dagli ormai ex occupanti fu caricata nel pomeriggio. Gli studenti si riunirono in serata nella sede della Federazione del Pci, in via dei Frentani, e convocarono una nuova manifestazione per la mattina seguente, con partenza da piazza di Spagna. Non era la prima volta che i manganelli della celere si abbattevano sulla testa degli studenti. Ai tempi erano corti e tozzi e gli agenti non disponevano dell’armamentario che gli sarebbe stato assegnato in dotazione l’anno seguente, insieme ai nuovi manganelli lunghi: gli scudi in plexiglas, le visiere, l’incentivo ad adoperare senza parsimonia i candelotti lacrimogeni. Pur peggio armati, si erano dati da fare più volte. A Palazzo Campana lo sgombro seguito da immediata rioccupazione e nuova irruzione degli agenti, in una catena infinita, era diventato quasi un rituale. La carica sui cortei di protesta degli sloggiati era altrettanto puntuale, prevedibile, prevista. A Valle Giulia successe però l’imprevedibile. Gli studenti reagirono, contrattaccarono, scoprirono che strade e parati erano pieni di “armi improprie” e le usarono. Aveva cominciato Massimiliano Fuksas, un passato da giovane neofascista spostatosi a sinistra alle spalle, un futuro da archistar di fronte, ancora avvolto nelle Nuvole. Ben piazzato, provò a forzare il blocco della polizia sulla porta della facoltà da solo poco prima che il corteo in arrivo da piazza di Spagna, qualche migliaio di studenti tra cui molti medi, raggiungesse la scalinata della facoltà. A riguardare oggi le istantanee di quella non oceanica manifestazione sembra di assistere a un inedito reality: il corteo dei famosi. Immortalato Giuliano Ferrara, che si prese la sua dose di botte, poi sparsi qua e là per il grande piazzale di Valle Giulia, Enrica Bonaccorti, Paolo Liguori, o come si chiamava ai tempi “Straccio”, con i capelli lunghissimi, un paolo Mieli appena meno compassato, Ernesto Galli della Loggia, sì sì proprio il futuro editorialista del Corrierone, un Antonello Venditti in anticipo sui primi accordi, Renato Nicolini, già leader di un’associazione goliardica vicina al Pci, Paolo Flores d’Arcais. Già innervositi gli agenti ordinarono la carica quasi subito, al primo lancio di sassi e uova. Per quanto negato in seguito per anni, a reggere il primo l’urto furono i fascisti. Caravella, l’associazione studentesca di estrema destra a stretta egemonia Avanguardia nazionale c’era tutta: Stefano Delle Chiaie, Guido Paglia, Adriano Tilgher, Mario Merlino. Quanto a scontri frontali erano più addestrati dei rossi: tennero la linea. La loro presenza fu cancellata peggio che nelle fotografie sovietiche dei funerali di Lenin per decenni. Riconoscere che a valle Giulia i fascisti non solo c’erano, ma erano pure in prima fila nella battaglia sarebbe stato poco conciliabile con la liturgia del caso. Ma anche il Movimento, la sera prima, aveva deciso di non limitarsi alla fuga e alla resistenza passiva. Arretrati in un primo momento rispetto ai fascisti, si lanciarono poi in una carica contro i caricanti che lasciò davvero tutti sbigottiti. Quando mai si erano visti gli studenti, mica portuali come quelli del ‘ 60 a Genova, oppure operaiacci come quelli di piazza Statuto a Torino nel ‘ 62, caricare gli agenti, usare rami e bastoni contro i gipponi, tenere botta di fronte alle cariche? Ancora quella mattina gli striscioni del corteo in marcia verso valle Giulia esaltavano il “Potere studentesco”. Il Movimento bersagliava l’università, le baronie, l’autoritarismo accademico e poi, di conseguenza, la struttura complessiva del sistema. Da Valle Giulia in poi dall’altra parte della barricata ci fu direttamente lo Stato.
Il 68 ci ha rubato il futuro, scrive il 27 febbraio 2018 Francesco Giubilei su "Il Giornale". Il 1 marzo ricorrono i cinquant’anni dagli scontri di Valle Giulia a Roma, un evento che ha segnato simbolicamente l’avvento del Sessantotto nel nostro paese. Le proteste sessantottine demoliscono i valori su cui si è fondata l’Italia fino a quel momento compiendo un attacco ai due elementi cardine della società: la famiglia e la scuola. Come scrive Marcello Veneziani su “Il Giornale” di domenica: “la rivolta del ’68 ebbe un Nemico Assoluto, il Padre […] ogni autorità perse autorevolezza e credibilità”. La delegittimazione del ruolo del padre si accompagna a un attacco tout court alla famiglia attraverso temi considerati un tabù (l’aborto, il divorzio, la liberazione sessuale). Le conseguenze più funeste del Sessantotto avvengono nel mondo della scuola e dell’università dove il concetto del sei politico diventa una prassi che si è tramandata fino ai nostri giorni con l’abbassamento complessivo sia della preparazione del corpo docenti che degli studenti. Il Sessantotto si fonda infatti sul grande equivoco dell’egualitarismo: tutti dobbiamo avere le stesse opportunità di partenza ma se una persona è più meritevole di un’altra va premiata. Più in generale è stata tutta la società ad essere sovvertita: il Sessantotto ci ha fatto scoprire i diritti ma dimenticare i doveri. Le regole vengono concepite come un qualcosa di cui si può fare a meno, una mentalità sintetizzata dallo slogan “vietato vietare”. Anche sul piano culturale le conseguenze del Sessantotto sono nefaste perché si crea un clima di conformismo dilagante: chi non la pensa come la maggioranza e non si omologa al pensiero dominante viene emarginato, escluso e ghettizzato suscitando un odio che sfocerà nei terribili anni di piombo. Un pensiero caratterizzato dal predominio del politicamente corretto di cui, non a caso, la nostra società è figlia ed è proprio negli anni successivi al Sessantotto che il concetto gramsciano di egemonia culturale si realizza a pieno titolo nel mondo della scuola, dell’università e della cultura portando l’ideologia nei libri di testo e orientando i programmi scolastici in senso progressista, in particolare nella filosofia, nella storia e letteratura. Ma soprattutto, e mi rivolgo in particolare ai miei coetanei, ai giovani nati e cresciuti nell’Italia postsessantottina, il Sessantotto ci ha rubato il futuro. La società in cui viviamo è figlia delle proteste studentesche, la classe dirigente che ci ha governato negli ultimi anni con risultati fallimentari si è formata nella scuola sessantottina. Nell’illusione di volere sempre più diritti ci siamo ritrovati a non averne più. Così, nell’Italia del 2018, il vero rivoluzionario è chi si oppone ai principi sessantottini e lotta per una società fondata sul merito, il rispetto delle regole e dell’autorità.
La battaglia di Valle Giulia 50 anni dopo, scrive Edoardo Frittoli il 28 febbraio 2018 su "Panorama". Tutto cominciò a causa dell'altissima tensione seguita allo sgombero della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma, a Valle Giulia. Il palazzo era rimasto occupato per quasi un mese dagli studenti in lotta e il 29 febbraio 1968 il Rettore Pietro Agostino D'Avack aveva deciso di richiedere l'intervento della forza pubblica per procedere allo sgombero. La decisione era giunta mentre le occupazioni degli Atenei italiani si erano moltiplicate, così come era cresciuta l'ostilità tra gli studenti in agitazione e quelli contrari all'occupazione. Durante quei giorni di massima tensione, il quadro della protesta universitaria aveva raggiunto l'apice di ben 25 Università occupate, da Trento a Palermo. Iniziamo dalle ore immediatamente precedenti la battaglia più famosa della storia della contestazione studentesca.
Università degli Studi di Milano, mattina del 29 febbraio 1968. Botte, sassi, vetri infranti, idranti antincendio in azione in Via Festa del Perdono di fronte ai portoni d'ingresso delle Facoltà di Lettere e Giurisprudenza. Niente polizia questa volta: lo scontro si consuma tra occupanti di Lettere e Filosofia e rappresentanti di destra giunti dalla Facoltà di Giurisprudenza contrari all'occupazione decisa il giorno prima nell'Aula Magna della Statale. Gli studenti di legge si presentano di fronte ai picchetti d'ingresso e comincia lo scontro fisico, dilagato anche nelle vie adiacenti l'Università tanto da indurre i negozianti ad abbassare le saracinesche. La guerriglia prosegue con gli occupanti che usano gli idranti antincendio per respingere i "fascisti", che inizialmente arretrano ma alla fine riescono a sfondare con blocchi di cemento un ingresso secondario. Si teme il peggio, ma in realtà il contatto non avviene e gli studenti di destra si rinchiudono in un'aula separati dai loro avversari.
Città Universitaria di Roma, 29 febbraio 1968. Molto diversa e sicuramente più drammatica la situazione a Roma: lo sgombero si era consumato come richiesto dal Rettore, ed aveva coinvolto un ingentissimo numero di agenti tra Polizia e Carabinieri in assetto da guerriglia. Guidati da ben 30 funzionari si presentarono 1.500 uomini alle porte delle Facoltà occupate, procedendo allo sgombero forzato delle Facoltà di Scienze Politiche, Lettere e Giurisprudenza, con il Vicequestore Prudenza che, a bordo di una camionetta, intimava con il megafono la resa agli occupanti. Assieme alle forze dell'ordine, quella mattina di 50 anni fa, erano presenti anche gli studenti di destra di "Primula Goliardica" e "La Caravella", armati di bastoni e catene. Verso la fine della giornata sono sgomberate anche le Facoltà di Lettere e Architettura, dove vengono posti in stato di fermo oltre 80 studenti. Con i portoni chiusi dai catenacci messi dalle forze dell'ordine, un corteo di studenti si dirige verso il centro della Capitale. Imboccata via Nazionale vengono a contatto con gli agenti che caricano e lanciano le jeep della Celere nei consueti caroselli. Uno studente rimane ferito dopo essere stato investito e alla fine della giornata si conteranno 10 persone in ospedale tra studenti, passanti e forze dell'ordine.
La battaglia di Valle Giulia: Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma: 1 marzo 1968. Il giorno dopo gli sgomberi voluti dal Rettore D'Avack, sulle scalinate di Architettura a Valle Giulia stazionano 150 agenti a protezione del portone d'ingresso. Come ricordato sopra, gli studenti (circa 3.000) arrivarono in corteo provenienti da Piazza di Spagna, dividendosi in due. Una parte dei manifestanti piegò verso la Città universitaria mentre il grosso del corteo si diresse dritto verso Architettura a Valle Giulia, la Facoltà più isolata. Con gli studenti di sinistra sfilarono quel giorno anche i rappresentanti dei movimenti di estrema destra Avanguardia Nazionale e La Caravella, in virtù di un accordo di non-provocazione tra le due fazioni studentesche. Tra i neofascisti decisi a combattere per cambiare l'Università "dei borghesi" nomi di primissimo piano della galassia nera come Stefano Delle Chiaie, Adriano Tilgher, Mario Merlino, Giulio Caradonna. Tra i rappresentanti del movimento studentesco che diventeranno personaggi preminenti nella storia futura d'Italia Giuliano Ferrara, Ernesto Galli della Loggia, Paolo Liguori, Aldo Brandirali, Oreste Scalzone. Davanti alle gradinate di Architettura la scintilla dello scontro alimentata dal lancio di uova, dagli slogan e dalle provocazione tra le due parti, scocca quasi subito. Partono le prime cariche della Polizia, ma gli studenti questa volta fanno sul serio. Inizia la fitta sassaiola sul piazzale antistante la Facoltà; due auto e un pullman della Celere vengono dati alle fiamme per impedire lo sfondamento da parte delle forze dell'ordine. Cadono i primi feriti e la superiorità numerica dagli studenti provoca l'arretramento dei cordoni di Polizia. Alcuni manifestanti riescono ad impadronirsi di 5 pistole sottratte ai funzionari, la situazione degenera. La Polizia carica anche con i cavalli cercando di rispondere alla forza degli studenti che dopo oltre 2 ore di violenti scontri riescono a penetrare all'interno di Architettura, proprio mentre arrivano i rinforzi di Polizia con gli idranti a schiuma e i lacrimogeni. Gli studenti di estrema destra riusciranno ad entrare nelle aule di Giurisprudenza. Sono rimasti sul campo 197 feriti, un bilancio da guerriglia urbana. Di questi ben 150 fanno parte delle forze dell'ordine, tra i quali figura anche il Vicequestore Provenza, colpito da una pietra scagliata dagli studenti.
Dalle fratture traumatiche alla frattura politica. Pasolini, Il PCI e il MSI dopo la battaglia. La Polizia riuscirà a riprendere il controllo della piazza solo con l'intervento degli idranti e con un fitto lancio di lacrimogeni, procedendo al fermo ed all'arresto dei manifestanti fino a tarda notte. La scarpata erbosa di fronte al palazzo rossiccio della Facoltà di Giurisprudenza mostrava i segni della lunga battaglia tra gli universitari e i poliziotti, che Pasolini difenderà all'indomani degli scontri identificando i figli di quei "contadini del mezzogiorno" come veri rappresentanti del proletariato, assaliti con violenza dai figli privilegiati dei borghesi. Valle Giulia rappresenterà una cesura definitiva tra gli studenti e i partiti politici di riferimento, sia a destra che a sinistra. Il Partito Comunista non intendeva assecondare lo spontaneismo e i miti stranieri (Mao e Che Guevara) fuori dai canoni interni e ai diktat della dirigenza, procedendo nei mesi seguenti a numerose espulsioni dalle proprie organizzazioni giovanili. Dall'altra parte la frattura è netta anche tra il Movimento Sociale Italiano e l'azione rivoluzionaria di giovani neofascisti dei primi movimenti extraparlamentari che caratterizzeranno il decennio successivo. Arturo Michelini, allora segretario missino, prese immediatamente le distanze di chi aveva combattuto a fianco dei "rossi", anche per il pericolo che queste azioni "di squadra" potessero influenzare negativamente il tentativo da parte della dirigenza del partito di rientrare gradualmente nell'arco costituzionale. Questa frattura sarà così profonda da spingere Michelini all'organizzazione di una "forza a difesa dell'ordine" che due settimane dopo gli scontri di Valle Giulia intervenne con la forza contro gli studenti che avevano di nuovo occupato, guidata da Giorgio Almirante.
L'impatto di Valle Giulia in Parlamento. Poco dopo la fine degli scontri parlò il Ministro dell'Interno, il democristiano Paolo Emilio Taviani. Rivolgendosi alla Camera dei Deputati il ministro difende a spada tratta l'operato della Polizia in difesa delle istituzioni dell'Italia democratica in senso ampio. Nel suo discorso rievoca la debolezza della forza pubblica ricordando la debolezza mostrata in occasione della Marcia su Roma e dall'opportunità lasciata al fascismo in quell'occasione. Fu interrotto dal deputato comunista Bronzuto, che apostrofò i membri del Governo come una "manica di fascisti" per la brutalità dell'intervento della forza pubblica. I missini si univano alle proteste in aula ed a riportare la calma toccherà ad uno dei protagonisti storici dell'antifascismo italiano, l'allora Vicepresidente della Camera Sandro Pertini. Chiamato in causa, il Ministro dell'Istruzione Luigi Gui metteva le mani avanti affermando che la riforma dell'Università (ancora da discutere e approvare) avrebbe certamente incluso una rappresentanza dei collettivi degli studenti. Mentre le urla e le accuse dei rappresentanti in Parlamento si spegnevano a fatica, i comitati studenteschi si davano appuntamento per una nuova manifestazione a Piazza del Popolo, che si svolgerà il giorno seguente gli scontri di Valle Giulia senza registrare particolari incidenti. Anche a Milano, al di là di qualche tafferuglio alla Statale tra studenti di destra e sinistra, sembrò tornare la calma alimentata dalla pausa del Carnevale ambrosiano. Tregua che naturalmente non durerà a lungo.
I dieci danni che ci lasciò il '68. Mezzo secolo fa l'arroganza del (presunto) contropotere generò la dittatura chiamata "politicamente corretto", scrive Marcello Veneziani, Domenica 25/02/2018, su "Il Giornale". Sono passati cinquant'anni dal '68 ma gli effetti di quella nube tossica così mitizzata si vedono ancora. Li riassumo in dieci eredità che sono poi il referto del nostro oggi.
SFASCISTA. Per cominciare, il '68 lasciò una formidabile carica distruttiva: l'ebbrezza di demolire o cupio dissolvi, il pensiero negativo, il desiderio di decostruire, il Gran Rifiuto. Basta, No, fuori, via, anti, rabbia, contro, furono le parole chiave, esclamative dell'epoca. Il potere destituente. Non a caso si chiamò Contestazione globale perché fu la globalizzazione destruens, l'affermazione di sé tramite la negazione del contesto, del sistema, delle istituzioni, dell'arte e della storia. Lo sfascismo diventò poi il nuovo collante sociale in forma di protesta, imprecazione, invettiva, e infine di antipolitica. Viviamo tra le macerie dello sfascismo.
PARRICIDA. La rivolta del '68 ebbe un Nemico Assoluto, il Padre. Inteso come pater familias, come patriarcato, come patria, come Santo Padre, come Padrone, come docente, come autorità. Il '68 fu il movimento del parricidio gioioso, la festa per l'uccisione simbolica del padre e di chi ne fa le veci. Ogni autorità perse autorevolezza e credibilità, l'educazione fu rigettata come costrizione, la tradizione fu respinta come mistificazione, la vecchiaia fu ridicolizzata come rancida e retrò, il vecchio perse aura e rispetto e si fece ingombro, intralcio, ramo secco. Grottesca eredità se si considera che oggi viviamo in una società di vecchi. Il giovanilismo di allora era comprensibile, il giovanilismo in una società anziana è ridicolo e penoso nel suo autolesionismo e nei suoi camuffamenti.
INFANTILE. Di contro, il '68 scatenò la sindrome del Bambino Perenne, giocoso e irresponsabile. Che nel nome della sua creatività e del suo genio, decretato per autoacclamazione, rifiuta le responsabilità del futuro, oltre che quelle del passato. La società senza padre diventò società senza figli; ecco la generazione dei figli permanenti, autocreati e autogestiti che non abdicano alla loro adolescenza per far spazio ai bambini veri. Peter Pan si fa egocentrico e narcisista. Il collettivismo originario del '68 diventò soggettivismo puerile, emozionale con relativo culto dell'Io. La denatalità, l'aborto e l'oltraggio alla vecchiaia trovano qui il loro alibi.
ARROGANTE. Che fa rima con ignorante. Ognuno in virtù della sua età e del suo ruolo di Contestatore si sentiva in diritto di giudicare il mondo e il sapere, nel nome di un'ignoranza costituente, rivoluzionaria. Il '68 sciolse il nesso tra diritti e doveri, tra desideri e sacrifici, tra libertà e limiti, tra meriti e risultati, tra responsabilità e potere, oltre che tra giovani e vecchi, tra sesso e procreazione, tra storia e natura, tra l'ebbrezza effimera della rottura e la gioia delle cose durevoli.
ESTREMISTA. Dopo il '68 vennero gli anni di piombo, le violenze, il terrorismo. Non fu uno sbocco automatico e globale del '68 ma uno dei suoi esiti più significativi. L'arroganza di quel clima si cristallizzò in prevaricazione e aggressione verso chi non si conformava al nuovo conformismo radicale. Dal '68 derivò l'onda estremista che si abbeverò di modelli esotici: la Cina di Mao, il Vietnam di Ho-Chi-Minh, la Cuba di Castro e Che Guevara, l'Africa e il Black power. Il '68 fu la scuola dell'obbligo della rivolta; poi i più decisi scelsero i licei della violenza, fino al master in terrorismo. Il '68 non lasciò eventi memorabili ma avvelenò il clima, non produsse rivoluzioni politiche o economiche ma mutazioni di costume e di mentalità.
TOSSICO. Un altro versante del '68 preferì alle canne fumanti delle P38 le canne fumate e anche peggio. Ai carnivori della violenza politica si affiancarono così gli erbivori della droga. Il filone hippy e la cultura radical, preesistenti al '68, si incontrarono con l'onda permissiva e trasgressiva del Movimento e prese fuoco con l'hashish, l'lsd e altri allucinogeni. Lasciò una lunga scia di disadattati, dipendenti, disperati. L'ideologia notturna del '68 fu dionisiaca, fondata sulla libertà sfrenata, sulla trasgressione illimitata, sul bere, fumare, bucarsi, far notte e sesso libero. Anche questo non fu l'esito principale del '68 ma una diramazione minore o uscita laterale.
CONFORMISTA. L'esito principale del '68, la sua eredità maggiore, fu l'affermazione dello spirito radical, cinico e neoborghese. Il '68 si era presentato come rivoluzione antiborghese e anticapitalista ma alla fine lavorò al servizio della nuova borghesia, non più familista, cristiana e patriottica, e del nuovo capitale globale, finanziario. Attaccarono la tradizione che non era alleata del potere capitalistico ma era l'ultimo argine al suo dilagare. Così i credenti, i connazionali, i cittadini furono ridotti a consumatori, gaudenti e single. Il '68 spostò la rivoluzione sul privato, nella sfera sessuale e famigliare, nei rapporti tra le generazioni, nel lessico e nei costumi.
RIDUTTIVO. Il '68 trascinò ogni storia, religione, scienza e pensiero nel tribunale del presente. Tutto venne ridotto all'attualità, perfino i classici venivano rigettati o accettati se attualizzabili, se parlavano al presente in modo adeguato. Era l'unico criterio di valore. Questa gigantesca riduzione all'attualità, alterata dalle lenti ideologiche, ha generato il presentismo, la rimozione della storia, la dimenticanza del passato; e poi la perdita del futuro, nel culto immediato dell'odierno, tribunale supremo per giudicare ogni tempo, ogni evento e ogni storia.
NEOBIGOTTO. Conseguenza diretta fu la nascita e lo sviluppo del Politically correct, il bigottismo radical e progressista a tutela dei nuovi totem e dei nuovi tabù. Antifascismo, antirazzismo, antisessismo, tutela di gay, neri, svantaggiati. Il '68 era nato come rivolta contro l'ipocrisia parruccona dei benpensanti per un linguaggio franco e sboccato; ma col lessico politicamente corretto trionfò la nuova ipocrisia. Fallita la rivoluzione sociale, il '68 ripiegò sulla rivoluzione lessicale: non potendo cambiare la realtà e la natura ne cambiò i nomi, occultò la realtà o la vide sotto un altro punto di vista. Fallita l'etica si rivalsero sull'etichetta. Il p.c. è il rococò del '68.
SMISURATO. Cosa lascia infine il '68? L'apologia dello sconfinamento in ogni campo. Sconfinano i popoli, i sessi, i luoghi. Si rompono gli argini, si perdono i limiti e le frontiere, il senso della misura e della norma, unica garanzia che la libertà non sconfini nel caos, la mia sfera invade la tua. Lo sconfinamento, che i greci temevano come hybris, la passione per l'illimitato, per la mutazione incessante; la natura soggiace ai desideri, la realtà stuprata dall'utopia, il sogno e la fantasia che pretendono di cancellare la vita vera e le sue imperfezioni... Questi sono i danni (e altri ce ne sarebbero), ma non ci sono pregi, eredità positive del '68? Certo, le conquiste femminili, i diritti civili e del lavoro, la sensibilità ambientale, l'effervescenza del clima e altro... Ma i pregi ve li diranno in tanti. Io vi ho raccontato l'altra faccia in ombra del '68. Noi, per dirla con un autore che piaceva ai sessantottini, Bertolt Brecht, ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati. Alla fine, i trasgressivi siamo noi.
Marcello Veneziani Editorialista del Tempo, sul '68 ha scritto Rovesciare il '68 (Mondadori, anche in Oscar, 2008)
«Così noi Uccelli occupammo la cupola del Borromini e iniziò il sessantotto», scrive Simona Musco il 20 Febbraio 2018 su "Il Dubbio". Paolo Ramundo era il leader degli “Uccelli”, che organizzarono il blitz a Sant’Ivo alla Sapienza. Diciannove febbraio 1968: tre studenti di architettura occupano il campanile di Sant’Ivo alla Sapienza a Roma. Sono gli “Uccelli” Paolo Ramundo, Gianfranco Moltedo e Martino Branca, all’epoca 26enni, coloro che portano gli studenti fuori dalle aule, liberandoli dalle discussioni fini a se stesse e dando di fatto via al ‘ 68. «Volevamo prenderci i luoghi guardando al presente. La nostra fu una rivoluzione culturale», racconta al Dubbio Ramundo.
Come nascono gli “Uccelli”?
«C’eravamo incontrati a capodanno, a una festa sulla Flaminia. Abbiamo continuato a frequentarci, vedendoci spesso in facoltà. Allora c’erano già delle presenze assembleari e la cosa ci coinvolgeva, ma avevamo una notevole autonomia rispetto a come venivano presentati nelle assemblee il movimento e la lotta degli studenti. Sentivamo che era un tema importante, però non ci piaceva che gli studenti stessero lì seduti ad ascoltare sempre le stesse persone, che facevano le loro riflessioni e rimandavano alla prossima assemblea. Era una cosa legata a un futuro ideologico e lontano. A noi interessava che questa agitazione spingesse gli studenti a prendersi i luoghi che in quel momento avevano vissuto in modo convenzionale e a saperli usare. Per noi si doveva fare già subito. Così, quando si parlava troppo, noi protestavamo fischiando e salendo sugli alberi. Così ci hanno dato questo soprannome. Ci chiamavano hippie: avevamo i capelli lunghissimi, mentre gli altri erano tutti più convenzionali, legati al ceto medio-alto».
Come nasce l’occupazione del campanile?
«Avevo seguito molto Paolo Portoghesi, grande studioso del Barocco, di Borromini e dell’architettura innovativa del 600. Conoscevamo quindi bene Sant’Ivo, prima sede universitaria della città. Quando ci fu un dissenso con alcuni leader del movimento, che ci fecero cacciare dalla facoltà, pensammo: siamo cacciati fuori, facciamo uscire anche gli altri studenti. Così andammo da Portoghesi, che in quel periodo faceva dei sopralluoghi con gli studenti a Sant’Ivo e accettò di portarci a visitare il luogo».
Senza sapere quale fosse la vostra intenzione.
«Esatto. Volevamo essere rilevanti, non semplicemente vederlo. Volevamo suscitasse attenzione da parte degli studenti e dei cittadini. Portoghesi ci fece salire fino alla guglia: il posto era straordinario. Appena arrivati disse: “allora, scendiamo?”. Ma noi dicemmo no, vogliamo che questo luogo, che era stato archiviato, venga completamente valorizzato, conosciuto e vissuto. Lui rimase sbalordito».
Come passaste quella notte?
«Faceva freddissimo. Rimanemmo fino al pomeriggio del 20. Gli studenti di tutte le facoltà vennero lì, in piazza Sant’Eustachio e corso Rinascimento, e si misero a cantare e ballare con le fiaccole. Era un momento di grande soddisfazione: per la prima volta giovani studenti fecero un’iniziativa nella città».
Quindi si può dire che avete dato inizio al ‘ 68?
«Sì. Iniziò così, con questa tensione verso l’importanza di essere presenti all’interno della società e conoscere le nostre aspettative, le condizioni che criticavamo e volevamo cambiare. Che poi sono tutte cambiate, perché il ‘ 68 ha generato un grande movimento di cambiamento. Noi dicevamo: non dobbiamo parlare di un futuro lontano, dobbiamo parlare subito di tutte le situazioni di cui ci vogliamo occupare, per far sì che ci sia subito un processo di cambiamento democratico dal basso».
Quali erano le questioni che vi stavano più a cuore?
«I processi relativi all’urbanistica, l’architettura, l’arte: dovevano essere super partecipati e democraticamente collegati alla società in cui ci trovavamo. Bisogna- va smettere di pensare alla divisione del lavoro e alle tendenze autoritarie. Tutto doveva diventare fortemente democratico. C’erano tanti temi sulle procedure con cui fare delle scelte, l’importanza della relazione tra le persone. L’architetto, ad esempio, non poteva stare da solo in dipendenza di un costruttore, ma doveva essere prima di tutto in relazione con le finalità di quello che veniva programmato. Se si doveva fare una scuola si doveva coinvolgere direttamente i cittadini su come farla, dove collocarla. Prima tutto veniva imposto dall’alto, quindi i processi democratici erano assolutamente da sviluppare. Le donne, ad esempio, che in università avevano un ruolo subalterno ai maschi, dovevano rivendicare la loro autonomia, tant’è vero che da quelle tensioni nacque il movimento femminista per affrontare i diritti che erano scritti sulle nostre normative costituzionali, ma non erano messi in pratica».
Qualche giorno dopo ci fu Valle Giulia. Quale fu il vostro contributo?
«Sicuramente abbiamo generato quella iniziativa. Siccome la facoltà di architettura era stata chiusa dal governo autoritario accademico, con la polizia a controllare l’accesso, gli studenti ti avevano organizzato un corteo da piazza di Spagna fino a via Gramsci, dove c’era la sede della facoltà. Non avevano programmato di fare guerriglia, si erano semplicemente dati appuntamento per marciare e reclamarne l’apertura. Ma all’interno del movimento c’erano dei provocatori. Qualcuno andò a bruciare una macchina della polizia e si creò uno stato di tensione che portò a corse lungo le discese di villa Valle Giulia, inseguimenti, spinte, botte, calci. Ma fu una cosa generata dall’autoritarismo del rettore».
E gli “Uccelli” cosa fecero?
«Stavamo in facoltà, avevamo delle pecore con noi, comprate con il contributo di alcuni intellettuali con lo scopo di sottolineare l’importanza del verde, degli spazi non costruiti, la cosiddetta agropoli. Quando cominciarono queste corse ci allontanammo e i carabinieri ci fecero passare. Il giorno dopo sacrificammo una pecora sull’altare della pace, un gesto simbolico per purificare da quella violenza, che era nata dall’autoritarismo. La strada, però, non era quella della violenza, ma era legata alla partecipazione, al coinvolgimento, alla relazione con le forze politiche, per fare sì che ci fossero dei cambiamenti, non per limitarci a fare qualche scazzottata».
Cosa accadde dopo?
«Abbiamo continuato ad essere presenti: facemmo un disegno sulla facoltà con Guttuso perché volevamo appropriarci dei luoghi in cui studiavamo. Non potevamo essere marginali e passivi, dovevamo metterci in relazione col mondo culturale e interessarlo al movimento dei giovani. Era la prima volta che a fare qualcosa non erano le categorie sociali ma i giovani. E questa è stata la nostra grande conquista».
Quando il Sessantotto finì nelle ideologie, risponde Aldo Cazzullo il 7 febbraio 2018 su "Il Corriere della Sera". Caro Aldo, già cominciano le rievocazioni. Ma ha ancora senso processare il ‘68? Filiberto Piccini, Pisa.
Caro Filiberto, La discussione sul ‘68 l’hanno sempre fatta i sessantottini: spesso celebrandosi, talora abiurando. Avrebbero diritto di parola anche le generazioni precedenti e successive. In Italia com’è noto il ‘68 è durato dieci anni, sino al caso Moro. I miei ricordi di bambino sono scanditi dagli scontri di piazza e dagli omicidi di terroristi rossi e neri. Certo la rivolta non è stata solo questo; ma negare che ci sia un nesso tra il ‘68 e gli anni di piombo mi pare arduo. Più tardi ho cercato, intervistando centinaia di protagonisti, in fabbrica e in questura, ai vertici Fininvest e in galera, di trovare un senso a quel che era accaduto. Mi sono fatto questa idea. A un’esplosione libertaria, che ha portato a un sano cambiamento dei costumi, dei rapporti tra le persone, del ruolo della donna, è seguito un irrigidimento dogmatico in una parte non trascurabile del movimento. Lo slancio dei giovani finì ingabbiato nelle due ideologie del Novecento, il comunismo e il fascismo, destinate a estinguersi da lì a pochi anni. I giovani di sinistra consideravano il Pci compromesso con la democrazia borghese, e si proponevano di proseguire il compito cui Togliatti e Berlinguer avevano rinunciato: la rivoluzione, come in Cina più che come in Russia. Qualche ex di Lotta continua ha il vezzo di dire di non essere mai stato comunista. Farebbe meglio a dire di essere sempre stato contro il Pci; ma i militanti di Lotta continua erano convinti di essere loro i veri comunisti. Qualcosa del genere, su scala più ridotta, accadde a destra nei confronti del Msi di Almirante, considerato filoatlantico, filoisraeliano, mercatista. Il risultato fu una mimesi della guerra civile, che lasciò sul terreno troppo odio e troppi morti. Di quella generazione salvo una cosa: l’idea, coltivata da molti, che si potesse essere felici soltanto tutti assieme, affidando la vita alla politica. La sconfitta è stata dura: qualcuno è finito nel terrorismo, qualcuno nella droga, qualcuno è rimasto in fabbrica negli anni della restaurazione. La generazione successiva, quella del riflusso (che è poi la mia), ha creduto che si potesse essere felici soltanto ognuno per proprio conto; e anche noi siamo andati incontro alla disillusione, con questo senso di solitudine esistenziale che ci portiamo dentro.
Il Sessantotto non è ancora finito. È stato un processo, non una serie circoscritta di eventi. Solo con la riflessione storica si esce dalla morsa tra nostalgia e rimozione, scrive Umberto Gentiloni il 7 febbraio 2018 su "L'Espresso". Il Sessantotto tra i tanti anniversari a cifra tonda del 2018 sembra mantenere il suo carattere divisivo a partire dalle declinazioni semantiche che lo qualificano: fedeltà o rimozione, modernità o conservazione, soggettività o distanza. Difficile uscire da una morsa che ha accompagnato il corso del mezzo secolo che abbiamo alle spalle, riconducibile al paradigma opprimente del «passato che non passa» ripresentandosi sotto mentite spoglie di memorie contrapposte o in forme apertamente conflittuali. Da un lato la nostalgia del come eravamo, la cifra di una generazione che segnata dagli appuntamenti con la storia in un anno così ricco di novità cerca di mantenere saldi legami con un tempo che le appartiene. Un’ancora di certezze e rimpianti che mostra lo straordinario fascino di poter riavvolgere il nastro di un itinerario fatto di storie, biografie, luoghi e situazioni. Dall’altro la critica che punta a ridimensionare, rimuovere, demolire un patrimonio di memorie e riferimenti comuni che ha attraversato un tratto di storia dell’Occidente. In mezzo lo spazio stretto e difficile della storicizzazione: giudizi, interpretazioni, confronti a partire dalla complessità di un passaggio del dopoguerra che più che un evento isolabile o circoscrivibile prende le sembianze di un processo dal passo lungo che si manifesta con modalità e tempi diversi in tanti angoli del pianeta. Uno spazio di analisi e riflessioni ricco di fonti plurali qualificato da interrogativi che vanno ben al di là del perimetro degli eventi del 1968. Decisivo non smarrire i punti di partenza nella società di allora. Ne ha scritto Guido Crainz nell’ultima puntata di questo confronto a più voci: cosa erano la scuola e l’università italiana? Da dove prende corpo l’anno delle rivolte? Quali contraddizioni si scaricano sul sistema formativo incapace di reggere l’urto della scolarizzazione di massa? Il ’68 degli studenti si lega all’autunno caldo dell’anno successivo, all’emergere di una conflittualità operaia che ha un’identità politica (salari e contratti) e generazionale (una nuova classe operaia entrata in fabbrica). Una specificità italiana il nesso e l’incontro tra studenti e operai, tra l’università e la fabbrica, tra il 1968 e il 1969.
La discontinuità più incisiva e duratura chiama in causa l’aspetto qualitativo dell’innovazione: consumi diffusi, benessere individuale, ricerca di nuove aperture verso mondi emergenti, scoperta di un tempo libero dal lavoro, cura di sé e del proprio corpo. Il conflitto da latente diventa manifesto, esplicito. Un crinale tra due mondi, al tramonto del vecchio non corrisponde una coerente e sinergica opera di rinnovamento. Molto rimane in vita, resiste e si conserva, altro muta parzialmente per poi trovare nuovi spazi, altro ancora viene travolto dal protagonismo di soggettività inedite. La frattura è trasversale, tra opportunità e chiusure, tra generazioni diverse, tra chi riesce a beneficiare delle trasformazioni e chi invece rimane emarginato, escluso e mortificato. Speranze e illusioni muovono uomini e donne verso la ricerca di nuove possibilità in grado di rompere gabbie e condizionamenti della stratificazione sociale di partenza. La disperata ricerca di una mobilità possibile. Una tensione costante che non si riassorbe trovando con il tempo nuovi interpreti non riconducibili alla indiscussa (fino ad allora) centralità del binomio amico - nemico imposta dal riflesso condizionato dell’ordine della guerra fredda. Il rapporto tra individuo e collettività entra in fibrillazione, le strutture tradizionali non soddisfano le aspirazioni di tanti: ha inizio una parabola discendente per partiti, organizzazioni collettive, sindacati o associazioni. Difficile trovare un punto di equilibrio tra la sfera della soggettività individuale che chiede sempre di più e meglio e le forme di espressione e organizzazione della collettività. Più si afferma la prima e più sembra irragionevole e irrealistico proporre l’articolazione di una società per gruppi o identità omogenee, figlie di un tempo che volge alla conclusione.
Per almeno due decenni sono mancate ricostruzioni storiche basate su documentazione non episodica o limitata. Uno studioso attento come Peppino Ortoleva si domandava - nel 1988 in occasione del ventennale - quali fossero i motivi dell’assenza di un quadro di riferimento in grado di rompere la morsa tra condanna senza appelli e revival nostalgici di chi voleva tornare alla meglio gioventù di allora (“I movimenti del ’68 in Europa e in America”, Editori Riuniti). Il Sessantotto nella sua lunga durata non può che coinvolgere direttamente una riflessione più generale sul dopoguerra italiano, sul ruolo dei movimenti, sul peso di una stagione segnata dal protagonismo di soggettività e culture inedite. Una riflessione pienamente inserita nelle dinamiche del sistema internazionale. Se sfumano i ricordi, se si affievolisce il rimpianto per un tempo lontano allora prendono corpo gli interrogativi e le ipotesi interpretative sulle grandi questioni che il Sessantotto solleva e proietta sull’Italia e, in un’ottica più ampia, sulle trasformazioni di un mondo inquieto. Il terremoto nel mondo comunista, la repressione violenta del riformismo cecoslovacco segna la fine di Mosca come guida indiscussa del movimento comunista internazionale. E sull’altro versante la sporca guerra in Vietnam indebolisce i presupposti del mito americano rendendolo vulnerabile e incerto. I modelli di riferimento perdono terreno, mostrano il volto contraddittorio del confronto bipolare. L’inizio della fine dei partiti si sovrappone e si accompagna ai primi i sintomi diffusi sulla inadeguatezza del confronto Est-Ovest.
La controversa questione dei lasciti di una stagione non è riconducibile alle dinamiche di un singolo contesto nazionale. Prevalgono i caratteri distintivi di un fenomeno globale quali «l’ampiezza geografica e la simultaneità temporale» (Marcello Flores, Alberto De Bernardi, “Il Sessantotto”, Mulino 1998.) In Italia il Sessantotto si lega a una crisi più generale del sistema politico, all’indebolimento inesorabile della capacità dei partiti di essere tramite e filtro tra cittadini e istituzioni. La fine della centralità di formazioni politiche che avevano percorso i decenni del dopoguerra con la consapevolezza di essere i soggetti principali di una dialettica capace di includere e coinvolgere settori diversi della società italiana. Gli stessi partiti di massa non sono in grado di comprendere la portata del fenomeno: alcuni ne raccoglieranno l’eredità altri, soprattutto nella sinistra storica, avranno i benefici dell’ingresso di nuovi quadri dirigenti, ma il movimento rimane ostile alla cultura e all’organizzazione dei partiti.
Aldo Moro aveva colto il segno di un tempo nuovo, scrive del Sessantotto più volte fino ai suoi ultimi giorni. Verso la fine dell’anno in un Consiglio nazionale della Dc (21 Novembre 1968) aveva pronunciato parole impegnative e per molti versi inascoltate: «Siamo davvero ad una svolta della storia e sappiamo che le cose sono irreversibilmente cambiate, non saranno ormai più le stesse».
Non date la colpa al ’68. Nella contestazione si confusero differenti umori e pulsioni. Ma non c’è alcun rapporto con gli anni Ottanta e con i disastri dell’oggi, scrive Guido Crainz l'1 febbraio 2018 su "L'Espresso". Dimensione nazionale e internazionale si intrecciano ma forse è bene prendere avvio da realtà concrete, evitando il rischio (sessantottino?) dell’ideologia. E per discutere realmente del nostro ’68, per comprenderne coralità e impatto, non dovremmo dimenticare mai come era la scuola italiana alla sua vigilia, nel vivo di una scolarizzazione di massa tumultuosa: gli studenti delle superiori erano il 10 per cento di quella fascia di età nel 1951, quasi il 40 per cento nel 1967; gli universitari erano 230 mila nel 1958, 550 mila dieci anni dopo. Una scolarizzazione di massa che avveniva in una fase di intensa circolazione internazionale di idee e suggestioni, in contrasto stridente con una arretrata “cultura docente” molto diffusa: si vedano le testimonianze di insegnanti raccolte allora da Marzio Barbagli e Marcello Dei (“Le vestali della classe media”, da leggere assieme alla “Lettera” di don Milani). «Lo studente è un sacco vuoto da riempire, dall’alto di una cattedra, di nozioni già confezionate»: lo scriveva nel 1966 il giornale dei giovani di Azione cattolica, mentre provocava bufere e processi il giornalino del liceo Parini di Milano per un’inchiesta su «quel che pensano le ragazze d’oggi». E il giudice inquirente chiedeva di sottoporre i suoi autori a una umiliante visita medica in base ad una disposizione fascista sui reati dei minori. In quello stesso periodo iniziavano ad estendersi le occupazioni delle Facoltà, a partire da Architettura, e Camilla Cederna ne dava conto proprio su “L’Espresso”. «Sono stanchi di copiare il Partenone», titolava nel febbraio del 1965, e non era solo una coloritura giornalistica: gli studenti chiedevano l’introduzione di materie ancora ignorate dai piani di studio come Storia dell’architettura moderna e Urbanistica (in un’Italia ormai invasa dalla speculazione edilizia). In un manifesto-simbolo del ’68, quello degli studenti torinesi, vi è l’elenco dei “controcorsi” avviati nell’Università occupata, dedicati a temi ancora esclusi dall’insegnamento: Filosofia delle scienze, Scuola e società, Pedagogia del dissenso, Psicoanalisi e repressione sociale, Imperialismo e sviluppo sociale in America latina...La critica del ’68 all’Università fu certo impietosa ma non era molto diversa l’analisi di un commentatore come Alberto Ronchey, che pur chiedeva di «Offrire un’alternativa agli errori degli studenti». Ed enumerava le ragioni di una crisi partendo da Roma: «60.000 studenti, 300 professori» (si riferisce ai professori ordinari, detentori esclusivi di ogni potere: non era improprio definirli “baroni”). E poi: «La seconda crisi riguarda gli uomini. Prima il professore era il re, adesso il re è nudo. La terza crisi discende dall’insegnamento dispotico, elusivo o muto sui temi che interessano gli studenti»; e poi ancora «le comunicazioni di massa, che rendono vicino ogni evento del mondo», «la rottura di linguaggio tra le generazioni», la crisi dei «partiti, i rapporti fra Stato e società e civile (...). L’ultima generazione non vede un disegno del tipo di società verso cui vogliamo andare» (“La Stampa”, 18 febbraio 1968). Poco dopo Giorgio Bocca annotava: in pochi mesi «si è scoperto in modo clamoroso che la didattica di quasi tutte le facoltà umanistiche e di molte facoltà scientifiche è inadeguata», e che dall’Università «escono dei giovani incapaci di esercitare una professione». Nel rapido dilagare del movimento studentesco differenti umori e pulsioni convissero e parvero quasi fondersi (ha ragione Roberto Esposito): anticonformismo e impegno politico, laicizzazione e solidarismo sociale, insofferenza per arretratezze anacronistiche e aspirazioni a profondi rivolgimenti, mentre la realtà del Paese dava molti argomenti a chi vedeva in ogni ingiustizia una “ingiustizia di classe”. E bisognerebbe ricordare la realtà delle fabbriche di allora, nell’intrecciarsi di forme di sfruttamento talora brutali, discriminazioni inique, illibertà (solo nel 1970 lo Statuto dei lavoratori vi introdurrà la Costituzione, come si disse): vedere “imborghesimento” in quegli operai è una licenza filosofica che non condivido. Certo, la coralità dei primi mesi iniziò progressivamente ad incrinarsi e la radicalizzazione ideologica rapidamente prevalse. Ad essa contribuirono anche la balbettante ottusità del potere accademico, il succedersi di interventi repressivi sproporzionati e l’assenza di un’azione riformatrice (fu la politica a mancare in Italia, non il ’68 a distruggerla: in Francia fu varata in pochi mesi la riforma Faure, che avviò la modernizzazione degli atenei e pose rapidamente fine alle proteste studentesche). E vi contribuì poi una radicalizzazione più generale: il 1969 sarà segnato dall’ “autunno caldo” sindacale e dalla strage di Piazza Fontana, con l’avvio di una drammatica “strategia della tensione”. In quel clima declinò - colpevolmente - l’impegno del movimento a rinnovare l’Università, considerata sempre più area di reclutamento per i gruppi extraparlamentari in formazione. Con l’infittirsi degli interventi in fabbriche e quartieri, e con il dilagare di una vecchissima (e disastrosa) ideologia: abbandonata la fase innovativa degli inizi, ha scritto Vittorio Foa, «straordinarie energie giovanili furono disperse nel riscoprire e ripetere la Dottrina; nel ricostruire, spesso come caricatura, quello che si era pensato di mandare al macero». Fu lasciata così cadere la suggestiva idea, pur avanzata, di dar corpo a una “Università critica”: base d’avvio di una «lunga marcia attraverso le istituzioni» volta a innovare saperi e professioni; e a «ridefinire la politica», per usare l’espressione di Carlo Donolo. Non mancarono neppure disincanti e ripiegamenti ma non è riducibile a questi estremi la spallata data allora ad un’Italia arcaica: da quei fermenti venne un più generale impulso alla modernizzazione civile, ad una più ampia concezione dei diritti, ad una maggiore sensibilità sociale. Si incrinò anche così il tradizionale profilo del ceto medio italiano, profondamente segnato sin lì da apatie e conservatorismi. Naturalmente il passaggio dalla prima fase a quella successiva non può essere rimosso (e costringe a interrogare criticamente anche i mesi “aurorali”) ma non mi sembra fondato schiacciare gli anni Sessanta sugli anni Ottanta, e neppure sugli anni Settanta (la contrapposizione del “movimento del ’77” agli operai, sprezzati come “garantiti”, è l’esatto opposto del sessantottesco “operai e studenti uniti nella lotta”). Né mi sembra fondato il «rapporto stretto» che Orsina intravede fra il ’68 e tutti i disastri dell’oggi, in uno scenario nazionale e internazionale squassato da allora in ogni sua parte. E nella nostra lettura complessiva è possibile continuare a ignorare gli studenti della Cecoslovacchia e della Polonia (o della Jugoslavia, con le divaricanti tensioni che vi comparvero), giustamente ed efficacemente evocati su queste pagine da Wlodek Goldkorn e da Gigi Riva? Nel ’68 di Praga e di Varsavia si ebbe la conferma definitiva che il “socialismo realizzato” non era riformabile e presero avvio anche da lì alcuni degli esili ma straordinari fili che porteranno all’89. Continueremo a considerarla “un’altra storia”?
1968: tragica illusione o vera rivoluzione? E' stato l'anno della catastrofe o quello che ha fatto saltare per sempre tutti gli equilibri? Mezzo secolo dopo, le posizioni restano inconciliabili. Da Hoellebeq al Papa, tra critica e nostalgia, scrive Federico Marconi il 18 gennaio 2018 su "L'Espresso". Che cos’è stato il Sessantotto? Mezzo secolo dopo non si contano i giudizi su uno degli anni che più hanno influito sulla nostra storia. Libertà e creatività, immaginazione e fantasia, contestazione e ribellione sono gli elementi di una “rivoluzione” che ha trasformato la politica, la società e il costume. Ma quali risultati hanno raggiunto quei ragazzi coi capelli lunghi che occupavano le università e volevano farla finita con l’autorità, i valori tradizionali, il sapere borghese?
In molti si sono chiesti se il ’68 abbia avuto successo. E c’è chi è convinto di sì. Mario Perniola, il filosofo appena scomparso, ha visto gli ideali del ’68 realizzati da uno che sessantottino non è mai stato: Silvio Berlusconi. L’idea l’ha espressa nel 2011 in un pamphlet paradossale e provocatorio: “Berlusconi o il ’68 realizzato”: il berlusconismo avrebbe fatto propri gli ideali della cultura libertaria esplosa con il maggio francese, e il suo sfacciato neoliberismo non sarebbe altro che l’esito della rottura rappresentata da quell’anno. Una realizzazione del ’68 postuma che dà tutto il potere non all’immaginazione, ma all’intrattenimento. Rivincita di quell’allegria e di quella spinta creativa che, per Edmondo Berselli in “Adulti con riserva”, sono state sacrificate sull’altare della seriosità sessantottina. Ma c’è anche chi considera la contestazione studentesca non una svolta progressista ma reazionaria, con la riproposizione di modelli autoritari.
Lo storico tedesco Götz Aly in “Unser Kampf” ha scritto che la generazione del ’68 condivide moltissimi elementi con quella che nel 1933 ha portò al potere Hitler. La contestazione di fine anni ’60, secondo Aly, è stata solo un epifenomeno del totalitarismo, che non avrebbe nemmeno portato alla tanto decantata liberazione della morale e dei costumi, visto che quel processo era già cominciato negli anni ’50.
Sulla stessa linea Alessandro Bertante, che in “Contro il ’68” definisce quella ribellione come «una clamorosa e tragica illusione», spezzata dalla repressione poliziesca e dalle bombe fasciste. Alcuni ragazzi hanno preso poi la strada dell’eversione armata. Altri sono tornati nell’ambito sociale di provenienza, la tanto odiata borghesia, dando ragione a Eugène Ionesco, che gridava agli studenti del maggio francese: «Tornate a casa! Tanto diventerete tutti notai!».
“Notai” ignoranti, secondo Indro Montanelli: «Vidi nascere dal Sessantotto una bella torma di analfabeti che poi invasero la vita italiana portando ovunque i segni della propria ignoranza». Ma, come tutti i “notai”, ricchi: i sessantottini hanno un reddito più alto delle altre generazioni, confermano gli studi della Banca d’Italia sul bilancio delle famiglie. L’economista Riccardo Puglisi lo ha evidenziato in un articolo nel 2013, che si chiudeva con la proposta di «rottamarli tutti». E tra coloro che gli hanno dato ragione c’è stato anche uno che nel 1968 era un maoista che finanziava il movimento smerciando libri rubati, e che oggi invece è conosciuto come il sondaggista di Porta a Porta. «Sì, rottamateci tutti» ha risposto Renato Mannheimer, pur difendendo le «innovazioni che il Sessantotto ha portato in Italia».
Uno che si sente ancora un sessantottino è Toni Negri, intellettuale, militante e ideologo della sinistra extra-parlamentare tra gli anni ’60 e ’80. In una recente intervista ha detto che «il Sessantotto ha fatto saltare tutti gli equilibri», e per questo gli si è risposto con una cultura reazionaria che ancora oggi lo odia e rifiuta. Ma non ci sono solo i nostalgici.
Critici e detrattori si rincorrono non solo in Italia, ma anche Oltralpe. Come Michel Houellebecq che, nel romanzo “Le particelle elementari”, descrive il ’68 come l’anno della catastrofe, che ha lasciato solo miseria, individualismo e violenza: un’uscita che non gli è ancora stata perdonata. E assai critica è stata anche la recente rilettura dell’anno da parte di Papa Francesco: parlando agli ambasciatori i cui Paesi hanno rappresentanza presso la Santa Sede, il pontefice ha detto che «in seguito ai sommovimenti sociali del Sessantotto, l’interpretazione di alcuni diritti è andata progressivamente modificandosi, così da includere una molteplicità di nuovi diritti, non di rado in contrapposizione tra loro». Col rischio di una «colonizzazione ideologica dei più forti e dei più ricchi a danno dei più poveri e dei più deboli».
La provocazione: il 1968 è stato l'anno in cui è nato il rancore. La contestazione chiedeva più politica. Invece ha prodotto la crisi, più egoismo, la rabbia di oggi. Uno storico apre il dibattito, scrive Giovanni Orsina il 18 gennaio 2018 su "L'Espresso". Il Sessantotto compie mezzo secolo in un periodo nel quale la politica è in grande difficoltà. I segnali sono numerosi, e si presentano in quasi tutte le democrazie avanzate: dalla presidenza Trump alla Brexit, dalla scarsa partecipazione alle elezioni francesi al successo elettorale di Alternative für Deutschland e allo stallo politico in Germania, per arrivare all’infelice condizione della vita pubblica nostrana. Questi sono – appunto – segnali: non cause, ma sintomi d’una crisi storica. Il cinquantenario del Sessantotto ci dà l’occasione per chiederci quale sia il rapporto fra gli eventi di mezzo secolo fa e il travaglio politico dei nostri tempi. La risposta è che un rapporto non soltanto c’è, ma è stretto: il Sessantotto è uno snodo cruciale d’una vicenda pluridecennale che pare esser arrivata oggi alla sua piena maturazione. Ma come - si obietterà -, un anno stracolmo di politica come il 1968 diviene parte d’una storia che si conclude, sia pure cinque decenni dopo, con una crisi della politica? In effetti, nelle democrazie occidentali la contestazione sessantottina nasce anche dal desiderio di ribellarsi contro i limiti ch’erano stati imposti alla politica dopo il 1945. Il desiderio di ribellarsi contro il principio secondo cui alcuni àmbiti - a partire dalla vita famigliare - dovevano esser tenuti il più possibile separati dai conflitti pubblici. Al contrario: «il privato è politico!». Il desiderio di ribellarsi contro i limiti che le tecnocrazie e l’“oggettività” scientifica imponevano al pieno dispiegarsi della volontà umana di cambiamento. Al contrario: «vogliamo tutto!»; «siate realisti, chiedete l’impossibile!». Il Sessantotto, insomma, vuole più politica: la produzione d’uno sforzo di trasformazione collettiva profondo, radicale, impaziente d’ogni limite in estensione o intensità. Questo desiderio di azione collettiva, tuttavia, monta in un momento nel quale le grandi ideologie che avrebbero potuto orientare quell’azione sono ormai o del tutto defunte, o in profonda crisi. A cominciare dalla più rilevante fra di esse. Il marxismo, in una forma o nell’altra, è l’ideologia portante della contestazione sessantottina. Ma in quegli anni è già irrimediabilmente colpito dalla degenerazione del socialismo reale, e forse ancor di più dal successo delle economie capitalistiche occidentali, che ne falsifica una delle profezie cruciali: la proletarizzazione universale. Alla crisi dei grandi progetti di emancipazione collettiva fa da controcanto l’affermazione crescente del desiderio di emancipazione individuale: se non possiamo essere liberi insieme, almeno che lo sia io! Non per caso, uno dei pensatori più influenti del Sessantotto è Herbert Marcuse, intento a superare lo stallo del marxismo immaginando che il desiderio individuale possa fungere da leva rivoluzionaria. Se non che, il desiderio di liberazione individuale è destinato a entrare in conflitto col desiderio di liberazione collettiva - ossia con la politica. L’azione collettiva richiede organizzazione e disciplina: subordinazione delle aspirazioni personali agli scopi comuni. E tanto più ne richiede, quanto più ambiziosi sono i suoi obiettivi. Lo mette in evidenza già all’epoca uno dei critici più acuti del Sessantotto, Augusto Del Noce, parlando proprio di Marcuse: «una rivoluzione antipuritana è quel che egli sa proporre: un vero ferro di legno, per una ragione storica intrinseca … che il motivo puritano è essenziale a ogni posizione rivoluzionaria seria … Marcuse può perciò essere definito come il filosofo della decomposizione della rivoluzione». Là dove per “puritanesimo” bisogna intendere appunto la negazione di se stessi, dei propri desideri individuali, in vista d’un obiettivo rivoluzionario da raggiungere tutti insieme. Questa contraddizione è una delle ragioni, e non la minore, per le quali la contestazione sessantottina non riesce a dar vita a un movimento politico ampio e robusto, ma si disperde in mille rivoli ideologici l’un contro l’altro armati; o si riduce a perseguire l’azione per l’azione, magari violenta; oppure finisce riassorbita nei partiti della sinistra tradizionale. La contraddizione del resto era ben presente già ai protagonisti dell’epoca – a Rudi Dutschke, ad esempio, a Daniel Cohn-Bendit. Una delle organizzazioni più importanti del Sessantotto tedesco, la Lega degli studenti socialisti, si scioglie nel 1970 perché «se la liberazione della società non è possibile qui e ora», la Lega «dovrebbe almeno garantire democrazia ed emancipazione nel proprio ambito». Deve insomma emanciparsi da se stessa. Fra le due anime del movimento studentesco, quella marcusiana e quella stalinista, nel breve giro di qualche anno finisce così per prevalere largamente la prima, notava nel 1980 Nello Ajello in un libro dal titolo assai indicativo: “Il trionfo del privato”. È un Marcuse depoliticizzato, però: non la soddisfazione del desiderio individuale come strumento di rivoluzione politica - ma la soddisfazione del desiderio individuale punto e basta. La vicenda di «Lotta Continua», che Ajello analizza nelle pagine citate, mostra bene questo passaggio: intorno alla metà degli anni Settanta il giornale diventa «l’organo più rappresentativo di una mentalità giovanile di sinistra nella quale il conflitto fra “privato” e “politico” si sta concludendo con una larga vittoria del primo». Così scrive in quegli anni un lettore al giornale: «Siate realisti, domandate l’impossibile, dicevano i compagni del maggio francese. Bene, noi vogliamo essere felici». Nello stesso torno di tempo, secondo la studiosa americana Kristin Ross, si modifica la memoria del Sessantotto francese: del suo contenuto politico si perde il ricordo, mentre le sue componenti esistenziali e culturali si dilatano fino a occupare tutta la scena. La politicità del Sessantotto si scioglie quindi nel giro di pochi anni nell’affermarsi dell’individualismo? Piano: magari fosse così semplice. La spinta alla liberazione personale che cresce a partire dai tardi anni Sessanta - in forma come s’è detto prima politica e poi impolitica - ha comunque degli effetti politici di rilievo. Vediamo quali.
La politica “ufficiale” affronta quella spinta con «moderazione ragionevole» (l’espressione è dello storico britannico Arthur Marwick): ossia, dove possibile, cede alla pressione. Sia sul piano retorico: il socialdemocratico Willy Brandt, Cancelliere tedesco dal 1969, promette un «nuovo inizio», e di «osare più democrazia»; il liberale Valéry Giscard d’Estaing, Presidente francese dal 1974, dichiara di volere una «democrazia liberale avanzata». Sia - e soprattutto - sul piano pratico: gli anni Settanta, com’è ben noto, sono caratterizzati da un processo imponente di ampliamento dei diritti individuali, sia civili sia sociali, in tutte le democrazie avanzate.
Il desiderio diffuso di liberazione individuale e la scelta della politica “ufficiale” di soddisfarlo generano però dei contraccolpi. Tanto più che i diritti sociali costano, e che negli anni Settanta giunge al termine la straordinaria crescita economica postbellica. Politologi come Michel Crozier, Daniel Bell, Samuel Huntington cominciano a chiedersi quanto a lungo possa sostenersi una democrazia se l’elettorato chiede troppo. Al di là e al di qua dell’Atlantico studiosi e intellettuali come Christopher Lasch, Richard Sennett, Gilles Lipovetsky denunciano l’involuzione dell’“individuo desiderante” in un “narcisista” incapace di distinguere fra se stesso e la realtà; disconnesso da un passato e incapace d’immaginare un futuro; sovreccitato, autoreferenziale, e in definitiva profondamente infelice. Da grande scrittore e giornalista, nel 1976 Tom Wolfe fornisce un ritratto straordinario di questo narcisista in “The “Me” Decade”, Il decennio dell’Io. In Italia Augusto Del Noce, Nicola Matteucci, Gianni Baget Bozzo, fra gli altri, evidenziano i limiti e le contraddizioni della società «permissiva» o «radicale».
Di fronte al montare della “democrazia del narcisismo”, quella stessa politica “ufficiale” che ha ceduto alla pressione individualistica deve cominciare a tirare il freno. Non può però, o non vuole, affrontare direttamente gli elettori, prendendosi la responsabilità di dir loro con chiarezza che la festa è finita, e correndo magari il rischio di dover pagare il prezzo della propria sincerità. Fa allora in modo che i cittadini si trovino di fronte dei muri di altra natura, tecnica e non politica: le banche centrali, le autorità indipendenti, le istituzioni economiche internazionali, il sistema monetario europeo. E naturalmente - soprattutto a partire dal 1979-80, con l’ascesa al potere di Margaret Thatcher e Ronald Reagan - il mercato. Che è un Giano bifronte straordinario: da un lato, col moltiplicarsi dei consumi, soddisfa il narcisismo; dall’altro gli impone la dura disciplina della concorrenza. Reagan guarderà soprattutto alla faccia della gratificazione; Thatcher a quella del rigore: «l’economia è il metodo», dirà, «l’obiettivo è cambiare l’anima della nazione».
Sia quando cede alla richiesta di maggiore emancipazione individuale, sia quando demanda alle tecnocrazie o al mercato il compito di arginarla, tuttavia, la politica sega il ramo sul quale sta seduta. La politica infatti è azione collettiva: ma come potrà mai ricomporre la società individualistica che essa stessa contribuisce continuamente a frammentare? E la politica è esercizio del potere: ma quale potere potrà mai esercitare, se ha contribuito a trasferirne una buona parte a organismi non politici, nazionali e internazionali? A partire dai tardi anni Ottanta, poi, nelle democrazie avanzate la destra e la sinistra convergono in una sorta di “grande centro” ideologico fatto di diritti (il contributo della sinistra) e di mercato (il contributo della destra) - ma incardinato in tutti i casi sull’individuo. Anche il conflitto politico, così, deperisce. E gli elettori cominciano a chiedersi quali siano le loro reali possibilità di scelta.
Alcuni studiosi - Ronald Inglehart, Ulrich Beck, Anthony Giddens - già dalla metà degli anni Settanta hanno cominciato a immaginare la ricomposizione politica del caleidoscopio individualistico: individui “riflessivi”, ossia capaci di generare da se stessi la propria identità, avrebbero costruito liberamente e creativamente delle nuove aggregazioni collettive. Ora, è vero che da ultimo, nella nostra epoca, la politica si sta ricomponendo. Solo, lo sta facendo in una maniera ben diversa da come immaginavano quegli autori. Altro che individui riflessivi: cittadini convinti che la politica della liberazione individuale non li protegga più da un mondo sempre più complesso e incontrollabile si rifugiano nell’ultima ridotta identitaria possibile - l’identità del luogo di nascita -, aderendo a partiti sovranisti o localisti. Oppure costruiscono un’identità collettiva nuova, ma negativa, mescolando finalità e provenienze assai diverse in un calderone comune: il rancore contro quelli che a loro avviso dovrebbero proteggerli, e non lo fanno.
Il conflitto politico rinasce così fra Clinton - figlia del Sessantotto, per tanti versi - e Trump. Fra l’establishment politico che ha gradualmente preso forma negli ultimi cinquant’anni, il “grande centro” individualistico dei diritti e del mercato, e che non riesce a mantenere la promessa universale di emancipazione individuale dalla quale trae la propria legittimità. E quelli che, per ragioni economiche o culturali, denunciano il fallimento di quel grande centro e lo combattono.
Per parte loro, questi ultimi non sanno davvero quali alternative proporre - e quando ne propongono, sono o assai poco desiderabili o del tutto irrealistiche. Siamo sicuri però che questa mancanza di realismo sia un ostacolo sulla via del successo politico? Uno che delle contraddizioni della modernità qualcosa aveva pur capito, Fëdor Dostoevskij, già un secolo e mezzo fa scriveva: «“Abbiate pazienza, - vi grideranno, - rivoltarsi è impossibile; è come due per due fa quattro! La natura non vi consulta; non gliene importa nulla dei vostri desideri e se vi piacciano o non vi piacciano le sue leggi …”. Signore Iddio, ma che me ne importa delle leggi naturali e dell’aritmetica, quando per qualche ragione queste leggi e il due per due non mi piacciono? S’intende che questa muraglia non la sfonderò col capo, se davvero non avrò la forza di sfondarla, ma nemmeno l’accetterò, solamente perché ho una muraglia davanti e le forze non mi sono bastate». In fondo, è un altro modo per chiedere l’impossibile.
Sorpresa: il ’68 è stato liberale. Al di là degli slogan marxisti, le proteste giovanili hanno cambiato la società soprattutto nella cultura e nei costumi, scrive il 19 novembre 2017 Bernardo Valli su "L'Espresso”. Il 1968 è stato ricco di avvenimenti e nel 2018, ormai alle porte, le rievocazioni per il cinquantenario non mancheranno. Comincio in anticipo. L’occasione mi è offerta dalla discussione aperta a Parigi sull’opportunità di celebrare, come movimento liberale (non libertario) l’esecrato o mitico Maggio ’68 e dal trovarmi in questi giorni a Praga, dove mezzo secolo fa fui testimone dell’effimera “Primavera”. L’anno debuttò con la grande speranza emersa sulle rive della Moldava. Era il 5 gennaio, giorno della nomina a segretario del partito di Alexander Dubcek. In agosto arrivarono i carri armati sovietici. Il tentativo di introdurre la democrazia nel comunismo reale fallì, finì in tragedia, ma annunciò il funerale del repressore - vincitore del momento. Il funerale ufficiale avvenne soltanto una ventina d’anni dopo, con l’implosione dell’Urss, ma l’agonia senza ritorno iniziò nella meravigliosa cornice di questa città che riscopro invasa dai turisti e dalle pizzerie. Come nel ’38 la Cecoslovacchia era stata lasciata ai tedeschi di Hitler, trent’anni dopo fu lasciata ai sovietici. Un piccolo prezioso paese è una facile preda. L’America era impegnata altrove, in Estremo Oriente, dove subiva l’offensiva del Têt. I suoi soldati, mezzo milione di uomini del più potente esercito della Storia, scoprirono di avere i viet cong sotto il letto. Fu la sorpresa di fine gennaio ’68, in occasione del capodanno vietnamita. Gli americani riuscirono a neutralizzare l’attacco dei guerriglieri infiltratisi negli alti comandi e nelle caserme, ma capirono che dovevano andarsene. È quello che fecero quattro anni dopo. Il tempo per fare i bagagli. La grande armata, vittoriosa nella Seconda guerra mondiale, non sarebbe stata sconfitta militarmente, ma avrebbe dovuto presidiare per un tempo indeterminato il Sud Viet Nam con cinquecentomila uomini. Oltre ai guerriglieri sotto il letto a Saigon e a Hué, c’erano migliaia di manifestanti contro la guerra ogni giorno a Washington e a New York. Tutto questo equivaleva a una sconfitta. Nel marzo dello stesso anno, all’altra estremità del pianeta, nella Cuba di Fidel Castro, veniva promossa un’“offensiva rivoluzionaria”, vale a dire una più ampia collettivizzazione, tesa a colpire le attività della piccola borghesia urbana. Il comunismo caraibico accentuava l’impronta sovietica. Sempre nel ’68 erano ancora in piena attività le “guardie rosse” di Mao. La rivoluzione culturale, cominciata due anni prima, fu una lotta interna per il potere, ma allora appariva a molti giovani europei un fermento sociale che avrebbe condotto alla nascita di un “uomo nuovo”. Tutti questi avvenimenti suscitavano entusiasmi, illusioni, distorte visioni della realtà, e comunque alimentavano gli slogan scanditi sui boulevard parigini. Le sponde della Senna erano il teatro di una rivolta giovanile, poi seguita da scioperi operai, contro il potere, e in favore di tutti i movimenti, dai maoisti ai viet cong, ai cubani, visti come esempi di contropotere. Erano immagini lontane, quindi potevano essere idealizzate, in contraddizione con il carattere libertario del maggio ’68. Libertario e al tempo stesso liberale. Facevo allora la spola tra il Ponte Carlo sulla Moldava e il Quartiere Latino in riva alla Senna. Erano le due facce dell’Europa. I giovani cecoslovacchi non capivano l’opposizione a un regime democratico che era il loro obiettivo; i giovani francesi non capivano l’opposizione a un regime che si era liberato del capitalismo. Eppure gli uni e gli altri avevano in sostanza obiettivi liberali. Ed è proprio questo aspetto che potrebbe essere ricordato cinquant’ anni dopo. Lo slogan dominante sui boulevard era “proibito proibire”. Lo stesso poteva essere scandito sulla piazza Venceslav. Ma là arrivarono i carri armati. In vista del cinquantenario, a Parigi si discute appunto sull’opportunità di celebrare il Maggio ’68, visto, al di là della rivolta con tinte marxiste, come un movimento che ha favorito una nuova società più liberale, una trasformazione culturale e politica. Insomma allora il vecchio mondo fu ripulito da molte tradizioni e restrizioni. Rinnovò i costumi. Il carattere libertario è svanito mentre quello liberale, nel senso autentico della parola, ha lasciato le sue tracce.
SESSANTOTTO: quando invece del populismo dilagò la rivolta, scrive Piero Sansonetti il 7 gennaio 2018 su "Il Dubbio". È l’anno cruciale del secondo 900. Una forma di populismo ma che niente ha a che vedere con quello di oggi. Il 1968 è stato l’anno di svolta nella storia del dopoguerra, in tutto l’Occidente, ma anche ad Est. In questi giorni sono usciti diversi articoli su vari giornali (soprattutto sui giornali di destra) nei quali si chiede di rinunciare alle commemorazioni. Benissimo, rinunciamo alle commemorazioni, ma non vedo proprio perché non dovremmo cogliere l’occasione del cinquantesimo anniversario per tornare a ragionare su quell’anno cruciale, che con la sua intensità sociale e politica ha modificato il percorso della storia. È un anno che non ha eguali nella seconda metà del novecento. Non ho mai capito perché, almeno da un po’ di tempo, l’idea di parlare di storia, e soprattutto del nostro recente passato, viene vista come una noiosa strampalatezza di un pugno di nostalgici. Penso che sia esattamente il contrario: la voglia di dimenticare i fatti che hanno influito sulle nostre vite – che hanno cambiato cultura, abitudini, modo di pensare e di agire – è un desiderio un po’ da cretini. Ed è forse una delle ragioni di un certo decadimento della nostra intellettualità, che chiunque avverte. Il 1968 è stato un anno specialissimo per tre ragioni.
La prima è l’ampiezza della rivolta che si è sviluppata in quell’anno contro le classi dirigenti e il sistema. Il ‘ 68 travolse gli Stati Uniti d’America, squassò l’Europa occidentale democratica, ma ebbe delle ripercussioni eccezionali anche nel mondo comunista e persino nei paesi autoritari di destra, come la Spagna, il Portogallo e alcuni paesi dell’America Latina.
La seconda ragione è il carattere generazionale della rivolta, che non solo non fu un limite ma, al contrario, moltiplicò la potenza del fenomeno, proiettandolo nel futuro.
La terza ragione è lo “spirito” originario del ’68, che poi negli anni seguenti si frantumò, in parte si ribaltò, comunque si spezzettò in mille rivoli, che portarono su sponde anche molto lontane. Lo “spirito” originario del ’68 è stato la contestazione delle gerarchie, e dunque del meccanismo essenziale che aveva governato il mondo fino a quel momento, e che regolava il potere, la distribuzione della ricchezza, i rapporti tra uomini e donne, la religione, la famiglia, la scuola, il sapere. La forza del ‘68 non risiedeva tanto nella improvvisa violenza della sua azione, e della sua contestazione, ma nella potenza rivoluzionaria di quel messaggio, che era qualcosa di molto più complesso delle vecchie rivendicazioni anarchiche. Ci sono migliaia di slogan del ’68. Molto diversi tra loro. Alcuni truculenti. (Ne ricordo uno che gridavamo spesso ai cortei: “È ora di giocare col sangue dei borghesi…”). Ma il vero slogan che riassume l’anima di quella rivolta è lo slogan più famoso del maggio francese: «E vietato vietare». Il ‘68 inizia come grandioso fenomeno libertario. Poi si piega su se stesso, si aggroviglia, e in moltissime sue espressioni ha un rinculo stalinista e autoritario. Se però immaginiamo il ‘68 solo come fenomeno di violenza politica e come anticamera della lotta armata, capiamo pochissimo di quello che è successo e di perché il ‘68 ha dilagato in territori molto lontani dal gruppetto di studenti e di intellettuali che lo innescò. Fino a coinvolgere, ad appassionare, e talvolta a travolgere pezzi molto vasti di classe operaia ma anche di borghesia moderata. Gli effetti più clamorosi del ’68 furono lo spostamento molto sensibile del senso comune conservatore, che ruppe gli argini, perse i punti di riferimento e le paure.
Fu un fenomeno populista? Certamente lo fu, ma quello sessantottino è un tipo di populismo di segno opposto a quello che conosciamo oggi. Oggi il populismo è una declinazione del qualunquismo, dell’antipolitica, della paura, anche dell’ignoranza. Non possiede nessuno spessore ideale, è chiuso in se stesso è rancoroso. Allora fu un fenomeno opposto: impegnato, molto politico, colto, con una componente fortissima – qui in Italia – di tipo cattolico, influenzata dalle grandi novità del Concilio. In comune con il populismo di oggi ha solo la domanda di rottura. Le risposte a questa domanda, però, sono opposte. Così come, in politica, sono opposte le spinte rivoluzionarie e quelle reazionarie. Il 1968 nasce sicuramente in America. Dove la rivolta dei neri e degli hippy era iniziata diversi anni prima. Aveva incendiato le città, i ghetti, i campus universi- tari. Aveva spinto possentemente a sinistra il kennedismo, che era nato come proposta di leggero e moderatissimo cambiamento e invece, con Bob Kennedy, aveva finito per avvicinarsi moltissimo al punto della rivolta. E però, curiosamente, se andiamo a controllare le cronologie, ci accorgiamo che il primo atto storico del sessantotto avviene all’Est. Precisamente il 5 gennaio (giusto ieri era il cinquantenario) con l’elezione di Alexander Dubcek alla segreteria del partito comunista cecoslovacco. Dubcek, 46 anni, intellettuale raffinato ma con un lungo passato di funzionario di partito, aveva riunito intorno a sé un gruppo di giovani intellettuali quarantenni ed era riuscito a scalzare dal potere il vecchio Antonio Novotny, uomo legatissimo a Mosca. Iniziò così, in pieno inverno, la Primavera di Praga, e cioè un periodo di riforme e di grande mobilitazione politica, con un vastissimo sostegno popolare, che fu il più robusto e organico tentativo di ristrutturazione del socialismo. Dubcek, spinto dal vento libertario del sessantotto, introdusse il concetto di libertà come valore fondante del progetto socialista. E questa non era una modifica, o un aggiustamento: era il ribaltamento del castello ideologico costruito da Lenin in poi. Dubcek si convinse che i valori di libertà ed eguaglianza non sono valori in competizione ma possono integrarsi perfettamente. E’ impossibile immaginare oggi cosa sarebbe successo se il tentativo di Dubcek non fosse stato represso in modo brutale, e in parte inaspettato, dalle forze armate sovietiche. Cosa avrebbe portato, all’umanità, una competizione equilibrata tra capitalismo rooseveltiano e socialismo democratico. Non lo sapremo mai.
Il tentativo durò meno di otto mesi. La notte tra il 20 e il 21 agosto le truppe del patto di Varsavia entrarono a Praga. Dubcek, insieme a Ludvick Svoboda, che era il presidente della Repubblica, fu portato a Mosca per chiarimenti, e poi deposto. Lo mandarono a fare l’impiegato in un ufficio, e riemerse solo dopo la caduta del Muro di Berlino. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, nel 1990. Era in visita in Italia e volle venire a cena con noi giornalisti dell’Unità, che lo avevamo intervistato un paio d’anni prima, quando era ancora in semi- clandestinità. Serio, timido, ma anche molto spiritoso e persino autoironico. Mi ricordo che ci raccontò una barzelletta forse non spiritosissima in assoluto, ma devastante perché raccontata da lui. La sintetizzo molto, perché era lunghissima: C’è una coppia che dorme a Praga la notte del 20 agosto. A un certo punto lei si sveglia e chiama il marito. Gli dice: “Ehi, cos’è questo sferragliare di camionette qui sotto casa?”. “Niente”, risponde lui, “sarà il mercato, ora dormi!”. Dopo mezz’ora lei lo sveglia ancora: “Ehi, sento dei colpi di cannone…”. Lui di nuovo la tranquillizza: “Sono tuoni, amore, dormi…”. Alle quattro del mattino la signora si affaccia alla finestra e grida: “Ci sono i carrarmati qui sotto, ci hanno invaso! ”. Lui resta tranquillo: “non aver paura, poi verranno i sovietici e ci libererano…”. E già, l’invasione fu una sorpresa. Non solo Dubceck era convinto che nel nuovo clima del ’68 i sovietici non avrebbero osato. Anche perché, nonostante tutto, Dubceck considerava i sovietici degli amici. Invece l’invasione ci fu e gelò il mondo. E’ vero che il ’68 fu un fenomeno essenzialmente occidentale. Ma se dovessimo mettere due date al suo inizio e alla sua fine, e cioè alla parabola del sogno sessantottino, prima che il ’68 si trasformasse, si incattivisse e in parte degenerasse, le date sono quelle lì di Dubcek: 5 gennaio e 20 agosto. E’ lì, quella notte, che finisce il sogno. Non solo dei cecoslovacchi, ma di tutti. Cioè di tutti quelli – americani, russi, polacchi, europei…- che avevano sperato nella riformabilità del potere. L’impermeabilità del socialismo alle riforme era lì a dimostrare questo: il potere non accetta di essere messo in discussione, tantomeno di mettersi in discussione da solo.
In Italia il ’68 inizia invece con un fatto tragico e che non ha molto a vedere, almeno all’inizio, con la politica: il terremoto del Belice. Avvenne nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, provocò circa 300 morti e rase al suolo decine di paesi della provincia di Trapani e di Agrigento. Gibellina scomparve. Ma adesso procediamo con la cadenza della cronologia. In ordine sparso 31 gennaio. In Vietnam inizia l’offensiva del Tet. Il Tet è il capodanno vietnamita. I vietcong e l’esercito del Nord, guidato dal mitico generale Nguyen Giap (che 15 anni prima aveva sbaragliato i francesi a Dien Bien Phu) attaccano tutte le principali città del Sud Vietnam. Muovono 800 mila uomini armati. E’ un successo militare clamoroso. Americani e Sudvietnamiti, sgomenti, reagiscono con ferocia. Il primo marzo, a Saigon, un generale sudvietnamita giustizia per strada, davanti al fotografo, un guerrigliero vietcong. La foto diventa famosissima.
1 marzo. E’ la vera e propria data d’inizio del 68 italiano. La battaglia di valle Giulia. Gli studenti attaccano la polizia che presidia la facoltà di Architettura, a Roma. Inizia un pomeriggio di fuoco. La polizia non si aspetta l’iniziativa spregiudicata e per molte ore non riesce a contenere la furia degli studenti. Guidati da Oreste Scalzone, da Sergio Petruccioli, da Massimiliano Fuksas, da Franco Russo. E con tanti ragazzini che non hanno nemmeno 18 anni, tra i quali i fotografi immortalano Giuliano Ferrara, figlio di Maurizio, direttore dell’Unità.
16 marzo. Una pattuglia di militanti del Msi, guidati da Giorgio Almirante, tentano di attaccare la facoltà di lettere, occupata dai “rossi”. Vengono messi in fuga, si rifugiano a Giurisprudenza, si barricano e tirano dal quarto piano un banco sui ragazzi che assediano la facoltà. Il banco prende in pieno il leader degli studenti, Oreste Scalzone, che è ridotto in fin di vita (si salverà ma porterà i postumi della botta per tutta la vita). Lo stesso giorno gli americani compiono in Vietnam l’azione più orrenda di tutta la guerra. Un gruppetto di marines, guidati da un certo tenente Calley, rade al suolo un piccolo paese (My Lai) e inizia a torturare e ad uccidere, uno ad uno, tutti gli abitanti. Ne manda al creatore 450, poi, all’improvviso, irrompe sulla scena un elicottero guidato da un giovane sottufficiale americano molto coraggioso. Si chiama Hugh Thompson. Atterra, imbraccia un bazooka e si frappone tra i marines e i vietnamiti. Punta il tenente Calley e gli dice: o vi ritirate o ti ammazzo. La spunta. Salva un centinaio di superstiti. La strage però viene nascosta per due anni, poi la scopre un giornalista dell’Associated Press. C’è un processo. Calley si prende l’ergastolo ma Nixon lo grazia.
4 aprile. A Memphis, in Tennessee, dove era andato per tenere un comizio, viene abbattuto con una fucilata Martin Luther King, il capo della rivolta pacifica nera. Tre anni prima era stato ucciso, a New York, Malcolm X, il capo della rivolta nera violenta. La morte di King scatena un’ondata di violenza nei ghetti. Molte decine di morti.
11 aprile. Dopo King è un altro leader del ‘ 68 a prendersi una revolverata: Rudy Ducke. E’ il capo degli studenti tedeschi. E’ un agitatore, un combattente, ma anche un intellettuale molto sofisticato. Gli sparano alla testa. Si salva, ma resta molte settimane tra la vita e la morte. Non si riprenderà mai del tutto, e morirà dopo dieci anni, per i postumi delle ferite.
Il 10 maggio parte la Francia. E il sessantotto raggiunge l’apice. Occupata la Sorbona. Scontri fino a notte nel quartiere latino.
13 maggio: un corteo immenso di studenti invade Parigi. Ci sono pure gli operai. Il movimento è guidato da un ragazzetto franco- tedesco, di appena 20 anni, che si chiama Daniel Cohn Bendit. Il ragazzo, Dany il rosso, fa tremare De Gaulle, il gigantesco De Gaulle, e fa temere che la rivoluzione sia davvero alle porte.
Il 5 giugno a Los Angeles viene ucciso Bob Kennedy. Stava per festeggiare il successo alle primarie della California. Era difficile che ottenesse la nomination, perché era partito troppo tardi, ma qualche speranza c’era. Kennedy ormai era diventato uno dei leader mondiali del 68, se avesse vinto, e avesse poi battuto Nixon, chissà come sarebbe andata la storia del mondo. Invece fu ucciso da un ragazzetto arabo di 24 anni. Che sta ancora in galera. Si chiama Shiran Shiran.
Del 20 agosto abbiamo già parlato, con la mazzata di Breznev e la fine della primavera di Praga.
Il 2 ottobre a città del Messico ancora gli studenti in piazza. La polizia spara in piazza delle Tre Culture, ne uccide cento. Un massacro che scuote il mondo, che ha gli occhi puntati sul Messico perché lì stanno per iniziare le Olimpiadi. Negli scontri resta ferita gravemente la giornalista italiana Oriana Fallaci.
13 ottobre. A Città del Messico iniziano le Olimpiadi. In un clima cupo e di conflitto.
17 ottobre. Tommie Smith, atleta nero americano, vince la medaglia d’oro sui 200 metri piani. Terzo arriva John Carlos, anche lui afroamericano. I due salgono sul podio della premiazione e alzano al cielo il pugno con un guanto nero. E’ il saluto dei Black Panther. Tutte le televisioni del mondo trasmettono questa scena. Nei quartieri neri americani è il delirio di entusiasmo.
Il 5 Novembre Richard Nixon viene eletto presidente degli Stati Uniti. Ha sconfitto Hubert Humphrey, vicepresidente uscente e rappresentate molto moderato del partito democratico. La Casa Bianca, dopo 8 anni, torna ai repubblicani. Simbolicamente è una vittoria della restaurazione. In realtà negli Usa non cambia molto. Nixon è un falco in politica estera e una colomba in politica interna. Come Lyndon Johnson, il suo predecessore che ha lasciato le penne in Vietnam. La vera svolta conservatrice, in America, avverrà solo 12 anni dopo, con Ronald Reagan.
2 dicembre. Ancora sangue in Italia, Stavolta ad Avola, Sicilia. La polizia spara sui contadini che occupano le campagne. Due morti, molti feriti, molta rabbia, molti arresti. Manifestazioni di protesta in tutt’Italia.
31 dicembre. Il ‘68 se ne va con un’altra sparatoria. Alla Bussola, night club di Viareggio, gli studenti attaccano lanciando uova e pomodori sulle pellicce di quelli che festeggiano (come era successo tre settimane prima alla Scala di Milano). La polizia interviene. Si scatena la guerriglia. Tra gli studenti c’è il leader di Lotta Continua, Adriano Sofri, e c’è anche uno studentello diciottenne della Normale di Pisa, che si chiama Massimo D’Alema. La polizia spara di nuovo. Un ragazzo di 17 anni, Soriano Ceccanti, è colpito alla schiena. Ancora oggi, Soriano sta in carrozzella, è rimasto paralizzato.
Che c’entra il ‘68 con i prof che chattano con gli studenti? Scrive Luciano Lanna il 20 gennaio 2018 su "Il Dubbio". Delle due l’una: o ci si rapporta criticamente con gli insegnanti e i genitori oppure si fanno saltare i confini generazionali. Nel 1968 s’era diffusa una massima che venne spontaneamente assunta a slogan dello spirito di quell’anno di trasformazioni: «Non fidarti di nessuno che abbia più di trent’anni». Era un monito ironicamente offerto come consiglio da Charlton Heston ai giovani e ribelli scimpanzé nel grande successo hollywoodiano di quell’anno, Il pianeta delle scimmie. Uno slogan che si trasformò via via in una modalità esistenziale e in un rapporto nuovo rapporto, dialettico e critico, nelle relazioni tra generazioni. Anche per questo non capiamo come si possa sostenere – l’abbiamo letto sul Messaggero a firma Marina Valensise, una giornalista e studiosa peraltro documentata e sofisticata – l’esistenza di un nesso tra alcune recenti denunce di molestie e abusi a scuola, in particolare relativi a casi riguardanti sconfinamenti in questa direzione tra professori e allievi, e la cultura del ’ 68. La quale, filologicamente, si muoveva semmai verso un altro orizzonte: quello della diffidenza o della messa in discussione critica rispetto alla presunta autorevolezza delle generazioni precedenti. Cosa c’entra, insomma, il non fidarsi più a scatola chiusa e il cominciare a verificare criticamente i rapporti con gli adulti, fossero essi genitori, professori, politici, che è uno dei portati storicamente più importanti del ’ 68, con quella «deriva erotico- sentimentale che abolisce ogni barriera tra docenti e discenti, confonde i confini tra un professore e l’allievo, travolge ogni limite di sicurezza, scardinando gli argini del rispetto umano e professionale»? Delle due l’una: o ci si rapporta criticamente con gli insegnanti e i genitori oppure, è il caso opposto, si fanno saltare i confini generazionali e si ipotizza come normale che con un docente si possa chattare come se si trattasse di un coetaneo.
Come tanti altri, sia ben chiaro, Marina Valensise mostra di non avere dubbi: «Abolire – scrive – la cortina del rispetto, squarciare il velo un tempo invalicabile che dovrebbe separare maestri e allievi è l’ennesimo frutto marcio prodotto dal ’ 68 e dalla cultura del ’ 68». Mostrando così di seguire la vulgata ormai egemone, e diffusa da anni a destra, a sinistra e al centro, secondo cui il Sessantotto – anno che viene trasformato in un feticcio, in una entità ideologica – da anno cronologico si trasforma nell’origine di tutti i mali, sociali, antropologiche, culturali. Nient’altro che in un’utopia, «inservibile e obsoleta – leggiamo ancora sul Messaggero – che in nome dell’uguaglianza, del ripudio delle forme, della guerra alla gerarchia e alle differenze ha finito per logorare la vita pubblica, privando il corpo sociale dei suoi anticorpi e delle valvole di sicurezza necessarie al suo funzionamento».
Niente di nuovo, in realtà. È la solita e trita litania sulla rovina della scuola, sul tramonto del principio di autorità, sulla fine della famiglia borghese, sull’eclisse della meritocrazia. Quando invece, e la storia stessa lo attesa, il ’ 68 fu più che altro la messa in discussione e lo scoperchiamento di tutta l’ipocrisia che aleggiava nella percezione vissuta di queste dimensioni sociali.
Non ci stupiamo comunque del fatto che la pubblicistica sia ricaduta nella ripetizione di questa lettura. Sin dal primo decennale, nel 1978, e a proseguire nei tre seguenti anniversari tondi, non è mancato il profluvio di lamentazioni postume all’insegna della massima “da allora tutto non fu più come prima”. Con il sospetto che davanti alle solite esortazioni del tipo “finiamola col sessantottismo”, “è tempo di archiviare la cultura del ’ 68”, sia più che legittimo il dubbio che in realtà si voglia parlar d’altro senza averne il coraggio e senza lo sforza dell’elaborazione di nuove categorie adeguate a interpretare la complessità dei fenomeni a noi contemporanei. È la scorciatoia del pensiero pigro: è facile trovare una causa generale per tutto ciò che non comprendiamo e di fronte a cui ci troviamo spiazzati. È come il personaggio di Alberto Sordi che di fronte ai suoi fallimenti diceva “io c’ho avuto la malattia” o “io ho passato la guerra”. Sarebbe invece il caso, ora che siamo al cinquantenario, di “storicizzare” finalmente il ’ 68, di raccontare cioè quell’anno, con tutte le sue “rotture”, per quel che è stato veramente. E di smetterla di presentarlo come un feticcio ideologico da utilizzare come causa di tutti i nostri mali.
Oltretutto, da allora è passato mezzo secolo, un periodo così lungo e complesso, attraversato da altre faglie e altri sommovimenti globali, che è davvero impossibile quando non fuorviante individuare – come nel caso da cui siamo partiti – nei fatti del ’ 68 l’origine di fenomeni del tutto inediti e spiegabili solo con processi davvero molto lontani da quell’anno. Cosa avrebbe a che fare, insomma, il chattare in rete in una dimensione orizzonte e privata tra docenti e studenti e le eventuali conseguenze con le intuizioni dell’anno vissuto all’insegna dell’immaginazione al potere? Un anno denso di eventi rivoluzionari come il Vietnam e le proteste contro la guerra, gli studenti contro la polizia a Valle Giulia, il Maggio francese, la Primavera di Praga, gli assassini di Martin Luther King e Robert Kennedy, le convenzioni per le elezioni americane che videro la vittoria di Nixon, la nascita del femminismo… «Con stupore ed entusiasmo – annota Mark Kurlansky nel fondamentale ’ 68. L’anno che ha fatto saltare il mondo (Mondadori) – si scoprì che a Praga, a Parigi, a Roma, in Messico, a New York, si stavano facendo le stesse cose. Grazie a nuovi strumenti quali i satelliti per le telecomunicazioni e i videotape, la televisione stava rendendo ognuno consapevole di quanto stavano gli altri. E questo era elettrizzante perché, per la prima volta nell’esperienza umana, eventi importanti e remoti erano vissuti in diretta». Questo, non altro, fu il ’ 68. Il professore che non solo dà ai suoi allievi del tu, ma pretende che glielo diano anche a lui, insieme con l’e-mail, al numero di cellulare e all’amicizia su Facebook per poterli chiamare a tutte le ore del giorno e della notte non capiamo cosa avrebbe dello “spirito del ’ 68”. Uno spirito che, semmai, muovendoci sul piano dell’immaginario andrebbe storicamente visto nella presenza e nel ruolo di un premio Nobel come Bob Dylan e di un intellettuale come Francesco Guccini nello scenario odierno. Queste sì, due vere “lezioni” viventi del Sessantotto.
Mughini: «A Parigi nel ‘68 tiravo pavé sulla polizia, poi mi innamorai di Craxi». Il 76enne ex direttore di Lotta Continua, poi personaggio televisivo: «Gli intellettuali e la politica? Pagliacci, compreso Pasolini. Anch’io ho vissuto la depressione». Intervista di Aldo Cazzullo del 24 marzo 2018 su "Il Corriere della Sera".
Mughini, cosa ci faceva a Parigi nel Maggio ‘68?
«Avevo vinto una borsa di studio per specializzarmi in francese, lingua da me venerata. Facevo il lettore di italiano al liceo Hoche di Versailles: per me che venivo dalla provincia, era come passare dal Viterbo al Real Madrid».
Era nell’aria la grande rivolta?
«Non sarebbe venuto in mente a nessuno che stava per scatenarsi un tale pandemonio. “La Francia si annoia” titolò un giornale. Altrove il casino era già cominciato; anche se le cose italiane facevano ridere al confronto».
Perché?
«Ricordo una foto della mitica battaglia di Valle Giulia: un poliziotto panciuto non riusciva ad afferrare un giovane Giuliano Ferrara, che pesava già almeno 120 chili. Noi a Parigi avevamo di fronte i reduci della guerra d’Algeria».
Truppe addestrate alla guerra coloniale.
«Addestrate talmente bene che non hanno ammazzato nessuno».
Lei partecipò alla prima notte di battaglia.
«E ho tirato i pavé contro i poliziotti; ma non dall’alto delle case, come altri».
Nel libro «Era di maggio. Cronache di uno psicodramma» racconta di essersi nascosto al sesto piano, mentre dal quinto salivano i colpi dei flic e le urla degli studenti.
«I poliziotti avevano avuto 271 feriti gravi in una sola notte. Avevano visto i compagni con il cranio sfondato: cento di loro non tornarono mai in servizio, uno morì. È un miracolo che si siano limitati alle manganellate».
Fu una guerra?
«No; uno psicodramma. Fosse stata una vera guerra, loro avrebbero spazzato via tutte le barricate del Quartiere Latino in dieci minuti. Ma noi non eravamo insorti algerini; eravamo la più fortunata generazione del dopoguerra, quella che stava godendo della ripresa economica. Per una volta non eravamo al cinema o a teatro; il film, la rappresentazione teatrale eravamo noi. Uomini e donne pari erano».
Lei racconta la vera storia della Marianne fotografata con la bandiera nordvietnamita.
«Era una modella di famiglia aristocratica. Stanca di marciare, salì sulle spalle di un compagno. Quando vide un reporter, fece il suo mestiere: si mise in posa. Il nonno la riconobbe e la diseredò».
Anche sua nonna materna era un’aristocratica.
«Sì, ma decaduta. Conosco la situazione degli ultimi, perché da lì vengo. I miei genitori erano separati. L’unico lusso del nonno era un fiasco di vino la domenica. A casa non c’era nulla, né libri né quadri; avevamo una radio, si guastò, non avevamo i soldi per farla aggiustare. Andavo dagli amici a vedere in tv i Mondiali del 1958 e Mike Bongiorno. Non avevamo di che comprare un frigorifero, uno zio ci portava il ghiaccio. Avevo un unico paio di scarpe, per giocare a pallone e per passeggiare. Non sapevo cosa fossero le vacanze».
Quando comincia la politica?
«Ricordo il luglio 1960: uccisero un operaio edile vicino a casa, Salvatore Novembre. Tenni un comizio per il 25 aprile, in cui devo aver detto delle fesserie da vergognarmi. Ebbi un applauso come mai in vita mia».
Suo padre era fascista.
«Sì, a Catania era il numero 2 dopo il podestà. Ma non aveva nulla della retorica del regime, non diceva una parola più del necessario. Teneva una bellissima foto di Mussolini giovane dietro la scrivania. Combatté in Albania, poi raggiunse la famiglia a Firenze. Quando i partigiani entrarono in città si nascose. Tornammo a Catania, il viaggio in autobus durò un mese».
E la politica di oggi?
«Non mi appassiona».
I 5 Stelle?
«Li considero il nulla, sotto forma di declamazione populistica. In Sicilia il reddito di cittadinanza c’è già: i forestali, le pensioni di invalidità, l’Assemblea regionale…».
Lei è siciliano.
«Non mi sento siciliano; mi sento italiano. Lo accetto perché erano siciliani Verga, Pirandello, Sciascia. Inutile fingere che esista l’Italia unica del sogno risorgimentale. C’è l’Italia del talento, della creatività, dei conti a posto; e poi c’è il Comune di Roma».
Salvini?
«Non ci meritavamo un risultato elettorale che premiasse un personaggio di questa fatta. È triste stilisticamente e antropologicamente che sia lui a rappresentare la Lombardia, il cuore produttivo del Paese».
Berlusconi?
«Mi sta immensamente simpatico. È uno che ha creato un impero. Sono anni che lavoro a Mediaset e con la Rai non c’è confronto: vedi ragazzi assunti non dai partiti, ma perché hanno voglia di lavorare».
È andata così male il 4 marzo?
«Abbiamo vissuto due catastrofi nello stesso tempo: la sconfitta di Berlusconi e quella di Renzi. Io speravo al contrario che avrebbero governato insieme: centrosinistra, l’unica formula che in Italia abbia mai funzionato».
Renzi è finito?
«Niente affatto. La storia della politica è piena di resurrezioni: de Gaulle, Churchill, Fanfani…».
Sono accostamenti molto generosi.
«Perché, il Pd chi ha? Martina? Franceschini? Renzi non è finito, anche se è difficile immaginare una sequela di passi falsi come quella in cui è incappato».
Lei perché ha diretto il giornale di Lotta continua?
«Per un motivo liberale. Lo avevano fatto Pannella, Pasolini, Piergiorgio Bellocchio. Venne Sofri a casa mia, mi chiese di fare il direttore responsabile. Pensavo che quel giornale dovesse uscire. Di più, pensavo che quelli di Lotta continua fossero i migliori della nostra generazione. Mi sono costati 28 processi e tre condanne».
Lo pensa ancora?
«Sofri per caratura personale e intellettuale lo è senza alcun dubbio. Vuol mettere con quel che scrivono Gad Lerner o Mario Capanna?».
Sofri è condannato come mandante dell’omicidio Calabresi.
«Non ne sono convinto. La mia personale idea è che il delitto sia stato organizzato dai servizi d’ordine di Milano e Massa; Sofri allora stava a Napoli. Sapeva quel che stavano combinando, ma non credo sia il mandante. La prova non c’è. E comunque quando ha ricevuto l’ordine di carcerazione si è presentato la mattina presto e si è fatto sei anni. Non ha mai voluto dire che lo sparatore fosse Bompressi, anzi ha detto che quelli che uccisero Calabresi sono i migliori della nostra generazione».
Frase che lei non condivide, vero?
«Certo che no. È una frase però che lui ha pagato. Come non mi è piaciuto il libro patetico di Sofri su Pinelli: ci ha messo trent’anni a realizzare che Calabresi non era in stanza quando l’anarchico cadde».
Come sono andate le cose secondo lei?
«Come stabilì D’Ambrosio, che in quattro anni di indagini non trovò nulla contro Calabresi; a cui 800 intellettuali avevano dato del torturatore. Una vergogna nazionale».
Non stima gli intellettuali italiani?
«Quando parlano di politica sono dei pagliacci, tranne rarissimi casi; tra cui purtroppo non c’è Pasolini. “Io so tutti i nomi ma non ho le prove…”: sciocchezze micidiali. Ricordo un documentario in cui si confrontavano Guareschi e Pasolini: Guareschi lo dominava, se lo mangiava a colazione. Ucciso per il libro Petrolio? Pazzesco».
Com’è morto Pasolini, secondo lei?
«I ragazzi di vita che lui aveva celebrato gli tesero un agguato. In tre o quattro l’hanno ridotto in quel modo; e Pelosi non ha mai fatto i nomi».
Però lei stimava Craxi.
«Moltissimo. Nel 1974 lo invitai a presentare il mio primo libro con Cicchitto e due comunisti, Reichlin e Chiaromonte. Loro arrivarono in anticipo, con un pacco così di appunti. Craxi ci raggiunse con tre quarti d’ora di ritardo. Il libro non l’aveva neanche aperto. Disse solo: “Di cosa stiamo parlando, finché è in piedi il Muro di Berlino? Finché i comunisti opprimono mezza Europa?”. Me ne innamorai perdutamente».
Non è finito bene.
«Mani Pulite fu un regolamento di conti mafioso. Uccise il Psi, la Dc e gli altri partiti che avevano costruito la democrazia italiana; così vennero fuori l’Msi, la Lega e un partito costruito dagli impiegati di Publitalia. Il crollo culturale è evidente».
Lei fu anche tra i fondatori del Manifesto.
«Sì. Volevano uno diverso da loro, che non fosse un fuoriuscito dal Pci. Dopo tre mesi me ne andai».
Non li stimava?
«Tutt’altro. Erano un gruppo di fuoriclasse, Pintor su tutti; ma facevano un giornaletto a sinistra del Partito comunista. Non si poteva sentire Luciana Castellina dire stupidaggini tipo che la scelta di Ingrao di restare nel Pci era segno di decadimento morale. Raccolsi una serie di pareri critici sul Manifesto e li pubblicai. Lucio Magri mi disse che avevo sbagliato. Presi la mia borsa e uscii. Solo la sua morte ha cancellato la mia ira; adesso lo considero un fratello».
Perché?
«Perché anch’io l’anno scorso ho vissuto la depressione. Quattro mesi in cui la vita non mi parlava più. In cui non riuscivo a leggere un libro: come restare senz’aria. Lucio Magri è andato in Svizzera una prima volta, ed è tornato indietro. È andato una seconda volta, e di nuovo è ritornato. La terza volta è stata l’ultima».
Le manca non aver avuto figli?
«Non sarei stato all’altezza di fare il padre. E non ho mai pensato di sposarmi. La storia con Michela è una scelta che si rinnova ogni giorno. Sono sensibile a tutto ciò che negli uomini è tenebra, solitudine, dolore. Montanelli mi raccontò di aver vissuto sette depressioni. Momenti in cui il cielo gli appariva nero».
Come conobbe Montanelli?
«Gli scrissi una lettera aperta su Pagina, la rivista che facevo con Galli della Loggia, Mieli e Massimo Fini. Mi chiamò e mi propose una rubrica sul Giornale, L’Invitato. Offrì 250 mila lire. Risposi: meglio 300. Discutere sul prezzo è sempre stato un punto della mia religione laica».
Cosa c’è nell’aldilà?
«Nulla. Rispetto chi ci crede; ma la sopravvivenza dell’anima è una favoletta consolatoria. Com’è l’anima di Brigitte Bardot?».
Giampiero Mughini, il mio '68. "Diritti, sesso e libertà. Poi venne il terrore". Intervista al giornalista e intellettuale. Il Sessantotto cominciò all'inizio degli anni '60 con gli scioperi alla Fiat e finì con l'omicidio di Moro nel1978. Divenne una guerra civile tra giovani. Intervista di Davide Nitrosi del 21 gennaio 2018 su Quotidiano.net. Il maggio francese, Valle Giulia, Praga, Ian Palach. Lotta continua, Potop, il movimento. E le ragazze con le minigonne e il sesso libero, il corpo è mio. Poi vent’anni fra terrore rosso, antilopi e giaguari, la democrazia.
Il Sessantotto compie 50 anni. Giampiero Mughini, è giusto celebrarlo?
«Celebrare non è la parola pertinente. Diciamo comprenderlo».
Non l’abbiamo ancora compreso?
«Comprenderlo significa innanzitutto sapere che il Sessantotto è durato 20 anni. È cominciato all’alba degli anni Sessanta con gli scioperi furibondi alla Fiat di Torino, quando la Fiat dettava tempi e umori della sinistra, ed è morto con Aldo Moro, il 9 maggio 1978, quando il corpo di Moro assassinato a freddo fu ritrovato in un’auto lasciata dai terroristi, sedicenti rivoluzionari, a metà strada tra la sede del Pci e quella della Dc».
Genesi operaia, epilogo tragico?
«Inizia con gli scioperi, ma non è solo la fabbrica. È anche cambio culturale. Nel 1961 nasce la rivista madre del gauchismo, Quaderni Rossi, e dopo di lei tante altre riviste, come quella che creai io a Catania, Giovane critica. Si prepara il terreno, il linguaggio, la poetica del Sessantotto vero e proprio».
Al centro una generazione nata sulle macerie della guerra: è un caso?
«No, perché era tutto elettrizzante, perché c’era stato il boom demografico, ed eravamo tanti ad avere 20 anni negli anni Sessanta e a condividere la crescita esaltante dell’Italia. Venivamo dalla povertà, ma stavano vivendo un momento in cui il mondo mandava messaggi eccitanti. La nuova moda, la nuova musica, la nuova cultura».
Non era un fenomeno elitario?
«L’élite ha fatto scattare il Sessantotto, ma poi i cortei erano ampi e popolari. A dare il via furono gli universitari del 30 e lode, molto diversi dai grillini di oggi. Ma poi vennero subito le manifestazioni, fu un grande casino perché il cambiamento toccava la vita quotidiana, le relazioni. Per la prima volta ragazzi e ragazze condividevano esperienze assieme».
La vita privata diventò vita collettiva.
«E fu la grande novità. Non il socialismo realizzato sulla terra, non il comunismo: la grande novità fu la trasformazione molecolare della vita».
Caddero i tabù. Oggi certe libertà verrebbero scambiate per molestie?
«Oggi è cambiato tutto, non è paragonabile. La società italiana di quegli anni è lontana dall’oggi come gli etruschi».
Che cosa fu la rivoluzione sessuale per i giovani del tempo?
«Fu un percorso e una bellissima scoperta. Uno choc rispetto alla mia educazione. Io arrivavo da una scuola di preti dove unica cosa che insegnavano era la sessuofobia».
E voi ribaltaste tutto?
«Quell’Italia fu ribaltata dalla nostra esperienza concreta. Sperimentavamo che avere accanto le ragazze, soprattutto le ragazze in minigonna, era una gioia. Quando vidi per la prima volta il mio amore dei vent’anni in minigonna, beh, capii che dio esiste!»
In quelle assemblee e occupazioni in fondo comandavano gli uomini. Restava il maschilismo?
«Assolutamente no. Ricordo solo che c’erano alcune ragazze che nelle occupazioni stavano in cucina mentre noi sproloquiavamo. Ma non tutte. La polemica sul maschilismo è stata inventata a posteriori quando al congresso di scioglimento di Lotta Continua alcune compagne salirono sul palco a dire che i loro uomini erano dei cazzoni che non valevano niente a letto».
Ma dopo il ’68 vennero gli anni Settanta e la violenza.
«Gli anni della guerra civile fra giovani. A differenza della guerra civile combattuta fra il 1943 e 1945, quella degli anni Settanta fu una guerra psicotica, anche se con molti morti. Ciascuno dei due gruppi considerava la parte avversa come una parte da distruggere».
Gli anni di piombo nascono dal Sessantotto?
«Vi nascono filologicamente. Già nel ’70 c’erano Curcio e Franceschini, c’era il gruppo di Sociologia a Trento. È un ecosistema che nasce a partire dal 1969 e dura fino alla morte di Moro. Se le Br avessero liberato Moro e si fossero presentate alle elezioni avrebbero preso un milione e mezzo di voti, perché avevano un seguito».
Un ecosistema, appunto.
«Quando rapirono Moro, ero sull’autobus e il passeggero vicino a me commentò la notizia dicendo: se lo merita. I grillini non sono nati adesso, mi ricordano quelli che vedevano la Dc, il più grande partito democratico dell’Occidente, come un nemico a prescindere. Questo è stato il cotè tragico e fallimentare del Sessantotto».
Un fallimento quindi alla fine?
«Non tutto. Il non fallimento è stata la rivoluzione della vita quotidiana, che allora è cambiata per tutti noi e che è l’aspetto più importante della nostra dimensione. Il divorzio, i diritti...».
Giampiero Mughini: "All'islam servirebbe un 1968", Intervista di Gianluca Veneziani del 24 Ottobre 2017 su "Libero Quotidiano". Di quella stagione lui è stato figlio ma, in un certo senso, anche padre, visto che con la rivista Giovane critica - da lui fondata e diretta a Catania nel 1963 - anticipò lo spirito e i temi del Sessantotto. Ora che si approssima il 50mo anniversario di quell’anno cruciale nella storia del Novecento, Giampiero Mughini prova a tracciare un bilancio in chiaroscuro dell’eredità di quell’epoca, ma anche ad analizzare come sia cambiato rispetto a mezzo secolo fa il ruolo dell’intellettuale nell’influenzare le evoluzioni della politica e della società.
Mughini, il ’68 fu una rivoluzione di studenti e operai, ma anche di intellettuali. Si pensi, per esempio, al ruolo dei Marcuse e dei Sartre. Oggi un intellettuale potrebbe avere la stessa capacità di favorire un cambiamento così radicale?
«No, oggi gli intellettuali umanisti sono dei ruderi, parlano con gli amici e basta, i loro principali vettori di espressione, i giornali, hanno un’influenza minima, pesano sull’opinione pubblica al 5% o forse meno, laddove Instagram vale il 20% o forse più. La tecnologia ha squassato le precedenti gerarchie e forme di comunicazione: gli unici intellettuali che contano sono quelli che attrezzano robot e computer, che permettono il lancio in cielo di missili ultrapotenti, i medici che combattono malattie micidiali. Ma non me ne rammarico. L’intellettuale così come è stato concepito in passato non è un’icona indistruttibile, è una figura storica che ha avuto un grande peso tra Otto e Novecento, tra Émile Zola e Benedetto Croce. Oggi a noi non resta che fare bene il nostro mestiere».
E nei confronti della politica un intellettuale umanista cosa può fare? Coltivare ancora il mito di essere engagé o costringersi all’isolamento?
«Se vuoi essere libero, non puoi che essere inorganico. L’alternativa è restare isolati o essere asserviti a qualche famigliola politica. Ma in quest’ultimo caso devi lustrare le scarpe al potente di turno e spiegare quanto la tua famigliola o la tua gang abbia ragione. Allora io preferisco rimanere isolato, isolatissimo. Non ho più un giornale su cui scrivere, ma almeno quando mi guardo allo specchio non ho nulla di cui vergognarmi, come quelli adusati a fare l’elogio di Berlusconi, Renzi, Grillo o della Boldrini».
Vale lo stesso anche per chi prova a portare qualche idea in tv?
«Per andare in televisione a esprimere ciò che pensi devi essere gradito a chi la tv la possiede, a Cairo, alla sinistra vicina a Repubblica, alla maggioranza renziana. Quando mi invitano in tv, vado volentieri a fare due chiacchiere. Ma è un segno dei tempi che io debba parlare di calcio. Il calcio ha una platea immensa. Se io andassi a parlare di libri, la platea sarebbe miserrima. La tv, si sa, ha bisogno di grandi numeri. E l’unico modo per portare i libri in tv, come ha provato a fare Baricco, è far parte del giro…».
Quanto la stagione del berlusconismo ha inciso nel depotenziare il ruolo dell’intellettuale anche in televisione?
«A dispetto di quanto si pensi, Berlusconi non disprezzava e non disprezza gli intellettuali. Alla sua prima discesa in campo arruolò in squadra menti come Lucio Colletti, Saverio Vertone, Piero Melograni, figure provenienti dalla sinistra e da quella allontanatesi. Ma Berlusconi è stato anche molto generoso nei confronti degli intellettuali, ha pagato bene direttori di quotidiani e tv, giornalisti, opinionisti. Ricordo quanto fosse munifico quando lavoravo a Panorama… Da uomo intelligente qual è non può avercela con gli intellettuali. Certo, gratifica gli intellettuali che non ce l’hanno con lui».
Esattamente 30 anni fa tu pubblicavi il libro Compagni, addio, tuo atto definitivo di distacco dall’intellighenzia sinistrorsa. Oggi che effetto ti fa vedere una sinistra completamente depensante, asservita soltanto al vangelo del Politicamente Corretto?
«Il termine sinistra non vuol dire più nulla da tempo, si è ridotto a una parola passepartout che riguarda temi astratti come il bene pubblico, la lotta alle ineguaglianze ecc. Sinceramente, se oggi Togliatti assistesse allo spettacolo di questa sinistra, divisa in tante famigliole, e alle beghe tra Pisapia e D’Alema, scoppierebbe a piangere. Ma anche il Pd in realtà non esiste, è solo una somma di ambizioni e arroganze personali. La sua obbedienza al Politicamente Corretto sulla questione dei migranti, del femminismo militante è la ricerca di una risposta già pronta che tuttavia non risolve un bel niente».
A livello culturale, invece, la destra pare contorcersi nel dibattito tra sovranisti e indipendentisti. Tu da che parte stai?
«Quello che sta accadendo in Catalogna è una robaccia orripilante: esistono dei Paesi, delle nazioni con le loro diverse anime ed etnie, ma anche con una storia in comune. L’idea che la Catalogna diventi uno Stato è semplicemente ridicola, non credo che la stessa gente di Catalogna lo voglia. Allo stesso modo, il referendum per l’autonomia fiscale di Lombardia e Veneto non andava fatto, e i risultati possono appenderseli in bagno. È assurdo pensare che la più grande regione d’Italia voglia rendersi autonoma dall’Italia, sarebbe uno schiaffo ai Silvio Pellico, ai Carlo Cattaneo, a chi l’Italia l'ha costruita davvero».
A breve si voterà anche in Sicilia, isola dove tu sei nato e cresciuto e che più volte hai detto di “odiare”. Chiunque vinca le Regionali, pensi che l'isola resterebbe irriformabile?
«Tanto per cominciare, io concederei un’autonomia totale alla Sicilia solo per vedere l’effetto che fa. In 15 giorni l’isola andrebbe in fallimento perché non è in grado di autogestirsi: lì c’è un’evasione fiscale inverosimile e sprechi indecenti, a partire dalle commende che ricevono i deputati dell’assemblea regionale. In Sicilia hanno vinto un po' tutti nel tempo, Berlusconi, Leoluca Orlando e ora rischiano di vincere i grillini, ma la politica comunque non potrà mai farci nulla, perché i politici siciliani sono figli di quella cultura».
A proposito di grillini, un loro eventuale trionfo alle prossime Politiche come potrebbe essere riassunto in uno slogan para-sessantottino?
«Sarebbe la vittoria dei politici di professione che tuttavia non avevano una professione prima di entrare in politica. I grillini non avevano un lavoro, non avevano competenze, non avevano un curriculum e ciascuno di loro ha avuto qualche decina di preferenze. Di quanto siano sprovveduti, te ne accorgi da quello che dicono Di Battista e Di Maio: Napoleone che vince la battaglia di Auschwitz, Pinochet dittatore del Venezuela… Pensare che il più grande partito politico italiano oggi è segnato dal colossale confronto tra Fico e Di Maio mi fa semplicemente rabbrividire».
Tornando all’inizio. Il prossimo anno si celebrano i 50 anni dal '68. È tempo di dire addio anche a quella stagione o di conservarne qualche traccia positiva?
«Io sono cresciuto in quegli anni, i suoi marchi mi sono rimasti addosso, e ho passato il tempo a smacchiare buona parte di essi. Di quella stagione salvo tutta la parte di libertà, di creatività, di rottura degli schemi tradizionali e naturalmente condanno la seminagione della violenza e del fanatismo ideologico. Si tratta di un’analisi complessa da fare però, perché il Sessantotto in Italia non fu un anno ma un periodo cominciato ai primi degli anni ’60 e terminato col ritrovamento del cadavere di Moro. Indubbiamente le ricadute nel costume, nel modo di vivere, nella cultura, nei libri, nei film e nei valori di riferimento sono state enormi. Anche in politica il '68 ha inciso nel senso che molti dei politici che oggi siedono in Parlamento sono figli di quegli anni. Ma è stata la rivoluzione nella società quella decisiva. Pertanto auspico che ci sia un '68 anche nell’islam: una società più secolarizzata contribuirebbe a limitare i radicalismi e gli estremismi. Anche se, a essere onesto, non la vedo una prospettiva probabile».
«Quando nascono i tribunali muoiono le rivoluzioni». A cinquant’anni dal Sessantotto un viaggio nella memoria con il leader del movimento studentesco. Intervista di Daniele Zaccaria del 26 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Conversare con Oreste Scalzone è un’esperienza proustiana e futurista allo stesso tempo. Il flusso della memoria scorre come un torrente, ma non è sempre un corso tranquillo, dalle acque affiorano improvvisi i vortici, e il gorgo dei ricordi procede agitato da un demone errante, con lo sguardo che punta fisso l’orizzonte in una specie di eterno presente. «Sono un ipermnesiaco (lo sviluppo eccessivo della memoria n. d. r.), anche se ogni tanto, come diceva Freud e come accadeva nel Rashomon di Kurosawa, posso vivere qualche illusione di memoria». Cinquant’anni fa, quando la società occidentale venne travolta dalla rivoluzione del ‘ 68, Scalzone era un giovane leader del movimento studentesco. In questi giorni di celebrazioni museali che fanno di quell’annata formidabile una specie di Risorgimento scamiciato, Scalzone accetta di tornare sul “luogo del delitto” per abbozzare quella che lui chiama con modestia una “anti- celebrazione”, una “anti- cerimonia”. Ma prima di tornare a quei giorni di marzo ‘ 68 vuole togliersi un sassolino dalla scarpa: «Questa vicenda dei fascisti che avrebbero avuto contatti con il movimento studentesco per organizzare gli scontri di Valle Giulia è una totale fake- memory che si basa unicamente sulle dichiarazioni di Delle Chiaie Stefano, detto “caccola”. Delle Chiaie era odiato in primis dai fascisti per così dire “puri”, che lo vedevano come un uomo dei servizi segreti. Il movimento non aveva alcuna contezza di quelle dinamiche, è probabile che ci furono tentativi di infiltrazione che però non riuscirono. I fascisti erano arroccati nella facoltà di giurisprudenza e il comitato di agitazione dell’Ateneo aveva deciso semplicemente di ignorarli, come fossero un tumore morto, non li vedevamo e intorno a loro c’era una specie di cordone sanitario. Le cose cambiarono la notte tra 15 e il 16 marzo, quando delle squadre di picchiatori del Msi entrarono alla Sapienza attaccarono i loro extraparlamentari sgomberandoli manu militari i e attaccarono il picchetto del movimento a Lettere ferendo alcuni compagni».
Cosa ricordi di quella mattina?
«Arrivai all’università di buon ora, quelli del Msi si erano già asserragliati dentro giurisprudenza con gli onorevoli Almirante e Caradonna. A quel punto noi lanciammo un attacco improvvido, generoso ma improvvido, tanto che avanzando potevamo contare i feriti, dall’alto ci lanciavano di tutto, biglie di ferro, vetri, oggetti di ogni tipo, poi sento uno schianto, la panca lanciata dall’alto colpisce di sbieco una sedia con cui malamente mi coprivo…, il contraccolpo mi schiaccerà due vertebre, vengo trascinato via, mi portano in ospedale, intanto la battaglia continua. Alcuni compagni scovano una porta secondaria e riescono a entrare, sono una dozzina e si trovano soli davanti Almirante, avrebbero potuto linciarlo, ma comprensibilmente esitarono, e l’attimo passò, fortunatamente non si aveva la stoffa di linciatori… A quel punto entrò in forze la polizia. Ora, per chi sostiene che ci fosse ambiguità tra il movimento e l’estrema destra, cito il dottor Paolo Mieli e il professor Agostino Giovagnoli, cosa avremmo dovuto fare? Linciare Almirante per dimostrare il contrario? Peraltro su quei giorni continuano a essere scritte e dette enormi sciocchezze. Molte ispirate da un misero “pasolinismo” di ritorno».
Cosa intendi?
«Parlo di questa divisione artificiosa tra i poliziotti figli del proletariato mandati nelle città a prendersi le botte dagli studenti figli della borghesia. Di sicuro Paolo Mieli era un figlio della borghesia, io ero un semplice pendolare di Terni, ma di cosa parliamo? Alla Sapienza c’erano più di 70mila iscritti, l’università era già un luogo di massa e nel movimento c’era di tutto, compresi i figli dei “cafoni” del sud, i figli degli operai mandati a studiare nella grande città per diventare ingegneri. Certo, la maggioranza dei leader proveniva da famiglie istruite ma solo perché, come diceva Don Milani, possedevano le parole sufficienti per diventare i capi, nelle facoltà e nelle piazze però il protagonista era altro, no?»
Pasolini si sbagliava dunque?
«Di sicuro si sbagliava sulla composizione sociale del movimento studentesco, e dire che sarebbe bastato aver ascoltato un mezzo discorso di Franco Piperno, non dico di aver letto Marx. Si sbagliava anche nella sua mitologia poetica della classe operaia che per lui era incarnata solamente dagli operai con la tuta e le mani callose e “professionali” quando già allora la figura centrale erano gli operai di catena, in gran parte immigrati dal Sud, quelli che si raccontano in Vogliamo tutto! di Balestrini; inoltre già allora avanzava il precariato tra le giovani generazioni. Si è sbagliato anche sulla natura del Pci, in questo sono d’accordo con lo storico Giovanni De Luna, Pasolini dice ai giovani di andare verso il Pci, pensare che quel movimento potesse andare verso il Partito comunista era una sciocchezza. Neanche il segretario Luigi Longo aveva il coraggio di affermare una cosa simile. Infine si sbagliava sui poliziotti, per lui erano «dei bruti innocenti» in quanto li riteneva delle bestioline irresponsabili, «li hanno ridotti così». Anche in questo caso è una lettura semplicistica, basterebbe un po’ di piscoanalisi, penso a Willelm Reich: esiste un margine di responsabilità in chi commette atti brutali e sadici, è la psicopatologia dell’ultimo dei crociati che s’intruppa dietro Pietro l’Eremita a fare la “teppa eterna” mentre a Gerusalemme, scrivono gli storici, «il sangue arrivava alle ginocchia». La stessa teppa descritta da Varlam Salamov nei Racconti di Kolyma che in quel caso erano i cechisti, ma potremmo parlare anche delle Guardie rosse, di chi andava a evangelizzare di chi andava islamizzare, di chi andava a colonizzare».
Un rapporto mortale e mimetico quello della sinistra rivoluzionaria e libertaria con il potere e la violenza costituita.
«Prendendo spunto dal Foucault di Microfisica del potere, quando si costituisce un tribunale del popolo o del proletariato, una giustizia istituita, la mutazione è già avvenuta, la rivoluzione è già diventata controrivoluzione. Il passaggio da «potere costituente» a «costituito», come dice Agamben, è stato la tragedia di tutte le «Rivoluzioni» che hanno «preso il potere». Questo, microfisicamente, è sempre in agguato anche per noi. Nei giorni del rapimento Moro, ero convinto che il movimento dovesse “interferire” con le Brigate Rosse per scongiurare il rischio che si lasciassero sospingere ad un epilogo annunciato, atteso e come prescritto della sentenza di morte».
Più volte hai criticato la sinistra e il suo antifascismo razziale, cosa intendi?
«Mi vengono in mente (oltre a Sergio Ramelli) i fatti di Acca Larentia: se un commando di estrema sinistra apre il fuoco su un gruppetto di ragazzotti fascisti uccidendone due e poi quelli escono con il sangue agli occhi e le forze dell’ordine ne uccidono un altro, io mi sento molto a disagio come dissi all’epoca a Giorgio Bocca che mi intervistò per Repubblica. Non si possono trattare i fascisti come fossero dei “diversi”, questo è un approccio etnico, razziale al conflitto politico e l’antifascismo rischia di diventare un ulteriore strumento di regime. All’epoca fui molto criticato per questa mia posizione, in questo caso come che Guevara, che per inciso è stato anche un uomo feroce: «Dobbiamo essere implacabili nel combattimento e misericordiosi nella vittoria»».
Il “fascismo” viene continuamente evocato come fosse il sinonimo, l’equivalente generale, del male assoluto.
«Potrei rispondere che le parole sono importanti, e che l’equivalenza fascismo- male assoluto è contraddittoria perché due totalità non possono convivere. Partirei invece dal fascismo storico, il cui demiurgo è stato Benito Mussolini, una figura di un’ambiguità degna del post- moderno. Mussolini aveva certamente letto il Manifesto del partito comunista, ma ignorava il primo libro del Capitale. Di padre anarchico e di madre maestrina dalla penna rossa, diventa già da molto giovane la figura di punta della sinistra massimalista italiana come scrisse lo stesso Lenin. Un personaggio social- confuso, ma pure questa non è necessariamente una colpa, anche il mio amico Pannella poteva sembrare un Cagliostro liberal- liberista che mischiava tutto. Soreliano, socialista, prima pacifista che gridava «guerra alla guerra», poi il transito per l’interventismo democratico di Salvemini un’area in cui peraltro passarono anche Gramsci e Togliatti. Poi si riconverte ancora, approda all’irredentismo, da avventuriero sfrutta il reducismo dei “terroni di trincea” messi in conflitto con gli operai delle fabbriche del nord, visti come un’aristocrazia operaia dei Consigli che partecipava alla produzione di guerra. Da talentuoso avventuriero Mussolini riesce a mischiare tanti elementi, ruba il nome dei Fasci siciliani, si prende il nero della camicia degli anarchici, si porta dietro sindacalisti rivoluzionari come De Ambris e Corridoni, si prende il futurismo suprematista italiano ma anche russo e crea uno strano melange, quasi un kitsch post- moderno».
L’antisemitismo era connaturato al regime?
«No, Mussolini non era un antisemita. Nel ‘ 32, rispondendo a una domanda sulla questione ebraica che gli pose il biografo tedesco Emil Ludwig afferma secco: «Quella è roba vostra. Cose da biondi, da tedeschi». Le svolte successive del regime vennero prese per opportunismo e non per convinzione ideologica. Però in tutto questo kitsch infinito rimane un elemento essenziale e coerente che può definire il fascismo: la guerra alle organizzazioni operaie, non alla classe operaia in quanto tale che può essere cooptata dalle corporazioni, ma alle sue organizzazioni, dalle più riformiste alle più sovversive. Quello è il nemico, la sua ossessione persistente, come l’antisemitismo fu l’ossessione psicotica dei nazisti. Qui c’è un filo conduttore che porta dritto al complottismo, un paradigma sinistro, che può guidare anche quelli che sventolano le bandiere rosse e di qualsiasi colore. Detto tutto questo vorrei però chiarire un punto».
Prego.
«I termini contano anche in quanto autodefinizioni, “terrore” nasce come autodefinizione di Saint Just e Roberspierre, “totalitarismo” non è una parola inventata da Hannah Arendt ma da Mussolini Benito proprio per definire il suo regime».
Oggi in Europa esiste un rischio concreto che movimenti o regimi di estrema destra, razzisti e autoritari prendano il sopravvento?
«Prendiamo il caso Traini, lo psicopatico neonazista e ultras leghista di Macerata che voleva compiere una strage di migranti, su questo punto la penso come Felix Guattari: Traini è senz’altro uno psicopatico ma se dieci psicopatici si mettono una divisa delle Sa non possono essere liquidati come dei malati di mente, diventano dei ne-mi-ci. E qui nasce un grandissimo problema. In questo sono d’accordo con l’analisi Bifo che parla di “inconscio disturbato della nazione”».
Qual è il più grande nemico della sinistra?
«È un nemico interno e si chiama complottismo, una vera e propria tragedia culturale, un pensiero demoniaco e cospirazionista che diventa responsabile di quella mutazione di cui parlavo, il passaggio dal potere costituente al potere costituito, mi piace citare Agamben e la sua riuscita formula (di risonanza spinoziana) “potenza destituente”. Per il complottismo qualsiasi gesto di rivolta, dal Camus dell’- Homme revolté al suicidio di Jan Palach è sempre un gesto manipolato, eterodiretto, ma il complottismo vive di falsità, di contro- revisionismi e generalizzazioni, non tocca mai un dente a quelli che chiama manipolatori, è inoffensivo per il potere ma letale per chi combatte il potere».
Il destino degli esseri umani è la ribellione?
«Non esercitare l’inferenza per la specie umana la pone al di sotto delle altre specie, la nostra specie si sporge fuori dall’essere per inseguire la conoscenza, l’arte, la politica. A differenza dei girini e dei puledri noi nasciamo prematuri, iniziamo a camminare a un anno e mezzo mentre il puledro cammina già poche ore dopo la nascita. Il leone è un predatore e caccia la gazzella che in quanto preda tenta di fuggire, nessuno di loro è felice o infelice. Noi invece, per realizzarci, abbiamo bisogno della protesi della conoscenza. L’albero del peccato in tal senso è proprio una bellissima metafora del nostro destino.
E il futuro?
«Il futuro non esiste, il futuro è la narrazione dei dominanti».
Buttiglione: “Il ’68? Aveva bisogno di Gesù invece ha scelto Marx…”. Rocco Buttiglione, filosofo allora ventenne, parla del Sessantotto. Intervista di Giulia Merlo del 25 Marzo 2018 su "Il Dubbio". Lo racconta col sorriso di chi parla di una stagione felice e ingenua, com’è quella parte della giovinezza che forma il carattere e la visione del mondo. Per Rocco Buttiglione, nato a Gallipoli nel 1948, il Sessantotto è stato l’anno di una rivoluzione fatta di fede più che di lotta di classe e sfociato poi in un’organizzazione – Comunione e Liberazione – che rispondeva alle domande di una generazione con le parole del Vangelo di Giovanni. Eppure, da cattolico, si è sentito parte di quel grande movimento studentesco, ricorda le stesse piazze e, in fin dei conti, ne ha condiviso la stessa esigenza di cambiamento.
Lei a vent’anni che ragazzo era?
«Dov’ero, prima di tutto. Nel 1967 mi ero appena immatricolato alla facoltà di giurisprudenza a Torino e nel novembre di quell’anno iniziò l’occupazione studentesca di Palazzo Campana, che era la sede delle facoltà umanistiche. A Torino, però, arrivai prima, durante l’adolescenza. La mia famiglia si spostava molto e, seguendo il lavoro di mio padre, a Torino arrivai da Catania e mi volli iscrivere al liceo Massimo D’Azeglio, tempio della cultura torinese e dell’anticlericalismo. Mi consigliarono subito di ripensarci ma io mi intestardii: mi presentai in classe molto fiero del mio perfetto accento siciliano e scoprii che lì essere meridionale e cattolico non era un vanto. I torinesi erano imbevuti di cultura azionista e dunque fortemente anticattolica, mentre antimeridionali lo erano senza saperlo, gli veniva naturale».
Come stava un meridionale cattolico a Torino?
«Innanzitutto persi l’accento catanese, poi scoprii che anche i torinesi avevano i loro complessi di inferiorità. Verso l’estero, però, e in particolare nei confronti degli Stati Uniti e della scienza tedesca. Ironicamente, il fatto che parlassi correntemente inglese e tedesco riscattò il fatto che fossi meridionale e cattolico. Poi all’università trovai un porto franco: l’istituto di scienze politiche era presieduto da Alessandro Passerin d’Entrèves, professore cattolico, ma anche ex capo della resistenza e insegnante ad Oxford. Per questo suo profilo esterofilo e partigiano godeva di una sorta di immunità e aveva creato uno spazio in ateneo in cui i cattolici erano tollerati. Nel Sessantotto l’idea era che l’Università fosse nostra, un luogo in cui non eravamo ospiti e dove si imparava non un mestiere, ma un sapere critico che indagava la verità dell’uomo».
Come si spiegava questo antagonismo nei confronti dei cattolici?
«A Torino interagivano tradizioni diverse: io venivo da una famiglia che aveva combattuto la guerra contro i tedeschi e per i miei genitori la resistenza era stata la lotta per la liberazione dell’Italia. A Torino, invece, per molti la resistenza era una cosa diversa: era stata una lotta per il comunismo, interrotta dall’intervento degli americani, che sconfissero i tedeschi e occuparono il Nord, e del Vaticano, che mobilitò il popolo per votare contro un governo comunista. Ecco, per chi era cresciuto in quella prospettiva, il Sessantotto era la grande occasione per portare a termine la rivoluzione incompiuta che era stata la resistenza».
Si avvicinò allora alla politica?
«Nel 1967 fondai con un gruppo di amici Gioventù Studentesca, un movimento cattolico da cui poi nacque Comunione e Liberazione e che fu parte del movimento studentesco».
Partecipavate alle manifestazioni di piazza coi vostri colleghi dei gruppi di sinistra?
«Sì certo. Uno dei punti caratteristici del movimento era la scelta della non violenza e l’idea del sit-in. Ci siedevamo tutti, poi arrivava la polizia che ci prendeva di peso e ci portava via. Ricordo che i poliziotti ci alzavano quasi con garbo e anche con una certa simpatia nei nostri confronti. Era il novembre del 1967. Poi, l’anno dopo, mi trasferii a Roma e anche qui fondai Gioventù studentesca».
Voi cattolici vi sentivate parte del movimento giovanile?
«Nel ‘ 67 moltissimo. Non eravamo discriminati, organizzavamo i nostri controseminari ed eravamo parte di quel grande movimento generazionale. Perchè questo è stato: un enorme movimento di massa, centrato sul bruciante desiderio di rompere con l’ipocrisia della società che ci circondava e di creare rapporti nuovi, fondati sulle relazioni interpersonali. In una parola, volevamo liberarci dall’egoismo individualistico per creare una nuova comunità. La nostra era una domanda di autenticità».
E avete trovato una risposta?
«Noi pensavamo che la fede cristiana fosse la risposta. Ancora oggi, sono convinto che la grande domanda generazionale del Sessantotto fosse prima di tutto una domanda religiosa, non una domanda politica. Il terrorismo successivo, che cominciò nel 1969, nasce proprio da questo errore: l’idea di dare una risposta tutta politica a una domanda religiosa».
Quanto ha litigato coi militanti della sinistra?
«Moltissimo. Ricordo una discussione con Mario Capanna, qualche anno dopo il 1968, a Milano. Comunione e Liberazione cresceva e noi ci consideravamo parte del movimento studentesco, ma Capanna voleva spiegarci che non era vero. Io obiettai che anche noi eravamo pronti a condividere la lotta di classe come lotta per la giustizia, ma lui mi rispose che non era sufficiente. Mi disse: «Anche se dite co- sì, per voi al primo posto non ci sarà mai la lotta di classe ma Gesù Cristo. Quindi siete dei reazionari, in questa università non avete diritto di parola e non ci metterete mai piede». Sei mesi dopo, Cl vinse le elezioni alla Statale».
Il Sessantotto è stato anche il momento della rottura con un certo modello di famiglia. Lo fu anche per i cattolici?
«Anche noi, solidarmente con la nostra generazione, eravamo in rivolta contro le nostre famiglie. La differenza, però, stava nel fatto che a questa rivolta offrivamo un’altra prospettiva educativa, in chiave critica ma non di rottura. Noi pensavamo che il conflitto è un elemento necessario ma positivo, poi si deve riconciliare: contestare significa non prendere alla lettera gli insegnamenti ma verificarne la veridicità nella propria vita, mettendo alla prova i valori proposti. Contestavamo piuttosto un certo modo di essere famiglia e ci siamo riconciliati con essa cambiando profondamente i modelli di interazione familiare».
E’ stata la declinazione cattolica di quello che fu la cosiddetta “liberazione sessuale”?
«Noi l’abbiamo vissuta come l’acquisizione di libertà rispetto alla coazione familiare, ma anche l’acquisizione di una responsabilità. Una delle cose di cui sono più grato a Cl e a Don Giussani è che ci ha insegnato a innamorarci, ad avere fiducia nel nostro innamoramento, a sposarci, avere figli, fare famiglie e a vivere il sesso come forza che salda due destini individuali creando una comunità. Ecco, questo pensiero non è stato molto diffuso ed è stata una grave perdita, sia per gli uomini che per le donne».
A proposito di donne, il Sessantotto ha visto fiorire i movimenti femministi.
«Io considero il Sessantotto come un movimento largamente maschile e anche con tratti maschilisti: la liberazione sessuale è stata vissuta in modo prevaricante nei confronti delle donne. Il femminismo è emerso dopo, ma nel Sessantotto l’immagine della donna era ancora quella della segretaria, con in più la libertà di usarla sessualmente».
Quanto c’è, allora, di mitico in quella stagione vista a cinquant’anni di distanza?
«Il Sessantotto è stato una grande occasione perduta. E’ stato una speranza: per un attimo c’è stata la sensazione che un’altra vita fosse possibile, ma le mani in cui questa sensazione è stata posta erano fragili. Subito si è perduta ed è poi degenerata. In un’immagine, penso al Giudizio universale: Dio tende la mano verso l’uomo, ma questa volta l’uomo non l’ha afferrata».
In questa degenerazione c’è il lato oscuro di un movimento che oggi viene celebrato?
«Io credo che si sia vissuta una riedizione in commedia del grande dramma del Novecento, con le sue religioni secolari. In termini teologici si potrebbe dire: si mette qualcosa al posto di Dio. Quando anche l’ideale più alto viene messo al posto di Dio, questo diventa demoniaco: la giustizia sociale diventa comunismo, la nazione diventa fascismo. La politica si presentò come risposta a una domanda religiosa e si trattò di una risposta inadeguata e di per sè, dunque, rovinosa».
Perchè dice che fu l’eccesso di politica a generare il terrorismo?
«La prima esigenza dell’uomo non è la politica, ma la religione. Dal modo in cui io definisco il mio rapporto con Dio deriva anche il modo in cui definisco il mio rapporto con gli uomini e dunque la mia capacità di avere misericordia per le loro imperfezioni. I terroristi travisarono l’intuizione di portare il regno di Dio su questa terra, identificandolo con il comunismo. In quegli anni veniva citato spesso Engels, in un passo di un libretto su Ludwig Feuerbach: «L’essenza della dialettica è che tutto ciò che è merita di morire». Per loro, davanti al bene assoluto che coincideva con la rivoluzione, tutto ciò che c’era perdeva valore e meritava disprezzo».
E dunque legittimava sparare?
«Alcuni anni dopo, nel 1977, le Brigate Rosse uccisero Carlo Casalegno, vicedirettore della Stampa. Il figlio Andrea era militante di Lotta Continua e ricordo che scrisse un bellissimo articolo: «Anche io ho sempre detto che la lotta di classe è al primo posto, ma non immaginavo che potesse venire anche prima della dignità e del rispetto dell’uomo»».
Quando avvertì la rottura con lo spirito del Sessantotto e l’inizio della stagione successiva?
«Per me fu nel marzo del 1969. A Roma c’era una grande manifestazione di studenti delle medie, che venivano in corteo alla città universitaria. I fascisti erano asserragliati dentro a Giurisprudenza, i gruppuscoli dell’ultrasinistra stavano dentro Lettere e la grande maggioranza del movimento era fuori, perchè era una bella giornata di sole. D’un tratto, capimmo che i fascisti volevano uscire per aggredire i ragazzi, così organizzammo un cordone non violento per impedirglielo. Loro ci vennero incontro agitando le bandiere e, quando arrivarono vicini, smontarono le bandiere e tirarono fuori le mazze ferrate. Ci diedero un sacco di botte e ci sbaragliarono, fino a quando i gruppi della sinistra uscirono da Lettere e li ricacciarono dentro Giurisprudenza. Io rimediai una lesione al ginocchio, quel giorno per me è finito il Sessantotto ed è iniziata un’altra storia».
Con il 1969 cominciò un’altra storia.
«Anche nel movimento del Sessantotto c’erano i gruppi dell’ultrasinistra, ma erano fondati su un’idea di comunismo comunitario, che i marxisti definirebbero di socialismo utopistico. I gruppi armati di scienza marxista- leninista e mazze ferrate vennero dopo, e occuparono il campo. Da allora il movimento di massa finì, chi parlava a nome degli studenti non era più uno studente, la partecipazione crollò drammaticamente. Iconograficamente, il passaggio si compì quando, in manifestazione, smettemmo di chiedere “Vietnam libero” e si iniziò a urlare “Vietnam rosso”».
Cosa ha spinto quegli stessi giovani a prendere le armi?
«Le cito un capitolo della Fenomenologia dello spirito di Hegel, che si intitola “La libertà assoluta e il terrore”. Ecco, il tentativo di realizzare la libertà assoluta in chiave politica induce a rivolgersi con spietata violenza contro tutto ciò che c’è, perchè nulla è adeguato all’ideale. L’uomo di ieri va spazzato via perchè totalmente corrotto e i riformisti, quelli che identificano il cambiamento come un percorso a tappe, sono dei traditori. I gruppi che imbracciarono le armi si consideravano gli unici depositari della giusta visione, mentre tutti gli altri erano massa dannata. Nel loro calvinismo rivoluzionario furono indotti a svalutare ogni limite, soprattutto quello della legge, pur di mettere la lotta di classe al primo posto».
In che modo, invece, Cl ha guidato quella stessa generazione?
«Cl era un fenomeno di massa e col tempo divenne largamente maggioritario tra gli studenti attivi, vincendo tutte le elezioni universitarie. Il legante che ci cementava come gruppo sta nel nome stesso: la risposta alla domanda di liberazione dei giovani è la comunione cristiana. Questo ha significato amicizie che duravano una vita, sostegno nelle necessità materiali, creazione di una comunità che nasceva dall’incontro con Cristo come rottura dell’individualismo edonistico. Leggevamo spesso il Vangelo di Giovanni, capitolo XV e seguenti, in cui è contenuta la metafora della vite e dei tralci: chi riconosce Cristo come sua identità vera diventa più che un fratello e nasce un legame che è più forte di quella della carne. Io sono convinto che la fede fosse la risposta alla crisi di quella generazione».
Eppure verrebbe da obiettarle che, per soddisfare la richiesta di cambiamento di cui lei diceva all’inizio, la politica fosse la strada obbligata.
«Io amo la politica e l’ho fatta per 24 anni, ma per fare una politica realistica bisogna fare i conti con gli uomini per come sono e avere la capacità di perdonare al finito il fatto di non essere infinito. Questo si può fare solo capendo che la società è imperfetta: si può provare a renderla meno imperfetta, ma essa non sarà mai il regno di Dio. In altre parole, la domanda di regno di Dio deve trovare una risposta in qualcosa di diverso dalla società stessa, perchè altrimenti si tenta di imporre al terreno una perfezione che non è in grado di raggiungere. Ecco, solo sapendo che il regno di Dio non è di questo mondo ma che è il modello dal quale partire per migliorarlo, si può fare bene politica».
Dunque è stato sbagliato mitizzare quella stagione, che tanto ha inciso su quella successiva, caratterizzata dal terrorismo?
«Quando tenti di spiccare il volo ma non ce la fai, cadi e ti fai male. Non per questo, però, era sbagliato provare a volare».
Banda Baader-Meinhof. Le idee, le bombe, i suicidi, “sospetti”. Nel 1968 in Germania si forma il gruppo terroristico Raf. E scoppia l’autunno caldo, scrive Paolo Delgado l'8 Aprile 2018 su "Il Dubbio". Li chiamavano “Banda Baader- Meinhof” e i media tedeschi li definivano comunemente “anarchici”, oltre che naturalmente “terroristi”. In realtà il nome che si erano dati era Raf, Rote Armee Fraktion, Frazione dell’armata rossa, ed erano comunisti con forte venatura terzomondista. Per sconfiggerli, lo Stato varò leggi eccezionali infinitamente più dure di quelle adoperate in Italia contro le Br. Calpestò ogni diritto, umano e civile. Fu il momento più tragico della storia della Germania ovest nel dopoguerra: “l’autunno tedesco”. Bettina Rohl, figlia di Ulrike Meinhof, una delle più famose esponenti del gruppo, ha segnalato in una recente intervista quanto, secondo lei, la separazione dei genitori sia stata determinante nella scelta estrema di sua madre. Materiale sufficiente per consentire qualche titolo a effetto sul terrorismo tedesco derivato dalle sofferenze private di Ulrike, giornalista molto nota negli anni anni 60. In realtà neppure Bettina Rohl accenna una tesi così balzana. Si limita ad affermare che il “tradimento” di suo padre Klaus Rohl, direttore della rivista radicale tedesca Konkret, la stessa dove aveva a lungo lavorato Ulrike, avesse fatto vacillare l’equilibrio mentale della madre, spingendola nelle braccia dell’Armata rossa. È anche questa una forzatura. Iscritta al Partito comunista illegale sin dal 1959, poi redattrice di punta dell’infiammata Konkret, Ulrike Menhoif era sempre stata schierata su posizioni molto estreme. E’ possibile che l’abbandono da parte di Rohl abbia pesato sulla sua decisione, ma certamente fu più determinate la situazione che si era creata in Germania ovest alla fine degli anni 60. Lo stesso clima incandescente che aveva portato alla nascita della Raf, gruppo armato longevo il cui scioglimento fu annunciato solo nel 1998, con numerosi attentati spettacolari all’attivo e un bilancio di sangue pesante: 33 vittime, oltre 200 feriti. Più una sfilza impressionante di suicidi, su molti dei quali non hanno mai smesso di aleggiare sospetti di omicidio camuffato, tra cui quello della stessa Ulrike Meinhof. Il ‘ 68 tedesco inizia in realtà il 2 giugno 1967. Quel giorno, nel corso delle manifestazioni contro la visita dello Scià di Persia, uno studente di 27 anni, Benno Ohnesorg fu ucciso da un poliziotto a Berlino. La situazione era già tesa di per sé. Per la prima volta era al governo una Grosse Koalition e i già esigui spazi d’opposizione, con il partito comunista fuori legge, si erano definitiva- mente chiusi. Il capo del governo, Kurt Georg Kiesinger, aveva avuto in tasca la tessera nazista fino al 1945. Ex nazisti di spicco erano disseminati un po’ ovunque nella pubblica amministrazione. L’assassinio di Ohnesorg suscitò tra i giovani una reazione fortissima, che si tradusse nella nascita di un diffuso movimento rivoluzionario che coniugava spesso confusamente marxismo, terzomondismo e suggestioni controculturali. Dal quel terreno sarebbero presto nati i gruppi armati, come la stessa Raf, le Cellule rivoluzionarie, il Movimento 2 Giugno di Bommi Bauman, che prendeva il nome proprio dalla data dell’uccisione di Ohnesorg. Il 2 aprile 1968 quattro studenti, tra cui Andreas Baader e Gudrun Ensslin, diedero fuoco alla sede di due grandi magazzini a Francoforte per protesta contro la guerra in Vietnam. Meno di dieci giorni dopo il leader della Sds, guida del movimento studentesco, Rudi Dutschke fu ferito gravemente da un neofascista dopo una campagna martellante contro il movimento e contro Dutschke personalmente dei giornali del gruppo Springer. La Germania prese fuoco. Le manifestazioni furono violentissime, costellate da attacchi ai giornali di Springer. Gli attentatori di Francoforte furono condannati a tre anni, con pena temporaneamente sospesa nel giugno 1969. Cinque mesi dopo, in novembre, fu spiccato un nuovo ordine di arresto ma a quel punto tre di loro, tra cui Baader e Ensslin erano già riparati in Francia, ospiti del giornalista amico di Castro e di Guevara Regis Debray. Baader fu catturato nell’aprile 1970: meno di un mese dopo fu fatto evadere grazie all’aiuto di Ulrike Meinhof. Il ruolo della giornalista, che aveva chiesto un’intervista per far sì che il leader della Raf venisse spostato dal carcere permettendo l’evasione, avrebbe dovuto restare ignoto. Ma nell’imprevisto scontro a fuoco ci scappò un ferito grave e la giornalista decise di seguire Baader e la Ensslin in clandestinità. La Raf propriamente detta nacque allora. Il gruppo si trasferì in Libano, fu addestrato all’uso delle armi nei campi del Fronte popolare della Palestina. Strinse legami fortissimi con i palestinesi e probabilmente anche con qualche servizio segreto dell’est. Scelse il nome e il simbolo, pare commissionato da Baader a un grafico pubblicitario debitamente pagato: la stella rossa col mitra sovraimpresso e il nome del gruppo. Iniziarono le rapine e gli attentati, molti segnati dall’antimperialismo ma molti anche contro le propietà di Springer. La Raf diventò il pericolo pubblico numero 1 in Germania, oggetto di una caccia all’uomo di proporzioni inaudite che si concluse con l’arresto di tutti i dirigenti nel giugno 1972. Una nuova generazione di militanti riempì però i vuoti lasciati dagli arresti e iniziò allora la fase più tragica della storia tedesca nel dopoguerra. I detenuti furono rinchusi nel carcere di massima sicurezza di Stammheim, un inferno lastricato di isolamento assoluto, luci sempre accese, controlli permanenti. Nel 1974 Holger Meins proclamò uno sciopero della fame per protesta e ne morì. Nel 1976 morì anche la Meinhof: un altro suicidio. In occasione dell’inizio del processo ai capi della Raf, nell’aprile 1977, il gruppo uccise il pubblico ministero, Siegfried Buback, con l’autista e la guardia del corpo. In luglio fu colpito a morte il banchiere Hans Jurgen Ponto. Il 5 settembre fu sequestrato a Colonia il presidente della Confindustria tedesca, in un attacco che fece da modello al sequestro Moro. I quattro uomini della scorta furono uccisi. La Raf chiese il rilascio dei detenuti, lo Stato prese tempo pur avendo già deciso di non trattare. In ottobre l’Fplp si unì all’operazione con uno spettacolare dirottamento aereo. Per il rilascio degli ostaggi avanzò le stesse richieste dei rapitori di Schleyer, aggiungendo alla lista due detenuti palestinesi. Le teste di cuoio tedesche attaccarono l’aereo in sosta a Mogadiscio uccidendo quasi tutti i sequestratori. La stessa notte Baader, la Ensslin a Jan- Carl Raspe si suicidarono a Stammheim. Sulla loro morte, come su quella di Ulrike Meinhof non è mai stata fatta davvero chiarezza. Schleyer fu ucciso il giorno dopo. L’autunno tedesco durò ancora a lungo.
1977: LA RIVOLUZIONE ANTICOMUNISTA.
Le date.
A Roma Luciano Lama, segretario della Cgil, va all’università La Sapienza per un comizio. Viene contestato dagli studenti e i giovani di Autonomia Operaia assaltano il palco e costringono Pci e Cgil alla fuga. 17 febbraio 1977
Scontri all’università di Bologna. Francesco Lorusso, venticinque anni, militante di Lotta Continua, viene ucciso da un carabiniere. Seguono giorni di guerriglia urbana, Francesco Cossiga, ministro degli Interni, invia i blindati per presidiare il centro della città. Viene chiusa Radio Alice. 11 marzo.
A Roma la polizia sgombera l’università occupata dall’Autonomia. Nella giornata scoppiano scontri nel quartiere San Lorenzo, con lancio di molotov e colpi di pistola da parte dei manifestanti contro la polizia. Viene ucciso l’agente Settimio Passamonti, ventitré anni. 21 aprile.
A Roma durante una manifestazione scoppiano scontri con la polizia nei quali resta uccisa Giorgiana Masi, diciotto anni, studentessa. 12 maggio.
A Milano durante una manifestazione di protesta per la morte di Giorgiana Masi scoppiano nuovi scontri tra polizia e movimento. L’agente Antonio Custra, venticinque anni, viene ammazzato da un colpo di pistola. 14 maggio
A Milano un gruppo di brigatisti tende un agguato a Indro Montanelli. Viene colpito alle gambe con otto colpi di pistola. 2 giugno.
A Bologna convegno contro la repressione. Le diverse anime della contestazione si scontrano. C’è chi inneggia alla lotta armata. Di fatto è la fine del movimento. 23-25 settembre.
A Torino agguato a Carlo Casalegno, giornalista e vicedirettore de La Stampa. La colonna torinese delle Brigate Rosse gli spara al volto: morirà il 29 novembre dopo tredici giorni di agonia. 16 novembre
Sulle Onde di Radio Alice correva il ’77 ribelle, scrive Luciano Lanna l'8 Marzo 2017, su "Il Dubbio". Quarant’anni fa l’emittente bolognese venne chiusa dalla polizia, arrestate le sue “voci”. La radio del movimento studentesco interpretò il cambiamento della società dell’informazione facendo saltare i vecchi schemi della militanza. Quarant’anni fa, il 12 marzo 1977, il giorno dopo l’uccisione a Bologna dello studente Francesco Lorusso, la polizia fa irruzione nei locali di Radio Alice, li sigilla e arresta tutti gli animatori. I media ufficiali avevano scatenato una vera e propria crociata contro l’emittente, con l’accusa di essere stata la diretta responsabile degli scontri violenti seguiti alla morte del giovane studente. Per dirla tutta, lo studente, un 25enne militante di Lotta Continua, era stato freddato da un colpo d’arma proveniente dalle forze dell’ordine dopo che una bottiglia molotov aveva raggiunto un autocarro. Ma la morte dello studente dette origine a ulteriori e pesanti scontri di piazza. Radio Alice aveva solo mandato in onda, come faceva per tutto quello che accadeva in città, la cronaca degli eventi. Del resto, è Umberto Eco, curiosamente attento ma spesso critico nei confronti dell’ala creativa del ’ 77, a difendere la redazione della radio dalla campagna denigratoria nei suoi confronti. Fatto sta che la chiusura determina la fine di un anno vissuto in prima persona da quella radio e che è stato decisivo per l’immaginario di una generazione. Tutti gli arrestati vengono portati in questura e successivamente trasferiti nelle carceri di San Giovanni in Monte. Ovviamente, in seguito vengono tutti prosciolti dalle accuse mosse nei loro confronti. Radio Alice riaprirà circa un mese dopo e continuerà le trasmissioni per ancora un paio d’anni, ma senza l’apporto degli originali fondatori e senza più la stessa vocazione, tanto che la frequenza della radio verrà ceduta a Radio Radicale. Quell’avventura era iniziata ai primi di gennaio del ’ 76, con le prime trasmissioni di prova dalla mansarda al civico 41 di via del Pratello, dall’idea di un gruppo di amici e studenti del Dams, il primo dipartimento universitario in Italia di “arte, musica e spettacolo”. «Quando Maurizio Torrealta venne a casa mia a propormi di fondare una radio – ha ricordato Franco Berardi Bifo, uno degli animatori – la trovai una idea bellissima. Pensai: sappiamo cantare, fare gli speaker, ballare, praticamente possiamo fare tutto: ma la macchina?». E così si aggregano quelli che avevano le competenze tecniche, come Torrealta o Andrea Zanobetti, ingegnere elettronico. Si decide di mandare in onda tutt’altro da quello che si ascoltava dalla Rai: brani di libri, comunicazioni sindacali, poesie e letteratura, lezioni di zen e di yoga, analisi politiche, dichiarazioni d’amore, commenti ai fatti del giorno, ricette non solo macrobiotiche, favole della buonanotte, liste della spesa, la musica dei Jefferson Airplane, degli Area o di Beethoven. E tutte le trasmissioni, sulla frequenza di 100.6 megahertz, si aprono e si chiudevano sempre col brano Lavorare con lentezza, del cantautore pugliese Enzo Del Re. È la versione bolognese, forse più creativa ed effervescente di altre per la presenza in città del Dams, di ciò che stava andando in onda in tutta Italia dopo la sentenza della Corte che aveva dichiarato anticostituzionale il monopolio statale sull’etere. S’era d’un tratto aperto un vero e proprio vuoto giuridico, nel quale in brevissimo tempo si inserì un circuito di piccole emittenti locali improvvisate, le cosiddette “radio libere”. Da questo punto di vista, osserva – in I sogni e gli spari. Il ’ 77 di chi non c’era (Azimut) – Emiliano Sbaraglia, «il 1977 produsse un esempio unico e irripetibile di comunicazione radiofonica: cambiano radicalmente le tecniche di informazione: si modificano, ampliandosi e migliorandosi, le possibilità di recupero di materiale informativo, i metodi di trattamento dello stesso, la pubblicazione e la diffusione di una notizia». D’un colpo irrompe in Italia l’epopea di Radio Popolare a Milano, di Radio Sherwood a Padova, di Radio Città Futura e Radio Onda Rossa a Roma ma non solo… Nascono infatti anche Radio University a Milano e Radio Alternativa nella Capitale e tante altre emittenti “di destra”. Interessante la recensione che L’uno, il supplemento “politico” di Linus, pubblica nel numero di marzo ’ 77: «C’è il solito coretto di scena post- brechtiano, tipo Dario Fo… Poi parlano alcuni giovanotti… Dicono che i servizi segreti sono infiltrati… Poi si mette su un altro disco, questa volta è una melopea dylaniana contro i grassi borghesi, le signore puttane che giocano a canasta… Poi si riprende il dibattito e si parla della strategia della tensione, della manovra della stampa borghese che mette in risalto gli elementi da fotoromanzo presenti negli atti di terrorismo e di equivoca criminalità comune. Altra musica, mitteleuropea ( Berlin, mein Berlin). Poi interviene un parlamentare che rincara la dose: le istituzioni sono in sfacelo, ma non da oggi; fin dai tempi di Salvatore Giuliano e della strage di Portella della Ginestra; ancora prima, dallo sbarco degli americani con i mafiosi». Quindi la sorprendente constatazione: «Tutto questo – si leggeva insomma agli inizi del ’ 77 sul supplemento di Linus – non viene trasmesso da una radio libera “democratica”, come si potrebbe pensare. Ma da Radio University, emittente milanese “fascista”…» ( che trasmetteva addirittura dalla sede della federazione provinciale del Msi). Non si notavano differenze, concludeva l’anonimo recensore, con le programmazioni, le parole e i suoni con le radio legate all’estrema sinistra. E tutto questo era vero, nella condivisione generazione di un immaginario e di una sensibilità esistenziale che accomunava il profondo dei giovani di allora, che alla notizia dei sigilli a Radio Alice, mentre Radio University trasmette in diretta le fasi drammatiche della chiusura dell’emittente bolognese, il conduttore Walter Jeder invitava i suoi ascoltatori a solidarizzare con i redattori bolognesi perché spiegava «potrebbe succedere anche a noi». Insomma, Radio Alice è il simbolo di tutto un più vasto fenomeno che stava trasformando la comunicazione e l’informazione nel nostro paese. Ma perché quel nome? La suggestione veniva dal nome del personaggio di Lewis Carroll, l’autore di Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio. Era accaduto che nel ’ 75 era uscito un saggio di Gilles Deleuze, autore caro ai giovani di quella fase, dal titolo La logica del senso e che analizzava proprio i luoghi e la mente della protagonista degli scritti di Carroll. Come se non bastasse, dal ’ 76 e fino al novembre ’ 77 Gianni Celati, docente di letteratura anglo-americana al Dams, tiene un seminario in forma di lavoro collettivo sulla figura di Alice nel paese delle meraviglie. Tra i suoi studenti, il futuro narratore Enrico Palandri, Andrea Pazienza in arte Paz e Roberto Freak Antoni, giovani creativi che rappresenteranno al meglio lo spirito del ’ 77. «Il nome di Alice era già stato messo in giro alla controcultura americana ed era diventato una parola d’ordine per riferirsi a quel tipo di aggregazione sparsa e senza gerarchie che è stato chiamato movimento», si legge in Alice disambientata, il libro che raccoglie i materiali del seminario e che verrà pubblicato l’anno successivo dalle edizioni “L’erba voglio” di Elvio Fachinelli. Fatto sta, che quel seminario tenuto nel ’ 77 finisce per definire la figura fiabesca di «Alice come emblema e, in qualche modo, nome del nuovo movimentismo giovanile, almeno a Bologna. La stessa Alice che, come ha ricordato Marco Belpoliti, suscitava contemporaneamente le reazioni polemiche dei «giovani barbuti con tascapani militari», gli ideologizzati e militanti che erano convinti che l’argomento fosse «futile e lontano dai problemi della società». Ecco, un personaggio fantastico, un simbolo dell’immaginario, si tramuta in elemento di discrimine: da una parte chi è in sintonia con i tempi nuovi, dall’altra chi resta attardato ai vecchi stilemi ideologici. D’altronde, i partecipanti al seminario ne erano consapevoli. Così scrivevano sulla scelta di una dimensione tutta “fantastica”: «Quando l’eroe parte per il fuori, va fuori dal villaggio dove non esistono più i rapporti di alleanza e parentela che gli forniscono i modelli culturali di comportamento. La fiaba insegna un modello di comportamento per zone dove l’individuo non è protetto dai rapporti sociali di alleanza e parentela, trasmette i modi per stabilire questi rapporti sociali anche fuori dal villaggio». Insomma, Alice diventa una figura che quell’anno compare un po’ dappertutto, metafora di un universo giovanile aperto, che sfugge – si legge nel libro – «all’elaborazione d’una linea e ad esportare verso l’esterno questa linea come proposta di discorso egemonico». Ancora: «Non parliamo di utopia. Anche l’utopia è un modo di ridurre le contraddizioni a uno schema fisso… La controcultura ha posto una questione minima: tutti i rapporti da stabilire sono affettivi, i rapporti politici sono quelli già esistenti nella nostra società e non piacciono a nessuno tranne ai politici». È la riscoperta generazionale del “personale”, dell’esistenziale, del comunitario, rispetto ai vecchi rapporti astratti, societari, istituzionali, politici: «L’ipotesi venuta dalla controcultura – leggiamo ancora in Alice disambientata – non è un’utopia, riguarda un problema di circolazione: un corrersi dietro tutti, cercando di darsi a vicenda dei rapporti d’identificazione affettiva». E in conclusione il seminario riconosce che i “mondi della vita” emergenti nella società in quel ’ 77, soprattutto tra le giovani generazioni, non sono più rappresentabili dalle istituzioni o dei partiti, quanto dalle reali comunità giovanili, un mondo fatto di pluralità e differenze: «Le tribù in movimento sono tante e molto differenziate, e con teorie di campo tanto dissimili». Ecco, quell’icona e Radio Alice rappresentavano al meglio la rottura con le vecchie forme della militanza e aprivano la strada a nuove forme di comunicazione. Tant’è vero che il quando il 9 febbraio ’ 76 iniziano le trasmissioni vere e proprie di Radio Alice, si aprono proprio con la musica di White Rabbit, un brano degli Jefferson Airplane che non poteva non ricordare il coniglio bianco compagno d’avventure dell’Alice ispiratrice. E, da subito il flusso quotidiano di informazione è continuo, senza alcuna interruzione, come invece accadeva con la Rai o con altre emittenti libere. Sarà proprio questa l’innovazione rappresentata dal prepotente ingresso di Radio Alice nel mondo della comunicazione. Un’innovazione che, nel 2004, verrà celebrata dal film Lavorare con lentezza, diretto da Guido Chiesa e sceneggiato insieme al collettivo Wu Ming. Qui le vicende di due ragazzi bolognesi si mescolano a quelle dei movimenti studenteschi del ’ 77 e delle trasformazioni antropologiche, politiche e nella comunicazione di quell’anno. E mentre queste cose accadono, sullo sfondo – a cominciare dal brano del titolo – si ascolta sempre, come una sorta di colonna sonora quotidiana, quanto va in onda sulle frequenze di Radio Alice.
Film d'epoca e documentari inediti: ecco la rivolta del '77. Per la prima volta in tv anche due documentari militanti come Pagherete caro, pagherete tutto del 1975 e Festival del proletariato giovanile al Parco Lambro (1976), scrive Matteo Sacchi, Mercoledì 1/03/2017, su "Il Giornale". Il 1977. Uno degli anni più complicati della storia italiana. Nasce un movimento universitario che scavalca a sinistra non solo il Pci ma anche i precedenti movimenti figli del '68, come Lotta Continua. La tensione politica sale alle stelle e per la prima volta una rivolta, fatta a colpi di cortei e radio libere. Il movimento però degenera rapidamente. Tra le idee dadaiste degli Indiani metropolitani e l'invito alla violenza di chi porta le P-38 nei cortei sono rapidamente le seconde a vincere. Eppure alcune cose dello spirito del '77 è arrivato sino a noi. Ecco perché a quarant'anni da quei fatti il canale Iris ha deciso di dedicare quindici film, in cinque serate consecutive proprio al '77 e dintorni. Protesta, politica, canzoni, terrorismo, amore libero: insomma tutto il mix di elementi contraddittori di quegli anni di piombo ma non solo è trattato nel ciclo Black Out (presentato ieri a Milano) che andrà in onda da sabato 11 a mercoledì 15 marzo. La data di partenza non è scelta a caso, l'11 marzo '77 a Bologna venne ucciso il militante Francesco Lorusso. Tra i film alcuni d'epoca che danno l'idea di come si sia creato il clima culturale che portò al '77: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), San Babila ore 20: un delitto inutile (1976) e La classe operaia va in paradiso (1971). Per la prima volta in tv anche due documentari militanti come Pagherete caro, pagherete tutto del 1975 e Festival del proletariato giovanile al Parco Lambro (1976). L'unico limite dell'iniziativa che ha un bel supporto documentale è quello che, a parte un filmato introduttivo e uno speciale a cura di Tatti Sanguineti (forse ce ne sarà anche uno di Maurizio Costanzo), il pubblico è lasciato solo, in alcuni casi, con delle pellicole (molto ideologiche) che richiederebbero un po' di inquadramento per essere capite. Soprattutto dai giovani.
17 febbraio 1977, gli studenti demoliscono Lama, scrive Paolo Delgado il 17 Febbraio 2017, su "Il Dubbio". Quarant’anni fa il segretario della Cgil veniva contestato alla Sapienza dagli studenti della sinistra ex parlamentare che lo accolsero con fischi e bastoni. Il palco venne giù come fosse di cartapesta, per qualcuno fu una frattura drammatica, per altri fu l’episodio più liberatorio del “decennio rosso”. La sola cosa che avevano in comune era la reciproca ostilità, una sensazione condivisa di estraneità totale, una punta di disgusto ricambiata senza alcuna cordialità. A quarant’anni di distanza ancora non si capisce bene chi prese la decisione sciagurata di spedire Luciano Lama, segretario della Cgil, in mezzo all’università di Roma occupata da un Movimento che il Pci considerava a un passo dal fascismo conclamato e che avrebbe visto il Pci e il sindacato come nemici assoluti anche senza le carinerie che l’Unità elargiva a getto quotidiano. Fu una decisione stupida ancor più provocatoria, e tanto inspiegabile che poi, per anni, Cgil, Federazione romana e Sezione universitaria del Pci si sono rimpallati la responsabilità della brillante trovata. Non poteva che finire malissimo: fu chiaro da subito. Il Movimento si preparò all’indesiderato appuntamento con una di quelle assemblee fluviali ed estenuanti che erano all’epoca merce comune. Ore e ore passate nell’aula I di Lettere, dal primo pomeriggio del 16 febbraio sino a notte inoltrata, accumulando proposte per poi confutarle, difendendo a spada tratta linee di condotte alternative ma che tutti, in fondo, sapevano destinate a essere comunque travolte dagli eventi. Quando uno dei principali leader dell’ala dura di Autonomia, esasperato, prese alla fine la parola per chiedere: «Tutto bene, ok. Ma i bastoni dove li mettiamo?» la sterzata fu accolta con sollievo generale. Finalmente la verità. Non significa che la scelta del Movimento fosse lo scontro fisico. Se nessuno riteneva che si dovesse accettare l’offerta degli organizzatori del comizio, disposti a far parlare dopo il super sindacalista anche un «esponente del movimento studentesco», la linea maggioritaria era favorevole a una contestazione morbida e ironica, a base di sberleffi, non di mazzate. Ma tutti, anche i più creativi tra gli indiani metropolitani, sapevano benissimo che il rischio che le cose prendessero un’altra piega c’era tutto. Chiedersi dove mettere i bastoni non era segno di estremismo e di propensione alla violenza. Era semplice realismo. Non poteva che andare male, ma andò anche peggio del previsto. Anche questo fu chiaro sin dal primissimo mattino, quando i militanti del servizio d’ordine del Pci e i funzionari del sindacato cominciarono ad affluire alla Sapienza, anticipando di un’oretta il segretario. Arrivavano con le facce tirate di chi marcia in territorio nemico e si aspetta l’agguato dietro ogni angolo. Sembrava l’avessero fatto apposta, e probabilmente era proprio così, a rimarcare nei particolari la distanza, anzi la contrapposizione antropologica, l’antagonismo anche estetico, rispetto ai “diciannovisti “che da 15 giorni occupavano l’università di Roma. Gli stessi che una decina di giorni prima avevano sottoposto il cronista del “quotidiano fondato da Antonio Gramsci” a un beffardo processo popolare. Capo d’accusa: “Affermazioni deliranti”. Sentenza, passibile di immediata esecuzione: “Espulsione a vita dall’università”. In quelle prime decine di minute, mentre il servizio d’ordine del Pci montava un palco improvvisato e la tensione s’impennava assai più del palchetto, il popolo del Pci e quello del Movimento si guardavano in silenzio, scoprendo quasi con sorpresa una differenza ormai totale, verificando la profondità di un abisso che non era più colmabile. Le scritte degli indiani, fatte nella notte, accoglievano i funzionari del partito che sosteneva con la sua astensione il governo Andreotti e quelli del sindacato che chiedeva agli operai di sacrificarsi in nome dell’ “interesse generale”. “Nessuno L’ama”, “I Lama stanno in Tibet”. I comunisti le degnavano appena di uno sguardo ma bruciavano d’indignazione: come ci si poteva permettere una simile mancanza di rispetto? Gli insolenti guardavano i sindacalisti con disprezzo anche maggiore, o forse con un’alterità che non permetteva più neppure il disprezzo. Quella gente, con le loro facce torve, la mascelle serrate, le divise d’ordinanza da burocrati così volutamente opposte a quelle altrettanto d’ordinanza ma variopinte e fantasiose del Movimento, non la si poteva più bollare, come si era fatto dal ‘ 68 in poi, come semplicemente “revisionista”, come compagni che miravano allo stesso obiettivo, una mondo diverso e più giusto, ma per una strada sbagliata, arrendevole, genuflessa, sconfitta in partenza. Quello ormai era direttamente il nemico in prima persona. Era, nel momento storico dato, il sostegno e il principale puntello dell’assetto di cui persino “i revisionisti” erano comunque stati considerati critici pur se non abbastanza severi. Gli slogan iniziarono ancora prima che Luciano Lama cominciasse a parlare. La derisione surreale e un po’ demenziale, “Fatti una pera, Luciano fatti una pera” sul tono di Guantanamera, bruciava forse anche più della critica politica, dell’accusa di tradimento: “Lama ti prego non andare via: vogliamo ancora tanta polizia”. Tra il palco, circondato dal servizio d’ordine del Partito, e la massa di minuto in minuto più folta dei ragazzi di Movimento, sotto la scalinata di Lettere, non c’erano che pochi metri. “Luciano” era terreo al momento dell’arrivo nella zona nemica, attorniato dall’immancabile codazzo di funzionari e dal servizio d’ordine, quasi una replica caricaturale delle immagini che dall’Urss raccontavano in ogni Tg la mesta fine dell’Ottobre rosso. Lo era ancora di più quando infine prese la parola, probabilmente già consapevole dello sbaglio commesso, per pronunciare un discorso che non sarebbe mai arrivato alla fine e del quale comunque si persero anche le prime parole, subissate dal fragore dei fischi, dagli slogan strillati a voce sempre più alta. A determinare una deflagrazione comunque inevitabile furono i palloncini. Tanti, colorati e innocui. L’arma scelta dagli indiani per marcare la distanza tra il grigiore plumbeo di chi chiedeva ai sacrificati di sacrificarsi sempre più e la festosità disperata del Movimento. Il quadrato intorno al palco rispose con i sassi, forse per esasperazione, forse perché costretti dalla loro stessa favola, che li voleva impegnati a fronteggiare una forma moderna e camuffata di fascismo. Nulla come quel discorso di Luciano Lama, segretario della Cgil, coperto dagli slogan ostili, pronunciato solo a uso delle persone che occupavano il palco mentre di fronte la sassaiola diventava sempre più fitta, racconta il ‘ 77. Più delle autoblindo spedite da Cossiga a Bologna meno di un mese dopo. Più delle istantanee che concentrano l’attenzione sulle armi in piazza, e così facendo falsano la storia. Più dei girotondi che trasmettono l’immagine di una gioiosità che era mimata e copriva invece un malessere profondissimo. Lama chiuse di corsa il suo discorso, troncandolo di netto, quando si rese conto che la situazione era definitivamente sfuggita di controllo. Fece in tempo ad abbandonare il palco e il campo un attimo prima che quei bastoni ai quali si era alluso la sera precedente entrassero in azione. Una sola carica, decisa e travolgente, non preordinata, forse neppure decisa da nessuno. Spontanea. Il palco venne giù come fosse di cartapesta, e in un certo senso lo era davvero. Poche ore dopo la polizia arrivò in forze a sgombrare l’università. Giusto per confermare che nulla di quanto era stato rinfacciato a Lama e tramite lui all’intero Movimento operaio istituzionale poche ore prima era infondato. Non fu tanto il giudizio politico a tracciare allora nel Movimento una linea di demarcazione che resiste e ancora separa gli ormai incanutiti. Fu una questione di sentimenti prima che di analisi politica. Di emozioni, non di mozioni. Per qualcuno, soprattutto per chi militava o dirigeva gli ex gruppi impegnati nel tentativo votato a certo fallimento di trasformarsi in partitini, si trattò di una tragedia, di una lacerazione drammatica che avrebbe dovuto essere a ogni costo evitata e che andava adesso ricucita quanto prima. Ancora oggi ricordano il 17 febbraio 1977 come un giorno di lutto. Per molti altri fu il momento di massima gioia, il singolo episodio più liberatorio dell’intero decennio rosso, e tale è rimasto nei decenni. Nell’assalto al palco del sindacalista dei sacrifici non c’era solo il rifiuto della linea decisa da un Pci che abboccava all’amo teso dal potere democristiano, quello illustrato in anticipo da Moro e Andreotti al dubbioso ambasciatore americano Gardner. In sintesi: «Dobbiamo prendere misure che gli operai non accetterebbero ma che grazie al sostegno del Pci invece passeranno. Poi però proprio l’aver sostenuto quelle misure provocherà un crollo di consensi a favore del Pci». Strategia mirabile che avrebbe colto tutti i risultati previsti nel giro di due anni. Non c’era neppure soltanto il compimento di una divaricazione che dal 1968 in poi si era fatta sempre più profonda e che aveva in realtà già toccato il punto di non ritorno quando, nel 1970, una serie di articoli dell’Unità denunciò Adriano Sofri per essere entrato illegalmente alla Fiat comiziando, chiedendone di fatto un arresto che arrivò puntuale e chiuse il leader di Lotta continua in carcere per mesi. Tutto questo certamente pesava, ma ancor più a fondo s’agitava un rifiuto globale di quel che il movimento comunista era stato sino a quel momento. Della sua passione per l’ordine. Del suo culto della disciplina, sia pur ribattezzata “disciplina di partito”. Della sua ipocrisia tattica camuffata da ardimentose piroette strategiche. Del suo culto del partito e di chi nel partito comandava. Della sua religione dell’obbedienza. Della sua abitudine a colpire il popolo in nome del popolo. Della sua struttura plumbea. Del suo grigiore costitutivo. Nelle sue componenti più innovative e nei suoi momenti migliori, quello del ‘ 77 è stato soprattutto un Movimento contro il “comunismo reale”. Il primo e sinora l’unico che abbia provato ad aggredire non gli orpelli ma il cuore stesso degli errori commessi dal movimento comunista non in nome della sua revisione e neppure in quello di un ritorno alla sua purezza, ma in nome della capacità di evolversi e cambiare imparando dagli errori senza rinnegare le radici. Per questo la cacciata di Lama, che della mesta e gelida realtà del movimento comunista era emblema, è ancora oggi la data chiave di quell’anno distante. E forse per questo è così difficile consegnare il ‘77 alla nostalgia e alla storia.
Settantasette, parole ed immagini. Tano D'Amico è l'autore dietro le foto che hanno raccontato il Movimento del '77: le proteste, gli scontri, le speranze di una generazione entrata nella storia muovendo i primi passi dal cortile delle Sapienza. Intervista a Tano D'Amico di Michele Smargiassi su “Robinson” (La Repubblica) il 19 febbraio 2017.
Vide gli zingari felici. Ne salvò i volti per noi, con le sue fotografie. Tano D’Amico, 74 anni e un sorriso da Gavroche, “compagno fotografo”, fotografo dei nomadi, degli occupanti di case, una lunga storia che comincia prima e finisce dopo il ’77: ma quell’anno, anche per lui, fu unico. L’anno in cui l’universo si mosse.
Vorrei partire da una foto non tua. Il militante incappucciato che spara in via De Amicis. Temo che l’icona del ’77 sia quella.
“Vollero farla diventare così. Non è un’immagine, è uno scalpo. Era l’immagine che tutta una cultura politica aspettava. Non solo quella di destra. In quel periodo lavoravo a Lotta Continua, e il ’77 lo odiavano pure lì. Certo, ricordo cosa scrisse Umberto Eco, che quella fotografia seppellì il movimento, ma ricordo cosa pensai io quando la vidi sulle prime pagine dei giornali: che era una brutta immagine, e che le brutte immagine prima o poi scompaiono”.
Brutta ideologicamente?
“No no, anche in senso estetico. Se vedessi un’immagine così in un film direi che è brutta, non perché c’è uno che spara. Le immagini sparatorie nei film di Peckinpah sono bellissime. Quella che dici tu invece è un’immagine repellente. Al di là di quello che rappresenta (lo sai vero che quello che si vede non è quello che ammazzò l’agente di Polizia?), diede origine a cose disastrose, un gruppo di giovanissimi che si vendettero gli uni gli altri… penso che le immagini si giudichino anche dal loro futuro”.
Del ’77, tu cercasti solo belle immagini?
“Penso che le belle immagini abbiano un posto nell’universo. Quando l’universo vede una brutta immagine, s’arrabbia. Certe foto invece vengono accolte dall’universo: penso alle due Polaroid di Moro nel carcere delle Br. Appena le vidi pensai a due icone bizantine. Nell’ultima foto Moro non fa caso ai suoi assassini che ha davanti, si appella all’universo, a noi, è già al di là, tutti lo volevano morto. Quella foto mi ha commosso più delle sue lettere”.
Prima di quella foto tutto era ancora aperto. E tu eri il fotografo “del movimento”.
“Ma io non volevo fare il fotografo del movimento. Io volevo fare il movimento, stare nel movimento. Sapevo che invece il fotografo deve mettersi da parte per osservare. Però trovavo brutte le immagini del movimento. Cosa ci potevo fare: ero figlio di emigranti siciliani a Milano, da bambino m’infilavo nei musei, erano gratis e caldi d’inverno e c’erano guardiani gentilissimi. C’era un’immagine che mi ricordava il mio Sud, un gruppo di donne normanne. Il pittore, lo seppi dopo, si chiamava Van Gogh. Forse per questo vedevo subito quando un’immagine smuoveva o bloccava qualcosa e lo dicevo. E i compagni: allora domani al corteo le foto le fa Tano”.
Fotografo precettato dal proletariato.
“Nelle assemblee dicevano Tano, tutti fotografano i fatti, tu fotografi i nostri desideri. Ebbi grande affettuosa libertà”.
Il fotografo dei desideri...
“Be’, non potevo fare diversamente. Mi mandavano nei posti dove era successo qualcosa ma coi treni di allora e pochi soldi per il biglietto arrivavo tre giorni dopo, non mi restava che cercare gli avvenimenti nei volti delle persone. Imparai a leggere la storia negli occhi della gente”.
Cosa ci leggevi?
“Bellezza. Passavo ore nel cortile della Sapienza, tra i ragazzi che sonnecchiavano, leggevano libri, si baciavano. In un libro Chomsky ha scritto che in quel cortile maturava la storia. Poi seguivo quei ragazzi in strada, nei cortei, fotografavo la loro grazia. Ma quelle immagini non uscivano mai sui giornali. I compagni mi prendevano in giro: Tano, ma lo metti il rullino nella macchina? I giornali volevano immagini di scimmie assetate di sangue, di assassini reali o potenziali. Le mie immagini erano intrattabili. Ero diventato una macchietta, il fotografo che fa foto che nessuno vede. Allora venne a casa mia una vera e propria commissione politica, autonomi, femministe, gay, indiani metropolitani… Mostrai le foto. Alcuni si misero a piangere. Bisogna fare un libro, dissero. Fecero una colletta, i soldi dentro un sacco del pattume. Il libro uscì, la bellezza fu vista”.
Eppure hai scattato anche tu fotografie “di fatti”. Il giorno in cui ammazzarono Giorgiana Masi...
“Ho condiviso la buona e cattiva sorte dei movimenti, è una favola che evitassi il conflitto. Quel giorno feci una foto a un agente in borghese armato. Mi pareva un’immagine banale, tutti sanno che ci sono gli agenti in borghese. Non era neppure la foto dell’uomo che sparò a Giorgiana, era un altro posto. Però la sera al telegiornale sento il ministro degli Interni garantire che non c’erano agenti in borghese, allora mi vesto e faccio il giro dei giornali con quella foto. Il primo giorno tutti scrissero che il ministro avrebbe dovuto dimettersi, poi tornò la solidarietà fra potere e stampa”.
C’è una foto di “fatti” che invece tenesti per te. Perché? Era una brutta foto?
“Tu dici la foto di Paolo e Daddo, uno ferito l’altro che lo sorregge e tiene in mano due pistole, dopo gli scontri del 2 febbraio all’università di Roma. Vero, non la feci vedere a nessuno. Vent’anni dopo, quando incontrai Daddo nella redazione del Manifesto, proprio lui mi rimproverò: ma perché non l’hai pubblicata? E io: ma era la tua vita, c’era il tuo sangue… E lui: no, è tua, è il tuo lavoro”.
Il ’68 era stato spensierato nel concedersi agli obiettivi. Il ’77 vide in ogni fotografo un delatore.
“Non volevo essere carnefice. Sapevo per esperienza che tutta la cultura del mondo s’apparecchia per difendere quello che già c’è, e che avrebbe usato certe foto per criminalizzare quel che si oppone. La verità è che nessuno voleva guardare il faccia il movimento del ’77. A destra e a sinistra. Mi ricordava l’Orwell di Omaggio alla Catalogna: gli anarchici odiati da tutti. Un movimento di cui tutti avevano paura perché metteva in discussione i ruoli, anche quelli dei giornalisti e dei fotografi. Quella che dà fastidio al potere, quella che non doveva essere vista era l’umanità delle persone. Invece sono queste le immagini che rimangono vive, che oggi si fanno ancora interrogare. Una bella immagine quando è fatta è fatta. L’universo lo sa”.
Il Movimento del Settantasette, 40 anni fa. Malesseri e speranze in una stagione di crisi. Nelle rivendicazioni dei giovani di allora si leggono i segni premonitori di cambiamenti futuri: i ragazzi erano cresciuti con la scolarizzazione di massa ma le aspettative risultavano frustrate, scrive Maurizio Caprara il 4 febbraio 2017 su "Il Corriere della Sera".
1. Con la scuola di massa, più istruzione. Non sempre i lavori ambiti. Sono trascorsi quarant’anni. Il 1977 fu per una parte dei giovani italiani un gran frullatore: di malesseri, speranze, violenza, intuizioni, abbagli, rivendicazioni. Affioravano i segni premonitori di una crisi dei partiti tradizionali che si sarebbe aggravata più avanti. Cresciuti con la scolarizzazione di massa, i ragazzi di quarant’anni fa vivevano meglio di come avevano vissuto i rispettivi genitori durante o dopo la guerra. Le conquiste del 1968 erano date per scontate. Le aspettative di molti tuttavia risultavano frustrate: per tanti era difficile trovare posti di lavoro adeguati al grado di istruzione raggiunto. Nell’irradiarsi dall’università alle scuole, questa frustrazione si mescolò ad altro. Ne derivarono richieste di programmi di studio aggiornati, proteste inventive. L’ondata di assemblee e manifestazioni cominciò perché fascisti, a Roma, il 1° febbraio avevano sparato su uno studente di sinistra ferendolo gravemente. La fanatica brutalità dell’Autonomia operaia rese ancora più pericolosa una spirale di scontri di piazza. In cortei nei quali non erano rari barricate e lanci di bottiglie Molotov, si aggiunse il ricorso a pistole contro carabinieri e polizia. Presto, gli spazi di azione per le anime maggioritarie del Movimento si estinsero. Tra autonomi e altri studenti di sinistra si ebbero confronti duri, anche fisici. Il quarantesimo anniversario del Settantasette può essere un’occasione per riflettere su come i sistemi democratici debbano recepire, indirizzare e selezionare, depurandoli dall’intolleranza, istanze e disagi di settori della società che si sentono ai margini delle decisioni. Prima che sia tardi.
2. La ritirata di Lama tra ironia e violenza. «I Lama stanno nel Tibet» venne scritto su un muro de «La Sapienza» di Roma prima che, il 17 febbraio, arrivasse il segretario della Cgil Luciano Lama. Un suo comizio doveva servire al Pci per dimostrare che l’università occupata da studenti non poteva fare a meno del sindacato italiano con più tesserati, guidato da un comunista autorevole. Le anime del Movimento reagirono in maniere diverse. Soltanto con alcune critiche i gruppi della «nuova sinistra», tranne Lotta continua su posizioni aspre. Gli Indiani metropolitani, l’«ala creativa», contestando il comizio al grido di «Ti prego/ Lama/ non andare via/ vogliamo/ ancora/ tanta polizia». Quando gli «Indiani» lanciarono palloncini con liquido colorato contro i servizi d’ordine di Cgil e Pci, questi, non capendo di che si trattasse, risposero con una carica. Finì male. Gli autonomi assaltarono il palco con spranghe, bastoni e pezzi di asfalto (nella foto). La ritirata di Lama fu una sconfitta per il più grande Partito comunista dell’Occidente che dall’anno precedente, per la prima volta dal 1947, in Parlamento si era avvicinato alla maggioranza astenendosi sulla fiducia al governo del democristiano Giulio Andreotti. Fu giorno nero anche per la parte ampia del Movimento che preferiva verso il Pci le armi della critica alla «critica delle armi».
3. Sperimentazione, autogestioni: una scuola da cambiare. L’insegnamento nelle scuole italiane meritava aggiornamenti che tardavano. Nei programmi didattici lo studio era considerato in troppi casi slegato dal lavoro. A fare rumore furono le contestazioni intimidatorie dei settori più estremi del Movimento che pretendevano dai professori presi di mira il «6 politico» nelle secondarie o il «18 politico» nelle università. Ma quegli obiettivi non appartenevano né a tutti gli studenti né all’intero Movimento, una parte consistente del quale richiedeva «sperimentazione didattica»: corsi sugli argomenti più vari, dall’economia al cinema, dal teatro alla sessualità. Se ne organizzarono alcuni durante autogestioni e occupazioni di scuole.
4. L’autocoscienza, fermenti e idee del femminismo. «La vostra violenza/ è solo/ impotenza», gridavano i cortei femministi denunciando stupri e soprusi subiti da donne. Si deve anche a quei momenti se oggi è più alto nella nostra società il disprezzo per i troppi delitti che hanno vittime di sesso femminile. Nel 1977 in Italia soltanto 35 donne su cento lavoravano o erano in cerca di lavoro. Il femminismo ha contribuito a farne salire in seguito il numero, riducendo su questo aspetto la distanza del nostro Paese da altri Stati europei. Nel Movimento l’«emancipazione» era giudicata da molte ingannevole rispetto alla «liberazione» della donna. Sommarietà e fondamentalismi non furono assenti. Una delle attività dei collettivi femministi consisteva nell’«autocoscienza»: riunioni nelle quali ogni componente comunicava alle altre propri problemi e pensieri intimi. Occasione di crescita, in vari casi. Non per tutte fu, psicologicamente, una passeggiata. Per fidanzati e mariti — il comportamento privato dei quali, in contumacia, veniva esaminato con la lente di ingrandimento nei collettivi — la tutela della privacy fu un’utopia. Inconfessabile.
5. Volti coperti. E scoperti, con trucco. Le foto dei giornali spesso ricordano le manifestazioni del 1977 con volti di manifestanti coperti da fazzoletti o passamontagna. Immagini scattate durante cariche di polizia, quando candelotti lacrimogeni rendevano l’aria irrespirabile, o nel corso di assalti a sedi di partito e blocchi stradali. Eppure i visi, non soltanto scoperti, anche truccati, furono un elemento non marginale delle proteste del 1977. Mai prima di allora nell’Italia repubblicana il ricorso a ceroni, kajal e matite varie aveva avuto una diffusione così ostentata e vasta per dimostrazioni politiche. A usare il trucco con vistosità teatrali non erano esclusivamente ragazze. Tra gli Indiani metropolitani, per i maschi poteva essere di ordinanza. Lo scopo: mettere in evidenza una irregolarità, un’anomalia, una diversità ritenute ragioni di orgoglio.
6. Il sangue. Le morti. Fuoco sulle speranze. L’11 marzo a Bologna in scontri con i carabinieri venne ucciso Francesco Lorusso, 24 anni, di Lotta continua. Il giorno seguente a Roma una manifestazione nazionale del Movimento con decine di migliaia di persone venne sfibrata da autonomi con le P38 o con armi improprie che assaltarono negozi, gettarono bottiglie incendiarie contro una sede della Dc e bar, scatenarono guerriglia in più punti del centro della capitale d’Italia. Le violenze furono per il ministro dell’Interno Francesco Cossiga, democristiano, motivo di porre divieto anche a una manifestazione indetta dai radicali per il 12 maggio, terzo anniversario del referendum sul divorzio, in piazza Navona. Ragazzi non organizzati si trovarono sbandati tra drappelli dei settori più estremi pronti allo scontro, agenti in borghese con armi in pugno. Cadde colpita da un proiettile Giorgiana Masi, studentessa di 19 anni. La speranza di cortei senza sangue si indebolì ancora di più.
7. Un altro lato della gioventù. Morire in servizio a 25 anni. A Milano il 14 maggio l’agente Antonio Custra fu ucciso in via De Amicis. Aveva 25 anni, il salario di un lavoratore. Le immagini di autonomi che sparavano segnarono un’epoca.
8. Il ministro Cossiga, gli infiltrati e la repressione. L’Autonomia operaia raccoglieva nel 1977 migliaia di persone e suoi spezzoni erano terreno di reclutamento per formazioni terroristiche. Per quanto non maggioritari, gli autonomi avevano beneficiato di ambiguità e indulgenze di una parte del Movimento e riuscirono a deviare il corso degli eventi in diversi cortei e assemblee. Ma una storia del 1977 non può essere scritta senza tener conto di quanto detto dal ministro dell’Interno di allora, Francesco Cossiga, in un libro del 2010, Fotti il potere: «La contestazione, la violenza politica e il terrorismo minacciavano l’autorità dello Stato e tutti i partiti a cominciare dal Pci mi chiedevano d riportare l’ordine con ogni mezzo. C’era solo un modo per farlo: usare la forza. Fu per questo che, dopo aver infiltrato nelle organizzazioni più estremiste alcuni agenti provocatori, diedi ordine di lasciare liberi i manifestanti di mettere a ferro e fuoco le città. Dopo due o tre settimane la gente non ne poteva più e così, forte del consenso popolare, potei scatenare la repressione».
1977, la rivoluzione che cancellò la rivoluzione, scrive Paolo Delgado il 3 gennaio 2017 su "Il Dubbio". I giovani manifestanti chiudono con la cultura della presa del potere, che dal 1917 russo arriva fino al ’68. Può sembrare del tutto sproporzionato e quasi irriverente azzardare confronti tra il ‘77 italiano e la grande rivoluzione che 60 anni prima aveva rovesciato il secolo e il mondo. Il paragone è certamente impossibile se si guarda alla portata degli eventi. Non così se ci si concentra invece sulla cartografia sociale e politica che il ‘77 ridisegna. Il ‘77 italiano certifica la fine della lunga fase inaugurata dal ‘17 russo, annuncia la fine di quel mondo, l’impraticabilità di quel modello di rivoluzione. Quello del ‘77 è stato un Movimento contro il ‘68, segnato dal radicale rifiuto della ossessione partitistica che aveva dato vita ai gruppi della sinistra extraparlamentare, della separazione tra le sfere del politico e del privato. Il ‘68, come il 1917, è il passato. Il 1977 è il presente. I botti che nella notte del 31 dicembre congedarono il 1976, anno di elezioni politiche finite con una sostanziale parità tra Dc e Pci, anno che di conseguenza aveva per la prima volta visto il Pci non opporsi a un governo monocolore democristiano e anzi sostenerlo con l’astensione, salutarono il 1977 ma solo sul calendario. Politicamente e culturalmente quello che oggi definiamo “il 77” era cominciato già da un pezzo e sarebbe proseguito ancora a lungo. A differenza del ‘68, quanto l’esplosione era stata pressoché contemporanea in tutta la penisola come del resto in tutta Europa e in mezzo mondo, il cosiddetto ‘77 si presentò in momenti diversi di città in città. A Milano era iniziato nell’aprile del 1975, con la settimana di rivolta e scontri seguita alla morte di Claudio Varalli, ucciso da un fascista il 16 aprile, e di Giannino Zibecchi, investito da un gippone della polizia il giorno successivo. Era proseguito con la nascita dei Circoli del proletariato giovanile, la pratica degli espropri nei negozi e nei ristoranti più cari, la teorizzazione del diritto al lusso, sino agli scontri dell’8 dicembre ‘76 per l’inaugurazione della stagione alla Scala. L’anno seguente, nel ‘77 propriamente detto, gli epicentri del Movimento furono Roma e Bologna. L’onda raggiunse gli operai di Torino, i protagonisti principali del decennio rosso, solo nel ‘79, con l’ultima grande ciclo di conflittualità operaia alla Fiat. Può sembrare del tutto sproporzionato e quasi irriverente azzardare confronti tra il ‘ 77 italiano e la grande rivoluzione che sessant’anni prima aveva rovesciato il secolo e il mondo. Il paragone è certamente impossibile se si guarda alla portata degli eventi. Non così se ci si concentra invece sulla cartografia sociale e politica che il ‘ 77 ridisegna, costringendo a depositare nei ripostigli della memoria quella precedente. Il ‘77 italiano certifica la fine della lunga fase inaugurata dal ‘17 russo, annuncia la fine di quel mondo, l’impraticabilità di quel modello di rivoluzione. Quello del ‘ 77 è stato un Movimento contro il ‘ 68, segnato dal radicale rifiuto della ossessione partitistica che aveva dato vita ai gruppi della sinistra extraparlamentare, della separazione tra le sfere del politico e del privato, della concezione sacrificale che rinviava la festa rivoluzionaria a dopo la conquista del palazzo d’Inverno di turno, di un’idea della rivoluzione intesa come presa del potere, dell’universalismo egualitario che il 1917 aveva ereditato dal 1789 e di lì era arrivato senza scosse al ‘68. La musica del ‘ 77 era diversa, tanto distante dai movimenti del passato recente quanto la rabbia punk di Anarchy in Uk lo era dalle utopie del rock impegnato della West Coast hippie. In quella lunghissima assemblea permanente che si svolse a Lettere dal 2 febbraio, giorno dell’occupazione della città universitaria, al 17 febbraio, data della cacciata di Lama dall’università e dello sgombro militare della stessa, si parlava davvero di tutto, senza ordine del giorno, senza presidenza, senza tentativi di strutturare il dibattito. Però il tema che appena pochi anni prima sarebbe stato dominante, l’interrogativo su come dare uno sbocco organizzativo a quel conflitto spontaneo, quasi non figurava nell’agenda. Il Movimento del ‘ 77 guardava al presente, sostituendo all’orizzonte lontano della rivoluzione a venire quello immediato del “qui e ora”. Puntava sulla spontaneità, sulla creatività e sull’autonomia senza inseguire la chimera bolscevica del “soggetto rivoluzionario”. Rompeva ogni barriera tra privato e pubblico, convinto che il “personale” fosse del tutto “politico”. Rifiutava l’universalismo per esaltare le differenze, instaurando il primato di una mitologia “differenzialista” opposta e forse non meno malintesa e pericolosa di quella egualitaria che aveva sin lì tenuto banco. Ma tutto il bagaglio che dal Movimento del ‘77 veniva negato e rinnegato, il ‘68 lo aveva ereditato dalla cultura dei movimenti rivoluzionari, per come si era definita a partire dall’Ottobre di Pietrogrado. La rottura del resto era anche più profonda. Gli studenti e i militanti del ‘68, anche in questo ereditando una cultura politica antecedente alla stessa rivoluzione russa, identificavano un soggetto sociale rivoluzionario, per alcuni l’operaio- massa, gli operai di linea e dequalificati delle grandi fabbriche, per altri i popoli del Terzo mondo destinati ad accerchiare le roccaforti imperialiste, al quale si rivolgevano pretendendo di mettersene al servizio e spesso mirando a guidarlo e indirizzarlo. Ma era sempre e comunque altro da sé. I ribelli del ‘ 77 sentivano e sapevano di essere loro stessi il soggetto sociale sfruttato e condannato a una vita grama. Erano la prima generazione che sperimentava sulla propria pelle la fine della società affluente e l’inizio dell’era del precariato e del neo- schiavismo, erano quindi loro stessi il soggetto rivoluzionario. Si spiegano così l’urgenza, la violenza e anche la sostanziale disperazione di un movimento che reagiva mimando la gioia, mascherando l’angoscia sotto le parvenze beffarde e dissacranti degli indiani metropolitani e del situazionismo riscoperto, ma alla fine inevitabilmente arrivando a uno scontro che era violentissimo perché la posta in gioco non lasciava spazio a possibili mediazioni. I ragazzi del ‘ 68 sapevano che, se sconfitti, sarebbero comunque tornati alle loro origini e avrebbero ripreso il loro posto nei ceti medi o medio- alti, come moltissimi hanno effettivamente fatto. Quelli del ‘ 77 erano senza rete e lo avvertivano a pelle. Come in ogni cesura storica, la nettezza del taglio si coglie meglio guardando a ritroso di quanto non si percepisse nel fuoco degli eventi. Gli elementi nuovi e inediti marciavano fianco a fianco con i bagliori estremi dell’epoca al tramonto, tra i quali nessuno era più abbacinante delle Brigate rosse, organizzazione comunista ancora del tutto interna alla logica rivoluzionaria inaugurata dal 1917 e dunque sospettosa e diffidente quasi quanto il Pci di fronte a quello “strano movimento di strani studenti”, come lo definì un fortunato pamphlet dell’epoca. Sul piano del fronteggiamento politico immediato, il nemico principale del Movimento del ‘77 fu il Pci, e lo fu da subito. Il primo febbraio, in piena città universitaria, viene ferito da una rivoltellata fascista lo studente Guido Bellachioma. Il giorno dopo, mentre in piazza della Minerva Walter Veltroni arringa a nome della Fgci alcune centinaia di studenti, migliaia di manifestanti assaltano e incendiano la sede del Fronte della Gioventù in via Sommacampagna, dietro piazza Indipendenza, con l’immancabile scia di scontri con la polizia e con i gruppi fascisti usciti dalla sede in fiamme. Una macchina della polizia in borghese taglia all’improvviso il corteo e viene bersagliata di sassi. Uno dei poliziotti, Domenico Arboletti, esce e senza qualificarsi spara alcuni colpi. Dal corteo rispondono al fuoco, l’agente cade ferito gravemente. Il suo collega esce a sua volta col mitra spianato, ferisce prima Paolo Tommassini, poi Daddo Fortuna che tentava di portare via il compagno ferito trascinandolo con una mano e tenendo con l’altra sia la sua pistola che quella di Tommassini. Dopo la sparatoria il corteo rientra nella città universitaria e la occupa. Il giorno dopo Ugo Pecchioli, “ministro degli Interni” del Pci dichiara: «Collettivi autonomi e fascisti svolgono da tempo un’azione parallela e concomitante, ma non sono due realtà opposte. E’ la medesima logica che li muove, l’odio per le istituzioni democratiche». Per la prima volta l’estremismo rosso non è solo messo sullo stesso piano di quello nero secondo la logica degli “opposti estremismi” ma è direttamente identificato con una forma di fascismo. Nei giorni seguenti il cronista dell’Unità Duccio Trombadori viene “processato” dall’assemblea riunita a Lettere ed «espulso a vita per affermazioni deliranti» dalla città universitaria. Il bando si allarga in realtà anche ai partitini della sinistra radicale che si vogliono eredi del ‘68. E’ in questo clima che si arriva alla folle scelta di organizzare il comizio di Lama nell’università occupata, il 17 febbraio. L’esito di quella provocazione e il seguito renderanno la lacerazione più profonda e incolmabile: gli scontri, il palco abbattuto, il segretario della Cgil messo in fuga con il servizio d’ordine del sindacato mai così plumbeo e torvo, il successivo arrivo delle ruspe a sgombrare l’università e poi, meno di un mese dopo, l’esplosione della capitale rossa, Bologna, in seguito all’uccisione di Francesco Lorusso, i blindati di Cossiga spediti a ripristinare l’ordine dopo 4 giorni di rivolta, la manifestazione nazionale del 12 marzo a Roma, aperta dai bolognesi che scandiscono “Bologna è rossa del sangue di Francesco”, che assalta la sede nazionale della Dc in piazza del Gesù, saccheggia un’armeria sul lungotevere, apre a ripetizione il fuoco sulla polizia, incendia il commissariato di piazza del Popolo. Non che in precedenza tra Movimento e Pci corresse buon sangue. Ma la critica si era sempre limitata a bersagliare “il revisionismo” del partitone, la sua rinuncia alla via maestra rivoluzionaria. Nel ‘ 77 le cose cambiano: il Pci è individuato come parte integrante dello Stato, sponda politica eminente di quella trasformazione sociale complessiva di cui i ragazzi del ‘ 77 si sentivano, a ragione, vittime e nemici mortali. La deriva che porterà i partiti socialdemocratici a gestire in prima persona la gigantesca riorganizzazione degli assetti sociali che, a partire proprio dalla fine dei ‘ 70, cancellerà le conquiste di un secolo instaurando una sorta di neoschiavismo inizia in quell’anno, così come entra in scena allora, per la prima volta, il soggetto sociale prodotto da quel riassetto. Se a distanza di 40 anni non riusciamo a guardare al ‘ 77 con la stessa distaccata nostalgia che avvolge il ‘68 è perché in quell’anno si è presentato, da ogni punto di vista, il mondo in cui viviamo oggi. Il ‘ 68, come il 1917, è il passato. Il 1977 è il presente.
Sogni, errori, libertà. Il nostro ‘77 fu diverso, scrive Carlo Rovelli il 14 febbraio 2017, su "Il Corriere della Sera". L’idea che il mondo andava cambiato è stata sconfitta ma non fu inutile. Quei valori sono rimasti radicati in noi. Leggo in questi giorni diversi articoli sul movimento giovanile che è passato sull’Italia nel 1977, quarant’anni fa, breve e intenso come una folata di vento. Non mi riconosco in questi articoli. Mi sembra non parlino di quanto ci dicevamo, pensavamo e sentivamo io e i miei amici in quegli anni lontani. Io non so fare analisi storiche e sociologiche e non voglio confondere la mia esperienza personale, mia e di qualche amico, con un fatto storico. Ma allora erano molti gli amici intorno a me che sentivano come me, e da qualche parte ci sono ancora. Scrivo qualche riga per loro, i miei tanti amici di allora, e anche per chi magari è curioso di sentire un ricordo diverso. Alcuni di quegli amici hanno un ricordo magico e mitico di quegli anni. Un momento intensissimo di scambio, sogni, entusiasmo, voglia di cambiare, voglia di costruire insieme un mondo diverso e migliore; lo ricordano con nostalgia intensa, fino a rendere grigia l’immagine di quella che è stata la vita poi. Per me non è così. Avevamo vent’anni, e a vent’anni la vita è spesso splendida e rovente, almeno nel ricordo. Non è il profumo della storia, è il profumo della giovinezza. Per me quegli avvenimenti sono stati sì magici e bellissimi, ma perché sono stati l’inizio, perché ne ho tratto delle cose. Hanno aperto un percorso. Non hanno reso la vita successiva meno colorata: sono stati la scoperta collettiva di colori che sono rimasti con me. Certo, l’anno successivo al 1977 è stato vissuto da molti di noi come una disfatta. La voglia luminosa di cambiare il mondo, che ci era sembrata per un attimo aprire possibilità vere, si scontrava contro la realtà. Naufragava, prima colpita dalla reazione delle istituzioni, quella che allora chiamavamo la repressione; poi sconcertata per la violenza di quello che adesso chiamiamo terrorismo. Eravamo in tanti a dirci e sapere bene che la lotta armata in Italia non avrebbe portato a nulla di buono, che era solo una reazione estrema e sciocca, in realtà disperata, a sogni che si chiudevano. I «compagni che sbagliano», lo sapevamo in tanti, erano ragazze e ragazzi con un senso morale più assoluto degli altri, e, come purtroppo spesso accade, accecati da questo. Noi volevamo altro, e per un momento, insieme, in tanti, avevamo pensato fosse possibile. Che fosse possibile andare in quella direzione. Quale direzione? I grandi sogni hanno la caratteristica che quando svaniscono sembrano inconcepibili. Talvolta nella storia i sogni più inconcepibili si realizzano: contro ogni aspettativa dei realisti, la rivoluzione francese abbatte il predominio dell’aristocrazia, il cristianesimo conquista l’impero romano, un allievo di Aristotele conquista il mondo e i suoi amici fondano biblioteche e centri di ricerca, i seguaci di un predicatore arabo cambiano l’ordine del pensiero di centinaia di milioni di persone, eccetera eccetera. Più spesso, grandi sogni si scontrano contro la forza del quotidiano, durano pochissimo o poco, crollano, vengono dimenticati. Sono i tanti rivoli della storia che, bene o male, non portano da nessuna parte. I movimenti del Trecento per una chiesa povera, le comunità utopiche del XVIII secolo, o il sogno egualitario del comunismo sovietico; oppure le fantasie naziste che appassionavano tanto la gioventù, forse oggi il Califfato… Ma più spesso ancora quello che succede è più complesso, e la storia segue percorsi tortuosi. Il Direttorio elimina Robespierre, Wellington batte Napoleone, e il re di Francia torna sul trono: la rivoluzione ha perso… Ma ha perso davvero? Il movimento delle suffragette per il diritto di voto alle donne è sconfitto al tempo della prima guerra mondiale. Ma ha perso davvero? I movimenti storici sono fatti di idee, giudizi etici, passioni, modi di vedere il mondo. Spesso non vanno da nessuna parte. Talvolta però lasciano tracce che continuano ad agire in profondità sul tessuto mentale della civiltà, la cambiano. La nostra civiltà, l’insieme dei valori in cui crediamo, è il risultato di molti sogni, di molti che hanno saputo sognare intensamente al di là del presente. Il movimento del ‘77 italiano non è comprensibile da solo. È stato un’espressione tarda, non certo l’ultima, ma una delle ultime, consapevole di questo, e per questo intensa, di uno di questi grandi sogni che ha spazzato non l’Italia ma il mondo intero per un breve ventennio che va dagli anni Sessanta alla fine degli anni Settanta. Sono stati anni in cui una parte considerevole della gioventù del mondo intero ha sognato e sperato intensamente di poter cambiare la realtà sociale in modo molto radicale. Non è stato certo un movimento di pensiero strutturato e coerente, anzi, era disperso in mille rivoli. Ma nonostante le grandi diversità, tutti questi rivoli sentivano con assoluta chiarezza di appartenere allo stesso fiume, dalle piazze di Praga alle università di Città del Messico, dal campus di Berkeley a Piazza Verdi a Bologna, dalle comuni hippie rurali e urbane della California ai guerriglieri sudamericani, dalle marce cattoliche per il Terzo mondo agli esperimenti dell’anti-psichiatria inglese, da Taizé a Johannesburg, nella strepitosa differenza di atteggiamenti specifici, c’era un reciproco intenso riconoscimento di appartenere allo stesso grande fiume, di condividere uno stesso grande sogno. Di «lottare», come si diceva allora, per un mondo molto diverso. Era il sogno di costruire un mondo dove non ci fossero forti disparità sociali, non ci fosse dominio dell’uomo sulla donna, non ci fossero confini, non ci fossero eserciti, non ci fosse miseria. Era il sogno di sostituire la collaborazione alla lotta per il potere, di lasciarsi alle spalle i bigottismi, i fascismi, i nazionalismi, gli identitarismi, che avevano portato le generazioni precedenti a sterminare cento milioni di esseri umani durante le due guerre mondiali. I sogni si spingevano lontano: un mondo senza proprietà privata, senza gelosia, senza gerarchie, senza chiese, senza stati potenti, senza famiglie chiuse, senza dogmi, libero. Dove non avevamo bisogno degli eccessi del consumismo, e si lavorava per il piacere di fare, non per lo stipendio. Solo a nominare oggi queste idee sembra di parlare di delirî. Eppure eravamo in tanti a crederci, in tutto il mondo. In quegli anni ho viaggiato molto, in diversi continenti, e ovunque incontravo giovani con questi stessi sogni. Di questo parlavamo i miei amici ed io in quell’anno, il 1977. Non certo della paura del precariato. Se vogliamo ricordare qualcosa di quelli anni, è questo che io ricordo. Vivevamo in case aperte. Si dormiva un po’ qui e un po’ là. Sapevamo bene che l’eroina è pericolosissima e chiunque avesse un po’ di cervello se ne teneva lontano. Ma sapevano anche che marijuana e Lsd non lo sono, e si offriva uno spinello con la semplicità con cui si offre un bicchiere di vino. L’Lsd era tutt’altro: un’esperienza potente e importante, da trattare con attenzione e rispetto, ma che poteva insegnare molto. L’occupazione principale, come è d’uso per ogni gioventù, era innamorarsi e disperarsi per amore; ma il sesso era moneta quotidiana, un modo per incontrarsi e conoscerci con tutti, dell’altro sesso come del proprio. Era preso sul serio, come il centro della vita, quasi con religione. E come per ogni religione, di sesso e amore si voleva riempire la vita. E di amicizia, di musica, di inventarsi modi di essere insieme, diversi da quelli grigi e competitivi delle generazioni precedenti. Si provava a vivere in comune, si provava a non essere gelosi, si provava a condividere. Ci si azzuffava e ci si disperava come in ogni famiglia, ma il senso di essere una grandissima famiglia sparsa per il pianeta, era forte: un grandissima famiglia che si adoperava insieme, come esploratori delle stelle, a costruire un mondo nuovo, molto diverso… Io mi sono sempre immaginato che le comunità quacchere dei primi coloni europei in America, i compagni di Gesù in Palestina, i primi cristiani, i giovani italiani del Risorgimento, i compagni di Che Guevara in Bolivia o gli allievi di Platone nell’Academia… si sentissero un po’ così…Quel mondo non l’abbiamo costruito, non c’è ombra di dubbio. La disillusione è arrivata presto. Alcuni dei progetti li abbiamo abbandonati perché ci sono sembrati sbagliati. Molti altri semplicemente perché sono gli altri che hanno vinto. La plausibilità di quei sogni si è sciolta per la mia generazione come neve al sole. Ci siamo separati, ciascuno è andato nella vita seguendo una sua strada. È stato inutile sognare? Non credo. Per due motivi. Il primo è che per molti di noi quei sogni hanno rappresentato il nutrimento fertile su cui costruire la vita. Alcuni di quei valori sono rimasti radicati dentro di noi e ci hanno guidato. La libertà di pensiero estrema di quegli anni, in cui tutto sembrava possibile ed esplorabile e qualunque idea sembrava modificabile, è stata la sorgente per cui molti di noi hanno fatto quello che poi hanno fatto nella vita. Il secondo motivo non so se sia credibile o no. Ma esiste lo stesso. Spesso nella storia i sogni di costruire un mondo migliore sono stati sconfitti. Ma hanno continuato a lavorare sotterraneamente. E alla fine hanno contribuito a cambiare davvero. Io continuo a credere che questo mondo sempre più pieno di guerra, di violenza, di estreme disparità sociali, di bigottismo, di gruppi nazionali, razziali, locali, che si chiudono nella propria identità gli uni contro gli altri, continuo a credere che questo mondo non sia l’unico mondo possibile. E forse non sono il solo.
FASCISTI-COMUNISTI PER SEMPRE.
Pansa: "Vi racconto l'Italia in cui tutti, o quasi, gridavano Eia Eia Alalà". Nel suo nuovo libro Giampaolo Pansa autore del «Sangue dei vinti» ricostruisce l'ascesa del fascismo e il consenso di massa al regime. Che molti dimenticano..., («erano tutti fascisti dice Pansa e poi hanno fatto finta di essere stati tutti antifascisti»).
Camilleri: «Gli scontri con Sciascia la vita da cieco e il No al referendum». Lo scrittore: a volte ho paura del buio, quando sarà il momento vorrei l’eutanasia. Io le riforme le voglio: ma questa è pasticciata, scrive Aldo Cazzullo il 18 novembre 2016 su "Il Corriere della Sera". Novantun anni, 102 libri, 26 milioni di copie solo in Italia: Andrea Camilleri è lo scrittore più importante che abbiamo. «Vorrei l’eutanasia, quando sarà il momento. La morte non mi fa paura. Ma dopo non c’è niente. E niente di me resterà: sarò dimenticato, come sono stati dimenticati scrittori molto più grandi. E quindi mi viene voglia di prendere il viagra, di ringiovanire, pur di vivere ancora qualche anno, e vedere come va a finire. Vedere che presidente sarà Trump: uno tsunami mondiale, un Berlusconi moltiplicato per diecimila. E vedere cosa sarà del mio Paese». «A guardare l’Italia ridotta così, mi sento in colpa. Avrei voluto fare di più, impegnarmi di più. Nel Dopoguerra ci siamo combattuti duramente, ma avevamo lo stesso scopo: rimettere in piedi il Paese. Oggi quello spirito è scomparso». Renzi non è un buon presidente del Consiglio? «No. È un giocatore avventato e supponente. Mi fa paura quando racconta balle: ad esempio che il futuro dei nostri figli dipende dal referendum. Mi pare un gigantesco diversivo per realizzare un altro disegno». Quale? «Mi sfugge, ma c’è». Al referendum andrà a votare? «Pur di votare No mi sottoporrò a due visite oculistiche, obbligatorie per entrare nella cabina elettorale accompagnato. Io le riforme le voglio: il Senato deve controllare la Camera, non esserne il doppione. Ma questa riforma è pasticciata. E non ci consente di scegliere i nostri rappresentanti». Spera nei Cinque Stelle? «Non mi interessano. Non ci credo. Mi ricordano l’Uomo Qualunque: Grillo è Guglielmo Giannini con Internet. Nascono dal discredito della politica, ma non hanno retto alla prova dei fatti: Pizzarotti è stato espulso dal movimento; la Raggi non mi pare stia facendo grandi cose». Se vince il No cosa succede? «Entra in campo Mattarella. Che si comporterà bene; perché è un gran galantuomo». «Galantuomo era mio padre Giuseppe, anche se avevamo idee politiche opposte. Lui aveva fatto tutta la Grande guerra nella brigata Sassari. Adorava il suo comandante: Emilio Lussu. Vide morire Filippo Corridoni. Poi divenne fascista e fece la marcia su Roma. Però quando il mio compagno Filippo Pera mi disse che non sarebbe più venuto a scuola perché era ebreo, mio padre si indignò: “È una sciocchezza che il Duce fa per il suo amico Hitler”. Lealtà, fedeltà alla parola data, ironia, arte di guardare oltre le cose: sotto molti aspetti Montalbano è il ritratto di papà. Fu mia moglie Rosetta a farmelo notare. I padri si innamorano sempre un po’ delle mogli dei figli; e Rosetta a lui ha voluto molto bene». «Il matrimonio dei miei genitori era stato combinato. Nozze di zolfo, toccate anche a Pirandello: gli zolfatari facevano sposare i loro eredi per concentrare la proprietà, e ritardare il fallimento cui erano condannati. Però il matrimonio dei miei era riuscito. Quando mio padre morì, Turiddu Hamel, il sarto, si inchinò al passaggio della bara. Hamel era l’antifascista del paese. Mi raccontò che, quando stava morendo di fame perché entrava e usciva dal carcere, papà gli aveva commissionato una divisa nera: “E sia chiaro che non lo faccio per sfregio…”. “To patri sapiva campari” mi disse il vecchio sarto: Giuseppe Camilleri sapeva vivere». «Anche io sono stato fascista. Avevo sedici anni quando il Duce annunciò la guerra: ascoltai il discorso dagli altoparlanti in piazza. Tornai a casa entusiasta, e trovai nonna Elvira e nonna Carolina in lacrime. Tutte e due avevano perso un figlio nelle trincee: “A guerra sempre tinta è”, la guerra è sempre cattiva. Anche mio padre la conosceva. E conosceva gli inglesi». «Il primo a dirmi che in realtà ero comunista fu il vescovo di Agrigento, Giovanbattista Peruzzo, piemontese di Alessandria. Leggevo le firme delle riviste del Guf, Mario Alicata, Pietro Ingrao, e mi riconoscevo. Ma la vera svolta fu un libro, che mi fece venire la febbre e mi aprì gli occhi: La condizione umana di Malraux». «Nell’estate del ’42 andai a Firenze al raduno della gioventù fascista. C’era il capo della Hitler Jugend, Baldur von Schirach, venuto ad annunciare l’Europa di domani: un’enorme caserma, con un unico vangelo, il Mein Kampf. C’erano ragazzi e ragazze di tutta l’Europa occupata: Francia, Spagna, Polonia, Ungheria; le ungheresi erano bellissime, facemmo amicizia parlando latino. Sul fondale c’era un’enorme bandiera tedesca. Protestai: “Siamo in Italia!”. Così issarono anche un tricolore. Ma Pavolini mi individuò tra la folla, mi chiamò, e mi rifilò un terribile càvucio nei cabasisi: insomma, un calcio nelle palle. Finii in ospedale. Il prefetto, che era amico di mio padre, mi fece trasferire in una clinica privata, nel caso che Pavolini mi avesse cercato». «Fui richiamato il primo luglio 1943. Mi presentai alla base navale di Augusta e chiesi la divisa. “Quale divisa?”. Mi mandarono a spalare macerie in pantaloncini, maglietta, sandali e fascia con la scritta Crem: Corpo reale equipaggi marittimi. La mia guerra durò nove giorni. Nella notte dell’8 luglio il compagno che dormiva nel letto a castello accanto al mio sussurrò: “Stanno sbarcando”. Uscii sotto le bombe, buttai la fascia, tentai l’autostop: incredibilmente un camion si fermò. Arrivai così a Serradifalco, nella villa con la grande pistacchiera dove erano sfollate le donne di famiglia. Zia Giovannina fece chiudere i cancelli e mettere i catenacci: “Qui la guerra non deve entrare!”. Arrivarono gli americani e abbatterono tutto con i carri armati». «In testa c’era un generale su una jeep guidata da un negro. Passando vide una croce, là dove i tedeschi avevano sepolto un camerata fatto a pezzi da una scheggia. Il generale battè con le nocche sull’elmetto del negro, e la jeep si fermò. Prese la croce, la spezzò, la gettò via. Poi diede altri due colpi sull’elmetto, e la jeep ripartì. Sfilarono altri sedici uomini. Io ero annichilito dalla paura. L’ultimo mi sorrise e mi parlò: “Ce l’hai tanticchia d’olio, paisà? Agghio cogliuto l’insalatedda…”. Erano tutti siciliani. Mi sciolsi in un pianto dirotto, e andai a prendere l’olio per l’insalata. Poi chiesi chi fosse l’uomo sulla jeep. Mi risposero: “Chisto è o mejo generale che avemo; ma como omo è fitusu. S’acchiama Patton”». «Noi comunisti siciliani le elezioni le avevamo vinte. Alle Regionali dell’aprile 1947 il Blocco del popolo prese 200 mila voti più della Dc. Il Primo maggio mi ritrovai con gli amici a festeggiare, e mi ubriacai. Arrivò la notizia di Portella della Ginestra: gli agrari avevano fatto sparare sui compagni. Vomitai tutto. Da allora non ho più toccato un goccio di vino». «Leonardo Sciascia era di un anticomunismo viscerale. Eravamo molto amici, ma abbiamo litigato come pazzi. Nei giorni del sequestro Moro lui e Guttuso andarono da Berlinguer e lo trovarono distrutto: Kgb e Cia, disse, erano d’accordo nel volere la morte del prigioniero. Sciascia lo scrisse. Berlinguer smentì, e Guttuso diede ragione a Berlinguer. Io mi schierai con Renato: era nella direzione del Pci, cos’altro poteva fare? Leonardo la prese malissimo: “Tutti uguali voiauti comunisti, il partito viene prima della verità e dell’amicizia!”». «Un’altra cosa non mi convinceva di Sciascia. Nei suoi libri a volte rendeva la mafia simpatica. A teatro gli spettatori applaudivano, quando nel Giorno della civetta don Mariano distingue tra “uomini, mezzi uomini, ominicchi, piglianculo e quaquaraquà”. Leonardo mi chiedeva: ma perché applaudono? “Perché hai sbagliato” gli rispondevo. Altre volte rendeva la mafia affascinante. “Lei è un uomo” fa dire a don Mariano. Ma la mafia non ti elogia, la mafia ti uccide; per questo di mafia ho scritto pochissimo, perché non voglio darle nobiltà. Eppure a Leonardo ho voluto un bene dell’anima. Andavo di continuo a rileggere i suoi libri. Per me erano come un elettrauto: mi ricaricavano». «Da quando sono diventato cieco, i pensieri tinti mi visitano più spesso. Cerco di scartarli; però tornano. A volte mi viene la paura del buio, come da bambino. Una paura fisica, irrazionale. Allora mi alzo e a tentoni corro di là, da mia moglie. Per fortuna ho Valentina, cui detto i libri: è l’unica che sa scrivere nella lingua di Montalbano, anche se è abruzzese. Fino a poco fa vedevo ancora le ombre. Sono felice di aver fatto in tempo a indovinare il viso della mia pronipote, Matilde. Ora ha tre anni, è cresciuta, mi dicono che è bellissima, ma io non la vedo più. Di notte però riesco a ricostruire le immagini. L’altra sera mi sono ricordato la Flagellazione di Piero della Francesca. Ho pensato all’ultima volta che l’ho vista, a Urbino — aprirono il Castello apposta per me —, e l’ho rimessa insieme pezzo a pezzo. È stato meraviglioso».
Caro Camilleri, tu di Sciascia non hai capito nulla, scrive Valter Vecellio il 22 novembre 2016 su "Il Dubbio". La questione della denuncia per calunnia a Berlinguer non andò come ha raccontato l'autore di Montalbano. E non è vero che, ne "Il giorno della civetta", «la mafia è stata resa simpatica». Il 20 novembre di sedici anni fa Leonardo Sciascia ci lascia. Il Corriere della Sera, coincidenze che sono - dice Sciascia - «incidenze», il giorno prima pubblica una lunga intervista ad Andrea Camilleri, curata da Aldo Cazzullo. Il titolo: "Gli scontri con Sciascia, la mia vita da cieco e il NO al referendum". A un certo punto, Camilleri dice: «Nei giorni del sequestro Moro lui e Guttuso andarono da Berlinguer e lo trovarono distrutto: KGB e CIA, disse, erano d'accordo nel volere la morte del prigioniero. Sciascia lo scrisse. Berlinguer lo smentì, e Guttuso diede ragione a Berlinguer. Io mi schierai con Renato: era nella direzione del PCI, cos'altro poteva fare? Leonardo la prese malissimo: "Tutti uguali voi comunisti, il partito viene prima della verità e dell'amicizia"?». Non ricordo interventi particolari di Camilleri, nei giorni della polemica che oppose Sciascia a Berlinguer e Guttuso. Forse ci sono stati, probabilmente privati. Di pubblici non ne ho trovato traccia. Ma non è questo il punto. Il fatto è che le cose non sonno andate come le racconta Camilleri. Di come si siano svolti i fatti posso dare testimonianza diretta, avendo avuto possibilità di sentire dallo stesso Sciascia cos'era accaduto. In sintesi: nel maggio del 1977, e dunque molto prima dei giorni del sequestro Moro, Sciascia si incontra con Enrico Berlinguer, per parlare di cose che riguardavano la Sicilia; è accompagnato da Guttuso, che era stato tramite per ottenere l'appuntamento. Siccome il giorno prima c'era stato l'incontro di una delegazione democristiana con una delegazione comunista, e secondo i giornali e la televisione in questo incontro si era anche parlato di una potenza o di potenze straniere che potessero avere mano nel terrorismo italiano, ad un certo punto, finito il colloquio sulle cose siciliane con Berlinguer, Guttuso domanda se sia vero che avevano parlato di paesi stranieri, e se uno di questi paesi stranieri era la Cecoslovacchia. Berlinguer risponde di sì; e del resto non era una confidenza, non era un segreto, perché tutti ne parlavano. Berlinguer, quindi, non fa altro che riferire un sentito dire, l'aveva sentito dai democristiani, ne era a conoscenza e lo diceva. Lo stesso giorno dell'incontro con Berlinguer, Sciascia viene invitato a colazione dal pittore Bruno Caruso, al quale racconta questo fatto, esprimendo anche un senso di ammirazione per la sincerità di Berlinguer: come un elogio nei riguardi di Berlinguer, che era tanto spregiudicato e tanto libero da ammettere che si fosse parlato di quella cosa. Passati due anni, Sciascia è deputato, membro della Commissione Moro. A un certo punto viene un eminente democristiano, al quale chiede se sa qualcosa di potenze straniere che danno una mano al terrorismo italiano, di sospetti, di indizi. L'eminente democristiano dice di non saperne nulla. Al che Sciascia ribatte: «Ma guardi, due anni fa, io ho avuto fortuitamente un incontro con Berlinguer, il quale mi ha raccontato tranquillamente questa cosa: quindi com'è che lei non ne sa nulla?». Tutto qui, l'intervento di Sciascia in Commissione Moro. Da lì però, esce alquanto deformato, come se Berlinguer avesse fatto delle confidenze su cose che risultavano a lui e non che lui avesse saputo dai democristiani. Questa deformazione provoca la smentita di Berlinguer, e in seguito la querela per diffamazione. Sciascia replica con una denuncia per calunnia. Guttuso è il testimone chiave, ma si allinea con Berlinguer, smentendo Sciascia. Il quale però poteva smentire Guttuso, perché il pittore, in presenza di un'altra persona, nella Pasqua del 1980, aveva ricordato il colloquio che aveva avuto con Berlinguer e il fatto che Berlinguer aveva parlato della Cecoslovacchia. Peccato che il giudice, che ha avuto tra le mani sia la querela di Berlinguer sia la denuncia di Sciascia, si sia limitato ad ascoltare Berlinguer e Guttuso, non ha ascoltato Sciascia e quel che aveva da dire; e archiviato tutta la vicenda. Questi i fatti, molto diversi da come li racconta Camilleri. Camilleri poi, ancora una volta (l'aveva già fatto sul Fatto quotidiano), si accoda a una tesi che non definisco perché dovrei fare ricorso all'invettiva volgare: quella di aver reso, nei suoi libri, la «mafia simpatica. A teatro gli spettatori applaudivano, quando nel Giorno della civetta don Mariano distingue tra "uomini, mezzi uomini, ominicchi, piglianculo e quaquaraquà". Leonardo mi chiedeva: "ma perché applaudono? "- "Perché hai sbagliato", gli rispondevo. Altre volte rendeva la mafia affascinante. "Lei è un uomo", fa dire a don Mariano. Ma la mafia non ti elogia, la mafia ti uccide; per questo di mafia ho scritto pochissimo, perché non voglio darle nobiltà?». Per restare al solo Giorno della civetta: famosissima la pagina evocata da Camilleri, che però omette dal ricordare che quella davvero importante è quella che viene prima: quando il capitano Bellodi sente che il mafioso - anche grazie alle protezioni politiche di cui gode a Roma - gli sta per sfuggire dalle mani. Lo capisce, e pensa a Cesare Mori, il "prefetto di ferro" che Mussolini aveva mandato in Sicilia, e che aveva stroncato il brigantaggio; quando poi Mori comincia a pestare i piedi alla mafia, che è già entrata nel regime, il prefetto viene nominato senatore e rimosso. I metodi di Mori erano brutali, all'insegna del «fine giustifica i mezzi», al di là e al di sopra delle leggi. Fare come Mori, pensa per un attimo Bellodi. Una tentazione che scaccia subito: no, dice, bisogna stare nella legge. Piuttosto quello che serve è indagare sui patrimoni, mettere la Finanza, mani esperte, come hanno fatto in America con Al Capone, a frugare sulle contabilità, e non solo dei mafiosi come Mariano Arena: annusare le illecite ricchezze degli amministratori pubblici, il loro tenore di vita, quello delle mogli e delle loro amanti, censire le proprietà e comparare il tutto con gli stipendi ufficiali; e poi, come scrive Sciascia: «tirarne il giusto senso». Quello che anni dopo fanno Beppe Montana, Ninì Cassarà, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino: che cercano di «tirare il giusto senso» appunto indagando sulle tracce lasciate dal denaro, che non puzza, ma una scia la lascia sempre, a saperla leggere, a volerla trovare. «Tirare il giusto senso», significa anche Anagrafe Patrimoniale degli Eletti; significa che ministri, parlamentari, amministratori pubblici devono vivere come in una casa di vetro, e devono rendere conto del loro operato agli elettori, che devono essere messi nella condizione di sapere. Se quei suggerimenti fossero stati accolti, probabilmente molte cronache giudiziarie, di ieri e oggi, ce le saremmo risparmiate. L'altra pagina importante e amarissima è l'ultima. Bellodi è tornato a Parma, c'è una festa, e si racconta una storia: quella di un medico del carcere che si mette in testa di cacciare i mafiosi sani dall'infermeria e ricoverarvi i detenuti malati. Il medico una notte è vittima di un'aggressione, un pestaggio all'interno del carcere. Nessuno lo aiuta, tutti gli dicono che è meglio lasci perdere. Il medico è un comunista, si rivolge al partito. Anche il partito gli dice di lasciar perdere. Il medico allora si rivolge al capomafia, e gli aggressori vengono puniti. Un aneddoto amarissimo, e non ne sfuggirà il senso, il significato. Poi, vengono i Camilleri a dirci che Il giorno della civetta è un romanzo che fa l'apologia della mafia!
Sciascia, il carabiniere, la mafia, l'antifascismo..., scrive Valter Vecellio il 30 novembre 2016 su "Il Dubbio". Il carteggio e l'amicizia tra lo scrittore di Racalmuto e Renato Candida. In un suo saggio del 1972 che racconta la storia della mafia, Leonardo Sciascia racconta che questa parola - mafia, appunto - appare nel primo vocabolario siciliano compilato nel 1868 da Antonino Traina: si ipotizza che addirittura sia stata importata dal Piemonte, «sulle ali della spedizione dei Mille di Garibaldi». Tuttavia, spiega lo scrittore, per lo studioso di tradizioni popolari Giuseppe Pitrè «mafia» è solo «una ipertrofia» dell'ego ribellista. Poi, con Giuseppe Rizzotto, autore nel 1862 de «I mafiosi di la Vicaria» (una prigione di Palermo) la mafia diventa «associazione». Ma, annota Sciascia, sarà un procuratore, Alessandro Mirabile, a parlarne come di «setta» nelle sue requisitorie. Sottolinea Sciascia: «Alcuni, anche in buona fede, credono che applicando la parola alla cosa si tenda a creare un pregiudizio. È ingiusto, affermano costoro, che a Milano una banda di rapinatori sia una semplice banda, mentre in Sicilia diventa cosca». Sciascia, su questo, è netto: «La parola mafia è stata applicata alla cosa, o la cosa ha preso quel nome, in forza di una distinzione qualitativa? questa distinzione già vien fuori nel 1838 da una relazione di don Pietro Ulloa, allora procuratore generale a Trapani». Ulloa, fin da allora, parla di «oscure fratellanze», «sette segrete che diconsi partiti», un popolo che «le fiancheggia, magistrati che le proteggono? al centro di tale dissoluzione c'è una capitale col suo lusso e le sue pretensioni feudali in mezzo al secolo XIX». Commenta Sciascia: «Leggeremo mai, negli archivi della commissione parlamentare antimafia, una relazione acuta e spregiudicata come questa di don Pietro Ulloa?». Dubbio, considerazione, che vale non solo per le commissioni parlamentari, ma anche per il tanto che si dice (e si scrive) generalmente di mafia. Non si vuole dire, con questo, che se ne parla (e se ne scrive) troppo; sicuramente però se ne parla (e se ne scrive), spesso a sproposito. Alcuni lo fanno, e lo hanno fatto, con buona, sprovveduta, intenzione (e pazienza, anche se la loro indubbia buona fede comunque un certo danno lo procura); altri si costruiscono una carriera, cementano posizioni di potere, tutelano interessi molto concreti, di "roba" (e come aveva ragione Leonardo Sciascia, in quel suo famoso articolo sul Corriere della Sera redazionalmente titolato "I professionisti dell'antimafia": la quotidiana cronaca ce lo ricorda). Per fortuna c'è anche qualcosa di buono in quello che si scrive e si dice. Più che "buono" (anzi decisamente prezioso, utile nel senso più pieno ed estensivo del termine) è, per esempio, un libro scritto più di cinquant'anni fa: "Questa mafia", scritto da un carabiniere, l'allora comandante dei carabinieri di Agrigento Renato Candida: uno che la mafia, la "Cosa Nostra" la respira, e vive tutti i giorni; e la capisce, la penetra. È un libro "secco", asciutto, un saggio che non è solo un saggio, pagine di un "diario" che però raccolgono anche una formidabile "appendice" costituita da documenti e relazioni? Un libro che attira l'attenzione di un giovane ma già vigile Sciascia, noto (anche a Candida) per aver pubblicato "Le parrocchie di Regalpetra", per il suo lavoro editoriale, per gli articoli scritti con piglio radicale sul milanese Giorno: dove racconta le ancora sconosciute realtà di Misilmeri, Niscemi, Canicattì, Villalba. Magistrale l'intervista con Giuseppe Genco Russo, il capomafia di Mussomeli, pubblicata su Mondo nuovo? Sciascia scrive a proposito di Questa mafia una recensione con toni di entusiasmo; e ne nasce un'amicizia che dura nel tempo. Candida diventa poi il modello di carabiniere a cui Sciascia si ispira per il suo capitano Bellodi, protagonista de "Il giorno della civetta". Pubblicato il libro, Candida ne riceve, qualche tempo dopo, il meritato "ringraziamento": sotto forma di trasferimento, alla scuola allievi ufficiali di Torino. Promosso, e rimosso. Si può dire, con il senno di oggi, che gli sia andata perfino bene. In quegli anni così s'usava, nei confronti di chi troppi piedi pestava, e troppo forte. Col tempo altre, più drastiche e sanguinose misure saranno prese: prima la "chiacchiera"; poi il rimprovero d'essere "chiacchierato". Infine la mortale carica di tritolo o la raffica di kalashnikov. La Cosa Nostra certo ha enormemente mutato i suoi connotati, da quegli anni ormai lontani; è ormai altro, da quello che hanno scritto Candida e Sciascia. Non solo è salita molto a Nord, la mafiosa palma; è diventata una ormai inestricabile foresta; e tanto più insinuante e pericolosa in quanto silenziosa, discreta. Non se ne parla più, non si mostra più. Segno, evidentemente, che non ha più bisogno di parlare, di mostrarsi. Fino a qualche settimana fa per entrare in possesso di una copia di Questa mafia, la cui tiratura da tempo risultava esaurita, bisognava confidare nella pazienza e nel portafoglio: il libro era reperibile nel circuito delle librerie antiquarie e a buon prezzo (per l'antiquario, s'intende); oppure si doveva confidare nel raro colpo di fortuna che può capitare a chi fruga nelle bancarelle dell'usato, dove tra tanta paccottaglia capita di trovare qualche "perla". Ma ora il libro è stato meritoriamente ripubblicato e dunque entrarne in possesso è più facile. Ne abbiamo un documento non di stretta attualità, ma neanche un "solo" documento di storia: è un testo che ci fa conoscere fatti di 'ieri', ma fondamentale per comprendere quelli di "oggi". L'amicizia che lega Candida a Sciascia (e Sciascia a Candida, ovviamente), è ben descritta in un articolo pubblicato, in origine, su La Stampa dell'11 novembre 1988, e poi compreso nella raccolta "A futura memoria" (Bompiani). Scrive, Sciascia: «Ci siamo conosciuti nell'estate del 1956. Io avevo da qualche mese pubblicato "Le parrocchie di Regalpetra". Candida lo aveva letto, mandò a dirmi che desiderava che ci incontrassimo. Ci incontrammo a casa mia, a Racalmuto: un uomo simpatico, aperto, spiritoso. E debbo anche dirlo, e sarà magari perché ne conoscevo pochi: ma era il primo funzionario dello stato veramente antifascista che io avessi incontrato. La sua radice di avversione alla mafia era appunto questa: il suo antifascismo? Diventammo amici. Ci incontravamo spessissimo, almeno due volte per settimana, in paese o nella mia casa di campagna; e ad Agrigento, nel suo ufficio. Stava scrivendo il suo libro sulla mafia. Quando lo ebbe finito, lo portai a Caltanissetta, dall'amico editore Salvatore Sciascia: che subito, senza alcuna esitazione, lo pubblicò. Qualcuno osò poi dire che io, sollecitato dal mio amico Luigi Cortese, capogruppo comunista all'assemblea regionale, avevo chiesto a Candida di tagliare quelle parti del libro che prospettavano collusione tra comunisti e mafiosi: nulla di più falso; e del resto, nel libro, qualche elemento in questo senso si trova. Non erano i comunisti, che preoccupavano Candida in quanto comandante del gruppo carabinieri di Agrigento, ma i democristiani. E tentò, proprio tra i giovani democristiani, di seminare coscienza antimafiosa?». Ecco: direi che questo brano chiarisce bene la qualità dell'amicizia tra lo scrittore e il carabiniere; di che pasta sono fatti l'uno e l'altro. Ma c'è molto altro, in quel bell'articolo di Sciascia, che "descrive" che tipo di carabiniere e di uomo sia stato Candida, di come l'Arma debba essere orgogliosa di averlo avuto tra i suoi "fedeli", e di come, fino a quando in questo paese ci saranno persone come Candida, si possa ancora sperare i qualcosa di buono. Questa mafia è ricca di preziose informazioni, di radicale impegno, impegnato radicalmente, si potrebbe dire; racconta la divisione tra giovani e vecchi mafiosi, il desiderio di affermazione dei primi, la preoccupazione dei secondi di non pregiudicare gli equilibri e le posizioni raggiunte, e il dissidio che inevitabilmente ne nasce e che porta all'altrettanto inevitabile guerra. Sciascia ne scrive su Tempo Presente, la bella rivista di Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte (siamo, giova ricordarlo, nei primi anni Sessanta): «Di una mafia di sinistra (avendo finora i partiti di sinistra monopolizzato i termini della lotta contro la mafia), nessuno prima del Candida aveva parlato; eppure esiste, e in molti centri dell'agrigentino riesce a battere sistematicamente la mafia di centro-destra. Ciò non toglie che l'essenza della mafia risieda in quell'ideale di ordine di cui si è detto. Peraltro, è da notare che la scelta di un partito in Sicilia è determinata da circostanza che niente hanno a che fare con un ideale politico: rivalità di gruppi, di famiglie o semplicemente di individui; gelosie e invidie? Ho davanti agli occhi un opuscolo sulla vita del sindacalista Salvatore Carnevale, indubbiamente liquidato per sentenza della mafia; a un certo punto si legge che col Carnevale le vittime della mafia, sindacalisti ed esponenti della sinistra, sono finora trentotto; e viene il sospetto che si faccia un po' di confusione. Perché bisogna distinguere tra delitti esterni e delitti interni; e se tra questi trentotto non ci siano soppressi per misura interna e per ragioni che non hanno niente a che vedere con la politica. Ma tant'è: un morto serve sempre, nel nostro retorico paese». E ancora: «leggendolo gli è avvenuto di dare "quella definizione della mafia che ha avut un certo corso e che credo resti ancora accettabile: la mafia è un'associazione per delinquere con fini di illecito arricchimento dei propri associati e che si pone come intermediazione parassitaria, e imposta con mezzi di violenza, tra la proprietà e il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato. Definizione che ognuno da questo libro può trarre o su questo libro verificare». Ben si capisce, ora, perché Sciascia nei suoi libri, quando immagina il personaggio di un investigatore, di una persona che cerca la verità, puntualmente ne modella il ritratto di Candida, quello che è stato, è riuscito ad essere. "Questa mafia", di Renato Candida, Salvatore Sciascia editore Pagg. 214, euro 22
Gli italiani? Sono fascisti dentro. Il nuovo libro di Tommaso Cerno in uscita in questi giorni, racconta come la mentalità del Ventennio sia ancora oggi diffusa nella politica, nella società, nella cultura del nostro Paese, scrive Tommaso Cerno il 20 novembre 2015 su “L’Espresso”. Pubblichiamo l’introduzione del libro di Tommaso Cerno, “A noi”, in libreria dal 20 novembre (Rizzoli, pp. 310, € 19). Si dice che un bambino nasca con la camicia, quando viene alla luce avvolto nel sacco amniotico. Quel sacco sembra un abito, cucito addosso durante i nove mesi dentro il ventre di mamma. E noi di chi siamo figli? L’Italia in cui viviamo, l’Italia del nostro Ventennio, quello che chiamiamo l’epoca di Berlusconi e Renzi, è nata con la camicia? Proviamo ad azzardare un’ipotesi: l’Italia è nata con la camicia nera. Proprio così, fasciata nel sacco amniotico del fascismo, da cui cerca a fatica di liberarsi da settant’anni, senza riuscirci davvero. Nel dopoguerra la retorica antifascista può avere dato l’impressione di un taglio netto con i vent’anni precedenti, ma come il “politicamente corretto” non cancella il razzismo, non ridà la vista a un cieco chiamandolo non vedente, l’affermazione di essere antifascista, per quanto eticamente giustificabile, non basta a cancellare ciò che del fascismo è dentro di noi. Dentro di noi perché italiano come noi, forse più di noi. In tutto il corso della sua storia, il fascismo fu senza dubbio un fenomeno rivoluzionario, giovanile, si direbbe oggi “rottamatore”. Mussolini contribuì a ringiovanire l’Italia, a partire dalla sua classe politica, così come consentì per la prima volta nella storia del nostro Paese ai ceti medi di entrare nelle stanze del potere. Questo significa che ebbe un legame con il Paese molto più radicato, profondo, osmotico di quanto si pensi. Un legame possibile solo quando c’è un collante. E questo collante viene proprio dall’essenza dell’italiano, dalle radici del nostro modo di essere, dal nostro rapporto con il potere, da ciò che non muta sulla nostra penisola al di là del regime o del governo, più o meno democratico, che ci capita di eleggere o di contestare. Impegnati come siamo a ripeterci che il fascismo è finito, oppure che si manifesta solo nei simboli esplicitamente esibiti del regime, dentro i partiti dell’ultradestra xenofoba, che alzano le croci celtiche nelle manifestazioni, non ci rendiamo conto di una cosa: quei militanti postfascisti sono riconoscibili prima ancora che espongano il proprio pensiero, mentre il fascismo del Ventennio fu un grande movimento di massa. Se ci ostiniamo a cercare il fascismo lì dove è fin troppo facile trovarlo, non facciamo altro che insistere nel non vedere. E perché lo facciamo? Perché abbiamo paura di ritrovarlo dove non ce lo aspettiamo più, nel nostro modo di essere quotidiano, nei nostri difetti di Paese, nel nostro sistema politico e sociale. Annidato là dove sempre è stato, nell’angolo buio della Repubblica che preferisce puntare i fari altrove, dove sa che fascismo non se ne vedrà. Riflettiamo su un fenomeno mediatico di questi ultimi settant’anni. Ancora oggi se accendiamo il televisore e ci sintonizziamo su un dibattito politico, sentiamo spesso ripetere come un ritornello: «Siete fascisti!». Si ascolta così tante volte, da essere assaliti dalla curiosità di capire perché. Un giorno il fascista in questione è Matteo Renzi, tacciato di metodi spicci da destra e da sinistra, addirittura da una parte del suo stesso partito, il Partito Democratico; il giorno appresso, invece, ci si riferisce a Silvio Berlusconi, accusato di avere addormentato il Paese come un nuovo Duce, di averlo assopito in una sorta di Ventennio che potremmo definire, piuttosto che regime dal volto umano, regime dal mezzobusto umano, trattandosi di un’anestesia televisiva pressoché totale. Questa anestesia, però, ha generato la propaganda di governo, come tutti i regimi democratici e non, ma ha generato anche i suoi anticorpi: l’antiberlusconismo militante. Un terzo giorno l’epiteto di fascista è attribuito alle epurazioni del Movimento 5 Stelle e a Beppe Grillo, accusato di essere l’uomo solo che decide per tutti, quando il tal deputato è espulso dal gruppo parlamentare perché “ribelle” alla linea ufficiale. Fino a Matteo Salvini, il leader leghista dell’era post-bossiana, il quale, abbandonato il divino Po e la sacra ampolla, si fa crescere la barba e si reinventa una specie di marcia su Roma per allargare il consenso, ormai troppo stringato, del suo Nord. La morale è che, almeno a parole, qui siamo tutti fascisti, destra e sinistra, alti e bassi, belli e brutti. Saremo anche il Paese delle generalizzazioni, ma c’è davvero da chiedersi cosa stia capitando a noi italiani. Perché, all’improvviso, ci accusiamo l’un l’altro di fascismo? Perché dopo la fine del regime, dopo l’epopea della Resistenza, dopo sette decenni di democrazia quella parola torna sulle labbra di tutti noi, usata con sufficienza, con disinvoltura? Forse perché il 1945, la data che mette fine ai regimi fascista e nazista in Europa, non è una data che l’Italia abbia davvero digerito. Certo sul piano ufficiale, nei proclami, nelle affermazioni di principio, così come nella retorica di Stato, il fascismo è morto e sepolto, giace sotto strati e strati di antidoto costituzionale, democratico, parlamentare. Eppure, nella vita di tutti i giorni, nel profondo degli italiani, la censura del modus vivendi mussoliniano non corrisponde affatto a una cesura, perché molti atteggiamenti del regime - che già provenivano dal passato - si sono conservati, pur con i naturali ammodernamenti, nel futuro: pensiamo ad esempio all’Italia bigotta e bacchettona che fa e non dice, al maschilismo diffuso in tutte le fasce sociali. Pensiamo alla distanza fra regole scritte e regole davvero applicate. Pensiamo all’usanza politica del dossier, all’insabbiamento dei misteri di Stato, alla corruzione come sistema di governo, all’utilizzo dell’informazione come macchina per controllare l’opinione pubblica prima ancora che per informarla, alle regole non scritte delle gerarchie comuniste del dopoguerra, dove il valore della “fedeltà coniugale” garantiva la scalata ai vertici del Pci (Partito Comunista Italiano) proprio come del Pnf (Partito Nazionale Fascista). Per arrivare, infine, all’uomo forte, al leaderismo craxiano, berlusconiano, renziano, incarnazioni del bisogno primario di un capo. Sono solo coincidenze? No, siamo nati davvero con la camicia nera. C’è un filo conduttore che unisce il fascismo “a noi”, proprio come era il saluto ai tempi del Duce. A noi del fascismo è giunto più di quello che vogliamo ammettere. Un’eredità che arriva dritta nell’epoca di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Un’eredità che non si manifesta nell’esibizione di simboli e bandiere, ma nei piccoli gesti, nei modi di pensare, nelle abitudini malate del nostro Paese che non mutano con i governi. Abitudini che ritroviamo nel fascismo di Benito Mussolini, nei risvolti del regime e del carattere del Duce che facevano del fascismo e del suo capo, prima ancora che una dittatura e un dittatore, un modello d’Italia e di italiano, simili nei difetti al popolo. Difetti che non sono scomparsi, sono solo mutati di sembianza. E che ritroviamo ancora oggi. Se sappiamo dove andare a cercarli.
L'ITALIA ANTIFASCISTA.
"Quel cane è fascista, non lo vogliamo". Filippo Facci, la verità sul segugio camerata l’8 novembre 2016 su “Libero Quotidiano”. Il primo tempo è ambientato nel consiglio comunale di Albenga. È la sera di giovedì 3 novembre e maggioranza e opposizione stanno discutendo di sicurezza. Si sapeva che il comando dei vigili stava per comprare un cane antidroga (ufficialmente: stava per istituire un’unità cinofila) perché quello dello spaccio è un problema molto sentito e la criminalità locale è molto cresciuta, ma qualcosa nell' acquisto del cane è andato storto e il centrodestra vuole capire perché. «Il sindaco vuole solo cani del Pd, e, se possibile, per il sì al referendum» tuonano i consiglieri di Forza Italia e Lega Nord. Pausa di stordimento. Poi riattaccano: «Risulta che al comando dei vigili, in cui si erano iniziate le prime trattative, sia stato suggerito l’allevamento "Decima Mas" visti i prezzi più convenienti, ma che poi sia intervenuta la Cgil per proibire l’acquisto di cani fascisti». Rumore in sala. A parlare è Eraldo Ciangherotti, consigliere di Forza Italia che per qualche ragione ha in mano una foto del Duce e quella di un pastore tedesco. Un membro della maggioranza, bevendo un caffè al bar, gli ha raccontato questa strana storia. E il dibattito, in aula, si scalda. La maggioranza dapprima ci gira intorno alla democristiana: «La politica sulla sicurezza di questa amministrazione», taglia corto l’assessore Manlio Boscaglia, «è basata sul riportare i vigili in strada e sul potenziamento della videosorveglianza»; «attualmente le nostre risorse», precisa il sindaco piddino Giorgio Cangiano, «non ci permettono di investire per acquistare un cane». I consiglieri si guardano in faccia. «Non neghiamo il problema dello spaccio e della microcriminalità», conclude il sindaco, «ma le iniziative intraprese al momento non contemplano questa possibilità». Non hanno i soldi per il cane. Albenga ha un bilancio di 41 milioni di euro e il cane ne costerebbe 800, dopodiché, tra addestramento e mantenimento, si arriverebbe a 7mila. Ci credono tutti. Il dibattito esplode. L'opposizione: «Avete appena speso 35 mila euro per comprare un secondo autovelox per fare cassa, ma l’amministrazione del Pd non vuole tirare fuori i soldi per il cane». Tra l’altro risulta che la delibera per comprarlo stesse per arrivare in giunta, ma poi dev’essere successo qualcosa. Si mormora di un veto non solo della Cgil, ma anche del cugino piddino del sindaco. Boh. Ed è proprio il sindaco il primo a cedere: «Il motivo principale per cui abbiamo deciso di respingere la proposta è che prevede dei costi per noi eccessivi... poi, certo, il nome dell’allevamento da cui proviene, "Decima Mas", ha un ruolo nella nostra scelta». Decima Mas. È il nome del corpo d' armata della Repubblica Sociale (dove militò anche Dario Fo con Valter Chiari, Enrico Maria Salerno e Giorgio Albertazzi), ma anche il nome dell’allevamento che aveva fatto l’offerta più conveniente e, pare, qualificata. «È una questione di rispetto per la storia di Albenga», aggiunge il sindaco, «perché se dovessimo prendere un cane antidroga lo faremmo da un altro allevamento, non da uno che porta il nome della milizia anti-partigiana». Fine primo tempo. Lo scrivente approfitta per ricordare che nel giornalismo, quando una storia c' è, non serve sprecare avverbi e aggettivi. Secondo tempo, dove intervengono anche l’Associazione partigiani e Forza Nuova. È il 5 novembre quando la sezione locale dell’Anpi (l’associazione partigiani, appunto) scende dall' iperspazio e interviene con solennità: «Condanniamo fermamente la leggerezza con cui un rappresentante delle istituzioni si permette di trattare il periodo del fascio. È vergognoso che in consiglio comunale si mostri una foto del duce». Ah, il problema è la foto. Il presidente dell’Anpi di Albenga, Claude Acasto, ce l’ha con Eraldo Ciangherotti (Forza Italia, odontoiatra, cattolicone) per quell' immagine portata in aula. «Chiediamo che tutte le istituzioni», insiste l’Anpi, «intervengano per stigmatizzare questa stupidata. Albenga è conosciuta come una delle città che ha dato il contributo più alto alla causa della Resistenza, l’antifascismo è un valore fondante della nostra città che non può essere sbeffeggiato e calpestato per argomenti così futili come l’acquisto di un cane». Eh, appunto. «Su questo avevamo già espresso i nostri più che legittimi dubbi», insiste tuttavia l’associazione, «non solo per la spesa, ma anche per il richiamo al canile di Ancona della Decima Mas». Manca nessuno? Sì: l’Anpi di Ceriale (5000 abitanti al confine con Albenga) fa sapere che «concorda appieno con le considerazioni dell’Anpi di Albenga». Ce lo segniamo. E, sull' allevamento, aggiunge che «il canile (sic) ha raggiunto una certa notorietà ostentando simboli chiaramente nostalgici-fascisti». Parentesi: l’allevamento "Decima Mas" (senza X) non sta proprio ad Ancona ma ad Agugliano (Marche) e non è la cuccia di un nostalgico che ha il busto del duce in tinello, ma un allevamento qualificato e conosciuto in tutto il mondo che ha fornito cani alle forze dell’ordine statunitensi, per dire; probabilmente avete visto i loro cani in qualche video sulle ricerche dei superstiti del terremoto. Sono pastori tedeschi hanno passato gli esami della Protezione Civile e che hanno vinto tutti i concorsi e campionati possibili, ma chissà, forse sono cani fascisti. Forse l’Anpi preferirebbe un pastore bergamasco (nel senso di cane) col barilozzo di cordiale. Dimenticavamo il fondamentale intervento di Forza Nuova, che dice cose sensate e perà è Forza Nuova: «Prendiamo atto che il sindaco rifiuta di contrastare il mercato della droga utilizzando tutti gli strumenti che potrebbe avere a disposizione, negando l' arrivo di un esperto cane antidroga per una stupida pregiudiziale antifascista... gli ricordiamo che gli Eroi della Decima Flottiglia Mas si resero protagonisti di azioni talmente ardite da meritarsi medaglie d' oro al valore militare e, soprattutto, il rispetto del nemico». Bene. Hanno parlato tutti? Quasi: «Bau», ha infine dichiarato una fonte che ha preferito mantenere l’anonimato. Titoli di coda. Del cane. Filippo Facci
MALEDETTO 25 APRILE.
25 aprile tra divisioni e polemiche tra Roma e Milano. Mattarella: “Ricordiamo senza odio né rancore, grati alla Brigata ebraica”. Nella capitale doppio corteo, uno dell’Anpi e l’altro della Brigata ebraica (contraria alla presenza di organizzazioni palestinesi alla sfilata dei partigiani) che ha ribadito: «La storia è qui, il resto sono menzogne», scrive il 25/04/2017 “La Stampa”. Settantadue anni fa hanno combattuto fianco a fianco per liberare l’Italia dal nazifascismo. Oggi si è celebrata quella ricorrenza, una festa di Liberazione sì ma anche di divisione. Così è successo a Roma, dove questo 25 Aprile ha avuto due piazze, una dell’Anpi e una della Comunità ebraica, contraria alla presenza delle organizzazioni palestinesi alla sfilata dei partigiani. A Milano ha prevalso l’unità, non senza qualche contestazione arrivata all’indirizzo della Brigata ebraica da parte dei movimenti anti Israele. Una Milano che il sindaco Beppe Sala ha salutato come «centro di un grande progetto per la pacificazione».
A Roma le celebrazioni si sono aperte con il ricordo istituzionale al Vittoriano: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Ma nella Capitale la divisione ha pesato: Anpi da una parte e Brigata ebraica dall’altra, come preannunciato, nonostante gli appelli all’unità. L’ultimo, oggi a Porta San Paolo, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: «Mi auguro che da oggi parta una riflessione per ricomporre tutte le componenti che lottarono per ridarci questa libertà». A via Balbo il vicepresidente della Comunità ebraica romana Ruben Della Rocca ha tagliato corto: «La storia è qui, il resto sono solo menzogne». Il rabbino capo Riccardo Di Segni ha aggiunto: «Il terrorismo che in questi anni sta devastando l’Europa ha avuto una scuola importante e noi sappiamo qual è», e a margine ha spiegato: «Alludevo ai palestinesi». Ma si è anche augurato che «il prossimo anno si torni in piazza insieme». Il valore della memoria «affinché la storia di un passato così buio non torni più» è stato l’auspicio della sindaca Virginia Raggi, che ha partecipato ad entrambi i cortei «con la stessa passione»: «Il 25 Aprile è una festa di tutta l’Italia». Ed è spettato al presidente Anpi Roma Fabrizio De Santis parlare della sua come di una «piazza unitaria e senza polemiche».
Corteo unitario a Milano dunque, e divieto di sfilare nella zona del cimitero dove sono sepolti i repubblichini per l’estrema destra. Dal palco di Piazza Duomo il presidente nazionale dell’Anpi Carlo Smuraglia ha salutato così i manifestanti: «Eccolo qui il nostro 25 aprile, decine di migliaia di persone in piazza per una festa», ma ha anche ammonito chi «coglie l’occasione per fare provocazioni sciocche e inutili» e «le strumentalizzazioni fatte da chi ritiene l’Anpi inutile perché i partigiani sono sempre di meno: sciocchezze». Il sindaco Sala ha parlato della sua città come «libera, aperta e accogliente»; presenti anche i segretari confederali di Cgil e Uil.
A Genova sempre Smuraglia ha ricordato a piazza Matteotti che «ci sono ancora troppi fascisti in giro, non importa se con la camicia nera o fascisti dentro. Quanto ci vuole perché lo Stato faccia il suo dovere?». Nel Cosentino vandali hanno danneggiato l’ingresso del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, mentre ad Ascoli Piceno sono state ricordate anche le vittime del terremoto. E ha assunto anche toni contro il razzismo il corteo di Benevento al quale ha partecipato un nutrito gruppo di migranti. A Cagliari un gruppo di donne ha sfilato portando a piedi la bicicletta in ricordo delle partigiane che durante il conflitto davano una mano, spesso come staffette, alla lotta.
A Torino, al cimitero Monumentale, c’è stato l’omaggio ai caduti con corteo e deposizione delle corone di fiori ai cippi. Ieri sera a Cuneo si è tenuta una fiaccolata in memoria di Giulio Regeni. A Firenze in piazza Unità Italiana è stata deposta la corona di alloro alla base al Monumento ai Caduti di tutte le guerre alla presenza delle autorità. Partigiani, sindacati e sinistra antagonista hanno sfilato insieme. A Napoli cerimonia al Mausoleo di Posillipo e in piazza Carità davanti al monumento a Salvo D’Acquisto. A Bari deposizione delle corone di alloro al sacrario dei caduti d’Oltremare alla presenza delle autorità. A Palermo deposta in mattinata la corona di fiori presso il cippo del Giardino Inglese.
Il 25 aprile non c'è più nulla da festeggiare, scrive il 26 Aprile 2017 Vittorio Feltri su "Libero Quotidiano". Dopo 72 anni siamo ancora qui a festeggiare il 25 aprile e a fingere di lottare contro il nazifascismo inesistente. Mi fanno pena quelli che vanno in giro, di qua e di là, a sfilare come se la liberazione fosse avvenuta ieri. Sono quattro gatti esaltati e patetici. Pochi hanno memoria di ciò che accadde alla metà degli anni quaranta e quei pochi lo ricordano per sentito dire. I partigiani erano una sparuta minoranza di italiani ininfluenti ai fini bellici e sono morti quasi tutti per ovvi motivi di età. I sopravvissuti alla dura legge dell’anagrafe, mosche rosse, hanno come minimo 90 anni e non sono in grado di andare in piazza, è già tanto se si reggono in piedi. Le tristi manifestazioni organizzate ieri sono state alimentate dalla più vieta retorica, che può avere emozionato solo qualche nostalgico delle squallide bandiere vermiglie. Spettacoli di una mestizia struggente. La Resistenza ormai va archiviata per quello che fu: un movimento elitario o, meglio, trascurabile in un Paese fino all’ultimo ad alta densità di fascisti. Ovvio, quando poi il baraccone di Benito Mussolini è crollato sotto i bombardamenti degli alleati e le masse hanno constatato (...) (...) che il conflitto era straperso, mentre i tedeschi si incattivivano con la collaborazione dei repubblichini sui partigiani, il vento è cambiato e le simpatie nei confronti del duce si sono trasformate in odio. Resta il fatto che il descritto mutamento è avvenuto nei tempi supplementari concessi al regime azzoppato il 25 luglio 1943 quando il re spedì il capo in camicia nera sul Gran Sasso. Farla tanto lunga col presunto eroismo di quelli all’epoca definiti ribelli, molti dei quali sbandati (incerti se stare coi fasci o coi comunisti, figli della stessa mignotta) serve soltanto a illudersi che gli italiani, subìto per oltre venti anni il giogo sulle spalle, si siano sollevati contro l’oppressore. Diciamola tutta e senza ipocrisia: non fossero arrivati in nostro soccorso gli angloamericani noi saremmo ancora a piazza Venezia irrigiditi nel saluto romano e inneggianti al dittatore, vendutosi a Hitler per un sacco di lenticchie in cambio di orrende leggi razziali e di una alleanza bellica sciagurata. Nella fase terminale della battaglia in Italia non si sono registrati episodi eroici degni di commemorazione. I nostri nonni si sono semplicemente lasciati andare, causa rancori mai sopiti, a una sanguinosa guerra civile ovvero uno squallido regolamento di conti. Risse e vendette che non è il caso di ammantare di gloria. Quanto all’Anpi, Associazione nazionale partigiani italiani, i cui iscritti sono degli zombie, teniamola pure in vita, ma smettiamo almeno di finanziarla con denaro pubblico. Rappresenta soltanto la propria inutilità.
25 Aprile, giorno del rancore, scrive il 25 aprile 2017 Luigi Iannone su "Libero Quotidiano". Il 25 Aprile è la festa più tediosa e incomprensibile dell’anno. E non lo dico per repulsioni tardo nostalgiche o per fatto estetico e avversione visiva a drappi rossi o similari ma perché è una ricorrenza che si dice ‘democratica’ ma discrimina più persone di quante non ne facciano tutte le altre feste comandate messe insieme. Niente di più che un raduno di vincitori che non hanno mai avuto e, tuttora, non hanno umana pietà per i vinti. In Spagna questa vicenda la superarono subito con la Valle de los Caídos. Un solo cimitero affinché fratelli combattenti su fronti opposti potessero riposare tutti, per sempre e in pace. Da noi, no! L’odio resiste imperituro e si alimenta non raramente su una Storia scritta male e commentata e spiegata ancora peggio. Più che festa trattasi di apologia della contrapposizione perpetua che coinvolge tutti, anche le nuove generazioni. Siamo al caos generalizzato sul fronte della corretta interpretazione storiografica ma all’inquadramento e al rigido manicheismo su quello organizzativo: e così ci ritroviamo partigiani che non vogliono la destra di qualunque forma o colore, ebrei che detestano i palestinesi che vorrebbero sfilare nello stesso corteo, progressisti che disprezzano i barbari leghisti, i trinariciuti che allontanano quelli di Forza Italia perché a lungo alleati dei post-fascisti di Alleanza nazionale, e potremmo continuare per decine e decine di righe. Una penosa vicenda che non conosce sosta ed è ancora più paradossale se si pensa che, con tutte le evoluzioni e involuzioni del caso, va avanti dalla fine della Seconda guerra mondiale. In ogni altro luogo della Terra chi si fregia della patente di democraticità e la celebra in una festa nazionale tende sempre ad accogliere e non a separare. Qui da noi è come una festa di famiglia trasformatosi in serata per Vip dove si fa selezione all’ingresso e si impedisce ai cugini, ai fratelli, ai figli, alle madri di prender parte. Non che vi siano fiumane di persone che bramino per entrare in questa annuale orgia del risentimento collettivo, tuttavia la boriosa selezione risulta stantia. È dunque una festa partita male e continuata peggio, qualificatasi per la peculiarità tutta italiana di quelle variegate colorazioni di rosso che imperversano per le strade e saturano di falsità i nostri libri scolastici (chi ricorda, per esempio, che i civili morti sotto i bombardamenti degli Alleati furono in numero maggiore rispetto alle pur deprecabili stragi naziste?); per una bandiera che simboleggia solo da noi, con una inconsueta potenza espressiva, democrazia e libertà mentre in giro per il mondo se ne guardano bene dal tirarla fuori ad ogni piè sospinto. E poi slogan triti e ritriti e linciaggio morale e politico per chiunque osi dissentire di una virgola rispetto al Verbo resistenziale. E non parlo solo di nostalgici e similari ma anche e soprattutto di coloro i quali hanno pure tentato in tutti questi anni di dare un senso al 25 aprile decrittando deficit e sconcezze, falsità storiografiche e reticenze; tentando in pratica di mettere sul piedistallo un minimo di verità condivisa senza far prevalere gli odi di parte o la difesa di una casacca. Qualcuno, per esempio, ricorda mai che il comunismo in tempo di pace ha mietuto più vittime che il nazismo in tempo di guerra? Lo si può fare? È permesso farlo? Invece, non c’è nulla da fare. C’è così tanta retorica in questa festa astiosa e divisiva, nutrimento quotidiano per gli istigatori di odio, che anche solo replicare alle solite nenie diventa atto para-terroristico e passibile di apologia di fascismo. Perché di questo si tratta. Si ostenta una vittoria militare ma allo stesso tempo una superiorità morale, e si nega con inaudita virulenza verbale e fisica la pietà per i morti dell’altra parte e gli sconfitti. E se per le prime due questioni possiamo intenderne le motivazioni primariamente culturali e politiche in un Paese come il nostro dove c’è necessità costante di un nemico, facciamo invece fatica a comprendere il disprezzo umano e il rancore verso combattenti passati a miglior vita oramai settanta anni fa. Molti di costoro, se non la quasi totalità, lottarono per una idea di Patria che oggi farebbe sorridere le giovani generazioni; ma per quello combatterono e non per altro. E molti di quelli che un attimo dopo la caduta di Mussolini si atteggiarono a strenui paladini dell’antifascismo, avevano passato la giovinezza cantando inni ultra-nazionalistici, concedendosi saluti romani a profusione e ascoltando ‘’il capoccione’’ parlare da Palazzo Venezia. Ma anche questa è cosa nota! E siccome la patria e la bandiera fino a qualche anno fa suscitavano l’orticaria a quasi tutti i rappresentanti del mondo cultural-politico-accademico come diretta conseguenza vi era il fatto che coloro i quali combatterono con in testa l’idea di una Patria da difendere fossero considerati degli illusi e degli sconsiderati. Ma queste convinzioni sono state tanto estese e vorticose che il 25 Aprile riesce comunque a oscurare ogni altra festa nazionale. Vi sono stati periodi anche recenti della nostra storia in cui sembrava dovesse fermarsi anche il battito cardiaco di ogni singolo italiano per permettere alle fanfare di ogni paesello di suonare con inaudita potenza Bella ciao. Gli anni dei governi Berlusconi li ricordiamo tutti; sembrava che un’orda di selvaggi in camicia nera si fosse impossessata del Paese e gli echi della lotta partigiana dovevano perciò ridestarsi con rinnovato ascendente su giovani e meno giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, alimentati da una grancassa massmediatica sempre prona. Eppure il 25 Aprile segna con un marchio di sangue una ‘guerra civile’. Una lotta armata fratricida dove fatti cruenti e indegni hanno coperto pagine di eroismi e coraggio. Morti innocenti perché dalla parte sbagliata; giustizia sommaria e violenza su donne inermi, colpevoli di aver condiviso brandelli di vita con un fascista e su anziani rei di aver mantenuto fede ad una idea. La Storia farà il suo corso ma in Italia è un scorrere lentissimo, sfiancante. L’antifascismo è infatti sin da subito divenuto religione laica inattaccabile, ma soprattutto strumento per carriere politiche, nelle università e nelle redazioni di giornali. Ecco perché non raramente si alimenta un fascismo virtuale proprio per mantenere in vita il carrozzone dell’antifascismo reale; antifascismo che per anni è stato predicato da coloro i quali esaltavano i carri armati a Budapest, attendevano l’arrivo di ‘Baffone’ o dipingevano il Maresciallo Tito come un buontempone. Gli stessi che ora sono talmente ideologizzati da essere antifascisti senza fascismo e magari erano usi al saluto romano e poi, in fretta e furia, in quella notte del 24 aprile, smisero la camicia nera per indossare quella rossa. Perché ciò che accadde da quella notte in poi è chiaro a tutti. I vecchi camerati divennero i nuovi compagni che, però, da più di mezzo secolo sono inseguiti dai loro fantasmi e scorgono il fascismo dappertutto. Eppure il fascismo è morto. È finito con Mussolini, e non vi potrà essere alcuna riedizione senza il ‘titolare’. Ma se il fascismo è morto e sepolto, l’Italia resiste ed esiste da tempo immemore. Ecco perché è utile ricordare almeno questo ai tanti soloni della democrazia repubblicana: l’Italia non nacque sulle colline insieme ai partigiani ma esisteva da qualche migliaio di anni. Se ne facciano una ragione.
Maledetto 25 aprile, scrive Nini Spirlì Lunedì 24 aprile 2017 su "Il Giornale". Può esserlo, maledetto, un giorno? Se chiudo gli occhi davanti al calendario e lo vivo come dono del Cielo, di Dio, no. Ogni alba è una carezza del Creatore, una possibilità in più di essere Umano e Divino insieme. E anche un qualsiasi 25 aprile è un regalo della Vita. Ma se, invece, ripongo la Corona del Rosario, tengo la mia Bibbia nella sua custodia di cuoio, cerco di dimenticare lo Scapolare che indosso h24 e la missione che dolcemente mi impone, e apro la porta a questa orrenda e incancrenita celebrazione politica e parziale, allora, sì! Questa giornata è maledetta dalle urla di migliaia di famiglie, colpevoli e innocenti, che chiedono giustizia e vendetta. Che odiano ancora perché sanno o perché non sanno. Che si tramandano livore e inimicizia a prescindere. Che meriterebbero, invece, salvifici silenzi. Oblio, piuttosto che ipocrite fanfare e reboanti proclami. Il fascismo è finito. O, forse no. E, se vive, è per “colpa” dei tanti “antifascisti”, che, da oltre settant’anni, si risvegliano ciclicamente per lucidare le aureole e affilare gli artigli. Se il fascismo “morisse”, a loro rimarrebbe ben poca visibilità e notorietà. E, dunque, è bene tenerlo in vita e garantirsi uno spicchio di telecamera. E il 25 aprile, per molti, è una sorta di Natale, di ferragosto, di Domenica di Pasqua. Un appuntamento solenne con la storia; quella che hanno scritto i vincitori, chiaramente. A prescindere da come abbiano potuto vincere. Combattendo o patteggiando, per esempio. Forse, più patteggiando che combattendo. Ma senza voler polemizzare, una cosa resta evidente. Gli animi, anche dopo lo scoccare del secolo e del millennio, non sono sereni. I cuori non conoscono pace. Le menti non hanno trovato la via. La liberazione da cotanto doloroso ricordo non è avvenuta. E la guerra civile continua. Anche nel ventre delle famiglie che, di quella guerra, non solo non ne hanno sentito le mitraglie, ma non ne possono serbare ricordo, perché nate tempo dopo. Molto tempo dopo. Maledetto 25 aprile di divisioni e malanimi. Veri e presunti.
Ma quale festa della liberazione? Oggi siamo più oppressi di prima, scrive il 24 aprile 2017 Andrea Pasini su "Il Giornale". “Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire”. Da questo spunto, arrivatomi da George Orwell, mi introduco nel mondo dell’ipocrisia targata 25 aprile. Un sentimento che non si sviluppa soltanto nelle ventiquattro ore dedicate alla Liberazione, ma che permane nella mentalità della sinistra italiana. “È sempre tempo di Resistenza” ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso anno durante i festeggiamenti. “Una festa di speranza ancor di più per i giovani”, l’ha definita invece nel 2015. Speranze di un futuro diverso. Ma quale futuro può nascere con il sostegno inesistente di questa classe politica. Un futuro in cui manca il rispetto per la propria nazione? In cui si canta Bella Ciao ignorando quanti morti, da un fronte all’altro, la storia ci ha portato in dono. Ricordo ancora una frase, di dodici mesi fa, pronunciata dalla più alta carica del nostro Paese: “Battersi per un mondo migliore è possibile e giusto”. Per questo motivo vi dico che serve una nuova giornata della Liberazione. I cittadini italiani si trovano nuovamente ed infinitamente vessati. Serve una nuova Liberazione, ma dall’attuale classe politica. Classe politica egoista ed arrivista capace di riempirci le orecchie con i suoi discorsi composti da bei virtuosismi. Parole che evocano la libertà, la giustizia, l’onestà, ma che nascondo l’orgoglio lugubre di un passato nefasto, lasciando aperto uno spiraglio in direzione del comunismo. Vergognoso. Una bassezza culturale figlia della falsità, incapace di concepire dei limiti. Serve un nuovo 25 aprile, una giornata per celebrare la riconquista della dignità dell’Italia. Una giornata non sia tinta di rosso o marchiata da una falce ed un martello, ma che abbia come punti di riferimento l’abbattimento delle tasse, la distruzione della pachidermica burocrazia e ridoni fiducia ad un popolo sull’orlo del suicidio. Una Liberazione da un governo ingiusto capace solamente di spendere i soldi da noi guadagnati con estremo sacrificio. Danaro, regalato, per mantenere i clandestini, che arrivano in numero sempre maggiore sulle nostre coste. Una Liberazione dalle istituzioni che mantengo i rom tutelandoli ben più degli italiani. Permettendogli di non lavorare, di non pagare le imposte e di usufruire di tutti i servizi per i quali paghiamo uno sproposito. Una Liberazione da un sistema vessatorio a dir poco criminale. Sistema che ci obbliga a pagare senza darci nulla in cambio. Una Liberazione da una politica anti-tricolore che vede i nostri connazionali costretti a vivere nelle automobili o sotto i ponti, mentre ai clandestini viene concessa la possibilità di alloggiare in alberghi. Abbiamo il dovere di batterci per una nazione in cui le istituzioni non siano nemiche delle imprese. Uno Stato volenteroso di aiutare i suoi cittadini a trovare un lavoro, mantenerlo e costruirsi un percorso. Uno Stato che metta gli italiani al primo posto e chiunque purché non sia nato da Bolzano a Palermo. Quale Liberazione può essere festeggiata sapendo che ogni giorno aumenta la povertà nelle famiglie italiane? Partiti di destra, di sinistra e movimenti vari hanno tradito il proprio popolo. Ci fanno credere che la libertà sia nostra, ora e per sempre, dopo essere stata “conquistata” il 25 aprile 1945. Ci tradiscono parlando di speranza, ma il domani racconta di teste chinate e sguardi persi. Sventolano le loro bandiere, mentre un’altra serranda viene abbassata senza che nessuno dica niente. La sovranità e la dignità ci spettano di diritto, questo dobbiamo rivendicare il 25 aprile. Gridandolo forte, con tutto il fiato che abbiamo in gola. È ora di ricordalo a questi politici. È ora di ricordarlo a noi stessi. Serve una rivoluzione per combattere tutto questo schifo che giorno dopo giorno ci sta distruggendo. La nostra storia è in pericolo, le nostre radici e la nostra dignità vanno al macero. Tutto questo ha un unico mandante ed esecutore il sistema politico-finanziario, le lobby che vogliono renderci schiavi, che vogliono portarci via tutto quello che siamo stati in grado di costruire nel tempo. Il lavoro dei nonni, dei padri, degli avi bruciato nel nulla. Noi dobbiamo lottare, non celebrare una festa che non esiste. Quale Liberazione? Quale libertà? Oggi siamo più oppressi e schiavi di prima, ce ne vogliamo rendere conto o no? Vogliamo riprenderci, con coraggio senza avere paura, la nostra vita e la nostra rispettabilità? Perché adesso il problema incombe sulle nostre teste, ma domani a pensarci saranno le nuove generazioni, nonché i nostri figli. Vogliamo costringerli a vivere un’esistenza da vittime? Io no, non ci penso neanche lontanamente. E voglio combattere per riconquistare la vera libertà.
"La Resistenza è solo un falso mito. La retorica della Liberazione è finita". Parla Arrigo Petacco, giornalista, storico e scrittore. "Sono state dette molte balle". Intervista del 24 Aprile 2016 su “Il Tempo”.
«Il 25 aprile, finché c’è stato il Partito comunista italiano, è stato molto festeggiato. Adesso assai meno perché sulla Liberazione e sulla Resistenza ci hanno costruito sopra un sacco di castelli di carta». A parlare, in questa intervista a Il Tempo è Arrigo Petacco, giornalista, storico, scrittore, autore anni fa della celebre intervista ad Indro Montanelli in cui il giornalista toscano parlò della guerra in Abissinia cui aveva partecipato, dicendo che «era come il West per gli americani: la nuova frontiera, un paese nuovo dove costruirci un’esistenza diversa. Andammo laggiù pure per sfuggire alle liturgie del regime. Ma anche lì arrivarono i gerarchi tronfi e buffoni. Fu il trionfo delle bischerate di Starace. Ci sentimmo traditi».
Petacco, quali sarebbero i castelli di carta?
«Diciamolo chiaramente, se non ci fossero stati gli americani la Resistenza non ci sarebbe mai stata. Si tratta di una retorica enorme e anche di qualche balla. All’epoca al Pci della patria non gliene fregava niente e il gruppo storico dei comunisti "inventò" il mito della Resistenza affinché sembrasse una lotta di popolo».
Non starà esagerando?
«L’hanno fatta in ottantamila partigiani che, poi, non erano neppure comunisti. Io sono stato un partigiano quando avevo 16 anni. Pochi anni dopo la guerra scrissi un libro, senza mitologia, "I ragazzi del 44", la storia di un partigiano un po’ per caso alle prese con problemi più grandi di lui, che mi venne rifiutato. Trenta e passa anni dopo, quando ero divenuto famoso per altre cose, me lo pubblicarono. Mi viene in mente il mito dei garibaldini dopo l’Unità d’Italia».
Che c’entrano i garibaldini con il 25 aprile?
«Ai tempi dell’Unità nazionale i garibaldini erano degli eroi del momento poi, col passare del tempo ne rimase solo uno, ma tutti si dicevano garibaldini. Oggi i partigiani che hanno fatto la Resistenza son tutti morti. O quasi. Ma sul mito della Resistenza, come sull’essere stati partecipi alla spedizione dei Mille ai tempi di Garibaldi, sono state costruite carriere, anche da chi non c’era affatto. Molte persone, io li definisco i partigiani del giorno dopo, ne han fatto una professione, magari con un bel fazzoletto rosso al collo».
Se come lei sostiene la Resistenza è stata un falso mito, perché gli italiani ci credono da così tanto tempo?
«Ci han creduto perché gli italiani son fatti così, come hanno fatto a credere per 20 anni a Benito Mussolini?».
Vuol dire che al popolo italiano piace salire sul carro del vincitore?
«Dopo il Risorgimento i famosi Mille di Garibaldi erano diventati 25mila. È normale salire sul carro del vincitore, lo fanno anche negli altri paesi, solo che in Italia lo facciamo con più entusiasmo».
C’è un libro che avrebbe voluto scrivere e non ha scritto?
«Sulla Resistenza "Il sangue dei vinti", l’ha scritto il giornalista Giampaolo Pansa, sulle esecuzioni e i crimini dei partigiani, un libro che ha avuto successo perché scritto da un giornalista che era visto come un uomo di sinistra».
Che intende dire?
«Che quelle critiche così feroci sulla Resistenza scritte da uno non di sinistra sarebbe state considerate una lesa maestà. Adesso le racconto una confidenza: negli anni Settanta, un editor della Mondadori, mi disse che era arrivato il tempo di scrivere un libro contro la Resistenza, ma io non ho mai avuto il coraggio di scriverlo. Pansa ha scritto la verità, verità che alcuni fascisti avevano già scritto prima di lui ma nessuno ci credeva, penso ad esempio a un fascista come Giorgio Pisanò. Non gli hanno creduto perché era ancora un fascista convinto e lo accusavano di essere un diffamatore».
Sul fascismo ha scritto diversi libri revisionisti. Lo rifarebbe?
«Io ho rotto un tabù, a sinistra mi hanno definito un revisionista, ma io me ne vanto».
Tempo fa sul Blog di Beppe Grillo ha sostenuto che Mussolini non fece uccidere Giacomo Matteotti. Ne è sicuro?
«Mussolini non aveva nulla a che fare con l’omicidio Matteotti, che fu ucciso dai fascisti che volevano impedire a Mussolini di fare un governo coi socialisti. Tenga presente che eravamo nel 1924, prima della svolta autoritaria. Mussolini ripeteva che gli avevano gettato il cadavere di Matteotti tra i piedi. Uno storico serio ha il dovere di spiegare che Mussolini non aveva nessun vantaggio dall’assassinio di Matteotti».
Una previsione: domani per il 25 aprile si riempiranno le piazze?
«In piazza andranno in pochi, la retorica della Liberazione e della Resistenza è finita».
Indro Montanelli: Da una guerra nasce la Repubblica. "La guerra perduta ha cambiato i destini d’Italia. Dal disastro militare fu travolto il fascismo, tra le macerie dell’8 settembre nacque la Resistenza, gli errori e le colpe della monarchia che aveva avallato l’intervento a fianco della Germania nazista portarono alla Repubblica. Sulla restaurata democrazia italiana pesa quest’ombra tragica: d’essere stata figlia della disfatta, e tenuta a battesimo dai vincitori. Circostanze che, sia chiaro, non vanificano i valori della democrazia, e nemmeno quelli della Resistenza, che fu un fenomeno politicamente e moralmente importante; con molte migliaia di morti e molti eroi: ma che fanno dubitare della ragionevolezza — e dell’opportunità — d’un certo trionfalismo ritualistico al quale siamo stati assoggettati. I discorsi enfatici che accompagnano le commemorazioni del 25 aprile 1945 rischiano di suscitare più disagio che consenso. Il 25 aprile segnò l’epilogo di una tragedia nazionale. I Paesi seri non sono usi a festeggiare le sconfitte, e non pretendono di barare con la storia: e la storia colloca l’Italia — beninteso, l’Italia di Mussolini — tra le nazioni che combatterono e persero la Seconda Guerra Mondiale. Poi, dal profondo buio morale del «tutti a casa!» scaturirono fiamme di riscossa, venne la guerra partigiana. Che nacque e si sviluppò perché l’Italia si era arresa, e i Tedeschi ne avevano occupato due terzi, e pretendevano di chiamare alle armi — tramite il vassallo di Salò — dei giovani che non ne volevano sapere. E non ne volevano sapere soprattutto perché la Germania era spacciata. Ho la convinzione che molti Italiani preferirebbero ricordare il 25 aprile con il silenzio, e con un omaggio di fiori ai morti. Nient’altro. Senza voler annoverare tra i fasti militari della storia patria le rese, attorno appunto al 25 aprile, di unità tedesche le quali non chiedevano, da giorni, altro che di arrendersi — e non riuscivano a farlo solo perché v’erano difficoltà tra gli Angloamericani e i Sovietici — e senza mitizzare quell’insurrezione generale dell’Alta Italia che fu un gesto politico — come tale probabilmente giusto — ma che fu scatenata contro il vuoto: Tedeschi e fascisti erano allo sbando, non c’era più nulla contro cui insorgere. Non si tratta di dissacrare. Ciò che di alto e nobile vi fu nella Resistenza resterà per sempre. Si tratta di resistere alle tentazioni della retorica resistenziale. La guerra perduta fu una guerra fascista, da ogni punto di vista. Mussolini decise di precipitarvisi, mentre la Germania hitleriana assestava colpi mortali all’Esercito francese, per non essere escluso dalla divisione del bottino. Lo fece per iniziativa personale, ignorando i sentimenti degli Italiani, e dando per scontata la vittoria tedesca. Entrò nel conflitto portandovi le Forze Armate che il regime ‘guerriero’ aveva forgiato, prescrivendo che ogni ragazzetto dovesse dormire con la testa sullo zaino e il moschetto in mano. Quelle Forze Armate erano inadeguate ai compiti, e anche di questo Mussolini portava la responsabilità. Scadente l’armamento, superati i mezzi (tranne che per la Marina), pessimo l’addestramento, in maggioranza politicizzati, arrivisti, incapaci i comandanti. Arrogatosi il comando delle Forze Armate, sottraendolo al re, il duce non ebbe una sola idea creativa. Cominciò la guerra con due simulacri d’offensiva, contro la Francia agonizzante e in Libia fino a Sidi-el-Barrani; progettò tardivamente e, per volontà di Hitler, finì col rinunciare alla conquista di Malta, che sarebbe stata vitale; volle solo qualche centinaio di morti da buttare sul piatto della bilancia. Poi restò al rimorchio dei Tedeschi, e una volta che volle fare da sé — con la campagna di Grecia — fu il disastro. L’avversario era piccolo, mediocremente armato, ma costrinse a un vistoso ripiegamento o allo stallo le forze prima di Visconti Prasca, poi di Soddu, infine di Cavallero. Dovette accorrere la Wehrmacht a darci man forte. La colpa della catastrofe militare ricade sul fascismo, questo è indubbio. Ma stiamo una volta di più attenti a non autoingannarci, sostenendo — come hanno fatto alcuni storici — che la guerra fu combattuta male dagli Italiani perché era guerra del regime e della borghesia, non di popolo. Se con questo s’intende che la guerra non fu sentita, nulla da eccepire. Se si vuole intendere, invece, che, ove fosse stata sentita, l’Italia avrebbe dato prova di straordinarie capacità militari, da eccepire c’è parecchio. Alle carenze materiali si sommarono carenze morali — o civiche — che non dipendevano da una maggiore o minore popolarità della guerra, ma che a tutti i livelli, cominciando dai generali, venivano di lontano. Erano il frutto intossicato di secoli in cui, per necessità, la furbizia fu il surrogato della forza. Rimane vero che i cattivi comandanti fanno i cattivi soldati. Quanto quei comandanti fossero impari alle loro responsabilità — non per mancanza d’intelligenza, merce che abbonda in Italia, ma per mancanza di carattere — lo si vide nella prova dell’8 settembre 1943. La fuga della famiglia reale e di Badoglio, umiliante, fu probabilmente inevitabile. Ma la calca di alti ufficiali — a cominciare da Roatta, capo di Stato Maggiore dell’Esercito, cui era affidata la sorte di molte centinaia di migliaia di soldati sparsi in mezza Europa — sul molo di Ortona a Mare, per inerpicarsi sulla corvetta Baionetta, fu una pagina ignobile. Il fuggi-fuggi che serpeggiava nei reparti era assai meno riprovevole dell’abbandono dei capi. Queste viltà furono riscattate da atti di valore di reparti e di uomini. E anche dalla lotta partigiana e dalle imprese del piccolo Esercito del Sud che, a Montelungo e dopo Montelungo, fece bene il suo dovere, tra la diffidenza o almeno l’indifferenza degli ex nemici divenuti alleati. Sulla Resistenza il discorso, già accennato del resto, dev’essere rispettoso e onesto (e si parla della Resistenza post-8 settembre, non dell’antifascismo di più vecchia e genuina data). La sua rilevanza politica fu enorme. Lì si formarono i lieviti che poi ebbero sviluppo nei decenni successivi, i CLN (e il CLNAI) prefigurarono gli schieramenti ideologici del dopoguerra, anche se taluni partiti, come quello d’Azione, ebbero folgorante successo iniziale e rapida morte, composti com’erano da ufficiali senza truppa. La Resistenza migliorò — benché meno, forse, di quanto si pretenda — l’immagine degli Italiani nei confronti degli Angloamericani, cui si poté dimostrare che tanti volontari erano in armi contro i Tedeschi e contro i ‘repubblichini’. Notevole fu anche la rilevanza morale della Resistenza: anche se sbocciò e dilagò — la lealtà ci costringe a rilevarlo — quando il fascismo era caduto per effetto di altre forze e la Germania era irreparabilmente in declino. Scarsa fu, invece, l’importanza della Resistenza italiana dal punto di vista militare, almeno in questo senso: che le scadenze fondamentali della guerra — presa di Roma, sbarco in Normandia, crolli tedeschi sul fronte russo — non furono influenzate dalla Resistenza italiana, ed è facile capire perché. Erano in azione i più potenti eserciti che la storia dell’umanità avesse mai conosciuto, e la sorte della Germania veniva decisa sui fronti occidentale e orientale. Infatti, la Linea Gotica era ancora salda, e i Tedeschi tenevano in pugno il Nord Italia, quando già le armate angloamericane e sovietiche calpestavano il suolo tedesco. Questa è la verità: che va onorata anche quando contraddice una consolidata mitologia, anche quando ha risvolti amari". Indro Montanelli, Da una guerra nasce la Repubblica, in C. Graffigna (a cura di), Italia: Ventesimo secolo, Selezione del Reader’s Digest, Milano 1985, pp. 298-299
Resistenze. Penso per prima cosa al mio professore di liceo, che ci diceva: “Liberazione, ma da chi?” Scrive Salvo Vitale il 25 aprile 2017 su "Telejato". In realtà, a quella data, cioè nel 1945, noi siciliani eravamo stati “liberati” da un pezzo, pochissimi i colpi sparati, nella marcia degli americani da Gela a Palermo. Qualche scaramuccia più cruenta si era avuta nel catanese per la presenza di un forte contingente tedesco che gli americani avevano scaricato sulle spalle degli inglesi. Non ci eravamo liberati dal nemico, sol perché numericamente insufficiente ad affrontare l’offensiva alleata, e che, pertanto si era ritirato, come i soldati borbonici davanti a Garibaldi, non ci eravamo liberati da noi stessi, perché nessuno aveva usato un’arma, non ci eravamo liberati dai fascisti, perché erano quasi tutti rimasti ai loro posti diventando collaborazionisti. E soprattutto non ci eravamo liberati dalla mafia, che aveva spianato la strada agli americani e aveva in cambio ricevuto lucrosi affari e incarichi. Il momento della liberazione parve invece essere arrivato due anni dopo, quando, il 20 aprile 1947 il Blocco del Popolo vinse le elezioni. Sembrava che tutto dovesse cambiare: c’era la fame di terra, la promessa di distribuzione delle terre incolte, la volontà e la capacità di organizzare le lotte per la conquista dei feudi da parte di alcuni sindacalisti, disposti a mettere a rischio anche la propria vita. Può essere affascinante l’ipotesi che la nostra Resistenza sia stata quella, ma che si sia tragicamente realizzata con la strage di Portella della Ginestra e con lo sterminio di una quarantina di sindacalisti. E a questo punto le differenze cominciano a delinearsi: la Resistenza era stata una “lotta armata”, oltre che un’insurrezione o una lotta di popolo contro un nemico interno, il fascismo, e contro il suo alleato esterno, il nazismo. La Resistenza aveva avuto un supporto logistico da parte degli alleati, che avevano rifornito di armi e assistenza alcuni nuclei più agguerriti, diffidando comunque dei gruppi troppo orientati a sinistra. La Resistenza aveva potuto usufruire di un forte comitato di Liberazione, attorno al quale si erano stretti tutti i nuclei antifascisti. Nulla di tutto questo invece nelle lotte contadine per la conquista delle terre del biennio 46-48. I contadini si battevano per il rispetto della legalità, ovvero per l’applicazione di una legge dello stato, i decreti Gullo. Non avevano armi, ma solo la loro voglia di lottare insieme contro i gabelloti, ovvero contro il braccio armato dei grandi latifondisti. Il P.C.I. e il P.S.I, a parte il grande dispendio di forze impiegate nella creazione di strutture organizzative (Federterra, Federbraccianti ecc.) non avevano potuto e saputo dare, ma non poteva essere altrimenti, una carica offensiva e difensiva forte che potesse fungere da risposta alle prepotenze armate dei mafiosi. Lo Stato se ne stava a guardare, potendo i mafiosi contare su tutta una serie di complicità che andavano dall’ordine pubblico all’amministrazione della giustizia, al controllo dei voti nelle campagne. A chiudere il cerchio l’atteggiamento americano, che mai avrebbe permesso, dopo gli accordi di Yalta, la creazione di una regione gestita dalle sinistre al centro del Mediterraneo. E così, quella che poteva essere una vittoria che avrebbe segnato la fine della mafia, si tramutò in una sonora sconfitta e nella perpetuazione del sistema atavico di controllo delle campagne e dei lavoratori. Si può chiamare questa la “nostra resistenza”? Erano partigiani i contadini in lotta? Qualcuno ci provò: Placido Rizzotto, per esempio, proveniva dall’esperienza partigiana al nord e su questa traccia stava cominciando ad organizzare i contadini. Anche di Giuseppe Maniaci, sindacalista di Terrasini, si sa che non era disposto ad accettare alcuna prepotenza. Tutto questo avrebbe significato lotta armata, cioè autentica Resistenza contro un nemico interno, la mafia, altrettanto feroce quanto i fascisti. Non fu così perché le condizioni per una guerra armata erano tramontate e perché i dirigenti contadini lottavano per il trionfo della giustizia dello stato. Adesso ha un senso definire partigiani tutti coloro che si impegnano nella lotta alla mafia? Non c’è dubbio che essere partigiano è qualcosa di affascinante, ma molto lontano dalla realtà, perché i mafiosi usano la pena di morte, mentre gli inermi cittadini, ma anche lo stato, si attengono alle norme della società civile, a meno di non indulgere a pericolose complicità. Perso in questa domanda scrivo qualcosa…
Partigiano d’altra sponda ho conosciuto mafiosi, anziché fascisti, la differenza non era poi molta:
stesse indicibili violenze, stesso sistema di paura, stessa scientifica teoria del silenzio, stesso teschio come simbolo.
Sempre col vecchio dilemma, se rispondere allo stesso modo o se scegliere la non–violenza,
se subire l’esercizio del ricatto e sperare nella protezione dello stato, oppure organizzare passaggi di lotta dura.
Nella teoria del rosso si amalgamano le arance, i gelsi, il melograno, il pomodoro, il sangue.
Ogni giorno trangugi la bibita e ti predisponi all’assuefazione.
Nei casi di ordinaria eversione c’è l’emarginazione, per la scheggia impazzita c’è l’eliminazione.
D’improvviso mi ricordo che il 25 aprile 1977 Radio Aut metteva in onda le prime prove di trasmissione. Sono passati appena tre anni e quella che poteva essere una micidiale arma d’offesa, in fin dei conti si è ridotta a sparare proiettili a salve, un pesce costretto a boccheggiare per mancanza d’ossigeno, di linfa vitale. Ogni velleità ha finito con il fare i conti, con il dileguarsi, davanti al muro invalicabile che ci è stato costruito attorno. Reagisco alla sensazione d’impotenza mettendo sul piatto canti di resistenza e canti di lotte sociali d’ogni tipo, a cominciare da “Contessa”. (Da Salvo Vitale “Cento passi ancora” Edizioni Rubbettino)
Salvo Vitale è stato un compagno di lotte di Peppino Impastato, con il quale ha condiviso un percorso politico e di impegno sociale che ha portato entrambi ad opporsi a Cosa Nostra, nella Cinisi governata da Tano Badalamenti, il boss legato alla Cupola guidata negli anni Settanta da Stefano Bontate.
Gli antifascisti che non vinsero. La sorte amara di Giustizia e Libertà. A 80 anni dall’assassinio di Carlo Rosselli e del fratello Nello un libro di Marco Bresciani ripercorre le vicende di intellettuali che cospirarono contro il regime di Mussolini, scrive Paolo Mieli il 2 maggio 2017 su "Il Corriere della Sera". Il nome veniva dal rovesciamento di quello del gruppo anarchico fondato a Napoli nel 1865 da Michail A. Bakunin: «Libertà e Giustizia». La nascita è databile all’agosto del 1929, quando giunsero a Parigi Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Francesco Saverio Nitti, evasi dal confino di Lipari. Ad accoglierli trovarono Gaetano Salvemini, Alberto Cianca e Alberto Tarchiani. A loro si sarebbero nel tempo aggiunti Umberto Calosso, Riccardo Bauer, Ernesto Rossi, Augusto Monti, Silvio Trentin, Vittorio Foa, Aldo Garosci, Leone Ginzburg, Andrea Caffi, Michele Giua, Max Ascoli, Franco Venturi e molti altri. Nessun gruppo o partito dell’epoca ebbe una concentrazione di cervelli di pari livello, sottolinea Marco Bresciani nelle pagine iniziali del saggio Quale antifascismo? Storia di Giustizia e Libertà, pubblicato da Carocci. Fondamentale fu per GL la generazione che si era formata all’inizio del Novecento, tutti grandi lettori de «La Voce», la rivista che Giuseppe Prezzolini fondò nel 1908. Le biografie politiche dei giellisti, scrive Bresciani, «erano accostabili, per certi versi e almeno per un tratto, a quelle di non pochi fascisti della prim’ora: la lontana ascendenza, o comunque la lealtà all’album di famiglia mazziniano; l’adesione al mito di una nuova rivoluzione nazionale; la passione interventista militante; l’avversione per il massimalismo socialista e la rivendicazione combattentistica postbellica». Fondamentale fu per tutti loro l’avversione all’esperienza di governo del liberale Giovanni Giolitti. La cultura di inizio Novecento, sostiene Bresciani, «trovò nell’antigiolittismo un comune denominatore (negativo)». Sotto la pressione dell’esperimento giolittiano di nazionalizzazione e insieme di democratizzazione del Paese, «si aprì una faglia profonda tra la classe dirigente liberale e classe intellettuale, che l’interventismo prima, il fascismo e l’antifascismo poi, in vario modo avrebbero cercato di ricomporre». La cultura antigiolittiana, con tutti i suoi strascichi, «fu il terreno d’incubazione dell’uno come dell’altro, depositando e accumulando molti dei materiali più innovativi — ed esplosivi — del nuovo secolo». La «virulenta critica antigiolittiana» e la «bruciante passione interventista» lasciarono nell’opinione pubblica «tracce ambigue (se non torbide), che riaffiorarono nella campagna per il rinnovamento della politica nazionale postbellica». Del resto ancora nel 1958 Salvemini ricordava che, nel 1922, ai tempi della marcia su Roma, tra Mussolini e Giolitti avrebbe scelto il primo. E non era l’unico. Ernesto Rossi aveva collaborato al «Popolo d’Italia», il quotidiano del movimento fascista, dal 1919 al 1922. Silvio Trentin, nel 1919, guardava a Mussolini come «artefice sicuro della rinascita» nazionale. Nicola Chiaromonte — come scrisse poi nel libro Il tarlo della coscienza (il Mulino) — fu in una fase iniziale attratto dalla figura di Mussolini. Identiche suggestioni ebbe Ferruccio Parri. Augusto Monti si spinse ad apprezzare le «buone intenzioni» mussoliniane. Anche coloro che sarebbero poi approdati ad una «versione intransigente di antifascismo» — è il caso di Rossi e Ascoli — furono a lungo esposti alla tentazione di guardare al fascismo come «rivolta generazionale». Paradossalmente la storia di GL e quella del fascismo, quantomeno nella sua fase iniziale, sono «indissolubilmente intrecciate»: ed è proprio su questo «comune terreno» che si possono «meglio comprendere le ragioni della loro contrapposizione». Dopo questa infatuazione iniziale, i giellisti adottarono la tesi di Piero Gobetti che identificava nel fascismo «l’autobiografia della nazione». Ma — come fece osservare uno di loro, Nicola Chiaromonte — si trovarono in contraddizione con la tesi gobettiana quando nell’ottobre del 1929 Rosselli, Lussu, Rossi e Tarchiani appoggiarono, nell’ottica del tirannicidio, l’attentato di Fernando De Rosa al principe Umberto. La difficile condizione di «fuorusciti» alimentò tra loro polemiche virulente. La collaborazione di GL con gli altri avversari del regime fascista — come è ben documentato nella Storia della Concentrazione antifascista di Santi Fedele (Feltrinelli) — suscitò le perplessità di Salvemini, emigrato a Boston, che raccomandava a Rosselli di lavorare piuttosto con i «giovani» e i «giovanissimi» rimasti a vivere sotto il regime. Ad un tempo i giellisti furono criticati da Togliatti, che su «Lo Stato Operaio» nel settembre del 1931 scriveva: «I quadri intermedi piccolo-borghesi di Giustizia e Libertà non hanno più davanti a sé, oggi, altra prospettiva che quella di dare il cambio ai limoni spremuti del riformismo». E persino da Max Ascoli che, emigrato a New York, accusò i suoi amici di essere inclini «ad agire prima che a pensare» e di assomigliare (nei loro ragionamenti) ai fascisti. Anche Chiaromonte obiettò che il loro antifascismo stava diventando una sorta di «fascismo a rovescio». Analoghi rilievi vennero da Umberto Calosso. Rosselli, e Lussu, Salvemini e Trentin, Rossi e Ascoli, scrive Bresciani, «avevano faticato a decifrare la novità e la radicalità del fascismo nella strisciante guerra civile del 1919-22». Una cultura «impregnata di umori antigiolittiani, di ardori interventisti e di slanci combattentisti», non aveva loro consentito di mettere bene a fuoco il fenomeno. Anzi, i «cascami impolitici» di quella cultura li aveva spinti a «identificare ogni esito della crisi postbellica con la stagione di Giolitti o anche solo a sottovalutarne la significativa discontinuità». Alcuni di loro «avevano stentato a riconoscere l’effettiva minaccia incombente sulle istituzioni liberali e parlamentari». Altri si erano lasciati suggestionare dal «messaggio di rinnovamento radicale del movimento di Mussolini». Ma una volta che ebbero maturato un convincimento antifascista, presero il regime sul serio e furono — soprattutto Salvemini e Trentin — «più attrezzati a comprenderlo di quanto non lo fossero tanti socialisti, comunisti e liberali». Nell’aprile del 1934, però, Salvemini accusò Rosselli di essere sempre di più «un fuoruscito… vivente di sogni e di parole astratte». E, stimolato da questa lettera, nel novembre di quello stesso anno così Rosselli elencò e stigmatizzò gli errori degli antifascisti: «Presentare il fascismo come in procinto di cadere da un istante all’altro; esagerare l’importanza dei movimenti esistenti; impiegare un tono roboante, minaccioso; esagerare nelle critiche di dettaglio e nello scandalismo, anziché attaccare le fondamenta e guardare all’insieme; condurre le requisitorie su motivi prevalentemente sentimentali o sulle violenze del passato; assumere verso coloro che stanno ancora nel Paese il tono di una aristocrazia antifascista; aver l’aria di difendere la così detta democrazia prefascista o le pseudo-democrazie esistenti; negare alcunché si sia fatto di utile sotto il regime; contestare a Mussolini ogni qualità, oppure, con esagerazione opposta, risolvere il fascismo in Mussolini; non insistere abbastanza sull’elemento positivo dell’antifascismo». Si distingue già allora Calosso il quale — «con spirito di raro anticonformismo», scrive Bresciani, e «infrangendo ogni canonico schema di classe» — riconosce che il reclutamento fascista è stato «anche contadino e operaio fin dalle origini», sicché è impossibile negare «le radici popolari del fascismo». La parte del movimento rimasta in Italia nel frattempo fu devastata dalle delazioni e dalle due retate torinesi, quella dell’11 marzo 1934 e quella del 15 maggio 1935, che misero fuori combattimento Leone Ginzburg, Carlo Mussa Ivaldi, Carlo Levi, Sion Segre, Vittorio Foa, Massimo Mila, Michele Giua, Augusto Monti, Franco Antonicelli, Cesare Pavese, Norberto Bobbio, Piero Martinetti, Giulio Einaudi, Ludovico Geymonat. Ed è qui che arriva il momento dell’apertura ai comunisti. Per quel che riguarda il regime dell’Unione Sovietica, il più lucido appariva Andrea Caffi che già nel 1932 , dopo aver definito la rivoluzione d’Ottobre «un positivo, generale sollevamento delle masse popolari», considerava il regime staliniano «un grandioso meccanismo per la coercizione e lo sfruttamento degli individui», notava le sue «evidenti affinità con i mostruosi parti dell’epoca nostra» e metteva in guardia dall’Unione Sovietica che, invece di costituire «un contrappeso ai regimi di reazione capitalistica», stava diventando «un elemento di questa costellazione reazionaria». Nella Vita di Carlo Rosselli (Vallecchi) Aldo Garosci nota come, invece, i giudizi del leader di Giustizia e Libertà dal 1934 in poi siano molto più generosi nei confronti dell’esperimento comunista. Bresciani attribuisce a Rosselli un corsivo redazionale comparso su «Giustizia e Libertà» (gennaio 1935) nel quale, in evidente polemica con Caffi e con Lionello Venturi, che aveva sottolineato le somiglianze tra i regimi fascista e comunista, è scritto: «Si possono combattere la dittatura russa e i suoi sistemi: non si deve però mai dimenticare che questa dittatura scaturisce dalla più grande rivoluzione del mondo moderno, si esercita su un Paese profondamente rinnovato e offre un vasto bilancio di opere per cui ogni parallelo tra dittatura russa e dittatura fascista è viziato alla base». La guerra civile spagnola, fin dagli inizi nel 1936, fu per Rosselli occasione per adottare quello che Bresciani definisce «un linguaggio insolitamente brutale, disponibile a giustificare qualsiasi violenza in chiave antifascista». Cosa che lo portò a scontri con Caffi, Lussu e Garosci. E, all’epoca dei processi staliniani, in Rosselli continuava ad affiorare, secondo Bresciani, «l’intrico di tentennamenti e cedimenti verso l’esperimento sovietico e il regime staliniano». Nei suoi scritti «si registrava una sempre più netta identificazione di anticomunismo e fascismo». La condanna delle «pratiche terroristiche» di Stalin si fece sempre più «fioca». Rosselli fu ucciso, assieme al fratello Nello, nel bosco di Bagnoles-de-l’Orne da fascisti italiani e francesi, secondo modalità ben esposte da Mimmo Franzinelli in Il delitto Rosselli 9 giugno 1937: anatomia di un omicidio politico(Mondadori). Morì che aveva da poco dato alle stampe un lungo saggio dal titolo Per l’unificazione del proletariato italiano, nel quale proponeva una sorta di partito unico dell’antifascismo. Ma, nonostante molti incontri tra giellisti e comunisti del calibro di Giuseppe Berti, Eugenio Curiel, Ruggero Grieco, quel che accadde in Spagna nella seconda fase della guerra civile, in Unione Sovietica e soprattutto le conseguenze del patto Molotov-Ribbentrop dell’agosto 1939, resero poco concreta la prospettiva da lui indicata. Alla notizia dell’accordo tra Hitler e Stalin, Cianca e Garosci scrissero per il giornale del gruppo un editoriale dal titolo esplicito: Crisi di un ideale. Infine il Comitato direttivo di GL si disperse nel giugno del 1940, al momento in cui le truppe di Hitler fecero il loro ingresso nella capitale francese. Ma il lavoro di questo straordinario gruppo di attivisti antifascisti e intellettuali raffinati ebbe eco nel Manifesto di Ventotene (scritto da Spinelli, Rossi e Colorni al confino, tra l’inverno del 1941 e la primavera del 1942) e nel Partito d’Azione fondato a Roma, in clandestinità nella casa di Federico Comandini, il 4 giugno del 1942. Anche se, precisa Bresciani, la storia del Pd’A deve essere tenuta «ben distinta» da quella di Giustizia e Libertà. Dopodiché, constata lo storico, nel dopoguerra gli ex giellisti «si presentarono (e si sentirono) più come vinti che come vincitori». A un suo personaggio — Andrea Valenti identificabile con Leo Valiani — Carlo Levi, ne L’Orologio (Mondadori), fa dire: «Eravamo partiti che volevamo la rivoluzione mondiale, poi ci siamo accontentati della rivoluzione in Italia, e poi di alcune riforme, e poi di partecipare al governo e poi di non esserne cacciati. Eccoci ormai sulla difensiva: domani saremo ridotti a combattere per l’esistenza di un partito, e poi magari di un gruppo o di un gruppetto, e poi, chissà, forse per le nostre persone, per il nostro onore e la nostra anima». Sarebbe andata proprio così. Ma Levi lo aveva capito già nel 1950. Il libro di Marco Bresciani Quale antifascismo? Storia di Giustizia e Libertà (Carocci, pagine 237, e 27) viene presentato il 4 maggio a Torino (ore 16.00) presso l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza (Istoreto) da Andrea Ricciardi. L’incontro fa parte dell’iniziativa «Giellismo e azionismo. Cantieri aperti» (4-5 maggio), che è ormai un appuntamento fisso per lo studio di questo filone politico. A Bresciani è stata assegnata la prima edizione del premio Giorgio Agosti, creato nell’ambito dei «Cantieri», a pari merito con Renato Camurri, curatore del volume Pensare la libertà. I quaderni di Antonio Giuriolo (Marsilio). Tra i libri su questi temi: Aldo Garosci, Vita di Carlo Rosselli (Vallecchi, 1973); Santi Fedele, Storia della concentrazione antifascista (Feltrinelli, 1976); Mario Giovana, Giustizia e Libertà in Italia (Bollati Boringhieri, 2005).
Giustizia e Libertà. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Giustizia e Libertà fu un movimento politico liberal-socialista fondato a Parigi nell'agosto del 1929 da un gruppo di esuli antifascisti, tra cui emerse come leader Carlo Rosselli. Il movimento era vario per tendenze politiche e per provenienza dei componenti, ma era comune la volontà di organizzare un'opposizione attiva ed efficace al fascismo, in contrasto con l'atteggiamento dei vecchi partiti antifascisti, giudicati deboli e rinunciatari. Il movimento Giustizia e Libertà svolse anche un'importantissima funzione di informazione e sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica internazionale, svelando la realtà dell'Italia fascista che si nascondeva dietro la propaganda di regime, in particolare grazie all'azione di Gaetano Salvemini, che era stato l'ispiratore del gruppo e il maestro di Rosselli. Alla fine del 1926, Carlo Rosselli, antifascista, iscritto al Partito Socialista Unitario (PSU) di Filippo Turati e del compianto Giacomo Matteotti, allievo del liberal-socialista Gaetano Salvemini, venne arrestato e condotto prima nel carcere di Carrara e in seguito in quello di Como.
Nel dicembre del 1926 fu deliberato nei suoi confronti il provvedimento di confino per 5 anni da scontare a Lipari. Tentò la fuga più volte, senza successo. Solamente il 27 luglio 1929, a bordo di un motoscafo, assieme ai compagni di confino Francesco Fausto Nitti e Emilio Lussu (avvocato e leader del Partito Sardo d'Azione), riuscì nell'impresa e, il 1º agosto, via Marsiglia, raggiunse Parigi. Rosselli e Lussu si trasferirono all'Hôtel du Nord de Champagne, a Montmartre; qui, dopo pochi giorni, ebbe i natali il movimento Giustizia e Libertà, grazie anche al contributo di altri fuoriusciti antifascisti, tra cui proprio Salvemini, residente in Saint-Germain-en-Laye presso l'abitazione del giornalista Alberto Tarchiani. Il simbolo del movimento - una fiamma, con nel mezzo le sigle G e L - fu disegnato da Gioacchino Dolci, un altro esule che aveva partecipato all'organizzazione dell'evasione di Rosselli da Lipari. Oltre agli esuli succitati, aderirono al nuovo movimento anche Alberto Cianca, Raffaele Rossetti, Francesco Fausto e Vincenzo Nitti. I triumviri incaricati di guidare il movimento furono Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Alberto Tarchiani.
Giustizia e Libertà non nasceva come partito, ma come movimento rivoluzionario e insurrezionale in grado di riunire tutte le formazioni non comuniste che intendevano combattere e porre fine al regime fascista, cavalcando la pregiudiziale repubblicana. Così si apriva il primo numero del periodico pubblicato dal gruppo: «Provenienti da diverse correnti politiche, archiviamo per ora le tessere dei partiti e fondiamo un'unità di azione. Movimento rivoluzionario, non partito, "Giustizia e libertà" è il nome e il simbolo. Repubblicani, socialisti e democratici, ci battiamo per la libertà, per la repubblica, per la giustizia sociale. Non siamo più tre espressioni differenti ma un trinomio inscindibile.» L'obiettivo di "Giustizia e Libertà" era quindi quello di preparare le condizioni per una rivoluzione antifascista in Italia che non si limitasse a restaurare il vecchio ordine liberale, ma in grado di creare un modello di democrazia avanzato e al passo con i tempi, aperto agli ideali di giustizia sociale, sapendosi inserire nella realtà nazionale e in particolare raccogliendo l'eredità del Risorgimento. Riprendendo le idee di Piero Gobetti, di cui era stato collaboratore, Rosselli considera il fascismo una manifestazione di antichi mali della società italiana e si propone quindi non solo di sradicare il regime mussoliniano, ma anche di rimuovere le condizioni politiche, sociali, economiche e culturali che lo avevano reso possibile. Il motto, coniato da Lussu, era "Insorgere! Risorgere!" e anche - come recita il primo bollettino mensile di GL - "non vinceranno in un giorno, ma vinceranno": anche se non saranno tutti loro i diretti testimoni di questa vittoria, lo sarà l'Italia repubblicana. Nel 1930 Carlo Rosselli pubblicò a Parigi, presso la Librairie Valois, il testo teorico del movimento, Socialisme Libéral, scritto l'anno precedente a Lipari; il testo sarà per la prima volta ristampato in Italia nel 1945, a cura di Aldo Garosci. Secondo Norberto Bobbio, gli intenti e le conclusioni a cui Carlo Rosselli vuole giungere sono, prima tra tutte, la necessità di una "rottura tra marxismo e socialismo" e, dunque, la possibilità di essere socialisti senza essere marxisti. Se il socialismo era stato considerato, in modo peculiare dal movimento operaio italiano, inscindibile dal sistema marxista, era giunto il tempo di riconsiderare il suo ruolo alla luce di una compatibilità possibile con il liberalismo: «Il socialismo inteso come ideale di libertà non per pochi ma per i più, non solo non è incompatibile con il liberalismo, ma ne è teoricamente la logica conclusione, praticamente e storicamente la continuazione. Il marxismo, e ancora una volta bisogna intendere per marxismo una visione rigorosamente deterministica della storia, ha condotto il movimento operaio a subire l'iniziativa dell'avversario, e una sconfitta senza precedenti.» (Carlo Rosselli.)
In una lettera a Garosci, Gaetano Salvemini, al contrario, stroncò senza riserve il socialismo liberale di Rosselli e non si astenne dal definirlo come «l'eruzione vulcanica di un giovane entusiasta e non un'opera critica, equilibrata e sostanziosa in cui era incapsulata una idea fondamentale: la ricerca di un socialismo che facesse sua la dottrina liberale e non la ripudiasse o assumesse di fronte ad essa una posizione indifferente o equivoca». Dopo la confluenza del partito donde proveniva Rosselli, il PSULI di Turati, Treves e Saragat, nel Partito Socialista Italiano di Pietro Nenni (luglio 1930), Giustizia e Libertà iniziò a conformarsi come un vero e proprio partito politico. In tale ottica, Rosselli stipulò un accordo con il Partito Socialista che riconobbe in GL "il movimento unitario dell'azione rivoluzionaria in Italia". Nell'ottobre del 1931, tale accordo fu esteso alla Concentrazione Antifascista, un'associazione di partiti antifascisti alla quale aderiva anche il Partito Repubblicano Italiano. Ciò sancì l'ingresso di Giustizia e Libertà nella "Concentrazione" e l'inclusione della stessa nel comitato esecutivo dell'organizzazione, composto da tre elementi in rappresentanza del PSI, del PRI e di GL, scelti di comune accordo. La Concentrazione Antifascista sembrò così conformarsi come un'associazione di tre forze politiche autonome e paritarie. L'accordo tra le tre formazioni politiche fu, tuttavia, ben presto segnato da numerosi contrasti: socialisti e repubblicani criticavano come un'"invasione di campo" il programma pubblicato da Rosselli nel primo numero dei Quaderni di Giustizia e Libertà, giudicato operaistico e giacobino. Inoltre, non era ben visto dal PRI e da GL il fatto che il Partito Socialista si orientasse verso un accordo con il Partito Comunista. Questo portò, nel maggio del 1934, allo scioglimento della Concentrazione Antifascista. Nel frattempo in Italia si erano formati clandestinamente altri nuclei antifascisti legati a GL, presenti soprattutto a Milano, dove si trovavano Ferruccio Parri, Riccardo Bauer e Umberto Ceva; a Bergamo, con Ernesto Rossi, in collegamento con il gruppo milanese; a Torino ove nel 1934 e maggio'35 vengono arrestati Franco Antonicelli, Norberto Bobbio,Umberto Cosmo, Giulio Einaudi, Leone Ginsburg, Carlo Foà, Vittorio Foa, Michele Giua, Carlo Levi, Gino Levi, Piero Luzzati, Massimo Mila, Giulio Muggia, Cesare Pavese, Battistina Pizzardo, Luigi Salvatorelli, Sion Segre Amar, Gioele Solari; a Firenze, con Nello Traquandi; a Roma, con Francesco Fancello e Vincenzo Torraca; in Sardegna, con Dino Giacobbe, Cesare Pintus e Michele Saba. Il gruppo venne subito decapitato a seguito di una spiata che condusse all'arresto (dicembre 1930) di Rossi, Bauer, Fancello, Traquandi, Parri, Torraca, Ceva ed altri. Condannati, Rossi e Bauer scontarono nove anni di carcere, poi commutati in confino, scontati a Ponza e a Ventotene; Fancello e Traquandi: cinque anni di carcere e cinque di confino; Parri: due di carcere e cinque di confino.
Nel febbraio 1936, in Spagna, dopo un periodo di grandi difficoltà politiche e sociali (moti rivoluzionari duramente repressi, sospensioni delle libertà civili, drammatiche condizioni sociali della popolazione nel quadro di un sistema economico ancora semifeudale), il Fronte popolare (comprendente il Partito Comunista di Spagna, all'epoca di estrazione marxista e filosovietica) vinse le elezioni. Le forze nazionaliste e antibolsceviche, che vedevano in pericolo gli interessi delle classi dominanti e le ancestrali tradizioni spagnole (anche religiose), passarono presto al contrattacco: nel luglio i militari di stanza in Marocco, guidati dal generale Francisco Franco, attuano un pronunciamento (colpo di Stato militare) contro il governo repubblicano. I militari, che speravano in una vittoria facile e breve, si trovarono contro una massiccia resistenza popolare che riuscì in poco tempo a fermare l'avanzata delle truppe ribelli e a riequilibrare la situazione. Anche una parte dello stesso esercito (marina e aviazione) si schiera con la Repubblica. Mentre i governi democratici restavano indifferenti, erano gli intellettuali e i militanti antifascisti di tutta Europa a sentirsi in dovere di portare il loro contributo alla lotta dei repubblicani spagnoli. Ovviamente Giustizia e Libertà fu subito in prima linea. Rosselli convocò tempestivamente una riunione dei gruppi antifascisti per organizzare un'azione comune. In un primo tempo però il partito comunista e il partito socialista decisero di non intervenire in Spagna per non creare problemi politici al governo repubblicano. Così Giustizia e Libertà decise di agire autonomamente insieme ad altri gruppi antifascisti minori (socialisti massimalisti, anarchici) e, grazie alla disponibilità della CNT-FAI, il sindacato anarchico che organizzò la resistenza in Catalogna, fu creata una Colonna Italiana, composta in maggioranza da anarchici ma aperta ad antifascisti di tutte le tendenze politiche e al comando di Carlo Rosselli. Solo successivamente, dopo l'appoggio dell'URSS ai repubblicani spagnoli e la nascita delle Brigate internazionali, i partiti comunista, socialista e repubblicano si accordarono per formare una legione unitaria, la Brigata Garibaldi, che operò lontano dalla Catalogna. La formazione di Rosselli si trovò isolata e, con la militarizzazione della resistenza popolare, si aprirono contrasti tra gli anarchici intransigenti, insofferenti a ogni disciplina, e lo stesso Rosselli. Quest'ultimo, che nel frattempo si era ammalato, decise di lasciare la Spagna temporaneamente per curarsi ma, il 9 giugno 1937 a Bagnoles-de-l'Orne, poco dopo il suo rientro in Francia, venne ucciso insieme al fratello Nello da sicari di una formazione della destra francese filofascista.
Dopo l'omicidio dei fratelli Rosselli, la guida del movimento venne assunta da Emilio Lussu, che impresse a GL una forte impronta socialista. Ciò provocò il dissenso e il distacco di numerosi componenti, tra i quali Alberto Tarchiani, che andò ad affiancare Randolfo Pacciardi alla direzione della pubblicazione repubblicana La Giovine Italia (1937). Giustizia e Libertà si indebolì ulteriormente a causa della "diaspora" conseguente alla minaccia bellica della Germania nazista. Nel settembre del 1939 Salvemini, rifugiatosi negli Stati Uniti, diede vita alla Mazzini Society, di cui il giornalista Max Ascoli assunse la presidenza. La nuova associazione si proponeva di contribuire all'orientamento dell'opinione pubblica americana di fronte alla questione italiana, ma aveva una forte connotazione repubblicana e liberaldemocratica. Con l'ingresso delle truppe tedesche in Francia, quasi tutti i dirigenti cercarono scampo altrove. Alberto Tarchiani raggiunse Salvemini a New York e assunse la segreteria della Mazzini Society. Paolo Vittorelli, rifugiatosi al Cairo, fondò Giustizia e libertà - Egitto, che svolse un'intensa attività propagandistica rivolta soprattutto ai militari italiani prigionieri dei britannici. Anche Lussu, nel giugno del 1940, fu costretto a lasciare la Francia per il Portogallo e quindi per l'Inghilterra. Nell'ottobre 1941 Silvio Trentin e Francesco Fausto Nitti sottoscrissero in Francia, ancora a nome di GL, un accordo unitario con comunisti e socialisti. Contemporaneamente (1941), dal confino di Ventotene, Ernesto Rossi, insieme al comunista dissidente Altiero Spinelli e al socialista Eugenio Colorni, redasse il Manifesto di Ventotene, il primo documento ufficiale prefigurante l'istituzione di un'Unione europea di tipo federalista. Nel gennaio 1942, negli Stati Uniti, un gruppo riunito attorno a Bruno Zevi fondò i "Quaderni Italiani", che divennero luogo di dibattito sui temi del liberalsocialismo. Lussu rientrò clandestinamente in Francia nel luglio 1942 e si incontrò con esponenti socialisti e comunisti per un patto d'unità d'azione dei partiti italiani di sinistra. L'accordo fu firmato il 3 marzo 1943 a Lione e fissava il quadro di un impegno programmatico a costituire un Comitato d'azione per l'unione del popolo italiano, alle cui decisioni i militanti dei tre partiti dovevano essere vincolati. Giustizia e libertà si dissolse, sostanzialmente, con il progressivo rientro in Italia dei suoi militanti, dopo il 25 luglio 1943 e la loro adesione ad altri partiti. In particolare, Emilio Lussu rientrò a Roma il 15 agosto e fu subito inserito negli organismi di vertice del Partito d'Azione. Tale operazione fu una precisa scelta politica del gruppo dirigente azionista, in particolare di Ugo La Malfa. Rossi aderì al P.d'A. dopo un convegno a Milano, tenutosi tra il 27 e il 28 agosto, mentre Spinelli attese ancora alcuni mesi (dic. 1943). Trentin giunse in Italia il 6 settembre e fu subito investito della direzione veneta del Partito d'Azione. Il 29 ottobre 1943, Emilio Lussu scrisse al “centro meridionale del Partito d'Azione” che mai il partito avrebbe collaborato con Badoglio e con la monarchia e di non preoccuparsi che GL scomparisse, perché “GL e PdA sono la stessa cosa e sarebbe fuori luogo ora far questione di denominazione”.
In Italia, un gruppo degli oppositori democratici ancora a piede libero aveva sentito l'esigenza di costituire un nuovo soggetto politico. Il 4 giugno 1942, nella casa romana di Federico Comandini, infatti, si era formato clandestinamente il Partito d'Azione. La nuova formazione era costituita, in particolare, da personalità repubblicane di estrazione liberal democratica come Ugo La Malfa, Adolfo Tino e Mario Bracci, insieme a personalità del mondo progressista e radicale come Guido Dorso, Tommaso Fiore, Luigi Salvatorelli, Adolfo Omodeo e ai liberalsocialisti di Guido Calogero, Norberto Bobbio e Tristano Codignola. L'elaborazione politica di quest'ultimi si era sviluppata in via del tutto autonoma da quella di Giustizia e Libertà. I giellisti aderirono progressivamente al nuovo partito che, dopo l'8 settembre 1943, rappresentò l'organizzazione a cui facevano riferimento i combattenti partigiani delle Brigate Giustizia e Libertà. Oltre a Lussu, Rossi e Trentin, entrarono nel P.d'A. anche Alberto Tarchiani e Alberto Cianca (per ricordare solo gli esponenti principali). Il Partito d'azione riuscì a presentarsi come un partito che lotta per un cambiamento radicale della società italiana rompendo, ovviamente, con intransigenza con il fascismo e l'Italia pre-fascista, contrapponendosi in questo ai liberali; per una società laica e secolarizzata, contrapponendosi ai democristiani, per una società democratica progressista ma pluralista e con ordinamenti politici liberali, contrapponendosi ai comunisti ancora saldamente legati all'Unione Sovietica. Per questi motivi distintivi riuscì a raccogliere vasti consensi tra le persone desiderose di combattere contro il nazi-fascismo, caratterizzandosi comunque come un movimento piuttosto elitario. Durante la guerra partigiana, il Partito d'azione fu attivo nell'organizzazione di formazioni partigiane, tra le quali si ricordano le brigate Giustizia e Libertà. Numericamente, le formazioni GL (dette "gielline" o "gielliste") erano seconde soltanto a quelle "garibaldine", riconducibili al Partito Comunista. I partigiani giellini si riconoscevano per i fazzoletti di colore verde. Tra costoro - tutti facenti parte del Partito d'Azione - si possono ricordare Ferruccio Parri, nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) comandante militare unico della Resistenza, Antonio Giuriolo e Riccardo Lombardi, nominato nel 1945 prefetto di Milano dal CLN dell'Alta Italia (CLNAI).
Il Partito d'Azione, fondato nel 1942, fu l'erede principale del movimento GL ma, nell'immediato dopoguerra si divise in due correnti: una socialista, guidata da Emilio Lussu, e una liberaldemocratica, guidata da Ugo La Malfa. Riccardo Lombardi e Vittorio Foa tentarono invano di organizzare una terza corrente che fungesse da ponte fra le due ali estreme. La divisione interna si manifestò insanabile: dopo che la minoranza liberaldemocratica aveva già aderito al Partito Repubblicano Italiano, il 20 ottobre 1947 la maggioranza socialista confluì nel Partito Socialista Italiano e il Pda fu sciolto. Una componente minoritaria del Partito d'azione (Piero Calamandrei, Tristano Codignola, Aldo Garosci, Paolo Vittorelli) non confluì nel Partito Socialista Italiano e, al momento dello scioglimento del partito, formò il movimento “Azione Socialista Giustizia e Libertà” che mantenne la proprietà della testata giornalistica L'Italia Socialista (già: L'Italia libera), con la direzione di Garosci. “Azione Socialista Giustizia e Libertà”, l'8 febbraio 1948, a Milano, poi, dette vita all'Unione dei Socialisti, insieme ad alcuni ex giellini indipendenti. L'Unione dei Socialisti partecipò alle elezioni politiche del 1948 nell'ambito della coalizione di Unità Socialista, insieme al PSLI. Il 31 gennaio 1949 confluì ufficialmente nel PSLI che, nell'occasione, cambiò il suo nome in PSDI. Successivamente, il 1º febbraio 1953, la componente ex azionista del gruppo di Calamandrei e Codignola uscì anche dal PSDI e formò Autonomia Socialista, insediandosi nella vecchia sede fiorentina del soppresso movimento “Azione Socialista Giustizia e Libertà”. Nel frattempo, il 18 gennaio 1953, lo scrittore Carlo Cassola, rifondò ufficialmente Giustizia e Libertà, ma il nuovo movimento si dissolse dopo solo tre mesi. Il 18 aprile 1953, infatti, in vista delle elezioni politiche del 1953, si costituì il movimento Unità Popolare, con l'obiettivo di far fallire la cosiddetta legge elettorale "truffa" varata dal governo De Gasperi. Confluirono nel nuovo movimento sia Autonomia Socialista di Calamandrei, sia Giustizia e Libertà di Carlo Cassola che un gruppo di dissidenti di sinistra del PRI (Unione di Rinascita Repubblicana), guidati da Oliviero Zuccarini e al quale, successivamente, aveva aderito anche Ferruccio Parri. Aderirono ad Unità Popolare anche ex-azionisti ed intellettuali come Leopoldo Piccardi, Federico Comandini, Giuliano Vassalli e Carlo Levi; il movimento ebbe anche il sostegno di Adriano Olivetti e del suo Movimento Comunità, di Carlo Bo, Norberto Bobbio, Mario Soldati e Leo Valiani. Tuttavia, colto il risultato di non fare scattare per un pugno di voti il premio di maggioranza a favore dei vincitori (la DC e gli alleati centristi), il raggruppamento non riuscì a proporsi come centro di coagulazione di un socialismo democratico di ispirazione non marxista. Dopo l'adesione dell'ala liberaldemocratica (Piccardi, Valiani) nel costituendo Partito Radicale, nel 1957 il movimento votò, a maggioranza, la sua dissoluzione e la confluenza nel Partito Socialista Italiano. Tra i contrari: Oliviero Zuccarini rientrò nel PRI e Aldo Garosci lasciò temporaneamente la politica. Le battaglie laiche, antimonopoliste e antiautoritarie condotte dal Mondo diretto da Mario Pannunzio sfociano nel 1955 nella costituzione del Partito radicale, che comprendeva fra i fondatori numerosi militanti di estrazione giellista e azionista, fra i quali spiccavano Ernesto Rossi e Leo Valiani. Questa esperienza, fra le più innovative del panorama politico italiano, entrò in crisi all'inizio degli anni sessanta, a causa della dura contrapposizione a proposito del "caso Piccardi" fra l'ala di origine azionista (rappresentata da Ernesto Rossi) e quella di origine liberale (guidata dallo stesso Pannunzio), che lasciò un lungo strascico di rancori personali. Successivamente, singole personalità, fuori e dentro i partiti, nei sindacati, nelle associazioni e sulle colonne dei principali giornali italiani, ripresero e rilanciarono alcuni temi cari a quest'area politica - le fondamenta della democrazia, la difesa della Costituzione, la laicità delle istituzioni repubblicane, lo sviluppo di una forte etica pubblica. Si pensi, per esempio, a Vittorio Foa, Norberto Bobbio, Alessandro Galante Garrone, Leo Valiani, Giorgio Bocca. Soltanto a partire dagli anni novanta si tentò di riallacciare i rapporti all'interno della diaspora giellista e azionista, dapprima con la costituzione, nel 1993, del Movimento d'azione Giustizia e Libertà[20] (alla cui presidenza fu chiamato Aldo Garosci), in seguito con la costituzione della Federazione nazionale dei circoli Giustizia e Libertà, il cui coordinatore è Vittorio Cimiotta. Quest'ultima è un'"associazione di associazioni" (facente capo allo storico Circolo "Giustizia e Libertà" fondato a Roma nel 1948) priva di finalità di tipo partitico, ma esclusivamente di studio e diffusione del patrimonio ideale, culturale e politico di GL e del Pda. Su questi temi collaborò con le fondazioni, gli istituti storici, gli archivi e le associazioni con questo comune interesse. A Torino, nel 1993, si costituì il Movimento d'Azione Giustizia e Libertà (con finalità di politica riconducibili ai partiti della sinistra) sotto l'egida culturale di Alessandro Galante Garrone e di Guido Fubini che lo presiedette sino al decesso. Dal 2010 è presidente Antonio Caputo; ha organizzato e coorganizza importanti eventi, come la manifestazione del 29 aprile 2001 al Cinema Eliseo di Torino che fu occasione per diffondere l'appello di Bobbio, Galante Garrone, Sylos Labini, Pizzorusso, per battere col voto la cosiddetta "casa delle Libertà"; il Palavobis del 2002, "se non ora quando" del 2011. Esprime la linea attualizzata dell'azionismo torinese, inteso come metodo che intende coniugare pensiero e azione, nella difesa e attuazione della Carta costituzionale e dell'affermazione dei principi sempre attuali di Giustizia e Libertà.
PRIMO MAGGIO. FESTA DEI LAVORATORI: SOLITA LITURGIA STANTIA ED IPOCRITA.
Primo maggio, Festa dei lavoratori? No! Festa dei violenti e degli immigrati.
1° MAGGIO, PERCHE' LA FESTA DEL LAVORO? (CHE NON C'E'...) Scrive Domenica 30 Aprile 2017 Luigi Garofalo su "Leggo". Tre 8. La festa dei lavoratori che si festeggia il primo maggio è figlia della rivendicazione, coniata in Australia nel 1856, di “otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire” perché nei Paesi che si stavano rapidamente industrializzando, si lavorava 11-12 ore in condizioni spesso bestiali. È una festa figlia delle lotte del movimento operaio e socialista. Perché si festeggia il 1^ maggio? Perché la prima volta è stato festeggiato nell’Illinois (USA) nel 1867: nonostante l’entrata in vigore di una legge che stabiliva la giornata lavorativa di otto ore, molti imprenditori non volevano rispettarla: per le vie di Chicago sfilarono 10mila operai, il più grande corteo mai visto fino ad allora. In Italia nel 1947 la festa del lavoro e dei lavoratori è diventata ufficialmente festa nazionale. Da diversi anni, a causa dell’alta disoccupazione, si dice che il primo maggio è la festa del lavoro…che non c’è.
Lavoro che non c’è, riflessioni sulla Festa dei lavoratori, di Giuseppe Saluppo su "La Gazzetta molisana" il 30 aprile 2017. La chiamano festa dei lavoratori, ma in realtà il 1° Maggio, ormai da qualche decennio, si è trasformato in una cerimonia funebre. Con la disoccupazione schizzata al 13% e quella giovanile (15-24 anni) che supera il 44%, con disoccupati e inattivi che vorrebbero lavorare ma non hanno prospettiva che arrivano al 25%. Festa del Lavoro? Si è già parlato, più o meno scherzosamente, del suo opposto: festa del non lavoro. E dunque, se così è, si può ancora parlare di festa? E’ vero, ci sono timidi segnali di ripresa ma, purtroppo, restano forti criticità. Con la disoccupazione giovanile alle stelle, una tassazione soffocante e un territorio che invecchia. E’ la fotografia, per certi versi impietosa, del nostro Molise. I numeri descrivono un territorio che procede a tentoni, alla ricerca di un rilancio possibile ma sostanzialmente fermo. Un primo maggio in cui il senso della festa è sostituito dalle preoccupazioni per il futuro, per il lavoro che non c’è; sostituito da quel senso di precarietà, dalla paura del domani, dal rischio di non farcela, non solo di chi il lavoro l’ha perduto, ma anche di chi il lavoro non l’ha ancora avuto: i nostri figli. Il “libero mercato del lavoro” sta spingendo i nostri giovani fuori dalla Regione, trasformandola in una terra di vecchi dove si sta rinunciando all’energia vitale, alla creatività, alla capacità di lavoro e di progetto perché i giovani saranno sempre più, una minoranza. Dovrebbe dunque essere chiara l’enormità economica, politica, umana della questione del lavoro, dove le aziende chiudono i battenti e nessuna capacità politico- progettuale crea alternative credibili di crescita. L’unico binario percorribile per inseguire un futuro migliore e regalare alle nuove generazioni un mondo del lavoro diverso è la legalità, la dignità e il rispetto della vita. Ideali limpidi da proteggere e rivendicare ad ogni costo. Perché, disoccupazione e precarietà uccidono il futuro e l’economia.
Quei cortei senza operai: gli immigrati in prima fila. Fino a pochi anni fa sfilavano manovali e tute blu. Ora non si sentono più rappresentati dai sindacati, scrive Riccardo Pelliccetti, Mercoledì 3/05/2017, su "Il Giornale". L'immagine non sorprende, ma fa riflettere. L'Italia è diversa e i sindacati pure, così il Primo maggio 2017 fotografa una realtà su cui spesso non ci soffermiamo: il cambiamento sociale. Rapido e inarrestabile. Certo, per i cultori della società multietnica sono passi verso il paradiso del progresso, un'opinione rispettabile ma non per questo condivisibile. Vedere la prima fila del corteo di Milano, in occasione della Festa del Lavoro, composta totalmente da lavoratori extracomunitari lascia interdetti. In passato ci eravamo abituati a veder sfilare le tute blu della Fiat, della Breda, dell'Ilva e di tante altre realtà operaie e industriali italiane. Sono solo un ricordo. Eppure i lavoratori italiani sono ancora tantissimi, anzi la stragrande maggioranza: sono oltre 22 milioni gli occupati in Italia (tra lavoratori dipendenti e autonomi) tra i quali gli stranieri sono poco più di due milioni. Un numero corposo ma parliamo del 10 per cento della forza lavoro. Per quanto in molti distretti industriali la manodopera dei migranti sia una realtà consistente, la media nazionale rivela che nove lavoratori su dieci sono italiani. Ma, a guardare le immagini del corteo del Primo maggio, le proporzioni sembravano opposte, anche se oltre un milione di stranieri è iscritto al sindacato. Ma forse c'è un altro motivo, senza bisogno di scomodare il passato. Tra quel 90 per cento di lavoratori italiani ve ne sono pochi che desiderino sfilare in corteo sotto i vessilli sindacali e, men che meno, che vogliano marciare in prima fila. Forse perché sono disillusi e delusi dai sindacati italiani che, in questi anni, non hanno fatto niente di più che avventurarsi in qualche conflittualità politica, mostrando di essere più partiti che associazioni di lavoratori. E molto spesso sono impegnati più a difendere i privilegi che a tutelare i diritti. Certo, in questa congiuntura economica e con il mercato del lavoro anoressico non c'è grasso che cola ma allora, a maggior ragione, dovrebbero tornare a essere rivoluzionari e proporre ricette che siano al passo con i tempi. Per esempio, è inutile arroccarsi sull'articolo 18 per difendere posizioni anacronistiche, quando da anni l'unica nuova occupazione è il cosiddetto precariato. Come accade nel pubblico impiego, dove i dipendenti a termine guadagnano la metà rispetto a uno assunto a tempo indeterminato, ma senza la tutela del posto fisso. Un controsenso, una vergogna di cui sono corresponsabili i sindacati, che hanno piantato i piedi solo per difendere chi è già garantito, il quale talvolta può anche permettersi di essere un fannullone senza temere alcunché. Detto questo, non vi è nulla di strano né di sorprendente se il Primo maggio i lavoratori extracomunitari sfilano in corteo, ci mancherebbe. Ma quella prima fila ha tanto il sapore della resa dei lavoratori italiani. Certo, meglio questa immagine di quella vista a Trieste, dove nel corteo sventolavano le bandiere con la stella rossa dei partigiani titini. Più che una festa del Lavoro, qualcuno ha preferito celebrare l'anniversario della sanguinosa occupazione jugoslava di Trieste, cominciata il Primo maggio 1945. Per qualcuno il tempo si è fermato assieme ai propri neuroni. Qualcun altro invece pensa di anticipare i tempi. I sindacati forse sono convinti che questa metamorfosi possa garantirgli un futuro. Può darsi che non abbiano tutti i torti (a guardare i rapporti dell'Istat, se non vi saranno inversioni di tendenza, gli stranieri in Italia saranno oltre 20 milioni entro il 2065).
Tra l'ipocrisia dei sindacalisti e la violenza dei centri sociali: il solito Primo maggio. Nelle piazze va in scena il copione di sempre: da una parte l'ipocrisia dei sindacati, dall'altra gli antagonisti violenti, scrive Chiara Sarra, Lunedì 1/05/2017, su "Il Giornale". Da una parte l'ipocrisia dei sindacati, in piazza a difendere il lavoro che loro stessi hanno ucciso. Dall'altra centri sociali e antagonisti, sempre pronti a vandalizzare e provocare la polizia, costretta a caricare per evitare disordini e eccessi. Va in scena il solito copione del Primo maggio. La giornata dedicata ai lavoratori è iniziata con l'omaggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil a Portella della Ginestra, in provincia di Palermo, a 70 anni dall'eccidio. "È un Primo maggio di impegno e non di festa perchè c'è poco da festeggiare", ha detto Carmelo Barbagallo (Uil), "Siamo qui per rivendicare l'opportunità di far riprendere l'economia del Paese mettendo al centro del dialogo l'articolo 1 della Costituzione, cioè che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. E vediamo di non affondarla sul lavoro". "Il messaggio di oggi deve essere lavoro, lavoro, lavoro", aggiunge, Annamaria Furlan (Cisl), "Siamo qui contro le mafie, siamo qua per mettere al centro del dialogo sul futuro il tema dell'occupazione dei nostri giovani che non trovano lavoro e sono costretti ad abbandonare il nostro Paese. Abbiamo bisogno delle loro intelligenze per proiettarci nel domani". Intanto a Milano si svolgeva sotto la pioggia il corteo dei sindacati che hanno sfilato insieme ai migranti. Un centinaio di persone, soprattutto uomini ma anche donne, di origine egiziana, senegalese, ivoriana e di altre nazionalità, con tamburi, bandiere rosse con la scritta "Proletari di tutti i Paesi unite", tradotta in diverse lingue e striscioni come "Migranti del mondo benvenuti" e "Basta con gli spacciatori di paura". E l'immancabile "Bella ciao" che ha accompagnato il corteo fino alla fine, in piazza della Scala. Tensioni e scontri invece a Torino dove la polizia ha bloccato i manifestanti dei centri sociali per impedire loro l'accesso in piazza San Carlo dove sono previste le manifestazioni ufficiali. I dimostranti hanno così tirato uova contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche di alleggerimento.
Se i sindacati festeggiano ciò che hanno ucciso. Nove milioni di italiani a rischio povertà. Invece che autocelebrarsi nelle piazze, i sindacalisti dovrebbero fare un esame di coscienza, scrive Carlo Lottieri, Lunedì 1/05/2017, su "Il Giornale". I dati diffusi nell'imminenza della festa dei lavoratori offrono una rappresentazione eloquente dei disastri conseguenti a decenni di alta tassazione e regolazione. Lo studio realizzato da Unimpresa, in effetti, mette il dito nella piaga, ricordando come ben nove milioni di italiani siano a rischio povertà. Invece che autocelebrarsi nelle piazze, allora, i sindacalisti dovrebbero fare un esame di coscienza e rivedere le proprie linee di condotta. Se manca il lavoro e se anche quanti hanno un'occupazione spesso possono contare su retribuzioni modeste, questo si deve al fatto che lo Stato pesa come un macigno sull'economia: esso sottrae un'enorme quantità di risorse e, oltre a ciò, impedisce quello sviluppo dei rapporti contrattuali che è alla base di ogni crescita. Avere eliminato i voucher, ad esempio, renderà ancora più difficile la vita di tante imprese e ostacolerà ancor più quanti cercano di guadagnarsi da vivere. Se il miglioramento delle condizioni di vita deriva sempre e soltanto dalla libera inventiva, dall'impegno e dal moltiplicarsi degli scambi, in questi anni i governi (spesso subendo i diktat sindacali) hanno fatto quasi tutto il possibile per impedire la crescita. E se ora l'esecutivo salverà 13mila posti di Alitalia, sarà solo per bruciare risorse che - qualora lasciate nelle tasche di chi le ha prodotte - con ogni probabilità potrebbero crearne molti di più. Una delle ultime battaglie di retroguardia è stato il «no» al lavoro festivo, conseguente alla pretesa d'imporre a tutti come devono vivere. Ma questa logica autoritaria, nei fatti, può solo aumentare la disoccupazione. Le strutture corporative che condizionano la vita produttiva (la Cgil e non solo), ogni Primo maggio scendono in piazza in nome dei lavoratori e a «difesa del lavoro», ma sono impegnate in attività che impediscono a molti giovani e meno giovani di costruirsi un futuro. Il sistema di tutele che è stato costruito spesso nega la possibilità d'interrompere un rapporto di lavoro anche quando il dipendente non è giudicato interessante dall'azienda. Tutto ciò, unito al prelievo fiscale esorbitante, frena molte imprese dall'assumere e spinge pure a trasferire fuori dalle frontiere i propri impianti. Statalismo e demagogia sono all'origine del disastro italiano. Se i sindacati non lo comprendono e non cambiano rotta, sperare in un futuro migliore è proprio da ingenui o da sprovveduti.
Ecco la verità sul crac Almaviva: il Tribunale dà la colpa alla Camusso. Nessuna volontà di dare attuazione agli accordi. E la Cgil paga le spese, scrive Patricia Tagliaferri, Mercoledì 3/05/2017, su "Il Giornale". Anche quest'anno, tante belle parole sui diritti dei lavoratori dal palco del concertone del primo maggio, in piazza San Giovanni. Salvo poi scoprire che non sempre i sindacati remano a favore di coloro che dovrebbero tutelare. Nulla di inedito. Questa volta, però, è anche un giudice a certificare che è andata così nella dolorosa vicenda di Almaviva, costata il licenziamento a 1.666 dipendenti del call center di Roma. La sentenza riportata da Il Messaggero è clamorosa, perché le carte giudiziarie raccontano una storia diversa da quella che solitamente passa dalle organizzazioni sindacali. Per il Tribunale del Lavoro di Roma ai licenziamenti dello scorso dicembre si è arrivati anche per colpa del comportamento dei sindacati che «hanno chiaramente dimostrato di non voler dare attuazione agli accordi firmati». Nella fase finale del confronto, poi, scrive il giudice, «non hanno chiesto alcuna interruzione della trattativa per attendere la consultazione dei lavoratori», così che il referendum fra i lavoratori si svolse a licenziamenti già partiti. Altro che concertazione, insomma. Sono accuse pesanti, quelle messe nero su bianco dal Tribunale, che offrono uno spaccato inedito su quello che normalmente si intende per confronto sindacale. Il ricorso contro i licenziamenti presentato dalla Cgil-Slc è stato così respinto e il sindacato di Susanna Camusso, oltre ad essere condannato a pagare 3mila euro, è finito sotto accusa, indiretto «complice» della perdita di tanti posti di lavoro. Nella sentenza il giudice ripercorre la vicenda, da quando azienda e sindacati si accordano per aumentare la produttività dei call center di Roma e Napoli. Poi però la Gcil-Slc salta i primi due incontri fissati e un terzo va a vuoto. Un comportamento che non passa inosservato al giudice, che pronunciandosi stigmatizza anche quello delle Rsu, alla cui «lacerazione» attribuisce la responsabilità del mancato accordo. Il risultato finale sono i 1.666 licenziamenti, giunti «per l'esito di un percorso svoltosi nel rispetto di condizioni e termini fissati dalla legge». In altre parole legittimi. Nulla da dire, dunque, su Almaviva, che grazie al lavoro di chi avrebbe dovuto tutelare gli interessi dei dipendenti si è potuta liberare di quelli in esubero.
Il concerto del 1˚ maggio ci costa 900mila euro, scrive "Libero Quotidiano" il 28 aprile 2017. Il Concertone del Primo maggio a Roma, più che ad un rito, assomiglia ad un rituale. Una sorta di piccola Sanremo alternativa, declinata dai sindacati a favore dei lavoratori, che non sono mai in piazza San Giovanni. Sotto al palco giovani e giovanissimi, che poco sanno di lavoro e ancora meno di sindacato. Figuriamoci del significato del Primo maggio. Per la maggior parte di loro è solo una grande occasione per fare una scampagnata a Roma. Eppure Cgil, Cisl e Uil si ostinano a chiamarlo «Concertone». Forse per i costi, visto che la kermesse, fra allestimento, cast, Siae, permessi e spese varie costerà «fra gli 800mila e i 900mila euro». A spiegarlo è Massimo Bonelli, musicista e produttore, che con la sua società «iCompany» produce il Concertone di piazza San Giovanni (che quest’anno sarà condotto da Clementino e Camila Raznovich) insieme alla Ruvido Produzioni di Carlo Gavaudan. Fra i costi non vi sono cachet degli artisti dato che, spiega Bonelli, «la quasi totalità degli artisti non riceve un compenso ma solo un rimborso spese», spiega il promoter, «accettano di esibirsi perché hanno motivi personali, di impegno civile, e poi perché il Concertone è una magnifica vetrina». Ecco, quest’ultima ipotesi è decisamente la più verosimile. Una folla acclamante in piazza, il resto davanti alla Tv. Il concerto dei confederali per la Festa dei Lavoratori ai sindacati, che ne sono solo promotori, non costa nulla. Chi paga il conto, sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno secondo Bonelli, sono gli sponsor e la Rai, che manda in onda il concerto. Viale Mazzini sborsa una cifra che oscilla fra i 400 e i 500 mila euro, facendosi carico del grosso delle spese. La parte restante è a carico degli sponsor. La domanda resta quella di sempre: è normale che la Rai paghi l’evento dei sindacati quando il ritorno, sia in termini pubblicitari che di ascolto, non è certo in linea con la cifra spesa? La domanda si rincorre da anni senza trovare una vera risposta. Se non quella di sempre. In fondo il Concertone è la piccola Woodstock de’ noantri (come si dice a Roma) e per riempire il palinsesto del primo maggio un po’ di musica non fa male.
Le magagne del concertone del primo maggio di Roma. Critiche incrociate, budget risicati, aziende in liquidazione e lavoratori in attesa dei pagamenti, scrive Lidia Baratta il 30 Aprile 2014 su “L’Inkiesta”. Guardando sotto il tappeto del concertone del primo maggio a Roma si scoprono tante cose. Dietro le quinte del palco di piazza San Giovanni, dove si esibiscono ogni anno band più o meno emergenti e artisti più o meno conosciuti, si nascondono critiche incrociate tra organizzatori e sindacati, budget sempre più risicati, società in liquidazione e lavoratori che aspettano di esser pagati. Dal 2001 l’evento viene organizzato da Marco Godano, da leggersi con l’accento sulla “o” per non confondersi con Godàno, cognome del leader dei Marlene Kuntz, con il quale il patron della manifestazione non ha nessuna parentela. Godano, un passato da militante di sinistra come dirigente dell’Arci Musica, lavorava già nella precedente gestione del concertone, per poi passare a essere il promoter principale dell’evento con la sua società Primata srl, acronimo di “Primo maggio tutto l’anno”. La società, controllata dal gruppo Godano - che fa capo a Connie Godano - risulta in liquidazione (come le altre tre aziende – su cinque – del gruppo), con 400mila euro di debiti sulle spalle; e dal 2011 non organizza più il concertone di piazza San Giovanni. Dopo lo scioglimento della Primata, la palla poi era passata alla Anyway srl, di cui Godano è amministratore unico, ma in vent’anni di attività ha accumulato più di un milione di debiti. Così «la Anyway ora non organizza più il Concertone», spiega Godano, nonostante il nome della società compaia ancora in fondo al sito dell’evento. «Proprio per mettere a posto i conti, abbiamo passato la mano alla società 1MVideo», nata nel settembre 2013, per iniziare ufficialmente le attività poco più di due mesi fa. Tolta un’azienda in difficoltà, se ne mette un’altra, purché il concerto si faccia. La storia senza lieto fine della Primata, però, non è isolata. Godano, il cui contratto per l’organizzazione del primo maggio scade nel 2015, ha alle spalle un lungo passato nel mondo dello spettacolo e dell’organizzazione di eventi, anche per Confidustria. Il suo curriculum è ricco di imprese ormai inattive, cancellate, liquidate e fallite. Come il gruppo Edo srl, che nel 2003 ha prodotto per la Rai la trasmissione Fiesta. Su Il Giornale di qualche anno fa venne fuori che autori e conduttori del programma si erano dovuti rivolgere agli avvocati per cercare di incassare le retribuzioni dovute. Ma lo speaker radiofonico Joe Violanti, che con Charlie Gnocchi era coautore e conduttore del programma, a distanza di undici anni dice: «I soldi naturalmente sono spariti, nell'assordante silenzio della Rai». E pare che non sia l'unico caso, visto che proprio di recente si è concluso un contenzioso con altri quattro lavoratori per mancati pagamenti da parte della GoEvent srl, sempre del gruppo Godano, e sempre in liquidazione. «È una vicenda destinata a concludersi», spiega l’avvocato Fabio Santoro, che ha seguito i quattro lavoratori. «La società GoEvent srl ha sottoscritto un accordo dopo un contenzioso durato un anno. Il 2 maggio le persone saranno pagate con il pagamento integrale, più gli interessi maturati in un anno. Il contenzioso da parte nostra si può quindi dire concluso con estrema soddisfazione». Le cifre sono «riservate», dice l’avvocato, e comunque dipende dai casi. Ci sono persone che aspettano gli arretrati di due mesi di lavoro, altri di più. Si tratta di qualche migliaio di euro mensile per lavoratore. Non stipendi stellari, insomma. Qualcuno di loro ha anche lavorato per il concertone del Primo maggio, ma Godano precisa che i mancati pagamenti «non riguardavano il concertone». Tant’è. Ma affidare l’organizzazione del concerto della Festa dei lavoratori a uno che non paga i propri dipendenti (tanto più sei quattro non sarebbero i soli ad aspettare ancora pagamenti da Godano, come giurano alcuni suoi ex dipendenti) sembrava quantomeno paradossale. Tanto che Cgil, Cisl e Uil sarebbero intervenuti per sollecitare l’accordo tra l’azienda e i lavoratori non pagati. «Avevamo saputo che c’era qualche problema, in particolare per il mancato pagamento di alcuni fornitori», dice Carmelo Barbagallo, segretario generale aggiunto della Uil. «Per cui abbiamo chiesto alla società di arrivare a una soluzione. Da parte nostra, però, siamo solo promotori del concerto, non ci occupiamo della gestione artistica. Quello che ci interessa è l’affidabilità dell’impresa e dal risultato finale mi pare ottima. Ma siamo anche sindacato, e se veniamo a conoscenza di qualche irregolarità, interveniamo, come è avvenuto». Cgil, sulla questione, ha preferito non rispondere. Dalla Cisl, invece, rispondono dicendo che i sindacati sono «solo i promotori e non gli organizzatori del concerto». In effetti i sindacati con l’organizzazione, soprattutto economica, del concerto non c’entrano proprio nulla. Cgil, Cisl e Uil, che quest’anno per la festa dei lavoratori hanno organizzato un corteo a Pordenone, dal 1990 scelgono l’impresa organizzatrice dell’evento e amen. Le tre sigle si trovano nel logo del concertone. Ma più di loro per il palco di piazza San Giovanni contano gli sponsor privati, che per metà, insieme alla cessione dei diritti alla Rai, garantiscono ogni anno la copertura economica del concertone. Per anni l’evento è stato sostenuto quasi esclusivamente da aziende a controllo statale: oltre alla Rai, Poste Italiane, Trenitalia ed Enel. «Sono quelli che si vedono ai lati del palco», spiega Godano, «gli sponsor più importanti sono Poste italiane, Gruppo Unipol, Eni e Banca Intesa, oltre ad alcuni sponsor tecnici di varia natura». Il sostegno del Comune di Roma, invece, messo in discussione negli anni precedenti dal sindaco Alemanno, che nel 2012 aveva presentato il conto ai sindacati chiedendo 240mila euro, «si concretizza per quanto riguarda i fondamentali servizi di pulizie dell’Ama, così come c’è un sostegno della Regione Lazio per la parte sanitaria, il 118 e la guardia medica. Non dimentichiamo che c’è una piazza con centinaia di migliaia di persone». Ma l’austerity vale anche per il concertone, e anche quest’anno ci saranno altri tagli al budget, che si aggirerebbe su per giù intorno agli 800mila euro. Il 20 aprile, a pochi giorni dalla festa di piazza San Giovanni, Godano dichiarava al Tempo: «Anche quest’anno non sappiamo quanti soldi abbiamo». Dal 2008 a oggi, tra sponsor e diritti tv, si sono persi circa tre milioni di euro. Per questo Godano chiedeva la costituzione di una «fondazione» per mano delle tre sigle sindacali. «Fa parte della situazione complessiva del Paese», taglia corto evitando polemiche, «che ci impone di fare scelte di sobrietà. Non ci lamentiamo: la forza del concertone è sempre stata la creatività, l’impegno, la competenza di quelli che ci lavorano, la generosità degli artisti e l’energia dei ragazzi della piazza. Un mix che non ci ha mai tradito, non abbiamo mai tradito e non tradiremo neanche quest’anno». Va detto, tra l’altro, che gli artisti sul palco percepiscono poco più che un rimborso spese. Grandi big a parte, che quest’anno - non a caso -sembrano latitare (qui l’elenco). Anzi, a vedere l’elenco, gli «avannotti» di cui parlano gli Elio e le storie tese nel loro Complesso del Primo Maggio sarebbero di più dei «pesci grossi». Eppure suona strano che per uno degli eventi live più grandi d’Europa non si sappia su quale budget si possa contare fino a pochi giorni prima. Si naviga a vista, insomma. «Bisognerebbe poter programmare dal 2 maggio quello che succederà l'anno dopo», dice Godano. «Purtroppo fino ad oggi non è stato possibile. Ci vorrebbe un provvedimento ad hoc per sostenere il concertone, che ha un valore sociale importante». Provvedimento ad hoc che, viene naturale ipotizzare, dovrebbe arrivare dai sindacati, che sotto l’evento continuano a metterci la firma. Anche se, precisa Godano, «rispetto al ruolo che hanno, i sindacati fanno abbondantemente il loro dovere». Con qualche piccolo incidente di percorso. Come quando due anni fa Fabri Fibra venne escluso dalla scaletta per via di presunti testi definiti «sessisti» dalle organizzazioni femministe. O quando nel 2007 i sindacati criticarono le parole del conduttore Andrea Riverasul Vaticano e il pm John Woodcock. Ma nonostante qualche incursione dei padroni di casa, con il sindacato e i lavoratori il concertone del primo maggio ha ormai poco o niente a che fare. Tra un pezzo e l’altro, a ricordare ai ragazzi danzanti «a torso nudo» (ancora citazione degli Elii) le radici “impegnate” dell’evento, ci pensa il tema scelto per l’edizione 2014: «Le nostre storie. Accordi e disaccordi delle nostre radici, della nostra memoria e del nostro domani».
LA FINE DELLA DEMOCRAZIA.
Da Bauman a Diamanti, viaggio al termine della democrazia. Avanza l’idea che con la globalizzazione sia finita un’epoca iniziata con l’Illuminismo. E dopo? Ecco le diagnosi, scrive Wlodek Goldkorn il 29 dicembre 2016 su "L'Espresso". Come il romanzo e la borghesia, i due migliori prodotti della modernità occidentale, anche la democrazia da quando esiste è in crisi: si interroga sempre e in continuazione su se stessa mentre lotta per la propria (non garantita) esistenza. Questa volta però, nel quarto lustro del Ventunesimo secolo, forse non siamo più a una qualche correzione di rotta e aggiustamento delle procedure. Molti studiosi concordano ormai sull’ipotesi che siamo nel “dopo la democrazia”. O meglio, avanza l’idea che qui in Occidente sia finita la democrazia come l’abbiamo conosciuta e immaginata a partire dal Secolo dei Lumi e fino alla globalizzazione. E ancora, fin dall’irruzione dei partiti di massa sulla scena politica (una forma di “parlamentarizzazione” della lotta di classe, altrimenti cruenta perché i proletari erano trattati alla stregua di “selvaggi” come i popoli colonizzati; e basti pensare a Bava Beccaris o al massacro dei comunardi di Parigi) a partire dall’ingresso dei partiti socialisti nel gioco parlamentare dunque, eravamo convinti che ci fosse un nesso intimo tra le seguenti categorie: progresso, libertà, democrazia, crescita economica, scolarizzazione di massa, emancipazione. Le cose andavano insieme, più libertà e più consumi; più democrazia e maggiore crescita economica e personale e via coniugando. Certo, le guerre mondiali e i fascismi hanno segnato dei passi indietro, ma dal 1945 regnava in Occidente una specie di stabile e progressiva convergenza tra il liberalismo e la socialdemocrazia (due avversari storici): più profitti e più uguaglianza, più libertà e più garanzie dei lavoratori e fino all’apoteosi, quasi hegeliana, dei diritti umani nel 1989. Poi, all’improvviso tutto è finito. I nostri figli vivranno peggio di noi; il voto non stabilisce legame tra gli eletti e i cittadini; il lavoro è precario quando c’è; e il futuro appare come una minaccia angosciante e non più come promessa e magnifica immaginazione. Del progresso nessuno parla se non per dire che è “cane morto” e illusione del passato, il sol d’avvenire è spento e i politici sembrano figuri grotteschi, dediti a celebrare riti vuoti dal punto di vista semantico, perché incapaci di suscitare un motto di identificazione con chi ci dovrebbe rappresentare (e basti pensare all’immagine delle consultazioni quirinalizie poche settimane fa). E allora, cosa ci aspetta? L’abbiamo chiesto a studiosi, filosofi, scienziati della politica. A partire da Zygmunt Bauman. Ma prima di sentirlo, due ulteriori premesse. Nel 1991 Christopher Lasch, storico americano scomparso ventidue anni fa, in un libro “Il paradiso in Terra” (Neri Pozza) in cui dava addio all’illusione appunto del progresso, citava un’osservazione di George Orwell (del 1940) per cui mentre le democrazie offrirebbero agiatezza e assenza di dolore, Hitler offriva lotta e morte; e ancora, nell’ultimo anno dell’Ottocento, Georg Simmel, sociologo tedesco cantore della metropoli con il suo caos e il denaro come la misura di tutto, diceva di comprendere comunque i laudatori dei valori all’antica e dei gesti eroici. E allora, anche oggi, di fronte alla Babele del pianeta globalizzato, stiamo cominciando (sotto le mentite spoglie dei populismi) a rivalutare il valore della comunità chiusa, isolata e retta da un uomo forte? La risposta di Bauman è sì. Il sociologo parte dalla nozione di “retrotopia”, utopia retroattiva: richiamo a un passato mitico, inventato e che si presenta come la più seducente possibilità di fuga dalla angustie di un incerto presente. La retrotopia spiega per esempio il successo di Trump. Il presidente eletto non ha offerto, appunto, alcuna visione di un futuro migliore, di avanzamento della condizione della gente (come un Roosevelt o un Kennedy): il suo messaggio è invece quello di ripristinare il “glorioso” passato degli States rurali e proletari, non contaminato dal linguaggio politicamente corretto delle élite mondializzate, attente alle “regole”; regole incomprensibili però per l’uomo comune che così si sente escluso e non all’altezza di competere per il proprio posto al sole. Le élite politiche, a loro volta, non sono in grado di mantenere le promesse fatte. E non lo sono perché abbiamo a che fare con «il divorzio tra il potere e la politica». Il potere è sempre meno legato al territorio, sempre più rappresentato da entità astratte e immateriali (banche, finanza, mercati). Tutto questo crea frustrazione, ricerca del colpevole, del capro espiatorio, desiderio di tornare dalla “condizione cosmopolita” (teorizzata già oltre un secolo fa da austromarxisti e da socialisti del Bund ebraico) verso una comunità chiusa e dove è possibile un’illusoria ed estrema semplificazione. Chiusura e semplificazione (accresciute dalla paura dei migranti) che si trasformano nel desiderio di un “uomo forte”. Dice Bauman: «Forse la parola democrazia non sarà abbandonata, ma sarà messa in questione la classica tripartizione di potere tra l’esecutivo, il legislativo e il giudiziario». Addio, dunque Montesquieu: porte spalancate a possibili forme dittatoriali. Anche perché, «perfino la speranza è stata privatizzata». Ma forse Bauman, non teorico dell’azione, ma critico dell’esistente è troppo pessimista (in realtà, in privato ammette di sperare in una rinascita della sinistra cosmopolita). Forse occorre aggrapparsi alle parole di Chantal Mouffe, belga, celebre per i suoi studi sul populismo e sul concetto dell’egemonia, quando parla della necessità di tornare a una sinistra antagonista e che rigetti il compromesso liberal-socialdemocratico. O forse ha ragione Pierre Rosanvallon, politologo francese, tra i più rinomati che va ripetendo che non siamo più in democrazia (“Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia”, “Le Bon Gouvernement”) e propone misure concrete di resistenza. Tra queste: sorvegliare, vigilare, controllare il potere e «parlar chiaro e dire la verità». E con quest’ultima parola d’ordine torna alle ricerche di Michel Foucault sulla “parresia”, il dire ciò che si pensa dei Greci ai tempi di Pericle, virtù cittadina e mezzo di opposizione alle tentazioni di ogni tirannide. Fin qui la speranza, perché Rosanvallon dice anche che la vecchia idea di un parlamento che legifera e un governo che esegue non esiste più, perché il potere politico è ormai in mano all’esecutivo e cresce la voglia di presidenzialismo ovunque. Gli fa eco David Van Reybrouck, uno studioso che arriva a teorizzare il sorteggio di persone chiamate a decidere delle cose della politica, come avveniva appunto ad Atene, tanto da aver scritto un libro intitolato “Contro le elezioni” (e aggiunge: «Gli eletti sono élite»). Dice Donatella Di Cesare, professoressa di Filosofia teoretica a La Sapienza e femminista con forti tendenze anarchiche: «La democrazia è l’ultimo tabù. Nessuno osa metterlo in questione, eppure bisogna cominciare a farlo se non vogliamo la catastrofe e se desideriamo preservare le nostre libertà». Indica l’America per dire: «La democrazia sta diventando dinastia». E allora che fare? «Rendere la democrazia più femmina e meno maschio. Accettare, in questi tempi di mondializzazione e di flussi di migranti, una sovranità limitata, condizionata, distaccata dall’ossessione identitaria, aperta invece ad Altri. Chi esalta la sovranità rigida, finirà per rinunciare alla libertà in nome appunto della mera sovranità. Io lo temo». Lo teme pure Jan Zielonka docente a Saint Antonys College, a Oxford, alla Cattedra intitolata a Ralph Dahrendorf, per decenni pontefice massimo del liberalismo. Da Varsavia, dove si trova in vacanza, al telefono conferma: «Sta vincendo la controrivoluzione. Certo, l’ondata controrivoluzionaria avanza grazie a elezioni e non con putsch militari o barricate, ma pensare che si possa tornare indietro verso il rassicurante mondo della democrazia liberale è una follia». A questo punto non resta che fare un po’ di ordine e ripetere la domanda: che fare? La parola va a Emmanuel Todt, personaggio geniale, controverso, poliedrico, storico «della lunga durata» (così si autodefinisce), che prima di esplicare il suo pensiero ci tiene a presentarsi come prosecutore delle tradizioni della «vecchia borghesia israelitica patriottica». Usa questa definizione desueta per sottolineare la sua impermeabilità alle mode identitarie, perché poi difende una certa idea di identità. Otto anni fa Todt pubblicò un libro intitolato “Après la démocratie” (dopo la democrazia). Oggi dice: «La storia dell’Occidente non coincide con la storia della democrazia». E anche: «La democrazia era legata alla diffusione del sapere a alfabetizzazione delle masse», per arrivare ad affermare: «Oggi invece le élite, minacciate da un popolo ormai in grado di leggere e scrivere cercano di stabilire comunque la differenza culturale. E così tradiscono la democrazia, dicendo che chi vota Trump o Brexit è ignorante». Rimarca: «La democrazia comunque non esiste più. È morta assieme alla globalizzazione e all’euro, ai flussi migratori incontrollati. Se io non sono padrone della moneta e del territorio, non posso esercitare i miei diritti democratici». Ripete: «Non sono uno xenofobo, ho in odio il Front national, ma mi preme dire ciò che penso». E allora, davvero è finita la democrazia? Conclude Ilvo Diamanti. Che dice due cose fondamentali. La prima: la democrazia è una forma di potere, di “cratos”, non può dunque essere parziale e deve anzi corrispondere a un territorio abitato e gestito da una popolazione di cittadini (una constatazione non del tutto ovvia ai tempi del mondo globale). In altre parole: la responsabilità, principio della democrazia contempla la delimitazione, quindi l’esistenza dei confini. La seconda: la forma della democrazia corrisponde alla tecnologia della comunicazione. Ai tempi dei notabili, l’arena era il parlamento e i partiti nascevano nelle Aule delle assemblee, elette per lo più per censo. Poi sono subentrati i partiti di massa e si è passati alla piazza e ai giornali. Lo stadio successivo è stata la personalizzazione e il leaderismo e siamo alla tv. Oggi a queste forme (nessuna del tutto scomparsa) va aggiunta la Rete. E siamo alla “democrazia ibrida”. Aggiunge: «La Rete permette qualcosa che assomiglia alla democrazia immediata, dove la deliberazione e l’esecuzione avvengono contestualmente. Ma la democrazia ha bisogno delle mediazioni, là dove invece è immediata e radicale (come nell’utopica visione giacobina o ad Atene del V secolo avanti Cristo) tende ad abolire se stessa». La abolirà? «Penso», risponde, «che vivremo in un mix tra democrazia mediata e immediata». E non è un futuro rassicurante.
La democrazia? E' viva e lotta insieme a noi. "L’elettorato protesta contro l’establishment, non contro il metodo democratico. Siamo scontenti delle scelte immediate dei nostri governanti, delle loro politiche. Ma non vedo all’orizzonte forze che seriamente vorrebbero rovesciare il sistema democratico". Il controcanto di Bernard Manin, scrive Wlodek Goldkorn il 29 dicembre 2016 su "L'Espresso". Bernard Manin, 65 anni, marsigliese, professore alla New York University e a L’École des hautes études en sciences sociales di Parigi, è considerato uno dei massimi studiosi dei sistemi politici e della loro storia. Autore del fondamentale “Principi del governo rappresentativo” (il Mulino), da anni parla dell’evoluzione della democrazia verso un “democrazia del pubblico”, dove non sono più i partiti con i loro apparati a scegliere i leader, ma l’ascesa e la carriera dei politici dipende dal loro rapporto con i potenziali elettori, rapporto talvolta diretto, talvolta mediato attraverso i mezzi di comunicazione.
Ha ancora senso parlare della democrazia?
«Sì. Penso che la forma che diamo a questo tipo di sistema politico cambia con il tempo. Ma non è esaurita. La democrazia ha un interessante futuro davanti».
Manca però il dibattito ponderato, razionale e dove alla fine gli elettori votano a seconda delle convinzioni e interessi ben compresi. Oggi, qualunque governo perde comunque qualunque referendum. La classe politica non ci rappresenta più?
«Non confonderei quello che è un fenomeno del tempo breve con i tempi lunghi della storia. L’elettorato protesta contro l’establishment, non contro il metodo democratico. Siamo scontenti delle scelte immediate dei nostri governanti, delle loro politiche, intese come “policy”, come soluzioni concrete. Ma non vedo all’orizzonte forze che seriamente vorrebbero rovesciare il sistema democratico, e cioè il fatto delle elezioni periodiche, dell’autonomia degli eletti e degli elettori e della libertà di esprimere le proprie opinioni ed esigenze».
E lo scontento?
«È dovuto alla globalizzazione. In quel processo ci sono i vincitori e gli sconfitti. La democrazia non è in grado di venire in soccorso ai perdenti. E questo è un problema».
E allora che fare?
«Non parlare della post-democrazia; non cedere alle utopie di stampo retrò e romantico; continuare a credere nei valori dell’Illuminismo e insistere sull’importanza dell’uguaglianza, della partecipazione e della libertà di parola. In altri termini: dobbiamo resistere, per migliorare la qualità delle nostre democrazie e non affossarle come fanno invece coloro che parlando della “postdemocrazia”. Ricordiamoci di cosa era il secolo scorso. Se la democrazia non è morta allora, vuol dire che ha una vita lunghissima davanti».
Colin Crouch: "L’illusione della rivolta apre le porte ai dittatori". Ha descritto un mondo in mano alle élite dove al popolo era concessa solo la “finzione” del voto. «Ma oggi è molto peggio». Parla il sociologo che ha inventato la parola “postdemocrazia”, scrive Marco Pacini il 29 dicembre 2016 su "L'Espresso". Peggio, oggi è peggio». Forse Colin Crouch non immaginava di giungere a una conclusione così perentoria a soli 13 anni di distanza dal mondo che descriveva in “Postdemocrazia”: un titolo, ma soprattutto una definizione destinata a entrare nel lessico politico in modo stabile. Perché quel mondo, analizzato dal sociologo e politologo inglese nel fortunato saggio del 2003, era già l’esito di un declino; e la sua era la diagnosi di un male oscuro che colpiva i gangli vitali di un sistema che l’Occidente, ma non solo, sembrava aver eretto a paradigma universale e insostituibile dalla seconda metà del Novecento. Se 13 anni fa Crouch metteva in guardia contro il sorgere di sistemi statali saldamente nelle mani della nuova aristocrazia delle grandi imprese, concludendo che alle élite non serve una dittatura per esercitare il potere, oggi il risorgere dei nazionalismi e l’emergere di leader sempre più “democratori” lo costringono a correggere in senso peggiorativo alcune delle sue analisi-previsioni. «Il mondo di Hitler potrebbe non essere così lontano», titolava nel marzo scorso The Guardian online un lungo stralcio sulla crisi delle democrazie firmato Timothy Snyder, storico di Yale. E se pur non arriva a tanto, Crouch oggi non fa fatica e evocare con l’Espresso i nomi di Hitler e Mussolini. «Questi movimenti populisti e nazionalisti - spiega il sociologo - sono una rivolta contro la postdemocrazia che analizzavo. Ma secondo me conducono verso qualcosa di peggio della postdemocrazia. Forse il caso italiano, e mi riferisco al Movimento 5stelle, è ancora parzialmente diverso. Ma quando osserviamo i nuovi movimenti populisti in Paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, quello che emerge è un conflitto profondo tra ragione ed emozione, un rifiuto del ragionamento. Forse la politica democratica nella postdemocrazia era ancora politica, senza un prevalere delle passioni, delle emozioni; era piuttosto dominata da dati, ragioni economiche, tecnologia. Ma conservava qualcosa di democratico».
In “Postdemocrazia” lei scriveva che “la massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apatico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve, e a parte lo spettacolo della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato dall’integrazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici”. Oggi è la rabbia, più che l’apatia, a dominare la scena, con esiti imprevedibili.
«Ciò a cui assistiamo prende la forma di una rivolta delle emozioni. Come avvenne in Europa negli anni 20 e 30 con Mussolini e Hitler. Ripeto: oggi è peggio. Assistiamo a una rivolta contro certi meccanismi postdemocratici che è ancora più postdemocratica. Perché non è il popolo che trionfa, ma certi leader che manipolano le emozioni e le paure del popolo. Non si tratta affatto di una rivolta contro le élite. Trump è un esempio perfetto di questa post-postdemocrazia. La politica delle emozioni che i Trump incarnano segna una svolta ancora più accentuata verso un “dopo” rispetto alla democrazia. E a questo processo partecipa anche l’informazione. Basti pensare a certi media online negli Usa e ad alcuni tabloid britannici che soffiavano sulla rivolta della Brexit attaccando pesantemente il ruolo dei giudici e del parlamento».
Dovremmo parlare allora di psicopolitica più che di politica, come suggerisce qualche filosofo?
«Psicopolitica è un termine pertinente per descrivere i fenomeni in atto. Io sono un sociologo, ma credo che oggi sociologia e psicologia debbano incontrarsi, procedere insieme nell’analisi dei processi politici. Perché il background delle azioni politiche spesso si chiama paura. Nient’altro che paura».
Chiamiamo populismo il vento che soffia sull’Occidente. Uno stesso clima che ci fa assimilare l’elezione di Donald Trump alla Brexit, e ora anche all’esito del voto nel referendum in Italia sulla riforma della Costituzione, benché in questo caso il voto anti-establishment sarebbe stato il Sì, secondo la campagna condotta dall’ex premier anche con toni populisti. Sviste degli analisti e degli osservatori? Semplificazioni?
«In effetti è apparentemente molto paradossale e contraddittorio quello che è accaduto in Italia. Ma al fondo di tutto c’è la parola rivolta. Il caso italiano è più complicato. Quella che veniva presentata come la “sostanza” del referendum pochi l’hanno vista. Ed è normale che in Italia se uno vuole troppo... poi susciti questo tipo di reazione. Ma nell’esito del voto, in generale, c’è dell’altro: dall’antieuropeismo all’immigrazione. È una rivolta del No generica. Accade nel mondo in generale, dalla Scandinavia all’Ungheria, alla Polonia; e ora anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Sembra che ci siano molte persone oggi che si sentono escluse dalla modernità. Non è stato un caso che gli elettori a favore della Brexit fossero in gran parte anziani. Al di là del merito specifico sul quale si chiede agli elettori di pronunciarsi, ciò che sembra prevalere, la vera divisione, è tra rifiuto e accettazione del mondo moderno. E il punto più forte di questa divisione riguarda l’immigrazione. Trump ha usato molto la paura dell’islam benché avesse pochissimo a che fare con i principali temi delle presidenziali. E nel voto sulla Brexit è accaduta la stessa cosa: non è razionale, è emozionale. E dobbiamo chiederci che cosa significa, dove porta. Il ruolo, la paura dell’Islam, fanno sempre parte del dibattito, magari sottotraccia. Ma ogni giorno arriva sempre più in superficie. Dopo il referendum sulla Brexit ho visto nel mio Paese un mutamento profondo, una nuova legittimazione del razzismo fino al moltiplicarsi di attacchi e aggressioni contro le persone di fede islamica».
È la fine del modello, o dell’illusione, multiculturalista?
«Siamo tutti divisi. Nel mondo islamico ci sono molte persone che vogliono vivere pacificamente insieme, che credono che possiamo condividere la cultura, cosa che la razza umana ha fatto da sempre. Per esempio, è fondamentale nella cucina italiana il ruolo del pomodoro, ma il pomodoro non è italiano, viene dall’America. Noi possiamo fare ancora questo con la cultura islamica. Ma ci sono molti altri che vogliono il conflitto. C’è una guerra in atto, ma più che tra Occidente e mondo islamico è una guerra tra chi crede che sia possibile la convivenza e chi no. Le nuove onde populiste non la accettano. Come non accettano il ruolo delle istituzioni delle democrazie. Questi aspetti, insieme, sono l’anticamera delle dittature. In molti Paesi assistiamo all’avanzata di movimenti populisti e alla retorica degli anni 20 e 30. Anche in Russia sta accadendo da tempo... Che accadesse degli Stati Uniti non potevano aspettarcelo. Ora più che mai abbiamo bisogno dell’Unione europea. Oggi che la “testa” americana sta con la Russia... E stanno insieme perché c’è una visione comune profondamente di destra. Questo è un grande cambiamento nel mondo».
Nei suoi lavori successivi a “Postdemocrazia” (“Il Potere dei giganti” e “Quanto capitalismo può sopportare la società”), lei si occupa a fondo delle disuguaglianze crescenti. Come e quanto hanno inciso all’interno delle società occidentali nello sfaldamento delle democrazie. E perché portano a destra?
«Già, è un fenomeno interessante. Finalmente è arrivata una rivolta contro la disuguaglianza... ma prende una forma politica di destra estrema, condita di razzismo. Così oggi abbiamo il confronto tra due opzioni di destra in molti Paesi: la destra neoliberale contro la destra populista e xenofoba. Queste due destre sono nemiche. E con un’idea di democrazia sociale molto debole, in questa fase sono i neoliberali che devono scegliere. Normalmente preferiscono i compromessi con la destra nazionalista. Ma forse adesso trovano che i loro nemici profondi sono le estreme destre. Perciò solo un compromesso tra la democrazia sociale e i neoliberali potrebbe essere l’argine. Solo coalizioni così potrebbero salvare le democrazie da derive autoritarie».
Se la democrazia finisce, cosa c’è dopo?
«Ci sono molte discussioni sulla democrazia diretta, come evoluzione della democrazia che conosciamo. Ma i referendum dimostrano che quando il popolo ha un’occasione per parlare c’è un potere di interpretare la “voglia” del popolo senza discussione parlamentare, senza filtri. La democrazia è solo un voto e il ruolo delle istituzioni viene quasi cancellato. E questa, ripeto, è la strada verso la dittatura. Perciò la risposta è: dopo la democrazia c’è solo la dittatura».
La falsa lezione di chi dice che la democrazia è falsa. Lo storico Emilio Gentile sembra scoprire solo ora i vizi del sistema di governo preferito in Occidente, scrive Dino Cofrancesco, Venerdì 30/12/2016, su "Il Giornale". «Storico di fama internazionale», Emilio Gentile si cimenta con la political theory, nella collana Idola dell'editore Laterza nata per smascherare i falsi ideologici di ogni tipo (non è vero che in Italia paghiamo troppe tasse, che dobbiamo restituire fiducia ai mercati, che senza proprietà non c'è libertà, che il matrimonio omosessuale è contro natura, che l'Islam è una minaccia etc.). In democrazia il popolo è sempre sovrano. Falso! (così s'intitola il suo saggio). Sarà anche vero che si tratta di un falso, ma tutto dipende dalle definizioni che si danno di democrazia, popolo, sovranità, come potrebbe obiettare Sancho Panza, memore della critica feroce che il democratico Rousseau rivolgeva alla perfida Albione: «Il popolo inglese ritiene di esser libero: si sbaglia di molto; lo è soltanto durante l'elezione dei membri del parlamento. Appena questi sono eletti, esso è schiavo, non è nulla». Per Gentile, in verità, è falsa quella che lui chiama la «democrazia recitativa», un'espressione da cui si ripromette, forse, un posto in quella secolare storia delle forme di governo che da Erodoto giunge a Montesquieu e oltre. «Oggi - scrive lo storico/filosofo politico sembra che l'ombra dell'ipocrisia democratica si vada estendendo con la rappresentanza scenografica di una democrazia recitativa, che ha per palcoscenico lo Stato, come attori protagonisti i governanti, e come comparsa occasionale il popolo sovrano, che entra sul palco solo per la scena delle elezioni mentre per il resto del tempo assiste allo spettacolo come pubblico». Sennonché cosa c'azzecca la recita, per parlare come un quasi conterraneo di Gentile? A teatro compare Alfio ammazza per finta compare Turiddu, ma a ogni elezione politica il popolo - sovrano solo nel momento in cui viene chiamato alle urne - non sostituisce Prodi a Berlusconi o viceversa per finta, e non importa l'indice di partecipazione o la competenza dei votanti. In sostanza, Gentile non dice assolutamente nulla di nuovo rispetto alle severe diagnosi che della democrazia dei contemporanei avevano già fatto sociologi e scienziati politici come S.N. Eisenstadt (Paradossi della democrazia, Il Mulino) e, soprattutto, C. Crouch (Postdemocrazia, Laterza). Il degrado della comunicazione politica di massa, la crescente personalizzazione della politica elettorale, la concentrazione del «potere politico nelle mani di una minoranza di governanti, legati a potentati economici e finanziari, quando non sono gli stessi esponenti di questi potentati a diventare governanti grazie a un elettorato sul quale ha avuto effetto» una «martellante campagna pubblicitaria», le sfide della globalizzazione economica e culturale, i nuovi antagonismi culturali, etnici, nazionalisti, religiosi, il declino del Welfare State e quella che un tempo si chiamava la «crisi fiscale dello Stato»: sono fenomeni fritti e rifritti in tutte le salse e non è certo l'invenzione della «democrazia recitativa» a darne una definitiva sistemazione concettuale. Il problema diventa serio quando si tenta (almeno) di individuare non le cause ma i mutamenti istituzionali che hanno reso quei fenomeni comuni dal più al meno - a tutti i Paesi delle due rive dell'Atlantico. Ma su questo piano il demistificatore del nuovo falso si chiude in un poco dignitoso silenzio. Non solo non viene mai fuori il nome di Giuseppe Maranini, un lucido analista della partitocrazia e della sua genesi, ma neppure si accenna a storici come Renzo De Felice o Rosario Romeo i quali avevano meditato sulla crisi della democrazia e sul suo nesso con la crisi della nazione, una tematica oggi al centro di autori come Pierre Manent, Yakov M. Rabkin, Roger Scruton. Inoltre meraviglia non poco che nell'analisi del berlusconismo lo storico non accenni neppure alle ragioni reali del suo successo ma si limiti a far suo il giudizio dell'Economist (aprile 2001) sull'uomo «inadatto a governare l'Italia» o che metta alla gogna quanti vorrebbero dare maggior potere all'Esecutivo, dimenticando che la Costituzione è stata criticata per mezzo secolo per aver riguardato il capo del governo come un primus inter pares alla mercé di un legislativo pletorico, bicefalo e (giacobinamente) onnipotente. Si ha l'impressione, in realtà, che Gentile abbia appena sfiorato l'universo liberale. Parlando della democrazia greca, a esempio, la definisce una «democrazia diretta», ma guastata da un demos che non comprendeva donne, schiavi e meteci, senza dire che, per i moderni (Benjamin Constant docet), il suo peccato di origine stava piuttosto nella mancanza di limiti alle competenze del popolo sovrano. In un'altra pagina, scrive che Tocqueville fu affascinato dall'esperimento democratico americano in cui il popolo «è la causa e il fine di ogni cosa: tutto esce da lui e tutto finisce in lui», ignorando che ad affascinare Tocqueville non era il popolo che «regna nel mondo politico americano come Iddio regna dell'universo» ma il fatto che «I repubblicani negli Stati Uniti apprezzano i costumi, rispettano le credenze religiose, riconoscono i diritti. Essi professano l'opinione che un popolo deve essere morale, religioso e moderato in proporzione alla sua libertà. Ciò che si chiama repubblica negli Stati Uniti è il regno tranquillo della maggioranza. (...) Ma la maggioranza, di per se stessa, non è onnipotente. Al di sopra di essa, nel campo morale, si trovano l'umanità, la giustizia e la ragione; nel campo politico, i diritti acquisiti». Ancora una volta, i limiti! Forse all'origine della crisi profonda della democrazia c'è una political culture che scarica sullo Stato ogni tipo di bisogni, ogni disagio individuale e collettivo, in linea con l'evergreen «piove, governo ladro!».
Grillo svela il programma: autarchia, decrescita e povertà felice, scrive Piero Sansonetti il 27 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". Beppe Grillo con due interventi ci ha offerto finalmente il suo programma. Nel primo si è pronunciato per l’espulsione dei clandestini dall’Italia. Nel secondo – citando Goffredo Parise – per la “povertà” e la decrescita come valore e come prospettiva di diversa modernità. Difficile non provare simpatia per il pianto di Virginia Raggi, all’incontro con la Caritas di Roma. Il pianto in pubblico non è una vergogna o una debolezza: è un modo di comunicare. Finalmente questa contestatissima sindaca di Roma ci comunica qualcosa di comprensibile: la difficoltà, la paura di non farcela, il disappunto per gli errori. Finora sembrava chiusa in una gelida torre blindata, lontana dalla gente, dai problemi, dai programmi. Adesso sappiamo che c’è. Non se è brava, se avrà successo, se servirà alla città: però almeno sappiamo che c’è. E questo un pochino ci rassicura. Ma il Movimento 5 stelle, a Natale, non ci ha regalato solo le lacrime tenere della Raggi. Anche un’altra cosa, che mancava da tantissimo tempo: il proprio programma politico. Finora avevamo capito solo che il movimento proclamava l’esigenza dell’onestà e la necessità di demolire il vecchio sistema politico. Avevamo dei dubbi sull’ utilità di demolire un sistema politico senza averne a disposizione un altro, mentre apprezzavamo l’inno all’onestà, ma francamente ci sembrava un valore “debole”, se preso da solo, e non in grado di alimentare un programma di governo o di riforma. Nelle ultime ore Beppe Grillo in persona, con due brevissimi interventi, ci ha offerto un programma politico – non so se di governo o solo di opposizione – che ha una sua solidità. Il primo intervento è stato quello nel quale si è pronunciato per l’espulsione dei clandestini dall’Italia, allineandosi su questo terreno alle posizioni della destra classica e in contrasto aperto col Vaticano. Il secondo intervento – illustrato da un bellissimo articolo di Goffredo Parise del 1974 – è stato quello a favore della “povertà” come valore e come programma. L’idea che ci propone Grillo – attraverso l’analisi spietata e suggestiva di Parise – è quella di ricostruire l’Italia ripartendo dall’inizio, e cioè mettendo tra parentesi i risultati – positivi e negativi – della ricostruzione postbellica, del boom economico degli anni sessanta, e poi delle riforme degli anni settanta e della gestione per metà liberista e per metà socialdemocratica dei decenni successivi. Ripartire da zero mettendo in discussione tre elementi che sono stati nel Dna di questi settant’anni di storia nazionale: il consumismo, lo sviluppismo e l’omologazione. La trasformazione che ci proponeva – quarant’anni fa – Goffredo Parise era un “ritorno indietro”. Attraverso una scelta di decrescita e di autarchia. Riduzione drastica dei consumi, redistribuzione delle ricchezze, appianamento verso il basso delle diseguaglianze, ritorno ai valori di una comunità contadina. Fine della predominanza dell’economia e della produzione di massa. La filosofia politica della decrescita è tornata di attualità qualche anno fa – nei primi anni di questo decennio – quando le varie anime del movimento cosiddetto no- global si sono opposte frontalmente alla globalizzazione delle multinazionali (che poi ha preso probabilmente una via molto diversa da quella che si era immaginato). Filosofi e politologi americani, sudamericani ed europei l’hanno studiata e predicata. Il più noto e il più completo probabilmente è il francese Serge Latouche. Ma l’idea anticonsumista non è nuovissima. In parte accompagnò lo sviluppo del sessantotto – arricchita persino da spinte di luddismo, e cioè di attività violenta volta a distruggere le macchine e le strutture dell’industria e quindi dello sviluppo – in parte, qui in Italia, diventò l’anima della politica del Pci berlingueriano, proprio negli anni immediatamente successivi a quelli nei quali scriveva Parise. La svolta fu sancita da un convegno importantissimo, organizzato dal Pci coi suoi intellettuali (che allora erano la parte prevalente e anche la più potente dell’intellettualità italiana) nel gennaio del 1977 ( esattamente 40 anni fa) al teatro Eliseo di Roma. In quella sede il segretario del Pci ( poche settimane prima dell’esplosione del movimento giovanile che si chiamò, appunto, il movimento del ‘ 77, e che culminò con la cacciata dall’università di Roma, in febbraio, del capo della Cgil Luciano Lama) tenne un discorso nel quale proclamò la necessità, anche per la classe operaia, di fare sacrifici e di rinunciare ad alcuni lussi e a parte della propria ricchezza per diventare la guida di un processo di profonda trasformazione che avrebbe prodotto un “modello di sviluppo” diverso dal modello industrialista e capitalista. Berlinguer concepì questa nuova linea politica – che camminò con gambe robuste dopo che la Cgil, in una famosa conferenza tenuta al palazzo dei congressi dell’Eur, fece prevalere al suo interno la linea dei “sacrifici”, che rovesciava la politica degli aumenti salariali dell’autunno caldo – anche per creare le condizioni di un accesso del Pci al governo ( accesso che non avvenne mai, anche se il Pci nel 1978– 1979 condizionò fortissimamente le riforme realizzate dal governo Andreotti, al quale, per la prima volta dopo il 1947, aveva concesso il voto di fiducia). Lo scritto di Parise – che in parte riprendeva idee già espresse da Pier Paolo Pasolini – anticipava la svolta del Pci. Era una ipotesi ragionevole di ingresso in una diversa modernità? Le opinioni sono tutte legittime e ragionevoli. Grillo oggi si schiera per la ripresa di quella strada, autarchica e antiprogressista. Che taglia in due le ideologie di destra e sinistra, le esclude entrambe, e sfida l’establishment e anche la storia. E’ una buona notizia. Adesso sarà più semplice confrontarsi con l’onda grillina. Nei suoi aspetti di destra e in quelli di sinistra. E anche nel suo affascinante e rischiosissimo antimodernismo. P. S. A me capita, ogni volta che dichiaro pubblicamente la mia idea “aperturista” sull’immigrazione, e cioè la richiesta di aumentare l’accoglienza e non di concentrarsi sulle espulsioni, di sentirmi dire, molto polemicamente: «Ma perché non te li prendi a casa tua, gli immigrati?». Non li prendo a casa mia per due ragioni: primo perché casa mia è piccola, secondo perché io non credo che la politica dell’accoglienza debba essere realizzata individualmente dai singoli cittadini, ma invece dallo Stato, anzi dagli Stati, anzi, meglio, dall’Europa. Non credo che si possano contestare le idee di una persona imponendole di realizzare individualmente quelle idee prima di dichiararle. E’ una vecchia questione, che è stata sollevata tante volte negli ultimi secoli. Da quando i tribuni della plebe erano aristocratici…Dunque non penso che Grillo prima di proclamare la necessità di diventare tutti poveri, debba diventare povero anche lui. Però non si può negare che un problema – come dire? – estetico, si pone. Non so quanto guadagni Grillo. L’ultima volta che ho letto una sua dichiarazione dei redditi è stato qualche anno fa, e quella dichiarazione diceva che in un solo anno Grillo aveva guadagnato – mi pare di ricordare – circa 4 milioni e mezzo di euro. Che è circa il triplo di quello che io – che non sono povero – ho guadagnato in quarant’anni di lavoro abbastanza duro. Beh…
Come l’Italia è diventata un non-Stato, scrive Corrado Ocone il 29 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". Storia del declino del nostro Paese. Quante volte abbiamo ripercorso la storia degli ultimi settant’anni, la storia dell’Italia repubblicana? Eppure, devo dire che raramente mi è capitato di farlo con tanta soddisfazione finale come in questo caso, cioè dopo aver letto il denso e ampio libro di Piero Craveri intitolato L’arte del non governo. L’inarrestabile declino della Repubblica italiana (Marsilio, pagine 592, euro 25). Il fatto è che questo volume, rispetto ai molti altri, pure eccellenti, sul tema, dà alla fine l’impressione di far cogliere al lettore il cosiddetto bandolo della matassa, quello attorno a cui un po’ tutti i fili, di volta in volta messi in luce, finiscono per raccogliersi. Sarà forse perché Craveri riesce a connettere la storia politica a quella economico– sociale e anche a quella istituzionale– amministrativa; sarà forse perché quella che egli racconta non è una storia di “magnifiche sorti e progressive”, ma una storia appunto di “declino” (una storia vista col senno dell’oggi), fatto sta che, alla fine dell’itinerario, molte cose ci sembrano più chiare. Che il nostro Paese, come ma molto più di altri dell’Occidente, sia in discesa, è opinione comune, oltre che stato psicologico generale. D’altronde, i dati macroeconomici sono chiari e inoppugnabili. Quello che però altrettanto chiaro non è a tutti, e che questo libro contribuisce a chiarire, è che il declino data da molto lontano, era già presente in nuce negli anni in cui tutto sembrava andare per il verso giusto e l’Italia si era lasciata alle spalle la distruzione della guerra e aveva addirittura fatto ingresso nel ristretto club dei paesi più industrializzati e ricchi del mondo. Le scelte di allora, degli “anni del boom”, quelli a cavallo fra i Cinquanta e i Sessanta, o meglio le non scelte di cui parla Craveri nel titolo, erano già un segno della crisi, come qualcuno fra i più avveduti e responsabili esponenti della classe dirigente faceva allora presente. Craveri pensa in primo luogo a Ugo La Malfa, uno dei pochi protagonisti in positivo della sua storia, il quale non a caso veniva apostrofato come una “Cassandra”. Si può es- sere più o meno d’accordo con Craveri. Il sottoscritto, per esempio, lo è solo in parte, ed ha seri dubbi a che le ricette lamalfiane, basate su una sorta di “dirigismo liberale” e sull’idea guida della “programmazione economica”, fossero sempre le migliori e più auspicabili per il nostro Paese. D’altronde, se il “non governo”, proprio perché è una “arte”, è anche una virtù e non sempre e solo un vizio. I processi, anche quelli economici, vanno sempre un po’ lasciati a loro stessi, controllati e anche governati, ma governati in senso formale e non sostanziale, con leggi e regole di contesto non con norme di condotta rigide e predeterminate. Credo che anche l’idea di un primo momento d’oro e positivo della Cassa per il Mezzogiorno e di altre “partecipazioni statali” vada rivisto e circoscritto. Ma un conto sono le ricette, altra l’analisi. E da questo secondo punto di vista ha davvero ragione Craveri quando individua in La Malfa e in pochi altri le “teste lucide” della nostra storia politica. Soprattutto però egli ha ragione quando collega il declino di oggi, soprattutto ma non solamente economico, a quel groviglio di poteri dispersi e sovrapponentisi che hanno fatto dell’Italia un “non Stato”. Craveri colloca negli anni Sessanta i prodromi della crisi, quasi in coincidenza e sovrapposizione con l’apice del nostro miracolo (nel 1963 fu raggiunta la piena occupazione mentre qualche anno prima, nel 1959, la lira aveva conquistato lo scettro di moneta più forte). Io, fatto tesoro delle pagine di questo libro, mi spingerei a dire che gli anni ‘ 68, ‘ 69 e ‘ 70 sono quelli simbolicamente più significativi. il ‘68 è, in tutto il mondo, l’anno della contestazione, che però in Italia assume da un lato un carattere molto politicizzato, più marxista che libertario, e dall’altro allunga le sue propaggini fino agli anni più recenti. È una vera e propria frattura, culturale e generazionale, la quale coinciderà con la secolarizzazione dei costumi del nostro Paese, ma che pure costituirà un ulteriore tassello di quella “ideologia italiana”, tutto fuorché liberale, che permea la cultura e la mentalità comune ancora oggi (il primo era stato, negli anni immediatamente successivi alla guerra, quel collante fra le culture cattoliche, comuniste e azioniste che aveva dato vita all’ideologia dell’antifascismo). Il ‘ 68 avrà anche una propaggine terroristica nel decennio seguente, con tutta la crisi che ne consegue a livello di sistema politico soprattutto dopo il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, un contesto che Craveri illustra in pagine di indubbia efficacia. Il ‘69 è invece l’anno delle rivendicazioni sindacali, che si concretizzeranno in quella che presto diverrà un’altra palla al piede del nostro Paese: la ipersindacalizzazione della nostra società e, per converso, la politicizzazione del sindacato. A cominciare dalla CGIL, vissuta come una “cinghia di trasmissione” del PCI, che avrebbe poi portato entrambi a sbattere negli anni Ottanta sul referendum sulla scala mobile (ma prima ancora c’era stata a Torino la “marcia dei quarantamila” che certi equilibri aveva cominciato a rompere). Infine, il 1970 fu l’anno in cui il dettato costituzionale sull’istituzione delle regioni a statuto ordinario fu attuato con le elezioni dei primi consigli. Fu un modo per “consociare” sempre più al potere i comunisti, che negli enti locali erano in maggioranza. Si risolse tuttavia sempre più, soprattutto al Sud, in un nuovo e spesso incontrollato meccanismo di spesa. L’idea di diffondere il potere, piuttosto che controbilanciarlo, di evitare di individuare con precisione un responsabile unico e ultimo delle decisioni politiche, era d’altronde una facilmente prevedibile conseguenza dell’impalcatura costituzionale: della costituzione formale, non meno di quella materiale che si era andata con gli anni sedimentandosi. Per un liberale le regole sono il meccanismo per imbrigliare il potere, e sono quindi importanti. Nel nostro caso, la Grundnorm, la “nor- ma fondamentale”, che pur aveva una nobiltà e una ragion d’essere al suo esordio, non è stato certo elemento ultimo nell’impaludamento successivo del nostro sistema politico. Gli elementi per ricostruire questi snodi nel libro di Craveri ci sono tutti. Così come anche una descrizione dei generosi tentativi fatti, prima dell’ultimo referendum, per riformare la Carta. Molto ponderato è il giudizio, tutto sommato positivo, che Craveri dà di Craxi, così come quello, tutto sommato negativo, che dà dell’altro e successivo “grande riformatore” della politica italiana, quel Silvio Berlusconi di cui si mettono qui in chiara evidenza i limiti politici (nonché il conflitto di interessi) ma senza mai soggiacere alla retorica e all’inconsistenza sostanziale dell’antiberlusconismo di maniera. Appropriata è anche l’immagine, politicamente fallimentare, che viene fuori di Berlinguer e in genere di quel PCI che si è fatto travolgere dagli eventi non riuscendo a decidersi mai, fino alla fine della sua parabola, fra un’irrealistica “alternativa di sistema” e una compiuta socialdemocrazia. Un po’ forse troppo negativo invece il giudizio su Andreotti, la cui figura politica viene forse troppo appiattita su una cifra di cinismo e di mancanza di visione politica. Ad un certo punto, Craveri contrappone la concezione della politica di Andreotti a quella di Moro: per il primo, la politica deve riflettere e adeguarsi alla realtà; per il secondo la deve indirizzare. Craveri non ha dubbio che, giusta la sua idea di fondo del “non governo, Moro avesse ragione e Andreotti torto. Il che può concedersi, ma nella sola misura in cui riflettere gli umori di una società, anche quindi i peggiori, significhi assecondarli. È però da chiedersi, ancora una volta, se il dirigismo, in genere, sia la migliore ricetta, e se lo sia stato, in particolare, per l’Italia repubblicana. Molto importanti sono poi anche le pagine che Craveri dedica al tentativo delle più sensibili fra le élite italiane a provare a risolvere con un “vincolo esterno” i problemi più sostanziali della nostra economia, a cominciare dal “debito pubblico (destinato a crescere a dismisura dalla “crisi petrolifera” di metà anni ’ 70 fino ad oggi, tranne una breve parentesi negli anni ’ 80 di cui non si approfittò). Fu soprattutto Guido Carli che concepì questa politica e cominciò poi a mettere in pratica nel corso dei negoziati di Maastricht. Al fondo, c’era un’idea pessimistica sulla capacità dell’Italia di autocorreggersi, soprattutto di rivedere e diminuire la spesa pubblica (utilizzata a fini di consenso politico da una famelica classe politica nazionale e locale). Ancorarci all’Europa fu poi la parola d’ordine con la quale Ciampi e Prodi, attraverso un processo ben ricostruito da Craveri, ci portarono a entrare da subito nell’euro laddove sarebbe forse stato più opportuno aspettare un po’. Problemi seri, storici e di lunga data quelli dell’Italia, ci ricorda questo libro. Che lascia, non c’è dubbio, l’amaro in bocca a chi ancora tiene a questo Paese e non intravede vie d’uscita. In ogni caso, la capacità di legare i diversi aspetti della “vita materiale” della Repubblica è, come dicevo all’inizio, il grande merito di questo libro. Che va ad integrarsi con altri libri sullo stesso argomento usciti in quest’ ultimo anno, di tono meno pessimistico ma anche forse con qualche limite concettuale in più. Mi riferisco in particolare alla storia di Guido Crainz, uscita da Donzelli, e che molto si concentra più sulle mentalità e le visioni del mondo degli italiani (Storia della Repubblica. L’Italia dalla Liberazione ad oggi, pagine VII– 387, euro 27,009). E mi riferisco anche a quella di Agostino Giovagnoli, uscita per Laterza, che colloca la vicenda repubblicana in un orizzonte internazionale e di geopolitica, dando fra l’altro molto spazio ai rapporti del nostro Stato con la Chiesa cattolica e degli italiani col cristianesimo (La repubblica degli italiani. 19214– 2016), pagine 388, euro 24).
IL COMUNISMO, IL FASCISMO ED I 5 STELLE: LA POLITICA COL VINCOLO DI MANDATO.
Cose nostre sono…, scrive Piero Sansonetti il 18 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Probabilmente la sentenza del tribunale civile di Roma è tecnicamente ineccepibile. Dice due cose. Che Virginia Raggi poteva essere eletta sindaco, anche se aveva firmato quel contratto capestro con la ditta Casaleggio. E questo è ovvio: chi prende i voti dei cittadini è eletto e basta, e ci mancherebbe altro che il tribunale decida di farlo decadere. Poi dice un’altra cosa, più preoccupante, discutibile. «Cose nostre sono!» Così si privatizza la politica. E cioè respinge la richiesta avanzata da un cittadino di considerare nullo il contratto di sottomissione della sindaca, eletta dai romani, nei confronti forse del capo del suo movimento o forse addirittura degli amministratori di una azienda privata (appunto, la Casaleggio). È possibile che il tribunale civile non potesse fare altro. E cioè che avesse bisogno del ricorso della stessa Raggi, o di qualche altro eletto dei 5Stelle contro il contratto capestro. Dunque che non potesse per motivi giuridici prendere in considerazione il ricorso presentato invece da un esterno, cioè dall’avvocato Monello. Tuttavia questa sentenza apre un problema enorme. Sul piano dei principi. Lascia capire che il Movimento 5 Stelle oggi, e in futuro qualunque altro partito, ha un diritto di proprietà e di dominio sui propri eletti. E in questo modo cancella il valore dell’articolo 67 della Costituzione, il quale esclude il vincolo di mandato per i parlamentari. Cosa vuol dire “vincolo di mandato”? Vuol dire in parole povere “disciplina di partito”. Cioè è n meccanismo che impedisce la libera coscienza e il libero convincimento degli eletti, e impone loro di comportarsi, e di giudicare, e di pensare, e di dichiarare in linea con i vertici del loro partito. Il vincolo di mandato è stato abolito in Europa quando è nata la democrazia moderna. Perché considerato non solo uno strumento illiberale – che nega le caratteristiche essenziali della libertà politica – ma un modo per espropriare i cittadini del proprio potere di elettori, e dunque del controllo sugli eletti, assegnando questo potere esclusivamente ai vertici dei partiti. Nella storia della Repubblica italiana il vincolo di mandato di fatto – ha convissuto per lunghissimi anni con la democrazia, in modo ambiguo. La disciplina di partito che vigeva nel Pci, e anche nell’Msi (cioè nel partito più di sinistra e in quello più di destra dello schieramento parlamentare) era, seppure in forma attenuta, un vincolo di mandato. Che raramente fu violato. Alla fine degli anni 80, la caduta del comunismo, la fine del Pci, poi lo scioglimento anche del Msi, avevano posto fine a questa fase. Nella seconda Repubblica, che è stata una Repubblica forse pessima ma comunque liberale, il vincolo non ha avuto diritto di cittadinanza. Qual è la differenza tra il contratto dei 5Stelle e la disciplina del Pci? La differenza sta nei soldi. Nella assoluta e totale privatizzazione e monetizzazione dell’idea politica. Il contratto non è più un accordo ideale con un partito, che comunque risponde a una struttura democratica (come era il Pci e come era anche il Msi) ma l’accettazione di una subordinazione a una ditta privata, e a un capo onnipotente. Non si basa più su un patto d’onore, su una consuetudine e una idea condivisa. Si basa sul potere del denaro frusciante. E dunque non solo riduce la democrazia ai minimi termini ed espropria gli elettori, ma rende la politica un’attività di tipo commerciale. Non era il tribunale civile di Roma a poter risolvere questo problema. Perciò se la politica e l’intellettualità fanno finta di non vedere che il problema esiste si suicidano. Negli ultimi anni la politica ha perso moltissimi spazi, ceduti al potere economico e alla magistratura. Ora rischia di giungere all’auto- annullamento. Gli elettori diventano spettatori, i partiti sono spariti, i leader decidono, dispongono, ordinano, eventualmente pensano. Il partito di Renzi, quello di Berlusconi, quello di Grillo, quello di Salvini. Tutti gli altri chinano la testa e obbediscono. Poi dicono che a uno gli viene la nostalgia di Andreotti…
DEMOCRAZIA: LA DITTATURA DELLE MINORANZE.
La coperta corta e l’illusione della rappresentanza politica, tutelitaria degli interessi diffusi.
Di Antonio Giangrande Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Antonio Giangrande ha scritto i libri che parlano delle caste e delle lobbies; della politica, in generale, e dei rispettivi partiti politici, in particolare.
La dittatura è una forma autoritaria di governo in cui il potere è accentrato in un solo organo, se non addirittura nelle mani del solo dittatore, non limitato da leggi, costituzioni, o altri fattori politici e sociali interni allo Stato. Il ricambio al vertice decisionale si ha con l’eliminazione fisica del dittatore per mano dei consanguinei in linea di successione o per complotti cruenti degli avversari politici. In senso lato, dittatura ha quindi il significato di predominio assoluto e perlopiù incontrastabile di un individuo (o di un ristretto gruppo di persone) che detiene un potere imposto con la forza. In questo senso la dittatura coincide spesso con l'autoritarismo e con il totalitarismo. Sua caratteristica è anche la negazione della libertà di espressione e di stampa.
La democrazia non è altro che la dittatura delle minoranze reazionarie, che, con fare ricattatorio, impongono le loro pretese ad una maggioranza moderata, assoggetta da calcoli politici.
Si definisce minoranza un gruppo sociale che, in una data società, non costituisce una realtà maggioritaria. La minoranza può essere in riferimento a: etnia (minoranza etnica), lingua (minoranza linguistica), religione (minoranza religiosa), genere (minoranza di genere), età, condizione psicofisica.
Minoranza con potere assoluto è chi eserciti una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Con grande influenza alla formazione delle leggi emanate nel loro interesse. Queste minoranze sono chiamate "Caste".
Minoranza con potere relativo è colui che sia incaricato di pubblico servizio, ai sensi della legge italiana, ed identifica chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Queste minoranze sono chiamate "Lobbies professionali abilitate" (Avvocati, Notai, ecc.). A queste si aggiungono tutte quelle lobbies economiche o sociali rappresentative di un interesse corporativo non abilitato. Queste si distinguono per le battagliere e visibili pretese (Tassisti, sindacati, ecc.).
Le minoranze, in democrazia, hanno il potere di influenzare le scelte politiche a loro vantaggio ed esercitano, altresì, la negazione della libertà di espressione e di stampa, quando queste si manifestano a loro avverse.
Questo impedimento è l'imposizione del "Politicamente Corretto” nello scritto e nel parlato. Recentemente vi è un tentativo per limitare ancor più la libertà di parola: la cosiddetta lotta alle “Fake news”, ossia alle bufale on line. La guerra, però, è rivolta solo contro i blog e contro i forum, non contro le testate giornalistiche registrate. Questo perché, si sa, gli abilitati sono omologati al sistema.
Nel romanzo 1984 George Orwell immaginò un mondo in cui il linguaggio e il pensiero della gente erano stati soffocati da un tentacolare sistema persuasivo tecnologico, allestito dallo stato totalitario. La tirannia del “politicamente corretto”, che negli ultimi anni si è impossessata della cultura occidentale, ricorda molto il pensiero orwelliano: qualcuno dall'alto stabilisce cosa, in un determinato frangente storico, sia da ritenersi giusto e cosa sbagliato e sfruttando la cassa di risonanza della cultura di massa, induce le persone ad aderire ad una serie di dogmi laici spacciati per imperativi etici, quando in realtà sono solo strumenti al soldo di una strategia socio-politica.
Di esempi della tirannia delle minoranze la cronaca è piena. Un esempio per tutti.
Assemblea Pd, basta con questi sciacalli della minoranza, scrive Andrea Viola, Avvocato e consigliere comunale Pd, il 15 febbraio 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Mentre il Paese ha bisogno di risposte, la vecchia sinistra pensa sempre e solo alle proprie poltrone: è un vecchio vizio dalemiano. Per questi democratici non importa governare l’Italia, è più importante controllare un piccolo ma proprio piccolo partito. Di queste persone e di questi politicanti siamo esausti: hanno logorato sempre il Pd e il centro-sinistra; hanno sempre e solo pensato ai loro poltronifici; si sono sempre professati più a sinistra di ogni segretario che non fosse un loro uomo. Ma ora basta. Ricapitoliamo. Renzi perde le primarie con Bersani prima delle elezioni politiche del 2013. Bersani fa le liste mettendo dentro i suoi uomini con il sistema del Porcellum (altro che capilista bloccati). Elezioni politiche che dovevano essere vinte con facilità ed invece la campagna elettorale di Bersani fu la peggiore possibile. Renzi da parte sua diede il più ampio sostegno, in maniera leale e trasparente. Il Pd di Bersani non vinse e fu costretto ad un governo Letta con Alfano e Scelta Civica. Dopo mesi di pantano, al congresso del Pd, Renzi vince e diventa il segretario a stragrande maggioranza. E poi, con l’appoggio del Giorgio Napolitano, nuovo presidente del Consiglio. Lo scopo del suo governo è fare le riforme da troppo tempo dimenticate: legge elettorale e riforma costituzionale. Tutti d’accordo. E invece ecco che Bersani, D’Alema e compagnia iniziano il lento logoramento, non per il bene comune ma per le poltrone da occupare. Si vota l’Italicum e la riforma costituzionale. Renzi fa l’errore di personalizzare il referendum ed ecco gli sciacalli della minoranza Pd che subito si fiondano. Da quel momento inizia la strategia: andare contro il segretario che cercare di riprendere in mano il partito. La prova è semplice da dimostrare: Bersani e i suoi uomini in Parlamento avevano votato a favore della riforma costituzionale. Non c’è bisogno di aggiungere altro. Invece il referendum finisce 59 a 41 per il No. Matteo Renzi, in coerenza con quello detto in precedenza, si dimette da presidente del Consiglio. E francamente vedere brindare D’Alema, Speranza e compagnia all’annuncio delle dimissioni di Renzi è stato veramente vomitevole. Questa è stata la prima e vera plateale scissione: compagni di partito che brindano contro il proprio segretario, vergognoso! Bene, da quel momento, è un susseguirsi di insulti continui a Renzi, insulti che neanche il proprio nemico si era mai sognato. Renzi, a quel punto, è pronto a dimettersi subito e aprire ad un nuovo congresso. Nulla, la minoranza non vuole e minaccia la scissione perché prima ci deve essere altro tempo. Non per lavorare nell’interesse della comunità ma per le mirabolanti strategie personali di Bersani e D’Alema. Avevano detto che dopo il referendum sarebbe bastato poco per fare altra legge elettorale e altra riforma costituzionale. Niente di più falso. Unico loro tormentone, fare fuori Matteo. Renzi, allora, chiede di fare presto per andare al voto. Apriti cielo: il baffetto minaccia la scissione, non vuole il voto subito, si perde il vitalizio. Dice che ci vuole il congresso prima del voto. Bene, Renzi si dice pronto. Lunedì scorso si tiene la direzione. Tanti interventi. Si vota. La minoranza, però, vota contro la mozione dei renziani. Il risultato: 107 con Renzi, 12 contro. “Non vogliamo un partito di Renzi”, dicono. Insomma il vaso è proprio colmo. Scuse su scuse, una sola verità: siete in stragrande minoranza e volete solo demolire il Pd e Renzi. Agli italiani però non interessa e non vogliono essere vostri ostaggi. E’ chiaro a tutti che non vi interessa governare ma avere qualche poltrona assicurata. Sarà bello vedervi un giorno cercare alleanze. I ricatti sono finiti: ora inizi finalmente la vera rottamazione.
No, no e 354 volte no. La sindrome Nimby (Not in my back yard, "non nel mio cortile") va ben oltre il significato originario. Non solo contestazioni di comitati che non vogliono nei dintorni di casa infrastrutture o insediamenti industriali: 354, appunto, bloccati solo nel 2012 (fonte Nimby Forum). Ormai siamo in piena emergenza Nimto – Not in my term of office, "non nel mio mandato" – e cioè quel fenomeno che svela l’inazione dei decisori pubblici. Nel Paese dei mille feudi è facile rinviare decisioni e scansare responsabilità. La protesta è un’arte, e gli italiani ne sono indiscussi maestri. Ecco quindi pareri "non vincolanti" di regioni, province e comuni diventare veri e propri niet, scrive Alessandro Beulcke su “Panorama”. Ministeri e governo, in un devastante regime di subalternità perenne, piegano il capo ai masanielli locali. Tempi decisionali lunghi, scelte rimandate e burocrazie infinite. Risultato: le multinazionali si tengono alla larga, le grandi imprese italiane ci pensano due volte prima di aprire uno stabilimento. Ammonterebbe così a 40 miliardi di euro il "costo del non fare" secondo le stime di Agici-Bocconi. E di questi tempi, non permettere l’iniezione di capitali e lavoro nel Paese è una vera follia.
NO TAV, NO dal Molin, NO al nucleare, NO all’ingresso dei privati nella gestione dell’acqua: negli ultimi tempi l’Italia è diventata una Repubblica fondata sul NO? A quanto pare la paura del cambiamento attanaglia una certa parte dell’opinione pubblica, che costituisce al contempo bacino elettorale nonché cassa di risonanza mediatica per politici o aspiranti tali (ogni riferimento è puramente casuale). Ciò che colpisce è la pervicacia con la quale, di volta in volta, una parte o l’altra del nostro Paese si barrica dietro steccati culturali, rifiutando tutto ciò che al di fuori dei nostri confini è prassi comune. Le battaglie tra forze dell’ordine e manifestanti NO TAV non si sono verificate né in Francia né nel resto d’Europa, nonostante il progetto preveda l’attraversamento del continente da Lisbona fino a Kiev: è possibile che solo in Val di Susa si pensi che i benefici dell’alta velocità non siano tali da compensare l’inevitabile impatto ambientale ed i costi da sostenere? E’ plausibile che sia una convinzione tutta italica quella che vede i treni ad alta velocità dedicati al traffico commerciale non rappresentare il futuro ma, anzi, che questi siano andando incontro a un rapido processo di obsolescenza? Certo, dire sempre NO e lasciare tutto immutato rappresenta una garanzia di sicurezza, soprattutto per chi continua a beneficiare di rendite di posizione politica, ma l’Italia ha bisogno di cambiamenti decisi per diventare finalmente protagonista dell’Europa del futuro. NO?
Il Paese dei "No" a prescindere. Quando rispettare le regole è (quasi) inutile. In Italia non basta rispettare le regole per riuscire ad investire nelle grandi infrastrutture. Perché le regole non sono una garanzia in un Paese dove ogni decisione è messa in discussione dai mal di pancia fragili e umorali della piazza. E di chi la strumentalizza, scrive l’imprenditore Massimiliano Boi. Il fenomeno, ben noto, si chiama “Nimby”, iniziali dell’inglese Not In My Backyard (non nel mio cortile), ossia la protesta contro opere di interesse pubblico che si teme possano avere effetti negativi sul territorio in cui vengono costruite. I veti locali e l’immobilismo decisionale ostacolano progetti strategici e sono il primo nemico per lo sviluppo dell’Italia. Le contestazioni promosse dai cittadini sono “cavalcate” (con perfetta par condicio) dalle opposizioni e dagli stessi amministratori locali, impegnati a contenere ogni eventuale perdita di consenso e ad allontanare nel tempo qualsiasi decisione degna di tale nome. Dimenticandosi che prendere le decisioni è il motivo per il quale, in definitiva, sono stati eletti. L’Osservatorio del Nimby Forum (nimbyforum.it) ha verificato che dopo i movimenti dei cittadini (40,7%) i maggiori contestatori sono gli amministratori pubblici in carica (31,4%) che sopravanzano di oltre 15 punti i rappresentanti delle opposizioni. Il sito nimbyforum.it, progetto di ricerca sul fenomeno delle contestazioni territoriali ambientali gestito dall'associazione no profit Aris, rileva alla settima edizione del progetto che in Italia ci sono 331 le infrastrutture e impianti oggetto di contestazioni (e quindi bloccati). La fotografia che emerge è quella di un paese vecchio, conservatore, refrattario ad ogni cambiamento. Che non attrae investimenti perché è ideologicamente contrario al rischio d’impresa. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è la tendenza allo stallo. Quella che i sociologi definiscono “la tirannia dello status quo”, cioè dello stato di fatto, quasi sempre insoddisfacente e non preferito da nessuno. A forza di "no" a prescindere, veti politici e pesanti overdosi di burocrazia siamo riusciti (senza grandi sforzi) a far scappare anche le imprese straniere. La statistica è piuttosto deprimente: gli investimenti internazionali nella penisola valgono 337 miliardi, la metà di quelli fatti in Spagna e solo l’1,4% del pil, un terzo in meno di Francia e Germania. Un caso per tutti, raccontato da Ernesto Galli Della Loggia. L’ex magistrato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, città assurta come zimbello mondiale della mala gestione dei rifiuti, si è insediato come politico “nuovo”, “diverso”, “portatore della rivoluzione”. Poi, dicendo “no” ai termovalorizzatori per puntare solo sulla raccolta differenziata, al molo 44 Area Est del porto partenopeo, ha benedetto l’imbarco di 3 mila tonn di immondizia cittadina sulla nave olandese “Nordstern” che, al prezzo di 112 euro per tonn, porterà i rifiuti napoletani nel termovalorizzatore di Rotterdam. Dove saranno bruciati e trasformati in energia termica ed elettrica, a vantaggio delle sagge collettività locali che il termovalorizzatore hanno voluto. Ma senza andare lontano De Magistris avrebbe potuto pensare al termovalorizzatore di Brescia, dove pare che gli abitanti non abbiano l’anello al naso. Scrive Galli Della Loggia: “Troppo spesso questo è anche il modo in cui, da tempo, una certa ideologia verde cavalca demagogicamente paure e utopie, senza offrire alcuna alternativa reale, ma facendosi bella nel proporre soluzioni che non sono tali”.
In Italia stiamo per inventare la "tirannia della minoranza". Tocqueville aveva messo in guardia contro gli eccessivi poteri del Parlamento. Con la legge elettorale sbagliata si può andare oltre...scrive Dario Antiseri, Domenica 04/09/2016, su "Il Giornale". Nulla di più falso, afferma Ludwig von Mises, che liberalismo significhi distruzione dello Stato o che il liberale sia animato da un dissennato odio contro lo Stato. Precisa subito Mises in Liberalismo: «Se uno ritiene che non sia opportuno affidare allo Stato il compito di gestire ferrovie, trattorie, miniere, non per questo è un nemico dello Stato. Lo è tanto poco quanto lo si può chiamare nemico dell'acido solforico, perché ritiene che, per quanto esso possa essere utile per svariati scopi, non è certamente adatto ad essere bevuto o usato per lavarsi le mani». Il liberalismo prosegue Mises non è anarchismo: «Bisogna essere in grado di costringere con la violenza ad adeguarsi alle regole della convivenza sociale chi non vuole rispettare la vita, la salute, o la libertà personale o la proprietà privata di altri uomini. Sono questi i compiti che la dottrina liberale assegna allo Stato: la protezione della proprietà, della libertà e della pace». E per essere ancora più chiari: «Secondo la concezione liberale, la funzione dell'apparato statale consiste unicamente nel garantire la sicurezza della vita, della salute, della libertà e della proprietà privata contro chiunque attenti ad essa con la violenza». Conseguentemente, il liberale considera lo Stato «una necessità imprescindibile». E questo per la precisa ragione che «sullo Stato ricadono le funzioni più importanti: protezione della proprietà privata e soprattutto della pace, giacché solo nella pace la proprietà privata può dispiegare tutti i suoi effetti». È «la pace la teoria sociale del liberalismo». Da qui la forma di Stato che la società deve abbracciare per adeguarsi all'idea liberale, forma di Stato che è quella democratica, «basata sul consenso espresso dai governati al modo in cui viene esercitata l'azione di governo». In tal modo, «se in uno Stato democratico la linea di condotta del governo non corrisponde più al volere della maggioranza della popolazione, non è affatto necessaria una guerra civile per mandare al governo quanti intendano operare secondo la volontà della maggioranza. Il meccanismo delle elezioni e il parlamentarismo sono appunto gli strumenti che permettono di cambiare pacificamente governo, senza scontri, senza violenza e spargimenti di sangue». E se è vero che, senza questi meccanismi, «dovremmo solo aspettarci una serie ininterrotta di guerre civili», e se è altrettanto vero che il primo obiettivo di ogni totalitario è l'eliminazione di quella sorgente di libertà che è la proprietà privata, a Mises sta a cuore far notare che «i governi tollerano la proprietà privata solo se vi sono costretti, ma non la riconoscono spontaneamente per il fatto che ne conoscono la necessità. È accaduto spessissimo che persino uomini politici liberali, una volta giunti al potere, abbiano più o meno abbandonato i principi liberali. La tendenza a sopprimere la proprietà privata, ad abusare del potere politico, e a disprezzare tutte le sfere libere dall'ingerenza statale, è troppo profondamente radicata nella psicologia del potere politico perché se ne possa svincolare. Un governo spontaneamente liberale è una contradictio in adjecto. I governi devono essere costretti ad essere liberali dal potere unanime dell'opinione pubblica». Insomma, aveva proprio ragione Lord Acton a dire che «il potere tende a corrompere e che il potere assoluto corrompe assolutamente». Un ammonimento, questo, che dovrebbe rendere i cittadini e soprattutto gli intellettuali ed i giornalisti più consapevoli e responsabili. Da Mises ad Hayek. In uno dei suoi lavori più noti e più importanti, e cioè Legge, legislazione e libertà, Hayek afferma: «Lungi dal propugnare uno Stato minimo, riteniamo indispensabile che in una società avanzata il governo dovrebbe usare il proprio potere di raccogliere fondi per le imposte per offrire una serie di servizi che per varie ragioni non possono essere forniti o non possono esserlo in modo adeguato dal mercato». A tale categoria di servizi «appartengono non soltanto i casi ovvi come la protezione dalla violenza, dalle epidemie o dai disastri naturali quali allagamenti e valanghe, ma anche molte delle comodità che rendono tollerabile la vita nelle grandi città, come la maggior parte delle strade, la fissazione di indici di misura, e molti altri tipi di informazione che vanno dai registri catastali, mappe e statistiche, ai controlli di qualità di alcuni beni e servizi». È chiaro che l'esigere il rispetto della legge, la difesa dai nemici esterni, il campo delle relazioni internazionali, sono attività dello Stato. Ma vi è anche, fa presente Hayek, tutta un'altra classe di rischi per i quali solo recentemente è stata riconosciuta la necessità di azioni governative: «Si tratta del problema di chi, per varie ragioni, non può guadagnarsi da vivere in un'economia di mercato, quali malati, vecchi, handicappati fisici e mentali, vedove e orfani, cioè coloro che soffrono condizioni avverse, le quali possono colpire chiunque e contro cui molti non sono in grado di premunirsi da soli ma che una società la quale abbia raggiunto un certo livello di benessere può permettersi di aiutare». La «Grande Società» può permettersi fini umanitari perché è ricca; lo può fare «con operazioni fuori mercato e non con manovre che siano correzioni del mercato medesimo». Ma ecco la ragione per cui esso deve farlo: «Assicurare un reddito minimo a tutti, o un livello cui nessuno scenda quando non può provvedere a se stesso, non soltanto è una protezione assolutamente legittima contro rischi comuni a tutti, ma è un compito necessario della Grande Società in cui l'individuo non può rivalersi sui membri del piccolo gruppo specifico in cui era nato». E, in realtà, ribadisce Hayek, «un sistema che invoglia a lasciare la sicurezza goduta appartenendo ad un gruppo ristretto, probabilmente produrrà forti scontenti e reazioni violente quando coloro che ne hanno goduto prima i benefici si trovino, senza propria colpa, privi di aiuti, perché non hanno più la capacità di guadagnarsi da vivere». Tutto ciò premesso, Hayek torna ad insistere sul pericolo insito anche nelle moderne democrazie dove si è persa la distinzione tra legge e legislazione, vale a dire tra un ordine che «si è formato per evoluzione», un ordine «endogeno» e che si «autogenera» (cosmos) da una parte e dall'altra «un ordine costruito». Un popolo sarà libero se il governo sarà un governo sotto l'imperio della legge, cioè di norme di condotta astratte frutto di un processo spontaneo, le quali non mirano ad un qualche scopo particolare, si applicano ad un numero sconosciuto di casi possibili, e formano un ordine in cui gli individui possano realizzare i loro scopi. E, senza andare troppo per le lunghe, l'istituto della proprietà intendendo con Locke per «proprietà» non solo gli oggetti materiali, ma anche «la vita, la libertà ed i possessi» di ogni individuo costituisce, secondo Hayek, «la sola soluzione finora scoperta dagli uomini per risolvere il problema di conciliare la libertà individuale con l'assenza di conflitti». La Grande società o Società aperta in altri termini «è resa possibile da quelle leggi fondamentali di cui parlava Hume, e cioè la stabilità del possesso, il trasferimento per consenso e l'adempimento delle promesse». Senza una chiara distinzione tra la legge posta a garanzia della libertà e la legislazione di maggioranze che si reputano onnipotenti, la democrazia è perduta. La verità, dice Hayek, è che «la sovranità della legge e la sovranità di un Parlamento illimitato sono inconciliabili». Un Parlamento onnipotente, senza limiti alla legiferazione, «significa la morte della libertà individuale». In breve: «Noi possiamo avere o un Parlamento libero o un popolo libero». Tocqueville, ai suoi tempi, aveva messo in guardia contro la tirannia della maggioranza; oggi, ai nostri giorni, in Italia, si va ben oltre, sempre più nel baratro, con la proposta di una legge elettorale dove si prefigura chiaramente una «tirannia» della minoranza. Dario Antiseri
Quelli che... è sempre colpa del liberalismo. Anche se in Italia neppure esiste. A sinistra (ma pure a destra) è diffusa l'idea che ogni male della società sia frutto dell'avidità e del cinismo capitalistico. Peccato sia l'esatto contrario: l'assenza di mercato e di concorrenza produce ingiustizie e distrugge l'eco..., scrive Dario Antiseri, Domenica 04/09/2016, su "Il Giornale". Una opinione sempre più diffusa e ribadita senza sosta è quella in cui da più parti si sostiene che i tanti mali di cui soffre la nostra società scaturiscano da un'unica e facilmente identificabile causa: la concezione liberale della società. Senza mezzi termini si continua di fatto a ripetere che il liberalismo significhi «assenza di Stato», uno sregolato laissez fairelaissez passer, una giungla anarchica dove scorrazzano impuniti pezzenti ben vestiti ingrassati dal sangue di schiere di sfruttati. Di fronte ad un sistema finanziario slegato dall'economia reale, a banchieri corrotti e irresponsabili che mandano sul lastrico folle di risparmiatori, quando non generano addirittura crisi per interi Stati; davanti ad una disoccupazione che avvelena la vita di larghi strati della popolazione, soprattutto giovanile; di fronte ad ingiustizie semplicemente spaventose generate da privilegi goduti da bande di cortigiani genuflessi davanti al padrone di turno; di fronte ad imprenditori che impastano affari con la malavita e ad una criminalità organizzata che manovra fiumi di (...) (...) denaro; di fronte a queste e ad altre «ferite» della società, sul banco degli imputati l'aggressore ha sempre e comunque un unico volto: quello della concezione liberale della società. E qui è più che urgente chiedersi: ma è proprio vero che le cose stanno così, oppure vale esattamente il contrario, cioè a dire che le «ferite» di una società ingiusta, crudele e corrotta zampillano da un sistematico calpestamento dei principi liberali, da un tenace rifiuto della concezione liberale dello Stato? Wilhelm Röpke, uno dei principali esponenti contemporanei del pensiero liberale, muore a Ginevra il 12 febbraio del 1966. Nel ricordo di Ludwig Erhard, allora Cancelliere della Germania Occidentale: «Wilhelm Röpke è un grande testimone della verità. I miei sforzi verso il conseguimento di una società libera sono appena sufficienti per esprimergli la mia gratitudine, per avere egli influenzato la mia concezione e la mia condotta». E furono esattamente le idee della Scuola di Friburgo alla base della strabiliante rinascita della Germania Occidentale dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ancora Erhard, qualche anno prima, nel 1961: «Se esiste una teoria in grado di interpretare in modo corretto i segni del tempo e di offrire un nuovo slancio simultaneamente ad un'economia di concorrenza e a un'economia sociale, questa è la teoria proposta da coloro che vengono chiamati neoliberali o ordoliberali. Essi hanno posto con sempre maggiore intensità l'accento sugli aspetti politici e sociali della politica economica affrancandola da un approccio troppo meccanicistico e pianificatore». E tutt'altro che una assenza dello Stato caratterizza la proposta dei sostenitori dell'Economia sociale di mercato. La loro è una concezione di uno Stato forte, fortissimo, istituito a presidio di regole per la libertà: «Quel che noi cerchiamo di creare - affermano Walter Eucken e Franz Böhm nel primo numero di Ordo (1948) è un ordine economico e sociale che garantisca al medesimo tempo il buon funzionamento dell'attività economica e condizioni di vita decenti e umane. Noi siamo a favore dell'economia di concorrenza perché è essa che permette il conseguimento di questo scopo. E si può anche dire che tale scopo non può essere ottenuto che con questo mezzo». Non affatto ciechi di fronte alle minacce del potere economico privato sul funzionamento del mercato concorrenziale né sul fatto che le tendenze anticoncorrenziali sono più forti nella sfera pubblica che in quella privata, né sui torbidi maneggi tra pubblico e privato, gli «Ordoliberali» della scuola di Friburgo, distanti dalla credenza in un'armonia spontanea prodotta dalla «mano invisibile», hanno sostenuto l'idea che il sistema economico deve funzionare in conformità con una «costituzione economica» posta in essere dallo Stato. Scrive Walter Eucken nei suoi Fondamenti di economia politica (1940): «Il sistema economico deve essere pensato e deliberatamente costruito. Le questioni riguardanti la politica economica, la politica commerciale, il credito, la protezione contro i monopoli, la politica fiscale, il diritto societario o il diritto fallimentare, costituiscono i differenti aspetti di un solo grande problema, che è quello di sapere come bisogna stabilire le regole dell'economia, presa come un tutto a livello nazionale ed internazionale». Dunque, per gli Ordoliberali il ruolo dello Stato nell'economia sociale di mercato non è affatto quello di uno sregolato laissez-faire, è bensì quello di uno «Stato forte» adeguatamente attrezzato contro l'assalto dei monopolisti e dei cacciatori di rendite. Eucken: «Lo Stato deve agire sulle forme dell'economia, ma non deve essere esso stesso a dirigere i processi economici. Pertanto, sì alla pianificazione delle forme, no alla pianificazione del controllo del processo economico». «Non fa d'uopo confutare ancora una volta la grossolana fola che il liberalismo sia sinonimo di assenza dello Stato o di assoluto lasciar fare o lasciar passare». Questo scrive Luigi Einaudi in una delle sue Prediche inutili (dal titolo: Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze tra liberalismo e socialismo). E prosegue: «Che i liberali siano fautori dello Stato assente, che Adamo Smith sia il campione dell'assoluto lasciar fare e lasciar passare sono bugie che nessuno studioso ricorda; ma, per essere grosse, sono ripetute dalla più parte dei politici, abituati a dire: superata l'idea liberale; non hanno letto mai nessuno dei libri sacri del liberalismo e non sanno in che cosa esso consista». Contro Croce, per il quale il liberalismo «non ha un legame di piena solidarietà col capitalismo o col liberismo economico della libera concorrenza», Einaudi giudica del tutto inconsistente simile posizione in quanto una società senza economia di mercato sarebbe oppressa da «una forza unica dicasi burocrazia comunista od oligarchia capitalistica capace di sovrapporsi alle altre forze sociali», con la conseguenza «di uniformizzare e conformizzare le azioni, le deliberazioni, il pensiero degli uomini». Così Einaudi nel suo contrasto con Croce (in B. Croce-L. Einaudi, Liberismo e Liberalismo, 1957). È un fatto sotto gli occhi di tutti che ipertrofia dello Stato ed i monopoli sono storicamente nemici della libertà. Monopolismo e collettivismo ambedue sono fatali alla libertà. Per questo, tra i principali compiti dello Stato liberale vi è una lotta ai monopoli, a cominciare dal monopolio dell'istruzione. Solo all'interno di precisi limiti, cioè delle regole dello Stato di diritto, economia di mercato e libera concorrenza possono funzionare da fattori di progresso. Lo Stato di diritto equivale all'«impero della legge», e l'impero della legge è condizione per l'anarchia degli spiriti. Il cittadino deve obbedienza alla legge. Legge che deve essere «una norma nota e chiara, che non può essere mutata per arbitrio da nessun uomo, sia esso il primo dello Stato». Uguaglianza giuridica di tutti i cittadini davanti alla legge; e, dalla prospettiva sociale, uguaglianza delle opportunità sulla base del principio che «in una società sana l'uomo dovrebbe poter contare sul minimo necessario per la vita» un minimo che sia «non un punto di arrivo, ma di partenza; una assicurazione data a tutti gli uomini perché tutti possano sviluppare le loro attitudini» (Lezioni di politica sociale, 1944). Netta appare, quindi, la differenza tra la concezione liberale dello Stato e la concezione socialista dello Stato, nonostante che l'una e l'altra siano animate dallo stesso ideale di elevamento materiale e morale dei cittadini. «L'uomo liberale vuole porre norme osservando le quali risparmiatori, proprietari, imprenditori, lavoratori possano liberamente operare, laddove l'uomo socialista vuole soprattutto dare un indirizzo, una direttiva all'opera dei risparmiatori, proprietari, imprenditori suddetti. Il liberale pone la cornice, traccia i limiti dell'operare economico, il socialista indica o ordina le maniere dell'operare» (Liberalismo e socialismo in Prediche inutili). E ancora: «Liberale è colui che crede nel perfezionamento materiale o morale conquistato con lo sforzo volontario, col sacrificio, colla attitudine a lavorare d'accordo cogli altri; socialista è colui che vuole imporre il perfezionamento colla forza, che lo esclude, se ottenuto con metodi diversi da quelli da lui preferito, che non sa vincere senza privilegi a favor proprio e senza esclusive pronunciate contro i reprobi». Il liberale discute per deliberare, prende le sue decisioni dopo la più ampia discussione; ma questo non fa colui che presume di essere in possesso della verità assoluta: «Il tiranno non ha dubbi e procede diritto per la sua via; ma la via conduce il paese al disastro». Dario Antiseri
"Liberali di tutta Italia, svegliatevi". Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore "La Nave di Teseo", un brano dal nuovo libro di Nicola Porro, "La disuguaglianza fa bene", scrive Nicola Porro, Lunedì 12/09/2016, su "Il Giornale". Nel tempo in cui viviamo, bisogna diffidare di quanti si definiscono liberali senza esserlo. I principi del liberalismo classico, nonostante sembrino accettati da tutti, non lo sono fino in fondo. Da quanto abbiamo appena detto, il liberale tende a essere conservatore quando c’è una libertà da proteggere (il diritto di proprietà, ad esempio, di chi non riesce a sfrattare un inquilino moroso), progressista quando se ne devono tutelare di nuove (si pensi alle recenti minacce alla nostra privacy da parte di banche, stati o anche motori di ricerca) e talvolta anche reazionario quando occorre recuperare diritti sepolti nel passato (ad esempio una tassazione ridotta). Il filo rosso che lega queste diverse attitudini è ciò che Dario Antiseri definisce l’«individualismo metodologico»: la storia è guidata dalle azioni degli individui e sono questi ultimi che determinano le scelte fondamentali dell’economia. La collettività non esiste in sé, è la somma di una molteplicità di individui. Come diceva Pareto, un altro grande liberale di cui parleremo: «I tempi eroici del socialismo sono passati, i ribelli di ieri sono i soddisfatti di oggi». Il rischio è che questi soddisfatti si spaccino per liberali e anzi finiscano per spiegare ai liberali come devono comportarsi, anche in virtù degli errori che essi stessi hanno commesso. Quanti intellettuali ex maoisti, ex comunisti, ex gruppettari, ex fiancheggiatori delle Brigate rosse e delle rivolte di piazza, oggi in posizioni di comando, decantano le virtù del mercato? Se la loro fosse una conversione ragionata, alla Mamet come leggeremo, la cosa non dovrebbe scandalizzarci. Il problema è che i soddisfatti di oggi hanno un’idea farsesca del liberalismo e lo associano al loro personale successo. Che nella gran parte dei casi è arrivato solo grazie alle loro spiccate capacità di relazione. Fermatevi un attimo, pensate agli intellettuali che contano e vedrete due caratteristiche ricorrenti: hanno praticamente tutti combattuto contro i liberali tra gli anni sessanta e settanta eppure oggi spiegano al mondo i pregi del liberalismo, che a seconda dei casi si porta dietro l’aggettivo sociale o democratico. I veri liberali, non solo di casa nostra, si devono dare una mossa. Svegliarsi da un letargo ideale, che dura da qualche lustro. Il progresso tecnologico e quello degli ordini più o meno spontanei in cui si sono trasformate le nostre istituzioni obbliga anche i liberali di ieri ad affrontare, sul piano teorico, nuove sfide. Se i principi restano i medesimi, il contesto e le minacce sono cambiate. Alcuni dei veleni tipici del mercato hanno preso forme diverse, soprattutto quando sono coinvolte istituzioni finanziarie e grandi corporation digitali. Il monopolio e la sua rendita, il ruolo del free rider (cioè di chi ottiene benefici senza pagarne il prezzo) e il peso del moral hazard (ovvero prendere rischi enormi contando sul fatto di essere poi salvati, come nel caso di alcune note banche) hanno assunto forme diverse. Non è questo certo il luogo per affrontare in modo dettagliato il problema. Qualcosa si può dire, però. Un liberale classico pretende che l’impresa con perduranti conti in rosso fallisca. Altrimenti si stravolgerebbe la regola principale del mercato e della concorrenza. Il discorso vale anche per le banche. E se vale per le banche di una nazione, dovrebbe valere per tutti, vista la globalizzazione dei mercati? La risposta, sia chiaro, non è univoca. Anche dal punto di vista strettamente liberale. Taluni ad esempio potrebbero, per la tutela suprema del mercato, continuare a pensare che in ultima analisi salvare il fallito danneggerà anche il salvatore: e dunque chiederanno il fallimento delle banche nonostante i paesi vicini le sostengano con denaro pubblico. D’altra parte è anche vero che la discussione sembra essersi spostata dai conti dell’impresa ai bilanci della politica, dagli scambi sul mercato alle trattative nei palazzi del potere. Come rispondere alle imprese che sono tutelate e protette dalle proprie leggi nazionali, nonostante abbiano i conti in disordine? Insomma è una sfida nuova al pensiero liberale tradizionale. Così come si è rinnovata la battaglia contro i monopoli. Una fissazione di Luigi Einaudi, ma non solo. Pensiamo a quando Facebook – tra poco con i suoi 1,7 miliardi di abitanti la nazione più popolata della Terra – o Google – praticamente l’unico motore di ricerca sopravvissuto – diventeranno dei rentiers, dei profittatori della posizione privilegiata che hanno conquistato, e non più degli innovatori. E qui dimentichiamo per un attimo la gigantesca questione della privacy (altro terreno inesplorato) e andiamo al centro degli affari. Grazie al loro successo questi colossi spazzeranno via dal mercato (comprandolo) ogni concorrente. È sbagliato pensare che lo stato si debba occupare di loro, ma altrettanto illogico ritenere che il set di regole pensate per l’atomo si possa adattare al mondo dei byte: siamo di fronte a un processo simile a quello che ha visto cambiare le nostre civiltà da agricole a industriali. E che oggi le vede diventare digitali. Nuove entusiasmanti sfide per i liberali, che ieri contestavano Pigou e le sue esternalità basate sull’inquinamento dell’industria nei fiumi, e oggi dovranno capire come, e se, contenere gli effetti collaterali del digitale. Facebook ha impiegato quattro anni a toccare la favolosa capitalizzazione di borsa di 350 miliardi di dollari (praticamente quanto vale l’intera borsa italiana), Google nove, Microsoft tredici, Amazon diciotto e Apple trentuno anni. La velocità con cui queste grandi multinazionali assumono dimensioni finanziarie gigantesche è aumentata vertiginosamente. Ciò può spaventare, ma d’altro canto può anche rappresentare la fragilità di questi colossi: come velocemente sono nati e cresciuti, così rapidamente si possono sgonfiare. Chi mai pensava che Yahoo sarebbe stata acquistata per pochi (si fa per dire, meno di 5) miliardi di euro da un operatore telefonico? Il dilemma di un liberale oggi resta: si deve intervenire o no nella regolazione economica? E come? Problemi di sempre, ma che oggi hanno cambiato forma.
LE DONNE (DI IERI E DI OGGI) PIÙ IMPORTANTI E BELLE DELLA POLITICA ITALIANA.
Le otto donne (di ieri e di oggi) più importanti della politica italiana. Scrive Marco Todarello su focusjunior.it il 20 luglio 2016. Fonti: Enciclopedia Treccani e Corriere della Sera. Lo sapevi che solo 70 anni fa, nel 1946, le donne non potevano votare? Fu proprio quell'anno, che votarono per la prima volta. Purtroppo, in tema di diritti delle donne, rispetto ad altri paesi l’Italia era molto indietro, e questo è un esempio significativo. Anche per questo in politica le donne italiane hanno sempre fatto un po’ fatica a farsi strada. Ne abbiamo però selezionate otto che hanno lasciato il segno. Quali sono le donne più importanti della politica italiana? Abbiamo selezionato le più famose, quelle che hanno lasciato il segno.
Le otto donne (di ieri e di oggi) più importanti della politica italiana:
1. Nilde Iotti (1920-1999). È stata forse la più importante donna della politica italiana. Dopo la laurea in lettere divenne insegnante, ma ben presto lasciò la professione per dedicarsi alla politica. Prese parte alla Resistenza contro il fascismo e fu molto attiva in varie battaglie per il riconoscimento dei diritti delle donne, fino a diventare presidente dell’Unione Donne Italiane. Nel 1946 entrò nella Commissione dei 75 della Camera dei deputati, il gruppo incaricato della scrittura dei testi della Costituzione. Dal 1948 al 1999 fu deputato alla Camera, e nel 1979 divenne la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera e vi rimase per ben tre legislature, dal 1979 al 1992.È stata il simbolo di una generazione di donne in lotta per l’emancipazione e per la rappresentanza femminile in politica, allora dominata esclusivamente da uomini.
2. Tina Anselmi (1927-2016). Anche lei lasciò il suo posto da insegnante di scuola elementare per dedicarsi interamente alla politica, nelle fila della Democrazia Cristiana. La sua vita, però, era cambiata per sempre già molti anni prima: a 17 anni, mentre era a scuola, i nazifascisti costrinsero lei e i suoi compagni a vedere l’impiccagione di 30 prigionieri e così decise di prendere parte alla Resistenza per combattere il fascismo. È stata deputata DC dal 1968 al 1992 e nel 1976 è diventata la prima donna ministro (del Lavoro) della storia della Repubblica. È stata anche due volte ministro della Sanità. Come politica si è occupata soprattutto dei problemi delle donne: è sua la legge sulle pari opportunità, che è servita per avvicinare le donne alla parità di diritti nel mondo del lavoro.
3. Lina Merlin (1887-1979). È stata partigiana, attivista antifascista, sostenitrice dei diritti delle donne e anche prima senatrice italiana. Si laureò in letteratura francese ed è poi diventata maestra. Fondò i Gruppi per la difesa della donna e per l’assistenza ai volontari della libertà, che coinvolsero circa 60mila donne e che divennero l’Unione Donne Italiane. Ha partecipato ai lavori per la scrittura della Costituzione: fu lei a chiedere di introdurre all’articolo 3 la frase «senza distinzione di sesso». L’impegno politico di Lina Merlin ha portato all’abolizione della prostituzione, l’eliminazione delle disparità tra figli adottivi e figli propri e l’abolizione della “clausola di nubilato”, che nei contratti di lavoro imponeva il licenziamento alle lavoratrici che si sposavano.
4. Emma Bonino (1948). È una delle donne italiane più famose al mondo grazie al suo impegno per la pace, per i diritti umani, delle donne e per l’autodeterminazione dei popoli. Ha avuto un ruolo fondamentale in varie associazioni per il disarmo, contro la pena di morte (su questo tema è stata delegata per l'Italia all’Onu) e contro la fame nel mondo. È stata eletta deputato a soli 28 anni con il Partito Radicale ed è rimasta a lungo alla Camera nel corso degli anni ’70 e ’80. È stata commissario europeo dal 1995 al 1999, nel 2006 ministro del Commercio internazionale e delle politiche europee, e dal 2008 al 2013 vicepresidente del Senato. Nel 2013 il presidente del Consiglio Enrico Letta l’ha chiamata come ministro degli Esteri, incarico che ha ricoperto fino a febbraio 2014. Nel 2011 la rivista statunitense Newsweek l’ha inserita nell'elenco delle "150 donne che muovono il mondo”.
5. Rosy Bindi (1951). È stata a lungo ricercatrice universitaria in diritto amministrativo e attivista dell’Azione cattolica prima di entrare in politica, iscrivendosi alla Democrazia Cristiana, nel 1989. Nello stesso anno è stata eletta al parlamento europeo. Dal 1996 al 2000 è stata ministro della Sanità e dal 2006 al 2008 ministro per le Politiche della famiglia. Nel 2008 viene nominata vicepresidente della Camera dei deputati. Da sempre favorevole alla formazione di un nuovo partito unitario del centro sinistra, è tra le più convinte promotrici della nascita del Partito Democratico, del quale diviene presidente nel 2009. Il suo nome è legato al disegno di legge sui DICO, scritto con l’obiettivo di garantire diritti e doveri dai conviventi non sposati. Per questo progetto ha ricevuto molte critiche dal mondo cattolico.
6. Maria Elena Boschi (1981). A soli 33 anni è diventata ministro delle Riforme e dei Rapporti con il Parlamento del governo Renzi. Di formazione cattolica, si è laureata in Giurisprudenza e ha intrapreso la professione di avvocato. Alle politiche del 2013 è stata eletta alla Camera dei deputati nella lista del PD. È sempre stata una fedelissima del presidente del Consiglio Matteo Renzi fin dall’inizio della sua carriera politica, che le ha assegnato il delicato ruolo di responsabile delle Riforme. Dal 9 dicembre 2013 è membro della segreteria del Partito democratico. Il disegno di legge che porta il suo nome propone la modifica costituzionale che abolisce il Senato e sancisce la fine del bicameralismo perfetto.
7. Laura Boldrini (1961). Quando non aveva ancora vent’anni ha cominciato a viaggiare per il mondo alternando il volontariato nei Paesi poveri allo studio in Giurisprudenza, materia in cui si è laureata prima di intraprendere la carriera di giornalista. Ha vinto un concorso all’Onu ed è stata addetta stampa alla Fao e dal 1993 al 1998 portavoce dell’Italia del Programma alimentare mondiale in vari paesi, dall’Afghanistan all’ex Jugoslavia. Dal 1998 al 2012 è stata rappresentante per il Sud Europa dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'Onu (UNHCR) compiendo missioni in vari Paesi. Ha ricevuto vari premi per il suo impegno a favore dei diritti umani, in particolare a favore di migranti e rifugiati. Il 16 marzo 2013 è stata eletta presidente della Camera dei deputati.
8. Virginia Raggi (1978). Con 770.500 voti raccolti, è il sindaco più votato della storia di Roma. Non solo: è anche il primo sindaco donna della capitale nonché membro del Movimento Cinque Stelle, il partito fondato da Beppe Grillo che non aveva ancora mai vinto le elezioni in una grande città. Nella precedente legislatura è stata consigliere comunale. Prima di laurearsi in Giurisprudenza, Raggi è stata anche baby sitter, cameriera e assistente volontaria nei canili. Ha promesso di riportare la legalità a Roma, investendo nella trasparenza dell’amministrazione, nell’efficienza del trasporto pubblico, nelle pari opportunità e nella difesa dell’ambiente.
Le donne più belle della politica italiana. Centrodestra e centrosinistra alla pari, ma la reginetta è lei: Maria Elena Boschi. Selezione (criticabile) del fascino politico nostrano, scrive su Panorama Claudia Daconto il 25 settembre 2015. Non sempre in politica essere delle “ladylike” porta fortuna alla donne. Ne sa qualcosa Alessandra Moretti, convinta che la colpa della batosta rimediata alle scorse regionali in Veneto sia stata della divisa da ferrotranviere che i guru della comunicazione elettorale l'avevano costretta a indossare. Ma è indubbio: alla dittatura della messa in piega si sono dovute arrendere alla ne anche deputate e senatrici grilline, entrate prima in Parlamento che dall'estetista. Nella top ten delle belle della politica italiana nessuna di loro ha però ancora conquistato uno straccio di posizione. Sono infatti tutte occupate dalle colleghe Pd, Fi e Ncd. Se no a qualche anno fa le parlamentari azzurre erano infatti considerate le più avvenenti dell'emiciclo, ormai anche a sinistra hanno recuperato terreno. Ecco, nelle slide che seguono, la nostra selezione:
1 - Sua maestà la principessa Maria Elena Boschi. Se le altre sono, almeno per noi, a pari merito, l'unica che svetta su tutte sui suoi tacchi 12, è solo lei, come viene malignamente soprannominata tra i corridoi del Nazareno, "sua maestà la principessa Maria Elena Boschi”. Entrata alla Camera Ormai oltre due anni fa, Maria Elena è ancora oggi la più fotografata, paparazzata, analizzata ai raggi x tra le politiche italiane. Le sue calzature leopardate hanno fatto storia. Le mollettine sono diventate un must della scorsa primavera. Sappiamo tutto del suo guardaroba, compreso ciò che vorremmo dimenticare come il chiodo indossato su leggins e minigonna. Bellezza virginale ma accattivante che sa rinunciare alle unghie pittate di rosso, la Boschi è riuscita a strappare il titolo di ministra più bella d’Italia a una concorrente di tutto rispetto.
2 - Barbara Carfagna, la più copiata Bellissima e soprattutto elegante, l'ex ministro delle Pari Opportunità del governo Berlusconi Mara Carfagna conserva però il primato di caschetto più copiato di Montecitorio. Sesta a Miss Italia nel 1997, nella sua vita precedente la Carfagna faceva la soubrette in televisione. Nel tempo è riuscita a costruirsi un look sofisticatissimo ed apprezzato ovunque. Tanto che un sito americano l’ha eletta addirittura la più avvenente al mondo tra i politici.
3 - Gabriella Giammanco. Con i suoi occhi da cerbiatta e il sico asciutto, tra le più corteggiate del Parlamento c'è anche la forzista Gabriella Giammanco. Con un passato da giornalista del Tg4, nel 2011 viene eletta direttamente da Silvio Berlusconi come la più bella della Camera. Tra i suoi colleghi maschi in tanti farebbero carte false per lei. Ma finora solo uno di loro è riuscito a conquistare il suo cuore. Sapete chi è?
4 - Rinascimentale Madia. Una bellezza quasi rinascimentale quella della ministra delle Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Qualcuno la reputa un po' scialba. Noi diremmo “coraggiosa”: uscire di casa senza un po di trucco oggi giorno è una scelta da impavidi rivoluzionari che merita rispetto. Soprattutto quando il look generale lascia un po' a desiderare.
5 - Elvira Savino. Il nome dice poco, ma un’altra che fa parlare di sé per le sue fattezze è la deputata di Forza Italia Elvira Savino. Eletta la prima volta nel 2008, subito abbagliò il Parlamento con la sua lunga chioma castana sapientemente illuminata da qualche colpo di sole. Pure uno come il dem Roberto Giachetti, non riuscì allora a trattenere l'entusiasmo: “La più bella? Elvira Savino! Raggiunge quasi la perfezione”. Diciamo che l'intervento di rinoplastica l'ha aiutata, pensavamo noi. E invece no. Ci ha contattato l'onorevole Savino: il naso non se l'è rifatto! "Tra tutte le colleghe di Forza Italia che appaiono in questa classica, in cui io non merito di trovarmi, l'unica a non essere mai ricorsa a un intervento del genere sono io". Riconosciamo l'errore e le chiediamo scusa. Siamo state ingannate da troppa bellezza Motivo per cui la Savino merita, eccome, di apparire di diritto in questo post.
6 - Micaela Campana. Poco citata dalle altre classifiche che circolano in rete, merita invece una menzione anche la pugliese di nascita ma romana di adozione Micaela Campana, deputata dem e membro della segreteria nazionale del suo partito. Occhi da cerbiatta quelli della Giammanco, occhi di gatta quelli della Campana. Come fai a non notarla?
7 - La verace De Girolamo. Si difende, eccome, la verace Nunzia De Girolamo. Recentemente tornata in Forza Italia, dopo un paio di anni trascorsi nel Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, l'ex ministro delle politiche agricole è maestra nel saper rinnovare il suo stile sfoggiando sempre outfit raffinati. I tubini neri le stanno benissimo. E che dire di scarpe ed accessori. Top.
8 - Laura Ravetto. Viso squadrato, capelli biondi, l'altra azzurra Laura Ravetto esordì in politica sostenendo che la bellezza non era la sua caratteristica principale. Comunque l'ha aiutata a farsi notare. Oggi infatti, a qualche anno di distanza e con una carriera consolidata alle spalle, può naturalmente lasciarsi andare e dichiarare che “per essere belle fare l'amore è la miglior cura”.
9 - Lo stile Finocchiaro. Se si parla di classe e stile, impossibile non menzionar bellezza non più freschissima ma assolutamente degni in questa speciale classica. Parliamo della signora di Madama Anna Finocchiaro, politica di lunghissimo c Matteo Renzi si è ben guardato dal rottamare. Sempre elegantissima anche in giacca e pantaloni, non rinuncia mai al vezzo di un paio d'orecchini di corallo o vagamente etnici. Impossibile non restare ammaliati dalla sua voce resa leggermente roca dalle Muratti che aspira incessantemente Fascinosissima.
10 - La più giovane. Infine una scommessa. Bellissima non è ma con un buon parrucchiere e un trucco ad hoc potrà migliorare. Con soli 28 anni è la deputata più giovane, ma nel firmamento renziano brilla già come una piccola stella. Si chiama Anna Ascani e pare che le colleghe più famose siano tutte un po' invidiose dello spazio che l'ex lettiana è riuscita a conquistarsi. Un consiglio: se ripara all'errore di mettere su Fb una foto profilo in cui è talmente bella che non assomiglia per niente a com'è nelle altre, allora per lei è fatta.
GLI ULTIMI 25 ANNI DEGLI ITALIANI.
Ecco come è cambiato il mondo in 25 anni. Da Tangentopoli all’Euro passando per l’11 settembre e l’avvento dei cellulari. In 25 anni sono mutati costumi, governi, confini e mode. Ma Totti dal 1993 è sempre lo stesso. Ed lo abbiamo sempre al nostro fianco, scrive Francesco Balzani il 27/09/2016 su “Forza Roma”.
1993 – Il prologo del 1992 aveva portato le carneficine di Capaci e via D’Amelio, e il battesimo dell’inchiesta Mani pulite. Nel 1993 la Mafia purtroppo torna a colpire: prima il cronista Beppe Alfano poi Don Puglisi. Il 15 di gennaio viene arrestato a Palermo il capo di Cosa Nostra, Totò Riina, latitante da ben 23 anni. Il giorno dopo a Firenze è il turno di Pietro Pacciani, che si presume sia il cosiddetto “Mostro di Firenze. In politica nasce la cosiddetta Seconda Repubblica: hanno ricevuto avvisi di garanzia tutti i leader della Dc, del Psi, del Pri, del Pli. Un intero sistema viene raso al suolo a colpi di codice penale: da Craxi ad Andreotti. Senza sconti. E il volto del magistrato Antonio Di Pietro diventa popolarissimo. Il Sindaco di Roma diventa Rutelli.
1994 – Tredici giorni dopo le dimissioni del governo Ciampi c’è un volto nuovo a scuotere la politica italiana. E’ quello di Silvio Berlusconi che il 24 gennaio annuncia di “voler scendere in campo”. E’ l’anno del processo ad Andreotti e delle dimissioni di Occhetto dal Pds. Da segnalare in cronaca nera l’evasione di Felice Maniero dal carcere di Padova, l’omicidio da parte della ‘ndrangheta’ dei carabinieri Garofalo e Fava sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di Scilla (Reggio Calabria). E quello a Mogadiscio della giornalista della Rai Ilaria Alpi e del cameraman Miran Hrovatin. La Alpi indagava su traffici internazionali di armi e di rifiuti tossici.
1995 – In politica è ancora caos e a governare è Lamberto Dini dopo lo scioglimento delle Camere e la fine di quello Berlusconi mentre nasce Alleanza Nazionale di Fini e l’Ulivo di Prodi e Veltroni. La cronaca registra l’omicidio del tifoso genoano Vincenzo Spagnolo durante Milan-Genoa del 25 gennaio e l’estradizione dell’ex-capitano delle SS Erich Priebke in Italia. Si apre anche il processo di Andreotti per associazione mafiosa.
1996 – Il 13 gennaio Lamberto Dini rassegna le dimissioni da Primo Ministro e il 21 aprile a trionfare sarà Romano Prodi che diventa così Presidente del Consiglio superando Berlusconi e la Lega Nord di Bossi. A febbraio Pietro Pacciani viene assolto per non aver commesso il fatto, dalla Corte d’appello di Firenze, dopo essere stato condannato all’ergastolo per i delitti del Mostro di Firenze. Era in carcere da 1.100 giorni.
1997 – L’anno si apre con una tragedia. Il 12 gennaio a Piacenza infatti l’ETR 460 “Pendolino” deraglia all’entrata della stazione medesima provocando 8 morti e 29 feriti. Nel mezzo del convoglio si trova anche l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, per cui molti pensano si tratti di attentato. L’11 aprile un incendio provoca danni al Duomo di Torino mentre il 31 ottobre a Milano, presso l’Ospedale Galeazzi, 11 persone muoiono carbonizzate nell’incendio di una camera iperbarica. E’ anche l’anno dei Referendum abrogativi e dell’omicidio di Marta Russo all’Università La Sapienza di Roma.
1998 – Prodi si dimette il 9 ottobre e il suo posto sarà preso da Massimo D’Alema. Il 5 maggio le località di Sarno, Quindici, Bracigliano e Siano sono colpite da un gravissimo fenomeno franoso, composto da colate rapide di fango, l’evento provocò la distruzione di molte abitazioni e la morte di 137 persone nella sola Sarno. Il 13 novembre giunge in Italia il leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan, ricercato dalla polizia turca. Un evento che porterà a una crisi tra i due paesi.
1999 – Il Presidente del Consiglio è ancora D’Alema col cosiddetto “Governo D’Alema 2”. E’ un maggio caldissimo: il 13 viene proclamato presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che succede a Scalfaro. Undici giorni prima Papa Giovanni Paolo II proclama beato Padre Pio da Pietrelcina. Il 20 a Roma, invece, le Brigate Rosse uccidono il consulente del ministero del lavoro Massimo D’Antona. Tragedia a Foggia l’11 novembre quando per il crollo di un palazzo in viale Giotto muoiono 67 persone.
2000 – L’inizio del nuovo millennio viene vissuto anche in Italia tra paura del Millenium Bag e l’apertura della Porta Santa per il Giubileo più importante della storia. E’ l’anno dello storico accordo tra Fiat e General Motors, della divulgazione del Terzo segreto di Fatima, della condanna alle agenzie assicurative e dell’addio alla Lira. E’ anche l’anno delle dimissioni di D’Alema e del grigio Governo Amato che riapre una stagione di dura lotta tra i partiti.
2001 – L’anno dello scudetto romanista si apre a gennaio con la scomparsa dalla sua villa di Portofino della contessa Francesca Vacca Agusta. Il cadavere sarà trovato sugli scogli francesi tra Marsiglia e Tolone. E anche con l’apertura dell’inchiesta sui decessi di alcuni soldati. Si sospetta che la morte sia causata dall’uso di armi all’uranio impoverito nei Balcani. Il 21 febbraio invece un delitto scuote il Paese: Erika e Omar, i due fidanzatini di Novi Ligure, uccidono barbaramente il fratellino e la mamma di Erika. L’otto ottobre all’aeroporto di Linate un Cessna sbaglia raccordo durante il rullaggio ed entra in pista scontrandosi con un altro aereo e causando 118 morti. Intanto il Governo i raggiunge accordi per cancellare il debito estero di 22 paesi poveri. Si conclude il processo per l’omicidio di Marta Russo, la sentenza di secondo grado condanna Scattone a 8 anni di carcere e Ferraro a 6 anni. E’ anche l’anno della condanna alla satira: dei licenziamenti di Luttazzi e Travaglio, delle polemiche tra Santoro e Berlusconi. Il 27 marzo il Ministero della sanità, firma l’ordinanza anti mucca pazza che bandisce la bistecca alla fiorentina dal primo aprile al 31 dicembre. A giugno nasce il secondo Governo Berlusconi e in seguito all’undici settembre vengono varate le prime norme anti-terrorismo. Qualche mese prima il G8 di Genova era stato teatro di fortissimi scontri, del massacro della scuola Diaz e dell’omicidio di Carlo Giuliani. Sindaco di Roma diventa Walter Veltroni.
2002 – Il 19 marzo fanno il loro ritorno le Brigate Rosse con l’omicidio a Bologna dell’economista e consulente del ministero del Lavoro Marco Biagi, ma a scuotere l’Italia è il delitto di Cogne: Anna Franzoni uccide il figlioletto Samuele di appena 3 anni con violenti colpi alla testa. Ci vorranno anni prima di arrivare a una sentenza definitiva. E’ l’anno delle grandi manifestazioni contro le modifiche del governo all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, dell’approvazione della legge Bossi-Fini contro l’immigrazione e del ritorno dei Savoia. Il 31 ottobre un’altra tragedia: le scosse di un violento terremoto in Molise dell’8º grado della Scala Mercalli causano il crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia (CB), uccidendo 27 scolari e un’insegnante. Altre due persone muoiono in paese. A novembre, infine, il senatore Giulio Andreotti viene condannato a 24 anni di carcere al processo per l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli.
2003 – Dopo la Mucca Pazza arriva il pericolo Sars. Per la prima volta a marzo viene isolato a Milano il virus della la polmonite atipica che ha ucciso 376 persone e contagiato quasi altre 6 mila. Il 26 giugno, invece, è il giorno del grande black-out a sorpresa per sei milioni di italiani che si ripete in particolar modo a Roma il 28 settembre durante la Notte Bianca. La data, purtroppo, da cerchiare col rosso però è quella del 12 novembre quando un attentato suicida a Nassiriya contro il quartier generale dei Carabinieri, uccide 13 Carabinieri, 4 militari dell’Esercito Italiano e 2 civili iracheni.
2004 – Il 14 febbraio viene ritrovato morto nel residence “Le Rose” di Rimini il ciclista Marco Pantani, accanto ad una confezione di ansiolitici. Nell’appartamento erano presenti anche altri farmaci. Qualche giorno prima il mondo del calcio e dell’imprenditoria aveva subito due brutti colpi coi crack di Cirio e Parmalat e l’arresto di Cragnotti e Tanzi. Nelle piazze italiane intanto sono sempre più popolati i girotondi in nome della Pace e contro la guerra in Iraq. Il 29 luglio dopo 143 anni di coscrizione, il parlamento approva l’abolizione del servizio militare obbligatorio (leva obbligatoria) mentre ad ottobre a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, scompare la piccola Denise Pipitone, di soli 4 anni. La bambina non è stata ancora ritrovata. Al governo c’è ancora Berlusconi che viene assolto in numerosi processi a suo carico.
2005 – Il 2 aprile muore il Papa più amato della storia: Giovanni Paolo II. Tutto il mondo lo piange e a Roma arrivano a milioni per il suo funerale a San Pietro. Il 20 aprile invece Berlusconi annunciò in Senato la volontà di costituire un nuovo governo di e tre giorni dopo si presentò al Quirinale con la nuova lista dei ministri. Il giorno dopo in Piazza San Pietro si svolge la Messa di insediamento e di inaugurazione del Pontificato del neo-eletto Papa Benedetto XVI (Ratzinger). Il 29 dicembre Mario Draghi diventa il nuovo Governatore della Banca d’Italia. Tra i fatti di cronaca purtroppo spicca la storia della piccola Matilde morta per un calcio infertole mentre in casa con lei c’erano solo la madre e il suo convivente.
2006 – L’Italia è scossa dal rapimento del piccolo Tommaso Onofri alla porte di Parma. Dopo settimane col fiato sospeso il corpo del bambini viene ritrovato senza vita. Un altro terribile fatto di cronaca andrà in scena l’undici dicembre quando Olindo Romano e Rosa Bazzi ad Erba compiono una strage uccidendo a coltellate e sprangate i vicini di casa Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, Paola Galli (nonna del bambino) e Valeria Cherubini. Il 12 febbraio vengono scoperti dei cigni affetti da influenza aviaria in Sicilia e in altre regioni italiane. L’allarme pian piano contagia tutta Europa. L’undici aprile invece viene arrestato il boss siciliano Bernardo Provenzano, dopo 43 anni di latitanza. Il senatore a vita Giorgio Napolitano viene eletto 11º Presidente della Repubblica Italiana. Nei giorni precedenti era caduto di nuovo il governo Berlusconi e il 17 maggio sarà di nuovo Prodi a essere eletto.
2007 – E’ un anno terribile. Cinque delitti scuotono l’Italia: In occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia infatti una guerriglia tra le tifoserie che porta alla morte dell’ispettore di Polizia Filippo Raciti. Il 13 agosto la ventiseienne Chiara Poggi viene uccisa nella sua villetta di via Pascoli 8 a Garlasco e il suo cadavere viene scoperto dal fidanzato Alberto Stasi. Il primo novembre muore a Roma Giovanna Reggiani, quarantasettenne aggredita e uccisa due sere prima alla stazione di Tor di Quinto da un immigrato rumeno di etnia rom. Due giorni dopo viene uccisa a Perugia la studentessa inglese Meredith Kercher. Verranno accusati dell’omicidio Amanda Knox, studentessa statunitense coinquilina della vittima; Raffaele Sollecito, fidanzato di quest’ultima e Rudy Hermann Guede. L’undici novembre, infine, in un autogrill di Badia Al Pino il tifoso laziale Gabriele Sandri viene ucciso da un colpo di pistola sparato dal poliziotto Spaccarotella. In Politica è sempre mare mosso: dopo una bocciatura al Senato in materia di politica estera, il presidente del Consiglio italiano Romano Prodi rassegna le sue dimissioni al Quirinale che però vengono respinte da Napolitano.
2008 – Tra febbraio e marzo Prodi annuncia il suo addio alla politica italiana e nel frattempo Berlusconi e Fini fondano il partito Popolo della Libertà. Proprio il Cavaliere tornerà al potere per la terza volta e resterà a capo del Governo fino al 2011. E’ l’anno in cui esplode la polemica per le morti bianche sul lavoro. Il più grave a Molfetta dove cinque operai rimangono asfissiati da esalazioni di anidride solforosa in un’autocisterna. Veltroni lascia alla fine del secondo mandato da Sindaco. Il 29 aprile viene eletto Gianni Alemanno del Centro Destra.
2009 – Sarà ricordato come l’anno del violentissimo terremoto in Abruzzo. Il 6 aprile, infatti, una scossa di magnitudo 6,3 fa tremare la Provincia dell’Aquila alle 3:32 causando 309 vittime, 1500 feriti, 65000 sfollati e il crollo di molti edifici. A Viareggio il 29 giugno deraglia un treno merci con 14 cisterne di Gpl, una esplode causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri, il bilancio è di 32 morti e 23 feriti. il 2 ottobre altra tragedia a Messina: una frana devasta due paesi e provoca 35 morti. Il 15 ottobre, infine, muore Stefano Cucchi durante la custodia cautelare.
2010 – Un altro delitto diventa oggetto dell’attenzione morboso dei media. Il 26 agosto, infatti, la 15 enne Sarah Scazzi scompare ad Avetrana. Il suo corpo sarà ritrovato in un pozzo. La vicenda ha avuto un grande rilievo mediatico in Italia, culminato nell’annuncio della confessione dello zio in diretta sul programma Rai Chi l’ha visto? dove era ospite, in collegamento, la madre di Sara. Per il delitto sono stati condannati in primo grado e poi in appello all’ergastolo dalla Corte d’assise di Taranto, la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano con le accuse di concorso in omicidio volontario premeditato aggravato, mentre Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima, è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. Nello stesso anno a Brembate di Sopra (BG) il 26 novembre scompare la 13 enne Yara Gambirasio. Il suo corpo senza vita sarà trovato tre mesi dopo in un campo aperto.
2011 – Ricorre il 150° anniversario dall’Unità d’Italia. Il 4 novembre a Genova muoiono 6 persone tra cui 2 bambini a causa dell’alluvione. Esondano Bisagno, Fereggiano, Sturla e Scrivia a causa delle intense precipitazioni. Il 12 novembre Berlusconi rassegna di nuovo le dimissioni. Dopo alcuni giorni di consultazioni, nasce ufficialmente (prestando giuramento) il Governo tecnico presieduto da Mario Monti tra crisi economiche, spread e proteste popolari.
2012 – Il 13 gennaio il naufragio della Costa Concordia nei pressi dell’Isola del Giglio provoca 33 morti e la condanna per il comandante Francesco Schettino. Un altro terremoto provoca danni e vittime. Stavolta a essere colpita è la provincia di Modena dove una scossa di magnitudo 6,0 causa 7 morti e diversi milioni di euro di danni. A Brindisi, invece, il 29 giugno davanti all’Istituto professionale “Francesca Laura Morvillo-Falcone” vengono fatti esplodere due ordigni: una ragazza sedicenne, Melissa Bassi, originaria di Mesagne, muore sul colpo. Altre sei studentesse rimangono ferite. Il responsabile, Giovanni Vantaggiato, verrà fermato pochi giorni dopo e condannato all’ergastolo. il 26 ottobre l’ex premier italiano Silvio Berlusconi è condannato in primo grado a 4 anni (di cui 3 condonati) nel processo per frode fiscale sull’acquisizione di diritti televisivi del gruppo Mediaset. Il 22 dicembre nuovo scioglimento delle Camere.
2013 – E’ un anno contraddistinto dalle dimissioni da pontefice di Papa Benedetto XVI. E’ l’undici febbraio e la notizia fa il giro del mondo in pochi minuti grazie ai social. Il 13 marzo, dopo lunghe consultazioni, sarà eletto Jorge Maria Bergoglio nuovo pontefice col nome di Papa Francesco. Il 20 aprile, invece, Giorgio Napolitano viene rieletto Presidente della Repubblica Italiana, divenendo il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. Una settimana dopo Enrico Letta diventa Presidente del consiglio, anche se non ci sono state elezioni. il 29 dicembre l’ex pilota Schumacher entra in coma dopo un incidente sugli sci. Sindaco di Roma viene eletto Ignazio Marino del Pd.
2014 – Il 22 febbraio, di nuovo senza elezioni, Matteo Renzi assume l’incarico di presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. Il 23 novembre la prima donna italiana astronauta, Samantha Cristoforetti, inizia il viaggio verso lo spazio. Alle elezioni per il Parlamento Europeo Matteo Renzi e il suo PD ottengono il 40% dei voti, seguiti dal sorprendente Movimento 5 Stelle con il 21% e Forza Italia con il 16,8%.
2015 – E’ un anno contraddistinto dalle tragedie dei migranti in mare. Il più grave avviene il 18 aprile nel Canale di Sicilia dove una imbarcazione carica di887 migranti al largo delle coste libiche, impattato incidentalmente con la nave King Jacob. Oltre 800 i morti, il numero più alto di vittime mai registrato. Il 31 gennaio Sergio Mattarella diventa Presidente della Repubblica mentre il 13 marzo Papa Francesco annuncia il Giubileo straordinario. Marino viene “esonerato” come sindaco di Roma dal governo Renzi in seguito a numerosi scandali tra cui Mafia Capitale che ha scoperchiato il rapporto tra mafia italiana e appalti pubblici.
2016 – Lo stiamo vivendo e purtroppo dobbiamo registrare un altro terremoto terribile che il 24 agosto scorso ha distrutto molti paesi del Centro Italia tra cui Amatrice. La scossa principale si è prodotta alle 3:36:32 e ha avuto una magnitudo momento 6 e provocato oltre 200 vittime. Viene eletto come Sindaco di Roma il candidato dei Cinque Stelle Virginia Raggi.
IL LIMBO LEGISLATIVO. LE LEGGI TEORICHE.
Quelle 700 norme che in Italia sono legge solo in teoria: un'attesa che dura anche tre anni. Siamo un Paese di provvedimenti attuativi in attesa, che significa norme non attuate, diritti negati, politiche di governo lasciata incomplete. I dati sugli ultimi tre governo, da Monti in poi: due leggi su tre sono ancora da completare e almeno 74 provvedimenti sono ormai scaduti, scrive Alessia Sgherza il 27 febbraio 2017 su "La Repubblica". In Italia esiste un limbo delle leggi, un arco di tempo in cui le norme sono state approvate ma rimangono teoria. Norme che vivono in una bolla, un'epoché, una sospensione del giudizio, tra reale e irreale. Perché spesso le leggi demandano la propria effettiva attuazione a successivi provvedimenti attuativi che devono declinare dei princìpi nel mondo di tutti i giorni, imponendo limiti, procedure, precisazioni. Un limbo che sfiora in alcuni casi i tre anni e riguarda centinaia di norme (709 per la precisione): due leggi su tre tra quelle approvate nell'ultimo quinquennio sono ancora da completare. Quello dei provvedimenti attuativi è un altro aspetto critico per la certezza del diritto in Italia. Ci sono i ritardi della giustizia - penale, civile o amministrativa che sia - e i ritardi da parte di ministeri ed altri enti nel rendere efficaci le norme approvate. Con un corollario non irrilevante: a volte le leggi prevedono un termine ultimo entro cui i provvedimenti vanno approvati. E non è raro che quel termine passi. Come è successo a decine di norme (74 per la precisione) approvate tra il novembre 2011 e il febbraio 2014. Norme che restano inapplicate e che per rendere effettive potrebbe essere necessario reintrodurre con una nuova legge, che farebbe scattare una nuova corsa contro il tempo. Sono questi i risultati di un dossier sulle norme in attesa di attuazione prodotto da Openpolis per Repubblica.it e significativamente intitolato 'Il secondo tempo delle leggi'. Un titolo che sottolinea come l'approvazione delle Camere non sia altro che metà della partita, il cui risultato non è definitivo. Indicativo certo, ma non sempre decisivo. La base dei dati. Tutti i dati riportati in questa analisi sono tratti dai report periodici dell'Ufficio per il programma di governo della presidenza del Consiglio dei ministri. Istituito nel 2012 dal governo Monti, l'ufficio tiene traccia dei provvedimenti attuativi di norme di legge già adottati o ancora da adottare. I dati dei report, per quanto utili, sono ancora parziali: al cambiare del governo infatti cambia anche la struttura del dato che è diffuso, e quindi è difficile fare dei confronti. Tutti i dati sono aggiornati al 3 gennaio 2017 e dove non diversamente indicato coprono il periodo che va dal novembre 2011 a oggi, ovvero il periodo di durata in carica dei governi Monti, Letta e Renzi. L'iter delle leggi. Dire "abbiamo approvato la legge" non sempre basta affinché i cittadini possano godere di quei diritti. Come detto le leggi ordinarie, i decreti legislativi (dlgs) e le leggi di conversione dei decreti legge (un complesso che da ora in poi indicheremo per comodità solo come 'leggi') possono - in uno o più articoli - rimandare a un atto successivo che dia concretezza a quelle norme. Più precisamente: tre leggi su dieci hanno bisogno di uno o più provvedimenti attuativi. Può trattarsi di decreti ministeriali (dm); di decreti del presidente della repubblica o del presidente del consiglio (dpr o dpcm); ma anche provvedimenti direttoriali, deliberazioni Cipe, linee d'indirizzo e altro ancora. Con una moltiplicazione dei soggetti coinvolti che rende difficile monitorare il secondo tempo. E quanto manca ancora da fare. La maggior parte di queste leggi (184 su 227) richiedeva un massimo di 10 interventi successivi. Ma in tre casi i provvedimenti richiesti erano più di 80. Si tratta della legge di stabilità 2016 (136 provvedimenti richiesti), della legge di stabilità 2015 (94) e della seconda legge sulla spending review del governo Monti (84). Quasi sempre sono le leggi economiche quelle che richiedono più interventi, e quindi il maggior lavoro ricade proprio sul ministero di via XX settembre. La legge di bilancio 2017 ad esempio, approvata prima delle dimissioni del governo Renzi, richiederà 77 decreti attuativi. O ancora: il decreto sviluppo ne richiedeva 70, il Salva Italia 61, la Stabilità 2014 65. Vedremo poi come nessuna di queste leggi sia stata ancora completamente attuata. Una pesante eredità. C'è uno slittamento di responsabilità e carico di lavoro che è importante sottolineare. I governi e le strutture amministrative sono responsabili di emettere le norme attuative di tutte le leggi che vengono approvate mentre sono in carica, ma non sempre riescono a completare l'opera prima della fine della legislatura o prima di cadere. Ma quella parte di provvedimenti non adottata fa capo sempre a una legge in vigore, quindi il governo successivo deve farsi carico anche dei provvedimenti non adottati dai quelli precedenti. Il governo Gentiloni, in carica da metà dicembre, ha così ereditato tutto il 'non fatto' dei governi che l'hanno preceduto. Solo l'esecutivo Renzi ha lasciato in eredità 550 provvedimenti. Ma nel frattempo ha smaltito parte del carico ereditato da Monti e Letta, e così via. Cosa aspettiamo. Delle 227 leggi che rinviano a provvedimenti attuativi approvate dal 16 novembre 2011, solo 78 sono state completate e sono quindi pienamente efficaci. Ne restano fuori altre 149, che hanno gradi di completamento diversi. Alcune sono quasi complete, come la seconda Spending review (77 adottati su 84 previsti, il 91%) o il decreto Competitività (31 su 33, il 94%). Ma ci sono anche leggi che sono ancora a zero. Due di queste risalgono ai tempi di Monti: si tratta delle leggi sulla Corte penale internazionale e la Legge comunitario 2010. Entrambe prevedevano un solo decreto attuativo, ma in più di 4 anni quell'unico decreto non è stato approvato. Molte le leggi del governo Renzi che hanno un grado di attuazione pari a zero, ma essendo più recenti è meno grave. In ogni caso, da oltre tre mesi si attende un decreto attuativo della riforma del terzo settore, tre provvedimenti previsti della Legge Europea 2015/2016 e una norma della legge per la città di Taranto. L'incidenza dei decreti legge. Il dl è la tipologia di legge che viene completata maggiormente, questo per due motivi: il primo è che la decretazione d'urgenza viene usata appunto per affrontare situazioni emergenziali che hanno bisogno di interventi rapidi; il secondo che a volte gli esecutivi utilizzano questa forma per velocizzare gli atti caratterizzanti il programma di governo. Così abbiamo che i decreti legge hanno il 'tasso di conversione' maggiore rispetto alle altre leggi: l'81% dei provvedimenti attuativi richiesti dai dl sono stati approvati (809 su 990), contro un tasso del 52% per le leggi ordinarie (320 su 611) e del 49% per i decreti legislativi (232 su 469). La percentuale sale di molto per le leggi che risalgono alla fine della XVI legislatura (sotto Monti), con tassi di conversione dell'81% sia per le leggi che per i decreti legislativi e l'86% per i decreti legge. Per i decreti sotto governo Letta stesso 86%, che però scende rispettivamente a 73 e 78% per leggi e dlgs. Renzi - che essendo più recente ha tassi di approvazione più bassi - si ferma al 70%, 42% e 39%. Guardando al totale, questo significa che siamo ancora in attesa di 709 provvedimenti attuativi di norme che sono diventate legge negli ultimi 5 anni. Mille giorni. Se il governo Renzi ha celebrato i suoi mille giorni in carica poco prima di cadere e Claudio Baglioni ha dedicato a questa cifra tonda addirittura una canzone, ci sono altri mille giorni che invece sarebbe meglio dimenticare. È la giacenza media di attesa perché un decreto legge sia completato con tutti i decreti attuativi. Ci sono attualmente 40 dl approvati dai governi Monti, Letta e Renzi che sono ancora incompleti pur essendo stati approvati (in media) da 1032 giorni. E bisogna sottolineare il paradosso dell'inserire norme differibili nella decretazione di urgenza e poi far passare centinaia di giorni prima di renderle efficaci. Il dato di giacenza è un po' più basso per le leggi ordinarie: ci sono 20 leggi ancora incomplete da 815 giorni. Quattro volte il tempo che ci ha messo il parlamento ad approvarle. Alle lentezze del sistema bicamerale si sommano quelle del secondo tempo. Nel 2012 ci furono anche due casi limite. Il governo Monti adottò due norme che risalivano al primo governo Prodi. Ovvero a quindici anni prima, leggi approvate tra il 1996 e il 1998. Tempo scaduto. Corollario della lentezza dell'approvazione è il problema della scadenza. Altro che zona Cesarini: il secondo tempo delle leggi spesso termina senza che le norme si possano approvare. Perché a volte le leggi prevedono un termine entro il quale i decreti attuativi vanno approvati. E non sempre succede. I numeri sono impietosi: dei 154 decreti attuativi risalenti ai governi Monti e Letta, 74 sono ormai scaduti. Si tratta quasi della metà, il 48,05%. Poi ce ne sono due che ancora si è in tempo per adottare e altri 78 che per fortuna delle amministrazioni pubbliche non hanno scadenza. Ma i numeri freddi da soli non bastano a dare il senso, se non si calano nella realtà delle norme e della società. Su un tema caldo della politica come il finanziamento ai partiti, la legge approvata dal governo Letta richiedeva in totale 5 provvedimenti attuativi. Due non sono mai stati adottati, e ormai sono scaduti. Il primo è il decreto che doveva definire criteri e modalità del divieto per i gruppi di società, società controllate e collegate di effettuare 'erogazioni liberali', ovvero donazioni, ai partiti per un valore superiore ai 100.000 euro. L'altro decreto attuativo che non ha visto la luce doveva stabilire come tracciare i finanziamenti e i contributi effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante. Non proprio due problemi irrilevanti o marginali. Superlavoro per Padoan. La maggior parte del lavoro di attuazione delle leggi ricade sul ministero dell'Economia, una costante per tutti i governi considerati. E il ministero di via XX Settembre è anche uno dei dicasteri più efficienti, considerando la mole di lavoro. Prendiamo il periodo Monti. L'Economia ha attuato l'88% di norme con l'adozione di 141 norme. I ministeri della Difesa, degli Esteri e degli Affari regionali hanno un tasso di approvazione del 100%, ma avevano in carico solo 15, 6 e 1 provvedimento in carico (rispettivamente). I meno efficienti - sempre in riferimento al periodo Monti - sono i ministeri dell'Istruzione (35 approvati su 44, 79%), Cultura (7 su 9, 79%), Infrastrutture (31 su 40, 77%), Interno (28 su 37, il 75%) e Giustizia (18 su 24, sempre il 75%). Con Letta si confermano al 100% gli Esteri e gli Affari regionali (ma in valori assoluti sempre di pochi atti si tratta, rispettivamente 2 e 1), mentre Giustizia e Cultura si riscattano adottando tutti i provvedimenti necessari (11 e 16). La maglia nera va invece al ministero dei Rapporti con il parlamento: solo 1 su 2. A ruota il ministero della Salute (9 su 15, il 60%). Sotto Renzi tassi di approvazione più bassi, ma l'economia spicca sempre per il superlavoro: ne ha adottati 122 su 300. Nessun altro ministero ne ha così tanto in carico: solo il Lavoro supera i cento (102, di cui solo 55 adottati). Miglior performance per il ministero dell'Ambiente, con tre provvedimenti su 4 adottati. Zero per cento per il ministero delle Riforme e dei rapporti con il Parlamento, con tre atti ancora in attesa. Il governo Gentiloni all'opera. Al di fuori dei dati del dossier Openpolis, che come detto si ferma a inizio gennaio, possiamo andare a fare un primo bilancio dell'attività del governo Gentiloni, che ha pubblicato il suo primo report (pdf). Al 1° febbraio, i ministri del governo in carica avevano dato attuazione a 19 norme, di una risalente al governo Letta e le altre approvate sotto il governo Renzi. Il più vecchio è quindi il decreto ministeriale previsto dal comma 54, articolo 1, della legge di Stabilità 2014 che riguarda la "Definizione delle misure per favorire i processi di crescita dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia". Tra le altre norme diventate realtà nelle ultime settimane troviamo un dpcm atteso da oltre un anno (era nella Stabilità 2016), ovvero l'aggiornamento dei Livelli minimi di assistenza che ha impatto sulla salute di decine di milioni di persone. Altra norma che riguarda molti dipendenti pubblici è la definizione delle amministrazioni statali "verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale dello Stato" che è stato accorpato ai Carabinieri e la "definizione dei criteri da applicare alle procedure di mobilità". La legge era stata approvata il 19 agosto scorso. E c'è ovviamente anche la norme del decreto terremoto, per i territori colpiti dal sisma di Amatrice, che riconosce "i Comuni colpiti dagli eventi sismici come aree di crisi industriale complessa". Ma la strada è ancora lunga. Almeno altri 700 gradini di una scala che continua ad alzarsi.
LA REPUBBLICA GIUDIZIARIA, ASPETTANDO LA TERZA REPUBBLICA.
La pronuncia della Cassazione su Totò Riina "è la prova che lo Stato è più forte della mafia", scrive Live Sicilia il 6 giugno 2017. Il fatto che la Cassazione ponga una questione umanitaria "rispetto a un soggetto che ha dimostrato con la sua condotta criminale il massimo della disumanità rende quasi orgogliosi di una giustizia che riesce a ragionare in termini di diritti nei confronti di chi ha negato diritti agli altri". Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Eugenio Albamonte, difende la decisione della Cassazione, che continua a suscitare polemiche per quel richiamo al "diritto a morire dignitosamente" valevole per tutti i detenuti, anche per Riina che sta scontando 17 ergastoli". Ma chiarisce che la Suprema Corte non ha detto che Riina va subito scarcerato: piuttosto che bisogna valutare la compatibilità delle detenzione con le sue condizioni di salute e se vi è una sua "attuale pericolosità; e a sentire quello che racconta oggi ai giornali il procuratore nazionale antimafia non ci dovrebbero essere problemi - osserva - a dimostrare che anche attualmente è ancora lui il capo dei capi".
Se Riina è ancora il “capo dei capi” lo Stato ha fallito. Riina resti pure dove sta, ma il 41 bis non funziona, scrive Sciascianamente Valter Vecellio l'8 Giugno 2017 su "La Voce di New York". La Corte di Cassazione ha stabilito che le condizioni di salute di Totò Riina sono gravi ed è necessario un suo trasferimento per ricevere "una morte dignitosa". ll tribunale di sorveglianza di Bologna ha rifiutato questa opzione e si sono scatenate le polemiche. Ma qual è la giusta domanda da porsi? Spesso si cade in un equivoco. A volte vi si vuole cadere. Altre volte accade in buona fede. Sia il risultato della buona o della cattiva fede, si finisce così col perdere di vista la questione essenziale. Conviene allora fermarsi, lasciar perdere il chiacchiericcio, attendere che il polverone si diradi, che il bla bla bla si acquieti. E ricominciare cercando, per il possibile, di ragionare (se si sa, se si vuole). Si prenda la recente sentenza della Corte di Cassazione sulle condizioni di salute di Totò Riina, attualmente detenuto nel carcere di Parma, condannato a svariati ergastoli per i mille crimini commessi e ordinati. Riina è sottoposto al regime duro previsto dal 41 bis. La famiglia e gli avvocati della difesa chiedono che – dato il suo precario stato di salute – gli sia revocato il regime “speciale”. Il tribunale di sorveglianza di Bologna ha detto di no, che Riina deve restare dove sta. Di qui il ricorso alla Cassazione e la sentenza “scandalo”. Sono sette paginette, non è faticoso procurarsela e leggerla. È scritta in “giuridicese”, ma non è difficile “tradurre” i passaggi più tecnici. Si preferisce invece (non è la prima volta) la sagra delle dichiarazioni, non importa di chi, non importa a che titolo, men che mai la competenza: l’importante è alimentare un festival fatto da chi chiede una giustizia simile alla vendetta e da chi ribatte con una giustizia venata di perdono. Astenersi da questo “torneo” è igienico. Nella sentenza, per esempio, non si dice che Riina va scarcerato. Allora perché discutere se sia giusto o meno farlo? Eppure non mancano gli indignati. Nella sentenza si ricorda che nella Costituzione esiste l’articolo 27 che recita: “[…] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. La Costituzione vale per tutti, Riina compreso. Si può dire: ahinoi! Ma allora si proponga una modifica dell’articolo 27 che non permetta a persone come Riina di avvalersi di questo diritto e che conceda, in quei casi, di derogare i trattamenti contrari al senso di umanità. La sentenza dice che tutti hanno diritto a una morte dignitosa. È scandaloso dirlo, pensarlo, crederlo? Ha senso sostenere che chi questa morte l’ha negata a tanta parte del suo prossimo non merita quel tipo di “riguardo”? Allora si sia conseguenti: si introduca un codicillo tipo la legge del taglione che valga solo per persone come Totò Riina (magari con interessi: due occhi per un occhio, due piaghe, per una piaga…). Ma si ripete: si rischia di perdere di vista la questione essenziale, su cui ci si dovrebbe interrogare e riflettere. La questione che pone Giuseppe Ayala, per esempio. Amico di Giovanni Falcone, pubblico ministero del primo Maxi-Processo a Cosa Nostra, dice cose che meritano una riflessione: “Molti parlano senza conoscere la legge. Ciascun detenuto anche il più sanguinario, e Riina è un sanguinario, ha diritto di essere curato al meglio. Lo dice la legge che prevede il trasferimento, nel caso si renda necessario, in un carcere ospedaliero. Ne esistono molti in Italia e funzionano bene. Se poi si verificasse che le attrezzature a disposizioni non sono sufficienti a curare il detenuto malato, questi può essere trasferito in un ospedale normale, ben piantonato ovviamente. La scarcerazione non c’entra nulla con quel che dice la legge, dunque non si capisce perché Riina debba lasciare il carcere e tornarsene a casa. Al massimo può finire in ospedale. E non si capisce perché per un detenuto come Riina debba valere il percorso contrario a quello che si adotta per ogni essere umano”. Riina è ancora il boss pericoloso che qualcuno dice sia? “Non lo so, bisognerebbe far parte di una qualche cosca per saperlo. So però che viene ancora considerato il capo dei capi. Se è così, dopo 24 anni di detenzione con il 41 bis vuol dire che lo Stato su questo terreno ha fallito ed è stato sconfitto. Se Riina continua o ha continuato nei suoi 24 anni di detenzione a dare ordini, mi dispiace dirlo ma lo Stato ha perso”. Un ragionamento che non fa una grinza. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ritiene che Riina sia ancora il capo indiscusso della Cosa Nostra, mentre il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri va più in là: Riina anche con un solo battito di ciglia, con la sua sola presenza, sarebbe in grado di dettare legge ai suoi accoliti. Se hanno ragione i Roberti e i Gratteri occorre essere conseguenti e fare nostro il ragionamento di Ayala: se dopo 24 anni di detenzione con il 41 bis Riina continua a essere il “boss dei boss”, se può ancora dare ordini all’esterno, e questi ordini vengono tenuti in considerazione e nel caso eseguiti, non si deve concludere che lo Stato perde, ha perso, e che il 41 bis non funziona e non ha funzionato?
Mafia, giustizia e coincidenze: una lunga settimana da Riina a Berlusconi. Sullo sfondo di Cosa Nostra, in pochi giorni atti, interviste e sentenze toccano tutti gli aspetti di una piaga italiana, scrive Fuori dal Coro Fabio Cammalleri il 9 Giugno 2017 su "La Voce di New York". Dalle cure di Totò Riina alla nuova assoluzione del Generale Mario Mori; dalla polemica di Ilda Boccassini con il Presidente dell’ANM, a quelle del Capo della polizia, Franco Gabrielli, verso una certa “categoria di interpreti”, fino alle clamorose ultime intercettazioni che riguarderebbero Berlusconi e le stragi, è stata una settimana- summa: di Mafia e Antimafia. Tentiamo di considerare i fatti e le coincidenze, di cui la settimana è stata sicuramente prodiga. Già lunedì la Corte di Cassazione aveva emesso la nota sentenza su Salvatore Riina.
Sullo specifico punto, del “morire nel proprio letto”, si può convenire oppure no, legittimamente; ma solo su questo: non sulla valutazione, rimessa al Tribunale di Sorveglianza, circa la “compatibilità” o meno del regime penitenziario con la malattia (se è compatibile, rimane e si cura lì, altrimenti, esce e si cura dove può; e non c’è altro). I demeriti di Riina, che é impossibile sopravvalutare, possono rendere la scelta difficile. Si deve piena comprensione a chi sente (proprio come quasi un malessere psico-fisico) la difficoltà della scelta, quale che sia il giudizio (sì, no) a cui mette capo. Ma la comprensione per l’altrui opinione non è di questo mondo, o non di tutto, a quanto pare. E andiamo a ieri. Il magistrato Ilda Boccassini, ha dichiarato: “Il provvedimento dei giudici di sorveglianza di Bologna è stato un atto di giustizia e non di vendetta nei confronti del pluriergastolano Salvatore Riina.”. E, fin qui, sembrerebbe anche questa un’opinione. Ma poi ha proseguito: “Ho percepito, al contrario, come inappropriate e per nulla condivisibili le dichiarazioni del presidente dell’Associazione magistrati. Mi auguro che, in questo caso, le sue parole non rappresentino il pensiero della maggioranza dei colleghi. Soprattutto -mi pare doveroso sottolinearlo- di quanti, in silenzio e rifuggendo la luce dei riflettori, ogni giorno si adoperano nel contrasto al crimine organizzato, e in generale per garantire ai cittadini una giustizia giusta”.
Formulazioni così perentorie agevolano chiare inferenze, anche per l’unico che qui risultasse fesso:
il “contrasto al crimine organizzato” costituisce criterio di legittimazione esclusivo, e generale, della funzione giudiziaria solo chi se ne occupa può stabilire la giustizia vera (o “giusta” che dir si voglia);
la legge, non integrata dal suddetto “contrasto”, non é sufficiente per un “giusto” esercizio della suddetta funzione giudiziaria, o “giustizia”;
il dissenso da questa asserzione non è espressione di legittima opinione, ma pone ogni appartenente all’Ordine Giudiziario che lo manifesta in una condizione “impropria”: cioè, non compresa nel perimetro di ciò che, nella superiore materia del “contrasto al crimine organizzato”, spetta all’Ordine medesimo, e, dunque, al singolo magistrato;
inoltre, poichè questa non è una opinione, ma una “improprietà”, essa tradisce un contegno essenzialmente vocato alla vanità e all’esibizione di sè: che si addita a pubblica riprovazione, non disgiunta da venature di sarcasmo (sappiamo che il dott. Davigo è stato un cenobita, da Presidente dell’ANM e anche ora: per questo la dott.ssa Boccassini non ha mosso rilievi al riguardo);
é auspicio di chi impersona tale, esclusivo, criterio di legittimazione “contrastivo” della funzione giudiziaria, che i dissenzienti, portatori di un’interpretazione impropria, siano ridotti a minoranza silenziosa.
Di passata, si può notare che, se l’auspicio dovesse essere accolto, l’ANM dovrebbe considerare o la possibilità di essere rappresentata da una cripto-minoranza; o di agire convenientemente per ripristinare una adeguata corrispondenza fra “giusto” pensiero della magistratura e sua rappresentanza; data la precisata superiorità del criterio indicato, valevole “in generale”, per definire una “giustizia giusta”. Come pure si può notare che tanto i collegi della Corte di Cassazione, quanto quelli dei Tribunali sono costituiti da magistrati. Ora, per avere un’idea di come sia culturalmente ed istituzionalmente significativa, e pressante, la presenza di una “idea di superiorità interpretativa”, e di quali difficoltà, anche operative, possa comportare, può essere d’aiuto quanto, pure ieri, ha dichiarato il dott. Franco Gabrielli, Capo della Polizia. Commentava una decisione del CSM, emessa in margine alla vicenda Consip: tutt’altra storia. Ma qui interessa l’aria che tira, non il particolare.
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha chiesto formalmente al Governo di promuovere l’abrogazione di una ben precisa norma; la quale impone al personale della Polizia di Stato di riferire per via gerarchica, quindi fino al Capo, il contenuto delle indagini in corso. Poichè l’Ordine Giudiziario, largo di inefficienze, evidentemente lo è anche di sense of humour, lo scopo dell’iniziativa è prevenire compromissioni al segreto delle indagini; la cui cura, ovviamente, culminando la via gerarchica propriamente fino al Ministro, cioè, alla “Politica”, non può che essere affidata alle mani della Magistratura: le uniche certamente sicure.
Ciò posto, Gabrielli ha parlato di “disonestà intellettuale”, non a proposito di persone, ma, giustappunto, di un’idea, che è questa: “sostenere che in questo Paese esistono pochi cavalieri bianchi, le cui mani vengono legate da vertici di Polizia corrivi con la Politica e le sue convenienze, servi di un progetto eversivo che avrebbe dovuto cambiare prima la Costituzione e poi mettere in un angolo la magistratura”. C’è “un pregiudizio, da cui questa falsità muove”; si ritiene, cioè “…che una categoria interpreti meglio il principio di fedeltà repubblicana di altre”. Chiaro come il sole. E per (non) concludere con ieri, la Corte di Cassazione ha reso definitiva l’assoluzione del Generale Mario Mori, già direttore del SISDE: quintessenza di un “vertice di polizia” (intesa generalmente come forza armata civile: anchè perchè Gabrielli, a proposito del potere di trasmissione informativa gerarchica, aveva svolto un formale ed espresso parallelo con gli identici poteri di Carabinieri e Guardia di Finanza). L’imputazione per Mori era di aver favorito Bernardo Provenzano, omettendone la cattura; sappiamo che è stato anche accusato, e del pari assolto, dall’accusa di avere nascosto, alla Procura della Repubblica di Palermo, la mancata perquisizione della casa-rifugio di Riina; ed infine, è ancora a giudizio nel processo-Trattativa, compendio per ogni ipotesi di infedeltà di Servizi investigativi e della “Politica”, rispetto alla “fedeltà repubblicana”: la cui fissazione si è ritenuta appannaggio insindacabile di “una categoria di interpreti”. E pareva finita qui, la settimana. E, invece, il giorno dopo la Cassazione su Mori, cioè, oggi, la Procura della Repubblica di Palermo deposita, proprio nel processo Trattativa, una copiosa integrazione probatoria (circa 5000 pagine la documentazione), avente ad oggetto conversazioni in cella, avvenute nell’Aprile 2016, fra Giuseppe Graviano, condannato per associazione di tipo mafioso, strage ed altro, e un altro detenuto. Per ora è trapelato quello che viene presentato come un riferimento a Silvio Berlusconi, quale possibile mandante delle stragi: “Berlusca mi ha chiesto questa cortesia… per questo è stata l’urgenza…”. Questa, grosso modo, l’epigrafe della novità. Naturalmente, sappiamo che avremo di che leggere, nelle prossime settimane, perciò, per ora, ci fermiamo qui. Giusto per dare atto anche di quest’altra coincidenza. Dunque, dopo vent’anni sotto processo (per ora), è stato reso all’uomo Mario Mori un documento simbolico prezioso (la sentenza di assoluzione): ma non la sua vita. Che è un altro simbolo, a sua volta: dell’aria che tira. Come non mancano di ricordarci pure gli ultimi aggiornamenti, è una brutta aria. E non finisce mai. “Chi controlla il passato, controlla il futuro; chi controlla il presente, controlla il passato”, diceva Orwell. Siamo ancora lì.
Magistrati e politica: l’architrave del potere, scrivono Milena Gabanelli e Dino Martirano il 4 aprile 2018 su "Il Corriere della Sera”. Tutti i cittadini della Repubblica hanno il diritto di accedere alle cariche elettive, e di ritornare, quando lo desiderano, a fare la loro precedente attività. Nel caso dei magistrati che si mettono in aspettativa per candidarsi è vietato iscriversi ai partiti, ma siccome è una questione più di forma che di sostanza, è lecito chiedersi: con quale terzietà si comporterà un giudice eletto in Parlamento, che dopo anni passati a stretto contatto con la politica, rientra nelle aule giudiziarie?
Governo e parlamento. In questo passaggio di legislatura, fra i magistrati non ricandidati dai partiti troviamo: la senatrice Anna Finocchiaro del Pd. Entrò in aspettativa nel 1988, quando era pubblico ministero a Catania; dopo aver militato in un partito per in quale ha ricoperto importanti incarichi nell’arco di 30 anni, ora avrebbe intenzione di indossare nuovamente la toga. Ha chiesto di rientrare in ruolo anche l’ex pm di Milano Stefano Dambruoso, eletto a suo tempo con Scelta Civica. Chiedono di rientrare in magistratura Doris Lo Moro (già giudice del Tribunale di Roma), non ricandidata da Liberi e Uguali, e il Procuratore Domenico Manzione (sottosegretario all’Interno). L’ex pm di Viterbo Donatella Ferranti è rimasta fuori ruolo per 18 anni, prima al Csm e poi deputata eletta fra le fila del PD, proprio in questi giorni è rientrata come giudice di Cassazione. Felice Casson invece risulta essere l’unico ad aver dichiarato di non voler più tornare a fare il magistrato.
Il «sindacalista», il sindaco, il Governatore. Nella lista dei «fuori ruolo» troviamo Cosimo Maria Ferri, già giudice a Massa ed ex leader della corrente di centro destra dell’Associazione nazionale magistrati (il «sindacato» delle toghe). Diventato nel 2013 sottosegretario alla Giustizia in quota Forza Italia nel governo Letta, ha poi mantenuto il suo posto in via Arenula anche con Renzi e con Gentiloni, ed ora è stato eletto nel Pd in Toscana. Michele Emiliano, ex procuratore capo della Repubblica di Bari, dal 2015 è Governatore della Puglia ed è passato anche da un doppio mandato da sindaco nel capoluogo pugliese. È stato «processato» dalla sezione disciplinare del Csm perché, cumulando la carica di segretario locale del Pd, ha infranto il divieto d’iscrizione ai partiti politici. Ma alla fine, la «disciplinare» ha deciso di rimettere gli atti alla Consulta per verificare la legittimità della norma.
La riforma che non c’è. Sulle falle del nostro sistema, nella primavera del 2017 era intervenuto anche l’Organismo di Controllo contro la corruzione (Greco) del Consiglio d’Europa, chiedendo all’Italia norme più stringenti per la partecipazione dei magistrati alla politica. Nella legislatura appena conclusa i partiti hanno anche provato a mettere dei paletti, ma senza successo. Il testo rimpallato tra Camera e Senato introduceva per esempio l’obbligo di prendere l’aspettativa anche per i magistrati che si candidano alla carica di sindaco o che accettano di fare gli assessori. Obbligo che, incredibilmente, oggi non esiste e rende possibile indossare la toga e la casacca di sindaco o di assessore. Mentre l’incompatibilità territoriale vale solo al rientro (non fai il giudice dove sei stato eletto) ma non alla partenza (non ti candidi dove fai il giudice). Poi c’è sempre l’eccezione: Giovanni Melillo, procuratore aggiunto a Napoli, uscito nel 2014 per fare il capogabinetto del Ministero della Giustizia, è tornato lo scorso anno sempre a Napoli, come Procuratore capo. È stato possibile perché non era stato eletto tra le file di un partito, anche se si tratta di incarico fiduciario e deve pertanto seguire una linea politica precisa. Ma qui si apre un altro capitolo.
Alti burocrati con la toga. Sotto la punta dell’iceberg, rappresentata dai magistrati che finiscono negli organi elettivi, ci sono poi i togati distaccati al CSM, alla Presidenza della Repubblica, alla Corte Costituzionale. I più numerosi però sono quelli chiamati direttamente dal governo a svolgere il ruolo di capo di gabinetto, direttore generale, capo dell’ufficio legislativo, consulente o esperto giuridico, nelle ambasciate, negli organismi internazionali, nelle giunte regionali, nelle Autorità di controllo. È previsto che il numero non superi i 200, con un distacco che recentemente è stato fissato a 10 anni. La macchina dello Stato, per funzionare, ha bisogno di queste competenze, ma diventa poi difficile sapere cosa succede lungo le tappe di quel «carosello» di incarichi — tra ministeri e stanze del potere — che alcuni magistrati amministrativi percorrono con estrema disinvoltura «in nome della professionalità messa a disposizione della politica».
L’architrave del vero potere. Nei posti chiave incontri il giudice partito dal Consiglio di Stato che, nel corso degli anni, transita negli uffici del segretario generale di Palazzo Chigi, in quello del gabinetto del Ministro dell’Economia, con la prospettiva di approdare all’Autorità di controllo sulla Concorrenza e, infine, ripassare dall’ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico. E così via, fino al termine del «carosello» che riporta il nostro magistrato — ormai altissimo burocrate — a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato. Dove tutto torna in caso di contenzioso, e dove — in barba al principio della separazione dei poteri — gli potrebbe anche capitare di giudicare e interpretare norme che lui stesso ha contribuito a scrivere.
I boiardi di Stato. Sono nomi noti a pochi, passano indenni ai cambi di governo, e rappresentano l’architrave del potere che comanda davvero. Si va da Franco Frattini a Roberto Garofoli, a Filippo Patroni Griffi. Passato dalla magistratura ordinaria a quella amministrativa, oggi è Presidente di sezione del Consiglio di Stato. Nella sua carriera è stato Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della funzione pubblica con 6 governi, Capo di Gabinetto del Ministro per le Riforme Istituzionali, capo del «Dipartimento affari giuridici e legislativi» della Presidenza del Consiglio, Segretario generale dell’Autorità garante per la Privacy, Ministro per la pubblica amministrazione, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Senza nulla togliere alle loro capacità, e senza fare di ogni erba un fascio, il problema sta nel meccanismo che crea gli «specialisti» dell’alta burocrazia, ne consente le incrostazioni, e di conseguenza la paralizza.
Responsabilità civile dei giudici, il referendum che mise in crisi la staffetta Craxi-De Mita. La Dc, spalleggiata dall’opposizione comunista, fu talmente intransigente o timorosa delle reazioni della lobby giudiziaria, da preferire le elezioni anticipate, scrive Francesco Damato il 5 Aprile 2018 su "Il Dubbio". È vero. Come ha raccontato Paolo Delgado cercando ironicamente di suggerire a Luigi Di Maio e a Matteo Salvini di conciliare le loro aspirazioni a Palazzo Chigi con una staffetta analoga a quella concordata nel 1983 fra Bettino Craxi e Ciriaco De Mita, ma persasi rovinosamente per strada, l’impressione che diede il leader socialista fu di volersi sottrarre all’intesa quando il segretario della Dc mise all’incasso la cambiale. Ciò avvenne il 3 marzo 1987 con le dimissioni di Craxi e la riapertura di una crisi già tentata nell’estate precedente, ma rattoppata all’ultimo momento con una mediazione dell’allora ministro degli Esteri Giulio Andreotti. Al quale il leader socialista si impegnò a passare la mano l’anno dopo per fargli concludere la legislatura alla scadenza ordinaria del 1988. “Non capisco – mi raccontò in quel frangente Craxi – quale interesse abbiano i democristiani a riprendersi Palazzo Chigi nell’ultimo anno della legislatura, il più rognoso di tutti, quando si moltiplicano le tentazioni elettorali di spesa e non si hanno i mezzi per soddisfarle. Contenti loro…”. La crisi per l’operazione staffetta subentrò però all’ammissione, da parte della Corte Costituzionale, di un grappolo di cinque referendum abrogativi ad altissima tensione politica, su quattro dei quali i partiti della maggioranza erano divisi, a dir poco, se non dilaniati. Tre referendum riguardavano le procedure e agevolazioni per la costruzione di centrali per la produzione nucleare di energia elettrica, diventate impopolarissime dopo l’incidente di Cernobyl, verificatosi in Ucraina nell’aprile del 1986. I repubblicani, i liberali e una parte della Dc erano contrari all’abrogazione, sostenuta invece dai socialisti e da un’altra parte della Dc. Un altro referendum, promosso da radicali, socialisti e liberali, riguardava l’abrogazione di tre articoli del vecchio codice di procedura civile che mettevano i magistrati al riparo dalla responsabilità appunto civile per i danni procurati con i loro errori. Proposto sulla scia della clamorosa vicenda di Enzo Tortora, letteralmente perseguitato con accuse di camorra da cui sarebbe uscito alla fine assolto ma dopo avere subìto danni irreparabili alla salute, quel referendum era inviso naturalmente ai magistrati e ai partiti o correnti più sensibili alle loro proteste. Solo sul quinto referendum non c’erano contrasti seri, riguardando l’abolizione della commissione parlamentare inquirente per i procedimenti d’accusa, in modo da far giudicare i reati ministeriali non più dalla Corte Costituzionale ma dalla magistratura ordinaria. Sul tema della responsabilità civile dei magistrati la Dc, spalleggiata in verità dall’opposizione comunista, fu talmente intransigente, o timorosa delle reazioni della lobby giudiziaria, da preferire il ricorso alle elezioni anticipate per rinviare la prova referendaria. E così avvenne, fra le inutili proteste di Craxi. Che rivendicava il diritto di gestire col suo governo dimissionario l’anticipo delle elezioni, dovendo la staffetta riguardare, secondo lui, solo un governo per l’esaurimento ordinario della legislatura, comprensivo quindi della gestione dei referendum. Il contrasto fra Craxi e De Mita fu fortissimo, con parole più o meno pesanti scambiate a distanza, ed anche con qualche oggettiva forzatura politica e istituzionale riconosciuta pure all’interno della Dc. Dove, in particolare, sia Andreotti, sottrattosi del tutto all’incarico per la soluzione della crisi, sia il ministro uscente dell’Interno Oscar Luigi Scalfaro, formalmente incaricato di formare il nuovo governo, si rifiutarono di prestarsi all’operazione voluta dal segretario del loro partito. Che ricorse alla fine al presidente uscente del Senato Amintore Fanfani. Al cui governo monocolore democristiano, che non mancava neppure di un ministro per i rapporti col Parlamento in via di scioglimento, Craxi – su suggerimento dell’amico Francesco Cossiga, presidente della Repubblica – decise di accordare la fiducia dei socialisti per obbligarlo a governare sino all’anno successivo. E ciò anche a causa di alcuni importanti adempimenti internazionali, come un vertice europeo organizzato a Venezia per il mese di giugno del 1987. Per scampare paradossalmente alla fiducia e obbligare il capo dello Stato a sciogliere le Camere i deputati della Dc si astennero nella votazione per appello nominale nell’aula di Montecitorio. A quel prezzo pure l’opposizione comunista, favorevole allo scioglimento per evitare il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, si sentì a disagio. E non lo nascose. L’unica ritorsione di Craxi fu quella di pretendere, ad elezioni avvenute, di condizionare la ripresa della collaborazione di governo con la Dc, che mandò a Palazzo Chigi Giovanni Goria, la riduzione dei tempi del rinvio dei referendum. Che si svolsero, con un’apposita legge, a novembre di quell’anno, anziché nella primavera dell’anno successivo. I sì all’abrogazione delle norme che risparmiavano ai magistrati la responsabilità civile valida invece su tutte le altre categorie a rischio di errori, come medici e ingegneri, furono una valanga: più dell’80 per cento dei voti. Ma la lobby giudiziaria, prevedendo l’esito, aveva saputo mettersene al riparo. Era stata già predisposta a livello politico una legge sostitutiva di quelle norme approvata a tamburo battente, in pochi mesi. La sua applicazione si rivelò di una tale difficoltà da non produrre praticamente effetti di sorta. Le toghe continuarono a godere di una sostanziale immunità civile. Craxi, pago del successo referendario, si affidò ciecamente per il dopo- referendum alle valutazioni e alle iniziative dell’autorevolissimo guardasigilli socialista Giuliano Vassalli, fra le inutili proteste o i mugugni dei compagni di partito e, all’esterno, dei radicali. Che gridarono al referendum “tradito”. “Di Vassalli – mi disse poi Craxi, come per giustificarsi – non potevo non fidarmi. I miei rapporti con lui erano come quelli con Sandro”, cioè con Pertini. Ereditata dal governo Goria, quella legge fu la prima pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica sotto il governo De Mita, nominato il 13 aprile 1988 e dimessosi il 19 maggio 1989 per essere sostituito il 22 luglio dal sesto e penultimo governo Andreotti. Della difficilissima applicazione di quelle norme cominciarono a fare le spese dopo pochissimi anni le vittime degli errori, che certo non mancarono, nelle indagini e nei processi demolitori della cosiddetta prima Repubblica. Mi riferisco naturalmente ai procedimenti giudiziari della presunta, assai presunta epopea di “Mani pulite”.
«È dal ’92 che in Italia comandano i magistrati». Intervista di Errico Novi del 30 Marzo 2017 su "Il Dubbio". Intervista al filosofo ed ex europarlamentare del Pci: «Siamo una repubblica giudiziaria, se ne esce solo con le riforme e la separazione delle carriere». «Eccome si potrebbe mai negare che oggi l’Italia è una Repubblica giudiziaria? Che in Italia i magistrati hanno il potere? E che per ribaltare la situazione ci vorrebbe una classe politica autorevole, capace, tra l’altro, di non compromettersi con storie di ordinaria corruzione, che una classe politica così non si vede e che siamo quindi in un vicolo cieco?». Il tono di Biagio de Giovanni sa essere lucidamente analitico ma anche, se necessario, inevitabilmente esasperato. Il filosofo ed ex europarlamentare del Pci vede con chiarezza la gravità della situazione e condivide in gran parte il discorso fatto due giorni fa da Luciano Violante, che in una lectio magistralis alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa ha detto «stiamo entrando in una società giudiziaria». L’ex presidente della Camera individua un punto di deragliamento: la legge elettorale del 2005, il porcellum, che ha sterilizzato i rapporti tra eletti ed elettori, con i primi «chiusi nella cerchia del capo anziché aperti alla relazione con i cittadini». Da qui a un sistema in cui «il codice penale è la nuova Magna Charta dell’etica pubblica» il passo è stato brevissimo.
È così, professor de Giovanni? È il sistema di voto con le liste bloccate ad aver aperto la strada alla società giudiziaria?
«Io farei partire le cose da un momento decisamente anteriore: le inchieste giudiziarie dei primi anni Novanta. In quel passaggio si è assistito a un fatto che non ha riscontri nelle altre democrazie occidentali: l’annientamento di un intero sistema politico. È lì che i rapporti tra politica e magistratura si spostano e da quel momento la situazione non è stata più ribaltata. Il nostro sistema è stato distrutto da Mani pulite e non è più rinato».
Da Tangentopoli ad oggi non c’è soluzione di continuità?
«Non c’è nel senso che l’equilibrio, appunto, non è stato più ripristinato. Poi non c’è dubbio che alle vicende dei primi anni Novanta si aggiungano altri elementi. Ed è verissimo che tutto quanto può accentuare il distacco tra eletto ed elettore favorisce il diffondersi di una critica radicale alla politica e il dilagare dell’antipolitica. C’è un attacco violento che di fatto punta alla fine della democrazia rappresentativa».
In questo c’è una deriva autoritaria?
«Intanto penso si possa dire che qui non si tratta di aggiustare un sistema elettorale: la propaganda antipolitica spinge per l’abbandono della democrazia rappresentativa in favore della cosiddetta democrazia diretta, che si realizzerebbe attraverso la rete».
Com’è possibile che vinca un’opzione del genere?
«Non possiamo sottovalutare un altro fattore che genera sfiducia nella rappresentanza politica classica: lo spostamento delle decisioni. Se la società non coincide più con lo Stato nazionale ma oltrepassa i confini, acquisisce una dimensione indeterminata se non globale, e se gran parte delle decisioni sono prese al di là dei confini nazionali, è chiaro che le società si sentono meno rappresentate politicamente. Cosa può decidere, ormai, un Parlamento nazionale? Al massimo può enfatizzare un aspetto del governo anziché un altro, ma le scelte di fondo vengono prese altrove. E questo ovviamente crea un terreno favorevolissimo per chi sostiene che la democrazia rappresentativa non serva più a nulla, non sia in grado di rappresentare gli elettori e che perciò bisogna aprire alla democrazia diretta».
La purezza opposta dai cinquestelle al resto della politica immondo e corrotto costituisce una forma di fascismo?
«I fenomeni non tornano mai uguali e io non allargherei troppo la consistenza storica di categorie come il fascismo. Certo, la critica violenta alla democrazia rappresentativa finisce per rivolgersi in concreto al Parlamento, e questa modalità è stata caratteristica di determinati movimenti di destra del Novecento. Intendiamoci: nessuno pensa che in Italia stia per arrivare il fascismo, e poi c’è la cornice dell’Europa che costituisce comunque una garanzia».
Siamo al sicuro, allora.
«Ma siamo anche in una situazione in cui la critica al Parlamento e al parlamentarismo ci mette un attimo a generare una dinamica pubblica confusa in cui emotività e parole d’ordine prevalgono sulla competenza, sulle soluzioni equilibrate. E non è che tra questo e le emozioni di massa di cui parlava Gustave Le Bon più di un secolo fa ci sia tanta differenza».
Il grado di preparazione medio dei parlamentari non fa certo da argine a questa deriva.
«E qui ci risiamo con la distruzione del sistema avvenuta a inizio anni Novanta e a cui non si è ancora posto rimedio».
In questa situazione c’è anche un cedimento rassegnato all’invadenza della magistratura? Il Pd per esempio paga un eccesso di vicinanza ai giudici praticato dai suoi “precursori”?
«Non c’è alcun dubbio che tutte le forze politiche siano in ginocchio davanti alla magistratura, chi sostenendola e chi subendola. Sarebbe urgente una vera riforma di sistema: separare le carriere, fermare l’osceno viavai tra la toga e i partiti, superare l’obbligatorietà dell’azione penale. Se non si fa questo non se ne esce: ora la magistratura ha il potere in Italia. L’Italia è una Repubblica giudiziaria. Mi sembra di non essere solo, in quest’analisi: perfino l’equilibratissimo Sabino Cassese, nel suo ultimo lavoro, scrive che lo squilibrio tra politica e magistratura è diventato un fatto patologico. Ma poiché ci vorrebbe una classe politica autorevole per ribaltare tutto questo, si ha la netta impressione di essere in un vicolo cieco».
Da Roma a New York, i 222 magistrati prestati ai «palazzi» del governo. Un universo di toghe distaccate alla diretta dipendenza dei ministri, nella presidenza del Consiglio, nell’ambasciata di Washington, all’Onu o al Quirinale. Brunetta chiede l’elenco dei giudici «fuori ruolo», scrive Dino Martirano il 20 marzo 2017 su “Il Corriere della Sera”. Sotto la punta dell’iceberg — i pochi magistrati eletti in Parlamento oppure chiamati al governo — c’è un universo di toghe fuori ruolo. Si tratta di magistrati distaccati nei palazzi del governo «alla diretta dipendenza» dei ministri, nella presidenza del Consiglio, nell’ambasciata di Washington, all’Onu a New York, in Marocco e in Albania per il «collegamento» con la giustizia locale, al Quirinale, alla Corte costituzionale, nelle commissioni parlamentari, alle Corti di Strasburgo, nelle Autorità di controllo, nelle strutture della Ue, di Eulex, di Eurojust, di Europol e dell’Olaf. Comunque, il gruppone dei magistrati che hanno abbandonato temporaneamente il ruolo presta servizio al ministero della Giustizia e al Csm, come impone la legge. Si restringe, invece, la pattuglia degli eletti con la toga negli enti locali: Michele Emiliano (ex pm), governatore della Puglia, una magistrata assessore in Sicilia e poco altro. Nel giorno in cui la Camera avvia, con la relazione di Walter Verini (Pd), la discussione sulla legge Palma approvata tre anni fa dal Senato — il testo varato per stringere i bulloni delle «porte girevoli» che mettono in comunicazione i ruoli della magistratura e il mandato politico o fiduciario del governo — il capogruppo di Forza Italia, Renato Brunetta, ha chiesto al Csm l’elenco dei magistrati fuori ruolo. I numeri e i nomi che saranno forniti a Brunetta dal vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, vengono aggiornati nello «schedario elettronico» curato dal Consiglio: nell’elenco appaiono i nomi di ben 818 toghe che dalla fine degli anni 80 (la ministra Anna Finocchiaro, del Pd, è in aspettativa dall’88) hanno smesso temporaneamente di fare il giudice o il pm. Al netto dei rientri, ora sarebbero 222 i magistrati fuori ruolo: 196 distribuiti tra i ministeri, il Parlamento, il Csm (16), la Scuola della magistratura, le istituzioni internazionali, il Quirinale (3), la Corte costituzionale (23). Altri 16 sono i togati del Csm eletti dalla magistratura ordinaria; 6 sono gli eletti in Parlamento (c’è anche la parlamentare europea Caterina Chinnici del Pd), 2 sottosegretari del governo Gentiloni (Cosimo Ferri e Domenico Manzione), il governatore Michele Emiliano e una magistrata in aspettativa perché ha raggiunto il marito all’estero. Nell’elenco del Csm (prima della periodica revisione avvenuta ieri sera) emergevano alcune posizioni datate: quella dell’ex deputato di Forza Italia Alfonso Papa, arrestato e condannato in primo grado a Napoli, che risulta «in aspettativa per mandato parlamentare». Non è aggiornata anche la posizione di Stefano Dambruoso, oggi questore della Camera eletto in Scelta civica nel 2013, che è in «aspettativa per elezioni politiche». Aggiornata, invece, la casella di Giovanni Melillo, capo di gabinetto del Guardasigilli Andrea Orlando, che dal 15 marzo 2017 è alla Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma. A questo universo sommerso, conferma il relatore della legge Walter Verini (Pd), vanno applicate le regole già vigenti per i togati del Csm: cioè, un anno di «congelamento» a fine mandato prima di poter ottenere una promozione con un incarico direttivo o semi direttivo. Il problema sono i magistrati chiamati direttamente dal governo a svolgere il ruolo di capo di gabinetto, capo dell’ufficio legislativo, consulente o esperto giuridico in una ambasciata; ma anche le toghe elette in Parlamento sono sottoposte a un periodo di decantazione alla fine del mandato: pure i 5 anni di «purgatorio» necessari per poter ottenere una promozione (deliberati dal Senato) ora sono ridotti a 3 nel testo giunto in aula alla Camera. Per il quale, il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore (Pd), prevede tempi rapidi di approvazione alla Camera. Anche se poi il ddl dovrà tonare al Senato.
Edward Luttwak il 18 marzo 2017 su “Libero Quotidiano”: "Perché i giudici sono la malattia dell'Italia". Babbo Renzi, Luca Lotti e Consip. L'inchiesta di cui si è discusso nell'ultimo mese, il caso che in un qualche modo fa tremare il governo e mina il futuro di Matteo Renzi, l'ex premier che pare essere l'obiettivo di questa "caccia grossa" dei magistrati. E un parere, duro, sull'intera vicenda piove da Edward Luttwak, il politologo americano intervistato da Il Foglio, il quale spiega senza troppi giri di parole che "il rapporto tra giustizia e politica è un antico grattacapo nel vostro paese. Agli inizi degli anni Novanta Mani pulite usò metodi bruschi, ai limiti della legge, per combattere la corruzione dilagante nella classe politica - ricorda -. Questa esperienza, per certi versi traumatica, ha generato uno squilibrio tra i poteri con un esecutivo debole e una magistratura strapotente. La politica si è spogliata di prerogative e immunità, la magistratura ha esteso il proprio raggio d’azione. Il risultato è una democrazia malata". Dopo la lunga introduzione con gli occhi rivolti al passato, Luttwak passa al presente. All'ultimo "blitz" delle toghe. "Il filone politico del Consip-gate mi sembra fragile. Quale sarebbe la smoking gun? C’è un manager che accusa e un ministro che respinge le accuse. Si tira in ballo il padre dell’ex premier, un escamotage impiegato in diverse democrature latinoamericane: quando si vuole delegittimare un politico - ricorda Luttwak - si coinvolge pretestuosamente un familiare. Il traffico di influenze è una fattispecie fumosa, non tipizzata e priva di specificità, che accresce a dismisura la discrezionalità del magistrato". Anche Luttwak, dunque, critica il reato contestato a Tiziano Renzi, i cui confini appaiono assai lacunosi. Ma l'attacco di Luttwak ai giudici non è ancora finito. "Le porte girevoli - rimarca il politologo - sono un fattore inquinante che lede l’indipendenza della magistratura. Non c’è da stupirsi per il Consip-gate: l’idea di una strumentalità politica connessa all'esercizio dell’azione giudiziaria è accettata nell'opinione comune. Ho operato in decine di paesi ma solo in Italia il mio nome è finito sui giornali per intercettazioni telefoniche nell'ambito di un’inchiesta in cui non ero neppure indagato". E ancora, l'accusa ai media: "La verità è che esiste un vasto clima d’impunità testimoniato dalla disinvoltura con cui certi giornali violano quotidianamente il segreto istruttorio. Nel paese dove l’azione penale è obbligatoria nessun magistrato apre un fascicolo", conclude.
Emiliano: non mi dimetto da magistrato neanche morto, scrive Il Quotidiano di Puglia (Brindisi) il 14 marzo 2017. Etichetta come «nulla lucente» la kermesse renziana del Lingotto di Torino, getta l’ombra delle «intimidazioni politiche» sul gioco di incastri, alleanze e posizionamenti congressuali nel Pd e rintuzza a muso duro le “invasioni di campo” sul suo futuro: «La magistratura? Io non mi dimetto neanche morto, non c’è ragione per consegnarmi al ricatto di chi mi vuole trasformare in un professionista della politica», dice Michele Emiliano. Questione spinosa e latente da 13 anni, da quando cioè il candidato alla segreteria nazionale del Pd ha temporaneamente dismesso la toga di pm per tuffarsi sulla scena politica. Questione, ora, ritornata prepotentemente alla ribalta, anche perché davanti al Csm giace un procedimento disciplinare circa la presunta incompatibilità tra carriera politica e status in magistratura (dal 2004 Emiliano è in aspettativa, senza percepire stipendio). «Non c’è nessuna ragione per cui uno debba dimettersi dal suo lavoro per candidarsi, è pazzesco che un magistrato sia incompatibile con la politica, questa è la teoria di Davigo (il presidente dell’Anm, che è terrorizzato e considera la politica una suburra in cui c’è il rischio di contaminarsi». Al momento refrattario per scelta e strategia a convention oceaniche, il governatore pugliese sta sciorinando il suo piano congressuale in altro modo: presidio dei media nazionali e assemblee sui territori.
Da Scalfaro a De Magistris: tanti i magistrati entrati in politica. De Magistris, che si candiderà per le prossime elezioni europee con l'Italia dei Valori, è l'ultimo dei molti ex-magistrati folgorati sulla via parlamentare. Alcuni di loro hanno anche ricoperto incarichi politici tra i più alti dello Stato. Ecco l'elenco dei più noti, scrive "Panorama". "Una scelta di vita, non tornerò indietro", dice l'ex pm di Catanzaro Luigi De Magistris spiegando perché si candiderà per le prossime elezioni europee con l'Italia dei Valori. E mentre il vicepresidente del Csm, Nicola Mancino, commenta: "I magistrati che scelgono la politica non dovrebbero più tornare in magistratura", è lungo l'elenco degli ex-magistrati che hanno scelto di fare il salto e in politica: sia a sinistra (molti) sia a destra (alcuni). Ricoprendo anche incarichi politici tra i più alti dello Stato. Tra i più famosi Oscar Luigi Scalfaro, magistrato solo dal 1942 al 1946, che iniziò la sua carriera politica nel 1946 come membro dell'Assemblea Costituente, per poi essere eletto in Parlamento dal 1948 al 1992, anno in cui è prima presidente della Camera, per due mesi, e poi presidente della Repubblica. Altri nomi eccellenti: Luciano Violante , magistrato fino al 1979 quando diventa deputato per il Pci e poi presidente della Camera; Franco Frattini , ex magistrato amministrativo diventato vicesegretario alla presidenza del Consiglio nel 1993 e poi ministro degli Esteri e commissario Ue; Antonio Di Pietro , ex pm di "Mani pulite", che lasciò la toga nel 1994 in diretta tv per diventare poi ministro dei Lavori pubblici nel Governo Prodi, senatore dell'Ulivo e infine fondatore dell'Italia dei valori; Gerardo D'Ambrosio eletto per Ds quando era già in pensione, dopo una prestigiosa carriera giudiziaria che lo ha visto protagonista delle inchieste sulla strage di piazza Fontana, sul Banco Ambrosiano, fino al pool 'mani pulite e all'incarico di procuratore capo di Milano. Ma i nomi da citare sono tantissimi, dall'andreottiano Claudio Vitalone recentemente scomparso a Enrico Ferri, il ministro dei lavori pubblici famoso per il limite dei 110 all'ora e segretario Psdi; dal pretore d'assalto Gianfranco Amendola (eletto per i Verdi) a Ferdinando Imposimato (eletto in varie liste di sinistra); da Tiziana Parenti , passata dal pool di "Mani pulite" a Forza Italia e diventata presidente della commissione Antimafia, a Felice Casson , che dalle indagini su Gladio è passato alla candidatura a sindaco di Venezia e poi all'elezione in Parlamento nelle liste dei Ds prima e del Pd poi, ad Adriano Sansa, eletto sindaco di Genova e poi rientrato in magistratura. L'elenco completo sarebbe troppo lungo, ma non si può fare a meno di nominare Francesco Nitto Palma, eletto in Forza Italia e sottosegretario all'Interno; Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd in Senato; Giuseppe Ayala, eletto senatore Ds e poi tornato in magistratura come consigliere alla Corte d'appello di L'Aquila; Alfredo Mantovano, parlamentare di An e sottosegretario all'Interno.
Anche i giudici contestano: «Basta giudici in politica», scrive Errico Novi il 19 Marzo 2017 su "Il Dubbio". Dopo il caso Minzolini, che fu condannato da un ex parlamentare, torna in primo piano il dibattito sui pm in politica. Slegare il caso Minzolini da quello dei magistrati in politica? Impossibile. Anzi il voto che ha impedito la decadenza del senatore costringe lo stesso Pd a scongelare la legge sulla candidabilità delle toghe, ibernata da 3 anni a Montecitorio. E soprattutto è la stessa magistratura a scuotersi per vicende come quelle di Giannicola Sinisi, il giudice ed ex deputato che ha condannato l’avversario Minzolini, o di Michele Emiliano, che da pm in aspettativa vuol fare il segretario di partito. L’ultima, pesante presa di posizione è quella di Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia: «Non ho nulla contro i magistrati che scelgono la politica ma non dovrebbero più tornare all’attività giurisdizionale, una volta cessati dal mandato», dice. Una richiesta pesante che va ben oltre il ddl atteso per lunedì nell’aula di Montecitorio. Lì si prevede che un magistrato non possa candidarsi nel distretto in cui ha esercitato le funzioni negli ultimi 5 anni. Una volta finito il mandato di parlamentare – o di premier, ministro, assessore o consigliere nelle amministrazioni locali – il giudice è ricollocato in Cassazione, se ne ha i requisiti, altrimenti in distretto diver- so da quello in cui è stato eletto. Non è certo la barriera invalicabile prospettata da Roberti. Nell’intervista a Tv2000 che andrà in onda oggi, il superprocuratore dice che a fine mandato «si dovrebbe essere assegnati in ruoli della pubblica amministrazione diversi da quelli di giudice o pm». Il Csm lo suggeriva in una delibera dell’estate 2015, ignorata dal Parlamento. Carlo Nordio lo ha ripetuto in interviste e nei suoi editoriali sul Messaggero. C’è chi come Gherardo Colombo prefigura una soluzione light come quella di Montecitorio ma, in un’intervista a Repubblica, chiarisce: «Io, se mai avessi deciso di entrare in politica, prima di candidarmi mi sarei dimesso». La schiera di chi è per soluzioni drastiche è ben presidiata. Annovera anche il presidente dell’Anm Piercamillo Davigo, che le porte girevoli tra magistratura e partiti non le tollera proprio. Chi come Gianrico Carofiglio ha da tempo smesso la toga è altrettanto netto. La magistratura più avvertita non vuole farsi più prendere in castagna. Magari da casi come quello di Minzolini, dietro cui si nascondeva in realtà l’incredibile parabola del giudice ed ex deputato che lo aveva impallinato.
Giustizia: Roberti (procuratore antimafia), “magistrati in politica non tornino indietro”, scrive il 17 marzo 2017, "Agensir". “Non ho nulla contro i magistrati che scelgono di passare in politica, ma dovrebbero non tornare più nell’attività giurisdizionale una volta finita la vita politica, tornando nel settore pubblico e nella pubblica amministrazione, con ruoli diversi da quelli di giudice o pubblico ministero”. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, in un’intervista a “Soul”, il programma-intervista di Tv2000 condotto da Monica Mondo in onda sabato 18 marzo alle ore 12.15 e alle 20.45 in occasione anche della Giornata per le vittime della mafia che si celebra il 21 marzo. “Non scenderei mai in politica – ha rivelato Roberti – non ho mai pensato a farlo. Ho molto rispetto per la politica, è la più nobile delle attività umane quando è volta al bene comune e dei cittadini. Quando ha interessi personali, di gruppo o di lobby, invece, è la più bassa. La gente ha questa percezione, ma ho conosciuto tanti esponenti politici che sono persone veramente intenzionate a ben operare nell’interesse dei cittadini. Spesso prevalgono le logiche dei partiti, di gruppo, di appartenenza o quelle mafiose. Questo inquina la vita politica, come quella civile, l’economia e il mondo delle professioni. Bisogna combattere contro tutto questo”. “Bisogna distinguere caso per caso – ha sottolineato Roberti – le situazioni di sovrapposizione tra legge e giustizia. I magistrati hanno giurato fedeltà alla Costituzione: siamo chiamati a tutelare i diritti di tutti i cittadini che è l’essenza dell’attività giurisdizionale. I magistrati non si sostituiscono al legislatore, ma cercano di raccogliere la domanda di giustizia che proviene dai cittadini. Credo che in un rapporto di reciproca e leale collaborazione i magistrati devono anche dare indicazioni al legislatore, quando non interviene a dovere prima, senza fare qualcosa di creativo ma in una interpretazione estensiva non spinta da ideologie”.
Intervista a Carlo Nordio: “Pm e politica? La legge si fa in un giorno”. Intervista di Errico Novi il del 21 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Il magistrato Carlo Nordio commenta il ritardo accumulato dal Parlamento sulla norma che dovrebbe limitare le candidature dei giudici, reclamata dal Consiglio d’Europa.
«Disegno preordinato contro la magistratura? No, non è l’idea che mi sono fatto. Non è che ci vogliono affossare: vedo solo incapacità di comprendere i problemi della giustizia e sostanziale indifferenza». Carlo Nordio è disincantato, non scorge perfide macchinazioni, non cede al dietrologismo neppure ora che la mancata estensione della proroga lo mette a un millimetro dalla pensione, prevista il 6 febbraio e a questo punto, per lui, quasi inevitabile. Semplicemente diffida della capacità del legislatore «in materia di codice penale come di trattamento di noi magistrati». Aggiunto a Venezia, svolge funzioni di capo perché il 1° gennaio è già andato in pensione il procuratore Luigi Delpino: dopo una brillante carriera di inquirente assapora il gusto un po’ agrodolce di una funzione direttiva da svolgere per altre due settimane appena.
«Ma il pensionamento arriva per me a un età giusta. Il problema non è personale ma ordinamentale: senza la proroga sono già andati in pensione 100 magistrati a gennaio, ancora di più si congederanno nei prossimi mesi, si tratta di uno tsunami senza precedenti per i vertici degli uffici, del tutto insensato: non si risparmia una lira, i magistrati anziani al massimo della carriera percepiscono una pensione identica all’ultimo stipendio. Almeno una parte di noi andrà sostituita, le nuove assunzioni hanno un costo e poi non è che si entra in servizio il giorno dopo aver vinto il concorso…».
Il suo scetticismo riguarda anche le regole sull’attività politica dei giudici: reclamate l’altro ieri dal Gruppo anti– corruzione ( Gr. e. co.) del Consiglio d’Europa.
«Quella che giace ora in Parlamento si può approvare in mezza giornata».
È ferma da quasi tre anni.
«Partiamo dal richiamo di Strasburgo. Tra richieste di trasparenza sul reddito dei giudici e di controlli sulla gestione dei fascicoli, si adombra lo spettro di magistrati corruttibili o almeno pesantemente condizionabili. E questo, me lo lasci dire, non ha senso. Alla magistratura italiana si possono cointestare tante cose, ma a parte casi rarissimi non è la corruzione il problema. Casomai lo sono certe scelte improprie come quella di fare politica.
La proposta di legge è passata al Senato ed è ferma a Montecitorio da quasi tre anni, come ha ricordato il laico del Csm Zanettin.
«Premessa: resto convinto che ai magistrati l’attività politica vada impedita persino quando sono ormai in pensione. Diventa un problema a maggior ragione quando si tratta di inquirenti che hanno condotto inchieste ad altro coefficiente politico: la loro attività può finire per essere letta come un preordinato disegno per prepararsi una cuccia calda prima di andare a riposo. E poi c’è un’altra ragione, più sottile ma altrettanto importante.
Quale?
«Un magistrato che magari si è guadagnato una certa fama con la propria attività, se entra in politica finisce per sfruttare quell’immagine alterando così la par condicio con gli altri candidati.
È un’ammissione che le fa onore.
«Non ho problemi a riconoscerlo perché lo verifico di persona: mi capita cioè di essere fermato per strada e di sentirmi dire ‘ ah, è stato proprio bravo con quell’inchiesta sul Mose, dovrebbero fare tutti come lei…’. Vero o falso che sia, ho fatto semplicemente il mio dovere e non credo che da questo sia giusto ricavare vantaggio.
Il Csm suggerisce di impedire il rientro in magistratura a chi è stato in Parlamento.
«Certo che non dovrebbe rientrare. L’unico problema è che per limitare l’ingresso in politica o il ritorno alle funzioni giurisdizionali credo serva almeno inserire in Costituzione una riserva di legge. Con la Carta vigente si rischia di violare il principio di uguaglianza».
La legge ferma a Montecitorio si limita a vietare per due anni l’esercizio della funzione di magistrato nello stesso collegio dove si era stati eletti.
«E per una norma del genere non serve ritoccare la Costituzione: la si approva in mezza giornata».
Ma i deputati della commissione Giustizia dicono: abbiamo accantonato quel testo perché nel frattempo abbiamo cambiato il codice antimafia, le norme sulle confische, le pene per il caporalato e tanto altro ancora.
«Ho presieduto una commissione per la riforma del codice penale: parliamo di strutture complesse e organiche, ed è sempre un errore modificarle in modo frazionato, o le si rende sempre più instabili. Il nostro codice porta ancora le firme di Mussolini e Vittorio Emanuele III, su materie come la disponibilità del diritto alla vita è tipicamente fascista. Meriterebbe di essere cambiato radicalmente, non di volta in volta con l’eliminazione di discriminanti sui diritti di difesa, con nuove aggravanti, nuovi reati o nuove pene».
E invece questo si è fatto.
«Se uno apre il codice trova più frasi in corsivo che in grassetto, vuol dire che soppressioni e aggiunte superano la norma originale: così la certezza del diritto va a ramengo. Ai politici d’altra parte interessa finire sui giornali con le leggine ad hoc, che assecondano l’emotività del momento, come per l’omicidio stradale».
D’accordo, si è esagerato che l’introduzione di nuovi reati, ma se per regolare almeno un po’ l’attività politica di voi giudici basta mezza giornata, perché non lo hanno fatto? Avevano timore di mettersi contro di voi?
«Questo è di gran lunga il governo che ci ha maltrattato di più. Altre volte abbiamo subito aggressioni, ma da quelle è più facile difendersi. Stavolta siamo stati semplicemente presi in giro, e almeno su questo sono d’accordo con Davigo. Parlo delle norme sui trasferimenti come di quelle sulle pensioni».
Condivide la decisione dell’Anm di disertare la cerimonia in Cassazione?
«Sì, la risposta dell’Anm è stata la migliore, sono sempre stato contrario allo sciopero e d’altra parte un segnale forte andava dato: non partecipare alle inaugurazioni è la cosa più giusta».
Due giorni prima Davigo vedrà Orlando.
«L’incontro del 24 rischia di essere una barzelletta: nell’occasione precedente c’era anche il presidente del Consiglio e agli impegni presi non è seguito nulla, stavolta c’è solo il ministro che è sempre lo stesso. Non vedo l’utilità ma chissà, spero si rendano conto dell’errore sulle pensioni».
Va a finire che la proroga arriva il giorno dopo che si sarà dovuto congedare lei.
«Eh già, ma vede, siamo preparati a tutto. Avremmo preferito ci fosse risparmiato un trattamento che non usano neppure le persone maleducate nei confronti delle colf. So solo che Venezia resterà nelle mani di un aggiunto costretto a fare il lavoro di tre persone, e che ci vorrà un anno per nominare un nuovo capo. Qui e in tanti altri uffici, e nessuno ha spiegato che senso abbia tutto questo».
Lo strano senso di Davigo per la politica. Il numero uno della Anm critica Michele Emiliano: "I magistrati non devono mai fare politica". Ma lui, pur non iscritto ad alcun partito, sono anni che la fa, scrive Ermes Antonucci su “Il Foglio” il 2 Marzo 2017. “Sono dell’opinione che i magistrati non debbano fare politica mai”. A dirlo, in maniera molto tranchant, è stato il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Piercamillo Davigo, intervenendo martedì sera alla trasmissione DiMartedì su La7. Il riferimento era al caso che sta coinvolgendo il governatore pugliese Michele Emiliano, frutto prevedibile dell’anomalo groviglio tutto italiano tra magistratura e politica, dove nella stessa persona (Emiliano) troviamo riunite le figure di magistrato, di candidato alle primarie di un partito politico (il Pd) e di testimone di un processo in cui è coinvolto il padre dell’ex presidente del Consiglio (vicenda Consip). Dunque, parlando del caso Emiliano, Davigo ha sbarrato la strada a ogni sconfinamento della magistratura in politica. E lo ha fatto non celando un certo senso di superiorità, come se i magistrati oggi possano fare politica solo se iscritti a un partito e come se lui spesso non avesse svolto attività sostanzialmente qualificabile come “politica”. Ci pare, infatti, che il presidente dell’Anm, pur non essendo iscritto a un partito, la politica – in senso lato e in forme diverse da quelle partitiche – la faccia da un pezzo. Non è politica dire, come ha fatto Davigo due minuti prima di lanciare il proclama anti-Emiliano, che la rottamazione delle cartelle esattoriali alla quale starebbe pensando il governo, nella sua piena autonomia di scelta di politica economica, “è una vergogna”? Non è politica negoziare per mesi con il governo per convincerlo a cambiare la legge sul pensionamento dei magistrati, tanto da minacciare il blocco delle aule di giustizia e disertando l’inaugurazione dell’anno giudiziario? Non è politica invocare l’introduzione per la lotta alla corruzione di “alcune norme che valgono per i mafiosi” (13 febbraio)? Non è politica chiedere di anticipare a prima del referendum costituzionale la discussione parlamentare sulla riforma penale (8 novembre)? Non è politica dire che “le nostre leggi sono fatte apposta per poter salvare i colletti bianchi” (7 novembre)? Non è politica dire che “se la riforma della giustizia viene approvata così com’è con un voto di fiducia per noi non va bene, aggrava i problemi e non li risolve”, se cambia “possiamo discutere” (2 ottobre)? Non è politica affermare che “la riforma della giustizia è inutile, se non dannosa” (25 settembre)? Non è politica dichiarare che “le leggi che aumentano le pene senza sapere a chi darle sono inutili” (19 giugno)? Non è politica dire che “è inutile la legge su chi segnala i reati nella Pubblica amministrazione” (17 giugno)? O descrivere il nuovo codice degli appalti come “tutta roba che non serve a niente” (10 giugno)? O affermare di “non vedere la necessità di una legge sulle intercettazioni” (20 aprile)? O sostenere che non serve una riforma della disciplina sulle intercettazioni perché “basta aumentare le pene per la diffamazione, il resto è superfluo” (10 aprile)? Non rappresenta uno sconfinamento nella politica per un magistrato dichiarare pubblicamente, pochi giorni dopo essere stato eletto alla guida dell’Anm, che a distanza di oltre due decenni da Mani pulite “i politici continuano a rubare, ma non si vergognano più” (21 aprile)? La verità è che un magistrato può fare politica in tanti modi e l’iscrizione a un partito è solo la via di sconfinamento più evidente. In fondo, non erano iscritti a partiti i magistrati della corrente di Magistratura democratica che diversi mesi prima del referendum costituzionale decidevano di aderire e cavalcare pubblicamente la campagna per il “No”, con tanto di manifesto in cui veniva definita come “autoritaria” la riforma voluta dal governo Renzi. Ciò vuol dire che un magistrato non può in alcun modo intervenire pubblicamente per fornire la propria opinione su tematiche di interesse generale? Nessuno sta dicendo questo. L’ex procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio ha indossato la toga per quarant’anni, commentando spesso – e nell’ultimo periodo con buona frequenza, tanto da diventare quasi “editorialista” di un giornale nazionale – i fatti e le questioni di attualità (dal terrorismo alle forme di repressione penale), ma lo ha fatto sempre con la discrezione e la sobrietà che il rilievo pubblico della funzione di magistrato dovrebbe imporre. E senza mai mostrare simpatie o iscriversi a questo o quel partito, ma anzi ribadendo fino all’ultimo – anche nell’intervista al nostro giornale pubblicata lo scorso 7 febbraio – la sua assoluta contrarietà a ingressi in politica da parte dei magistrati persino dopo il loro pensionamento. È comprensibile, va ammesso, che una simile riflessione sull’esigenza di un atteggiamento di self restraint da parte dei magistrati, fatichi ad affermarsi nel nostro paese. Dopotutto, sono passate quasi inosservate le dichiarazioni espresse dalla deputata-magistrata Donatella Ferranti nei confronti dello stesso Emiliano (“Scelga: o il partito o la toga”), lei che non solo è una toga eletta con il Pd, ma presiede la commissione Giustizia della Camera. Quella chiamata, invano, ad esaminare da due anni una proposta di legge sulla candidabilità e l’eleggibilità dei magistrati in occasione delle elezioni politiche.
Chi critica l’ingiustizia dei giudici in politica, scrive Sabato 11 marzo 2017 Aldo Grasso su "Il Corriere della Sera". Diceva Piero Calamandrei: «Quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra». Sante parole. Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia, bacchetta a dovere il governatore Michele Emiliano: «È un caso limite. Per un magistrato un conto è partecipare attivamente alla vita politica, mettendosi ovviamente in aspettativa. Altro è non solo iscriversi a un partito, ma entrare nella sua direzione, al punto da candidarsi alla guida». Difficile darle torto. C’è un però. Anche la Ferranti è magistrato. Prima al Csm ai tempi di Rognoni e Mancino e poi il salto in politica nel 2008: capolista Pd nel collegio Lazio 2. Non sono pochi i magistrati in aspettativa che siedono al Parlamento: Felice Casson, Anna Finocchiaro, Doris Lo Moro, Stefano Dambruoso, Cosimo Ferri, Domenico Manzione… In aspettativa, ma con avanzamenti di carriera! Una vera ingiustizia. La Costituzione all’articolo 51 garantisce l’elettorato passivo a tutti i cittadini, anche ai magistrati, ma prevede, all’articolo 98, che la legge limiti per le toghe, come per i militari, le forze dell’ordine, i diplomatici (di mio aggiungerei i giornalisti), l’iscrizione a un partito. Si può, certo, ma poi uno cambia mansione. Per certe professioni occorre essere e apparire al di sopra delle parti. E qui sta la fatale distinzione fra ciò che è legale e ciò che è legittimo. Si può imporre la legge, ma non la prudenza.
Mattarella a giovani toghe: "Non smarrire mai senso del limite". Il Presidente della Repubblica al Quirinale per la cerimonia con i 610 giudici ordinari in tirocinio, alla presenza del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini e del ministro della Giustizia Andrea Orlando, scrive il 6 febbraio 2017 "La Repubblica". "Anch'io ho svolto il ruolo di giudice costituzionale e ho avuto modo di constatare il valore del confronto e della dialettica. Eppure in quegli anni ho sentito anche la tensione di dover rendere giustizia. Non fatevi condizionare da nulla se non dall'applicazione della legge. Neppure da quel sottile senso di solennità che deriva da questo ambito in cui operiamo. Occorre non smarrire mai il senso dei propri limiti particolarmente di quelli istituzionali". Così, a braccio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per la cerimonia con i 610 magistrati ordinari in tirocinio, alla presenza del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini e del ministro della Giustizia Andrea Orlando. Mattarella, rivolgendosi alle giovani toghe, ha sottolineato come sia "un'esortazione che rivolgo innanzi tutto a me stesso perché in questo salone così solenne tutto esprime un senso di autorevolezza e, operando in questo ambiente, occorre non smarrire mai il senso dei propri limiti, particolarmente di quelli istituzionali. Nel corso della vostra carriera ogni tanto, se vi è possibile, cercate di rammentare questo mio sommesso suggerimento". "I magistrati hanno un compito molto importante" dice il capo dello Stato ricordando la sua esperienza di giudice costituzionale, "ho apprezzato fortemente la grande, fondamentale utilità del confronto dei punti di vista e della dialettica delle opinioni: fa conseguire un arricchimento progressivo". Il Presidente spiega che "l'equilibrio nell'esercizio della funzione giudiziaria consiste nel sapere evitare il duplice rischio di applicazioni meccanicistiche delle norme o di letture arbitrariamente 'creative' delle stesse". "Equilibrio, ragionevolezza, misura, riserbo sono virtù che, al pari della preparazione professionale, devono guidare l'agire del magistrato in ogni sua decisione. Lo spirito critico verso le proprie posizioni e l'arte del dubbio, l'utilità del dubbio, sorreggono sempre una decisione giusta - spiega Mattarella - frutto di un consapevole bilanciamento tra i diversi valori tutelati dalla Costituzione". La magistratura, nella nostra recente storia, sono ancora le sue parole, "ha dimostrato di avere tutti gli strumenti per garantire il riconoscimento dei diritti, senza condizionamenti. È un bene che sia sempre più orgogliosa della sua funzione insostituibile, ma anche consapevole della grande responsabilità che grava sulla sua azione". La giustizia, rileva il capo dello Stato, "è una risorsa fondamentale, ancor più per un Paese integrato nella comunità internazionale. È un servizio che contribuisce a garantire l'ordinato sviluppo civile e sociale". Secondo Mattarella, proprio al fine di assicurare la più efficace tutela dei diritti "al magistrato è garantita autonomia e indipendenza nelle sue decisioni che, per essere credibili, devono essere sorrette da una solida preparazione, frutto di un assiduo impegno professionale". In questo modo, conclude il Presidente, "evitando di correre il rischio dell'arbitrio si tutela al meglio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura".
Parlamento in attesa di giudizio. Così il destino di una legislatura è nelle mani delle sentenze, scrive Michele Ainis il 22 gennaio 2017 su "L'Espresso". Chi comanda a Roma? Dipende dalle vendemmie, dalle annate. Nel 2011 comandava il capo dello Stato (Napolitano); nel 2014 il presidente del Consiglio (Renzi); nel 2017, a quanto pare, comanda la Consulta. L’11 gennaio, negando il referendum sui licenziamenti, ha allungato la vita della legislatura; il 24 gennaio, decidendo sull’Italicum, può stabilirne i funerali. Nel frattempo ogni sentenza genera un clima di suspense, s’iscrive in un giallo aperto a ogni finale; mentre la politica attende trattenendo il fiato, inerte, come paralizzata. Il vuoto d’iniziative sulla legge elettorale ne è la prova più eloquente. Ma è normale quest’alone d’incertezza sulle pronunce giudiziarie? In qualche misura, sì: il diritto non è una scienza esatta, altrimenti non ammetterebbe appelli e contrappelli. Oltremisura, no: un conto è la discrezionalità degli organi politici, un conto è il capriccio degli organi giurisdizionali. Quando i tribunali si sostituiscono invece ai Parlamenti, quando ne insidiano il primato, si manifesta un pericolo che può ben essere letale per le democrazie: il governo dei giudici, «government by judiciary». Quest’espressione risale all’alba del secolo passato, sull’una e sull’altra sponda dell’Atlantico. Venne coniata nel 1914 dal Chief justice della Corte suprema del North Carolina, per denunciare i rischi del controllo giudiziario sulla costituzionalità delle leggi («una perversione della Costituzione»); in Europa fu esportata da un libro francese del 1921. Da allora in poi s’aprì una storia di baruffe, di colpi incrociati. Memorabile il conflitto che oppose il presidente Roosevelt alla Corte suprema degli Stati Uniti, durante gli anni Trenta, quando quest’ultima respinse alcune tra le riforme più significative del New Deal. Anche in Italia, però, non sono state rose e fiori. Non per nulla la Consulta rischiò d’essere abortita già in Assemblea costituente, per la veemente opposizione di Togliatti; ma la Dc difese con tenacia la creatura, salvo pentirsene alla prima occasione. Era il 1956, l’anno di “Lascia o raddoppia?”; la Corte costituzionale esordiva nel nostro ordinamento, sia pure con 8 anni di ritardo rispetto alla Costituzione; e calò subito la scure su alcune norme poliziesche ospitate nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Da qui l’ira di Tambroni, ministro democristiano dell’Interno; peraltro imitato perfino dal papa, Pio XII. Nei decenni successivi la protesta si è trasformata non di rado in rissa, in insulto, in improperio. Per esempio da parte di Pannella: «Corte Beretta» (1981), «strumento del regime» (1985), «suprema cupola della mafiosità partitocratica» (2004). Da parte di Berlusconi, con il suo ritornello sulla «Corte comunista». Da governatori regionali come Formigoni (nel 1997 dipinse la Consulta come un «organo partigiano, ulivista, anzi della parte peggiore e più retriva dell’Ulivo»). O anche da ministri come Guido Carli, che nel 1990 mise alla berlina le sentenze costituzionali «di spesa», presentando il conto dinanzi all’opinione pubblica: 53 mila miliardi in un decennio, quasi un quarto dell’intero deficit dell’epoca. D’altronde due anni prima, nel 1988, un’accusa analoga era risuonata per bocca di chi l’aveva preceduto al ministero del Tesoro. Il suo nome? Giuliano Amato, che adesso siede proprio alla Consulta. La vita è una giostra, come no. Ma su quella giostra i giudici costituzionali non si limitano a incassare calci e ceffoni dai politici; talvolta li restituiscono, aggiungendo qualche grammo di curaro. Come fece, per esempio, il presidente Granata, in una conferenza stampa del febbraio 1999: la Consulta aveva riscritto le norme sui pentiti, sollevando critiche e dissensi; lui reagì con parole di fuoco al fuoco sparato dal Palazzo. O come fece, con toni ancora più furenti, il giudice Romano Vaccarella. Nel maggio 2007 si dimise, puntando l’indice contro tre ministri (Chiti, Mastella, Pecoraro Scanio) e un sottosegretario (Naccarato). La loro colpa? Pressioni sull’inammissibilità del referendum elettorale, uno dei tanti su cui la Corte costituzionale si è trovata a giudicare in questi anni. Secondo Vaccarella, insomma, nell’occasione il controllato cercò di controllare il proprio controllore. In Italia può succedere, ma può anche succedere il contrario. Ossia che l’arbitro diventi giocatore, che una sentenza prenda il posto della legge. Specie se la legge latita per l’impotenza o per la negligenza dei politici. È il caso della stepchild adoption: negata dal Parlamento, concessa dalla Cassazione (sentenza n. 12962 del 2016). Ma già nel 1975 furono i giudici ordinari a codificare il diritto alla privacy (la legge intervenne soltanto nel 1996). E sempre i giudici, ben prima dei politici, nel 1988 offrirono tutela al convivente more uxorio. Una Repubblica male ordinata reca più danni d’una tirannia, diceva nel Cinquecento Donato Giannotti. È esattamente questo il morbo che intossica la nostra vita pubblica; e la Consulta, da parte sua, non è affatto vaccinata. Altrimenti non si spiegherebbero certe iniziative, certe scelte politiche travestite da responsi oracolari. Come il rinvio dell’udienza sull’Italicum: era fissata al 4 ottobre, ma un paio di settimane prima (il 19 settembre) sbucò un comunicato di rinvio, senza uno straccio di motivazione. Anche se la motivazione trapelava fra le righe: il referendum costituzionale di dicembre, guai a sovrapporre l’una e l’altra decisione. Così adesso, a referendum consumato (e fallito), la politica riprende il centro della scena. Ma è politica giudiziaria, è sentenza costituzionale, l’unica forma di politica che resta ancora in auge.
Prontuario post-democratico per il Paese dove è vietato votare, scrive Tommaso Cerno il 23 gennaio 2017 su "L'Espresso". Siamo l’unico Stato occidentale senza una legge che consenta le urne. E la Consulta ha il dovere di indicarci una via d’uscita: ma è normale? L’Espresso, dopo il flop elettorale di Matteo Renzi al referendum e la straripante vittoria dei No (non dico del No, perché le sfaccettature erano molte), titolò facendo il verso alla storica frase attribuita a Ernesto Che Guevara: “Hasta elezioni siempre!” Significa, letteralmente: “Sempre fino alle elezioni!”. In quel frangente, qualche cerchiobottista e qualche spaventato esponente del Pd ridotto com’è ridotto, ci criticò dicendo che non avevamo a cuore la democrazia rappresentativa, quella dei Padri, per intenderci, perché adesso c’era da fare un governo tecnico-politico, c’era da pensare un nome, c’era da riflettere sul senso di responsabilità e sulle scadenze, sul G7 di Taormina e via elencando. Insomma, c’era da prendere tempo. Tutto giusto e tutto vero. Salvo per un dettaglio che, soprattutto dopo avere pontificato per mesi sulla Costituzione e il suo valore simbolico prima ancora che materiale, dopo avere tirato in ballo i partigiani e la memoria delle dittature, pesa come un macigno sull’Italia furbetta che cerca una strada per recuperare elettorato e credibilità politica. E non è nemmeno questione di vitalizio, come vanno molti ripetendo per strappare un applauso qua e là. Certo c’è del vero nell’onorevole ingordigia di prebende, basta guardare lo storico delle legislature. Ma, in questo caso, per un liberale, c’è in gioco qualcosa di più profondo, su cui vale la pena fare una riflessione. Detta in poche parole: è vero che in Italia, paese democratico (dove cioè governa il popolo attraverso una delega) la Costituzione non prevede che si vada al voto dopo un No al referendum, essendoci una maggioranza parlamentare che sostiene un governo. Ma è altrettanto vero che mai i padri costituenti si sarebbero immaginati un Paese dove, all’improvviso, è vietato votare. Non vi è cioè una legge elettorale in vigore. Ora mi domando se questo sia normale. Pur senza arrivare al modello americano, alle prese con il passaggio Obama-Trump, che ha fissato in Costituzione tanto la legge elettorale quanto la data delle elezioni (si sa già oggi con certezza in che giorno si voterà fra quattro, otto, dodici, sedici anni), il caos italiano ci porta a essere privati a tempo, ma nella sostanza, di un diritto delle democrazie. Eppure il diritto - per essere tale - deve essere “di tutti” e “sempre”. Altrimenti si classifica come privilegio. Deve cioè vivere sia quando serve esercitarlo, sia quando non è necessario. Qualcuno dirà: di leggi non ne abbiamo una, ma tre. Inutili, però. C’è l’Italicum giudicato dalla Consulta che - in ogni caso - si sarebbe potuto applicare a una sola Camera, vista la sicumera di chi lo presentò e approvò, all’epoca convinti che l’abolizione del Senato (poi bocciata dagli italiani) fosse scritta nelle stelle. Ne abbiamo un’altra, abrogata da quest’ultima, l’ex Porcellum poi Consultellum, che non potrebbe essere usata in caso di emergenza come estintore democratico. Ne abbiamo poi una terza, sepolta nella Seconda repubblica, il Mattarellum, che per curiosa coincidenza porta oggi il nome del Capo dello Stato garante della Carta. Ma nemmeno essa esiste nella realtà. Per questo, la settimana che si apre è fondamentale. Dobbiamo mettere fine a questa anomalia, ben più grave del rapporto deficit-Pil sforato, ben più perniciosa per il nucleo caldo della convivenza democratica di quanto possa essere la modifica (più o meno riuscita) del Senato della Repubblica. Sappiamo che Non basterà la sentenza. Non basterà in se stessa e non basterà al parlamento avido di mettere le mani sulla materia elettorale, in quanto meccanismo diabolico capace di perpetuare o meno le poltrone di Montecitorio e di Palazzo Madama. Ma l’importante è che l’Italia comprenda che le regole del voto sono una priorità democratica. E si smetta di ripetere che abbiamo altre urgenze. È ovvio che lottare contro la disoccupazione e la criminalità, rispondere all’emergenza immigrazione, prevenire i disastri naturali con politiche urbanistiche è il compito concreto di uno Stato moderno. Ma solo dentro una democrazia compiuta, sana e matura, libera da legacci, questo Stato può trovare la forza (e la credibilità) di presentarsi al popolo per fare delle proposte. Uno Stato che al contrario considera il diritto di voto una questione secondaria non può farlo. Per sua stessa natura insalubre. Perché riduce la delega popolare a pura formalità.
L'Italicum e la Consulta, quella piccola corte sempre più potente. La decisione sulla legge elettorale la prenderà un conclave silente e paludato. Che vive di riti e rifiuta la trasparenza. Ma conta sempre di più, nel vuoto del Parlamento, scrive Denise Pardo il 24 gennaio 2017 su "L'Espresso". L’archivio è previsto persino dal regolamento, ma chi avrebbe avuto il potere si è ben guardato dal costituirlo. Non c’è traccia dell’attività della Corte Costituzionale. «Coperta dall’oblio eterno in ossequio a una sbagliata concezione del segreto» ha scritto il giudice emerito Sabino Cassese, «la Corte ha deciso di cancellare i documenti della sua storia. Nessuno dei più segreti atti di Stato è mai rimasto coperto per sempre dal segreto». Una prassi che non esiste in nessun’altra Corte al mondo, il contrario di quella Suprema americana, inno alla trasparenza. Il sontuoso palazzo della Consulta, secoli fa di proprietà pontificia rimesso a nuovo un attimo dopo il tramonto dei Borgia, resta inespugnabile all’esterno. Ma, nessun altro luogo in questo momento è più centrale. E più misterioso. In uno scenario globale dove tutto si svela, la Corte costituzionale continua a rimanere un enigma. Il papa ha un account Twitter, il Quirinale anche, persino l’ultranovantenne regina d’Inghilterra non si è sottratta. Ma la Corte non informa. Se trapela qualcosa è un oltraggio. Al massimo materializza un laconico comunicato stampa firmato «dal Palazzo della Consulta» a opera forse di un Belfagor del posto, ossessiva custode della delicatezza del ruolo. E delle implicazioni e possibili chine di pressioni politiche, ben conscia che davanti a lei si staglia l’ombra del Quirinale, con il monito presidenziale di un ex giudice costituzionale, Sergio Mattarella, il primo a aver attraversato la strada. C’è la fitta nebbia del potere intorno ai riti, ai ritmi, alle segrete stanze, alle posizioni dei suoi giudici, giuristi, magistrati, politici, spesso quirinabili, come Cassese, Conso, Amato, riuniti nella sala del consiglio, un tavolo ovale, i microfoni neri, gli affreschi alle pareti. Pochi alieni a quel mondo hanno varcato il portone. Molti hanno scritto dei privilegi, gli stipendi, le auto blu, gli autisti, l’immunità, il costo del funzionamento oltre 60 milioni di euro all’anno. Se ne conoscono i componenti e anche i patimenti ogni volta che vanno scelti e nominati, 31 sedute e altrettante votazioni un anno fa per assegnare dal Parlamento tre posti vacanti da mesi. Per il Pd il costituzionalista Augusto Barbera, massimo esperto di leggi elettorali, non un fan del Mattarellum; per i Cinque Stelle il suo collega Franco Modugno, e per Area Popolare Giulio Prosperetti, giuslavorista e giudice della Corte d’Appello della Città del Vaticano. Con una politica sempre più debole, incapace di dare risposte e certezze, la Corte è diventata l’unico topos risolutivo. Nel Palazzo che protegge e ripara, i tredici giudici, dovrebbero essere quindici, un trio di cinquine nominate dal Colle, dal Parlamento e dalle alte magistrature, abbigliati due-tre volte l’anno come una pièce in costume, Giuliano Amato con i volants della camicia e la toga d’ordinanza è da dipinto di Goya, hanno studiato la costituzionalità delle leggi più importanti degli ultimi anni (ogni norma può essere rimessa alla Corte), gli ultimi governi hanno dato molto lavoro, Berlusconi in testa. E ora il segno della futura governance del Paese spetta di nuovo alla Corte con il responso più atteso di quel che resta dell’amministrazione Renzi: la costituzionalità dell’Italicum, relatore il giurista Nicolò Zanon, ex laico del Csm, vicino al Pdl, anche consultato dall’ex Cavaliere per un parere pro veritate. Il 24 gennaio il giorno x, data di partenza in un senso o nell’altro della legge elettorale di una sconosciuta nuova era politica. I giudici hanno l’obbligo della discrezione, ha ricordato questa settimana incupito il presidente emerito Gustavo Zagrebelski dopo che sulla sentenza clou dell’11 gennaio, quella sul Jobs Act, ancora il governo Renzi sulla graticola, chiusa con un no al referendum della Cgil sull’articolo 18, un sì per quelli su voucher e appalti, sono scappati all’esterno particolari scandalosi. Per esempio che la relatrice Silvana Sciarra, giuslavorista di Firenze indicata dal Pd, seguace, secondo alcuni colleghi più moderati, più di Maurizio Landini che del suo vero maestro Gino Giugni, avrebbe voluto allargare la consultazione referendaria anche all’articolo 18. Posizione contraria a quella di Amato, il vincitore del confronto, in campo con Prosperetti e Mario Rosario Morelli, magistrato della Corte di Cassazione, i relatori degli altri due referendum. Sui giornali è uscita anche la conta dei voti, otto a cinque, una proporzione di contrari troppo alta per la media tacitamente consentita perché «il punto essenziale per capire il lavoro della Corte è il principio di collegialità», ha specificato una volta la vice presidente Marta Cartabia, allieva del presidente emerito Valerio Onida, scelta da Giorgio Napolitano (come Amato, Daria De Pretis e il presidente Paolo Grossi) segnalata a un certo punto perfino come quirinabile. E così stimata da provocare uno sconquasso dopo la nomina a vice presidente che sarebbe spettata a due giudici ben più anziani. Tanto che ora, pazienza per il regolamento, i vice presidenti sono dovuti diventare tre, oltre a lei, Giorgio Lattanzi, presidente di sezione della Corte di Cassazione e Aldo Carosi, consigliere dalla Corte dei Conti. In realtà, la promozione era propedeutica alla poltrona più alta della Corte secondo un brain storming di Napolitano e Cassese uno dei pochi giudici a rifiutare lui la presidenza arrivata di diritto per anzianità di nomina ma di brevità di durata rispetto alla naturale scadenza. Dettaglio che non turba tutti, visto che il circolo dei presidenti emeriti è affollatissimo da chi ha accettato di presiedere soltanto per poche settimane: un mese e 14 giorni Vincenzo Caianiello, tre mesi e due giorni Giuliano Vassalli, tre mesi e 4 giorni Giovanni Maria Flick, tre mesi e dieci giorni Giuseppe Tesauro, battezzati nello slang della Corte i “balneari”. Con i suoi legni dorati, i damaschi di seta, i lampadari dalle cento luci, i corridoi silenziosi, la Consulta ha un clima da conclave. Per le cerimonie i commessi aiutano la vestizione, la toga nera rassettata a Diana De Petris, ex potente rettore dell’università di Trento, il collare dorato da posizionare a regola d’arte al presidente Paolo Grossi, professore di Storia del diritto italiano, stimatissimo anche se, per segnalare lo snobismo giuridico dell’ambientino, alcuni costituzionalisti puri non dimenticano l’argomento della sua tesi discussa nel 1955, secondo le biografie, sul regime giuridico delle abbazie benedettine nell’Alto Medioevo italiano. Per Cassese la Corte è un misto tra un convento e un collegio di studenti. Nel 2015 ha osato l’inosabile scrivendo “Dentro la corte”, diario sulla sua esperienza di giudice, intento apprezzato e normale nelle aule di Yale, meno alla Consulta. Senza citare nemmeno un nome ha memorizzato i nove anni «incandescenti» segnati da sentenze storiche. Sul tavolo della Camera di consiglio, tra pennichelle, bigliettini che passano da un giudice all’altro, giudici che hanno studiato e altri meno diligenti, sono stati esaminati il lodo Alfano, l’ammissibilità dei referendum sulla legge elettorale, il caso delle intercettazioni al Presidente della Repubblica, la costituzionalità del Porcellum. Ma anche leggi che segnano pesantemente la vita privata delle persone, com’è stato il via libera alla fecondazione eterologa o le udienze pubbliche sulla “Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso” o persino la “Mancata depenalizzazione dell’ingiuria tra i militari”. I giudici si danno subito del tu e si chiamano per nome. In Camera di consiglio il “vicino di banco”, soprannominato così come alla scuola materna, del primo giorno rimane lo stesso per nove anni. La Corte diventa un gruppo. I padroni del diritto sono molto competitivi sulla qualità giuridica delle argomentazioni e meno esigenti sul menù che trovano alla buvette all’ultimo piano del palazzo mentre il secondo è riservato solo ai loro uffici. L’obiettivo è favorire la comunicazione lontano da occhi indiscreti quando durante “la settimana bianca”, che non è dedicata al pattinaggio su ghiaccio, ma è quella senza sedute pubbliche e di consiglio, si studia, ci si confronta in incontri a due, massimo a tre. Secondo le fonti, anonime perché terrorizzate, non c’è affiliazione automatica tra i giudici di nomina parlamentare, tra i giuristi o i magistrati. Valerio Onida, invece, stando a Milano nella “settimana bianca” percepiva al suo ritorno che i romani si erano scambiati idee e punti di vista. La prima donna nominata alla Corte è stata Fernanda Contri, poi Maria Rita Saulle. Per lungo tempo, la Cartabia è stata l’unica in mezzo a soli colleghi maschi, solo dopo sono arrivate Sciarra e De Petris. «La Corte non è tra gli organi più solleciti a realizzare la parità di genere», ha ammesso Amato. «Ora su 15 giudici tre sono donne. E sono fiducioso perché c’è stato anche un momento in cui se ne vedeva una sola circondata da quattordici maschi come non capitò nemmeno a Biancaneve perché i nani erano sette, esattamente la metà». Adesso, via via che la data del responso sull’Italicum si avvicina, l’atmosfera si surriscalda e la Corte entra nel mirino di chi teme la contaminazione politica, il condizionamento (difficile dimenticare, l’episodio, rivelato dall’Espresso, del giudice Luigi Mazzella a cena con Silvio Berlusconi al tempo del lodo Alfano, eccezione non commentabile). Ritornano a galla annosi interrogativi. In un paese in cui si cambia legge elettorale quanto i premier è giusto ricorrere ogni volta alla Corte? Poi, si domanda qualcuno, è stata una scelta tecnica o politica aspettare il 24 gennaio allontanando così le elezioni anticipate? Forse è arrivato anche il momento di costituire un archivio, magari prendendo esempio dal Conseil constitutionnel francese che dopo venticinque anni rende pubblici i suoi verbali, evitando misteri e arcani. Molti anni fa in America Bob Woodward, quello del Watergate, e Scott Armstrong hanno pubblicato un memorabile libro sulla Corte suprema, titolo «The Brethren» i confratelli. Chissà cosa scriverebbero della Consulta.
“Ma quale pensione! A noi magistrati piace il potere…”. Intervista a Guido Salvini, giudice al Tribunale di Milano che interviene nella polemica tra l’Anm e il ministro Orlando, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 2 febbraio 2017 su "Il Dubbio". Abbiamo chiesto al dottor Guido Salvini, attualmente giudice del Tribunale di Milano, la sua opinione su alcuni temi che in questi giorni stanno facendo molto discutere. Non ultima, la rinnovata polemica sulla modifica delle prescrizione del reato.
Consigliere, l’Associazione nazionale magistrati ha disertato l’inaugurazione dell’Anno giudiziario per protesta contro il governo che non ha portato a 72 anni il pensionamento dei magistrati. Cosa pensa di questa scelta?
«Anche a me il pensionamento a 72 anni sembra una via di mezzo ragionevole tra i 70 e i 75, ma da qui sino a minacciare anche uno sciopero contro il governo ne passa. Giudico l’enfasi di questa protesta un caso di falsa coscienza, di quelli in cui non si vuole riconoscere nemmeno dinanzi a sé stessi le ragioni di un comportamento e lo si riempie con qualcosa di non vero».
Si spieghi meglio.
«La magistratura è l’unica categoria di lavoratori che chiede con insistenza di lavorare più a lungo. E la strenua opposizione dei magistrati all’abbassamento dell’età della pensione mi convince poco, forse non riguarda che marginalmente l’attenzione per i cittadini. Più semplicemente esprime lo sgomento per l’accorciarsi del tempo del proprio prestigio e potere personale. Negli anni il potere della magistratura si è molto espanso, tocca tutti i campi della società, come ha ricordato anche il ministro Orlando, e le aspettative dei singoli sono la conseguenza di questa espansione. In questo senso parlo di falsa coscienza».
Lei partecipa di solito all’inaugurazione dell’Anno giudiziario?
«No, l’inaugurazione dell’Anno giudiziario mi sembra una cerimonia ormai superata, anche sul piano estetico: quelle toghe d’ermellino rosse credo suscitino più che interesse un senso di lontananza, sembra un anti- co conclave, qualcosa che per il cittadino assomiglia più ad un rito che a un momento di servizio in suo favore».
Andrebbe abolita la cerimonia?
«Basterebbe un incontro meno paludato e più asciutto, solo con qualche relazione, magari in una sala del Consiglio comunale o in un altro luogo più aperto alla città».
Tornando alle pensioni quindi per lei la mancata posticipazione non è una catastrofe per la giustizia?
«Non credo, anche perché quando si parla di giudici che mancano si evita sempre di considerare le decine e decine di magistrati che, anche da moltissimi anni, non svolgono le funzioni giurisdizionali, perché sono collocati fuori ruolo in incarichi ministeriali, politici, internazionali spesso superflui e per i quali basterebbe di norma un buon funzionario».
Come spiega questa corsa al “fuori ruolo”?
«Questo avviene perché incarichi di questo genere sono un prestigio per i prescelti e, per la categoria, una delle porte girevoli tra politica e giustizia, porte che non dovrebbero esistere o essere ridotte al minimo».
In effetti ci sono magistrati che svolgono compiti che nulla hanno a che vedere con la giurisdizione…
«Infatti. Non si parla mai, quasi nessuno lo sa, delle centinaia di magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali ridotte perché fanno parte delle numerose strutture di supporto che il Csm ha voluto: è il caso dei magistrati segretari del Consiglio, di coloro che fanno parte delle Commissioni organizzative, delle Commissioni per l’informatica, delle Commissioni scientifiche. Anche qui basterebbe a seconda dei casi un buon tecnico, un funzionario o uno studioso e negli altri gli incarichi non dovrebbero ridurre le presenze in udienza».
Possiamo dire che far parte di questo mondo parallelo alla giurisdizione serva a far carriera?
«La partecipazione a queste strutture, in cui si entra per cooptazione, è quasi sempre un passaggio obbligato per ottenere poi dallo stesso Csm gli agognati posti direttivi».
Cambiamo argomento. Diritto all’informazione e processo mediatico, un valore e un disvalore che secondo lei dovrebbero essere meglio bilanciati?
«La giustizia spettacolo e gli show in televisione che partono già all’inizio dell’indagine e rischiano di condizionarne gli sviluppi sono un problema tutto italiano. Non credo che negli altri Paesi europei dopo ogni delitto eclatante si assista in televisione a processi paralleli con opinioni senza alcun freno. Chi vi partecipa è complice di questa stortura. A parte questo, un problema ormai irrisolvibile, si dibatte da anni sui limiti reciproci tra giustizia e informazione».
È pessimista, a riguardo?
«Il problema è complesso ma credo che vi sia un punto essenziale: nessuno, grande o piccolo, antipatico o simpatico che sia, deve avere notizia per la prima volta dalla stampa di una sua iscrizione nel registro notizie di reato, di una proroga indagini, di una intercettazione, di un atto che lo riguarda».
Come si potrebbe fare?
«Non dovrebbe esserne consentita la pubblicazione sino ad un momento preciso, non troppo avanti rispetto alla notizia, ma ben definito. Quello in cui l’interessato, indagato o testimone, abbia avuto la possibilità davanti a un magistrato di dare la sua versione su ciò di cui è accusato o su quanto stanno dicendo di lui. Una soluzione civile che dovrebbe essere studiata anche con l’aiuto dell’Ordine dei giornalisti, il quale non credo debba essere contento che i suoi scritti funzionano da semplici postini».
Un’ultima domanda. Cosa ne pensa del dibattito sulla prescrizione?
«Non bisogna dimenticare che vi sono due piani e che anche se si allunga la prescrizione rimane il problema della ragionevole durata dei processi, questione spesso offuscata dalla prima. Si può allungare la prescrizione per certi reati anche a 15 anni, ma se il processo di primo grado si celebra dopo 7 o 8 anni chi viene condannato e soprattutto chi viene assolto è sottoposto ad un meccanismo che non può riconoscere come una giustizia accettabile. L’esigenza non è solo quella di allungare la prescrizione ma anche di avvicinare i processi, altrimenti il processo stesso diventa una pena aggiuntiva anche per l’innocente».
L'intoccabile "irresponsabilità" dei magistrati. Il ministero della Giustizia: in due anni 115 citazioni, una sola condanna finora in appello. Intanto gli errori giudiziari dal 1992 ci costano 691 milioni, scrive Maurizio Tortorella il 23 gennaio 2017 su Panorama. Il ministro della Famiglia, Enrico Costa, ha reso noti i costi esorbitanti che la giustizia italiana si trova a pagare per risarcire gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni. Soltanto nel 2016, ha rivelato Costa, sono stati spesi per queste due voci 42,1 milioni di euro. Il computo totale dal 1992 al 2016 è di 648,3 milioni di euro per le ingiuste detenzioni e di altri 43,4 milioni per errori giudiziari. La polemica di Costa, che ieri ha dichiarato "dovremmo dibattere meno di età pensionabile dei magistrati e più di queste profonde lesioni della libertà personale", riaccende inevitabilmente il faro sul tema, più che annoso, della responsabilità civile delle toghe. Quando nel febbraio 2015 il Parlamento varò la legge 18, che modificava la norme sulle responsabilità civile dei magistrati, quella riforma venne trionfalmente presentata dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi come una mezza rivoluzione, l'intervento che avrebbe finalmente sbloccato l'anomalia italiana dell'assenza di sanzioni per i danni causati da una toga, e insieme la norma che avrebbe rimediato all'inganno legislativo rappresentato dalla legge Vassalli del 1988, che aveva tradito il voto popolare rappresentato da una schiacciante maggioranza di consensi al referendum popolare proposto dai radicali. Va ricordato, infatti, che la Legge Vassali era stata così pienamente ed eccessivamente garantista, nei confronti dei magistrati, che dal 1989 e fino a tutto il 2014 gli italiani avevano presentato in tutto 410 citazioni per responsabilità civile. Se si considera che in quei 26 anni soltanto i procedimenti penali aperti sono stati all'incirca 52 milioni, le citazioni presentate rappresentano appena lo 0,0008% del totale. Ma gli italiani avevano piena ragione di essere scettici: le loro citazioni ammesse al vaglio dell'autorità giudiziaria furono appena 35, nemmeno una su dieci. E quelle che vennero reputate degne di essere accolte furono in tutto sette. Sette, in 26 lunghissimi anni. Nelle settimane precedenti all'entrata in vigore della riforma del febbraio 2015, l'Associazione nazionale magistrati manifestò tali spropositate reazioni ("questo è un attacco mortale alla nostra autonomia"), che il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, promise avrebbe messo in piedi un sistema per controllare che la riforma non straripasse in eccessi puntivi nei confronti della categoria. «Faremo un tagliando», garantì Orlando. Vale la pena di ricordare sommessamente che due anni fa, ascoltate le grida di giubilo da una parte, e le terrorizzate lamentele dall'altra, Panorama sostenne che i magistrati non avevano nulla da temere e che i politici non avevano nulla da festeggiare, perché nulla in realtà sarebbe cambiato. Ora siamo arrivati a un primo redde rationem. Eccessi puntivi? Autonomia uccisa? Risate. A distanza di due anni, purtroppo, i dati danno ragione al pessimismo di Panorama. Perché è vero che (udite, udite!) sono aumentate le azioni di responsabilità per "dolo o colpa grave" nei riguardi dei magistrati, ma il numero delle condanne resta del tutto "insignificante". Il ministero della Giustizia, dopo i controlli eseguiti in omaggio alla promessa di Orlando, rivela con evidente soddisfazione che "non si è, finora, verificato il temuto aumento esponenziale del contenzioso". Ed è proprio il governo a utilizzare l'aggettivo "insignificante" per descrivere il numero delle condanne: nemmeno una in tutto il 2015; e una sola condanna d'appello nel 2016. Dall'entrata in vigore della legge, infatti, è vero che gli esposti sono più che raddoppiati, passando da 35 (nel 2014) a 70 nel 2015 e a 80 del 2016. Ma la quota di condanne - tutte non definitive, perché finora parliamo di sentenze di Corte d'appello e nessuna vicenda è ancora arrivata al giudizio finale - è pari allo 0,01%. Insomma, la riforma della responsabilità civile si è risolta in una farsa, forse in un inganno anche peggiore rispetto a quella che era stata varata nel 1988. I magistrati dell'Anm possono quindi riposare in pace: l'autonomia della categoria non ha subito alcun attacco, tantomeno l'assalto mortale che temevano due anni fa. Le toghe restano pienamente, irriducibilmente "irresponsabili".
Magistrati premiati con stipendi più alti. Anche quelli che sbagliano tanto, scrive Annalisa Chirico, Martedì 24/01/2017 su "Il Giornale". Ci sono dei numeri che, considerati isolatamente, non destano sorpresa, ma accostati gli uni agli altri fanno una certa impressione. La Ragioneria dello Stato ci informa che in dieci anni la retribuzione media per chi lavora alla presidenza del Consiglio è cresciuta del 45 percento, per i diplomatici del 37 percento, per chi indossa una toga del 28,4. In particolare, rispetto al 2005 la remunerazione dei magistrati è aumentata, in media, di otre 30mila euro toccando quota 138.481 euro. Com'è noto, gli stipendi dei magistrati non dipendono dal numero di sentenze prodotte o di ore trascorse in ufficio, la produttività non c'entra nulla, i loro salari sono il risultato di automatismi previsti dalla legge. Sulle colonne di Repubblica compaiono i dati aggiornati relativi ai risarcimenti che lo stato versa nei casi di ingiusta detenzione ed errore giudiziario. Si apprende che dal 1992 a oggi il ministero dell'Economia ha sborsato 648 milioni di euro per il carcere ingiustamente inflitto agli innocenti, e 43 milioni per gli errori di pm e giudici nell'interpretazione di fatti e norme. Se guardiamo soltanto allo scorso anno, scopriamo che lo Stato - vale a dire noi contribuenti - ha pagato dieci milioni di euro per risarcire le persone danneggiate da un errore giudiziario ad opera degli stessi magistrati i cui stipendi nel frattempo sono aumentati progressivamente. Ammontano invece a trenta milioni gli indennizzi corrisposti alle vittime di arresti preventivi sproporzionati e ingiusti. In altre parole, in questi anni sono aumentate le spese per le vittime e contestualmente si sono gonfiati i salari degli autori degli errori. Vale la pena notare che mentre i casi di errore giudiziario acclarati nel 2016 sono in tutto sei (con cifre esorbitanti come i sei milioni e mezzo in un singolo caso a Reggio Calabria), gli episodi di detenzioni ingiuste che hanno dato luogo al risarcimento sono quasi settecento. Viene da chiedersi se qualche sanzione sia stata comminata nei confronti dei magistrati che hanno sbagliato, travisato una prova, richiesto o autorizzato l'arresto, poi annullato, di una persona innocente. Sono domande tanto più urgenti alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Se l'appuntamento annuale non vorrà ridursi a una rituale sfilata di ermellini ed establishment, sarà bene che i vertici della magistratura affrontino, senza infingimenti, la stridente anomalia di stipendi che aumentano al pari dei risarcimenti per errori e arresti facili. Colpisce che a far emergere i dati sull'entità dei risarcimenti sia stato Enrico Costa, avvocato appassionato e ministro della Famiglia e degli Affari regionali. «Se dibattessimo meno di età pensionabile dei magistrati e più di queste profonde lesioni della libertà personale, non sarebbe male», ha commentato Costa nelle stesse ore in cui il ministro della Giustizia in carica, Andrea Orlando, prosegue lungo la via del tenace dialogo con il numero uno dell'Anm Piercamillo Davigo. Chissà se, tra un discorso e un altro, tra una lamentazione corporativa e un'altra, il vertice del sindacato delle toghe formulerà una riflessione sul paradosso di stipendi e indennizzi. Qualcuno dovrebbe chiedergliene conto.
Corruzione, il Consiglio d'Europa all'Italia: "Roma limiti i giudici in politica". Il Gruppo di stati anticorruzione (Greco) rende pubblico un rapporto con dodici raccomandazioni rivolte al nostro Paese, tra cui anche regolare i "conflitti di interessi" dei politici e salvaguardare l'integrità delle commissioni tributarie, scrive il 19 gennaio 2017 "La Repubblica". Limitare la partecipazione dei magistrati alla politica. E regolare con norme più stringenti i "conflitti di interessi" dei deputati. Sono due delle dodici raccomandazioni che il Gruppo di stati contro la corruzione (Greco), organo del Consiglio d'Europa, ha rivolto all'Italia in un rapporto dedicato al nostro Paese, approvato il 21 ottobre 2016 ma reso noto solo oggi. Magistrati. E allora per prima cosa Roma deve introdurre leggi che pongano limiti più stringenti per la partecipazione dei magistrati alla politica, e mettere fine alla possibilità per i giudici di mantenere il loro incarico se vengono eletti o nominati per posizioni negli enti locali. "È chiaro che la legislazione italiana contiene diverse lacune e contraddizioni a tale riguardo, che sollevano dubbi dal punto di vista della separazione dei poteri e della necessaria indipendenza e imparzialità dei giudici" recita il dossier di Greco. L'organismo afferma che pur "riconoscendo l'indiscutibile reputazione, professionalità e impegno dei singoli magistrati" è suo compito "segnalare l'effetto negativo che qualsiasi presunta politicizzazione della professione può avere sulla percezione che i cittadini hanno dell'indipendenza dell'intera magistratura". Parlamentari. Quanto ai politici, invece, bisogna che l'Italia introduca norme "chiare e applicabili" per regolare "la spinosa questione" del conflitto d'interessi dei parlamentari. Perché, si legge ancora nel rapporto, "questa situazione insoddisfacente si traduce in un processo piuttosto difficile di verifica delle possibili cause di ineleggibilità e incompatibilità, che rischia di compromettere l'efficacia dell'intero sistema". Secondo gli esperti, infatti, "le regole esistenti sono difficili da applicare" e questo "va a scapito della complessiva trasparenza e efficienza del sistema". Nel documento si sottolinea che "l'alto numero di leggi e disposizioni, i relativi emendamenti e una generale mancanza di consolidamento e razionalizzazione delle norme, conduce a un quadro confuso del conflitto d'interessi". Questo "crea problemi per l'applicazione delle regole esistenti e anche della loro comprensione". Tribunali fiscali. Il Consiglio d'Europa accende un faro anche sui tribunali fiscali, sottolineando la necessità di applicare più misure e strumenti per assicurare l'integrità dei membri delle commissioni tributarie, anche a causa "degli scandali in cui recentemente sono stati coinvolti i componenti non appartenenti alla magistratura", dice ancora il rapporto. Greco raccomanda dunque di adottare "misure appropriate per migliorare il controllo sulla professionalità e l'integrità dei componenti delle commissioni tributarie, con l'introduzione di un sistema di valutazione periodico e corsi di formazione regolari anche su questioni etiche e sulla prevenzione della corruzione". Prescrizione. Greco non manca poi di evidenziare "l'allarmante" numero dei processi penali non conclusi a causa della prescrizione. Nonostante vengano riconosciuti gli sforzi italiani - come l'introduzione di sanzioni più dure, l'ampliamento delle definizioni dei reati, l'istituzione dell'autorità nazionale anticorruzione - tuttavia vi sono ancora diverse questioni da risolvere, tra cui "il problema dei tempi di prescrizione dei reati". Una "seria preoccupazione" già espressa nei rapporti precedenti, per "l'impatto negativo sui casi di corruzione". Il gruppo d'esperti che ha valutato l'Italia "si rammarica che una riforma di una questione così cruciale non sia stata ancora attuata".
Il regime di Orlando o il regime di Davigo? Scrive Piero Sansonetti l'1 Febbraio 2017. C’è una stampa di regime che fiancheggia il ministro Orlando nella sua crociata contro la magistratura? Lo sostiene il giornale ufficioso dei Pm – Il Fatto Quotidiano – nell’editoriale del direttore, pubblicato ieri in prima pagina. Prima di tutto bisognerebbe capire bene cosa si intende per regime. Il “regime Gentiloni”? O addirittura il “regime Orlando”? Non credo che ci voglia moltissima fantasia per capire che in Italia, in questo momento, il rischio politico è il caos e l’ingovernabilità, non certo il regime. Ci sono almeno tre schieramenti in corsa per vincere le elezioni politiche (con pari possibilità). E’ il regime del ministro Orlando o di Davigo e dei maestri dell’Etica? Epoi ci sono un bel gruppetto di partiti e sottopartiti che cercano un loro spazio, voci di scissioni, di riaggregazioni, eccetera. Non succedeva esattamente così né nell’Italia di Mussolini né nella Russia di Breznev. In genere nei regimi c’è una sola lista elettorale che è in grado di vincere le elezioni (se ci sono le elezioni), non è legale l’opposizione. Ma allora perché il Fatto, e il suo “vate”, il dottor Davigo, si ostinano a parlare di regime? Credo che ci siano due ragioni.
La prima è la necessità di difendere una richiesta corporativa dell’Anm (l’associazione magistrati guidata da Davigo) e cioè l’aumento dell’età della pensione. Richiesta praticamente indifendibile davanti all’opinione pubblica.
La seconda è una ragione di potere. Se ci fate caso, è quasi sempre così: quando, in democrazia, si parla di regime, chi ne parla serba in qualche angolo del suo animo una sua propria aspirazione al regime. O comunque a un forte aumento del proprio potere. C’è un settore importante – anche se forse non maggioritario, ma egemone – della magistratura, che si è convinto della necessità di aumentare il proprio potere. Non è detto che questo desiderio sia originato semplicemente da ambizioni personali o da fini oscuri; anzi, molto probabilmente dipende in larghissima parte da un altro fattore: la convinzione che la società sia corrotta e che sia corrotto lo Stato, e che dunque occorra una drastica azione di pulizia, e che questa azione non possa essere condotta in un regime fortemente democratico e di equilibrio di poteri, ma solo in presenza di un soggetto forte – e cioè la magistratura – che possa agire indisturbato, che possa far prevalere il sospetto sul diritto, che non debba rispondere a nessuno. E’ una specie di pulsione autoritaria originata da una spinta etica. E non è detto che l’aspetto più pericoloso di questo fenomeno sia l’aspetto autoritario: forse è proprio l’aspirazione all’etica, che in alcuni casi diventa la culla del fondamentalismo e dell’integralismo.
Nel caso specifico, Davigo e Travaglio contestano al ministro Orlando di volersi scegliere lui i giudici che gli fanno comodo. Fingendo di non sapere che nessun Pm e nessun giudice e nessun procuratore o presidente di nessun luogo o grado della magistratura è nominato dal governo, né in alcun modo il governo, o il ministro o chi per lui può influenzarne o pretenderne la nomina. In questo caso la polemica di Davigo e Travaglio è esplicitamente contro il Presidente della Cassazione, Giovanni Canzio. Per quale ragione? Canzio è un interprete molto rigoroso del diritto e un difensore dello Stato di diritto, e dunque – comprensibilmente e legittimamente – non sta molto simpatico a Davigo e Travaglio, che hanno un’idea diversa di giustizia, abbastanza lontana dallo Stato di diritto. Ma chi lo ha nominato Canzio? Il Consiglio superiore della magistratura. E da chi è composto questo consiglio superiore? Lo abbiamo già detto nei giorni scorsi: per i due terzi da magistrati scelti dagli altri magistrati secondo le indicazioni (per la verità un po’ partitocratiche o correnti– cratiche) dell’Anm, cioè del cosiddetto partito dei Pm guidato da Davigo. Sulla nomina di Canzio il governo ha avuto un peso pari a zero, l’Anm un peso enorme.
Diciamo che il governo, e Orlando, per ragioni di opportunità e per non lasciare la Cassazione senza una guida, quando è stato varato il provvedimento sulle pensioni a 70 anni per i magistrati (che ha fatto infuriare molti magistrati che in pensione non ci vogliono andare), ha concesso una proroga (non di un decennio: di un anno!) alle massime cariche in modo da non provocare traumi. Una proroga ai magistrati nominati dal Csm e scelti dall’Anm! E questa sarebbe l’ingerenza? E così si metterebbe in discussione l’autonomia della magistratura?
Ma avete una idea vaga di quale sia il potere dei governi, rispetto alla magistratura, negli altri paesi occidentali, dalla Francia agli Stati Uniti? Dieci volte superiore al potere dell’esecutivo in Italia. E allora di quale regime e di quali giornali di regime, si parla? Beh, forse qualche giornale di regime c’è, se posso fare un paradosso. In qualunque altro paese, dove la stampa è critica e autonoma, una sollevazione corporativa e scombiccherata come quella di Davigo e di una parte dell’Anm per ‘ sto fatto delle pensioni, sarebbe stata massacrata di critiche e di ironia, su tutti gli organi di informazione. Qui da noi silenzio. Perché la stampa, in larghissima parte, è subordinata alla magistratura e non osa criticarla o metterla in burla. Tutto qui. (E tuttavia, anche in questo caso, se parliamo di regime lo facciamo per puro spirito polemico).
P. S. Nello stesso articolo del “Fatto” del quale riferivamo, c’era un altro elemento interessante. Si diceva che per mettere in prigione, in Italia, tutti quelli che se lo meriterebbero, altro che le attuali carceri, “non basterebbero gli stadi! “. Oddio: Gli stadi? Come faceva Pinochet? Gli sarà scappata, d’accordo, però certe espressioni, quando scappano…
Orlando: «La magistratura ha in pugno le nostre vite», scrive Errico Novi il 19 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Nel suo intervento sullo stato della giustizia, il ministro rivendica l’importanza delle ispezioni sui magistrati. È una relazione ricca di traguardi raggiunti e obiettivi ancora da cogliere, quella che il guardasigilli Andrea Orlando ha proposto ieri alle Camere sullo stato della giustizia. Ma è anche l’occasione per riaffermare alcuni aspetti decisivi del sistema, a cominciare dall’enorme peso della magistratura. «La nostra azione è stata rivolta a garantire che i controllori siano sottoposti ad altri controllori rispondenti soltanto alla legge, nella piena garanzia del principio di separazione dei poteri», ha affermato il ministro nei due rami del Parlamento a proposito dell’attività ispettiva di via Arenula, «e questa vigilanza deve essere tanto più stringente, tempestiva ed efficace in quanto riguarda poteri in grado di incidere in modo fortissimo e talvolta persino irreparabile sulla vita dei cittadini». Andrea Orlando affronta per prima l’aula del Senato. È lì di fatto che apre l’anno giudiziario, considerato che la relazione al Parlamento letta in mattinata a Palazzo Madama e poi a Montecitorio, è il primo atto delle inaugurazioni. L’assemblea presieduta da Pietro Grasso è d’altronde croce e delizia per il guardasigilli, luogo di confronti «proficui» ma anche di fatale paralisi del ddl penale. E se tra le obiezioni dell’emiciclo c’è anche un «difetto di franchezza» rilevato da Corradino Mineo, che pure apprezza complessivamente il ministro, va detto che Orlando dosa toni secchi e abili perifrasi anche quando parla del peso della magistratura. Quando cioè all’inizio della sua relazione ne segnala l’immenso potere e la necessità di controllarlo: «La nostra azione è stata rivolta a garantire che i controllori siano sottoposti ad altri controllori rispondenti soltanto alla legge, nella piena garanzia del principio di separazione», dice il ministro, «e questa vigilanza deve essere tanto più stringente, tempestiva ed efficace in quanto riguarda poteri in grado di incidere in modo fortissimo e talvolta persino irreparabile sulla vita dei cittadini». È un passaggio che si intreccia con ripetuti richiami al populismo penale, all’eccessivo numero di reati e alla demagogia con cui se ne invocano sempre di nuovi. La cifra del garantismo e della ricerca di un equilibrio che faccia argine allo strapotere giudiziario, segna quella che potrebbe essere l’ultima relazione di Orlando da ministro della Giustizia. Non solo perché non è detto che la legislatura arrivi fino a gennaio 2018, ma anche perché il leader dei “giovani turchi”, in qualche accenno, lascia trapelare l’aspirazione a occuparsi di giustizia anche in senso lato, la necessità di «agire perché non sia fortemente diseguale la ricchezza della nazione», come dice alla fine delle sue comunicazioni. Obiettivi da aspirante segretario del Pd più che da guardasigilli. Non a caso, a proposito del ddl penale, di cui invoca di nuovo l’approvazione in Senato, afferma che se diverrà legge, determinerà «un passo di qualità che consentirà, al prossimo ministro della Giustizia, di fare una relazione in cui molti problemi possano essere considerati alle spalle». Sui magistrati e la necessità di non tralasciare la vigilanza sul loro operato, il ministro torna più volte, sia nella relazione sia nelle repliche agli interventi in Aula. Quando parla di controllori si riferisce in particolare al sistema delle ispezioni, condotte «senza ricerca di sensazionalismo» e accompagnate da un «monitoraggio statistico» sulle «performance degli uffici». Sarebbe bene che «il Csm voglia sempre più affidarsi a simili criteri» nella scelta dei capi degli uffici, «che deve procedere senz’altro con maggiore speditezza». E dovrebbero essere più celeri, sostiene Orlando, anche «le pronunce disciplinari» che lo stesso Coniglio superiore è chiamato a emettere sulla base dell’attività ispettiva di via Arenula: «Spesso arrivano troppo tempo dopo che è stato segnalato l’illecito». A proposito di responsabilità civile, il guardasigilli allude a un possibile effetto deterrenza, invisibile nelle statistiche a quasi due anni dall’approvazione della riforma: «Ora i magistrati sanno che in caso di negligenza inescusabile sono sottoposti a valutazione di merito come qualunque altro cittadino». Ma alla magistratura come a tutti gli altri soggetti chiamati ad assicurare il servizio giustizia, Orlando rivolge il suo ringraziamento. Lo fa anche nei confronti dell’avvocatura, che «credo possa salutare con soddisfazione il completamento dell’attuazione della riforma forense». Agli avvocati il ministro assicura anche di voler portare fino in fondo l’impegno per assicurare compensi decorosi pur in un quadro ormai privato da anni delle tariffe minime: «Ho già mandato un disegno di legge a Palazzo Chigi sul tema dell’equo compenso: lo ritengo un elemento caratterizzante dell’attività di governo. C’è ormai una sperequazione inaccettabile nel rapporto tra professioni e grandi soggetti finanziari ed economici». Ci sono, dice senza mezzi termini il guardasigilli, delle «compressioni dell’autonomia del professionista dettati da posizioni dominanti che credo siano da contrastare». Nell’intervento a più riprese del ministro c’è spazio per la difesa degli interventi compiuti sul carcere, dei riscontri anche internazionali alla deflazione del contenzioso sia penale che civile e al diffondersi delle soluzioni alternative al processo (i passaggi salienti sono riportati in altro servizio, nda) . E non manca l’impegno a portare al traguardo progetti di legge come la delega sul fallimentare e la riforma civile, entrambi necessari per «dare sistematicità all’intervento realizzato finora per via amministrativa e con strumenti normativi diffusi». Ma è inevitabile che Orlando, soprattutto a Palazzo Madama, insista sui contenuti del ddl penale: ricorda che il testo sulla prescrizione è «un compromesso positivo», e che la delega sulle intercettazioni «è necessaria nonostante le circolari delle Procure vadano nella direzione auspicata: non si può essere esposti al rischio di usi impropri solo perché nella città dove si vive il capo dell’ufficio non ha dato le stesse istruzioni». Nella replica non manca di rispondere sui nodi sollevati dall’Anm con l’annunciata protesta contro il decreto Cassazione: «Sui termini per i trasferimenti siamo venuti incontro alle richieste e abbiamo posticipato l’applicazione del nuovo regime quadriennale. Sulle pensioni, la reazione mi pare eccessiva: è l’unico punto che resta e ora c’è un presidente del Consiglio diverso». Il che conferma l’impressione che alcune scelte compiute con Renzi premier siano state concepite a Palazzo Chigi più che a via Arenula.
Se il totalitarismo è giudiziario, scrive Pierluigi Battista il 15 gennaio 2017 su "Il Corriere della Sera". A Roma non si sa dove e quando e come potranno essere collocate le bancarelle dei libri (che ci sono da sempre, e sono un meraviglioso momento di sosta) perché lo deve stabilire la magistratura. Nel Texas la Apple è stata messa sotto accusa giudiziaria perché un automobilista, usando FaceTime mentre era alla guida, aveva violentemente urtato un’altra macchina provocando la morte di una bambina che era a bordo. La colpa è di aver inventato la app per le videochiamate senza la funzione che la disattiva nei veicoli in movimento. Cioè la colpa non è solo del deficiente criminale che fa videochiamate mentre guida, ma della società che non ha previsto l’esistenza di un deficiente criminale che guarda dentro al telefonino ammazzando la gente con la macchina che guida. Intanto in Italia si stabilisce che le leggi elettorali non le fa il Parlamento ma la Corte Costituzionale. La quale Corte Costituzionale aveva già deliberato su importanti provvedimenti di politica economica del governo, come l’intervento sulle pensioni. Con l’approvazione della legge sulle unioni civili, pare non abbia molta importanza la disciplina della stepchild adoption perché valuteranno i magistrati caso per caso. E del resto, l’assenza di una legge sul testamento biologico demanda alla magistratura anche l’ultima parola sui temi decisivi come la vita e la morte. La magistratura francese può decidere se a un intellettuale è permesso di sottolineare i pericoli dell’islamismo politico senza essere portato in tribunale come «islamofobo». In Italia la magistratura può disporre il sequestro giudiziario, con conseguenze economiche notevolissime, della centrale termoelettrica di Vado Ligure mentre in un’altra regione un’altra centrale identica può continuare a lavorare con gli stessi livelli di inquinamento accertati dalle autorità sanitarie e ambientali. Cosa ci dice questa macedonia di casi tanto diversi tra loro? Cosa hanno in comune tutti questi episodi? Hanno in comune in tutto il mondo lo strapotere della dimensione giudiziaria su ogni altro aspetto della vita pubblica. La «giuridicizzazione» radicale e totale dei rapporti sociali, politici, economici, antropologici in cui si imbatte l’umanità. L’idea che l’ultima parola spetti sempre a un’autorità giudiziaria. In Italia e ovunque. Vi sentite tranquilli nel mondo del totalitarismo giudiziario?
Toghe alla guerra dei privilegi: disertano l'anno giudiziario. Anm contro il governo: protesta per pensioni e trasferimenti. Ma è scontro tra le varie correnti, scrive Anna Maria Greco, Domenica 15/01/2017, su "Il Giornale". L'Anm accusa il governo di non aver rispettato gli impegni e per protesta diserterà la cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario, il 26 gennaio in Cassazione. Per la prima volta il «sindacato» dei magistrati non sarà dunque presente tra gli ermellini nell'Aula magna del Palazzaccio di Roma, luogo finora non investito dai venti di contestazione perché il dissenso si esprimeva solo alle inaugurazioni nelle Corti d'appello. Due elementi, nel corso della riunione di ieri del Comitato Direttivo Centrale, hanno fatto decidere l'associazione delle toghe a rompere la tradizione: pensioni e trasferimenti dei magistrati. Il Guardasigilli Andrea Orlando si dice disponibile a discutere, ma ormai è tardi. «La Giunta aveva condotto con il governo e con il ministro della Giustizia - spiega il presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo - una trattativa per ricondurre l'età pensionabile, anche se in via transitoria, a 72 anni e a riportare il vincolo di permanenza dei magistrati di prima nomina da 4 a 3 anni. Gli impegni non sono stati rispettati, nonostante la dichiarata continuità del governo attuale con quello precedente». Si riferisce al fatto che è ristretta ad un pugno di alti magistrati l'ultima proroga per allontanare l'età della pensione, che l'ex premier Matteo Renzi ha portato per tutti da 75 a 72 anni. E il suo governo aveva assicurato che almeno sui giovani di prima nomina non sarebbe pesato l'allungamento da 3 a 4 anni del periodo minimo di permanenza in un ufficio prima di chiedere un trasferimento, ma non è andata così. Nella base delle toghe monta un grande scontento, le correnti fanno a gara per raccogliere le lamentele e ad infervorare ancor più il dibattito ci sono le elezioni al Csm del 2018 che si avvicinano. Il direttivo dell'Anm è stato già convocato per il 18 febbraio, per valutare altre iniziative prima della conversione in legge del Milleproroghe. C'è chi preme per lo sciopero, ma finora Davigo ha tenuto insieme i gruppi. Non senza danni, però, e proprio nella stessa corrente nata attorno al nome dell'ex star di Mani pulite, Autonomia&Indipendenza. Ieri, infatti, c'è stato un duro scontro nella riunione tra Davigo e il coordinatore di A&I, che insisteva sullo sciopero bianco. Lo aveva proposto anche Magistratura indipendente, l'altra corrente moderata, ma poi ha accettato il compromesso per consentire un accordo con le correnti di centro, Unicost e di sinistra, Area. Davigo ha lavorato per mantenere l'unità della magistratura, ma a Pepe la protesta in Cassazione non bastava. Voleva che A&I uscisse con un suo documento chiedendo lo sciopero bianco e rompendo di fatto l'unanimità. Il presidente dell'Anm alla fine si è imposto, nell'associazione e nella sua corrente, ma poi ha lasciato la seduta prima della fine, molto irritato dallo scontro con il suo secondo, al vicepresidente di Area Luca Poniz. Anche perché sembra che le liti con Pepe siano frequenti. La notizia è anche questa, dunque: la neonata corrente A&I rischia di implodere, per contrasti interni, proprio mentre Davigo si appresta a concludere ad aprile il suo anno di presidenza dell'Anm.
Pensioni e trasferimenti, toghe infuriate: il gesto estremo dei magistrati, scrive “Libero Quotidiano" il 14 gennaio 2017. L’Associazione nazionale magistrati diserterà la cerimonia, fissata per il 26 gennaio, di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione. È la forma di protesta, approvata all’unanimità dal direttivo del sindacato delle toghe, adottata dall’Anm per il "mancato rispetto degli accordi" da parte del Governo sui correttivi, chiesti dai magistrati, al decreto sulla proroga dei pensionamenti solo per alcuni (tra cui il presidente e il pg della Suprema Corte, Gianni Canzio e Pasquale Ciccolo) e sulla legittimazione ai trasferimenti. I rappresentanti dell’Anm parteciperanno invece alle inaugurazioni dell’Anno giudiziario nelle Corti d’appello sabato 28 gennaio. Si tratta della prima volta che viene attuata una protesta delle toghe durante la cerimonia in Cassazione, dove i vertici dell’Anm non svolgono di regola un intervento ma sono presenti tra gli ospiti nell’Aula magna di Palazzaccio. Negli anni passati, invece, iniziative di protesta si erano svolte durante le inaugurazioni nelle Corti d’appello. Il 26 gennaio, inoltre, il sindacato delle toghe predisporrà un documento che sarà anche illustrato ai giornalisti con una conferenza stampa e che sarà letto dai rappresentanti delle sezioni distrettuali dell’Anm durante le cerimonie nelle Corti d’appello. Sabato 28 gennaio, la Giunta centrale del sindacato delle toghe parteciperà a una delle inaugurazioni in Corte d’appello, presumibilmente la stessa a cui prenderà parte il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il direttivo dell’Associazione nazionale magistrati tornerà a riunirsi il 18 febbraio: in quella sede, discuterà ancora di eventuali iniziative di protesta, anche alla luce degli sviluppi dell’iter di conversione in legge del decreto Milleproroghe, a cui il Governo dovrebbe presentare un emendamento per modificare le norme in materia di legittimazione ai trasferimenti per le toghe.
Il Pm Gratteri: «E' pronta la rivoluzione giudiziaria», scrive Piero Sansonetti l'8 novembre 2016 su "Il Dubbio". Il compito della magistratura è quello di accertare i reati e perseguirli, o è invece quello di combattere alcune battaglie politiche? Nel luglio del 1948, a Roma, in piazza Esedra, si tenne una gigantesca manifestazione comunista. Avevano sparato a Togliatti, che era in fin di vita, e i militanti del Pci erano furiosi. Sul palco salì per il comizio Edoardo D'Onofrio, dirigente amatissimo, stalinista di ferro, alle spalle 10 anni nelle carcere fasciste. La gente cominciò a gridare: «Edo, dacci il là!». Volevano dire: dai un segnale e noi iniziamo l'insurrezione. D'Onofrio però aveva ricevuto un ordine preciso da Luigi Longo, il vice di Togliatti: «Niente rivoluzione». E allora rispose alla folla, scandendo le parole: «Non è questo il momento storico». La rivoluzione non ci fu, non ci fu la guerra civile (anche se ci furono violenze, scontri morti e arresti). Togliatti si salvò e la democrazia uscì salva e forte. Beh, colpisce il fatto che il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri (che pure non dà per niente l'impressione di essere comunista) abbia usato esattamente la stessa espressione: «Ho in testa una rivoluzione sul sistema giudiziario, ma non è ancora il momento storico». Naturalmente Edo d'Onofrio aveva ben chiaro che prima o poi la rivoluzione si sarebbe fatta. Poi invece, qualche anno dopo, nel 1956, ci fu la destalinizzazione, e Togliatti lo emarginò. Chissà come andrà a finire, invece, con Nico Gratteri...Il Procuratore di Catanzaro ha annunciato la rivoluzione (e il suo rinvio) nel corso di una intervista rilasciata a Lucio Musolino del "Fatto Quotidiano". È una intervista che inizia con una frase non nuovissima (per Gratteri) ma sempre abbastanza sorprendente. La trascrivo: «L'articolato di legge che abbiamo elaborato per aggredire maggiormente corruzione e mafie è nei cassetti del Parlamento, ma al momento nessuna forza politica lo ha preso in considerazione». Di che "articolato" si tratta? Gratteri spiega che si tratta di un vero e proprio disegno di legge, che prevede la modifica di circa 850 articoli tra codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario. A occhio croce la riforma riguarda almeno la metà dell'intero impianto legislativo che riguarda il diritto penale, visto che il codice penale e il codice di procedura, sommati, contengono attualmente circa 1500 articoli, dei quali però non più di 8 o 900 sono quelli davvero importanti. Di conseguenza Gratteri ci dice una cosa molto semplice: la sua commissione ha preparato una riforma radicale della giustizia. Noi non sappiamo bene cosa intenda Gratteri per rivoluzione giudiziaria, né per "momento opportuno". Certo sono espressioni molto preoccupanti, specialmente se pronunciate da un magistrato così potente, così famoso, così importante. Però sappiamo qualcosa sullo Stato di diritto e sulla separazione dei poteri. E allora ci vengono alcune domande, alle quali, magari, qualche autorità potrebbe anche rispondere. La prima domanda è questa: elaborare un articolato di legge non è compito che spetta al potere legislativo? La stessa Costituzione non prevede una separazione netta tra potere legislativo e potere giudiziario? E allora, è cosa normale che un magistrato elabori i disegni di legge? (A me sembra un po' come se si chiamassero i deputati a fare le sentenze, o almeno a dirigere le indagini preliminari sui delitti....). La seconda domanda è più spigolosa. La riassumo così: il compito della magistratura è quello di accertare i reati e perseguirli, o è invece quello di combattere alcune battaglie politiche? Gratteri parla della sua intenzione di "aggredire corruzione e mafie", ma è giusto che un magistrato si ponga l'obiettivo di combattere fenomeni sociali negativi? Non è forse, il compito di aggredire corruzione e mafia, un compito che spetta alla politica - sul piano dell'azione legislativa e culturale - e alla polizia sul piano militare? Non sono domande provocatorie, né sofismi: si tratta di capire quale sia l'orientamento politico e costituzionale prevalente nelle classi dirigenti italiane. Se bisogna gratterizzare la magistratura, e anche il Parlamento, sarà inevitabile porre mano, seriamente, alla Costituzione. Non con la piccola riforma Boschi, ma con un rivolgimento profondo, che cambi la natura dello Stato di diritto e ne riduca fortemente i confini. Vogliamo istituire una repubblica giudiziaria, che sostituisca la Repubblica parlamentare? Discutiamone, se volete, però bisogna avere il coraggio di dire le cose chiare, non basta sperare in quella riforma della "Costituzione materiale" che, in realtà, è già largamente in corso.
Aspettando la Terza Repubblica. Il saggio di Agostino Giovagnoli «La Repubblica degli italiani 1946-2016» (Laterza) ripercorre la storia dell’Italia postbellica: il vero «partito della nazione» è stato la Dc, scrive Andrea Riccardi il 20 ottobre 2016 su "Il Corriere della Sera". La Repubblica ha settant’anni. Non c’è festa però, anzi — osserva lo storico Agostino Giovagnoli — tra gli italiani «è diffusa l’insoddisfazione». Soprattutto per il presente, ma anche per il passato repubblicano, considerato, per i suoi errori e scelte sbagliate, all’origine dei problemi dell’oggi. Il debito pubblico appare il monumento degli errori del passato, che pesa sul futuro. Una storia sbagliata, che non si ama ricordare. Anche perché non è facile farlo, complessa com’è, con tanti attori e combinazioni: cangiante ma, alla fine, con una stabilità di fondo. È quanto emerge dal ricco volume di Giovagnoli, La Repubblica degli italiani 1946-2016, edito da Laterza, che spazia da De Gasperi «padre della Repubblica» fino al big bang del sistema tra il 1992 e il 1994, alla Seconda Repubblica e a quello che considera l’attuale passaggio a un nuovo assetto. È una storia, per tanti aspetti, bella e avvincente: non solo un succedersi di governi fragili né un gioco di alchimie politiche. Leggere questo volume riconcilia con la nostra storia appassionandoci a essa: gli italiani sono cresciuti sotto tanti punti di vista. Anche la disaffezione dalla politica o la protesta sono il frutto di un processo storico per cui gli abitanti della penisola sono divenuti pienamente cittadini. Non è una storia sprecata o solo una trama di errori. I primi decenni sono quelli della Repubblica dei partiti, per usare l’espressione di Pietro Scoppola: si passa dalla nazionalizzazione fascista delle masse alla partecipazione politica ed emotiva al destino della nazione attraverso i partiti. In questo quadro si staglia la Dc, «partito della nazione» (Alcide De Gasperi è il primo a usare l’espressione): il perno di un sistema di alleanze con un particolare rapporto con lo Stato. La classe dirigente democristiana, pur nella rapida successione dei governi, costituisce il presidio della stabilità e della continuità delle politiche nazionali e internazionali. La tensione, con ostacoli e battute di arresto, è allargare l’area di governo fino alla solidarietà nazionale con il Pci. Questo si accompagna a due aspetti rilevanti della Prima Repubblica: da una parte le ideologie e il dibattito delle idee che permeano la politica e, dall’altra, il radicamento capillare nella società e la mobilitazione degli italiani alla politica. In questo processo, Giovagnoli mette in luce il ruolo della Chiesa, l’istituzione più radicata nel Paese, preoccupata del pericolo comunista e sostenitrice della Dc. La svolta del Vaticano II scompone il solido blocco Chiesa-Dc. «Il mondo è cambiato» — scrive l’autore in un denso capitolo dedicato agli anni Ottanta. «Dalla società agli individui»: è un processo lungo (dal Sessantotto alla globalizzazione) che mette in discussione identità organiche e strutture che erano l’architettura della politica. Gli italiani cambiano prima della politica, tanto che questa, con la caduta del Muro e la globalizzazione, viene travolta. Sono il discredito dei partiti e la protesta a travolgerla, quasi una corrente carsica destinata più volte a riemergere e guadagnare consenso sino a oggi. La domanda è se siano ingredienti bastevoli a creare un’alternativa. Metà della Repubblica degli italiani è dedicata alla Seconda Repubblica: «È tramontato, in particolare, il rapporto tra élites e masse, mediato dai partiti…». Si disarticolano gli «universi politico-culturali» che, per quasi mezzo secolo, sono stati i pilastri della democrazia: quello comunista, laico-socialista, cattolico. Quest’ultimo, con il tramonto della Dc, è destinato a giocare un ruolo con la Cei del cardinale Camillo Ruini per il rapporto con Silvio Berlusconi e per l’affermazione del ruolo etico-culturale della Chiesa. Il bipolarismo non ricuce la «persistente frammentarietà» della politica e porta a «un sistema politico iperconflittuale». Se la Prima Repubblica, alla luce della storia e nonostante i problemi, non è un «buco nero» per Giovagnoli, i due decenni successivi sono quasi un interludio. Così crede l’autore, che dedica pagine acute in una prospettiva storica (tra i primi) a Berlusconi come un misto di antipolitica, di vecchia politica e d’interessi anche disparati: il decennio berlusconiano, poi, dal 2001 al 2011, parte nel clima dello scontro di civiltà dopo l’11 settembre 2001 e si solidifica nel «bipolarismo etico» del Paese. Nonostante i governi guidati da Romano Prodi abbiano inciso per varie decisioni e ancoraggio all’Europa, gli anni della Seconda Repubblica sono dominati dal clima impresso da Berlusconi, anche per chi gli si oppone. La lunga storia repubblicana, però, non è smarrita. In un certo senso parla dal Quirinale che, con gli anni Novanta, diventa un’istituzione cardine della democrazia, perdendo quel carattere notarile e cerimoniale che l’aveva in parte caratterizzato. Oscar Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano: tre storie personali diverse, ma tutte radicate nella cultura politica repubblicana, come si vede dai loro richiami e impulsi. Ma non solo: «Si deve a questi tre presidenti della Repubblica un impegno per contrastare il ripiegamento provincialistico della società italiana». La Seconda Repubblica ha rappresentato più una fase di assestamento che il raggiungimento di un nuovo equilibrio. Agostino Giovagnoli è convinto che questa storia, quella della Prima e della Seconda Repubblica, non debba essere consegnata però a una damnatio memoriae: senza conoscerla e senza sentirla come nostra, non si capiscono i problemi attuali, ci si abbandona a semplificazioni emotive. Per Giovagnoli, dal 2011 siamo oltre il secondo tempo della Repubblica. Il governo Monti è stato una rottura e una ricollocazione europea dell’Italia. Con Renzi, «molti aspetti dell’assetto bipolare, prevalsi per un ventennio, sono… definitivamente tramontati». Sorge, sul crinale del settantennio repubblicano, nonostante le difficoltà, una voglia di estroversione italiana nel mondo globale, anche se assediata da problemi e disaffezioni. La domanda è se si possa già parlare di una Terza Repubblica, anche con un nuovo assetto costituzionale.
Ma quale repubblica parlamentare? La nostra è una repubblica giudiziaria, scrive il 19 ottobre 2016 Francesco Damato su "Il Dubbio". Da 24 anni il Parlamento si è piegato al potere togato. Da quando Scalfaro decise che per formare il governo si doveva consultare il Procuratore di Milano...È un vero spreco di energie quello che si sta facendo nella campagna referendaria in difesa della Repubblica parlamentare voluta dai costituenti e minacciata, secondo gli avversari di Matteo Renzi, dalla sua riforma. Che farebbe diventare la Repubblica "oligarchica", ha sentenziato il presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky fra la sorpresa e le proteste di Eugenio Scalfari, convinto che l'oligarchia, intesa però solo come "classe dirigente", sia compatibile con la democrazia. In fondo - si potrebbe dire seguendo il ragionamento filologico di Scalfari - anche il Parlamento è oligarchico, poco importa se composto di quasi 1000 esponenti, come oggi, o di 730, come avverrebbe con l'approvazione della riforma. Alternativa all'oligarchia, sempre secondo il ragionamento di Scalfari, sarebbe la dittatura, non la Repubblica parlamentare che i critici di sinistra della riforma sentono minacciata. I critici di destra invece, preferendo la Repubblica presidenziale, ritengono che nella Costituzione riformata da Renzi rimanga ancora troppa Repubblica parlamentare, in cui i poteri del capo dello Stato e del presidente del Consiglio rimangono invariati. Eppure questi stessi critici di destra, convergendo con quelli di sinistra, accusano Renzi di avere voluto e portato a casa col cosiddetto Italicum una legge elettorale su misura delle sue ambizioni di potere: una legge peraltro ch'egli non difende più con l'ostinazione di qualche mese fa, disponendosi a cambiarla, ma anche prevedendo che potrebbe essere modificata da interventi della Corte Costituzionale, com'è accaduto alla legge precedente voluta dal centrodestra. Ma sono proprio sicuri, a sinistra e a destra, di vivere ancora in una Repubblica parlamentare, rispettivamente, da difendere o da superare? Né da una parte né dall'altra sembrano essersi resi conto che da almeno 24 anni, come documenteremo, viviamo in una Repubblica giudiziaria. Eppure a destra, almeno dalle parti di Silvio Berlusconi, è sistematico il richiamo al ruolo smisurato assunto dalla magistratura, alla quale la politica si arrende sistematicamente, anche dopo essersi proposta, come con Renzi appena approdato a Palazzo Chigi, di riprendersi il proprio "primato". Il fresco rinvio a dopo il referendum del 4 dicembre della riforma del processo penale dopo le proteste dell'associazione nazionale dei magistrati parla da solo. Non è soltanto la "società" ad essere diventata "giudiziaria", come ha lamentato l'ex presidente della Camera Luciano Violante commentando le recenti assoluzioni, nei tribunali, di troppi politici condannati invece nei processi mediatici avviati con gli avvisi di garanzia. Purtroppo è la Repubblica, con le istituzioni di vario livello, ad essere diventata giudiziaria, senza che la sinistra e la destra, alternatesi al governo o addirittura associatesi nelle cosiddette larghe intese, abbiano saputo o addirittura voluto porvi rimedio. Il primo passaggio dalla Repubblica parlamentare a quella giudiziaria risale al 1992, quando i magistrati di Milano impegnati nelle indagini sul finanziamento illegale dei partiti protestarono contro l'ipotesi di una commissione d'inchiesta parlamentare, appunto, su quel fenomeno generalizzato. Il Parlamento vi rinunciò, dopo avere indagato su tutto: dalle banane alla mafia, da Sindona alla P2, dalla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino ai soccorsi nell'Irpinia terremotata. Il secondo passaggio lo indicherei nella decisione di Oscar Luigi Scalfaro, fresco di insediamento al Quirinale, sempre nel 1992, di estendere al capo della Procura della Repubblica di Milano le consultazioni per la formazione del primo governo dopo il rinnovo del Parlamento. Seguì l'anno dopo il rifiuto, sempre di Scalfaro, peraltro ex magistrato, di firmare un decreto legge approvato dal primo governo di Giuliano Amato, e contestato dal capo della Procura milanese, sempre lui, per la cosiddetta "uscita politica", e non solo giudiziaria, da Tangentopoli. Eppure quel decreto legge era stato varato in una lunghissima riunione del Consiglio dei Ministri, più volte interrotta per consultazioni fra gli uffici di Palazzo Chigi e del Quirinale sugli articoli via via esaminati. E sul provvedimento uscì la mattina dopo un commento positivo di Eugenio Scalfari, prima che arrivassero il pronunciamento della Procura ambrosiana e l'annuncio del rifiuto del capo dello Stato di firmare. Il 1993 fu anche l'anno della modifica a tamburo battente dell'articolo 68 della Costituzione per togliere dalle immunità parlamentari la richiesta delle "autorizzazioni a procedere" nelle indagini. Ma già degli indagati eccellenti come Giulio Andreotti, intimiditi dagli umori di quella che Violante chiamerebbe "la società giudiziaria", avevano votato a scrutinio palese a favore dei processi a loro carico. Su Bettino Craxi erano state già buttate monetine, accendini, ombrelli in piazza, e i ministri del Pds-ex Pci erano usciti dal governo di Carlo Azeglio Ciampi per protesta contro la Camera -ripeto, contro la Camera, e quindi contro il Parlamento- per avare concesso a scrutinio segreto non tutte ma solo alcune delle autorizzazioni a procedere chieste da varie Procure contro il leader socialista. Un cappio infine era già stato sventolato nell'aula di Montecitorio dai leghisti, che si sentivano gli interpreti più autentici delle toghe. La musica non migliorò, anzi peggiorò decisamente l'anno dopo col primo governo del pur garantista Silvio Berlusconi. Che esordì offrendo il Viminale ad Antonio Di Pietro, il magistrato simbolo allora delle indagini sui politici. Poi il Cavaliere si arrese ai leghisti, sempre loro, presenti nel suo governo col ministro dell'Interno Roberto Maroni e arresisi a loro volta alla protesta corale, con minacce di dimissioni, dei magistrati della Procura milanese, sempre loro, contro un decreto legge che limitava il ricorso alle manette durante le indagini preliminari. Eppure a quel decreto Scalfaro aveva fornito la propria firma senza fare storie. Ed erano seguite alcune scarcerazioni. Le proteste della Procura ambrosiana fecero scoprire a Maroni, pur avvocato, parti del provvedimento che aveva sottoscritto, per sua penosa ammissione, senza rendersene conto. Il decreto fu lasciato decadere, senza peraltro che Berlusconi riuscisse dopo pochi mesi ad evitare la caduta del suo governo per mano proprio della Lega sul terreno già allora scivoloso della riforma delle pensioni, anche se è ancora opinione diffusa che la causa della crisi fosse stata un avviso giudiziario a comparire per corruzione: avviso anticipato dal Corriere della Sera e notificato al presidente del Consiglio mentre faceva col sindaco di Napoli Antonio Bassolino, che ha rievocato recentemente la vicenda in una intervista a Il Dubbio, gli onori di casa ai partecipanti ad una conferenza delle Nazioni Unite sulla lotta alla criminalità organizzata. Per assistere a qualche serio, per quanto insufficiente, tentativo di liberare la Repubblica parlamentare dall'assedio giudiziario si sono dovuti aspettare gli anni di Giorgio Napolitano al Quirinale, dopo che la Procura di Palermo ne aveva clamorosamente violato la riservatezza garantitagli dalla Costituzione intercettandolo al telefono, sia pure "accidentalmente", con Nicola Macino, allora indagato e oggi imputato di falsa testimonianza nel processo in corso da più di tre anni sulle presunte trattative fra lo Stato e la mafia della stagione stragista. Poi la Procura resistette alla richiesta di distruggere le intercettazioni, peraltro ritenute irrilevanti ai fini processuali dagli stessi inquirenti, senza passare per un'udienza che ne avrebbe potuto compromettere la segretezza. Il buon Napolitano, per non lasciare compromesse ai suoi successori - come tenne a spiegare con un comunicato- le prerogative del presidente della Repubblica, anch'esse minacciate da un esercizio invasivo delle funzioni giudiziarie, dovette clamorosamente ricorrere alla Corte Costituzionale. Che gli diede ragione. Ma una rondine, si sa, non fa primavera. Napolitano è ormai un presidente emerito. E il suo successore è già alle prese con l'ipotesi di rendere testimonianza pure lui a quello stesso processo, la cui sola durata è un'enormità. Il riscatto della Repubblica parlamentare dagli assedi giudiziari, altro che dai presunti assalti di Renzi, deve ancora venire. Non è un caso che il presidente del Consiglio abbia deciso di portarsi appresso alla Casa Bianca, per la cena di commiato dal presidente uscente degli Stati Uniti, anche il magistrato Raffaele Cantone, che come capo dell'Autorità anticorruzione è stato considerato fra le personalità più rappresentative dell'Italia, accanto a Roberto Benigni, Paolo Sorrentino, lo stilista Giorgio Armani la sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini, la campionessa paralimpica Bebe Vio, la direttrice del Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti, e l'architetta Paola Antonelli, del Museo internazionale dell'arte moderna.
IL PARTITO DELLE MANETTE COL CULO DEGLI ALTRI.
Crocetta nella palude degli scandali. È la fine di un moralizzatore, scrive Accursio Sabella sabato 3 giugno 2017 su "Live Sicilia". Dalle fragorose denunce alla clamorosa indagine che lo vede coinvolto. La parabola del governatore. Morale della favola: se fai la morale, rischi di finire moralizzato. È successo persino a Rosario Crocetta, il governatore siciliano giunto a Palazzo d'Orleans indossando i pennacchi dell'antimafia militante e seguito da una fanfara della legalità spesso fuori tempo. È toccato anche a lui, finito dentro una inchiesta che ancora promette di riservare sorprese, con una accusa che somiglia ai titoli di coda di un pessimo film: concorso in corruzione. È la fine di un moralizzatore. Perché al di là di quanto verrà accertato dalle indagini e dal processo che ne seguirà, passano agli archivi della cronaca e degli atti giudiziari, opere e omissioni, debolezze e vanità. Un canovaccio di protagonisti e comparse, di figuranti e presunti potenti, che raccontano, ciascuno a suo modo, la storia di una Regione corrotta, nel senso più ampio del termine. E in questa storia, c’è anche il personaggio che non ti aspetti. Le macchie che spuntano sugli abiti candidi dell'eroe. La denuncia che si rivolta contro, come l’inaspettato rinculo di uno sparo a salve. La difesa, imposta negli ultimi anni a malcapitati delinquenti o – molto più spesso – a ladri di polli e furbastri di provincia, diventare una necessità per allontanare da sé le ombre. Quando all'improvviso si spengono le musiche e si sgonfia il tendone del circo. Quando viene svelata l'illusione ottica in questo teatro nero della corruzione e si scopre che il trapezista, in realtà, aveva finora volteggiato a dieci centimetri dal pavimento e che la tigre altro non era che un docile gattino. La nebbia dell'impostura, insomma, che svanisce. La facciata che crolla. Liberando finalmente lo scheletro a tanti noto: quella che in Sicilia in questi quattro anni e mezzo hanno chiamato “moralizzazione” altro non era che una trovata politica. Messa drammaticamente a nudo dall'inchiesta della Procura di Palermo che ha coinvolto anche il presidente Crocetta. Del resto, senza andare a scomodare Nenni e i più puri che epurano i già puri, quello del moralista che affonda nella sua stessa retorica è un finale dal quale spesso non si scappa e che non subisce l’influenza di latitudini e palazzi, anagrafe e geografia. Dall’estremo Nord al profondo Sud, la storia è sempre quella. Prendi Gianfranco Fini: era lui, o almeno doveva essere, la versione più composta, più ordinata di quel centrodestra che vestiva le paillettes alla “Drive in” del berlusconismo folgorante e le sbracate camicie verdi della Lega. Eccolo, il moralizzatore politico finire dentro le inchieste per la nota vicenda riguardante la casa di Montecarlo, l’uso dei fondi del suo partito, il rapporto con i Tulliani, suoi nuovi familiari. Metti su casa, e va giù il partito. Insieme alla carriera politica. Perché ti sposti un po’, e scorgi un’altra tipologia di moralizzatore. Quello che urlava contro “Roma ladrona” è finito a processo con l’accusa di appropriazione indebita dei fondi della Lega Nord. Soldi che secondo l'accusa sarebbero serviti anche per ristrutturare la villa di Gemonio del Sanatùr. Per Umberto Bossi che nel frattempo si è fatto “scippare” il partito da Matteo Salvini, e il figlio Renzo, i pm milanesi già due mesi fa hanno chiesto una pesante condanna. Altro che casa, dolce casa. Ne sa qualcosa anche un moralizzatore istituzionale come fu Antonio Di Pietro. La sua leadership in Italia dei valori (un nome che contiene in sé una 'morale') e lo stesso partito finirono per sgonfiarsi repentinamente di fronte alle inchieste che allungavano ombre sui fondi di Idv e sul patrimonio immobiliare dell'ex pm-star di Mani pulite che ha provato recentemente e senza successo a rilanciarsi in occasione delle ultime amministrative di Milano. In quei giorni, nella Capitale d'Italia arrivavano invece i web-moralizzatori. Al grido di “Onestà, onestà” i grillini prendevano Roma. Ma nemmeno in quel caso l’autoproclamazione rendeva immuni da scivoloni e grane giudiziarie. La stessa Virginia Raggi è indagata, il suo (ex) braccio destro Raffaele Marra è finito ai domiciliari, un altro assessore (Paola Muraro) è finita nel registro degli indagati prima di dimettersi, mentre la Procura e l’Anticorruzione hanno bacchettato il primo cittadino su incarichi e promozioni. La stessa Anac che in Sicilia non molto tempo fa puntava il dito contro un moralizzatore “di professione”. Antonio Ingroia era stato appena inviato dal presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta a capo della Provincia di Trapani anche con l’obiettivo di “contribuire alle ricerche del latitante Matteo Messina Denaro”, ma ha finito per scomodare Raffaele Cantone che ha dovuto dire “alt” a quell’incarico: l’ex pm aveva superato il limite massimo di poltrone consentite dalla legge. Ma sulla toga che aspirò a fare il premier è pure piombata una inchiesta della Procura della Corte dei conti, ancora in corso, sulle assunzioni in un carrozzone regionale. Da inquisitore a “inquisito”. Che è come dire, in fondo, da moralizzatore a moralizzato. E così, per non andare troppo lontano da Ingroia, il caso più clamoroso è tutto siciliano. Giusto il tempo di consentire a Massimo Giletti di chiudere la stagione dell’Arena, da dove l’ospite fisso e quasi mai contraddetto Rosario Crocetta recitava il domenicale Angelus dello scandalicchio vero o presunto, ed ecco che proprio il governatore della rivoluzione finiva dentro un’inchiesta ampia su un presunto caso di corruzione in Sicilia. Persino lui, il moralizzatore antimafia, il presidente – per usare sue parole – dal fiuto sbirresco, l’aglio per i vampiri della manciugghia (che sarebbe poi, fuor di vernacolo, lo spreco, lo sperpero). L’inchiesta che sta estendendosi non solo alle diverse Procure siciliane, ma anche verso qualche tribunale “continentale”, a cominciare da quello di Perugia, sta cercando di far luce sulle relazioni tra la politica siciliana e alcuni imprenditori padroni degli aliscafi con i quali vengono assicurati i collegamenti tra la Sicilia e le Isole minori. Sono già finiti ai domiciliari l'attivo consigliere regionale e attuale candidato a sindaco di Trapani Girolamo Fazio, il potente armatore Ettore Morace e Giuseppe Montalto uno dei collaboratori più stretti dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giovanni Pistorio. Come detto, tra gli indagati altri nomi “eccellenti”, tra cui il Sottosegretario alle Infrastrutture Simona Vicari che si è dimessa a causa di un rolex, un po’ come avvenne per il ministro allo stesso ramo Maurizio Lupi (anche lui esponente alfaniano). “Le indagini fin dall’origine – hanno scritto del resto gli inquirenti in una ponderosa ordinanza - hanno evidenziato i rapporti talvolta assai confidenziali tra gli armatori e diversi esponenti delle amministrazioni pubbliche sia a livello politico che dirigenziale”. E quando si parla di politica, appunto, si fa esplicito riferimento anche al governatore. Il vertice delle istituzioni siciliane. Per il quale la Procura ha disposto persino controlli e pedinamenti, sulle assolate stradine di Filicudi, isola delle Eolie. Un’isola per la quale, stando alle intercettazioni, il presidente nutrirebbe una grande, irrefrenabile passione. Al punto da chiedere ai suoi burocrati e allo stesso assessore ai Trasporti, di creare una “corsa” attiva tutto l’anno. Un aliscafo pronto a salpare da Palermo anche nelle stagioni rigide, su quel mare d’inverno che persino Loredana Bertè tanti anni fa definì un “concetto che il pensiero non considera”. Non per il presidente che si sarebbe innamorato, stando alle conversazioni tra assessori e armatori, tra sindaci e burocrati, non solo delle bellezze naturalistiche dell’isolotto. E così, la patina dei discorsi da bar, la marmellata delle facili ironie, delle battute da caserma, si stende su un’amicizia tra il governatore e il gestore di un hotel a Filicudi che potrebbe avere però dei risvolti giudiziari, al di là del canovaccio da softcore, da sboccacciato filmetto anni ottanta. “Non sono un novello Formigoni”, si è sfogato subito Crocetta, prima di presentarsi all’opinione pubblica come un governatore francescano: “Quando ero a Filicudi, - ha raccontato - rifiutavo i giri in barca perché sapevo che me li avrebbero fatto fare gratis. Non andavo nei lidi perché temevo non mi facessero pagare. Così me ne andavo tra gli scogli, tra le pietre, senza nemmeno un ombrellone". Roba da rimanere scottati. Ma nelle carte degli inquirenti c’è il sospetto, e più di quello, che il governatore potesse utilizzare la Regione, le sue casse, per un “capriccio” come lo ha definito il suo stesso assessore. Un guaio che si aggiunge ad altre contestazioni della Procura, che ha deciso di recapitare al presidente un avviso di comparizione. L’accusa, in quel caso, è relativa a uno strano bonifico che l’armatore Morace avrebbe fatto giungere al nuovo movimento politico di Crocetta, “Riparte Sicilia”. “Sono così cretino da farmi corrompere con un bonifico? Se fosse così – ha spiegato Crocetta - dovrei autoproclamarmi primo presidente coglione della Regione". Al di là della consistenza delle accuse a Crocetta, però, e delle personalissime presunte responsabilità del governatore, c’è un dato che è emerso dall’inchiesta con una evidenza inaffondabile: la Regione degli scandali è sempre lì, tale e quale, così come in passato. Gli sprechi non sono stati debellati, e gli assessorati sono permeabili, gli uffici corruttibili, ora come allora. E come poche settimane fa, quando gli scandali venivano serviti al pubblico della domenica, insieme ad abbondanti dosi di populismo, di numeri strampalati, di manicheismo da fumetto. Scandali dai quali, però, il governatore si era sempre ovviamente tirato fuori. Stavolta non è così. E del resto, le incrinature sul paravento legalitario di Crocetta erano apparse già da tempo. E l’inchiesta sui rapporti tra politica e imprenditori privati non pare poi così dissimile da un’altra indagine che investì la Sicilia degli scandali mai estirpati. Un contesto fatto di amicizie e pubbliche relazioni, una Sicilia degli interessi pubblici piegati alle consuetudini dei caminetti, dei rapporti più o meno personali. È l'indagine che un paio di anni fa coinvolse alcuni medici e manager della Sanità siciliana. Anche in quel caso le intercettazioni svelarono la filigrana di una Regione ripulita solo in apparenza, le trame fittissime che legavano il pubblico e il privato. Gli ospedali siciliani e le amicizie. Inchieste che coinvolsero Giacomo Sampieri, commissario di un grosso ospedale palermitano, il “Villa Sofia-Cervello”, e in ottimi e frequenti rapporti col presidente della Regione. Il primario Matteo Tutino, invece, finito ai domiciliari, la mattina dell'arresto, all'arrivo delle forze dell'ordine chiamò proprio Rosario Crocetta. Che liquidò quei rapporti con un semplice: “E' solo un medico da cui mi sono fatto curare qualche volta”. Fatto sta che già mesi addietro, proprio da quella Sanità malata e dalla giunta di Crocetta era fuggita, sbattendo la porta, addirittura Lucia Borsellino, figlia del magistrato Paolo, che parlerà di dimissioni dovute a “ragioni di ordine etico e morale”. Un concetto che sarà ribadito in maniera drammatica dal figlio di Paolo, Manfredi, di fronte al presidente della Repubblica Mattarella: “Lucia ha portato la croce perché voleva una sanità libera e felice”. Tutto dimenticato. Troppo presto, forse. Sepolto dalle successive sparate del governatore sulle magnifiche azioni di pulizia in una Regione rimasta identica a prima. E non è un caso che alla fine del 2016 la Sicilia risultasse tra le Regioni più corrotte d'Italia, dietro solo a Campania e Lombardia. Non esattamente un successo, per il governo che avrebbe dovuto portare, anche nella pubblica amministrazione, il vento fresco della legalità. E che invece è impegnato, in questi mesi, nell’occupazione militare di ogni poltrona pubblica. Crocetta ha piazzato fedelissimi ovunque, a volte persino eludendo le norme pur di nominare un amico. È successo in un grosso ente pubblico che si occupa di finanziamenti alle cooperative siciliane, dove Crocetta ha fatto di tutto per designare un proprio consulente di origine tunisina. Nel cda di un istituto di credito regionale ha invece inviato il proprio Segretario generale e il proprio capo di gabinetto. Rantoli di un’agonia politica, spesso finiti, anche questi, sui tavoli delle Procure. Nell'ultima indagine, ad esempio, quella sulla presunta corruzione per favorire gli armatori Morace, è stato il turno di Massimo Finocchiaro, che Crocetta ha voluto a capo di una mega-azienda che si occupa del trasporto pubblico. Il funzionario è un amico personale, un militante del Megafono dalla prima ora, un attivo sostenitore di Crocetta fin dalla campagna elettorale del 2012. Ma non è l'unico caso. Della Sanità, così come dell'inchiesta contabile su Antonio Ingroia abbiamo già detto, ma lo stesso si può dire per esponenti della burocrazia regionale, per amministratori di alcune società partecipate, per giungere fino al suo vero braccio destro: il Segretario generale della Regione siciliana Patrizia Monterosso, fedelissima di un governatore che ricambia con almeno altrettanta fiducia, è già stata condannata dalla Corte dei conti per un danno all'erario da oltre un milione di euro ed è anche finita sotto processo per un presunto peculato. Che ha fatto il moralizzatore che diffondeva dai microfoni delle conferenze stampa e dal tubo catodico il Verbo della legalità? Prima le ha rinnovato l’incarico, poi ha anche deciso, nonostante un parere di segno opposto dell'Avvocatura dello Stato, che la Regione siciliana non dovrà costituirsi parte civile contro la dirigente. A differenza di quanto fatto in tante occasioni analoghe nel corso di questi quattro anni e mezzo di legislatura. Perché in fondo, la morale della favola è anche questa: il moralista, presto moralizzato, ha sempre con sé una morale di scorta.
Di Matteo studia da Guardasigilli per mollare il processo flop. La scalata ai 5 stelle del pm della trattativa Stato-mafia, scrive Mariateresa Conti, Venerdì 02/06/2017, su "Il Giornale". Sarà un misterioso virus sprigionato dal processo sulla trattativa Stato-mafia. Una sorta di effetto collaterale di quello che si annunciava come il processo dei processi e che ora si avvia all'epilogo, a fine anno, dopo avere incassato qua e là più di una bocciatura e con tutte le caratteristiche del flop. Ad Antonio Ingroia, il papà di quel processo, il passaggio alla politica è andato malissimo. Ma al pm Nino Di Matteo, il pm antimafia che quel processo ha ereditato, potrebbe andare meglio. Già solo per il fatto che, contrariamente al collega, lui non sembra intenzionato a crearsi un partito tutto suo, ma sarebbe piuttosto pronto ad accomodarsi in casa M5s, movimento del quale ha benedetto il codice etico, e del quale - è questo il sogno - in un ipotetico governo potrebbe diventare Guardasigilli. Cinquantasei anni, palermitano, vita blindata dal 1993, il pm più minacciato da Cosa nostra deve la sua carriera alle stragi. È con le indagini su quegli eccidi, soprattutto su quello di Borsellino in via D'Amelio, che il giovane sostituto Nino Di Matteo approdato a Caltanissetta nel 1991 diventa l'eroe che i grillini oggi sperano di avere al proprio fianco. Oddio, le indagini su Borsellino non è che alla distanza si siano rivelate un successone, anche per Di Matteo, che era uno dei pm. Il nuovo processo Borsellino nato dalla revisione, scoperti falsi pentiti e depistaggi precedenti, si è appena chiuso. E ha confermato il grande flop della prima indagine. Da Caltanissetta a Palermo, le stragi restano il filo conduttore dell'attività di Di Matteo. Che diventa l'erede naturale di Ingroia. C'è anche lui tra i pm della prova generale del processo sulla trattativa, quello contro il prefetto Mario Mori e l'ex colonnello Mauro Obinu, conclusosi in primo grado e in appello con l'assoluzione. E c'è lui soprattutto nella cabina di regia del processo su cui la procura di Palermo si gioca la faccia, quello sulla trattativa tra i boss e Cosa nostra. Un processo partito tra rulli di tamburo e che a Di Matteo ha già procurato più di qualche grattacapo. A cominciare dal procedimento davanti al Csm (poi archiviato) per avere indirettamente rivelato a Repubblica, confermandone l'esistenza, che le intercettazioni dell'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano al telefono con Nicola Mancino non erano agli atti perché non rilevanti. Non è il solo dispiacere che il processo trattativa gli ha causato. L'ex ministro Calogero Mannino, processato con rito abbreviato, in primo grado è stato assolto. E l'ex caposcorta di Di Matteo, chiamato al processo come teste, andrà a giudizio per calunnia. Sempre in guerra, Di Matteo. Non solo contro la mafia. Anche con il Csm ha avuto le sue battaglie. Come quella per la promozione alla Direzione nazionale antimafia. Negata regnante Napolitano al Quirinale, l'ha ottenuta a marzo. «Sono stato costretto - ha esultato - a conciliare la delicatezza di certi impegni con la necessità di occuparmi di una massa di procedimenti su piccoli furti, truffe e reati comuni». Il procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi non ha gradito. E gli ha risposto, con una lettera indirizzata a tutti i suoi pm: «La notorietà è un valore effimero». Però nel frattempo, per sei mesi, lo ha trattenuto a Palermo. Ad occuparsi del processo trattativa ma pure dei disprezzati furtarelli.
Woodcock, nemico di politici e vip che colleziona solo flop. E sognava di fare lo stilista..., scrive il 13 Aprile 2017 Filippo Facci su "Libero Quotidiano”. Nota preliminare: non è che possono dirmi «occhio alle querele» e poi chiedermi il ritratto di uno come Henry John Woodcock: significa che non hanno capito. Le querele basta farle, e lui le fa. Se un magistrato arresta mille persone per genocidio ma poi ne condannano una sola per divieto di sosta - è solo uno stupido esempio - ufficialmente la sua inchiesta non è stata un flop. Non puoi scriverlo, o meglio: puoi, ma rischi.
Comunque: Woodcock ha fatto un sacco di flop (lo scrivo, amen) e per il resto è la vanità fatta persona. Tralasciamo i cenni biografici soliti (nato a, figlio di) e diciamo solo che è un napoletano di crescita. La prima volta che lo vidi era al ristorante del lido di Macchiatonda, a Capalbio, alle 13.30 di una domenica del 2007: giubbotto rosso, cappellino da baseball, lo sguardo autoriflesso di chi si sentiva al centro dell’inquadratura. La stampa italiana, che tende a far schifo, aveva appena dedicato ampi servizi alla sua moto, al suo cane e alla bistecca di vitella tagliata grossa, che gli piaceva tanto e che comprava da un certo macellaio di Potenza. A un cronista di Vanity Fair, testata dal nome azzeccatissimo, era bastato chiedere per ottenere, dal riservato Woodcock, immagini posatissime. Sulla copertina di Dipiù comparivano Woodcock e signora (discreto magistrato anche lei) e all’interno eccoti Woodcock in barca, in jeans, in cravatta, in toga, con la mamma, ancora con il cane, col padre, senza padre, sulla slitta. Tutte foto private e il titolo «Woodcock, la carriera e l’inchiesta dell’uomo che sta affascinando l’Italia». Su Panorama lo si vedeva poppante e poi quattordicenne in Croazia, poi ancora col cane.
La stampa italiana è qualcosa che nel 2007 ti faceva sapere che Woodcock mangiava formaggini, arance, banane e soprattutto antipasto con ricotta, salame, mozzarella e caciocavallo. Però secondo Panorama - viva il pluralismo - preferiva fagioli e cozze, mentre Vanity Fair insisteva sugli strascinati e aggiungeva pasta e ceci. A Studio Aperto, su Italia Uno, nell’aprile 2007, Woodcock confessò che da giovane voleva fare lo stilista. Beh, a suo modo ce l’aveva fatta: era indubbiamente uno stilista del diritto come già gli avevano riconosciuto molti tribunali giudicanti. Le sue inchieste più note erano già state state una collezione di incompetenze territoriali, nomi altisonanti assolti, ministri prosciolti, richieste d’arresto ingiustificate, e poi archiviazioni, bocciature per il 70 per cento dei suoi ricorsi, più 6 milioni e 400mila euro spesi per tre anni di intercettazioni a Potenza. E dire che da scriverne seriamente non mancava: il primo flop risaliva al 2000, quando Woodcock imbastì un’inchiesta sulla Banca Mediterranea che diede un nulla di fatto. Poi il più noto “Vipgate” (2003) che coinvolgeva 78 persone e tra queste Franco Marini, Nicola Latorre, Maurizio Gasparri, Francesco Storace, il diplomatico Umberto Vattani, il cantante Tony Renis e la conduttrice tv Anna La Rosa. Accuse di ogni tipo (associazione per delinquere, corruzione, estorsione) ma poi l’inchiesta approderà a Roma e finirà archiviata. Poi l’inchiesta “Iene 2” (2004) su presunte connessioni tra politici lucani e mafia (51 arresti respinti) con tanto di ispezione mandata dal guardasigilli Roberto Castelli: fecero flop entrambe, l’inchiesta e l’ispezione.
Ed eccoci al mitico “Savoiagate”, quello che prese di mira Vittorio Emanuele di Savoia il quale tutto meritava, fuorché uno come Woodcock: finirà in nulla anche questa, e il reale verrà assolto con molti altri imputati. All’ex sindaco di Campione Roberto Salmoiraghi, arrestato e costretto alle dimissioni, fu riconosciuto un risarcimento di 11mila euro, mentre a Vittorio Emanuele, 40mila. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano giunse a chiedere al Csm notizie di questo Woodcock. Uh, abbiamo dimenticato l’inchiesta sull’Inail: furono prosciolti tutti i parlamentari che aveva inquisito e rispediti al mittente una sessantina di arresti, compresi due deputati e il presidente della Camera penale della Basilicata, poi scagionato e uscito di galera in tempo per diventare difensore di Vittorio Emanuele. Là è tutto un po’ aggrovigliato.
Forse è per questo che, più di queste cose, nel 2007, la stampa italiana spiegava che quando c’era Montalbano in tv, la sera, Woodcock usciva anzitempo dall’ufficio. Spiegava che gli piaceva anche Distretto di Polizia. Che sul suo comodino c’erano libri di Salinger, Pasolini ed Erri de Luca. Che il rapporto tra Woodcock e la giornalista Federica Sciarelli (con la quale fu immortalato in varie situazioni) era solamente di tipo professionale. Notizie importanti. E le ispezioni ministeriali, spedite a Potenza dall’allora guardasigilli Clemente Mastella, in fondo, di notizie non ne trovarono molte di più. I giornali invece sì, anche perché la nuova inchiesta glamour “Vallettopoli” era fantastica: la soubrette Elisabetta Gregoraci, il portavoce di Gianfranco Fini Salvatore Sottile, e Lele Mora, Fabrizio Corona, l’allora ministro Alfredo Pecoraro Scanio, poi vabbeh, l’inchiesta approdò a Roma per legittima competenza e videro che non c’era nulla: però c’eravamo divertiti, no? Morto un processo nel silenzio, tanto, i giornali già si lanciavano su sempre nuove inchieste: allora come oggi. Woodcock fece anche un’inchiesta sulla massoneria (mancava) ma per una volta fu lui stesso a fare marcia indietro per inconsistenza dell’accusa. Miracolo. Sta di fatto che Woodcock aveva raggiunto la quota di 210 innocenti accusati senza fondamento - fu calcolato - con una media di 15 all’anno a partire dal 1996.
Poi si trasferì a Napoli (2009) e con lui il suo metodo. Nel 2011, quando uscì il primo numero del Fatto Quotidiano, il primo titolo di prima pagina fu: «Indagato Gianni Letta»: e naturalmente era innocente. Indovinate di chi era l’inchiesta. Fecero rumore, dunque, le intercettazioni dell’indagine cosiddetta P4, un «sistema informativo parallelo» allestito dal mediatore Luigi Bisignani. Alfonso Papa (Pdl) fu clamorosamente svenduto dal Parlamento e divenne il primo parlamentare italiano a finire in carcere per dei reati non violenti: anche se, dopo 157 giorni di galera, fu scarcerato dal Tribunale del Riesame e poi anche dalla Cassazione, che di passaggio sancì che l’associazione P4 non esisteva.
Poi? Poi è finito lo spazio - qui - ma non i flop - ovunque. Ci sarebbe da dire anche sull’inchiesta sulla Guardia di Finanza avviata da Woodcock nel 2014: limitiamoci al destino del generale Vito Bardi, già indagato da Woodcock nell’inchiesta “P4” (innocente) e nuovamente archiviato il 4 aprile scorso per «insussistenza di ogni ipotesi di illecito». Bardi non era neppure stato mai ascoltato né aveva avuto la possibilità di conoscere i suoi accusatori. Carriera distrutta lo stesso: diversamente da quella del magistrato che l’aveva accusato due volte. In tribunale, comunque, Woodcock ha ottenuto anche delle vittorie: per le querele che ha sporto. Eccoci candidati a suoi nuovi mirabolanti successi. Filippo Facci
È caccia al pm Woodcock su falsi e fughe di notizie. Procura di Napoli e toga finiscono ancora sotto accusa Alta tensione tra tribunali, possibile fascicolo del Csm, scrive Anna Maria Greco, Giovedì 18/05/2017, su "Il Giornale". Negano che ci sia una guerra tra procure di Roma e Napoli nei palazzi di giustizia, eppure sul caso Consip ogni scandalo accentua le differenze tra due metodi investigativi. E nel mirino c'è ancora una volta lui, il pm anglopartenopeo Henry John Woodcock, titolare dell'inchiesta prima che passasse nella Capitale il filone principale. Sul sostituto procuratore pesa l'istruttoria disciplinare avviata dal Procuratore generale della Cassazione e, dopo l'ultima intercettazione tra Matteo e Tiziano Renzi finita nel libro del giornalista Marco Lillo, con la grancassa del Fatto quotidiano, anche il Guardasigilli Andrea Orlando ha disposto un'ispezione. La vicenda è sotto osservazione anche del Csm, che un mese fa ha negato l'apertura di una pratica in prima commissione chiesta dal laico di Fi Pierantonio Zanettin, ma ora potrebbe ripensarci. In un'intervista a Radio radicale Zanettin è tornato alla carica, dichiarandosi «allibito» per il fatto che il vertice di Palazzo de' Marescialli non voglia approfondire «fatti così inquietanti», che rappresentano un «inquinamento del processo democratico». Pesa sulla vicenda una frase a Radio 24 di Nicola Gratteri, stimatissimo procuratore di Catanzaro che ha appena scoperchiato i traffici nel più grande centro calabrese per profughi: «Quando la polizia giudiziaria fa la fuga di notizie, c'è quanto meno una sorta di silenzio-assenso da parte della Procura. Sennò le notizie non escono». Il pm ha alle spalle un'esperienza di 30 anni di intercettazioni e insiste sulla «tracciabilità» degli interventi sui file audio (la conversazione non era stata trascritta). «Il procuratore - spiega - è il responsabile della sala di registrazione... Se io vado, vedo esattamente chi ha scaricato il file. L'ufficiale di polizia giudiziaria dirà me l'ha chiesto il procuratore. Ma se non ha una ricevuta, risponde lui». E anche da Roma arriva una nota polemica che tra le righe punta verso Napoli. La dirama il procuratore capo Giuseppe Pignatone per smentire la distruzione di una delle intercettazioni: «Peraltro - aggiunge in modo significativo il magistrato - l'eventuale distruzione poteva essere disposta solo dall'Ufficio che l'aveva disposta». È a Napoli che a marzo si è deciso di riprendere a spiare le conversazioni di Renzi senior, interrotte a dicembre. Si è fatto contro il parere di Roma, visto che il padre dell'ex premier è indagato per un reato che non giustifica le intercettazioni: traffico d'influenze illecite. È a Napoli che il lavoro di ascolto è ancora affidato al Noe dei carabinieri, cui i pm della capitale hanno revocato l'incarico dopo le prime fughe di notizie e gli errori o falsificazioni nelle trascrizioni che hanno fatto finire sotto inchiesta il capitano Gianpaolo Scafarto, che peraltro afferma di essere stato sempre diretto da Woodcock. Ora, l'ennesima violazione del segreto investigativo e Renzi che dice: «Le intercettazioni sono illegittime. Voglio sapere chi ha violato la legge». Come sono finite in pasto ai media le sue chiacchiere con il babbo, non penalmente rilevanti, ma politicamente sensibili? Il presidente del Pd Matteo Orfini parla di «attacco alla democrazia», Vito Crimi del M5S di «piccola recita» tra l'ex premier «che sa di esser intercettato» e il padre «che sa che è sotto indagine» e Daniela Santanchè di Fi dice che ora il Pd si rende conto del prezzo della gogna mediatica.
Ieri al Csm la questione non è stata affrontata in plenum, ma si è riunito a lungo il Comitato di presidenza, che decide sull'apertura delle pratiche ed era stata preannunciata una comunicazione. Alla fine tutto è stato rinviato ad oggi, quando proseguirà l'incontro tra vicepresidente Legnini, primo presidente Canzio e Pg della Cassazione Ciccolo, che secondo i rumors sarebbe stato pieno di tensione.
Giustizialisti. Così la politica lega le mani alla magistratura. Libro di Piercamillo Davigo, Sebastiano Ardita. Descrizione: «Noi con le nostre forze di Polizia li abbiamo arrestati. I giudici li hanno liberati. L'opinione pubblica deciderà». Così l'ex ministro dell'Interno Angelino Alfano all'indomani dei disordini degli antagonisti avvenuti a Bologna nel novembre del 2015. Come se i giudici avessero deciso liberamente, senza applicare le leggi in materia che il Parlamento aveva varato in precedenza. Alfano, ma non solo, sa che un magistrato spesso ha l'obbligo di scarcerare qualcuno, pur riconoscendo che la norma impone una scelta che egli stesso ritiene sbagliata. Lasciandolo in galera, infatti, incorrerebbe in una severa misura disciplinare. Questo, al contrario, non vale per i politici che se votano una legge iniqua o ad personam sono indenni da rischi perché agiscono nell'«esercizio dell'attività parlamentare». Un libro duro, sull'eterno scontro tra magistratura e politica. Un viaggio nelle aule dei tribunali, nelle Procure e nelle carceri dove i paradossi della legislazione nostrana implicano decisioni al limite della decenza e dove la giustizia diventa spesso ingiustizia.
L’ANTEPRIMA – GIUSTIZIALISTI, IL ROMANZO SOGNATO DA MONTANELLI. DAVIGO E ARDITA CI SPIEGANO COME LA POLITICA LEGA LE MANI ALLA MAGISTRATURA. Scrive il 30 marzo 2017 "Stampalibera.it". Un libro duro, sull’eterno scontro tra magistratura e politica. Un viaggio nelle aule dei tribunali, nelle Procure e nelle carceri dove i paradossi della legislazione nostrana implicano decisioni al limite della decenza e dove la giustizia diventa spesso ingiustizia. Noi di stampalibera abbiamo deciso di pubblicare la prefazione di Marco Travaglio che ci anticipa, come solo lui sa fare, i contenuti di un libro che con chiarezza spiega a tutti i non addetti ai lavori perché la giustizia italiana è allo sfascio. Verso la fine della sua lunghissima e bellissima vita, Indro Montanelli mi commissionò un libro: «Marco, tu devi scrivere il Codice penale tradotto in italiano. Te lo chiedo perché sarei il tuo primo lettore. Ho una vecchia laurea in Giurisprudenza, presa ancora ai tempi del codice Zanardelli, ma non mi è mai servita a niente: io nei meandri, nei meccanismi e nei linguaggi del processo penale mi perdo. E vorrei capirci qualcosa, anche perché ormai tutto passa di lì: è impossibile distinguere la cronaca politica da quella giudiziaria». Ci ho provato diverse volte, a scrivere quel libro, ma né prima né dopo la morte di Montanelli ci sono riuscito: c’era sempre qualche argomento più attuale, più urgente che prendeva il sopravvento. Poi, per fortuna, senza che ci parlassimo, la stessa idea è venuta a Sebastiano Ardita e Piercamillo Davigo, due magistrati valorosi e benemeriti. Non solo per le indagini e i processi che hanno condotto. Ma anche e soprattutto per un’altra virtù, tanto rara quanto preziosa: quella di parlare e scrivere in italiano chiaro, diretto e comprensibile, al contrario di tanti loro colleghi che si esprimono nel sanscrito del giuridichese e impiegano un quarto d’ora solo per dire «buongiorno». Giustizialisti è proprio quel Codice penale (e anche di procedura penale) tradotto in italiano che sognava Montanelli e che io non sono riuscito a scrivere: un libro semplice e stuzzicante, provocatorio al punto giusto, che spiega a tutti i non addetti ai lavori i perché e i percome della giustizia italiana allo sfascio. Una giustizia-paradosso che macina montagne di processi e partorisce solo topolini. Una giustizia-spaventapasseri che, vista da lontano, fa paura a tutti e, da vicino, fa ridere anche i polli. Una giustizia accusata di non funzionare per colpa dei giudici e invece programmata dagli altri poteri apposta per non funzionare. Parlando e scrivendo come mangiano, Ardita e Davigo illuminano questioni che a noi comuni mortali risultano inintelligibili e invece hanno tutte una spiegazione semplice, spesso banale. Fanno parlare i dati, le cifre, le norme, gli episodi di vita vissuta sviscerando le questioni di più bruciante attualità e lumeggiandone le cause e le possibili soluzioni. E, al contempo, smontano a uno a uno gli slogan, le dicerie, i luoghi comuni e le menzogne diffusi a piene mani dall’eterno Partito dell’Impunità che in Italia si ammanta ipocritamente di alti principi e sacri valori come il “garantismo”, la “presunzione di innocenza”, la “separazione dei poteri”, il “primato della politica”. Tutte imposture divenute il rifugio dei peggiori mascalzoni in guanti gialli.
Il Paese dell’impunità. Si sente sproloquiare di sovraffollamento delle carceri, poi si scopre che ogni anno entrano nelle patrie galere 90 mila persone e ne escono 80 mila, con una permanenza media in cella di appena 90 giorni. Si sente cianciare di abusi della custodia cautelare, poi si scopre che è quasi impossibile arrestare un incensurato, salvo che si metta a sparare (e spesso neppure questo basta): così si crea la figura unica al mondo dell’“incensurato a vita” che delinque serialmente. Si sente vaneggiare di colletti bianchi perseguitati dalla giustizia, poi si scopre che solo lo 0,3% dei detenuti in espiazione della pena appartengono alla categoria Vip, mentre tutti gli altri sono condannati per reati di strada, di solito infinitamente meno gravi e socialmente meno dannosi di quelli commessi dai ricchi e dai potenti (in controtendenza con Paesi portati a esempio di virtù dai nostri “garantisti”, come gli Stati Uniti, dove la giustizia non ha alcun riguardo per i ricchi e i potenti, come dimostrano i casi di Dominique Strauss-Kahn, Paris Hilton, Mel Gibson, Hugh Grant, Bernie Madoff e così via). Anche fra i reati di strada, poi, le infinite scappatoie infilate nei Codici da una classe dirigente col culo sporco hanno creato un sistema demenziale che punisce più severamente condotte più lievi rispetto a quelle più pericolose: un condannato per rapina a mano armata trascorre in prigione una media di 635 giorni, contro i 761 di uno spacciatore di droga. In compenso, chi ha sottratto alla collettività decine o centinaia di milioni con una bancarotta fraudolenta non supera di solito i 190 giorni effettivi di detenzione (poi ottiene una pena alternativa, cioè torna in libertà con qualche ridicola restrizione), mentre chi è stato condannato per furto di soldi o beni di valore infinitamente più lievi, le pene alternative se le scorda e sconta in cella almeno 256 giorni. Il che basta e avanza per spiegare come mai l’Italia esporta cervelli in fuga e importa criminali da tutto il mondo. Fantastico il racconto della riunione al ministero della Giustizia fra le delegazioni del governo italiano e di quello romeno per il rimpatrio di cittadini della Romania condannati per delitti commessi nel nostro Paese. Gli italiani rinfacciano ai romeni gli altissimi tassi di devianza criminale dei loro concittadini, i romeni rispondono che i due Paesi hanno più o meno la stessa percentuale di delinquenti, senonché quelli romeni preferiscono delinquere in Italia perché da loro chi sbaglia paga e da noi no. Si sente delirare sulle ragioni della lunghezza dei processi, salvo poi scoprire – nel libro di Ardita e Davigo – che siamo l’unico Paese al mondo con la prescrizione eterna, che continua a decorrere anche dopo due condanne in primo e secondo grado; con i tre gradi di giudizio automatici, sempre sotto forma di dibattimento (nei Paesi anglosassoni i processi come li conosciamo noi sono una rarissima eccezione, perché il rischio di condanna per i colpevoli è talmente alto da indurli quasi tutti a confessare e a patteggiare la pena, cosa che in Italia non fa nessuno poiché il colpevole ha tutto l’interesse a tirarla in lungo in attesa della prescrizione); con il divieto per il giudice d’Appello di aumentare la pena inflitta da quello di primo grado (il che rende i ricorsi – anche se infondati e pretestuosi, cioè destinati alla bocciatura – comodi, gratuiti, a rischio zero e a vantaggio mille). Per questo in Italia delinquere conviene: prevale, nel legislatore, l’interesse a una giustizia che non funzioni, cioè l’interesse opposto a quello dei cittadini perbene, che i reati non li commettono ma spesso li subiscono.
«Siamo giustizialisti». Senza anticipare tutti i contenuti del libro, che si legge come un romanzo (ma noir, a tratti horror), trovo particolarmente preziosi alcuni capitoli. Quello sulla demenziale riforma Renzi sulla responsabilità (in)civile dei giudici, che ha reso la magistratura italiana ancor meno libera, indipendente dal potere (non solo politico, ma anche e soprattutto economico che, quando delinque e viene scoperto, ricatta la società con le conseguenze sociali, occupazionali e finanziarie dei processi). Quello sulle politiche dell’immigrazione, che tentano ridicolmente di affidare alla macchina già inceppata della nostra giustizia la soluzione delle conseguenze bibliche delle guerre e delle carestie e delle dittature di tutto il mondo: vedi il reato di clandestinità, che non ha mai prodotto una sola condanna davvero espiata e al contempo ha distrutto i processi agli scafisti e agli schiavisti (l’immigrato viene indagato appena sbarca e dunque non può essere sentito come testimone con l’obbligo di rispondere e di dire la verità su chi l’ha trasportato e sfruttato, magari gettando a mare decine o centinaia di esseri umani). Quello sulle tante balle che si raccontano, nei Palazzi del potere, contro lo strumento principe per la scoperta della verità: le intercettazioni telefoniche ambientali, che sarebbero sempre troppe e troppo costose rispetto agli altri Paesi (che invece ne fanno molte di più e senza alcun controllo, vedi anche gli ultimissimi casi dello spionaggio mondiale targato Stati Uniti e svelati da Wikileaks). Quello sulla voglia crescente di giustizia privata, sparando od organizzando “ronde” con l’appoggio di partiti politici che, nel frattempo, hanno fatto di tutto per distruggere la repressione e la prevenzione delle autorità pubbliche. E, infine, quello sul rapporto fra magistratura e politica (anche con forti accenti autocritici sulla “correntocrazia” del Csm e sulle indulgenze della magistratura progressista sulle controriforme dei governi di centrosinistra), sempre gabellato dal Partito Trasversale dell’Impunità per uno “scontro” o per una “guerra”: anche qui, dati e cifre alla mano, gli autori dimostra- no come la magistratura italiana, pur con tutti i suoi difetti, riesca a fare pulizia al proprio interno molto più e meglio di quanto non facciano le classi politica e imprenditoriale. Il titolo Giustizialisti è una risposta ironica alle accuse che pioveranno sul capo di Ardita e Davigo all’uscita del libro. Ma a me piace intenderlo anche come una rivendicazione orgogliosa del principio costituzionale secondo cui la legge è uguale per tutti, anzi meglio: «Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge» (articolo 3 della Costituzione). Se il “garantismo” – strappato abusivamente dalle nobili pagine di Cesare Beccaria – è diventato il gargarismo dei peggiori farabutti per negare e rifiutare pro domo sua i principi di eguaglianza, di legalità e di responsabilità, e se il suo contrario è il “giustizialismo” (che un tempo definiva i seguaci di Juan Domingo Perón in Argentina, senz’alcuna attinenza con i temi giudiziari), è venuto il momento di dichiarare con orgoglio da che parte stiamo: ebbene sì, siamo giustizialisti. E allora?
La fine di Gianfranco Fini. L'accusa di riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta sulla casa di Montecarlo potrebbe porre fine alla sua carriera politica, scrive Francesco Curridori, Lunedì 29/05/2017, su "Il Giornale". L’accusa di riciclaggio e il sequestro di un milione di euro pone fine a una vicenda, quella della casa di Montecarlo, che ha segnato la carriera politica di Gianfranco Fini.
Gli inizi della carriera politica. Carriera iniziata nel lontano 1968 quando, all’età di 16 anni, il futuro fondatore di Alleanza Nazionale, rimane coinvolto negli scontri con un gruppo di estrema sinistra che, all’uscita di un cinema di Bologna, contestava la proiezione del film sulla guerra in Vietnam, Berretti verdi. “Non avevo precise opinioni politiche. Mi piaceva John Wayne, tutto qui. Arrivato al cinema, beccai spintoni, sputi, calci, strilli perché gli estremisti rossi non volevano farci entrare. E così per reagire a tanta arroganza andai a curiosare nella sede cittadina della Giovane Italia”, racconterà molti anni più tardi a un quotidiano. Agli inizi degli anni ’70 si trasferisce a Roma ed entra nel Fronte della Gioventù, la formazione giovanile dell’MSI che aveva preso il posto della Giovane Italia. Il 7 gennaio 1978, giorno della strage di Acca Larentia, Fini, che nel frattempo era diventato presidente nazionale del Fronte, venne ferito da un candelotto lanciato dalla polizia per fermare i disordini.
Fini segretario dell'Msi. Ma l’anno che cambia la storia politica di Fini è il 1987 quando si svolge il Congresso del Movimento Sociale di Sorrento che segna l’uscita di scena di Giorgio Almirante. Fini, che ne è il delfino e l’erede designato, ne prende il posto alla segreteria battendo lo sfidante Pino Rauti propugnando per l'imminente futuro una nuova visione politica: "il fascismo del 2000". Alle elezioni Politiche dello stesso il Msi raggiunge il 5,5% dei voti in una campagna elettorale segnata dalla contiguità politica con il Front National di Jean-Marie Le Pen sul tema dell'immigrazione. A seguito del deludente risultato elettorale alle Europee del 1989, Rauti soffia la poltrona di segretario a Fini che la riconquisterà nel 1991. Siamo alla vigilia dell'inchiesta Tangentopoli che travolgerà il governo del pentapartito e aprirà le porte alla Seconda Repubblica. In questo contesto Fini, alle elezioni comunali del 1993, raccoglie i frutti di una campagna elettorale basata sulla lotta alla corruzione. Il passaggio al secondo turno nella sfida romana contro Francesco Rutelli segna il definitivo sdoganamento della destra italiana e l'imminente passaggio da Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale. L'alleanza con Berlusconi e la vittoria alle Politiche del 1994 portano la destra a compiere la "svolta di Fiuggi". L'esperienza della destra al governo dura solo sei mesi ma passano due anni e Fini ottiene la sua vittoria più grande: An raggiunge il 15,5% incentrando la sua campagna elettorale sulla riforma presidenzialista dello Stato. Da lì in poi ha inizio il lento e inesorabile declino che si intravede nel 1999 con il sostegno a Mario Segni sul referendum per l'abolizione della quota proporzionale del Mattarellum, perso per un soffio, e con il flop alle Europee. La lista dell'elefantino, creata insieme ai pattisti di Segni, non sfonda ma si ferma al 10%. La carriera politica di Fini si risolleva con le Politiche del 2001 che riportano il centrodestra al governo per il quale ricopre l'incarico di vicepremier e di ministro degli Esteri. Il rapporto con Berlusconi va avanti, tra alti e bassi, fino al 2007 quando il Cavaliere annuncia dal predellino la nascita del partito unico del centrodestra.
La rottura con Berlusconi. "Voglio che sia chiaro a tutti che, almeno per quel che riguarda il presidente di An non esiste alcuna possibilità che An si sciolga e confluisca nel nuovo partito di Berlusconi", disse all'epoca, a poche dall'annuncio sentenziando: "Berlusconi con me ha chiuso". Questa è la prima di una lunga sfilza di bugie che Fini propinerà ai suoi elettori. Per le Politiche del 2008 nasce la lista Popolo della Libertà che, nel marzo dello stesso anno, diventerà partito. Fini, da presidente della Camera, inizia un’opposizione interna al premier Berlusconi che si fa sempre più incalzante fino alla rottura definitiva con quel “Che fai? Mi cacci?” pronunciato durante la direzione nazionale del 2010 che decretò la sua espulsione dal Pdl.
La fine della carriera politica e la vicenda della casa di Montecarlo. Di lì a poco nascerà Fli, Futuro e Libertà per l’Italia, che, un anno dopo, appoggerà il governo tecnico di Mario Monti. Un partito “nato morto” che nel 2013 raccoglie solo un disastroso 0,4% complice la svolta centrista e l’alleanza con Scelta Civica di Monti e l’Udc di Casini. Ma a travolgere Fini non è soltanto l'uscita dal Parlamento dopo 30 anni ma è soprattutto la vicenda della casa di Montecarlo, venuta fuori nell’estate 2010. Il presidente della Camera, in un intervento video, professa la sua estraneità ai fatti contestati al cognato, Giancarlo Tulliani, reo di aver acquistato a un prezzo di favore una casa di proprietà del partito. “Se dovesse emergere che l'appartamento di Montecarlo appartiene a Giancarlo Tulliani lascerò la presidenza della Camera”, disse all’epoca Fini. Nel 2015, però, la casa fu poi rivenduta a un imprenditore svizzero a ben 1,3 milioni di euro, con un plusvalore di oltre 1,2 milioni di euro, e, a dicembre 2016, la procura di Roma richiede la custodia cautelare per Francesco Corallo. Fini, a pochi giorni di distanza, al Fatto Quotidiano, ammette: “Sono stato un coglione, corrotto mai”. Ora spetterà alla magistratura stabilire quale sia la verità.
Perché la finanza ha sequestrato polizze da un milione di euro a Gianfranco Fini. Da alcuni mesi l'ex presidente della Camera è indagato per complicità in riciclaggio. E quello di oggi è l'ultimo atto di una vicenda che inizia con la casa di Montecarlo e passa dal re delle slot Francesco Corallo, scrivono Paolo Biondani e Giovanni Tizian il 29 maggio 2017 su "L'Espresso". Mazzetta nera, sarai romana e per bandiera ti darem quella italiana... Bisogna rassegnarsi a parafrasare l'inno mussoliniano per raccontare la caccia al presunto bottino che segna l'ultimo sviluppo della pesante inchiesta che ha coinvolto l'ex presidente di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini: un leader politico che ha avuto il merito storico di trasformare la destra post-fascista in un partito di governo con Berlusconi e Bossi. Per ordine dei magistrati di Roma, questa mattina i militari dello Scico (il reparto antimafia della Guardia di Finanza) hanno sequestrato all'ex presidente della Camera due polizze vita del valore di un milione di euro. Da alcuni mesi, come rivelò per primo l'Espresso, Fini è indagato con l'accusa di complicità nel riciclaggio di un tesoro intestato a tre suoi congiunti: circa 6 milioni di euro versati segretamente, attraverso anonime società offshore, dal re delle slot machine Francesco Corallo, che dal dicembre scorso è in stato d'arresto alle Antille Olandesi. Corallo, titolare del gruppo Global Starnet (già denominato Atlantis e poi Bplus), è l'imprenditore catanese che nel 2004 ha ottenuto, benché figlio di un pericoloso pregiudicato, la concessione statale a gestire il business miliardario delle macchinette mangiasoldi (new slot e vlt) che a partire da quell'anno hanno invaso l'Italia. Il re del gioco d'azzardo è stato arrestato con i più stretti collaboratori nella sua base ai Caraibi, con l'accusa di aver sottratto all'Italia oltre 250 milioni di euro: profitti incamerati con le macchinette mangiasoldi, trasferiti all'estero e occultati in anonime società offshore. L'indagine internazionale ha accertato che dalle casseforti segrete di Corallo è uscito un fiume di denaro che ha premiato anche tre familiari di Fini: la consorte Elisabetta Tulliani, suo fratello Giancarlo e il loro padre Sergio, che in totale si sono divisi, a partire dal 2008, quasi sette milioni di dollari. Interrogato dai magistrati di Roma dopo l'avviso di garanzia, Fini ha giurato di non aver mai saputo nulla dei fondi neri intascati dai suoi congiunti. E ha definito false le dichiarazioni accusatorie dell'ex parlamentare Amedeo Laboccetta, inquisito e poi scarcerato, che aveva accusato Fini, tra l'altro, di aver incontrato personalmente Corallo sia in Italia che ai Caraibi. Ma ora nelle motivazioni del sequestro patrimoniale, chiesto dal pm Barbara Sargenti con l'aggiunto Michele Prestipino e il procuratore capo Giuseppe Pignatone, il giudice delle indagini preliminari, Simonetta D’Alessandro, definisce «del tutto inverosimile» la versione di Fini secondo cui i Tulliani si sarebbero arricchiti a sua insaputa. ll provvedimento, al contrario, elenca una lunga serie di documenti, testimonianze e altri indizi concatenati che, secondo l'accusa, proverebbero la «piena consapevolezza» di Fini. In questo capitolo dell'inchiesta rientra anche lo scandalo politico dell'appartamento di Montecarlo: una casa di proprietà di Alleanza nazionale che nel 2008, con l'autorizzazione dell'allora presidente Fini, fu venduta a due società offshore, dietro le quali si nascondevano proprio Giancarlo ed Elisabetta Tulliani. L'inchiesta ha documentato che i due fratelli, a conti fatti, non spesero un soldo: il prezzo fu pagato interamente delle offshore di Corallo; e i Tulliani hanno poi rivenduto l'appartamento guadagnandoci un altro milione di euro. Elisabetta, in particolare, ha intascato personalmente un bonifico di 739 mila euro netti. In questi mesi la procura di Roma ha già ottenuto il sequestro di una dozzina di appartamenti e box nella zona di Roma, che risultano acquistati con un'altra parte del presunto bottino. Si tratta dei 3 milioni e 599 mila dollari versati nel 2009 dalle solite offshore Corallo su un conto estero intestato a Sergio Tulliani, che questi ha poi girato ai figli Giancarlo ed Elisabetta, per essere reimpiegati, appunto, negli investimenti immobiliari che hanno fatto scattare anche la nuova accusa di «auto-riciclaggio». Gli avvocati Michele Sarno e Francesco Caroleo Grimaldi, che assistono Fini, ora annunciano un ricorso al tribunale del riesame e ribadiscono «l'assoluta estraneità» dell'ex leader di An. Secondo i legali, inoltre, le polizze sono state sequestrate «per equivalente», per cui non sarebbero state create con soldi sporchi versati da Corallo ai Tulliani: sarebbero invece risparmi personali dell'ex leader di An, investiti da tempo in polizze intestate ai figli minorenni.
Il giustizialista Fini andrà da indagato al congresso Fli. Il gip rinvia al 2 marzo la decisione sull’archiviazione del caso Montecarlo nel quale il leader è imputato di truffa. Nuove rivelazioni dal Principato sullo scandalo del quartierino, scrive Gian Marco Chiocci, Giovedì 03/02/2011, su "Il Giornale". Ha sbagliato i calcoli un’altra volta. Travolto dallo scandalo della casa di Montecarlo (di proprietà del cognato Giancarlo Tulliani) il presidente della Camera era certo di presentarsi al congresso fondativo del Fli dell’11 febbraio libero dalla pendenza giudiziaria che lo vede a tutt’oggi sott’inchiesta per truffa. E invece, purtroppo per lui, l’indagato neo-giustizialista Gianfranco Fini, quello che dispensa consigli all’indagato Berlusconi, arriverà all’appuntamento con quest’onta poiché il gip Figliolia ha preferito rimandare al 2 marzo la decisione sull’archiviazione richiesta da una procura sin qui molto attenta a non esporre alla gogna mediatica e giudiziaria l’ex delfino di Giorgio Almirante. Sarà dunque curioso vedere come si comporterà il Grande Moralizzatore di fronte ai suoi fedelissimi, lui che da un po’ di tempo ha scoperto una vena giustizialista «che - per dirla con Storace - porta a chiedere le dimissioni di chiunque sia sotto indagine. Se crede nelle parole che pronuncia, questo è il momento di far seguire i fatti». Ieri mattina bastava mettere a confronto le facce degli autori dell’esposto de la Destra (Marco Di Andrea e Roberto Buonasorte) con quella, attonita, dell’avvocato-deputato finiano Giuseppe Consolo, per capire come la decisione del gip abbia scombussolato i piani del massimo inquilino di Montecitorio che dal 28 luglio, giorno dello scoop del Giornale sull’appartamento monegasco, si è espresso in ogni sede possibile, per 48 volte, a favore della magistratura. Il giudice ha accolto l’istanza presentata dall’avvocatessa Mara Ebano per conto dei denuncianti de La Destra per vagliare la documentazione proveniente da Santa Lucia che i solerti pubblici ministeri avevano invece bollato come «irrilevante». Ora non sappiamo se corrisponda al vero quel che minaccia Storace («in questo mese sarà possibile produrre ulteriore documentazione e Fini resterà indagato») ma è sicuro che da Montecarlo rischiano di uscire, a brevissimo, ulteriori rivelazioni sull’affaire immobiliare del Principato. Se saranno rilevanti per la decisione del gip è presto per dirlo. Di sicuro potrebbero avere una certa attinenza col filmato del Tg1 - preannunciato ieri dai ricorrenti contro la richiesta d’archiviazione - nel quale l’imprenditore italomonegasco Garzelli riferisce di aver ricevuto mandato direttamente dal principe Alberto di mettersi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’intervista alla tv di Stato Garzelli parla dei suoi rapporti con Tulliani e con la sorella Elisabetta per la sistemazione dell’alloggio al 14 di rue Boulevard Charlotte, e rileva che in una telefonata il cognato più famoso d’Italia gli disse che il giorno prima Fini e la compagna erano stati a Montecarlo e si erano lamentati per aver trovato la casa non abitabile. Se le cose stanno come le racconta Garzelli, siamo di fronte a un altro testimone che smentisce Fini sulla sua presenza a Montecarlo.
Da Mani pulite alla galera per gli indagati. Quando invocava la forca giustizialista. La nemesi dell'ex Msi che tuonava contro i ladroni e faceva il moralizzatore, scrive Domenico Ferrara, Mercoledì 31/05/2017, su "Il Giornale". C'era un tempo in cui Gianfranco Fini sventolava le manette e faceva della moralizzazione politica il suo cavallo di battaglia. Erano gli anni di Mani Pulite. All'allora segretario del Msi bastava ascoltare la parola tangente o leggere di un avviso di garanzia per alzare l'indice e invocare le dimissioni, se non la galera. Qualche esempio? Quando il deputato repubblicano Antonio Del Pennino ricevette nel maggio del '92 un avviso di garanzia, Fini tuonò: «Il partito degli onesti perde colpi. Da oggi in poi, i repubblicani faranno bene a tacere sulla questione morale. Deve finire questa moda dell'autocensura di chi è accusato. Troppo spesso diventa un alibi per sfuggire all'autocritica. È molto meglio l'auto-arresto». Insomma, Fini era più dipietrista di Di Pietro, tanto da chiedere le elezioni amministrative anticipate per dar vita proprio a una «lista Di Pietro» formata «con chi non vuol pagare le tangenti» e da sfilare in piazza imbracciando cartelloni contro i partiti finiti sotto accusa. All'epoca non c'era nessun «coglione», erano tutti ladri e corrotti. «Occorre mandare a casa il governissimo dei ladroni, il ladronissimo Dc-Psi-Pds che ha inquinato la pubblica amministrazione milanese», chiosava Fini. E quando Gherardo Colombo, uno dei magistrati del pool, avanzò la proposta di condono per chi fosse coinvolto nelle inchieste sulle tangenti, Fini intervenne dimostrandosi ancora più severo della toga aggiungendo una conditio sine qua non: «Le sanzioni pecuniarie devono riguardare anche i partiti e non i loro singoli esponenti coinvolti». È lo stesso Fini che predicava la forca giustizialista basandosi sui condizionali. Come fece con l'allora sindaco di Palermo Aldo Rizzo: «Ha predicato contro la mafia ma pare che facesse affari con personaggi al di sotto di ogni sospetto. L'Europeo documenta eloquentemente le compromissioni di Rizzo con mafiosi di sicura fede. Se non ci sono reati, emerge sicuramente un quadro di intrecci censurabile politicamente». O, giusto per fare un altro esempio, è lo stesso Fini che nel 1993, dopo il coinvolgimento nell'inchiesta tangenti del presidente dell'Olivetti, Carlo De Benedetti, chiese le dimissioni del direttore Eugenio Scalfari in quanto: «Come si fa a dirigere un quotidiano, tanto più moralista e moralizzatore come il suo, quando l'editore è implicato in prima persona nella questione morale, al pari di personaggi come Ligresti o altri?». Col passare del tempo la musica non è poi così cambiata. Fini ha continuato a sostenere che i politici dovessero dare il buon esempio; che bisognasse disprezzare chi rubava senza scadere però nell'antipolitica; che la lotta alla corruzione non dovesse essere a intermittenza e che non si dovessero candidare i condannati in primo grado. Al grido di «chi è indagato lasci gli incarichi di partito», Fini è stato giustizialista pure nella storia recente. Solo per citare alcuni dei casi più simbolici, ha chiesto le dimissioni di Denis Verdini dal partito quando era soltanto indagato. Lo stesso ha fatto con Nicola Cosentino, pretendendone le dimissioni anche da coordinatore campano del Pdl. Poi, sul caso di Alfonso Papa, quando Fini era presidente della Camera, fu accusato di essere un «cinico burocrate che cerca di ribaltare la maggioranza con espedienti infimi» per aver conteggiato Papa ai fini del numero legale nonostante fosse in carcere. Il moralizzatore adesso però è finito nello stesso tritacarne politico-giudiziario che invocava per gli altri. Una nemesi storica travestita da paradosso.
Da Napolitano a Saviano tutti i "complici" di Fini. Travaglio, Saviano, politici e industriali. Quelli che nel 2010 difesero Fini accusandoci di essere una "macchina del fango", ora chiedano scusa, scrive Alessandro Sallusti, Mercoledì 31/05/2017, su "Il Giornale". Concorso esterno in riciclaggio, depistaggio, falso in scrittura pubblica e privata e calunnia, dovrebbero essere i reati morali e professionali da contestare ai non pochi colleghi e ai tanti politici ed esponenti delle istituzioni che in quella estate del 2010 e nei mesi successivi garantirono a priori sulla moralità di Gianfranco Fini e si scagliarono con violenza contro noi de il Giornale, inventori a loro dire di una macchinazione, la famigerata «macchina del fango», che attentava all'onorabilità dell'allora presidente della Camera su ordine di Silvio Berlusconi. La «casa di Montecarlo» non è solo una truffa di Fini e dei suoi amici mafiosi, come oggi appare in modo incontestabile dalle carte giudiziarie, ma è stata, cosa assai più grave, una gigantesca operazione di occultamento e mistificazione della verità a cui si sono prestati in tanti che oggi fanno finta di nulla. In primis i giornali. La Repubblica schierò il suo primo trombone (parlandone da vivo) Giuseppe D'Avanzo, che garantì su Fini e bollò noi come «assassini politici», che se oggi fosse vivo dovrebbe nascondersi; sul Fatto Quotidiano Travaglio scrisse tra le tante - un'articolessa dissacratoria del nostro lavoro intitolata «Il pistolino fumante» che a noi parve idiota allora ma che riletta oggi risulta invece tragica e dovrebbe portarlo a dimettersi dalla professione per manifesta incapacità. Non mancarono intellettuali e scrittori, che quando si tratta di sparare a vanvera abbondano. Saviano, sulla «macchina del fango» fece uno dei suoi monologhi moralisti al Festival internazionale di giornalismo di Perugia (sic), bissato in diretta tv dal suo amico Fabio Fazio a «Vieni via con me», che se ha usato la stessa arguzia e faciloneria nel giudicare noi e nello scrivere Gomorra è anche possibile che un giorno si scopra che la camorra non esiste. E poi i politici di ogni genere (ci furono molte incertezze anche nelle file del centrodestra), magistrati compiacenti che in poche settimane scagionarono Fini e istituzioni omertose, a partire dal presidente Napolitano che difese Fini e dopo pochi mesi scoprimmo il perché, con il primo tentativo di disarcionare Berlusconi per mano proprio dell'allora presidente della Camera. Non furono mesi facili. Fini era diventato una star. Non solo Santoro e compagnia lo elevarono da fascista a statista, ma persino un uomo libero come Enrico Mentana gli concesse la vetrina di un suo TgLa7 senza contraddittorio. Lui era lui, noi eravamo servi, killer, «macchina del fango» appunto. In tv era un inferno. Più che in uno studio televisivo era come salire su un ring, dove conduttori compiacenti davano libertà di menarti a gente come Italo Bocchino e Fabio Granata, gli onorevoli picchiatori di Fini finiti chi in storie di corruzione chi non si sa dove. Tra di loro ce n'era uno particolarmente attivo e viscido: Benedetto Della Vedova, uomo per tutte le stagioni (è passato con disinvoltura dai radicali ai fascisti, da Monti a Renzi) che da buon trasformista è tra i pochi di quella stagione ancora oggi in attività, addirittura sottosegretario del governo Gentiloni. Nessuno aveva stima di Fini, ma tutti sapevano che si era reso disponibile a tradire Berlusconi e a far cadere il governo di centrodestra. E allora addosso a noi, che svelando il caso di quella maledetta casa (innescato da una intuizione di Livio Caputo, collega di lungo corso al di sopra di ogni sospetto) avevamo senza ancora saperlo messo una zeppa nel diabolico piano. Per fermarci arruolarono, penso a sua insaputa, persino la presidentessa di Confindustria, Emma Marcegaglia, donna capace ma, almeno in quella occasione, un po' isterica. Le fecero credere riferendole una battuta scherzosa - che la «macchina del fango» del Giornale stesse puntando su di lei. Così una mattina all'alba io e il vicedirettore Nicola Porro ci ritrovammo in casa i carabinieri mandati dall'immancabile pm Woodcock: se non ci hanno arrestati c'è mancato un pelo. Gianfranco Fini chiamò subito donna Emma e per esprimerle tutta la sua solidarietà in quanto anche lei vittima de il Giornale e si premurò di farlo sapere. Il sapientone Travaglio subito spiegò in un lungo articolo che la Marcegaglia era stata critica con Berlusconi e per questo il Giornale si apprestava a punirla. Sentenza, la sua, disattesa da quella della magistratura ordinaria, che ci ha poi scagionato senza ombra di dubbio da qualsiasi sospetto. Sarà un caso, ma in quei giorni subii due intrusioni in casa da parte di ladri che non rubarono nulla. «Servizi segreti», mi suggerì un amico esperto del settore. Fermare il Giornale attraverso la calunnia era diventata una vera ossessione dell'articolato sistema politico-mediatico che aveva trovato il pollo antiberlusconiano e non voleva che nessuno lo spennasse prima del tempo. Cercarono, Fini e soci, di intimidirci con querele a raffica (una, storica, di Bocchino denunciava per stalking tutti i miei colleghi che lo avevano anche solo citato) e richieste di risarcimenti milionari. Ricordo che in quelle settimane Silvio Berlusconi mi disse, scherzando ma non troppo: state facendo un gran casino, il mio governo rischia di cadere più per colpa vostra che per mano di Fini. Perché ricordiamo tutto questo? Perché di Fini oggi a noi interessa poco. Ha pagato politicamente e pagherà il suo conto con la giustizia. Ha detto, per sviare e minimizzare: «Scusate, sono stato un coglione». Non ci basta per chiudere questa storia di cui siamo stati vittime. «Sono stato un coglione» lo dovrebbero dire a La Repubblica per conto di D'Avanzo, Travaglio, Saviano, Della Vedova e soci, Napolitano, la Marcegaglia e Woodcock, Santoro e Mentana, e tutti quelli che all'epoca indicarono noi come criminali. Perché i casi sono solo due: o coglione o complice. Terzo non dato.
La memoria sporca di Calabresi. Il direttore di "Repubblica" non ha preso bene che gli abbiamo ricordato la cantonata presa dal suo giornale su Fini, scrive Alessandro Sallusti, Venerdì 2/06/2017, su "Il Giornale". Mario Calabresi, direttore di La Repubblica, non ha preso bene che gli abbiamo ricordato la cantonata, per la penna di Giuseppe D'Avanzo, presa dal suo giornale ai tempi dello scandalo della casa di Montecarlo. Tra la nostra documentata inchiesta e le bugie di Fini, La Repubblica e D'Avanzo infangarono la prima e spacciarono per buone le seconde. Incapaci, complici, in malafede, ossessionati? Chi può dirlo. Ma la verità spesso irrita Calabresi, che ieri ha scritto un isterico corsivetto a difesa del suo eroe D'Avanzo (pace all'anima sua) rinnovando a me l'accusa di essere il capo della «macchina del fango». Si legga le carte dell'inchiesta su Fini - altro che fango - e si rassegni: D'Avanzo, e altri con lui, scrissero un mare di castronerie, cosa che peraltro non ci sorprese conoscendo i soggetti. E dire che Calabresi di fango dovrebbe intendersi, dirigendo un giornale di un gruppo che sul fango ha costruito la sua fortuna. Fin dall'inizio, con la famosa inchiesta-campagna stampa de L'Espresso che costrinse l'allora presidente della Repubblica Giovanni Leone a dimettersi e che si rivelò poi la più grande bufala nella storia del giornalismo italiano. E che dire del fondatore di La Repubblica, Eugenio Scalfari, firmatario insieme a diversi colleghi del quotidiano stesso di un manifesto che infangò l'onorabilità di un commissario di polizia, tale Luigi Calabresi (storia che il direttore dovrebbe ben conoscere essendo il di lui figlio) al punto da provocarne l'assassinio? E che dire, in tempi più recenti, del fango con cui La Repubblica ha sommerso Silvio Berlusconi per un reato - il caso Ruby - che i tribunali hanno poi dichiarato «non sussistere» in maniera inequivocabile? Siccome Calabresi è circondato dal fango, immagina che ogni giornale sia così. E invece non è così: qui al Giornale non abbiamo mandanti morali o politici di assassinii, noi su Fini avevamo scritto il giusto (per difetto) così come sul caso Boffo non abbiamo ricevuto neppure una querela. Perché noi quando commettiamo anche un solo piccolo errore anche se non inficia la sostanza lo ammettiamo e chiediamo scusa. Siamo fatti così, e al mattino non abbiamo problemi a guardarci allo specchio. Noi.
Caro Scalfari, non puoi dare lezioni a nessuno, scrive Alessandro Sallusti, Domenica 21/05/2017, su "Il Giornale". Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano la Repubblica, ieri sul suo giornale ha scritto un lungo (e noioso come sempre) articolo zeppo di insulti contro Vittorio Feltri e chi, come noi, sostiene che lui e tanti altri intellettuali e giornalisti furono, nel 1971, i mandanti morali e politici dell'omicidio del commissario Calabresi di cui in questi giorni cade l'anniversario. Firmarono un appello, questi fenomeni, che sapeva di condanna a morte, che infatti poco dopo fu eseguita dai compagni di Lotta continua. Oggi, a distanza di quarantacinque anni, Scalfari scrive che noi siamo «ciarpame» e svela di avere recentemente chiesto personalmente scusa alla vedova Calabresi per quella sciagurata firma sull'appello del 1971. Questo mascalzone pensa insomma che l'omicidio Calabresi sia stato, e sia ancora oggi, un fatto privato tra lui e i familiari della vittima, come fanno i banditi comuni pentiti - spesso per convenienza processuale - dei loro «raptus». No Scalfari, quell'appello non fu un «raptus» ma la libera scelta di stare dalla parte sbagliata - come poi si è dimostrato - della storia e per di più in modo criminale. Che oggi diventa furbo, perché non vuole ammetterlo né pagare pegno. Per Scalfari il «ciarpame» siamo noi, che Calabresi lo avremmo difeso fisicamente se ne avessimo solo avuto la possibilità, non lui e i suoi amici killer. È incredibile come in questo Paese ci sia gente in galera per «concorso esterno in associazione mafiosa» e quelli che fecero «concorso esterno in associazione terroristica» l'abbiano sfangata e ancora oggi si permettano di pontificare e giudicare. Essere di sinistra è stato per troppo tempo un salvacondotto che ha fatto più danni che se lo avessimo concesso a Vallanzasca.
Ma adesso basta, Scalfari. Gente così dovrebbe togliersi di mezzo, ha perso su tutti i fronti. Questo giornale, per il coraggio e la visione, è stato fin dall'inizio dalla parte che la storia ha dimostrato essere quella corretta, non la Repubblica e l'utopia socialista che tanti danni ha fatto e continua a fare. Purtroppo sotto la regia di un direttore che porta lo stesso cognome del commissario Calabresi.
Prima lo ammazzano poi lo fanno santo al Corriere della Sera e dintorni, scrive Vittorio Feltri il 19 maggio 2017 su "Libro Quotidiano". Di certo da quel mazzo furono pescati tutti gli assi che parteciparono alla fondazione della Repubblica. Oscuri professorini, da quella firma cavarono un balzo nella carriera accademica. Alla cerimonia non è venuto alcuno di costoro. Battendosi non dico il petto, ma almeno il doppiopetto. La vedova Gemma ha offerto il «perdono trovato grazie alla fede»: non c'era nessuno lì a cui darlo. In via Fatebenefratelli l'altro ieri si è così esaltata la persona della vittima, com'è buono e giusto. Le autorità e la famiglia erano commosse. C'è la proposta di fare Luigi beato. Auguri, ma di questo non intendo occuparmi. Temo anzi che l'esaltazione dell'eroe a martire cattolico sia persino un modo comodo per avvolgere di mistica religiosa un fatto atroce e barbarico, trasferendolo così quasi sul piano della mitologia salvifica, una specie di male necessario e in fondo benedetto da Dio (oltre che da Marx). Forse Calabresi sarà innalzato agli altari. In realtà qualcuno tra i suoi pugnalatori è già diventato beato, di più, è stato consacrato divo immortale delle arti e della cultura, grazie alla meticolosa dimenticanza della realtà storica in cui maturò quell'assassinio. La smemoratezza dei mandanti morali di quel delitto è diventata omertà, e lega con fili sottili e indicibili la classe intellettuale che ha ancora il possesso delle sorgenti della conoscenza storica e del giudizio politico sui fatti passati e recenti di questo Paese. Lo s'è visto molto bene alla morte di Umberto Eco, nume tutelare, con Eugenio Scalfari, della brigata di diffamatori del commissario Calabresi. Stetti zitto allora per non passare per un perturbatore di funerali, ma a cerimonia fresca proCalabresi ho una voglia esagerata di turbare questi santoni che s'innalzano a vicenda, da vivi e da morti. Erano stati, se ho contato bene, 757 coloro che con nome e cognome si misero in fila per sottoscrivere le tesi della sciùra più popolare dei salotti progressisti di Milano, la Camilla Cederna. 757 più un nome collettivo che ha aderito senza se e senza ma: il «Movimento nazionale dei giornalisti democratici» che prese in mano attraverso sue propaggini l'Ordine dei giornalisti e il sindacato con la corrente Rinnovamento, cui si oppose Walter Tobagi, fatto fuori pure lui. Erano tanti, dunque. Di essi pochissimi hanno chiesto pubblicamente scusa, dichiarando di vergognarsene. Che io sappia, sono Paolo Mieli e Carlo Ripa di Meana. Se ce n'è altri, sarò lieto di pubblicare nomi e fotografia. Torno a Eco. La morte di Eco è avvenuta nella serata dello scorso venerdì 19 febbraio. La domenica un supplemento speciale lo ha commemorato su Repubblica. L'articolo decisivo è stato quello di Eugenio Scalfari. Vi ha rievocato l'allegra baldoria notturna che caratterizzava quel gruppo di autentici capataz della cultura italiana: «Per qualche tempo fu perfino un rapporto di baldoria; quando lui veniva a Roma da Milano dove abitava o da Bologna dove insegnava, la sera ci trovavamo al piano bar di Amerigo dove dopo le dieci della sera c'era tutta l'intellighenzia della nostra sinistra, della quale Umberto faceva parte. E lì si chiacchierava, si beveva, si cantavano canzoni e si ballava fino alle due del mattino». Domanda: è in una di queste simpatiche serate che si stabilì che Calabresi andava additato come un torturatore e lasciato in mano alla giustizia popolare? È antipatico fare i nomi dei pezzi grossi della simpatica masnada. Si fa prima a dire chi non c'era. Indro Montanelli ed Enzo Biagi. Neppure Giampaolo Pansa firmò. Il resto aderì. Mario Soldati, Dario Fo (ovvio), Federico Fellini, Gae Aulenti, Norberto Bobbio, Ferruccio Parri, Giancarlo Pajetta. Sono morti, e non hanno fatto a tempo a chiedere che io sappia scusa pubblica come pubblica fu l'accusa infame. Forza Scalfari, leader dei sopravvissuti, scrivi un manifesto da proporre ai firmatari di allora di sottoscrivere una semplice frase: abbiamo sbagliato, domandiamo perdono. Senza una rivisitazione critica e onesta di quel periodo terrificante, durante il quale furono seminati terrorismo e discriminazione ideologica, questa Italia resterà un povero Paese. Dunque, rassegniamoci, lo resterà per saecula saeculorum.
Il commissario Calabresi e quella firma del 1971. Era un periodo molto agitato della vita italiana, politica, economica e sociale: l’inizio di queste tristi e lunghe vicende cominciò con la strage di piazza Fontana a Milano, scrive Eugenio Scalfari il 20 maggio 2017 su "La Repubblica". Agli attacchi che da qualche tempo si moltiplicano nei miei confronti da parte di Vittorio Feltri sul suo giornale che si chiama " Libero" non ho mai risposto. Si tratta di puro teppismo giornalistico che non merita né querele per diffamazione né calunnie; forse ci sarebbero gli estremi ma è tempo perso per la magistratura e per l'offeso di rivalersi contro questo ciarpame. Nessuna somiglianza con il "Foglio" di Claudio Cerasa: sarebbe come mettere sullo stesso piano un buon giornalismo polemico con il teppismo e quindi due cose del tutto differenti. Ieri però mi ha chiamato in causa, a due giorni dal 45esimo anniversario della morte del commissario Calabresi, ricordando il manifesto pubblicato dall'Espresso nel 1971. Nel caso in questione sento il dovere di ricordare il tema e di aggiungere qualcosa che fino ad oggi era rimasto un fatto privato, non per rispondere a lui ma per chiarire una vicenda che coinvolse in qualche modo l'Italia democratica (e anche quella antidemocratica). Era un periodo molto agitato della vita italiana. Quella politica, quella economica, quella sociale. Eravamo nella seconda metà degli anni Sessanta e quell'agitazione, cambiando spesso segno e misura, durò fino alla metà degli anni Ottanta, culminando con il rapimento e poi l'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse nel 1978. L'inizio di queste tristi e lunghe vicende cominciò con la strage di piazza Fontana a Milano, quando una bomba piazzata all'interno della Banca dell'Agricoltura uccise 17 persone e provocò il ferimento di molte decine di impiegati e di clienti. Era il 12 dicembre del 1969. La magistratura aprì immediatamente un'inchiesta e un'analoga indagine fu portata avanti dalla polizia. Tra gli investigatori c'era il commissario Luigi Calabresi, noto per la sua efficienza nel mantenimento dell'ordine pubblico e per la sua attenzione a non turbare ed anzi possibilmente a tranquillizzare i vari ceti che operavano nella città: il proletariato delle fabbriche, la borghesia delle professioni, degli affari, delle banche, e infine l'immigrazione dalle campagne meridionali che in quegli anni ancora continuava creando frizioni evidenti. Calabresi era molto attento a gestire un ordine pubblico che fosse in qualche modo al servizio dei vari ceti, distribuiti anche territorialmente in zone diverse. Quando si aprì il problema della strage in piazza Fontana Calabresi tentò in tutti i modi e avvalendosi anche dei vari "confidenti" della polizia di trovare una traccia criminale, gli autori di quell'accaduto che non aveva precedenti. Questa indagine dette pochissimi frutti, anzi quasi nessuno, tant'è che polizia e magistratura si orientarono in un certo senso ideologicamente: da un lato aprirono indagini verso gruppi ben noti di neofascisti, ma dall'altro puntarono sugli anarchici di cui c'era abbondanza anche perché si distinguevano nettamente in due parti non contrapposte ma profondamente diverse: una che non disdegnava di praticare violenza e l'altra che si limitava a predicare le tesi politiche dell'anarchia. Tuttavia la parte violenta degli anarchici non aveva mai infierito contro la popolazione anonima, com'era accaduto alla Banca dell'Agricoltura. I suoi obiettivi semmai erano persone molto potenti. Così agivano certi anarchici non solo in Italia ma anche in Europa e in altri paesi: il regicidio. E così era stato ucciso Umberto I re d'Italia e qualche anno dopo a Sarajevo uno dei nipoti dell'imperatore d'Austria scatenando in quel caso addirittura la prima guerra mondiale 1914-18. Niente di simile a piazza Fontana. Lì si era colpita proprio la popolazione civile il che dimostrava un puro desiderio di spargere sangue per aumentare la tensione sociale. Furono arrestati parecchi anarchici tra i quali un ferroviere che si chiamava Giuseppe Pinelli. Lui la violenza non l'aveva mai praticata ed anzi l'aveva esclusa dalle sue idee. Predicava l'anarchia e la predicava con grande efficacia tanto che era diventato uno dei dirigenti o per lo meno una personalità a cui tutti gli altri guardavano, anche molti che anarchici non erano ma facevano parte di schieramenti politici di sinistra. L'arresto era comprensibile ma non dette alcun risultato, anzi ne dette uno sommamente tragico per le persone coinvolte a cominciare dallo stesso Pinelli. Era stato fermato e trattenuto per tre giorni nella Questura che aveva la sua sede in via Fatebenefratelli. L'interrogatorio al quale era presente anche Calabresi fu molto duro anche se nelle testimonianze emerse che il commissario non praticò mai la violenza. Non si arrivava però ad alcun risultato perché Pinelli negava di aver commesso o organizzato o comunque simpatizzato verso le bombe di piazza Fontana; al contrario condannava quel tipo di azione che aveva privato della vita molte persone, appunto impiegati o clienti, di cui si ignoravano le idee politiche e persino lo stato sociale. L'interrogatorio comunque continuava perché in questi casi uno degli elementi che può cogliere qualche notizia dall'interrogato si sposa con la stanchezza e mentre i poliziotti si avvicendavano ed erano quindi freschi e riposati Pinelli era ormai straziato da ore e ore di interrogatorio. Ad un certo punto Calabresi fu chiamato dal Questore il quale aveva urgente bisogno di parlargli e lo aspettava nel suo studio. Il commissario andò nella stanza del Questore mentre l'interrogatorio continuò senza di lui. Ad un certo punto Pinelli cadde dalla finestra della stanza situata al quarto piano e morì prima di arrivare in ospedale. La Polizia parlò di suicidio, la piazza di omicidio, la magistratura stabilì che era caduto per un malore. Naturalmente l'effetto sulla cittadinanza di quanto era accaduto fu enorme e ancora più enorme fu quello esercitato sulla politica e in particolare su quella di sinistra: i comunisti, i socialisti, il partito d'azione, i repubblicani, insomma la sinistra e il centro sinistra. Venne l'idea di fare una grande manifestazione popolare per le strade della città, ma le strade erano state ovviamente tutte bloccate e impedite dalla polizia e quindi una manifestazione del genere era improponibile. Si passò allora all'idea di stilare un documento di denuncia e di farlo circolare su tutti i giornali e le agenzie di informazione. Più avanti, era ormai il 1971 e si stava tenendo il processo per la morte di Pinelli, fu stilato un testo, fu discusso da un gruppo del quale anch'io facevo parte (ero deputato alla Camera dal 1968 e lo rimasi fino al '72) e nel finale di quel documento c'era scritto che in attesa della fine del lavoro della magistratura, il primo atto di riparazione morale avrebbe dovuto essere l'allontanamento del commissario Calabresi dalla sua sede di lavoro. Non ricordo più tutte le firme ma ricordo che erano alcune centinaia di persone tra le quali Rossana Rossanda, Umberto Eco, e gli esponenti intellettuali di tutti quei settori che ho sopra ricordato. Passarono alcune settimane. Calabresi non fu trasferito né lo voleva e cominciò una campagna sempre più violenta contro di lui, che culminò con il suo omicidio. In quel periodo cercai un colloquio con Calabresi, ma non riuscii a parlargli. Era stremato dalla situazione e non sovrapponeva al suo lavoro altri incontri inutili. Cercandolo ebbi modo di parlare brevemente con la moglie, molto più giovane di lui, la signora Gemma, la quale mi colpì per la sua gentilezza. Il commissario fu ucciso l'anno dopo, il 17 maggio del 1972, a soli 35 anni. Ma la storia non finisce qui. Esattamente dieci anni fa, era il 16 maggio del 2007, ho rivisto la signora Gemma. L'allora sindaco di Roma Walter Veltroni aveva deciso di intitolare una via all'interno di Villa Torlonia a Luigi Calabresi. Decisi di partecipare e solo quando la cerimonia si fu conclusa la avvicinai, le chiesi se potevo abbracciarla e lei accettò, poi le dissi che ero andato lì per fare pace con la storia. Allora parlammo brevemente dei fatti del passato, del manifesto e delle firme, le dissi che quella firma era stata un errore. Lei accettò le mie scuse e si commosse. Per il resto parlammo del lavoro del figlio Mario che allora era corrispondente di Repubblica da New York e che ora, da oltre un anno, dirige questo giornale.
L’assalto dei nani contro Eugenio Scalfari, scrive Piero Sansonetti il 23 Maggio 2017, su "Il Dubbio". Perché il fondatore di Repubblica, un uomo che ha discusso di politica e di economia con Togliatti ed Einaudi, con Fanfani e Moro e Berlinguer, con Nenni, La Malfa, Craxi e Riccardo Lombardi deve essere costretto a subire gli attacchi volgari di giornalisti come Feltri e Travaglio? Non ho mai avuto simpatia per Eugenio Scalfari. Un po’ perché la sua è un figura altezzosa. Un po’ perché, politicamente, è sempre stato espressione di un pezzo di sinistra abbastanza lontana dalla sinistra che piaceva a me. Una volta – quando ero giovane, una trentina di anni fa – rifiutai persino una sua proposta di andare a lavorare a Repubblica. Perché mi sentivo lontano dal suo modo di pensare, di essere borghese. Trovo francamente fuori da ogni misura della realtà, e anche volgari, gli attacchi che sempre più spesso gli vengono rivolti da giornalisti molto più giovani e molto molto meno dotati e meno autorevoli di lui. Lo accusano di oscillazioni politiche, oppure lo accusano di essere renziano, oppure gli rinfacciano di aver fatto parte della intellettualità progressista degli anni sessanta. Alcuni di loro, per esempio Travaglio, evidentemente lo fanno non conoscendo bene la sua storia, per colpa delle loro giovane età e per lacune di studio. Altri, per esempio Vittorio Feltri, lo fanno fingendo di non conoscerla. E bastonano, bastonano. Bastonano il vecchio intellettuale liberale – per fortuna solo virtualmente – un po’ come i fascisti facevano – realmente – con Amendola, o con Gobetti, o con Rosselli. Mi chiedo come si fa ad accusare di renzismo (seppure questo fosse un reato) un signore che da circa 70 anni è al vertice del giornalismo italiano, che ha interpretato ai massimi livelli il pensiero laico e liberale, che ha discusso di politica e di economia con Togliatti ed Einaudi, con Fanfani e Moro e Berlinguer, con Nenni, La Malfa, Craxi e Riccardo Lombardi. E che ha diretto e fondato il più importante e anticonformista settimanale italiano e il più innovativo e prestigioso quotidiano del dopoguerra. Eugenio Scalfari, nella sua vita, e anche nella sua lunga carriera di osservatore politico – certo – ha commesso un numero notevole di errori. La sua continua ricerca di una sponda riformista nel mondo politico ha dato quasi sempre pessimi risultati, per colpa sua o per colpa della sponda. De Mita, Occhetto, Prodi. Ma non credo che nessuno possa negare che egli sia un colosso del giornalismo italiano. Nel dopoguerra non mi pare che esista no altre figure della sua statura, a parte, forse (ripeto: forse), quella di Indro Montanelli. L’ultimo attacco gli è venuto da Vittorio Feltri, il quale lo ha accusato di essere stato tra coloro che sottoposero a linciaggio morale il commissario di polizia Luigi Calabresi, nel 1971, e quindi di portare sulle proprie spalle la responsabilità morale per la sua uccisione (avvenuta nel maggio dell’anno successivo). E gli ha ingiunto di chiedere scusa pubblicamente. Scalfari ha già risposto, su Repubblica, con un articolo per niente reticente, molto sereno e anche dolce (dote inconsueta per lui) che smonta l’assalto di Feltri. Non c’è molto altro da aggiungere a questa polemica. Però forse c’è da fare qualche riflessione ulteriore per cercare di capire perché Eugenio Scalfari è diventato il bersaglio preferito dei giornali della destra e non solo della destra (compreso Il Fatto). Sento in questa aggressione tutta la forza e lo spirito di sopraffazione del moderno giornalismo, che si è sostituito al vecchio giornalismo, e lo disprezza, e vuole cancellarlo, e per cancellarlo tende a demolire i pochi simboli che sono rimasti. Il nuovo giornalismo – quello inventato da Vittorio Feltri un quarto di secolo fa, e che poi ha avuto molti seguaci, tra i quali il più noto è sicuramente Travaglio – è fondato non sulle idee, né tantomeno sulla ricerca dell’informazione, della descrizione, del racconto. Non tiene in nessuna considerazione l’aspirazione alla verità. Considera l’oggettività una dote degli imbelli, dei paurosi. E fonda se stesso solo sulla ricerca ossessiva di un avversario, della colpa dell’avversario, della maledizione dell’avversario, della punizione, della demolizione, dell’umiliazione. Perché immagina – forse con qualche ragione – che questa sia l’unica via per conquistare il favore del lettore, per prendere possesso dei suoi sentimenti – accarezzandoli, blandendoli, oppure incattivendoli – e quindi per assicurare una platea a una attività che altrimenti rischia l’isolamento e la sconfitta. Il nuovo giornalismo ha escluso la possibilità di ricostruire una informazione di qualità. Dove le diverse posizioni si confrontino e lottino tra loro, e non si scontrino in una battaglia giudiziaria e di mostrificazione. Ha escluso il valore della verità. Ha abolito strumenti – una volta essenziali – come la verifica della notizia, il ragionamento sulla notizia, l’inchiesta, la ricerca, l’anticonformismo. Tutti elementi che ormai vengono considerati come impicci pericolosi. In parte anche per ragioni economiche. Verificare, studiare, indagare: costa. Richiede risorse umane molto grandi. Gli editori non vogliono. Vogliono la notizia subito, a due lire. Se c’è qualcuno, per esempio un po’ di Pm, disposto a fornirla, evviva i Pm. Succede così che una volta avevamo Scalfari, e Montanelli, e Pintor, e Reichlin, e Biagi, e Valli, e Mo, Colombo, Levi, Casalegno, Tobagi, Pansa, Bocca: ora ci restano solo il ghigno avvelenato di Travaglio e le frecce di Feltri. Una volta c’era l’inviato che passava un mese ai cancelli della Fiat, o a Gibellina, e poi scriveva un’inchiesta in tre puntate. Ora c’è Marco Lillo che passa un paio d’ore davanti alla porta di un carabiniere o di un Pm, e poi consegna al suo direttore quattro presunti scoop già pronti. Una volta un buon giornalista doveva saper scrivere. Ora deve sapere trascrivere. Mi ricordo che una trentina d’anni fa il giornale per il quale lavoravo, l’Unità, prese una gran cantonata: diede retta a un documento falso, che gli fu consegnato da un confidente della polizia o forse dei servizi segreti, e lo pubblicò. In questo documento c’era scritto che il ministro Scotti era stato in carcere a trattare con Raffaele Cutolo, boss della camorra, la liberazione di un assessore democristiano che si chiamava Ciro Cirillo e che era stato rapito dalle Brigate Rosse. Ci volle poco, nei giorni successivi, dopo le proteste indignate di Scotti e della Dc, per capire che il documento era falso. Si dimisero il direttore dell’Unità, il vicedirettore e il redattore- capo. E si dimise anche il vicesegretario – di fatto – del Pci, che era solo il partito editore. Il capo dei deputati comunisti si alzò nell’aula di Montecitorio e prese la parola per chiedere scusa. Si chiamava Giorgio Napolitano. Dare una notizia falsa, allora, era una cosa gravissima, quasi una vergogna per un giornalista. Di solito rovinava una carriera. Ora, tra le altre varie bufale, ci troviamo di fronte a giornali che hanno condotto una campagna di giorni e giorni sulla base di un documento falso, prodotto da un carabiniere ora inquisito, che accusava il padre del premier dell’epoca – e cioè Renzi – di avere incontrato l’ex parlamentare Bocchino per conto dell’imprenditore Romeo. Si suppone, a fini di corruzione. Quando si è scoperto che era una balla confezionata apposta o per errore, non solo non si è dimesso nessuno, ma si è moltiplicata la campagna, si è dato fondo alle intercettazioni illegali, si è giunti fino all’abominio – per qualunque liberale, anche leggermente liberale… – di pubblicare le intercettazioni del colloquio tra un avvocato e il suo assistito. È questo il nuovo giornalismo? A questo dobbiamo adeguarci? Bisogna chinare il capo perché è la modernità? Se proprio devo chinare il capo, preferisco farlo per dare omaggio al vecchio, indomito, saccente e insopportabile Eugenio Scalfari.
Vittorio Feltri il 21 Maggio 2017 su "Libero Quotidiano" risponde a Scalfari sul manifesto contro Luigi Calabresi: "Sarò teppista, ma so ancora distinguere gli errori e i crimini". Sarò un teppista, come mi definisce Eugenio Scalfari, ma mi sono preso la soddisfazione di svegliare l'elefante. Negli ultimi anni, nella sua omelia domenicale, aveva tenuto una corrispondenza solo con il Papa, con barriti flautati e grati, dato che il collega di prediche pare gli avesse garantito che non esiste il peccato. Mi sono permesso di sventolargliene uno sopra la proboscide, antico ma rinfrescato da recentissime cerimonie, e il pachiderma si è imbufalito (non so se si possa dire così, ma rende l'idea). Lascio perdere le villanie e le sgrammaticature, che scuso per l'età e perché la questione non è personale, e vado al sodo. A cosa debbo l'onore della barbuta reprimenda? A un articolo che qui, facendo crescere la barba anche a voi, sintetizzo. La cerimonia del 45° anniversario dell'assassinio del commissario Luigi Calabresi ha rilanciato l'idea di promuoverne la beatificazione. Tutti d' accordo: è stato un martire. Lo sostengono anche quelli che gli hanno confezionato, mentre era vivo, la bara. Dal gregge di pecore (ma cachemire, beninteso) che isolò Calabresi e lo gettò in pasto al commando di Lotta Continua non si è levato non dico un grido, ma neanche un belato traducibile in mea culpa. Siccome sono uno che fa nomi, li ho fatti. Nessun lavorio dietro le quinte, nessun verbale coperto da segreto: carta pubblica, stampata, a gran tiratura. Nel 1971 uscì non una sola volta ma per alcune settimane il manifesto dell'Espresso firmato da 800 personaggi della crème di sinistra, e i cui capi intoccabili erano Umberto Eco ed Eugenio Scalfari. Sotto il titolo "Colpi di karatè" si indicava nel "commissario torturatore" il responsabile della morte di Giuseppe Pinelli, un anarchico in stato di fermo dopo la strage di Piazza Fontana. Ho anche citato due signori che hanno avuto il coraggio di battersi il petto davanti a tutti per quel mandato morale di omicidio, Paolo Mieli e Carlo Ripa di Meana. E ho concluso che l'Italia sarà un povero Paese finché non si avrà il coraggio della verità. Di quegli 800 nessuno ha pagato alcun prezzo di carriera o di immagine. Ci sia un gesto, un piccolo gesto, che costa pochissimo, ma vale moltissimo per dare magari persino un insegnamento alle giovani generazioni, ma anche a quelle anziane e ancora silenti. Forza Eugenio. Questo ho scritto più o meno, con altre parole per non farmi pagare due volte lo stesso articolo. Dinanzi a questa richiesta scritta persino in italiano corrente, Scalfari ha emesso una gigantesca pomposa pernacchia. Ma la dirige contro se stesso. Mostra infatti di avere ottima memoria e conferma di essere stato allora e di essere oggi un uomo di potere, tale e quale. Egli ricostruisce il momento in cui stese quel manifesto anti-Calabresi insieme ai pezzi grossi della cultura italiana. Sostiene che era un suo dovere, ci era tenuto in quanto a quel tempo era deputato socialista. La piazza fremeva, i "ceti" (scrive così) si ribellavano. E loro diedero indirizzo all' ira, quello di Calabresi. Ma non volevano fosse ammazzato, bensì semplicemente trasferito. Se è per questo ci riuscirono, fu spedito all' altro mondo. L' accusa dei colpi di karatè, quella di essere un torturatore? Scalfari non lo dice, se l'è scordato. Fu quasi un modo per proteggerlo, lascia capire, dalla giusta furia del proletariato. Scalfari rivela che nel 2007, cioè 36 anni dopo, abbracciò la vedova Gemma Calabresi partecipando con Walter Veltroni alla intestazione di una strada di Roma al commissario. Alla signora «dissi che quella firma era stata un errore». Del resto il figlio Mario - ricorda - era corrispondente da New York della "sua" Repubblica, e oggi ne è il direttore. Insomma. Ha aspettato qualche decina d' anni per confessare in privato un "errore", un onesto errore; ma ha dato lavoro al figlio, il quale ha fatto carriera, che si vuole di più da lui? Grande è il potere della menzogna. A questo punto mi consenta Scalfari di rubargli l'arte delle citazioni specialmente francesi. Questa frase è di Joseph Fouché, ministro di polizia di Napoleone durante il primo impero, commentando la fucilazione del duca di Enghien: «È peggio di un crimine, è un errore». Per Scalfari, che vede la storia dal suo balcone, dove laggiù sullo squallido suolo le formichine uccidono e muoiono, è stato un errore. Per noi, che siamo gente volgare, siamo teppisti, è peggio il crimine. E quel manifesto fu un crimine. Di Vittorio Feltri
Tutte le ultime baruffe di carta fra Scalfari, de Bortoli, Feltri e Cerasa, scrive Francesco Damato su "Formiche.net" il 20 maggio 2017. Il Foglio è notoriamente un giornale che supplisce alle poche copie vendute con la fantasia del fondatore Giuliano Ferrara, fra le altre cose ex ministro per i rapporti col Parlamento, nella ormai lontana stagione dell’esordio politico dell’amico Silvio Berlusconi. Una fantasia, quella di Ferrara, brillante, prolifera e mai inosservata perché il suo giornale, oltre ad arrivare nelle edicole, con le incognite e gli inconvenienti di un mercato un po’ avaro con tutti i quotidiani, è diffuso con le rassegne stampa negli ambienti che contano, fra quelli che l’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli, di cui tornerò a scrivere, chiama “i poteri forti, o quasi”. Poteri, per esempio, come quelli di Carlo De Benedetti e di Eugenio Scalfari, rispettivamente editore e fondatore di Repubblica. Si sa quanto sia difficile di gusti Scalfari, intervenuto pochi giorni fa a bacchettare e un po’ a dileggiare Claudio Cerasa, subentrato da qualche tempo a Giulianone nella direzione del giornale e azzardatosi a strappare a Matteo Renzi la prima intervista come risegretario del Pd, precedendo Repubblica. Ma per una questione personale, di cui vi dirò più avanti, il buon Scalfari ne ha appena tessuto gli elogi confrontandolo col “teppista” Vittorio Feltri, di Libero. Da qualche tempo tuttavia Il Foglio non è più soltanto un giornale. Sembra diventato una specie di sala parto di quel grande ospedale dove è ricoverata la politica italiana. In questa sala parto si cerca affannosamente, ogni volta che la politica offre un emergente, quello che Ferrara anni fa chiamò “royal baby”, inteso come erede del suo già ricordato amico Berlusconi. Dei cui anni che passano lo stesso Berlusconi non si accorge, ma Ferrara sì. Il primo royal baby del Foglio è stato notoriamente Matteo Renzi, con tanto di libro scritto dallo stesso Ferrara e più fortunato del suo quotidiano nelle vendite. Ma Renzi, per quanto risorto come segretario del suo partito dopo la mazzata invernale del referendum costituzionale, non ha più la brillantezza di una volta. Pertanto al Foglio hanno cominciato a cercare qualche altro baby da promuovere a royal. E Cerasa ha dato la sensazione di averlo trovato o intravisto in un sessantenne vigoroso e promettente, paragonandolo proprio a Berlusconi, di cui fu peraltro collaboratore da giovanissimo e potrebbe ripetere il percorso politico, se solo lo volesse. E’ Urbano Cairo, proprietario di una squadra di calcio, che il vecchio Berlusconi ora non ha più; di un giornale – addirittura il Corriere della Sera – altro che quello diretto da Alessandro Sallusti; e di una televisione. Che è la 7 e, pur non avendo gli ascolti delle tre reti del Biscione, fa più politica di tutte quelle messe insieme. E la fa in un modo che all’ex royal baby Renzi deve piacere sempre meno.
Ferruccio de Bortoli – vi ricordate? Vi avevo promesso che sarei tornato ad occuparmene ed eccomi qua – pubblica un libro che, volente o nolente, crea un bel po’ di problemi a Renzi, fra banche, massoneria e altro? E qual è la televisione che lo invita per prima a parlarne, avendo peraltro come spalla un Massimo Cacciari in grandissima forma? La 7 naturalmente, nello studio di Lilli Gruber, dove l’ex direttore del Corriere raccoglie e rilancia la minaccia della renziana sottosegretaria ed ex ministra Maria Elena Boschi, sfidandola a querelarlo davvero per averne rivelato un incontro politicamente galeotto con Federico Ghizzoni, quando questi era amministratore delegato di Unicredit e la Banca Etruria vice presieduta del papà della stessa Boschi ambiva ad essere acquistata, e salvata, proprio da Unicredit. Romano Prodi si fa intervistare da Repubblica mostrandosi assai scettico, se non contrario all’ipotesi che Renzi riconquisti la guida del governo, oltre alla segreteria del partito, e quale televisione lo chiama subito ad approfondire il tema cogliendo l’occasione anche per lanciarne un libro fresco di stampa? La 7, sempre nello studio di Lilli Gruber, che affonda continuamente il coltello nella piaga di Renzi possibile premier, contando sempre sul sorriso complice dell’ospite. La sera dopo quella birichina sempre o simil giovane Lilli, coetanea comunque del suo editore, chiama nel suo salotto un altro ex illustre: Walter Veltroni. Di cui la conduttrice deve presentare non un libro ma un film, dedicato ad un tema allettante come quello della felicità. Ma il tema principale della conversazione finisce -guarda caso- per diventare quello di Renzi e della sua ambizione, vera o presunta, a tornare anche a Palazzo Chigi, dopo essere rimasto al Nazareno. Il povero Walter, che peraltro ammette di avere votato alle primarie per Renzi, pur essendo quel giorno in viaggio -se non ho capito male- in Sudamerica, cerca più volte di sottrarsi all’assedio ma la Lilli non molla, anche a rischio di dimenticarsi del film. Che alla fine però arriva al pettine lo stesso, anche con la visione di qualche scena. Sbaglierò, ma l’impressione che ho ricavato è che la Gruber valuti personalmente l’ipotesi di Renzi di nuovo a Palazzo Chigi come Prodi, cioè male.
Vi avevo promesso che sarei tornato a scrivervi di Scalfari, che ha dato del “teppista” a Vittorio Feltri. Egli ha così reagito al rimprovero fattogli su Libero, in occasione del 45.mo anniversario – ahimè – dell’assassinio del commissario di polizia Luigi Calabresi, vicino ora alla Beatificazione di Santa Romana Chiesa, di avere firmato l’anno prima del delitto un manifesto destinato ad eccitare ancora di più i malintenzionati di Lotta Continua. Dove accusavano il povero Calabresi, contro le stesse risultanze giudiziarie, di avere quanto meno contribuito nel 1969 alla mortale caduta da una finestra della Questura di Milano dell’anarchico Giuseppe Pinelli, fermato per la strage di Piazza Fontana. A parte l’insulto a Feltri, che un po’ – bisogna riconoscerlo – se la va a cercare con quel modo troppo urticante di scrivere e di titolare, Scalfari ha finalmente colto l’occasione per sciogliere un dubbio manifestato anche da me qui, su Formiche.net, quando egli non gradì quanto meno le modalità della nomina del figlio di Calabresi, Mario, a direttore della “sua” Repubblica. Dove peraltro Mario, prima di assumere la guida della Stampa, aveva lavorato con ruoli di rilievo, compreso quello di redattore capo. Scalfari ci ha ora rivelato di essersi pentito subito, sia pure solo in privato, della firma a quel manifesto, vista la strumentalizzazione cui si era prestato. Di avere inutilmente cercato di chiarirsi con lo stesso commissario, con cui tuttavia non riuscì a parlare, riuscendo invece con la moglie Gemma. Che incontrò personalmente nel 2007 nella via di Villa Torlonia appena dedicata alla memoria di suo marito, presente l’allora sindaco di Roma Walter Veltroni, rinnovando le sue scuse e abbracciandola, entrambi commossi. Un abbraccio col quale Scalfari ha forse un po’ troppo enfaticamente scritto di avere ritenuto di “fare pace con la storia”. Ma se tutto questo lo avesse raccontato in occasione della nomina di Mario Calabresi a direttore della “sua” - ripeto – Repubblica, Scalfari non avrebbe fatto male. Nè avrebbe sbagliato ritirando quella maledetta firma pubblicamente, visto che il manifesto contro Calabresi fu a lungo riproposto dall’Espresso, e non solo, in ogni avversario della morte di Pinelli.
I due piombi di Calabresi, scrive Marcello Veneziani. Quest’anno il commissario Luigi Calabresi avrebbe compiuto ottant’anni. E invece all’età giovane di 35 anni, in un giorno di maggio, fu ucciso da un commando di Lotta Continua. È una ferita ancora aperta nella storia del nostro Paese anche perché vi fu una rete di complicità morali e intellettuali intorno a quell’assassinio che ancora scotta. Come ha dimostrato in questi giorni la polemica rovente tra Eugenio Scalfari, uno dei firmatari del manifesto contro Calabresi, e Vittorio Feltri, che glielo ricordava senza giri di parole. Quando ripenso ai primi anni settanta, ne ho un’immagine in bianco e nero come la tv del tempo; i maglioni dolcevita, le basette lunghe, la 500, le spranghe e le catene, i poliziotti, il sessantotto inacidito in terrorismo, la lotta politica che degradava nella lotta armata, le stragi. Quelle immagini, lievi e cruente, si compendiano tutte nel ritratto di Luigi Calabresi, commissario e martire negli anni di piombo. Ove per piombo s’intende non solo quello delle armi ma anche quello sotto le rotative. E che condannò Calabresi con una fatwa micidiale. Lo ricordo in bianco e nero, il commissario, con un dolcevita, le basette lunghe, lo sguardo fiero e mediterraneo, la sua cinquecento, tra i poliziotti; e poi le violenze di quegli anni, i cortei, gli insulti, il linciaggio a mezzo stampa, l’omicidio. Calabresi aveva il senso dello Stato, credeva al decoro delle istituzioni e alla dignità del suo ruolo, aveva la responsabilità di uomo d’ordine. Un’espressione antica, terribilmente demodé, le compendiava tutte: Servitore dello Stato. Così si definiva Luigi Calabresi. E a chi fa una smorfia d’insofferenza per un’espressione antiquata e retorica, ripensi con rispetto che a quella definizione Calabresi restò fedele fino alla morte. Inclusa. Tutto per 270 mila lire mensili, uno stipendio medio per quei tempi, che a Milano con famiglia a carico non consentiva una vita molto agiata. Un minimo decoro, però senza scialare. Ad aggravare il suo ritratto di uomo d’onore, vi era in Calabresi anche un fervente senso religioso. “Sono nelle mani di Dio” diceva. Anche per questo fu avviato il suo processo di beatificazione e fu proclamato servo di Dio. In un suo scritto, Calabresi criticava il degrado del senso civico e la riduzione delle aspettative di vita al successo, al sesso e al denaro. Era l’affiorare della società dei consumi; oggi dovremmo dire che Calabresi aveva visto sul nascere la barbarie benestante del nostro tempo, privo di valori. La borghesia cinica e miscredente muoveva allora i suoi primi passi. Sarà quella borghesia “illuminata” a partorire i radical chic e i salotti nemici di Calabresi. A lui fu data dal presidente Ciampi, con 32 anni di ritardo, la medaglia d’oro al valore civile. Un riconoscimento postumo, assai postumo, che si insinuava come una piccola parentesi nel fiume di parole, interventi, pressioni per concedere la grazia a Sofri e Bompressi. Nell’immaginario collettivo dei media, i martiri erano diventati loro, non Calabresi. Il caso Calabresi resta una ferita profonda nella storia civile e culturale d’Italia. Non possiamo dimenticare che si mobilitarono contro di lui, in un famigerato manifesto, i tre quarti della cultura e dell’intellighentia italiana. Ottocento firmatari, l’intero establishment culturale, accademico, editoriale e giornalistico italiano, ancora in auge, si schierò contro di lui, lo squalificò, lo delegittimò. Gettarono le basi per il suo assassinio, o perlomeno crearono un clima di ostilità favorevole alla “giustizia proletaria”. Non è il caso di rivangare con rancore quegli anni e quegli errori che mutarono in orrori. Ma quando si tratta di far la storia di quegli anni bisogna pur dirla la verità, bisogna pur ricordare la mobilitazione che collegò il partito armato al partito degli intellettuali, tramite l’estremismo politico e la sinistra intellettual-militante, in un girotondo nazionale da cui scappò più di un morto. Non capiremmo neanche la lobby continua in favore della scarcerazione di Bompressi e Sofri se non ricordassimo quelle ottocento firme. E se non ricordassimo la carriera folgorante di quel ceto di sessantottini arrabbiati che si raccolsero intorno a Lotta Continua. Belle intelligenze, ma all’epoca anche spietati radicali, feroci nel linguaggio e duri nei servizi d’ordine, teorici convinti che “uccidere un fascista (o un poliziotto) non è reato”; poi si disseminarono nella tv e nel giornalismo, nella sinistra ma anche nel centro-destra. Magari non capiremmo neanche la direzione de la Repubblica – covo di firmatari del manifesto anti-Calabresi – al figlio dello stesso Calabresi. Non è mai troppo tardi per ammettere: si, ci eravamo sbagliati, Calabresi era un galantuomo. Il furore di quegli anni ha oscurato la mente e inferocito gli animi, ma Calabresi fu uno dei pochi che lasciò a noi ragazzi degli anni settanta la residua speranza nello Stato, nell’amor patrio, la fedeltà alla propria missione. Quando sento parlare oggi di fedeltà alla Costituzione, vorrei ricordare che altri, come Calabresi, scontarono sulla propria pelle la fedeltà non a una carta, ma a uno stile, a una patria, a uno Stato. Che li mandava allo sbaraglio e poi si dimenticava di loro. Di lui mi resta viva un’immagine raccontata da Luciano Garibaldi: quella del Commissario Calabresi che passando con suo figlio ancora bambino, davanti alle scritte minacciose e infamanti contro di lui, “Calabresi assassino”, ha un sussulto di tragico e grottesco ottimismo, dicendo: meno male che lui non sa ancora leggere…Ma dopo, quando suo figlio ha capito chi era suo padre e chi erano i suoi nemici che lo volevano ammazzare, quando ha saputo leggere a rovescio quella scritta, non “Calabresi assassino” ma “assassino Calabresi”, mutando un sostantivo e un’accusa infami in un verbo e in una tragica minaccia, avrà ripensato a chi lo portava per mano per le vie di Milano e si sarà detto con commosso orgoglio: sì, quello era mio padre. Ma la storia di poi, come sapete, non andò proprio così…Il Tempo 26 maggio 2017.
Tutti gli strepitii giustizialisti contro Augusto Minzolini, scrive Francesco Damato su “Formiche.net” il 17 marzo 2017. Prima sono arrivati i 161 voti, per appello nominale, contro la sfiducia “individuale” reclamata dai senatori grillini per il ministro dello sport Luca Lotti, renziano di strettissima osservanza, indagato per violazione del segreto d’ufficio o istruttorio, da lui negato agli inquirenti, nell’inchiesta giudiziaria sugli appalti della Consip per gli acquisti miliardari della pubblica amministrazione. Poi, a distanza di meno di ventiquattro ore, sempre nell’aula del Senato, sono arrivati i 137 voti, anch’essi palesi, a favore del forzista Augusto Minzolini, sottratto alla decadenza da parlamentare proposta dalla competente giunta in applicazione della cosiddetta legge Severino, essendo stato condannato sette mesi fa in via definitiva a più di due anni -due anni e sei mesi- per peculato, anche su denuncia di Antonio Di Pietro. E di chi sennò? Peculato ai danni della Rai, dalla quale Minzolini dipendeva come direttore del Tg1 usando una carta di credito aziendale diventata poi oggetto di una lunga e contorta controversia amministrativa e infine giudiziaria, con verdetti opposti in primo e secondo grado. Un secondo grado, però, per quanto confermato dalla Cassazione, dove il giornalista e senatore si era imbattuto in un avversario politico, appena tornato a fare il giudice dopo una ventina d’anni di attività parlamentare, e anche di governo, tutti a sinistra. Mi pare di avervi raccontato tutto, sia pure per sommi capi: più comunque di quanto non abbia fatto con i suoi lettori, a grandissima sorpresa, Il Foglio del fondatore Giuliano Ferrara e del direttore Claudio Cerasa. Sulla cui prima pagina ho trovato solo sei righette di corpo millesimale sulla vicenda Minzolini nella rubrica La Giornata. Ma i colleghi avranno tempo, se vorranno, per recuperare, non foss’altro a causa delle scomposte, a dir poco, reazioni dei grillini e affini, convinti che non ci sarebbe da stupirsi se i loro elettori, simpatizzanti e quant’altri assaltassero i palazzi del potere per protesta contro il Senato e mettessero a ferro e a fuoco le piazze d’Italia. Dove -ahimè- può accadere anche questo senza che nessuno ne possa o debba poi rispondere, come dimostra la guerriglia appena praticata a Napoli contro l’ospite indesiderato Matteo Salvini, deriso dal sindaco della città Luigi de Magistris. Vi raccomando il de minuscolo perché spetta anagraficamente all’ex magistrato.
A guidare sul fronte mediatico la rivolta alla quale i grillini hanno garantito quanto meno la loro comprensione è naturalmente il direttore e co-fondatore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che non si dà pace delle delusioni procurategli dal Senato elettivo della Repubblica. Di cui lui nella campagna referendaria sulla riforma costituzionale targata Renzi ha pur difeso strenuamente la sopravvivenza, accusando l’allora presidente del Consiglio di volerlo ridurre ad un dopolavoro dei troppo sputtanati - scusatemi la parolaccia - Consigli Regionali, dove non si riesce neppure più a contare i condannati e inquisiti per peculati, sperperi e varie. A fare saltare i sismografi degli umori nella redazione del Fatto Quotidiano e dintorni è stata anche la paura che, rotto col caso Minzolini l’incantesimo della legge Severino, e della sua applicazione curiosamente retroattiva, ne possa trarre presto beneficio anche Silvio Berlusconi, che di quella legge nell’autunno del 2013 rimase vittima con una votazione che lo espulse dal Senato. Il ricorso dell’ex presidente del Consiglio pendente da tempo davanti ad una Corte internazionale potrebbe ricevere una spinta decisiva proprio dal diverso verdetto, questa volta, dei senatori. Non si dà proprio pace, il povero Travaglio, del fatto che Minzolini non sia già decaduto automaticamente da senatore, che abbia invece continuato a riscuotere la sua indennità e a maturare la sua pensione, o come diavolo si chiama, per sette mesi dopo la sentenza definitiva di condanna, e possa continuare adesso, anche dimettendosi, come Augusto ha annunciato orgogliosamente di voler fare perché convinto di avere sostenuto una causa di principio, non di interesse. Travaglio si è fatto rapidamente i conti e si è accorto che nei nove o dieci mesi che mancano alla fine ordinaria di questa diciassettesima legislatura i senatori non avranno il tempo di accettare le dimissioni del loro collega con un voto a scrutinio, questa volta, rigorosamente segreto, e con la consuetudine maledettamente consolidata di respingerle la prima volta. Ah, sono proprio sfortunati questi afflitti da anticastite, nel senso di casta, fatta salva naturalmente la propria, perché di caste nel nostro Paese ce ne sono tantissime, al coperto di ordini, associazioni e quant’altro.
Se ne avesse avuto il tempo e lo spazio, forse Travaglio avrebbe completato con le loro fotine l’elenco pubblicato in prima pagina - tipo i manifesti dei ricercati nel far west- dei reprobi del gruppo Pd del Senato che hanno consentito a Minzolini di scampare alla decadenza. Un elenco però comprensivo sia dei 19 che hanno votato a favore del “pregiudicato”, avvalendosi della “libertà di coscienza” concessa dal capogruppo Luigi Zanda, sia dei 14 che si sono astenuti ma che di fatto, in base al regolamento di Palazzo Madama, si sono sostanzialmente aggiunti ai 35 che hanno votato contro. Neppure il modo di opporsi astenendosi, quindi, va bene ai grandi depositari della illibatezza morale e politica. Se la situazione non fosse drammaticamente seria, ci sarebbe da ridere. Ma a pochi giorni dal cambio naturale di stagione voglio sperare di festeggiare anche un cambio politico di stagione. Una rondine, si sa, non fa primavera. Ma due rondini, a distanza di poche ore l’una dall’altra, come sono stati i 161 voti a favore di Lotti e i 137 a favore di Minzolini, possono forse fare davvero primavera: quella del garantismo. E ciò alla faccia dei grillini, dei loro estimatori e persino del loro governo, che a Repubblica si sono appena avventurati a immaginare prevedendo il vice presidente della Camera Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, il suo amico-competitore Alessandro Di Battista, il Chè Guevara di Trastevere, al Viminale e l’ingegnere informatico Manlio Di Stefano, un palermitano eletto in Lombardia, alla Farnesina grazie al tirocinio in affari internazionali, diciamo così, fattosi in quattro anni frequentando la Commissione Esteri della Camera.
Pagina Facebook di Servizio Pubblico, 9 febbraio 2017 alle ore 19:59. Lettera aperta di Michele Santoro a Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it. "Caro Peter Gomez, Vedo che hai sentito la necessità di correggere il tiro ma voglio lo stesso rivolgermi a te pubblicamente. Nella top ten delle frasi celebri penso che resti al primo posto quella di Stefano Ricucci, che bollava quelli che amano “fare i froci col culo degli altri”. Mi sembra che tu ora ne abbia varato una versione più casta: “Fare i moralisti col culo degli altri”. L’operazione della Stampa nei miei confronti (ma sarebbe più corretto dire, come si vedrà, nei confronti miei e de “Il Fatto”) è semplicemente vergognosa e rappresenta un insulto al giornalismo. Ma tu l’hai ripresa come se si trattasse di un personalissimo affare e non di un contratto con la Rai che porta la firma del tuo amministratore delegato, all’epoca anche amministratore della Zerostudio’s, e che riguarda non me come persona ma una società di cui il tuo giornale è socio al 48 percento. Ho sempre pensato che tu sia un giornalista vero e non uno Tze-Tze allenato a far girare la merda col ventilatore; perciò mi dedicherò all’impresa, temo inutile, di fornirti elementi seri per un giudizio. Prima di tutto occorre dire che la somma ormai famosa dei due milioni e settecentomila euro non è stata intascata ancora per intero da nessuno, come invece hai lasciato intendere nel tuo sito. Il pagamento avviene, infatti, a distanza di mesi dalla messa in onda, e la società deve anticipare tutti i pagamenti per il personale, le diarie e i servizi impiegati. Si riferisce a sei dirette di prima serata, a sei puntate di un reportage di Giulia Innocenzi e ad una serie di Sciuscià da rieditare, che comportano ulteriori turni di montaggio, mie presentazioni in studio, sonorizzazioni e missaggi. Tutto ciò è distribuito in un arco temporale molto vasto. Le puntate delle dirette sono molto distanti fra loro e dunque comportano costi raddoppiati, perché occorre ogni volta montare e smontare scenografie e luci. Anche i contratti dei redattori sono più lunghi di quelli che sarebbero necessari in una serie di trasmissioni programmate con cadenza settimanale. Non si tratta di un appalto ma di una fornitura “chiavi in mano”: la nostra società (e sottolineo nostra) deve provvedere a tutto ciò che è necessario alla messa in onda del programma, redazione, personale amministrativo, studio di registrazione, satelliti, regia; e siamo noi a farci carico delle spese legali che derivano dalla messa in onda dei nostri contenuti, con ulteriori costi. La Rai deve limitarsi a controllarne la qualità e ad autorizzare che si spinga un bottone per offrirli alla visione del pubblico. Posso garantirti che, prendendo come riferimento prodotti dello stesso tipo e applicando le stesse identiche valutazioni, si scoprirebbe che il costo di questi programmi è assolutamente in linea con il costo medio dei programmi simili del servizio pubblico. Usare l’espressione “compensi di Santoro” per definire questo tipo di contratto o addirittura quella di stipendio, come ha fatto la Stampa, è una corbelleria di cui un giornalista serio si dovrebbe semplicemente vergognare. La conclusione provvisoria è che non c’è nessuno scandalo; ma se uno scandalo esiste riguarda me quanto il tuo giornale, e se ci sono stati “compensi” sono stati anche per la società che edita il tuo giornale. Ma purtroppo per “Il Fatto”, per te e anche per me, nessuno di noi ha tratto guadagni dalle trasmissioni della Rai. Siamo stati così onesti da realizzare le quattro serate in perdita, e sottolineo in perdita, come chiunque potrà facilmente controllare scorrendo la nostra contabilità che, al contrario di certi spettacoli, fattura ogni cosa meticolosamente. Tempo fa ho chiesto a Grillo di mandare il suo fidato commercialista a fare un controllo. Non lo ha fatto perché è più comodo infangare senza fact checking, evitando di prendere atto di come stanno veramente le cose. I miei compensi non esistono. Da quasi due anni lavoro per tenere in piedi un gruppo che doveva servire a un progetto comune con “Il Fatto”, con regolari quanto rari contratti giornalistici. Ho accettato di fare queste trasmissioni prima di tutto per ricostruire un rapporto con la Rai, alla quale tengo molto e che continuo a considerare un bene essenziale per il Paese, ma anche perché erano compatibili con questo progetto. Ora tutti possono comprenderne il motivo. Ma di questi 2 milioni e settecentomila euro non ho preso e non prenderò per me un solo euro. Grillo non ha voluto verificare questa mia affermazione, ho chiesto al Direttore della Stampa di farlo, lo chiedo anche a te. C’è però Cinzia Monteverdi che è ancora presidente della Zerostudio’s e amministratore delegato de “Il Fatto”. Le chiederò di controllare i conti col microscopio e di pubblicare sul tuo sito un comunicato ufficiale in proposito. Anche se la inoppugnabile verità è questa: 1) Michele Santoro non ha percepito compensi né in forma diretta né in forma indiretta, né dalla Rai né da Zerostudio’s. 2) Zerostudio’s ha realizzato in perdita i programmi della Rai. Per il resto, lasciami concludere che una visione del mondo che non riconosce il valore degli altri, perfino quando le loro storie sono così intrecciate alla nostra da non poter emettere giudizi senza sentirci umanamente e moralmente coinvolti, non mi appartiene. Vedo che tu non hai paura di assomigliare a “Libero” e a “Il Giornale” che scrivono su di me quello che già scrivevano ai tempi di Berlusconi, ma se preferisci la loro compagnia alla mia dovresti almeno sentire la necessità di distinguerci separando definitivamente i nostri conti correnti. Almeno per evitare di cadere nel ridicolo. Michele Santoro".
IL PARTITO DELLE MANETTE SI SPACCA SUL BOTTINO. Giorgio Arnaboldi per "La Verità" l'11 febbraio 2017. Potremmo chiamarlo un regolamento di conti. Nel senso che il sasso che rotola dalla montagna con il compenso di Carlo Conti per condurre il festival di Sanremo ha provocato la valanga: altre rivelazioni, altri soldi a pioggia a firma Antonio Campo Dall' Orto e polemiche che con si fermano più alla sola Rai. Non è facile metabolizzare neppure i 2,7 milioni iscritti a bilancio alla voce Michele Santoro per 12 puntate di tre programmi giornalistici. Un rientro in Rai impalpabile nella memoria del telespettatore ma pesante per le casse dell'azienda pubblica, che ha fatto saltare sulla sedia anche i cronisti del Fatto Quotidiano, il suo giornale di riferimento, i quali, per nulla intimoriti dal suo ruolo di ispiratore, padre nobile e soprattutto azionista (lui possiede il 7% dell'editoriale e Il Fatto ha il 46,4% della sua società Zerostudio' s) hanno pubblicato la notizia sul sito. Per un sincero democratico rispettoso del ruolo della libera informazione come Santoro (in teoria), tutto ciò dovrebbe essere normale. Invece per un abile cesellatore di coscienze come Santoro (in pratica), tutto ciò normale non è. Infatti si è indignato per lesa maestà. Lo immaginiamo mentre si stupiva («Come osano?»), compreso nella parte come Eleonora Duse aggrappata alle tende, e si apprestava a scrivere l'estenuante post su Face book con il quale ha provato a inchiodare il direttore del sito del Fatto, Peter Gomez, alle sue responsabilità. Così si è scatenata una battaglia tutta interna alla sinistra legalitaria del giornalismo italiano, per una volta non tenuta insieme dal collante Berlusconi o dal bostik Renzi, ma libera di prendersi a schiaffi e specchio della sinistra italiana in politica, dove bastano tre per fare una scissione. Con una lecita forzatura da titolo potremmo dire che il partito delle manette litiga sui soldi. Sulla sua pagina dal nome Servizio pubblico, Santoro è andato giù pesante. «Nella top ten delle frasi celebri penso che resti al primo posto quella di Stefano Ricucci, che bollava quelli che amano "fare i froci col culo degli altri". Mi sembra che tu ora (si riferisce a Gomez, ndr) ne abbia varato una versione più casta: "Fare i moralisti col culo degli altri". L' operazione della Stampa (il giornale che per primo aveva rivelato i compensi Rai, ndr) nei miei confronti (ma sarebbe più corretto dire nei confronti miei e de Il Fatto) è semplicemente vergognosa e rappresenta un insulto al giornalismo. Ma tu l'hai ripresa come se si trattasse di un personalissimo affare e non di un contratto con la Rai che porta la firma del tuo amministratore delegato, all' epoca anche amministratore della Zerostudio' s, e che riguarda non me come persona ma una società di cui il tuo giornale è socio al 48%». Si intuisce un Santoro furibondo, del tutto sorpreso da quella che per il mondo è una notizia e per lui una pugnalata. Il che dimostra quanto sia facile fare i moralisti con i privilegi degli altri (anche questo ha qualcosa a che vedere con il filosofo situazionista Ricucci). Un Santoro che nel prosieguo del post spiega che i 2,7 milioni non li ha ancora incassati per intero, li ha dovuti anticipare a un nutrito staff per un lavoro in un arco temporale molto ampio, riguardano programmi «chiavi in mano» che hanno un costo in linea con altri simili. Quindi niente scandalo. Ma Michele è troppo arrabbiato per tirare il freno, così va lungo. «Se uno scandalo esiste riguarda me quanto il tuo giornale, e se ci sono stati "compensi" sono stati anche per la società che edita il tuo giornale. Ma purtroppo per Il Fatto, per te e anche per me, nessuno di noi ha tratto guadagni dalle trasmissioni della Rai. Siamo stati così onesti da realizzare le quattro serate in perdita, e sottolineo in perdita, come chiunque potrà facilmente controllare scorrendo la nostra contabilità che, al contrario di certi spettacoli, fattura ogni cosa meticolosamente». Travolto dalla disperazione, Michele Santoro fa sapere che la Rai non lo ha pagato, che i programmi erano in perdita e che 2,7 milioni di euro sono comunque evaporati dalle casse. Bel servizio pubblico. La risposta di Peter Gomez è fredda e lapidaria. «Caro Michele, in uno dei tanti turni della mattinata abbiamo ripreso le notizie sui compensi Rai. Nel tuo caso specificando non con sufficiente chiarezza che si trattava del compenso per Zerostudio (comunque citato). Appena ce ne siamo resi conto ci siamo doverosamente corretti. Sarebbe bastato un tuo sms per informarmi». Come dire che si può sbagliare in buona fede e che non è necessario suonare le trombe di Gerico al primo sussurro. Dopo una vita trascorsa col ditino alzato, Michele Santoro ha scoperto che c' è qualcuno più puro di lui. È il destino di chi sta sempre seduto dalla parte della ragione e non riesce a entrare in nulla tranne che nei propri comodi panni. Il rapporto fra lui e la squadra del Fatto Quotidiano vive un momento delicato, perché la polemica sul compenso va a sommarsi al diverbio sul referendum costituzionale. Santoro, sponsor di Renzi, non ebbe remore nel criticare Travaglio (paladino del No) tacciandolo di deriva grillina. «Trovo imbarazzante che tutto il Fatto Quotidiano, fin dentro ai necrologi, sia schierato per il No. È ridicolo. Trovo imbarazzante possedere delle quote di un giornale senza sfumature, che non ha dubbi». Mentre loro litigano, Berlusconi spolvera ridendo tutte le sedie della villa di Arcore.
STORIA DELL’AMNISTIA.
Storia dell’amnistia da Togliatti ai giorni di Tangentopoli, scrive Massimo Lensi il 14 Aprile 2017 su "Il Dubbio". La chiedevano i Papi, ci aiutò a uscire dal fascismo, Marco Pannella ne ha fatto per anni il suo campo di battaglia, ma dopo Mani Pulite è scomparsa dall’orizzonte politico e culturale italiano. A Pasqua si terrà a Roma la Quinta marcia per l’Amnistia, organizzata dal Partito Radicale. Marco Pannella coniò un’efficace espressione per spiegare l’importanza della clemenza. Egli la invocava per la Repubblica, per rientrare nella legalità e porre fine alle violazioni della Costituzione nella gestione del sistema penitenziario, nella durata dei processi, nell’utilizzo della prescrizione nascosta conseguente all’applicazione discrezionale dell’obbligatorietà dell’azione penale da parte dei magistrati. “Amnistia per la Repubblica” era lo slogan di Pannella. La storia dei provvedimenti di clemenza di un Paese racconta, infatti, più cose di quanto si possa immaginare. L’amnistia e l’indulto – a volte anche il provvedimento di grazia – sono atti politici a tutto tondo. La clemenza porta sempre con sé un’attenzione particolare ai rapporti tra Stato e magistratura, tra esecuzione della pena e reinserimento sociale, tra eventi di particolare rilievo e opinione pubblica, ed è accompagnata sempre da una tendenza a un particolare intento di riscrittura della storia, riscontrabile nei dispositivi legislativi: accertare la verità, farla dimenticare o renderla del tutto illeggibile. Stéphane Gacon nel suo libro “L’Amnistie” (2002) classificava la clemenza di Stato in tre tipologie differenti: l’amnistia perdono, atto di generosità tipico dei regimi totalitari; l’amnistia- rifondazione, che interviene per riunificare un Paese diviso; l’amnistia- riconciliazione che segue la fine dei regimi dittatoriali. L’Italia repubblicana ha concesso una trentina di provvedimenti di clemenza, tra amnistie e indulti. L’ultima amnistia è del 1990, mentre nel 2006 fu approvato l’ultimo indulto. Terminate le drammatiche vicende politiche e militari che portarono alla caduta del regime fascista, lo strumento dell’amnistia fu utilizzato tra il 1944 e il 1948 per vanificare la vigenza della normativa penale del regime, il codice Rocco, nei confronti dei delitti politici commessi durante la Resistenza, o nel periodo successivo. E’ interessante notare come, all’epoca, il tentativo del legislatore fu di chiudere con il periodo dittatoriale e la sua legislazione penale, al fine di far nascere lo stato “nuovo” e far sì che questo trovasse in sé la propria legittimità giuridica e non nelle leggi dello Stato precedente. Un tentativo che, però, rimase tale. Per Piero Calamandrei, infatti, mancò sul terreno giuridico della forma “lo stabile riconoscimento della nuova legalità uscita dalla Rivoluzione”. Ed è altrettanto vero che i provvedimenti di amnistia di quel periodo ebbero in comune una natura delegittimante nei confronti della Resistenza, in quanto le azioni commesse durante la lotta antifascista vennero considerate alla stregua di reati comuni, anche se motivati da eccezionali contingenze. Si restava a tutti gli effetti all’interno del recinto dell’art. 8 del codice penale, che definisce come delitto politico: “ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici”. Il decreto presidenziale n. 4/ 1946, conosciuto con il nome di “amnistia Togliatti”, all’epoca guardasigilli della Repubblica, tentò di consegnare all’oblio non solo i reati connessi all’attività partigiana, ma anche i reati legati alla collaborazione con l’esercito tedesco di occupazione, pur con numerose eccezioni e sollevando numerose polemiche. L’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde (cioè Togliatti) scommise sul futuro per mettere fine a un possibile ciclo di rese dei conti, ma fu accusato, in nome della sua proverbiale “doppiezza”, di aver aperto le porte del carcere ai fascisti e ai repubblichini imprigionati subito dopo la Liberazione. Sta di fatto che, forse anche a causa di un’interpretazione distorta del testo del decreto (scritto, invero, con un linguaggio giuridico assai poco limpido), tra i 7061 amnistiati, 153 erano partigiani, e 6.908 fascisti. Negli anni ’ 50 e ’ 60 i provvedimenti di clemenza furono nove, di cui cinque strettamente connessi sia a fatti politici legati alla scia lunga del dopo- guerra, sia ai movimenti della fine degli anni ’60, con l’attribuzione di reati commessi in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali (amnistia del ’ 68). Tutti e cinque questi provvedimenti comportarono la concessione sia di amnistia, sia di indulto. Il primo fu nel 1953 (7.833 amnistiati) e l’ultimo nel 1970 (11.961 amnistiati); gli altri furono concessi nel 1959 (7.084 amnistiati), nel 1966 (11.982 amnistiati) e nel 1968 (315 amnistiati). Dopo il 1970 non ci furono più amnistie per fatti politici. L’amnistia del ’ 68 fu particolarmente importante perché ebbe come oggetto esclusivamente reati politici e sociali. Il senatore Tristano Codignola del Partito Socialista nel presentare il provvedimento al Senato disse: “Appare quindi evidente che, nell’interesse stesso della democrazia, nell’accezione aperta e progressiva voluta dalla nostra Costituzione, occorre procedere di pari passo alla realizzazione di profonde riforme strutturali e alla creazione di un clima maggiormente democratico ed antiautoritario nel Paese”. Con l’amnistia del ’ 68, si chiuse finalmente il ciclo legato alla guerra di Liberazione, si aprì però il capitolo che precedette gli anni di piombo. E per la prima volta nel 1970 fecero capolino nell’amnistia il riferimento ai reati in materia tributaria e nell’indulto il riferimento a reati in materia di dogane, di imposta di fabbricazione e di monopolio. La giovane Italia del primo dopo- guerra diventava maggiorenne e i reati comuni, al posto di quelli politici, iniziarono a catturare sempre più l’attenzione del legislatore: un’attenzione che, come vedremo, costerà cara. Nel 1982 e 1983 furono approvati due provvedimenti di sola amnistia ed esclusivamente per reati finanziari. Il clima iniziò a farsi pesante e il parlamento venne accusato di difendere corrotti e concussi tanto che, dopo qualche anno, il 6 marzo del 1992, il Parlamento operò una revisione costituzionale modificando profondamente la ratio dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto. Nel testo voluto dai Padri Costituenti amnistia e indulto erano concessi dal Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione da parte delle Camere, approvata a maggioranza semplice. La modifica introdotta nel 1992 fece sì che questi provvedimenti di clemenza potessero essere concessi solo con una legge deliberata in ogni articolo e nella votazione finale dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. L’innalzamento del quorum necessario all’approvazione del provvedimento fu deciso sull’onda dell’emotività suscitata nella piazza dallo scandalo di “Mani Pulite” per evitare il ripetersi di amnistie “concesse a cuor leggero”. Erano i tempi del lancio delle monetine davanti all’Hotel Raphael e la piazza esigeva una svolta nel rispetto della penalità. Fu in quel periodo che prese il via una prima trasformazione dei modelli istituzionali che lentamente portò al trasferimento dei sistemi di controllo sociale dalle forme di protezione a quelle della punizione. La grande crisi economica degli anni successivi portò a compimento questa operazione di trasformazione. L’insicurezza sociale che ne è scaturita si è, infatti, rivolta al sistema penale, nella forma dell’esercizio delle funzioni repressive. Il numero dei reati inseriti del codice penale ha continuato a crescere insieme alla domanda di penalità, portando in pochi anni a raddoppiare il numero di detenuti delle carceri italiane: dai 30mila degli anni Novanta ai quasi 60mila dei nostri giorni. Il mutamento delle relazioni sociali e di potere e il tramonto di un certo tipo di welfare hanno condannato qualsiasi progetto di amnistia in fondo al cassetto delle priorità. Le carceri italiane hanno così cominciato a conoscere il sistematico sovraffollamento e i trattamenti inumani e degradanti riservati alla popolazione detenuta. A ben vedere, quindi, la richiesta di amnistia (e indulto) sostenuta con forza dal Partito Radicale non è per un provvedimento clemenza. Quella che si chiede non è la amnistia- amnesia; è, invece, la richiesta di una amnistia politica per porre fine al sovraffollamento cronico e inumano delle nostre carceri e alla intollerabile lentezza dei processi, che hanno fatto meritare allo stato italiano plurime condanne dalle Corti europee. In altre parole, un’amnistia per porre le radici di una Giustizia (più) Giusta.
I TRADITORI, OSSIA I FRANCHI TIRATORI.
Camera, l'errore del tabellone che mostra i franchi tiratori: chi può esserci dietro e perché, scrive l'8 Giugno 2017 "Libero Quotidiano". Un problema tecnico. Pochi secondi. Un bagliore. Il tabellone alla Camera mostra i "franchi tiratori" che affondano la riforma elettorale - del M5s e di Forza Italia su tutti -: crolla l'intesa e si scatena il finimondo. Già, quel voto era segreto e nella storia della nostra Repubblica non era mai accaduto che un voto segreto venisse palesato dal tabellone. Pochi istanti, come detto, che però sono come una rivelazione. Soprattutto perché Emanuele Fiano ha il tempo di fotografare quel tabellone pieno di puntini rossi e verdi - soprattutto rossi - e darlo in pasto al web. Tutto svelato. Altro che segreto. Ma chi c'è dietro questo errore così sospetto? Già, sospetto. In primis perché senza precedenti. E poi anche perché è andato a colpire proprio i grillini, la forza parlamentare "meno parlamentare" - ci si passi il termine - di tutte le altre (poi, sul fatto che il "colpo" rovini la loro immagine è tutto da discutere. Anzi, forse il contrario: si sono mostrati sì truffaldini, ma duri e puri). Comunque sia, per ritornare al dubbio: chi c'è dietro? Impossibile dare una risposta certe. Ci sono però alcuni che puntano il dito. Chi contro Laura Boldrini, che ha immediatamente sottolineato: "C'è stato un problema tecnico, avevo già detto che era un voto segreto. Colleghi c'è stato un disguido". Alcuni parlamentari, però, hanno accusato la presidente della Camera di non aver avvisato per tempo che stava per scattare una votazione segreta. Altri, invece, puntano il dito contro un famigerato "commesso" che avrebbe azionato il tabellone. Per certo, ad azionarlo è stato uno dei funzionari di Montecitorio. Ad ora, non è chiaro di chi si tratti. Se si sapesse il nome, forse, qualcosa in più su questa vicenda potrebbe essere scritto, quantomeno si potrebbe ragionare sul dubbio: solo un errore o c'è del dolo? Nel frattempo, le polemiche - complottiste - infuriano. Si pensi a Roberto Fico del M5s, il quale dichiara sibillino: "Il tabellone? Devo dire per forza che è stato un errore tecnico, che altro potrebbe essere? I retroscena li fanno i giornali...". Parole pronunciate in Transatlantico con cui dice chiaro e tondo che alla vicenda del problema tecnico non crede fino in fondo. Ma la protesta è trasversale: anche Massimo Corsaro di Cor e Maurizio Lupi di Ap hanno manifestato tutto il loro disappunto. E oltre alle proteste, i guai. Quelli in cui potrebbe finire Emanuele Fiano, il piddino che il tabellone lo ha pubblicato. "Lo sa l'onorevole Fiano che la pubblicazione del tabellone con l'andamento del voto segreto è reato?", gli chiede retorico Edmondo Cirelli di Fratelli d'Italia. Dunque, sottolinea che "l'articolo 683 del codice penale è chiaro". Quindi ricorda il testo della legge: "Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 51 a 258 euro".
L'autogol dei falsi trasparenti. È la nemesi grillina. Gli alfieri del voto palese, grazie a un imprevisto voto palese, si sono palesati per quello che sono realmente: dei parolai, scrive Francesco Maria Del Vigo, Venerdì 9/06/2017 su "Il Giornale". È la nemesi grillina. Gli alfieri del voto palese, grazie a un imprevisto voto palese, si sono palesati per quello che sono realmente: dei parolai. Dopo avere ossessionato per anni il dibattito politico con il vaccino della trasparenza (unico vaccino che loro, antiscientisti di professione, vorrebbero somministrare) finiscono sputtanati da se stessi. E si è capito che per loro la trasparenza è una cosa spontanea come un selfie di Chiara Ferragni: studiano per ore la posa che li renda il più naturali possibile. Ma appena qualcosa va storto e li prendi alla sprovvista, cambia tutto. E così è stato ieri alla Camera, quando un errore di Laura Boldrini, ha messo alla berlina i deputati pentastellati (e non solo). Caduto il sipario del voto segreto, sul tabellone che troneggia nell'emiciclo, è andata in scena la solita farsa. Protetti dall'anonimato i parlamentari grillini fanno quello che gli pare, anche il contrario di quello che dicono. Cioè votare l'opposto di quello che si era assicurato in Commissione. Non appena le pareti della «casa di vetro» del Movimento si appannano si comportano come tutti gli altri. Pure peggio. Perché, farsa nella farsa, erano stati ampiamente istruiti via whatsapp su come comportarsi per apparire integerrimi. Roba da attori consumati: riprendersi con il telefonino durante l'operazione e non lasciare dubbi su eventuali trucchetti da prestigiatore della prima Repubblica votando con un solo dito. Probabilmente il dito era il medio...Ma quello che sembra un banale scivolone parlamentare su un emendamento marginale, è in realtà una crepa che permette di sbirciare oltre l'artefatta maschera pentastellata. E c'è una galassia di contraddizioni. L'ipocrisia di chi nel nome di un'iper-legalità compie un atto illegale: filmare le operazioni di voto è vietato dai regolamenti parlamentari. Filmarle non per testimoniare i fatti, ma per contraffarli, non è ancora vietato. Ma è da impostori. E poi l'opacità delle manovre politiche, dei voti on line su Rousseau. E ancora: l'inaffidabilità di una parola data in pubblico e poi smentita nel segreto dell'urna. Perché mezzo partito non risponde più a Grillo e i papaveri del Movimento vogliono tenere le terga attaccate alla poltrona e non finire nella sciocca tagliola che, ancora una volta, si sono autoimposti: quel limite dei due mandati che lascerebbe molti di loro, sulla soglia dei quarant'anni, con un luminoso passato in politica. Ma questa volta è andato tutto storto: i «franchi tiratori» grillini si sono sparati in un piede, per tenere l'altro in Parlamento. Ps: Una piccola nota a margine sulla coerenza delle vergini a 5 stelle: il 13 settembre del 2013, al fine di debellare la piaga dei franchi tiratori, di chi dice una cosa e poi ne fa un'altra, depositarono un'iniziativa a Palazzo Madama «per abolire il voto segreto e prevedere la votazione nominale e palese per ogni tipo di votazione». Altri tempi. Ma soprattutto altre motivazioni: in quel caso il voto riguardava la decadenza di Silvio Berlusconi...
Ecco chi sono e perché si chiamano franchi tiratori, scrive l'8/06/2017 "L'Adnkronos". Legge elettorale in bilico dopo il voto di ieri alla Camera. Un gruppo di 'franchi tiratori' ha infatti minacciato l'iter del nuovo testo. Ma chi sono i 'franchi tiratori' e perché si chiamano così? Nelle aule del Parlamento italiano non è certamente la prima volta che compaiono, basti pensare alla corsa al Quirinale di Romano Prodi nel 2013, affossata da più di 100 'franchi tiratori' appartenenti al suo stesso partito, il Pd. Sull'enciclopedia Treccani si legge che il termine è attestato nella nostra lingua già dal 1870 ed ha un'origine militare. L' etimologia ci porta nella Francia del 1870, quando i giornali francesi utilizzavano il termine “franc-tireur” per indicare i combattenti della guerra franco-prussiana. Ricomparve poi nella seconda guerra mondiale per indicare i cecchini. Il passaggio dal significato militare a quello politico avvenne a partire dagli anni Cinquanta. 'Franco tiratore' indica oggi il deputato che vota in modo diverso da quanto concordato, disattendendo l'ordine del partito cui appartiene e approfittando del voto a scrutinio segreto. In un certo senso, quindi, il termine conserva l'accezione di cecchino che colpisce in modo imprevisto e occulto.
Franchi tiratori, quando la vittima fu Prodi, scrive l'8/06/2017 "L'Adnkronos". Tutti li temono. I franchi tiratori restano nascosti e colpiscono all’improvviso, pronti ad affossare non solo le leggi - come nel caso del mancato patto sulla legge elettorale di oggi - ma anche gli uomini che provano a salire al Quirinale senza essere graditi ai cecchini del Parlamento. Esattamente quanto accadde a Romani Prodi nel 2013. Il suo affossamento fu uno dei casi più eclatanti e quando si parla di franchi tiratori, la mente va automaticamente a quei 101 cecchini che gli impedirono di diventare capo dello Stato. Era l'aprile del 2013 quando Prodi fu tradito dai suoi stessi compagni di partito - il Pd - che fermarono clamorosamente la sua corsa al Colle. Sulla carta il professore disponeva di 496 voti del centrosinistra, ma alla fine si fermò a quota 395. E pensare che la proposta di candidare Prodi, lanciata dal segretario Pier Luigi Bersani, era stata accolta dai grandi elettori Pd addirittura con una standing ovation. Il giorno prima si era consumato il flop di Franco Marini, candidato al Quirinale dell’accordo tra Bersani e Berlusconi. Alla fine dei giochi, ad essere eletto Presidente della Repubblica, fu nuovamente Giorgio Napolitano cui fu chiesto, vista la difficile situazione politica nazionale, di dare la disponibilità per un secondo mandato (Napolitano era già stato eletto nel 2006). Il ricordo di quell'aprile brucia ancora, soprattutto nella memoria dei protagonisti del clamoroso 'tradimento' e l'immagine di quei 'cecchini' che, nascosti, 'sparano' all'improvviso è tutt'ora vivissima.
La mira dei franchi tiratori, ecco le vittime eccellenti. Le gesta dei guastatori delle Camere vanno avanti da decenni nel nostro Paese Dal fuoco amico su Cossiga ai 101 contro Prodi. L’uso spregiudicato fatto dalla Dcdi Vittorio Emiliani, scrive il 9 giugno 2017 “La Nuova Ferrara”. La legge elettorale proporzionale alla tedesca, o meglio all’italiana, voluta da Renzi, Berlusconi, Salvini e Grillo, uno strano quartetto, è stata affossata alla Camera dai “franchi tiratori” e dalla minoranza di sinistra. Chi siano i deputati che nel segreto dell’urna hanno crivellato il tanto discusso (e ormai esecrato come e più del Porcellum, anche da molti commentatori) disegno di legge non lo sapremo mai con esattezza. Come non conosciamo i 101 parlamentari che affossarono nell’urna la elezione di Romano Prodi al Quirinale, voluta da Pier Luigi Bersani e sgradita anche a più di un esponente del Partito democratico. È stato l’episodio più clamoroso, fra quelli recenti, dell’azione distruttiva dei “franchi tiratori”. Termine militare, mutuato dai Francs-Tireurs francesi che costituivano nel 1870 l’ossatura dell’Armata dei Vosgi posta sotto la guida di Garibaldi, il solo a vincere contro i trionfatori prussiani. Dall’Armée al Parlamento il termine è passato indicando quanti, profittando del voto segreto, votavano contro le indicazioni del proprio gruppo o partito. Nel Regno di Sardegna lo Statuto Albertino (1848) prevedeva l’obbligatorietà del voto segreto che venne mantenuta anche dopo l’Unità a garanzia dell’autonomia dei parlamentari. Lo abolì ovviamente il fascismo anche se alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni voti contro il regime erano impensabili. L’Assemblea Costituente si rifece a un sistema prevalente di voti segreti rimettendone la disciplina alle singole Camere. Il relatore Aldo Moro si oppose «a consacrare costituzionalmente il voto segreto che ha già dato luogo a tanti inconvenienti». E gli “inconvenienti” li diedero soprattutto i democristiani che col voto segreto impallinarono più e più volte loro esponenti di punta unendosi ai voti delle sinistre e facendo cadere governi o candidature al Quirinale. Ad esempio quelle dei candidati Dc Merzagora, Fanfani o Forlani. Il massimo uso del voto segreto quale arma politica lo si raggiunse tuttavia all’Assemblea Regionale Siciliana fra Dc ed ex Dc. A Roma fu clamorosa la seconda consecutiva votazione negativa dei compagni di partito riservata a Francesco Cossiga e al suo governo nel settembre del 1980. Sembrò che ne avessero stroncato la carriera. Non fu così. Cossiga doveva tornare in auge ed essere eletto trionfalmente alla presidenza della Repubblica nel 1985. Dalla quale si dimise sette anni più tardi dopo aver “picconato” il sistema. Nel 1988 si giunse a regolamenti parlamentari restrittivi per l’area vasta del voto segreto. Bettino Craxi volle porre fine alle intese sotterranee fra il Pci e una parte della Democrazia cristiana che si giovavano del segreto dell’urna e sostenne con forza la necessità di tornare su molte materie al voto palese. Lo fece alla Camera ricordando come nella Repubblica Veneta del 1848-49 il socialista Sartori fosse per il voto a viso aperto e il cattolico Tommaseo invece per il voto segreto. E agitò polemicamente un garofano rosso verso i banchi del Pci. Il voto palese è oggi obbligatorio sulla legge di stabilità, sulle leggi di bilancio, su tutti i provvedimenti finanziari. Il voto segreto, non su queste materie, può essere richiesto da 30 deputati e da uno o più presidenti di gruppi, per esempio quando siano in gioco i diritti civili, i diritti di libertà, il diritto di famiglia, di difesa, di giustizia, l’educazione dei figli, la protezione della maternità, ecc. Nel caso di questa legge elettorale così frettolosamente portata al voto, i parlamentari dissidenti hanno manifestato – come spesso è accaduto in passato – anche la loro profonda insofferenza per decisioni calate dall’alto sulle loro teste e per l’abitudine dei governi di usare le Camere (e meno male che è rimasta la seconda lettura) come luoghi di convalida del decreti blindati col voto di fiducia. La legge elettorale era comunque così brutta che, una volta tanto, bisogna ringraziare i “franchi tiratori”.
Riecco i franchi tiratori, in guerra da 60 anni, scrive l'8 giugno 2017 "l'Ansa". I partiti nascono, muoiono, si trasformano, immersi nel “panta rei” della politica. Ma loro sono sempre lì, una falange nascosta che colpisce a tradimento, e fa cadere leggi, governi, candidati eccellenti. La prima repubblica è passata, la seconda è lì lì per farlo, e i franchi tiratori – immortali come in un film horror – si sono di nuovo organizzati per decidere come dovrà essere la terza. Devono il nome ai guerriglieri francesi che nel 1870 tendevano imboscate agli invasori prussiani. Ma a differenza dei patrioti transalpini, colpiscono solo all’interno delle proprie linee, intralciando le manovre degli eserciti e le carriere dei comandanti. Gli ultimi 60 anni di storia della repubblica sono attraversati dalle loro scorribande. Protetti da un anonimato imperscrutabile, si muovono in Parlamento come gli adepti della setta dei Beati Paoli: non si sa chi siano i loro capi (di solito leader politici di primissimo piano che però stanno ben attenti a non lasciare tracce), non si sa dove si incontrino, i loro colpi lasciano sempre il nemico tramortito e umiliato. Il voto segreto è il paravento dietro il quale si nascondono e grazie al quale possono portare a segno le loro trame. Alla Camera attaccarono per la prima volta nel 1958, quando colpirono e affondarono il governo presieduto da Amintore Fanfani: la guerriglia era animata da un gruppo di deputati della Dc che non sopportavano la somma di cariche riunite nelle mani del politico aretino (Fanfani, 60 anni fa, era presidente del consiglio, segretario del partito e ministro degli Esteri). I franchi tiratori sono stati per decenni l’arma segreta manovrata dai capi corrente della Dc. Anche Aldo Moro non si fece scrupolo a utilizzarli, quando nel 1964 riuscì a bloccare la corsa di Giovanni Leone al Quirinale. Sulle scale di Palazzo Chigi, Moro suggerì a Carlo Donat Cattin di organizzare l’imboscata contro Leone utilizzando i “mezzi tecnici” a disposizione. “Quali mezzi tecnici?” gli chiese un collaboratore di Donat Cattin. “I mezzi tecnici sono solo tre: il pugnale, il veleno e i franchi tiratori”, rispose Moro con un lieve sorriso. Fanfani, negli anni d’oro della prima repubblica, fu il loro bersaglio preferito. Ma i congiurati delle Camere misero all’angolo anche Bettino Craxi, costretto a dimettersi da presidente del consiglio nel 1986. E chi altri se non le misteriose truppe del voto segreto impedirono a Arnaldo Forlani nel 1992 di diventare presidente della Repubblica? In quell’occasione i sospetti si concentrarono su Giulio Andreotti, che si era visto stoppare la sua candidatura al Quirinale proprio dallo stesso Forlani. Dopo la tempesta di Mani Pulite e l’approdo al sistema maggioritario, gli anonimi pugnalatori si sono tenuti a lungo fuori dalla mischia, e mano a mano il ricordo delle loro gesta ha cominciato a sbiadire. Ma il franco tiratore vive nascosto all’interno di ogni parlamentare, una seconda natura pronta a manifestarsi quando è necessario. Se la seconda repubblica li ha visti meno protagonisti è solo perché con la riforma dei regolamenti i voti segreti sono diventate più rari. Ma quando l’occasione è propizia, ecco che i guastatori tornano in superficie. La Dc non c’è più, ed è il Pd il partito dentro il quale si sono in maggioranza trasferiti. Ne sa qualcosa Romano Prodi, trafitto dai 101 che la sera del 19 aprile 2013 gli voltarono le spalle nelle votazioni per la scelta del nuovo capo dello Stato. Ne sa qualcosa anche Franco Marini, che di pugnalate, il giorno prima di Prodi, ne aveva ricevute ben 224. Due anni fa l’ultimo attacco di rilievo. Anche allora, come oggi, sul campo c’era una legge elettorale: in 90 (tutti anti renziani più o meno dichiarati) tentarono di sabotare l’Italicum votando contro le indicazioni della maggioranza sulla reintroduzione delle preferenze. Fu un insuccesso: i novanta non bastarono a mettere in crisi la legge voluta da Renzi. Una delle rare volte in cui i franchi tiratori hanno fatto cilecca. Ma con il voto di oggi la loro terribile reputazione è stata di nuovo riscattata. Marco Dell’Omo, ANSA.
Dal ’48 ai «101» di Prodi. Anatomia del franco tiratore che si esalta affossando. I franchi tiratori erano l’incubo della Prima Repubblica. O meglio, erano l’incubo di chi ne subiva il cecchinaggio, ma era un grande sfogo per chi nel segreto dell’urna destabilizzava, distruggeva, manovrava, scrive Pierluigi Battista l'8 giugno 2017 su "Il Corriere della Sera". Il trionfo del franco tiratore è quando sente che ci sono tanti franchi tiratori insieme a lui: un cecchino, alla fine muore, ma tanti cecchini determinano le sorti di una battaglia. Senza appalesarsi, galvanizzandosi nel segreto, nella manovra nascosta, nelle trame invisibili. Che poi, quando vanno a segno, come è accaduto ieri con la legge elettorale, sono il massimo della soddisfazione: l’immensa goduria del franco tiratore. La goduria di quell’anonimo poeta che in rima vergò la sua scheda demolitrice contro Amintore Fanfani candidato al Quirinale nel 1971: «Nano maledetto, non sarai mai eletto». E non fu eletto. Uno dei tanti candidati democristiani alla Presidenza della Repubblica caduti sotto i colpi micidiali dei franchi tiratori che nelle elezioni a scrutinio segreto si esaltano, si insinuano nel gioco delle correnti con una raffinatezza programmatica che soltanto i più esperti giocatori di biliardo sanno decifrare. Esiste tutta una letteratura sul trionfo del franco tiratore che fa perdere il Quirinale al presunto predestinato. C’è l’elezione del primo presidente della Repubblica che Alcide De Gasperi avrebbe voluto che fosse Carlos Sforza, che però era considerato un massone e un libertino dall’austera sinistra dossettiana e finì straziato dai cecchini: e arrivò Luigi Einaudi. Poi fu il turno dell’impallinamento via franco tiratore di Giovanni Leone nel ’64, che però si rifece nel ’71 battendo il favorito Fanfani, che ci rimase assai male. Poi i fasti e le tragedie del 1992 quando bisognava votare il sostituto di Francesco Cossiga in un clima intossicato tra Tangentopoli che stava inabissando il sistema della Prima Repubblica e l’offensiva stragista della mafia. Per Arnaldo Forlani, massacrato dai franchi tiratori, fu un’agonia politica. Il nome di Giulio Andreotti aleggiava come un falchetto sull’aula dove erano riuniti i grande elettori per il Quirinale ma la strage di Capaci sconvolse tutti i giochi e alla fine il nome prescelto fu quello di Oscar Luigi Scalfaro, malgrado gli sforzi di Giovanni Spadolini.
I franchi tiratori erano l’incubo della Prima Repubblica. O meglio, erano l’incubo di chi ne subiva il cecchinaggio, ma era un grande sfogo per chi nel segreto dell’urna destabilizzava, distruggeva, manovrava, disintegrava sogni e ambizioni. Ma non è che nella Seconda, di Repubblica, i franchi tiratori non abbiano avuto i loro momenti di gloria. Per esempio, nel 2008 quando bisognava eleggere il presidente del Senato dopo la risicatissima ma proprio risicatissima vittoria del centrosinistra di Prodi, sul nome di Franco Marini (per lui non sarà l’ultima volta nel mirino del franco tiratore) si accese una battaglia molto complicata per cui i seguaci di Clemente Mastella nel segreto dell’urna, sotto il catafalco in cui i senatori dovevano apporre il loro voto, decisero di scrivere sulla scheda «Marini Francesco» che era un modo bizantino per annullare e mandare un segnale a chi di dovere. Poi i «Marini Francesco» divennero «Marini Franco» e la manovra del franco tiratore ebbe fine e soddisfazione. Poi venne il giorno, nell’aprile del ’93, del respingimento segreto dell’autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi, e la sera stessa il popolo dei forcaioli si radunò sotto l’albergo Raphael, quartier generale socialista, per colpire con le monetine chi era stato salvato dal Parlamento. Proprio quel Craxi che aveva combattuto epiche battaglie per riformare i regolamenti parlamentari e ridurre le occasioni del voto segreto, anticamera di accordi consociativi inconfessabili con il Pci. Da allora, da quello scrutinio pro-Craxi, e senza quelle fastidiose lucette verdi e rosse che dicono troppo su chi vota per cosa, i voti per le autorizzazioni all’arresto di parlamentari sono rimasti le occasioni più ghiotte per gli accordi e le manovre invisibili. Ma poco prima, nel primo atto ufficiale del neonato Pds nato sulle ceneri del Pci, alla fine del gennaio 1991 a Rimini il voto segreto dei franchi tiratori colpì con durezza Achille Occhetto che non fu eletto subito segretario del partito. Per poi arrivare, nel 2013, alla grande sagra del franco tiratore che riunito in un esercito di 101 cecchini del Pd, sbarrò la strada del Quirinale a Romano Prodi, dopo aver anche seppellito nei giorni precedenti le ambizioni presidenziali di Franco (con Francesco) Marini. Il franco tiratore si acquatta, scompare ma mai del tutto. Nel segreto dell’urna, del resto, nessuno può vedere. Solo il capocorrente sì.
LE FAKE NEWS DEL CONTRO-REGIME.
Fake news, il veleno che piegò Mia Martini, scrive Domenica 14 maggio 2017 Aldo Grasso su "Il Corriere della Sera". Ventidue anni fa, di questi giorni, moriva la cantante Mia Martini. Una morte misteriosa, al culmine di una vita privata e di un percorso artistico segnati dalla maldicenza: dicevano portasse iella, non volevano mai pronunciare il suo nome. Proviamo a leggere questa vergognosa storia con gli occhi di adesso. Mia Martini è stata prima vittima di due fake news (dicevano portasse male per un tragico incidente in cui persero la vita due musicisti della sua band e per il crollo di un telone che copriva il palco su cui doveva esibirsi) e poi di bullismo. Un bullismo feroce, consapevole e adulto: quello di certi suoi colleghi, di certi impresari, di certi giornalisti. Mia è vissuta per anni nella post verità, nel regno delle bufale e delle cattiverie. E non c’erano nemmeno gli algoritmi dei social media a rilanciarle. Di fake news e bullismo si può morire, è bene saperlo. Ieri come oggi. Sono veleni iniettati per privare la vittima di ogni difesa. In ebraico c’è un’espressione forte per indicare la maldicenza, lashon hara (malalingua). È considerata una colpa gravissima, che Dio non tollera: «Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai alla morte del tuo prossimo» (Levitico 19:16). Nelle nostre società laiche e illuminate, il reato ha sostituito il peccato. Ma il rito tribale e persecutorio della maldicenza è sempre lo stesso, amplificato oggi dal «popolo del web».
Fake news, bufale e dintorni, scrive Paolo Campanelli il 17 maggio 2017. Con la scusa dell’“informazione libera e super partes perché fatta dall’uomo qualunque” che molti hanno visto in internet, la bufala ha invece raggiunto il livello opposto, diventando propaganda, il metodo più diretto di attacco costituzionale. L’amore per le bufale è un curioso concetto. Certo, c’è chi spaccia notizie con titoli dubbi o incompleti per far andare persone sui propri siti e guadagnare soldi, c’è lo Schierato Politico Estremo che s’inventa storielle inverosimili per favorire la propria posizione, ma molte, troppe false notizie vengono semplicemente buttate nella rete e lasciate a loro stesse. Prima di andare oltre, c’è da fare una chiara differenza: la bufala è differente dal giornale di satira; dove la prima è disinformazione, i secondi fanno ironia con situazioni chiaramente grottesche e impossibili, il Vernacoliere è lo storico giornale cartaceo, mentre Lercio è uno dei più famosi siti internet al riguardo. Il problema sorge quando le fonti delle bufale si fingono giornali di satira. Ma una cosa è dire che il politico “presunto corrotto” di turno ha un indice di gradimento del 215% nelle carceri, cosa impossibile già matematicamente oltre che improbabile dal punto di vista della necessità di fare rilevazioni, o prendere qualche istantanea da una fiction o un cartone animato e aggiungerci sotto una didascalia che la faccia sembrare presa da un momento critico nei libri di storia e aggiunto il colore, un’altra è incolpare il gruppo di immigrati di turno di aver fatto danni ad un palazzo storico aggiungendo la foto di qualche resto archeologico cittadino o dei veri e propri ruderi tanto comuni nel territorio italiano. Quella delle bufale recentemente soprannominate Fake News (seguendo la denominazione americana diventata famosa per via del costante usa da parte del loro Presidente, è una situazione che si autoalimenta, una persona che crede a varie bufale diventa più suscettibile ad altre, creando un loop di cecità dalla quale il credulone non si riesce a liberare, al grido di “metti tutto in discussione”. Tralasciando però la seconda parte “e analizza i risultati metodicamente per non farti ingannare nuovamente”. Il caso più eclatante degli ultimi tempi è stata quello di “Luciana” Boldrini: sorella di Laura, presidente della Camera dei Deputati, accusata di aver speso, solo nell’ultimo anno, ingenti somme pubbliche nell’accoglienza di immigrati oltre a ciò già fatto dal governo. In realtà Lucia Boldrini, pittrice, è morta da più di trent’anni. E il punto di origine della bufala non lascia alcun dubbio, si trattava di un attacco a base di “fango politico” in piena regola. Ricostruendo il percorso di alcune delle bufale dalla diffusione più rapida infatti, si giunge ad una cerchia di persone che le creano “professionalmente”, fin troppo spesso collegati con medie e piccole industrie e con gruppi politici; dove l’obbiettivo dei secondi è chiaramente quello di ottenere il voto di persone facilmente influenzabili anche al di fuori dei sostenitori del proprio partito, per le aziende si tratta di manovre più subdole: incrementare la vendita di prodotti “alternativi” mettendo in circolo l’informazione di come i prodotti più diffusi creino problemi all’organismo o all’ambiente, talvolta persino con informazioni parzialmente corrette. La storia degli acidi a base di limone che circolava a inizio 2013 è emblematica, in quanto prendeva in considerazione che il succo di limone è effettivamente una sostanza acida utilizzata come sgrassatore e come anticoagulante in ambito medico (acido citrico), ma nelle percentuali di purezza e quantità in cui si trova negli alimenti è comunque inferiore all’acidità dei succhi gastrici. Gli effetti più estremi di una bufala possono essere sottovalutati, vedendo come molte possano essere risolte con una semplice e rapida ricerca su un qualsiasi browser internet, ma tre sono i giganteschi esempi di una bufala fuori controllo: l’omeopatia, i vaccini e l’olio di palma. Omeopatia e vaccini richiedono conoscenze chimiche di un livello al di sopra di quello del cittadino medio, e comunque prenderebbero troppo tempo, l’olio di palma, invece, pur se segue gli stessi schemi, è un “concetto” estremamente più comprensibile. Fino a un paio di anni fa, nessuno si interessava all’olio di palma, eccetto le industrie alimentari; l’olio di frutti e semi di palma è sempre stato utilizzato in Africa e medio oriente per una moltitudine di usi, fra cui la preparazione di cibo, anche sostituendo oli e altri tipi di grassi, come ad esempio il burro, sapone, ed infine, nel caso del Napalm e del biodiesel, come componente di armi e di carburanti rispettivamente; una delle peculiarità dell’olio di palma è che ha una grande percentuale di grassi saturi, e quindi può essere confezionato in un panetto simile al burro a temperatura ambiente, che ne semplifica la lavorazione quando si ha a che fare con gli enormi quantitativi industriali. Tuttavia, con l’aumento della richiesta nel XX secolo, la coltivazione della palma ha portato a un incremento delle colture a discapito di altre produzioni, e di deforestazione. A questo si aggiunge che il consumo smodato di quest’olio ha effetti deleteri sull’organismo, identici all’eccesso di burro e di grassi. A partire dalla metà del 2014, però, cominciò a girare la notizia che “l’olio di palma fa male”; In breve tempo, espandendosi a macchia…d’olio, la notizia lasciò tutta l’Europa terrorizzata. I reparti di marketing delle grandi aziende, però, presero la palla al balzo, e scrissero chiaramente sui loro prodotti che non contenevano olio di palma, anche su quelli che non lo avevano mai utilizzato. Eccetto la Ferrero, che forte della sua posizione, e della sua cremosità, affermò fermamente che la Nutella, e tutti i suoi fratelli dolciari, avrebbero continuato a usare l’olio di palma nelle loro ricette, poiché parte essenziale nella creazione del gusto e non come araldo dei mali dovuti all’eccesivo consumo di dolci (arrivando persino a fare test di laboratorio). Questo ha indubbiamente posto il potenziale bersaglio della “bufala” di fronte ad un inatteso dilemma tra l’ansia indotta dalla pressione mediatica ed il consolidato piacere della adoratissima crema di nocciole. Con la scusa dell’“informazione libera e super partes perché fatta dall’uomo qualunque” che molti hanno visto in internet, la bufala ha invece raggiunto il livello opposto, diventando propaganda, il metodo più diretto di attacco costituzionale. La costituzione, infatti, delinea la libertà di informazione, che è legata a doppio filo con la libertà di opinione degli utenti, e con l’obbligo per chi fornisce le informazioni di, attendibilità, cioè di dimostrare che si tratta di fatti avvenuti. Due concetti che non possono e non devono sovrapporsi l’uno all’altro, ma che non hanno alcuna limitazione se semplicemente messi in rete e spacciati per “Fatto”. Dei passi contro la disinformazione e le bufale sono stati fatti sia dai governi di vari paesi, fra cui dei timidi passi anche in Italia, che dai privati, prevalentemente dai social network, ma a questo deve corrispondere un minimo di attività da parte dell’utente, il cosiddetto “Fact Checking” (o in italiano, controllo delle fonti), particolarmente da parte di chi si è “laureato all’università della vita” e da chi si è ritirato dagli studi, conscio di una minore abilità in ambito di studio e comprensione.
Rai, Alfano denuncia autori e conduttori Gazebo: "Mi diffamano da tre anni". Lo annuncia una nota di Alternativa Popolare: "Non si è trattato di un singolo atto ma di una intera campagna durata anni a spese del contribuente", scrive il 20 maggio 2017 "La Repubblica". Angelino Alfano denuncia autori e conduttori del programma Rai Gazebo (condotto da Diego 'Zoro' Bianchi su Rai3) per diffamazione, in sede civile e penale: lo annuncia una nota di Alternativa Popolare, il partito del ministro degli Esteri. "Ieri, con i soldi degli italiani, due milioni e mezzo di euro per il 2017!!!, si è consumata la consueta diffamazione. Quel che è più grave è che essa è stata perpetrata da parte del servizio pubblico". La nota spiega che: "Ieri, con i soldi degli italiani - due milioni e mezzo di euro per il 2017 - si è consumata la consueta diffamazione. Quel che è più grave è che essa è stata perpetrata da parte del servizio pubblico. Il presidente di Alternativa Popolare, Angelino Alfano, annuncia, dunque, di avere dato mandato ai propri legali per denunciare autori e conduttori di Gazebo in sede civile e in sede penale". È quanto si legge in una nota. "Alla denuncia, Alfano allegherà i riferimenti diffamatori a lui rivolti durante gli ultimi tre anni di puntate televisive di Gazebo, per dimostrare ciò che sarà facile dimostrare: non si è trattato di un singolo atto diffamatorio - che sarebbe stato comunque grave - ma di una intera campagna diffamatoria durata anni a spese del contribuente e con una pervicacia diffamatoria che rende plateale il dolo, l’intenzionalità, la tenace volontà di creare un danno alla persona e all’area politica che rappresenta. Il punto è reso ancor più grave dall’enorme sproporzione che vi è, all’interno del servizio pubblico, tra lo spazio dedicato alla diffamazione da questa trasmissione e lo spazio dedicato alla informazione, in altre trasmissioni Rai, sulla medesima area politica e sulla stessa persona che la rappresenta. Infine, è stata la stessa Rai 3, pochi giorni fa, a sottolineare che tale trasmissione è un mix tra informazione e satira, con questa frase contenuta nella nota che era stata diffusa e che riportiamo qui fedelmente: ’... programma caratterizzato dal mix di satira e informazione che ne definiscono l’identità...’. Quindi, se è già stato ampiamente superato il confine della satira traducendosi in diffamazione, a maggior ragione tutto ciò nulla ha avuto a che fare con l’informazione. Ultima considerazione amara: questa diffamazione non può che essersi svolta con la azione o la dolosa e persistente omissione di una intera catena di comando che, dalla rete sino ai vertici massimi, ha consentito questi abusi. Anche costoro, nei limiti del legalmente consentito, saranno, da Alfano, chiamati a rispondere sia nel giudizio civile che nel giudizio penale. Alfano fa presente, infine, di essere giunto a questa amara determinazione dopo tre anni di paziente sopportazione di questo scempio che ha fatto il servizio pubblico, nella speranza che vi fosse un operoso ravvedimento nella diffamazione". L'annuncio della denuncia arriva a pochi giorni dall'ultima polemica: Alternativa Popolare aveva negato l'accredito a Gazebo per partecipare alla conferenza stampa sulla legge elettorale convocata nella sede del partito di Alfano.
“Casa Renzi”, la soap opera infinita del Fatto Quotidiano, scrive Lanfranco Caminiti il 17 Maggio 2017 su "Il Dubbio". Il caso Consip e la miseria del giornalismo: quando l’informazione diventa pettegolezzo e spettacolo di bassa lega. Quel che conta è la cornice narrativa e non più i fatti.
‘Ofiglie: Tu ha da riciri ‘ a verità, ggiura. Ggiura ca nun ricuordi.
‘ O pate: T’o ggiuro, nun m’arricuord nniente.
‘ O figlie: Ggiurale ‘ ncoppa a Maronna ‘ e Pumpei.
‘ O pate: ‘ O ggiuro, ncoppa a Marunnina nuost’. Nun m’arricuordo nniente.
‘ O figlie: E nun mmiettiri ‘ a mmiezzu ‘ a mamma. ‘ Nce fa’ passa’ nu guaie.
‘ O pate: No, t’o ggiuro, ‘ a mamma, no.
‘ O figlie: Statte bbuono. E accuorto.
Non è un dialogo spoilerato dell’ennesima puntata dell’ennesima stagione della saga dei Savastano, insomma della fiction Gomorra. Piuttosto una verace traslazione, dal toscano del “giglio magico” al napoletano più proprio della notitia criminis (tutto ruota intorno il napoletano imprenditore Alfredo Romeo), dell’ennesima puntata dell’ennesima stagione di intercettazioni intorno “casa Renzi” – secondo la sceneggiatura di Marco Lillo, casa di produzione Il Fatto Quotidiano. La quale casa di produzione pubblica (cioè spoilera, fregando il segreto delle procure) un fitto e drammatico dialogo tra figlio e padre Renzi riguardo l’incontro con uno degli imputati del caso Consip. Come se fosse, appunto, la conferma di quanto ha sempre sostenuto – un appalto “mafiosizzato”, in cui imprenditori, facilitatori, politici e commissari si tengono insieme da un patto scellerato di corruzione – e non, piuttosto, quanto è lampante, evidente. Che cioè, l’allora presidente del Consiglio e segretario del Partito democratico non ne sapesse proprio una beneamata mazza, e che, pure, tutto quest’ambaradam è stato costruito “ad arte” per colpirlo. Come è possibile questo, cioè che l’una cosa venga spacciata per l’altra? È possibile per lo stesso meccanismo per il quale se un personaggio muore in una stagione di una fiction può capitare che risorga due stagioni dopo: quello che conta cioè è la “cornice narrativa”, per un verso, e la disponibilità dello spettatore, per l’altro. E anche la cosa più inverosimile, cioè che un morto resusciti, viene passata per buona. Vedete, è la stessa risposta di Marco Travaglio quando gli si fa notare che tutto è un po’ illegittimo. E lui che dice? Non è questo che conta, è la “sostanza” che conta. La “sostanza” è solo il racconto. La tensione drammatica del dialogo tra figlio e padre Renzi c’è tutta. Un figlio deve chiedere conto al padre di un certo comportamento. Di un episodio, di una cosa. È un uomo fatto, ormai, e l’altro è sulla strada del declino. È un destino, questo, che prima o poi tocca tutti. Ma non a tutti tocca prendere di petto il proprio padre, incalzarlo di domande, metterlo all’angolo perché sia limpido, almeno per una volta, per questa volta. Accenna a qualcosa d’altro – e toccando proprio un tasto che sa l’altro ha proprio a cuore, la fede – per fargli capire che non è proprio aria, che non sorvolerà come magari altre volte è accaduto. Sa che il padre indulge alla bugia, magari piccola piccola, di quelle che si dicono per il bene – è un insegnamento che i cattolici conoscono a perfezione. O forse solo all’omissione. Lo ha fatto con lui, chissà quante volte quand’era piccino, e adesso ancora, adesso che è l’uomo più potente d’Italia, lo ha fatto con un suo braccio destro, Luca Lotti. «E non farmi dire altro», questo dice Matteo Renzi a suo padre. L’altro sa di cosa stia parlando il figlio, capisce, tace. Non farmi dire altro: è una frase forte, potente. Terribile. Matteo Renzi è un maschio alfa, un capo branco. Ha fatto presto, forse anche troppo presto, a misurare la sua forza, i suoi denti, la sua zampata con i vecchi capi del suo branco – non erano di già sdentati. Li ha rottamati a cornate, a unghiate, a morsi. Per quello che era la storia del suo partito era poco più di un cucciolo – la gerontocrazia vigeva sovrana nei partiti comunisti d’occidente. Eppure, quel cucciolo – all’inizio guardato con sufficienza nella sicurezza di domarlo al primo impatto – ha mostrato che era impastato di smisurata ambizione e forza. S’era addestrato in casa, prima. Forse presto, troppo presto, aveva già preso a cornate il proprio padre. Il primo, probabilmente, a essere rottamato. Vedete, in letteratura, c’è il complesso di Edipo, l’amore del figlio verso la madre e l’ostilità verso il padre, e il complesso di Elettra, per spiegarlo dalla parte delle bambine, e il complesso di Giocasta, l’amore morboso di una madre per il figlio. Ma non c’è letteratura, e nominazione, per un complesso del padre verso il figlio. Quell’uomo è tornato adesso come un incubo. E anche gli altri – quelli che ha rottamato politicamente – sono tornati come un incubo. Tutto troppo presto: nei racconti tutto questo accade quando il personaggio è ormai in agonia, negli ultimi giorni di vita, in cui rivede a ritroso la propria storia e tutti quelli che ha “fatto fuori” per il potere, quel dannato potere, tornano come fantasmi malmostosi. Chi sta accelerando il corso degli eventi narrativi? Qual è la manina che scrive? Che di soap opera si tratti è ormai evidente. Gli ingredienti ci sono tutti. Il malloppo, anzitutto, ovvero: l’avidità. E poi, il militare infedele, le carte false, il giudice che non decide su fatti e reati ma se gli atteggiamenti di uomini e donne siano o meno integerrimi, le gazzette ciarliere, gli azzeccagarbugli, la famiglia, quella naturale e quella allargata della Massoneria, e soprattutto: isso, issa e ‘ o malamente. Dove isso e issa è abbastanza facile identificarli, in Renzi e in Maria Teresa Boschi. Non c’è niente che unisca il caso Consip e il caso Banca Etruria, certo, a parte l’appartenere entrambi i personaggi principali, le dramatis personae, allo stesso “pacchetto di mischia”. Non c’è niente che unisca il caso Consip e il caso Banca Etruria, tranne il fatto che siano due giornalisti – de Bortoli e Lillo – le “gole profonde”. Scrivono e trascrivono, orecchiano e intercettano, alludono e illudono. A un certo punto, combaciano pure. Nella tempistica, intendo. Escono allo scoperto.
Sono loro, i due scrivani, ‘ o malamente? Due persone, in carne, ossa e testata, per un solo personaggio? Qualcosa si va sfaldando nella storia. Il militare infedele – che avrebbe dovuto “sacrificarsi” – va in giro a raccontare come sono andate davvero le cose. A chi rispondeva. Gli era stato ordinato di fare così, non è farina del suo sacco. Quasi, dice, ho solo obbedito agli ordini. E addita il responsabile. È stato il magistrato che indagava a voler lasciare intendere che i servizi segreti si stessero interessando della cosa – non c’è proprio traccia di questa storia, ma un faldone che racconta di come probabilmente i servizi segreti si sarebbero potuti interessare di questa storia. E le trascrizioni un po’ abborracciate, in cui l’uno veniva scambiato con l’altro, e quello che aveva detto l’uno veniva messo in bocca all’altro, beh, sì, quelle forse sono state un mio errore – dice l’infedele – però, dovete capirmi, ero sotto stress, quello – il giudice – voleva dei risultati e io non avevo in mano niente. Lo chiamava di notte, mentre compulsava ancora le sudate carte, il giudice Woodcock al capitano Scarfato per chiedergli conto di cosa fosse riuscito a concludere quel giorno? O lo chiamava all’alba, mentre iniziava a compulsare le sudate carte, per incitarlo a concludere finalmente qualcosa quel giorno? Che qua, di risultati, se ne vedevano pochini. Ah, che stress per il povero capitano. A un certo punto deve aver capito che sarà solo lui a pagare, a finire a dirigere il traffico a Forlimpopoli, e non ci sta. Tutto l’impianto narrativo rischia di impazzire come la maionese. E qua ‘ o malamente iesce ‘ a fora.
Banca Etruria, Renzi contro De Bortoli: "È ossessionato da me". Renzi in campo per blindare la Boschi: "Che Unicredit studiasse il dossier Etruria è il segreto di Pulcinella". E attacca De Bortoli: "Ha un'ossessione per me", scrive Sergio Rame, Sabato 13/05/2017, su "Il Giornale". "Ferruccio de Bortoli ha fatto il direttore dei principali quotidiani italiani per quasi vent'anni e ora spiega che i poteri forti in Italia risiedono a Laterina? Chi ci crede è bravo". In una intervista a tutto campo al Foglio, Matteo Renzi va all'attacco dopo le indiscrezioni sul salvataggio di Banca Etruria pubblicate dall'ex direttore del Corriere della Sera sul nuovo libro Poteri forti (o quasi). "De Bortoli ha una ossessione personale per me che stupisce anche i suoi amici". "Quando vado a Milano, mi chiedono: ma che gli hai fatto a Ferruccio? Boh. Non lo so". Nell'intervista al Foglio l'ex premier non fa sconti a De Bortoli: "Forse perché non mi conosce. Forse perché dà a me la colpa perché non ha avuto i voti per entrare nel Cda della Rai e lo capisco: essere bocciato da una commissione parlamentare non è piacevole. Ma può succedere, non mi pare la fine del mondo". Per Renzi "che Unicredit studiasse il dossier Etruria è il segreto di Pulcinella". "Praticamente tutte le banche d'Italia hanno visto il dossier Etruria in quella fase. Come pure il dossier Ferrara, il dossier Chieti, il dossier Banca Marche. Lo hanno visto tutti e nessuno ha fatto niente", continua Renzi. Che, poi, aggiunge: "Ferruccio de Bortoli ha detto falsità su Marco Carrai. Ha detto falsità sulla vicenda dell'albergo in cui ero con la mia famiglia. Ha detto falsità sui miei rapporti con la massoneria. Non so chi sia la sua fonte e non mi interessa. So che è ossessionato da me. Ma io non lo sono da lui. È stato un giornalista di lungo corso, gli faccio i miei auguri per il futuro e spero che il suo libro venda tanto". Renzi è convinto che, quanto prima, "si chiariranno le responsabilità a vari livelli". "E - avverte - se c'è un motivo per cui sono contento che la legislatura vada avanti fino ad aprile 2018 è che avremo molto tempo per studiare i comportamenti di tutte le istituzioni competenti. Cioè, competenti per modo di dire. Non vedo l'ora che la commissione d'Inchiesta inizi a lavorare. Come spiega sempre il professor Fortis, vostro collaboratore, Banca Etruria rappresenta meno del 2 per cento delle perdite delle banche nel periodo 2011-2016. Boschi senior è stato vicepresidente non esecutivo per otto mesi e poi noi lo abbiamo commissariato: mi pare che non sia stato neanche rinviato a giudizio. Se vogliamo parlare delle banche, parliamone. Ma sul serio".
Sulla propria pagina Facebook, De Bortoli replica ricordando all'ex premier che "avendo detto due volte no alla proposta di fare il presidente, non era tra le mie ambizioni essere eletto nel cda della Rai". E incalza: "Visto quello che sta accadendo, ringrazio di cuore per non avermi votato. Non avrei potuto comunque accettare avendo firmato un patto di non concorrenza". Poi continua: "Io non ho mai scritto che è un massone, mi sono solo limitato a porre l'interrogativo sul ruolo della massoneria in alcune vicende politiche e bancarie. Ruolo emerso, per esempio, nel caso di Banca Etruria. Ho commesso degli errori, certo". Nel libro ne ammette diversi in oltre quarant'anni. Come quello, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera sul caso JpMorgan-Mps, della data di un sms solidale inviato da Marco Carrai a Fabrizio Viola, "licenziato" poi dal governo. "Non so quali falsità siano state scritte sul soggiorno a Forte dei Marmi nell'estate del 2014 - continua - mi aspetterei invece da Renzi che chieda scusa al collega del Corriere che, in quella occasione, stava facendo il suo lavoro e alloggiava nell'hotel. L'inviato venne minacciato dalla scorta che gli intimò di andarsene. E gli faccio i miei migliori auguri per il suo libro che uscirà a breve".
Giornalismo del controregime, scrive Piero Sansonetti il 13 Maggio 2017 su "Il Dubbio". Le fake news sono diffuse dai social network o comunque dalla rete? No. Le fake news sono diffuse principalmente dai giornali e dalle televisioni. I social vengono a rimorchio, le rilanciano. Ma non sono loro a costruirle. Almeno, non sono loro a costruire le fake importanti. La responsabilità della creazione delle bugie e del loro uso come arma politica e di disinformazione ricade soprattutto sui grandi quotidiani e sui grandi giornalisti. Giornalismo di contro- regime Cioè, giornalismo di regime. Proviamo un inventario di avvenimenti recenti. Caso Guidi, con annesse dimissioni della ministra. Caso Consip, con annessa richiesta di dimissioni del ministro Luca Lotti. Caso Ong, con annessa richiesta di limitazione dell’azione dei soccorsi ai migranti sul Mediterraneo. Caso De Bortoli, con annessa – ed ennesima – richiesta di dimissioni della ministra Maria Elena Boschi. Su questi quattro casi i giornali italiani e i principali talk show televisivi hanno vissuto per mesi e mesi. Con titoli grandi in prima pagina e – alcuni – con vere e proprie campagne di stampa, molto moraleggianti e molto benpensanti. Certo, soprattutto del “Fatto Quotidiano” – che quando offre ai suoi lettori una notizia vera succede come successe a Nils Liedholm quando per la prima volta in vita sua sbagliò un passaggio: lo Stadio di San Siro lo salutò con una ovazione… – ma anche di parecchi altri giornali che godono di alta fama. Ora vediamo un po’ come sono finiti questi quattro casi.
Guidi: mai incriminata. L’inchiesta giudiziaria che la sfiorò, Tempa Rossa, conclusa con il proscioglimento di tutti. Era una Fake. Federica Guidi è scomparsa dai radar della politica.
Consip, l’inchiesta è stata trasferita a Roma, le accuse al padre di Renzi erano fondate su una intercettazione manipolata da un carabiniere, anche le notizie sull’ingerenza dei servizi segreti (evidentemente mandati da Renzi per ostacolare le indagini) erano inventate da un carabiniere e l’informativa al Pm che riguardava queste ingerenze era stata scritta su suggerimento dello stesso Pm che avrebbe dovuto esserne informato. Fake e doppia fake.
Ong, l’ipotesi del Procuratore di Catania che fossero finanziate dagli scafisti è stata esclusa dalla Procura di Trapani da quella di Palermo e da svariati altri magistrati. Fake. Intanto l’azione di soccorso ha rallentato.
De Bortoli. Sono passati ormai quattro giorni da quando, per lanciare il suo libro sui poteri forti, l’ex direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore ha diffuso la notizia della richiesta di Maria Elena Boschi all’amministratore delegato di Unicredit di comprare la banca nella quale lavorava il padre. Boschi ha smentito nettamente. Anche la banca ha dichiarato che non risulta niente. De Bortoli ha fatto mezza marcia indietro, poi ha accusato Boschi e Renzi, o almeno i loro ambienti, di essere massoni, ed è andato in Tv, senza portare neppure uno straccio di prova delle sue accuse ed evitando il confronto diretto con gli avvocati della Boschi. Tranne improvvisi colpi di scena, appare evidente un po’ a tutti che l’accusa di De Bortoli è infondata, altrimenti, ormai, avrebbe fornito degli elementi a sostegno della sua tesi. Anche qui possiamo dire: fake.
La questione invece del complotto massonico a favore di Renzi, denunciato da de Bortoli, non è definibile esattamente una fake, è solo qualcosa di già visto tante volte nella politica italiana. In frangenti non bellissimi. Il più famoso complotto massonico – per la precisione giudaico-massonico, anzi: demo-pluto-giudaicomassonico – fu denunciato da Mussolini, nel 1935, per favorire la persecuzione dei massoni e poi lo sterminio degli ebrei. Non ci fa una gran figura De Bortoli a tornare sul quel concetto, peraltro senza avere proprio nessun indizio sulla appartenenza di Boschi o di Renzi alla massoneria. E in ogni caso andrà segnalato il fatto che la massoneria non è una associazione a delinquere. Furono massoni, in passato, un gran numero di Presidenti americani, tra i quali Washington e Lincoln, furono massoni poeti come Quasimodo e Carducci, furono massoni Cesare Beccaria, Mozart, Brahms, e svariate altre centinaia di geni, tra i quali moltissimi giornalisti di alto livello, parecchi dei quali del Corriere della Serra. Possibile che un giornalista colto e autorevole come De Bortoli scambi la massoneria per Avanguardia Nazionale? Eppure De Bortoli ha trovato grande sostegno nella stampa italiana. In diversi giornali e in diverse trasmissioni Tv la sua “ipotesi di accusa” alla Boschi è stata ed ancora in queste ore è presentata come dato di fatto: «Lei che ha svelato la richiesta della ministra…». Una volta esisteva la stampa di regime. Ossequiosa verso i politici, soprattutto, e in genere verso l’autorità costituita. Ora esiste la stampa di anti- regime. O di contro- regime, che però funziona esattamente come la stampa di regime. Anche perché ha dietro di se poteri molto forti. Non solo un pezzo importante di magistratura ma uno schieramento vasto di editori, cioè di imprenditoria, diciamo pure un pezzo robustissimo della borghesia italiana. De Bortoli oggi è sostenuto da quasi tutti i mezzi di informazione, e si può pensare tutto il bene possibile di lui, tranne una cosa: che sia un nemico dei poteri forti. De Bortoli, per definizione, è i poteri forti. Lo è sempre stato, non lo ha mai negato, nessuno mai ne ha dubitato.
La stampa di contro-regime funziona esattamente così. Non è una stampa di denuncia ma una stampa che costruisce notizie e le difende contro ogni evidenza e logica anche queste crollano. Nei regimi totalitari questa si chiamava “disinformazia” ed aveva un compito decisivo nel mantenimento al potere delle classi dirigenti. Ora si chiama fake press e ha un ruolo decisivo nella lotta senza quartiere che è aperta nell’establishment italiano per la conquista del potere, di fronte alla possibilità di un rovesciamento dei rapporti di forza nel ceto politico. L’avanzata dei 5 Stelle ha provocato un terremoto. Pezzi molto grandi, autorevoli e potenti proprio dei poteri forti si predispongono a dialogare coi 5 Stelle, prevedendone, o temendone, l’ascesa al governo. Questo movimento tellurico squassa la democrazia e devasta i meccanismi dell’informazione. Esistono le possibilità di resistere, di fermare il terremoto, di reintrodurre il principio di realtà – se non addirittura di verità – nella macchina dei mass media che lo ha perso? Non è una impresa facile. Molto dipende dai giornalisti. Che però, nella loro grande maggioranza, oggi come oggi non sembrano dei cuor di leone…
Ferruccio, per favore, se hai le prove mostrale, scrive Piero Sansonetti il 12 Maggio 2017 su "Il Dubbio". Il caso Boschi-Banca Etruria si sta sgonfiando. Finirà nel dimenticatoio come il caso-Guidi, il caso-Lupi, il caso Madia? Il caso-Boschi si ridimensiona. Molti giornali di destra hanno mollato la presa dopo la parziale marcia indietro di Ferruccio De Bortoli, che ha spiegato di non aver mai sostenuto che la Boschi fece pressioni indebite su Unicredit per salvare Banca Etruria. Eppure nel suo libro c’è scritto che «Boschi chiese a Ghizzoni (amministratore delegato di Unicredit) di valutare l’acquisto di Banca Etruria». Resta in campo, al momento, solo Il Fatto Quotidiano che ieri si è lanciato in soccorso di De Bortoli sostenendo di avere le prove della colpevolezza della Boschi. Lo ha scritto enorme, in prima pagina, con l’inchiostro rosso: «Boschi mente: ecco le prove». E ha pubblicato un servizio d Giorgio Meletti nel quale si parla di una riunione a casa del papà della Boschi, dirigente di Banca Etruria, con gli amministratori della stessa Banca Etruria e di alcune banche del Nord. A questa riunione – dice Meletti – che si tenne nel marzo del 2014, partecipò anche la Boschi. Il servizio di Meletti è fatto molto bene e sembra assai informato, anche se naturalmente occorreranno dei riscontri. E tuttavia resta una domanda: ma Meletti non accenna nemmeno all’ipotesi che a questa riunione, o ad altre riunioni, partecipò Ghizzoni. E allora perché mai questo fatto dovrebbe provare che De Bortoli ha ragione? Ieri de Bortoli ha partecipato alla trasmissione televisiva “Otto e Mezzo” di Lilli Gruber. Ha detto che la vicenda di Banca Etruria è tutta una vicenda di massoneria. Un paio d’anni fa aveva detto la stessa cosa del governo Renzi. Né allora né adesso, però, ha citato elementi di prova, o almeno di indizio. Più che altro è sembrata una sua sensazione. Se anche le accuse alla Boschi di aver tentato di spingere Ghizzoni a comprare la Banca dove lavorava il papà dovessero basarsi solo su una sua impressione, non sarebbe una buona cosa. Questa vicenda può concludersi in tre modi. O De Bortoli si decide a portare le prove della sua affermazione, e allora il governo Gentiloni va a gambe all’aria. O De Bortoli queste prove non le ha, e davvero ha scritto il libro solo basandosi su voci raccolte in ambienti vicini a Unicredit, e allora ci troveremmo di fronte a un capitolo nerissimo per il giornalismo italiano. Oppure può succedere che i due contendenti capiscono che è meglio non esagerare nel duello, anche perché l’uno e l’altra hanno dietro le spalle forze abbastanza potenti e capaci di far male, e in questo caso anche “Il Fatto” abbasserà i toni e tutta la storia passerà in cavalleria. Come è successo col caso-Guidi, col caso-Lupi, col caso Madia. E’ sicuramente la terza l’ipotesi più probabile. E non è una bella cosa, né per il giornalismo né per la politica.
Quelle cene con Ligresti per tornare in via Solferino. La vacanza dell'ex direttore nel resort in Sardegna, scrive Domenica 14/05/2017, "Il Giornale". Le cronache raccontano di aragoste a quintali per gli ospiti illustri di Salvatore Ligresti al Tanka Village di Villasimius, in Sardegna. Vecchie storie, un'altra epoca, uno splendore e una leggerezza che ormai non ci sono più. Alla corte dell'ingegnere, quando i tempi del crack Fonsai erano ancora molto lontani, accorrevano in tanti, per lo più personalità del mondo politico e istituzionale, ministri, generali, prefetti, sottosegretari, direttori. Andare al Tanka era un po' lavorare, perché lì si tessevano le relazioni pubbliche che contavano e che portavano spesso alle poltrone importanti. Relazioni rigorosamente trasversali, bipartisan si direbbe oggi. Il Tanka, insomma, veniva considerato un po' una prosecuzione dell'ufficio. Anche se molti scroccavano pure la vacanza, visto che pochi alla fine pagavano il conto. Qualcuno, quando poi se n'è parlato sui giornali, ha persino negato di esserci stato. Non si sa mai. Tra i tanti che negli anni sono passati per il bellissimo villaggio sardo un tempo regno della famiglia Ligresti c'era anche l'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli. Correva l'estate del 2008. All'epoca non guidava più il quotidiano di via Solferino, che aveva già diretto per sei anni, dal 1997 al 2003, ma era già in trattativa per tornarci e si muoveva in quella direzione. C'è chi lo ricorda, infatti, ospite di Ligresti, proprio lì, nel resort di Villasimius, dove l'ingegnere amava organizzare cene speciali per i suoi ospiti di riguardo. Quell'estate il giornalista trascorse qualche giorno al Tanka e tutte le sere sedeva al tavolo di Ligresti, in quel periodo ancora saldamente al vertice di Fonsai, azionista di peso del patto di sindacato dell'editore del Corriere della Sera. Per poter tornare al timone di via Solferino, insomma, era quello il posto giusto dove mangiare aragoste in compagnia e dove valeva la pena trascorrere qualche giorno di vacanza. Di lì a qualche mese, infatti, de Bortoli tornò al comando del giornale milanese, dove è poi rimasto fino al 2015. E pensare che in quei giorni d'estate furono in molti a stupirsi di vederlo al Tanka, tra i clientes di Ligresti. C'è anche chi lo ricorda bersaglio di amichevoli sfottò sull'argomento da parte di chi sedeva con lui al tavolo dell'ingegnere e che sapeva bene perché fosse lì. Pare che lui non gradisse le prese in giro sull'evidente motivo della sua presenza in quel luogo. Era tanti anni fa. Un'altra epoca, appunto.
Il libro di de Bortoli e la memoria corta sul "Corriere" indipendente, scrive Alessandro Sallusti, Venerdì 12/05/2017, su "Il Giornale". Ho letto Poteri forti (o quasi), il libro di Ferruccio de Bortoli già direttore del Corriere della Sera e del Sole24Ore - edito da «La nave di Teseo», di cui si parla in questi giorni per il clamore suscitato dal capitolo che svela l'interessamento della ministra Boschi presso Unicredit per agevolare il salvataggio della banca di papà, la Etruria. «Memorie di oltre quarant'anni di giornalismo», recita il sottotitolo di copertina. E questo basta per mettere l'autore al riparo da critiche su eventuali errori ed omissioni nel racconto che corre fluido come si addice alla penna di un grande giornalista e direttore. Perché di «memoria» ognuno ha la sua e ha il diritto di centellinarla a suo piacimento, che sia per amnesia o per calcolo. Non so perché Ferruccio de Bortoli abbia deciso di raccontarsi a soli 64 anni. Di solito l'autobiografia salvo casi di conclamato narcisismo o ragioni economiche arriva a chiudere una carriera, non a rilanciarla. Svelare retroscena, dare giudizi su uomini viventi e potenti si presta a ritorsioni pericolose. Conoscendo la cautela dell'uomo, grande e cauto navigatore, mi vien quindi da pensare che de Bortoli consideri conclusa la sua brillante carriera, almeno nel giornalismo attivo e di vertice. Fatti suoi, ovviamente. Ma torniamo al libro. De Bortoli vuole farci credere di essere stato per dodici anni (in due tranche, 1997-2003, 2009-2015) a capo di un giornale tempio della libertà e sentinella di democrazia, arbitro imparziale delle partite alcune violente e drammatiche - che si giocavano nel Paese. È la vecchia tesi, retorica e falsa, della sacralità del Corriere della Sera, giornale in cui ho lavorato per diversi anni e che quindi ho ben conosciuto dall'interno. Il Corriere è stato il primo, e per lungo tempo unico, grande e ricco giornale nazionale e per questo ha allevato e ospitato le migliori firme del giornalismo e della cultura per oltre un secolo. Fin dalla nascita, il vestito è stato a libera scelta da qui la sua apparente indipendenza - del direttore e dei giornalisti, ma il cappello è sempre stato attaccato dove padrone voleva: monarchico durante la monarchia, fascista sotto il fascismo, antifascista alla caduta del regime, piduista all'epoca della P2, filo-Fiat sotto il regime di Agnelli, benevolo, negli anni più recenti governati da Bazoli, con il sistema finanziario e bancario vincente. Quest'ultimo è un club di miliardari i cui membri, come tutti i padroni, sono conservatori, ma hanno la necessità di apparire progressisti per non avere rogne nel loro espandersi nell'ombra (in Francia la chiamano «sinistra al caviale»). Tutto ciò non significa che de Bortoli non sia stato un direttore libero. Lui, nato in altro mondo (la sua era una solida e umile famiglia), sognava e studiava fin da giovane racconta chi l'ha frequentato in quegli anni di entrare in quell'ambiente dorato ed esclusivo. Sulla plancia del giornale degli Agnelli prima e dei banchieri poi è stato quindi perfettamente a suo agio. Più che di indipendenza parlerei quindi di coerenza.
Non è poca cosa, la coerenza, cioè la fedeltà alle proprie idee. Ma perché non dirlo? Perché evitare, in una biografia di oltre duecento pagine, di scrivere due righe sul suo essere stato un giovane e convinto comunista, sia pur di quelli che, essendo intelligenti, avevano capito che più che le piazze era meglio frequentare i salotti, che le parole potevano essere più utili e potenti delle spranghe alle quali, infatti, l'uomo, a differenza di tanti compagni, non si è mai neppure avvicinato. Nel libro la fede politica di de Bortoli la si deduce solo dal fatto che le offerte di lavoro che narra di aver ricevuto (presidente Rai, sindaco di Milano, direttore del Corriere) gli arrivavano sempre da politici o banchieri di sinistra (una, in verità, da Letizia Moratti, ma era appunto per dirigere il Tg3). Essere di sinistra è infatti la non misteriosa precondizione per dirigere il Corriere della Sera, altrimenti non si spiega come a giornalisti altrettanto bravi (penso a Montanelli prima di lui e a Vittorio Feltri suo quasi coetaneo) sia stata negata tale possibilità. Anche l'attuale direttore, Luciano Fontana, non a caso professionalmente e culturalmente nasce e cresce all'Unità. De Bortoli (con Paolo Mieli, con il quale si è avvicendato più volte al comando) è stato la faccia presentabile dell'antiberlusconismo militante, la lunga mano della sinistra politica e affaristica (che nel libro, giustamente, si vanta di aver frequentato con reciproca stima e soddisfazione) per manipolare l'opinione pubblica in punta di regole («la notizia è notizia», ama ripetere il direttore, quasi a scusarsi). Noi tutti sappiamo che cosa de Bortoli che oggi ci rinfresca la memoria anche con aneddoti curiosi - è stato libero di scrivere e far scrivere, non cosa non ha pubblicato (potere questo più importante del primo). E, forse, non lo sa neppure lui, perché in un giornale l'acqua inevitabilmente scorre dove il direttore (e il padrone) traccia il solco. Escludo in modo categorico che de Bortoli sia mai stato servo di qualcuno, ma socio ho il sospetto di sì. Forse pure dei magistrati che davano la caccia a Silvio Berlusconi. Nel libro c'è un lungo paragrafo di elogi a Ilda Boccassini («ne ammiro il coraggio, per fortuna il Paese ha toghe come lei, coraggiosa e preparata»). Dice di averla incontrata tante volte, la chiama per nome, «Ilda», incurante di poter così suscitare anche solo un sospetto sull'origine di tanta abbondanza di informazione che il Corriere ha sfornato durante il caso Ruby («una inchiesta per la quale è stata ingiustamente attaccata», scrive senza aggiungere che l'imputato, Berlusconi, è stato assolto per non aver commesso il fatto e che, quindi, non fu una grande inchiesta). Di Berlusconi scrive con distacco: «Il Cavaliere non si arrese mai all'idea che un giornale liberale non stesse per definizione dalla sua parte». Per la verità il Corriere della Sera è stato «per definizione» contro Berlusconi, il cui dubbio è lo stesso che negli ultimi cinquant'anni hanno avuto in tanti: come ha fatto un giornale che si dice liberale a farsi soggiogare dal Pci, dal sindacato interno (un vero Soviet con diritto di censura), fino a strizzare l'occhio alla non pacifica rivoluzione sessantottina? Cosa c'era, nel 1994, di liberale nello sperare che Occhetto prendesse il potere a scapito di un partito davvero liberale come Forza Italia (io c'ero, dietro le quinte, e l'apparente equidistanza era tifo vero)? Cosa c'è stato di liberale nel fare un endorsement, alla vigilia del voto del 2006, a firma del direttore (Paolo Mieli, prima volta nella storia di quel giornale) a favore di un governo Prodi-Bertinotti? Cosa c'è stato di liberale nell'avere un pregiudizio profondo nei confronti non solo di un liberale come Silvio Berlusconi, ma di chiunque emergesse in qualsiasi campo (arte, letteratura, musica, perfino lo sport) e non fosse dichiaratamente di sinistra? La risposta è semplice: Il Corriere, da un secolo a questa parte, non è un foglio liberale. È un camaleonte che ha ingannato, e inganna tuttora, i suoi non pochi lettori liberali (e tutti i politici liberali che bramano di apparire sulle sue colonne). Il Corriere di de Bortoli è stato, lo ripeto, «per definizione» e con un abile gioco di doppi pesi e doppie misure, contro tutto ciò che non era omologato al clan. Tra i suoi editori nel consiglio di amministrazione Rcs - De Bortoli ne ha avuto uno mal visto dai salotti della sinistra e simpatico alla destra: Salvatore Ligresti. E, guarda caso, è l'unico che nelle sue memorie stronca anche con un certo cattivo gusto: «Mi sono trovato a disagio a sedermi a tavola con la sua famiglia». Ora, è vero che Ligresti era un personaggio atipico, che è fallito malamente. Ma sono certo che la sua coscienza non è meno linda di quella di diversi suoi soci apparentemente «per bene» tanto cari al direttore. Certo, è facile vantarsi, con un eccesso di civetteria, dell'amicizia di Mario Draghi: «Una sera camminavo per Parigi, mi suona il telefonino: ciao Ferruccio, sono Mario...». Facile liquidare l'appoggio entusiasta dato dal Corriere al disastroso governo Monti dando un paio di buffetti al Professore oggi in disuso. Facile svelare solo oggi l'aggressione subita da un cronista del Corriere da parte di Matteo Renzi, taciuta quando l'aggressore era potente primo ministro. Insomma, è facile continuare la narrazione della favola di un Corriere della Sera vergine e nelle mani di coraggiosi paladini senza macchia con fonti disinteressate. Facile e pure legittimo. Ma, almeno io, non ci casco.
Giornalista horizontal…, scrive Piero Sansonetti il 5 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Panegirici per Davigo, interviste senza domande, anche il bravo Massimo Gramellini si piega alla cupola del giustizialismo. Bisogna sparare a zero sui politici, ma l’ossequio al giudice è un atto dovuto. Sul “Corriere della Sera” è apparso un articolo di Massimo Gramellini intitolato “Davigo vertical”. È una tipica espressione spagnola, l’hombre vertical, molto lusinghiera, che indica l’uomo tutto d’un pezzo, coerente, serio, incorruttibile. Mi è venuto da chiedermi cosa sarebbe successo se sul “Corriere della Sera” fosse apparso un articolo altrettanto adorante, e firmato da una delle firme più prestigiose del giornale, rivolto all’esaltazione di qualche leader politico. Renzi, magari, o Berlusconi, o Alfano, o Salvini o – al limite – Grillo. Oppure se un panegirico di stile gramelliniano fosse stato pronunciato in Tv, dedicato a un uomo di governo. Sarebbe successa l’iradiddio e il malcapitato adoratore avrebbe capito in un batter d’occhio di essere giunto a fine carriera. Giornalismo horizontal. L’ossequio al giudice è sempre ammesso. Gramellini invece è solo all’inizio di una carriera che sarà – ve lo garantisco – di grande, grande successo. Qual è la differenza tra Davigo e – poniamo – Gentiloni? Come mai se osanni Gentiloni sei degno di disprezzo e se osanni Davigo sei un giornalista coraggioso? A occhio non c’è nessuna differenza tra i due: Davigo e Gentiloni sono rappresentanti del potere, e dunque – vorrebbe una versione forse un po’ antica della deontologia professionale giornalistica – dovrebbero sempre essere osservati con occhio critico dai giornalisti, tenuti a distanza, non celebrati. In realtà uno dei due è molto più potente dell’altro. Davigo ha assunto un ruolo di comando nella magistratura, fino al vertice dell’associazione magistrati, è un giudice di Cassazione, ha un ascolto altissimo nei giornali e nelle Tv, ha a disposizione persino un partito politico, e cioè i 5 Stelle, cosa che – paradossalmente – Gentiloni neanche si sogna. Davigo decide sulla politica della giustizia molto più di Gentiloni, è in grado di guidare campagne di opinione che possono bloccare qualunque provvedimento del governo. E infatti ha bloccato la riforma- Orlando. Del resto lo ha detto lui stesso, proprio l’altro giorno, all’assemblea del suo partito di riferimento (i 5 Stelle): «Non entro in politica perché ho molta più forza se resto fuori». Davigo orienta la magistratura e anche la politica, e se lui chiede più carcere ottiene più carcere. Influenza le sentenze dei suoi colleghi e frena i provvedimenti di clemenza. Intimidisce i tribunali di sorveglianza. Probabilmente Gentiloni sarebbe favorevole all’amnistia o a una riforma garantista del codice penale. Non può, ha le mani legate da un potere molto più grande del suo. La risposta alla domanda sul “diritto di ossequio” è esattamente questa. L’ossequio andrebbe evitato, ma se proprio va reso allora conviene renderlo al più forte. Il potere politico da anni è in verticale caduta, e non è strettamente necessario rendergli omaggio. Il potere di un pezzo di magistratura è in esponenziale crescita, sta allargandosi attraverso una nuova ferrea alleanza con la stampa e pezzi della Tv, ed è molto pericoloso opporsi. Un tipo come Davigo – dicono che sia anche permaloso – va tenuto nel giusto conto. Talvolta, non c’è niente di male: anche i giornalisti possono accettare di diventare hombre orizontal. Il bello è che ci sono alcuni giornali che ogni tanto pubblicano le classifiche dei giornalisti subalterni. Il Fatto Quotidiano, per esempio, li chiama i “lecca lecca”. State pure certi che non metterà Gramellini nell’elenco. Né metterà lo stesso Travaglio, che l’altro giorno, intervistando il Pm palermitano Di Matteo, è riuscito a fare una sola domanda, formulata più o meno così: “Lei ha già risposto a tutte le domande che avrei voluto farle, prima ancora che io gliele facessi…”. Esempio sfrontato di giornalista guascone che non guarda in faccia all’intervistato. Del resto poco prima dell’intervista a Di Matteo, e nella stessa sede (gli stati generali sulla giustizia tenuti mercoledì scorso a Roma dal movimento 5 Stelle) una giornalista di Repubblica aveva dichiarato candidamente: «Non posso non unirmi, anche se non dovrei, all’ovazione per Davigo». Almeno lei ha aggiunto, sottovoce, quelle quattro paroline: «anche se non dovrei…». Naturalmente non ha nessun senso parlare di giornalismo di regime. Come non aveva senso farlo qualche anno fa, quando imperava Berlusconi, non lo ha neppure ora che impera Grillo. Però per chi fa il giornalista è giusto fare qualche attenzione al fenomeno. Il giornalismo italiano si sta piegando sempre di più alla cupola del giustizialismo. Gli spazi per i liberali e i garantisti sono diventati stretti stretti. Non è il caso di piangersi addosso, però non c’è ragione per nasconderlo.
A Otto e mezzo uno show giustizialista. Dodici domande a Lilli Gruber, scrive Piero Sansonetti il 18 Aprile 2017 su "Il Dubbio". Marco Travaglio, Nicola Gratteri e Beppe Severgnini ospiti di La7 in un dibattito su politica e giustizia pieno di false informazioni e privo di contraddittorio. Ma questo è buon giornalismo? Indiscutibilmente Lilli Gruber è una delle giornaliste più prestigiose della televisione italiana. È preparata, ha carisma. Però ogni tanto sbaglia anche lei. Spesso sbaglia l’assortimento degli ospiti. E se commette questo errore senza conoscere troppo bene l’argomento del quale si parla, e dunque senza poter esercitare lei stessa l’obbligo della critica, finisce per fornire ai lettori un cattivo servizio, e per confondere le idee un po’ a tutti. Così è stato venerdì scorso, durante la puntata di “Otto e Mezzo”. Tema, la Giustizia. Ospiti: Nicola Gratteri (da Gruber definito Pm e saggista) Marco Travaglio e Beppe Severgnini. Dov’era l’errore nell’assortimento? I tre, sui temi in discussione, avevano idee perfettamente collimanti. E così non solo nessuno dissentiva, ma venivano lasciate passar per buone (cioè per vere) affermazioni del tutto infondate, o false, o quantomeno discutibilissime. Uno degli ospiti parlava, e gli altri due (ma anche Lilli Gruber, talvolta) annuivano, con la testa o coi sorrisi, in un clima sicuramente idilliaco ma che aveva a che fare poco poco sia col giornalismo, o con l’informazione, sia, ovviamente, col dibattito politico. Qui riassumo – senza commentare, o quasi… – in dodici punti solo le principali affermazioni non vere (o contestabilissime) che mi sono segnato su un taccuino. E provo a smentirle, sulla base dei fatti, e dei codici, e delle leggi. O anche del buonsenso.
Il processo a distanza. Il dottor Gratteri ha spiegato tutti i vantaggi del processo a distanza. Che funziona così: l’imputato non è presente in aula ma sta in carcere ed è collegato per via telematica in video e in audio. Dunque non ha il suo avvocato al fianco, non può consultarsi con lui in tempo reale, non è di fronte ai testimoni di accusa, né al pubblico ministero, non può intervenire, non può vedere documenti che eventualmente l’accusa esibisce, eccetera eccetera. Gratteri però questi inconvenienti non li ha elencati. Ha solo detto che comunque l’imputato può eventualmente consultarsi con l’avvocato via cellulare. E poi ha spiegato che in questo modo si risparmiano 70 milioni all’anno, facendoci capire che più che dello Stato di diritto è bene occuparsi del bilancio. Ha ragione Gratteri? No, ha torto. Il processo a distanza indubbiamente danneggia l’imputato e le sue possibilità di difesa. E lo costringe (se ha i soldi per pagarseli) ad avere due avvocati, uno in aula e uno accanto a lui in carcere. Ma se è povero, niente da fare. E soprattutto Gratteri ha torto perché esiste l’articolo 111 della Costituzione che dice così: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato (…) abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (…)». In coscienza, qualcuno può ritenere che il processo a distanza, nel quale l’imputato, ad esempio, non può mai trovarsi faccia a faccia davanti al testimone d’accusa, e neppure davanti al giudice, è compatibile con questa norma della Costituzione? L’altro giorno persino il nuovo presidente dell’Anm (associazione nazionale magistrati) ha detto che il processo a distanza non sta in piedi. In trasmissione non si è neppure fatto cenno a questa circostanza.
«Gli avvocati difendono lo status quo». Questa è stata la motivazione fornita da Beppe Severgnini (editorialista del “Corriere della Sera” e direttore del settimanale “Sette”) per spiegare l’opposizione degli avvocati al processo a distanza. Eppure gli avvocati da molti e molti anni chiedono profondissime riforme della giustizia: la separazione delle carriere, per esempio, la fine dell’obbligatorietà dell’azione penale, la riforma della carcerazione preventiva, la regolamentazione delle intercettazioni e tante altre. A opporsi a queste riforme è stata una parte della magistratura, mai gli avvocati. Cosa c’entra lo Status quo? Il problema è la difesa dello Stato di diritto. Che alcuni considerano un orpello, una cosa antimoderna, incompatibile con una giustizia severa ed economica, e che gli avvocati invece difendono coi denti.
Carceri affollate per mancanza di personale. Gratteri ha sostenuto che non esisterebbe il sovraffollamento delle carceri se ci fosse il personale sufficiente per usare tutte le celle a disposizione. Ma siccome il personale è usato per i trasferimenti dei detenuti (che potrebbero essere aboliti col processo a distanza) le celle restano vuote. Non è vero. Le carceri sono sovraffollate semplicemente perché la massima capienza (e cioè 45 mila posti letto) è inferiore al numero dei detenuti (55 mila).
Detenuti stranieri. Gratteri ha fatto notare che in Africa il costo della vita è molto basso. E dunque ha auspicato che i detenuti in Italia, di nazionalità africana, siano rispediti nei paesi d’origine, con accordi che prevedano che l’Italia paghi loro il vitto. In questo modo – ha spiegato – svuoteremmo le carceri e risparmieremmo un sacco di soldi, perché il vitto africano costa poco. Applausi di Severgnini. Purtroppo nessuno ha fatto notare a Gratteri che in alcune carceri africane (per esempio in Libia) spesso si applica la tortura, e gli standard umani sono inferiori a qualunque principio costituzionale italiano.
Carcere duro. Gratteri – in contrasto con il linguaggio usato solitamente in magistratura – ha affermato che il famoso articolo 41 bis consiste nel carcere duro. Probabilmente è stata una disattenzione. I magistrati hanno sempre sostenuto che è solo una forma di maggiore vigilanza sull’attività del detenuti. Se il 41 bis è carcere duro come dice Gratteri (e su questo, probabilmente, ha ragione) è una forma incostituzionale e illegale di detenzione che va immediatamente abolita.
Prescrizione. Sempre Gratteri ha sostenuto che non va allungata la prescrizione ma ne vanno abolite le cause. E le cause sono la lunghezza dei processi. Anche qui: d’accordo. E qual è la causa principale della lunghezza dei processi? Dice Gratteri: il mancato processo a distanza. E se invece – chiediamo – si abolisse l’obbligatorietà dell’azione penale, come in tanti paesi occidentali, e si dimezzasse, o più, il numero dei processi? E se si abolisse il diritto dell’accusa di fare appello dopo una assoluzione in primo grado, dal momento che una sentenza di assoluzione in primo grado è di per se un “ragionevole dubbio” sulla possibile colpevolezza?
Tasso di impunità / 1. Marco Travaglio ha sostenuto che il provvedimento cosiddetto “svuota- carceri” ha disposto che sia impossibile, anche dopo la sentenza definitiva, mettere in prigione qualcuno se è stato condannato a meno di 4 anni. Prima – ha detto Travaglio – il limite era tre anni, ora l’hanno aumentato. Non è vero. Travaglio probabilmente ha fatto parecchia confusione. Esistono vari provvedimenti e non si capisce bene a quale lui si riferisca. Uno è la riforma carceraria di trent’anni fa, quella firmata dal parlamentare cattolico di sinistra Mario Gozzini, e approvata all’unanimità (tranne i neofascisti), che prevedeva la possibilità di varie misure alternative alla detenzione per i detenuti considerati non pericolosi. Tra queste misure c’era la possibilità di scontare la pena, o una parte della pena, in forme diverse dalla detenzione in cella. Il giudice di sorveglianza ha la possibilità di sospendere la pena per un certo numero di mesi, in caso di condanna a meno di tre anni, per dare il tempo dal condannato di chiedere le misure alternative. Ha la facoltà – attenzione – non l’obbligo. La decisione spetta solo a lui, non al parlamento. L’idea di portare dai tre ai quattro anni il tetto per ottenere queste misure, non è stata ancora realizzata. E’ una legge delega che aspetta i decreti attuativi. Non riguarda tutti i carcerati ma solo le donne incinta, i padri con bambini sotto dieci anni, i malati, gli anziani e i ragazzi sotto i 21 anni. Io non dico che tutti debbano conoscere per filo e per segno le leggi, ma insomma è proprio necessario parlare in tv, con prosa apodittica, di cose che non si conoscono? (Scusate il commento, mi è scappato…)
Tasso di impunità / 2. Travaglio sostiene che in questi ultimi anni le carceri si sono svuotate e i tassi di impunità aumentano, perché i politici fanno leggi per non andare loro in galera, e, con effetto- domino, finisce che aiutano anche i delinquenti di strada. E così il crimine aumenta. I delinquenti restano a piede libero, e la gente si spaventa e si arma. È giusta questa analisi? No, è sbagliata. Le carceri, in questi anni, non si sono svuotate ma riempite. E i delitti – viceversa – non sono aumentati ma diminuiti. Per l’esattezza, nel 1970 i detenuti erano circa 25.000. Nel 1990 erano circa 30 mila. Ora sono 55 mila. Negli anni 70 il tasso di delinquenza era circa il doppio, rispetto ad oggi. Gli omicidi circa 4 volte di più. Diciamo che viviamo in una società molto più sicura, molto più legale e anche molto più repressiva rispetto a quella di 30 o 40 anni fa.
Reati dei colletti bianchi. Beppe Severgnini ha sostenuto che in Italia esistono solo 230 colletti bianchi messi in prigione per reati finanziari. In Germania – ha detto – sono 18 volte di più. Ignoro l’origine di questi dati. Ho dato un’occhiata al foglio ufficiale del Dap (il dipartimento penitenziario). Prendo qualche numero a caso. Detenuti per bancarotta l’ultimo giorno dello scorso anno: 517. Per appropriazione indebita: 342. Per insolvenza fraudolenta: 726. Peculato: 341. Omissione d’atti d’ufficio: 401. Non voglio conteggiare truffa (1505) o altri reati simili, perché riguardano sia i colletti bianchi che la povera gente. Ho citato solo alcuni reati a caso. Ne mancano moltissimi altri, fra i reati dei colletti bianchi. Solo con questi che ho citato (e senza conteggiare le truffe) siamo oltre i 2400 detenuti. Da dove esce quel dato di 240? Nelle prigioni italiane ci sono un senatore in carica (Antonio Caridi) e due parlamentari della scorsa legislatura (Dell’Utri e Cosentino) più alcuni che sono ai domiciliari. Non sono sicurissimo che esistano molti altri paesi europei con dei parlamentari in prigione.
Carcerazione preventiva. Marco Travaglio ha spiegato che in Italia è difficile ottenere la carcerazione preventiva, perché per ottenerla bisogna beccare il reo mentre sta tenendo un testimone col coltello alla gola. Cioè bisogna dimostrare che sta cercando di fuggire, o di inquinare le prove, o di reiterare il reato.
Non è vero. E’ sufficiente il rischio. Il Pm e il Gip, a loro discrezione, decidono se esiste o no il rischio di inquinamento fuga o reiterazione. L’Italia infatti è il paese occidentale con la percentuale più alta di carcerazione preventiva. Circa il 33 per cento. Cioè più di 15 mila persone. Dei quali almeno la metà risulterà innocente. Negli ultimi 10 anni le ingiuste detenzioni accertate sono state 7000 all’anno. Cioè, più o meno, venti al giorno. Non bastano ancora?
Il capitan “Riscrivo” (Consip). Travaglio ha difeso il capitano dei carabinieri (capo del Noe) accusato dalla Procura di Roma di falso per aver consegnato una “informativa” nella quale si sosteneva che l’imprenditore Romeo era stato intercettato mentre diceva di avere incontrato Tiziano Renzi. L’informativa – sulla quale si è costruito un clamoroso scandalo sui giornali – era sbagliata, perché non era Romeo ma era l’ex parlamentare Italo Bocchino quello che diceva di avere incontrato Renzi, e si riferiva non a Tiziano ma a Matteo, che Bocchino, in quanto ex parlamentare, incontra spesso nei corridoi di Montecitorio. Travaglio ha detto che il capitano probabilmente ha solo commesso un errore “di svista”, perché ha sbagliato nell’informativa ma non nella trascrizione dell’intercettazione che invece riporta giustamente il nome di Bocchino. Già, ma Travaglio non ha detto che la trascrizione non l’ha eseguita il capitano, l’hanno eseguita un brigadiere e un maresciallo, i quali l’hanno consegnata al capitano, correttamente, e il capitano ha poi compilato l’informativa, e l’ha consegnata alla magistratura, invertendo i nomi. Che forse il capitan Riscrivo sia innocente, e abbia solo commesso un errore involontario, è possibilissimo. Solo stupisce l’eccesso di garantismo di Travaglio, abbastanza insolito, e qualche omissione nel riferire i fatti. Forse anche perché il Noe del capitan “Riscrivo” (come è stato scherzosamente ribattezzato) tempo fa aveva fornito presumibilmente al “Fatto” una intercettazione di Renzi che parlava male di Enrico Letta col comandante della Gdf (intercettazione priva di rilievo penale e che quindi andava distrutta e non passata i giornali).
Intercettazioni. Il dottor Gratteri ha sostenuto che la giustizia italiana vive di intercettazioni – a differenza degli altri paesi occidentali – perché sono economiche. Dice che altri metodi d’indagine, più concreti – accertamenti, pedinamenti, riscontri, testimonianze, eccetera – costano troppo. Severgnini a questo punto lo ha proposto come ministro della Giustizia. A me sembrerebbe più adatto a fare il ministro dell’economia.
Mi fermo qui. Non è successo niente di grave, naturalmente. Tutti errori veniali. Ma il numero di informazioni inesatte fornite ai telespettatori in 38 minuti di trasmissione è stato davvero altissimo. Io dico solo, sommessamente, che questo non è buon giornalismo. Può succedere. E’ che sui temi della giustizia succede spesso. Magari sarebbe opportuno, talvolta, quando si parla di giustizia, invitare non solo fans del “Fatto”, ma anche qualche esperto, qualche avvocato, qualcuno che conosce bene le cose e le ha studiate un po’. Voi direte: ma Gratteri le conosce bene! Non mi pare, francamente.
Ma il partito dei Pm esiste e ha molti appoggi, scrive Piero Sansonetti il 6 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Carissimo Morosini, sul Dubbio di ieri noi abbiamo riportato le sue dichiarazioni virgolettate ed esatte, e poi abbiamo pubblicato un commento. Come usano gli inglesi. Naturalmente i commenti appartengono a chi li scrive e basta. Le sue opinioni però mi hanno dato lo spunto per provare ad aprire una discussione con la magistratura Ma il partito dei Pm esiste e ha alleati nei partiti e nei giornali. Carissimo Morosini, sul Dubbio di ieri noi abbiamo riportato le sue dichiarazioni virgolettate ed esatte, e poi abbiamo pubblicato un commento. Come usano gli inglesi: i fatti separati dalle opinioni (in Italia, è vero, si usa pochissimo questo metodo). Naturalmente i commenti appartengono a chi li scrive e non certo a chi ne è “l’oggetto”. Ovvio che le mie considerazioni non coincidono con le sue opinioni. Né tantomeno con le cose che lei dichiara ufficialmente, soppesando bene le parole, come è giusto che sia visto il suo ruolo istituzionale, la sua lunga carriera in magistratura e la sua presenza attiva nelle associazioni dei magistrati. Le sue opinioni però – interessanti e non frequenti tra i magistrati – mi hanno dato lo spunto per andare oltre e provare a rivolgermi a quella parte della magistratura più moderna e meno reazionaria (della quale lei sicuramente fa parte), per chiedere di venire allo scoperto, di partecipare o addirittura pro- muovere un dibattito di idee che è necessario per fare uscire la giustizia italiana dalla crisi profonda nella quale si trova. Quanto alle osservazioni espresse nella sua lettera, mi permetto di fare a mia volta qualche altra considerazione.
A) Lei dice che per sostenere che esistono casi di magistrati che usano la giustizia per fare lotta politica bisogna fare nomi e cognomi. Specie se, come nel suo caso, si ricopre un ruolo istituzionale. Potrei fare diversi nomi e cognomi, visto che, ad esempio, come lei sa bene, il parlamento è pieno di magistrati, i vertici delle regioni sono pieni di magistrati, lo sono molte giunte comunali, diversi magistrati hanno partecipato anche ai governi della Repubblica, altri sono stati proposti per ruoli rilevantissimi, compreso quello di ministro della Giustizia. Oppure potrei citarle, tra i tanti, il caso di quell’ex deputato del Pd ( che mi pare si chiami Nicola Sinisi, peraltro ottima persona e onestissimo) che dopo anni di battaglie contro Augusto Minzolini, giornalista schierato a destra e poi senatore di Forza Italia, si trovò a giudicarlo (e Minzolini finì condannato, credo ingiustamente); o ancora le potrei parlare di un certo Bernini, assessore in Emilia di centrodestra, che finì indagato per collusioni con la ‘ ndrangheta ( restò nel limbo per anni, fu rovinato, e poi ne uscì pienamente assolto) da un magistrato di centrosinistra che era stato il capoufficio in un ministero del governo Prodi. Non sono belle cose, so che lei è d’accordo con me. Non succede in nessuna altra professione. Dopodiché è chiaro che in genere sono i partiti, e non direttamente la magistratura, ad utilizzare le inchieste a fini di lotta politica. Basta pensare alle liste di proscrizione stilate alla vigilia delle elezioni dalla Commissione antimafia, o al caso del povero sindaco di Roma Marino, del quale, giustamente, ha parlato anche lei, un po’ indignato, nell’intervista al quotidiano siciliano.
B) Lei giustamente sottolinea la necessità di regole certe per i magistrati, in tema di segretezza e la necessità “di sanzioni per chi non le rispetta”. Ha ragione. Però le regole ci sono, quasi nessuno le rispetta, e di sanzioni, fin qui, nemmeno l’ombra… O mi sbaglio?
C) Lei dice che condotte penalmente irrilevanti possono appannare la credibilità di un politico, e dunque ben vengano i codici etici. Forse ha ragione. Io però penso che a giudicare le condotte penalmente irrilevanti sarebbe giusto che se fossero gli elettori. Dovranno pure avere un potere questi elettori, o no? Oppure devono solo ratificare le scelte compiute a monte o dalla magistratura o dagli Stati maggiori dei partiti, o – nel caso in cui si parla tanto in questi giorni – da Grillo in persona?
D) Sul partito dei Pm possiamo discutere per ore e ore. Però, francamente, dottor Morosini, sostenere che non esiste è arduo. Ha una sua struttura (si chiama Anm), un capo (si chiama Davigo), una linea politica (attualmente, purtroppo, è il davighismo), moltissimi referenti esterni e moltissimi alleati, tra i quali un partito politico vero e proprio, i 5 Stelle, e un gran numero di testate giornalistiche. Altra cosa è dire che non è monolitico. Anch’io credo che non lo sia. E del resto la sua intervista al Giornale di Sicilia lo conferma. Il problema – che cercavo di sollevare nell’editoriale di ieri – è proprio questo: il silenzio di un pezzo importantissimo di magistratura che non è d’accordo con la linea davighiana eppure non esce allo scoperto. Le ultime righe della sua lettera mi incoraggiano: mi fanno capire che forse c’è la volontà di riaprire una discussione chiusa da troppo tempo. La domanda che le faccio è questa: esiste un pezzo di magistratura ha l’interesse e la forza e il coraggio per mettere tutto in discussione (in discussione vuol dire che si esaminano i pro e i contro e poi si decide): dalla separazione delle carriere, alla responsabilità civile, alle manette facili, al 41 bis, eccetera eccetera eccetera? Finché questa discussione non si apre, in modo moderno e leale, è difficile pensare a qualcosa di buono per la giustizia italiana.
Procura e redazioni: quando il copia-incolla diventa uno scoop! Scrive Paolo Delgado il 2 Aprile 2017 su "Il Dubbio". Spesso dietro le notizie ci sono i magistrati, così finisce che a dettare la linea e il senso comune siano, appunto, quegli stessi magistrati. Intercettato in carcere Massimo Carminati, che secondo la procura di Roma è la versione romanesca di Totò Riina, si lascia andare a una confidenza sbalorditiva: «La vera Cupola a Roma sono i costruttori». Sull’Espresso, uno dei giornalisti più addentro nelle cose della Cosa nostra capitolina commenta: «La bomba er Cecato la sgancia così. Senza aggiungere nulla. Senza dare una spiegazione all’interlocutore che però comprende il messaggio». Però se le parole del temibile sono una bomba conviene evitare i bar della Capitale, pena il ritrovarsi nell’inferno di Mosul: che a Roma i padroni siano i palazzinari lo sanno e lo ripetono proprio tutti. Da decine d’anni. L’articolo in questione, uscito nel settembre scorso ma del tutto omogeneo a un migliaio d’altri usciti su quasi tutte le testate italiane, è un florilegio. Carminati è in cella con altre tre detenuti e stando in regime di 41bis non vede nessun altro. Sempre in virtù del medesimo 41bis, l’articolo che dispensa il carcere duro per i mafiosi, capita che in cella il Pirata si ritrovi appunto con mafiosi, tra cui Giulio Caporrimo, considerato intimo del super latitante Matteo Messina Danaro. Capita anche, per quanto incredibile sembri, che ci parli. Commento del settimanale: «Ecco come la mafia siciliana ritorna prepotente e silenziosa in questa storia». Di perle del genere, a spulciare i media italiani se ne rintracciano senza sforzo a tonnellate. Fanno notizia, anche quando la notizia latita o si riduce a un’opinione. Fanno cultura di massa, mentalità diffusa, e siccome 99 volte su 100 dietro quelle notizie ci sono le procure finisce che a dettare il senso comune sono appunto le procure. Fanno anche carriera: per essere promossi a principi del giornalismo niente, neppure una bella sparata contro i politici magnaccioni, vale una minaccia mafiosa, un sguardo di sbieco del boss di turno. Se resuscitasse, Leonardo Sciascia volgerebbe oggi i suoi strali non più contro i palazzi di giustizia ma contro le redazioni, che del resto ne sono spesso pure dependences. Roberto Saviano ha aperto la strada e indicato la rotta. In mezzo allo stuolo di principi e duchesse è senza discussioni il sovrano. Cosa abbia scritto nel celebre Gomorra che non fosse già noto è un mistero. L’apporto creativo e fantasioso in quello storico titolo è conclamato: si chiama romanzo proprio perché non perde tempo a separare i fatti dall’immaginazione. Ma se ai boss non è piaciuto deve per forza trattarsi di capolavoro: tanto che qualche anno fa di Saviano, con all’attivo due titoli, è uscita l’edizione di lusso delle opere complete. Come usa Con Tolstoj o Gadda. Il secondo titolo in questione, al quale si è aggiunto nel frattempo un terzo e bisognerà sfornare al più presto l’edizione aggiornata dell’opera omnia era un’inchiesta sullo spaccio di cocaina, “ZeroZeroZero”: basta spulciare i ringraziamenti finali per scoprire che le fonti dell’inchiesta sono essenzialmente le inchieste della magistratura. Del resto anche in quel caso si trattava di un romanzo…L’esempio più lampante ed eloquente resta tuttavia ancora quello dell’inchiesta Mafia capitale. La procura ipotizza l’associazione mafiosa, ma è ben consapevole di muoversi su un terreno friabile, tanto che nelle ordinanze pagine e pagine sono devolute a giustificare la pesante accusa a carico di un gruppo che non ammazza, non ferisce, non picchia ed è discutibile persino che minacci. A giudicare a fondatezza del capo d’accusa saranno ovviamente i tre gradi giudizio, ma il dubbio è lecito e dovrebbe anzi essere obbligato. Qualche giornalista infatti dubita, ma il circolo è ristretto e sembra essere precluso, con pochissime eccezioni, ai cronisti di giudiziaria. I quali si sono invece procurati in massa il crampo dello scrivano per spiegare senza pensarci su due volte che il capo d’accusa è in realtà solare e solidamente giustificato. Neppure quando una sentenza ha stabilito che nell’unico municipio di Roma sciolto per mafia, quello di Ostia, la mafia non c’era. Non è solo questione di opportunismo e asservimento alle procure. Quando si parla di mafia e affini entra in ballo l’impegno civile. Revocare in dubbio le conclusioni dei pm che indagano sulla criminalità organizzata significa farsene complici, e chi mai potrebbe guardarsi nello specchio sapendo di aver dato una mano a Matteo Messina Denaro o Massimo Carminati? Non è forse l’etica civile a imporre per prima di prendere per oro colato qualsiasi cosa i guerrieri dell’antimafia partoriscano, scemenze incluse? Il rovello non si pone solo nei casi clamorosi, come il processone romano. La logica discende sino a quelli microscopici.
LA DEMERITOCRAZIA.
La demeritocrazia che uccide. Luana Ricca, dopo una brillante carriera da chirurgo a Parigi, torna in Italia e si suicida, scrive Ilaria Bifarini il 6 febbraio 2016 su "L'Intellettuale dissidente". È la storia di un controesodo, del ritorno in patria di un cervello in fuga. Un rientro desiderato, ambito, sospirato. Era il 2014 quando Luana raccontava la sua storia a Radio24 “Sono Luana, ho 36 anni, sono una mamma ed un chirurgo (…)Per lavorare vivo a Parigi con mio figlio di 5 mesi, mentre mio marito vive e lavora a Roma, facendo i tripli salti mortali per vederci. Dopo avere inviato diverse domande per concorsi pubblici, in Italia attualmente non ho alcuna possibilità”. Un curriculum di tutta eccellenza il suo, che racconta una storia fatta di esodi e di speranze, che la veda giovanissima abbandonare la natìa Sicilia per andare a studiare a Roma, in uno dei migliori atenei di Medicina, dove si laurea a solo 23 anni. Segue la specializzazione in Chirurgia Generale alla Sapienza e Luana decide di arricchire la sua formazione con stages all’estero: Londra, Barcellona e Parigi. Proprio nella capitale francese trova la sua prima occupazione da chirurgo nel primo centro francese di trapianti di fegato e di chirurgia epato-biliare, “gratificante in termini di responsabilità e remunerazione”, come racconta agli utenti radiofonici italiani. Il desiderio di migliorarsi e la passione per la sua professione rendono inarrestabile il suo impegno: effettua più di 1500 interventi chirurgici, scrive su riviste chirurgiche internazionali e parla tre lingue straniere (inglese, francese e spagnolo). Dal 2012 comincia un doppio dottorato di ricerca in oncologia, in italiano e francese, alla ricerca di una via di ritorno in Italia che riunisca la sua famiglia. Dopo anni di sospiri arriva il concorso all’Ospedale Regionale de L’Aquila e Luana lo vince, arrivando quinta. Ma l’esultanza dura poco. Viene spedita al distaccamento di Sulmona, a ore di auto da L’Aquila, dove risiede con il marito che fa la spola con Roma, a occuparsi di endoscopie digestive. Si apre un periodo buio nella vita di Luana, il suo brillante percorso formativo e professionale si interrompe, anni di studio e di esperienza vanno in fumo; la giovane chirurgo nell’ambiente medico italiano si sente isolata, incompresa, per la prima volta impreparata. Anni all’estero di studio e lavoro, di risultati e gratificazione conseguiti con l’impegno e la passione non l’hanno formata per sopravvivere alla realtà lavorativa italiana, in cui per andare avanti le logiche meritocratiche non solo non aiutano ma ostacolano. Per mettere in campo le proprie capacità e competenze bisogna accettare le logiche clientelari e corrotte, conoscerle e saperle cavalcare. Luana, con la sua brillante carriera all’estero alle spalle, non ce l’ha fatta, troppo estranee alla sua forma mentis acquisita studiando e lavorando sodo. Si è ammalata di uno dei mali più oscuri anche per i medici come lei: la depressione. Così, nel silenzio generale della stampa e dei media, pochi giorni dopo Natale si è suicidata. Vittima di mobbing, di demansionamento, di aspettative infrante. In una sola parola, demeritocrazia.
Poi c'è il caso di Antonio Palma, il ragazzo commerciante non omologato ed inviso dai suoi compagni comunisti (moralisti ipocriti, che magari le merendine a nero le avevano comprate), perchè esercitava al di fuori delle regole dettate da uno Stato ladrone.
Torino, vendeva merendine in nero: sospeso un 17enne a Torino. Avrebbe iniziato un traffico nero di merendine nonostante fosse stato sospeso lo scorso anno per 10 giorni: il consiglio di classe deciderà a breve le sanzioni, scrive Enrica Iacono, Lunedì 21/11/2016, su "Il Giornale". All'Istituto Pininfarina di Moncalieri, in provincia di Torino, uno studente è stato sospeso dopo aver avviato un commercio nero di merendine. La vicenda ha dell'incredibile ma, come riporta La Repubblica, tutto sarebbe iniziato durante lo scorso anno scolastico quando il ragazzo diciassettenne aveva iniziato a comprare delle merendine al supermercato per poi rivenderle a un prezzo più basso del bar della scuola ai numerosi studenti. La sospensione di 10 giorni è stata inevitabile ma anche quest'anno lo studente ci è ricascato. La scorsa settimana infatti è stato scoperto nuovamente dagli insegnanti mentre ricominciava, da vero imprenditore, il suo "traffico di merendine". Il preside dell'istituto Pininfarina Stefano Fava si è detto molto risentito del comportamento dell'alunno: "Questo è un problema di legalità. La scuola, insieme ai saperi, alle conoscenze, alle abilità, deve anche insegnare a questi ragazzi a essere cittadini e dunque a rispettare le leggi. Non vogliamo inibire la sua vena imprenditoriale, ma dobbiamo pensare al benessere e alla salute dei nostri studenti. Non sappiamo da dove provenissero quelle merendine, né se fossero scadute o mal conservate. E se i nostri allievi fossero stati male? A me le famiglie consegnano ragazzi sani e si aspettano che glieli restituisca tali". Le sanzioni nei confronti del ragazzo recidivo saranno decise dal consiglio di classe anche se lo studente sembra non voler imparare la lezione certamente affascinato dal mondo dell'imprenditoria.
Lo strano caso delle merendine, scrive Econoliberal il 16 dicembre 2016. Qualche giorno fa appare la notizia di uno studente di un istituto tecnico di Moncalieri (TO) premiato dalla Fondazione Einaudi per aver venduto merendine a scuola, subendo per questo una sospensione. Faccio un salto sulla sedia: la Fondazione Einaudi di Torino ha la fama di essere una istituzione seria. Perchè dovrebbe premiare uno studente sospeso due volte in due anni? Basta qualche controllo per capire che il premio (500 euro) arriva dall'omonima fondazione con sede a Roma, che non ha un comitato scientifico composto da seri economisti ma è formata per lo più da politici e giornalisti uniti da una comune passione contro le imposte e lo Stato. Cosa faceva di grave lo studente? Comprava merendine uguali a quelle del distributore automatico e le vendeva a scuola a un prezzo inferiore a quello del distributore automatico, ottenendo guadagni non irrilevanti (pare 15 mila euro in alcuni anni), naturalmente esentasse. E' stato sospeso due volte in due anni e tutto sarebbe finito lì se non fosse che la Fondazione Einaudi di Roma ha deciso di premiarlo con una borsa di studio e qualche intervista, nella quale si dice pronto a andare a vivere in Portogallo perchè le imposte sono basse. Battaglia ideologica che rischia di costargli cara: dopo il premio sono arrivate le proteste dei compagni di scuola, e qualche minaccia. Così il Tribunale di Torino si sta chiedendo quale sia stato il ruolo del padre del ragazzo (che rischia di subire qualche provvedimento del Tribunale dei Minori) mentre il fisco è interessato a indagare sui guadagni del piccolo commercio.
Pininfarina: gli studenti scendono in piazza contro il premio al compagno "venditore di merendine". Benedetto (Fondazione Einaudi):"Pronti a confrontarci con loro per spiegare", scrive Jacopo Ricca il 12 dicembre 2016 su "La Repubblica". Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi Gli studenti del Pininfarina si schierano contro la decisione della fondazione Luigi Einaudi di premiare il loro compagno Antonio, il venditore abusivo di merendine dell'istituto di Moncalieri che è stato sospeso per 15 giorni dalla scuola proprio per questa sua attività. “Non ci sembra giusto premiare un comportamento illecito. Non è un messaggio corretto per i tanti che si impegnano a rispettare le regole” attaccano i rappresentanti degli studenti che domattina saranno fuori dalla scuola insieme ai loro compagni per manifestare il dissenso. Hanno scelto di scendere in piazza domattina quando il ragazzo sarà con suo padre a Roma nella sede della fondazione Einaudi per ritirare la borsa di studio che il centro dedicato a uno dei più importanti autori liberali d'Italia ha deciso di offrirgli: “Il suo spirito d’iniziativa non è da perseguire, ma da promuovere – recita la motivazione – In un Paese dove l’iniziativa privata è spesso ostacolata riteniamo che il ragazzo abbia invece messo in pratica molti degli insegnamenti di von Hayek e dello stesso Einaudi”. Questa scelta, ma anche le tante offerte di lavoro arrivate ad Antonio non hanno convinto i suoi compagni: “Sia chiaro che non è una manifestazione contro di lui – continuano i rappresentanti – Noi non ce l'abbiamo con lui, ma ci sembra scorretto dare riconoscimenti a lui e non ai tanti studenti meritevoli che ci sono anche in questa scuola”. La vicenda del venditore di merendine insomma continua a scatenare polemiche, anche dentro la scuola. Il preside Stefano Fava considerava la vicenda chiusa dopo che la sospensione di due settimane, spalmata su tutto il 2017, da passare in un'associazione di volontaria decisa dalla scuola, era diventata definitiva nonostante la richiesta che il consiglio di classe aveva fatto al consiglio d'istituto di inasprirla. La presenza del programma tv “Le iene”, che aveva intervistato Antonio e suo padre, confermando, quanto sempre sostenuto dai ragazzi, che il business dietro alla vendita di merendine fosse di alcune decine di migliaia di euro ha ulteriormente inasprito gli animi. E ora si arriva addirittura a una manifestazione: “Staremo fuori dalla scuola per far sentire la nostra voce e far capire che anche al Pininfarina c'è chi rispetta le regole” concludono gli studenti. Nei giorni scorsi la fondazione Einaudi ha invitato anche il preside della scuola, Stefano Fava, alla premiazione di domani. “La sua storia ci ha colpito molto e mi sembra che la sua sia stata una scelta d'impresa applicata – aveva spiegato il presidente della fondazione, l'avvocato Giuseppe Benedetto, – Non credo che quella di questo giovane sia un'attività illecita, ho sentito parlare di nero, ma non mi pare sia questo da mettere in evidenza in questa storia”. In queste settimane la fondazione è rimasta in contatto constante con la famiglia del ragazzo e si è detta anche disponibile a confrontarsi con gli altri studenti della scuola per spiegare la scelta.
TGcom 24 del 13 dicembre 2016: Sospeso dalla scuola perché vende snack in nero e premiato da una Fondazione, Regione: "Sbagliato". Il giovane era stato sorpreso mentre spacciava merendine a un prezzo più basso delle macchinette. La Fondazione Einaudi lo ha premiato per spirito imprenditoriale. Fioccano le polemiche a Moncalieri. Presidio dei compagni davanti alla scuola per protesta. "E' comprensibile che la decisione della Fondazione Einaudi di assegnare una borsa di studio allo studente del Pininfarina, sospeso per aver venduto abusivamente merendine, susciti un certo sconcerto tra i suoi compagni". Lo ha affermato l'assessora all'Istruzione della Regione Piemonte, Gianna Pentenero. Il giovane era stato sospeso per aver creato uno spaccio di merendine, che comprava al supermercato e poi le rivendeva ai compagni a un prezzo più basso rispetto agli snack della scuola. La notizia del premio ha fatto scoppiare le polemiche. "Credo infatti sia sbagliato far passare il messaggio secondo il quale non rispettare le regole viene letto come un'innovativa capacità imprenditoriale - ha aggiunto l'assessora regionale -. Senza voler criminalizzare nessuno o esacerbare gli animi, penso tuttavia che punizioni o, al contrario, riconoscimenti finiscano per essere fini a se stessi se non aiutano il giovane a distinguere tra ciò che è lecito e ciò che non lo è". "Con la premiazione di oggi il rischio concreto è che l'unico insegnamento che il ragazzo trarrà da questa vicenda - ha concluso - è che chi è più furbo avrà sempre la strada spianata". La protesta: "Non ce l'abbiamo con Antonio, ma il premio è sbagliato" - "Non ce l'abbiamo con Antonio, ma riteniamo sbagliato attribuire un premio a lui e non ai tanti studenti meritevoli che ci sono anche nella nostra scuola", è la presa di posizione dei rappresentanti dell'istituto, che sono scesi in piazza per protestare contro la borsa di studio che ritengono ingiusta. "Staremo fuori dalla scuola, per far sentire le nostre ragioni", dicono annunciando il presidio.
“No alla borsa di studio ad Antonio”: un terzo degli studenti del “Pininfarina” di Moncalieri diserta le lezioni, scrive "Torino Oggi" martedì 13 dicembre 2016. La protesta, dicono gli studenti, non sarebbe contro Antonio ma contro quelli che hanno deciso di premiarlo. Ma la verità sarebbe assai diversa e la situazione potrebbe anche diventare davvero difficile da gestire, da parte delle autorità scolastica dell’Istituto. Prende le distanze anche l'assessora Pentenero. All’insegna di un emblematico "Le borse ai fuorilegge, no a chi legge", 500 dei 1.600 studenti che frequentano l'Istituto Pininfarina di Moncalieri non hanno preso parte alle lezioni, stamani per protestare contro la decisione della fondazione Einaudi di Roma di assegnare una borsa di studio ad Antonio, il loro compagno diciassettenne sorpreso per ben due volte a vendere abusivamente di merendine. La protesta, dicono gli studenti, non sarebbe contro Antonio ma contro quelli che hanno deciso di premiarlo. Ma la verità sarebbe assai diversa e la sensazione è che la situazione potrebbe anche diventare davvero difficile da gestire, da parte delle autorità scolastica dell’Istituto. Questa mattina, infatti, alcuno studenti avevano in mano il cellulare con alcuni messaggi non propriamente “accomodanti” (anzi) inviati dallo stesso Antonio via WhatsApp: "Io andrò in tv e anche quelli del Pininfarina là fuori a protestare come cog... con il freddo, tanto la borsa di studio la prendo comunque" oppure "Sono solo degli handicappati loro". Nel tritatutto delle polemiche è finita così la Fondazione Luigi Einaudi, dipinta come colei che premia l’illegalità e – dopo i messaggi inviati da Antonio, che nel frattempo ha denunciato di essere stato aggredito da un paio di dozzine di compagni più grandi nel corso dell’intervallo di ieri – anche l’arroganza e la strafottenza. La Fondazione ha un bel dire che il suo intento è quello di premiare “lo spirito d'iniziativa imprenditoriale del giovane ": i compagni di Antonio all’esterno del Pininfarina, hanno allestito un paio di bar "abusivi", per protesta contro quanto avvenuto all’interno della scuola ed il successivo “premio”. Il tutto sotto gli occhi discreti dei carabinieri di Moncalieri. Sulla stessa lunghezza d'onda degli studenti anche l'Assessora all'Istruzione della Regione Piemonte, Gianna Pentenero: "E’ comprensibile che la decisione della Fondazione Einaudi di assegnare una borsa di studio allo studente del Pininfarina, sospeso per aver venduto abusivamente merendine, susciti un certo sconcerto tra i suoi compagni. Credo infatti sia sbagliato far passare il messaggio secondo il quale non rispettare le regole viene letto come un’innovativa capacità imprenditoriale. Senza voler criminalizzare nessuno o esacerbare gli animi, penso tuttavia che punizioni o, al contrario, riconoscimenti finiscano per essere fini a se stessi se non aiutano il giovane a distinguere tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. Con la premiazione di oggi il rischio concreto è che l’unico insegnamento che il ragazzo trarrà da questa vicenda è che chi è più furbo avrà sempre la strada spianata".
Spacciatore di merendine tradito dai compagni: no al premio, studenti in piazza, scrive il 13 dicembre 2016 Manlio Grossi su "Skuola net". Sembra davvero senza fine la vicenda che coinvolge l’ormai noto spacciatore di merendine dell’Istituto Pininfarina di Moncalieri. Dopo esser finito su tutti i giornali per la sua attività illecita, aver ricevuto proposte di lavoro da più aziende ed esser stato sospeso per due settimane dal Consiglio d’Istituto, il giovane si trova oggi a Roma per ricevere una borsa di studio dalla fondazione Luigi Einaudi. Proprio questo premio ha scatenato le razione dei suoi compagni di classe, scesi in piazza per manifestare il loro dissenso. Secondo gli studenti del Pininfarina, il premio dato al loro compagno non è un messaggio corretto da dare, soprattutto nei confronti di chi rispetta le regole. Alla base del premio che la fondazione Luigi Einaudi ha voluto dare al giovane, il suo spirito di iniziativa che secondo l’istituto “Non è da perseguire ma da promuovere, in un Paese dove l’iniziativa privata è spesso ostacolata riteniamo che il ragazzo abbia invece messo in pratica molti degli insegnamenti di von Hayek e dello stesso Einaudi”. Dopo aver saputo delle polemiche nate al Pininfarina proprio per questo premio, la fondazione si è detta disponibile a confrontarsi con gli studenti per chiarire meglio e far comprendere la decisione presa. La vicenda dello spacciatore di merendine, sembra quindi destinata a continuare…
Nobel allo spacciatore di merendine: studente di Torino premiato con una borsa di studio. È polemica tra gli studenti del Pininfarina di Moncalieri per il premio conferito dalla Fondazione Luigi Einaudi di Roma, scrive Giulia Morici su "Pontile news" il 13-12-2016. Chissà se un giorno, tra i vari premi Nobel, spunterà fuori anche quello delle merendine. Per il momento, lo studente dell’Itis Pininfarina di Moncalieri, in provincia di Torino, dovrà accontentarsi di una bella borsa di studio conferita dalla Fondazione Luigi Einaudi di Roma. Andando indietro nel tempo, fino ad arrivare alla fine del novembre scorso, si ricorderà che il giovane in questione balzò agli onori della cronaca per il suo spirito imprenditoriale, grazie al quale diede vita a un traffico illecito di merendine all’interno dell’istituto scolastico. Un episodio che gli costò un provvedimento disciplinare, tanta notorietà e l’apprezzamento da parte di alcuni imprenditori; oggi a questa lista va aggiunta la borsa di studio conferitagli dalla Fondazione Einaudi. La creatività, in tempi di crisi, non è di certo una questione da sottovalutare, ma l’episodio di Moncalieri, ragionevolmente, ha suscitato non poche critiche le quali, oggi, hanno assunto i toni di una vera e propria protesta sfociata tra gli studenti del Pininfarina. A spingere la Fondazione a conferire la borsa di studio allo studente imprenditore, come è riportato sul sito web, vi è stata la volontà di promuovere lo spirito di iniziativa del giovane: «In un Paese dove l’iniziativa privata è spesso ostacolata riteniamo che il ragazzo abbia invece messo in pratica molti degli insegnamenti di von Hayek e dello stesso Einaudi», si legge nell’articolo. Proprio stamani, il giovane imprenditore di merendine e la sua famiglia sono stati ospiti nella sede di Roma dell'ente erogatore del premio, presso la quale al ragazzo è stata conferita la borsa di studio. Un’occasione, quella di oggi, «per condividere assieme alla Fondazione Einaudi una bella giornata all’insegna della libertà e della creatività dello spirito imprenditoriale». Eppure, messaggio peggiore non sarebbe potuto passare dall’episodio in questione. Viva il liberalismo, viva lo spirito imprenditoriale, potrebbero sostenere alcuni difensori di tale corrente di pensiero, ma un dubbio sorge spontaneo: dove la mettiamo la legalità? Seppur i guadagni del giovane imprenditore non siano stati da capogiro, la sua azione non è di certo da incoraggiare, in quanto si poggia su basi scorrette, ovvero quelle dell’illegalità. Dunque, come dar torto a una lecita osservazione di uno degli slogan comparsi durante la protesta degli studenti del Pininfarina, il quale recitava «cervelli in fuga, venditori di snack abusivi da Nobel»?
Torino, borsa di studio a studente che vende merendine a scuola. Protesta dei compagni: “Immeritata”. La decisione della Fondazione Einaudi di premiare il 17enne (già sospeso per 15 giorni) per il suo spirito imprenditoriale ha scatenato l'ira degli altri alunni Itis Pininfarina di Moncalieri. Assessore Regionale: "Messaggio sbagliato", scrive "Il Fatto Quotidiano" il 13 dicembre 2016. Merendine comprate al supermercato e rivendute ai compagni a un prezzo più basso rispetto agli snack della scuola. Per l’istituto, il comportamento del 17enne torinese è scorretto, tanto che il ragazzo è stato sospeso per 15 giorni. Di tutt’altro parere la Fondazione Einaudi, che ha voluto premiare lo studente con una borsa di studio per il suo “spirito imprenditoriale”. Una decisione che ha scatenato le proteste dei compagni di scuola che questa mattina, mentre a Roma il ragazzo riceveva il premio, hanno organizzato un presidio davanti all’Itis Pininfarina di Moncalieri, alle porte di Torino. “E’ un premio immeritato: un illecito in una scuola non è un motivo serio per dare una borsa di studio”, dice uno studente. “Hanno dato una borsa di studio a caso”, aggiunge un rappresentante dei circa 500 studenti presenti alla manifestazione. E ancora: “Al Pinin non vince il dieci ma gli evasori”, “borse di studio anche per noi”, “cervelli in fuga, venditori di snack abusivi da Nobel”, sono alcuni dei cartelli esposti davanti alla scuola dagli studenti, che hanno anche mostrato alcuni messaggi dello studente-imprenditore in cui li prenderebbe in giro. “Noi non ce l’abbiamo con il nostro compagno, sia chiaro – dicono i ragazzi – ma riteniamo che questa borsa di studio sia stata data a caso”. Interviene anche la Regione Piemonte, che si schiera con gli studenti. “E’ comprensibile che la decisione della Fondazione Einaudi di assegnare una borsa di studio allo studente del Pininfarina, sospeso per aver venduto abusivamente merendine, susciti un certo sconcerto tra i suoi compagni”, afferma in una nota l’assessora all’Istruzione della Regione Piemonte, Gianna Pentenero. “Credo infatti sia sbagliato far passare il messaggio secondo il quale non rispettare le regole viene letto come un’innovativa capacità imprenditoriale”, aggiunge Pentenero. E così la storia di Antonio, papà operaio, mamma casalinga e un grande fiuto per gli affari, da giorni fa discutere tra i banchi dell’Itis di Moncalieri, e non solo. “Ho iniziato per scherzo, i compagni mi ordinavano la roba perché risparmiavano”, ha raccontato lo studente che si era inventato anche una chat su Whatsapp per raccogliere le ordinazioni. “Pagavo gli snack 30 centesimi, li rivendevo a 50. Alla macchinetta costano un euro”, ha spiegato il giovane che con questa attività avrebbe intascato, secondo alcuni, qualche migliaia di euro. “Saranno stati cento euro al mese”, ha sostenuto invece il ragazzo, che sogna di aprire un locale da gestire con i genitori e la famiglia. L’iniziativa di Antonio non è passata inosservata al preside dell’istituto, che lo ha punito per quello che era diventata una vera e propria borsa nera delle merendine. Quindici giorni di sospensione, spalmati su tutto l’anno, da passare in un’associazione di volontariato, perché “le regole vanno rispettate”, è stata la spiegazione, e perché “non sappiamo da dove provenissero le merendine ed è un problema di sicurezza alimentare”. Eppure per la Fondazione Luigi Einaudi, che dal 1962 promuove la diffusione del pensiero liberale, quello spirito d’iniziativa non è da punire, ma da promuovere. Per questo motivo, presso la sua sede romana di largo dei Fiorentini, il presidente Giuseppe Benedetto ha conferito un assegno e dei libri dei maestri del liberismo. “Con questa iniziativa non vogliamo certo premiare una attività illegale, che anzi condanniamo, ma semplicemente lo spirito di iniziativa imprenditoriale del giovane studente”, spiega Benedetto, che alla cerimonia ha anche invitato la famiglia dello studente e il suo preside. “Non ce l’abbiamo con Antonio, ma riteniamo sbagliato attribuire un premio a lui e non ai tanti studenti meritevoli che ci sono anche nella nostra scuola”, è la presa di posizione dei rappresentanti dell’istituto.
Moncalieri, la Procura apre un'inchiesta sul venditore di merendine: verifica fiscale sugli incassi. "Palma t'ammazzo" e "Muori male": alcune delle minacce comparse davanti al "Pininfarina" contro lo studente venditore di merendine. L'indagine affidata ai carabinieri, decisa dopo le minacce di morte allo studente comparse davanti al Pininfarina, si allarga a tutti gli aspetti della vicenda, scrive Jacopo Ricca il 16 dicembre 2016 su "La Repubblica". Finisce in procura la vicenda del venditore abusivo di merendine del Pininfarina di Moncalieri. I carabinieri della cittadina alle porte di Torino stanno preparando un rapporto su quanto accaduto nella scuola del ragazzo, dalla vendita abusiva di snack fino alle minacce ricevute negli ultimi giorni dal giovane. Da tempo il preside è in contatto con le forze dell'ordine che stanno monitorando la situazione: ieri è stato ascoltato come persona informata sui fatti per la relazione che i militari invieranno in procura. Tra le testimonianze raccolte dai mezzi d'informazione ci sono anche quelle dei compagni del diciassettenne che attribuiscono al padre del ragazzo un ruolo attivo nella vendita di merendine. Accuse sempre respinte dalla sua famiglia, ma che potrebbero portate a un coinvolgimento del tribunale dei minori e dei servizi sociali. Altro filone è quello del mancato pagamento delle tasse sui ricavi del business abusivo di merendine: secondo alcuni il guadagno in tre anni avrebbe raggiunto 15mila euro, ma è stato lo stesso venditore a riconoscere che negli ultimi tempi l'incasso mensile aveva raggiunto quota 800. Per questo l'informativa dei carabinieri sarà inoltrata anche all'Agenzia dell'Entrate e agli uffici comunali componenti che valuteranno se ci siano gli estremi per un intervento del Fisco.
Lo Studente sospeso: ai pusher però non fanno niente, scrive Martedì 22 Novembre 2016 "Leggo". L'idea era semplice ma geniale: dal momento che snack e bibite venduti nei distributori automatici della scuola erano troppo costosi, studiava appositamente le offerte di tutti i supermercati della zona e acquistava i prodotti più richiesti negli esercizi commerciali con i prezzi migliori, per poi rivenderli a scuola. Un piccolo business nato per gioco, ma illegale, che è già costato caro ad uno studente 17enne di Moncalieri (Torino) e che ora rischia di costare carissimo. «Tutto era cominciato lo scorso anno, quando mi resi conto che era troppo far pagare agli studenti 1,50 euro un tè freddo che al supermercato costa non più di 35 centesimi, o merendine da 30 centesimi addirittura un euro. Così iniziai a organizzarmi e a fare la spesa per i miei compagni di classe» - racconta Antonio, lo studente che gestiva il mercato parallelo - «Non vendevo a prezzi eccessivamente maggiorati, i margini di guadagno erano bassi ma chi comprava poteva risparmiare moltissimo rispetto alle macchinette. Poi mi sorpresero e fui prima sospeso e poi bocciato. Per parecchio tempo mi fu anche impedito di uscire dalla classe durante la ricreazione». Con l'arrivo del nuovo anno scolastico, il ragazzo ha riprovato l'avventura imprenditoriale, ma è stato colto sul fatto e sospeso ancora una volta. Il padre lo difende: «L'anno scorso lo sgridai e decisi di punirlo, poi mi aveva detto che alcuni compagni di classe continuavano a chiedergli quel favore. D'altronde, questa volta è stato sorpreso con poche merendine e qualche bottiglietta di tè. Antonio è un bravo ragazzo, molto timido. Non beve, non fuma, non si droga e non ha piercing né tatuaggio». Il ragazzo però non vuole accettare una nuova sanzione da parte della scuola: «C'è chi in classe porta e vende droga, ma a loro non fanno nulla. Perché?». La scuola fa sapere che si tratta di una decisione doverosa: quegli snack e bibite potrebbero essere scaduti o mal conservati. Antonio però non ci sta: «Li compravo il giorno prima al supermercato, non potevano essere scaduti». Il preside dell'Itis Pininfarina, Stefano Fava, avrebbe però in mente una sanzione alternativa: «Merita di essere punito ma non di essere lasciato solo, potremmo anche inserirlo in un progetto legato all'imprenditorialità e ai giovani». Il ragazzo, comunque, non ha dubbi sulle aspirazioni future: «Mi piacerebbe aprire un'attività per aiutare la mia famiglia, ma papà fa l'operaio e abbiamo solo il suo reddito».
Torino, snack a scuola. Parla Antonio: "Io, venditore di merendine, sospendono me e non i pusher". Il ragazzo di 17 anni che nella sua classe di Moncalieri smerciava spezzafame e bevande ai compagni "Nell’istituto gira droga, ma a loro non fanno niente", scrive Stefano Parola su "La Repubblica" il 22 novembre 2016. Il vicepreside lo ha visto entrare con uno zaino enorme e si è insospettito. Ora rischia una sospensione ancora più lunga della precedente, anche se il preside Stefano Fava sta pensando a una soluzione "alternativa": "Proporrò al consiglio di classe di inserirlo in un progetto legato all'imprenditorialità. Vogliamo lavorare per il successo dello studente, non lo lasceremo indietro", assicura. Faccia da bravo ragazzo, papà operaio, mamma casalinga, una famiglia numerosa. Antonio racconta a Repubblica la sua versione dei fatti con il papà al suo fianco, che lo definisce "bravo, timido: non fuma, non si droga, non beve, non ha piercing né tatuaggi".
Partiamo dall'inizio: dopo aver letto quell'articolo, come le è venuto in mente di passare all'azione?
"Quando ho notato che gli snack a scuola erano cari. Un tè freddo da mezzo litro costa 1,50 euro, quando al supermercato va dai 29 ai 35 centesimi. Ho iniziato per scherzo: i compagni mi ordinavano la roba, perché risparmiavano".
E una merendina dopo l'altra, il mercato si è ingrandito. Dicono che lei avesse un bel giro d'affari, è così?
"Ma no, mi usciva a malapena una ricarica telefonica al mese. Durante il mio periodo di attività mi sono comprato un cellulare usato da 300 euro, niente di più. È vero che nel mio istituto ci sono 1.700 allievi, ma mica compravano tutti da me".
Quanti clienti aveva?
"Guardi, quando mi hanno beccato la settimana scorsa nello zaino avevo 20 snack, 10 lattine di bibite e 10 tè freddi".
Com'erano le tariffe?
"Pagavo gli snack 30 centesimi, li rivendevo a 50. Alla macchinetta, però, costano un euro. I margini erano minimi, faccia lei i conti. Saranno stati cento euro al mese".
A scuola si parla di cifre ben più alte.
"Girano tante voci, qualcuno è invidioso".
Dicono che fosse anche molto attento ai gusti dei suoi compagni.
"Avevamo una chat su Whatsapp e loro mi dicevano cosa avrebbero voluto. Io andavo al supermercato e compravo ciò che serviva".
E i compagni? Tutti soddisfatti?
"Erano tutti contenti perché risparmiavano. Ecco, la cosa che mi fa arrabbiare è che a scuola gira droga, ma a chi la porta non viene detto nulla. A me invece...".
Però anche vendere prodotti in nero è illegale. Infatti lo scorso anno lei era già stato sospeso, no?
"Per dieci giorni. In più, per 20 giorni sono stato piantonato in classe durante i due intervalli, delle 10 e delle 12, in modo che non potessi smerciare gli snack".
Il preside ha fatto notare che in ballo c'era anche una questione di sicurezza alimentare: come potevano essere sicuri che i suoi prodotti non fossero scaduti o mal conservati?
"Li compravo poco prima al supermercato, lì mica vendono le cose scadute".
Nonostante la punizione, la settimana scorsa ci è ricascato: perché?
"Tutti i miei compagni continuavano a chiedermi la roba".
E i suoi genitori non si sono accorti di nulla?
Qui interviene il papà di Antonio: "L'altra volta l'ho punito. Poi mi diceva che i suoi compagni continuavano a chiedergli di portare merendine e io pensavo fossero quattro, cinque, dieci compagni. Poi, appunto, quando l'hanno scoperto aveva una ventina di snack, parliamo di una classe".
Antonio, da grande cosa vorrebbe fare?
"Il mio sogno sarebbe aprire un locale per far lavorare la mia famiglia e i miei fratelli. Mi piace avere a che fare con le persone. Ma è un sogno irrealizzabile, papà fa l'operaio, abbiamo solo il suo reddito".
Spacciatore di merende, scrive il 23/11/2016 Massimo Gramellini su "La Stampa". Per capire l’aria di rivolta che si respira in giro, l’adolescente di Moncalieri punito dalla scuola perché vendeva merendine è già un eroe nazionale. Le notizie che lo riguardano sono tra le più condivise sul web e la sua storia di intraprendenza al di fuori delle regole, lungi dallo scandalizzare, affascina. Anche me. Di lui colpisce la capacità di mettersi nei panni degli altri per coglierne i bisogni e trasformarli in affari. Quanti manager strapagati la possiedono ancora? Ai vertici di troppe aziende pascolano individui che se ne infischiano dei clienti e pensano solo a fare carriera con le pubbliche relazioni. I veri affossatori del capitalismo sono loro. Il giovane Antonio osserva gli snack nelle macchinette della scuola e si accorge che costano il quintuplo rispetto al supermercato. Allora va a fare la spesa, riempie lo zaino di merendine e le rivende ai compagni a un prezzo lievemente superiore, ma pur sempre conveniente. L’abicì del commerciante di razza. Di lui piace la diversità che lo rende inviso al sistema, messo in crisi dal suo spirito di iniziativa. E il sistema reagisce, normalizzando il diverso in nome delle regole. Quelle stesse regole che i conformisti possono invece violare ogni volta che vogliono. Antonio dice: puniscono me e non il pusher che nello stesso corridoio smercia la droga. Per fortuna nel sistema c’è una crepa: un preside intelligente. Ribalta la decisione dei sottoposti di sospendere lo spacciatore di merendine e propone di affidargli un progetto imprenditoriale. Applausi (e tasse, ma in modica quantità).
Torino, tutti vogliono assumere il ragazzo che vende merendine. Ha fatto breccia tra gli imprenditori la storia dello studente del Pininfarina, scrivono Stefano Parola e Jacopo Ricca su "La Repubblica" il 23 novembre 2016. Dopo aver ricevuto tanta solidarietà da tutta Italia (ma pure molti rimbrotti e inviti a rispettare le regole, per il ragazzo che aveva creato un mercato alternativo e abusivo di merendine a basso costo nell'Istituto Pininfarina di Moncalieri sono arrivate pure delle offerte di lavoro. Andrea Visconti, co-fondatore di una startup torinese chiamata Sinba, dice di avere una proposta di assunzione pronta: "È strutturata in modo che Antonio possa finire la scuola", assicura l'imprenditore, che spiega di aver vissuto un'esperienza simile al liceo. "Abbiamo ricevuto investimenti importanti e li vogliamo utilizzare per puntare sui giovani talenti italiani: lui è esattamente il prototipo di talento che stiamo cercando" dice Visconti, che ha costruito la propria azienda attorno a un'applicazione per cellulari che consente di pagare senza fare code in cassa. Anche Michele Valentino, giornalista e co-proprietario di M&C Media, una piccola società di comunicazione, ha scritto al Pininfarina per offrire "uno stage formativo al fine di indirizzarne in modo positivo lo spirito di imprenditorialità, di creatività e di iniziativa". Insomma, la storia di Antonio (questo il nome di fantasia usato da Repubblica per raccontare la sua storia) ha fatto breccia nei cuori degli imprenditori, nonostante le regole infrante. Sarà il consiglio di classe di venerdì a stabilire quale punizione infliggergli, anche se il preside Stefano Fava sta pensando a una soluzione per veicolare l'intraprendenza del ragazzo nella giusta direzione. Su tutto il resto, il dirigente predica calma: "Ci sono arrivate proposte ma le valuteremo nei prossimi giorni, quando richiamerò chi ce le ha inviate. In questo momento voglio tutelare sia lo studente coinvolto sia i tanti allievi della mia scuola. Il mio obiettivo sono loro". Anche l'I3p, l'incubatore d'impresa del Politecnico di Torino, è pronto a dare una mano: "Con il Pininfarina abbiamo già avviato un progetto di avviamento all'imprenditorialità e siamo pronti a rafforzarlo ancora" assicura il presidente Marco Cantamessa. La storia di Antonio ha colpito pure lui: "Ci sono talenti che vanno stimolati, ovviamente vanno aiutati, ma mai e poi mai vanno considerati come malati". In fondo, dice il docente del Poli, "è normale che l'imprenditore sia un po' matto e che talvolta si ponga ai confini delle regole. Ovvio, le norme vanno rispettate. Ma non possiamo pensare di 'normalizzare i nostri ragazzi più intraprendenti". Domani Alberto Barberis, presidente del gruppo Giovani imprenditori dell'Unione industriale di Torino, incontrerà il preside del Pininfarina: "Vogliamo dare la nostra disponibilità per insegnare al ragazzo come diventare imprenditore attraverso un percorso di tutoraggio", spiega il numero uno degli industriali under 40. E commenta: "La sua intuizione è apprezzabile: ha individuato un bisogno e ha cercato di soddisfarlo. I modi invece non lo sono e probabilmente questo è dovuto al fatto che lo studente non è stato formato adeguatamente su cosa significhi essere imprenditore e avere un'attività. Per questo crediamo che anziché condannarlo sia meglio formarlo".
Truccati anche i loro concorsi. I magistrati si autoriformino, scrive Sergio Luciano su "ItaliaOggi". Numero 196 pag. 2 del 19/08/2016. Il Fatto Quotidiano ha coraggiosamente documentato, in un'ampia inchiesta ferragostana, le gravissime anomalie di alcuni concorsi pubblici, tra cui quello in magistratura. Fogli segnati con simboli concordati per rendere identificabile il lavoro dai correttori compiacenti pronti a inquinare il verdetto per assecondare le raccomandazioni: ecco il (frequente) peccato mortale. Ma, più in generale, nell'impostazione delle prove risalta in molti casi – non solo agli occhi degli esperti – la lacunosità dell'impostazione qualitativa, meramente nozionistica, che soprattutto in alcune professioni socialmente delicatissime come quella giudiziaria, può al massimo – quando va bene – accertare la preparazione dottrinale dei candidati ma neanche si propone di misurarne l'attitudine e l'approccio mentale a un lavoro di tanta responsabilità. Questo genere di evidenze dovrebbe far riflettere. E dovrebbe essere incrociato con l'altra, e ancor più grave, evidenza della sostanziale impunità che la casta giudiziaria si attribuisce attraverso l'autogoverno benevolo e autoassolutorio che pratica (si legga, al riguardo, il definitivo I magistrati, l'ultracasta, di Stefano Livadiotti). Ne consegue una constatazione ovvia, per quanto dolorosa, che nulla toglie al merito – a volte condotto fino all'eroismo – di singoli magistrati che sacrificano le loro giornate e a volte la loro vita per compiere al meglio un dovere esigentissimo: la constatazione è che di tanti singoli magistrati ci si può fidare, della magistratura come «sistema» no. Essa è parte del problema generale dell'inefficienza di una macchina statale e burocratica che rappresenta il vero male oscuro (mica tanto oscuro) dell'Azienda Italia. Pensare che questa magistratura, così com'è, sia la soluzione al problema generale della cattiva amministrazione è quantomeno ingenuo. I vizi del nostro pubblico impiego – talmente eclatanti da essere meritatamente tema costate della commedia all'italiana – ricorrono tutti anche nella «casta delle toghe»: clientelismo, furbettismo, «demeritocrazia», pressappochismo. Bisognerebbe riformare la magistratura: ma non può farlo nessuno, se non essa stessa. Chi ci prova dall'esterno – compreso Renzi – viene respinto con perdite e anatemi. E immediatamente comincia a temere, forse a torto forse no, rappresaglie. Allora che la magistratura si autoriformi. Piercamillo Davigo, il segretario dell'Associazione magistrati, è certo un magistrato duro, serio e severo. Non sarà contento che le nuove leve della categoria siano selezionate grazie ai geroglifici che segnano sui compiti per farli riconoscere dagli esaminatori imbroglioni.
Per Montesquieu (1748): «Chiunque abbia potere è portato a abusarne, egli arriva fin dove non trova limiti». Ci vuole «il potere che arresti il potere», scrive Serena Gana Cavallo su "ItaliaOggi". Numero 206 pag. 10 del 31/08/2016. Recentemente su queste pagine (ItaliaOggi del 20/08/2016) Sergio Luciano ha trattato il caso, rivelato da Il Fatto Quotidiano, dei concorsi per la magistratura vistosamente e diffusamente truccati. Luciano, invitando ad una riflessione sullo stato della Magistratura, ha invocato una riforma, o meglio una autoriforma, promossa magari da Piercamillo Davigo, di recente assurto al ruolo di Segretario della corrente sindacale (maggioritaria) Magistratura democratica. Condividendo molte delle affermazioni di Luciano, trovo tuttavia alquanto irrituale, se non impraticabile, l'idea che una sindacato, o meglio una corrente sindacale, possa e voglia procedere ad una «autoriforma», anche perché la bandiera, in genere di un sindacato, ma in particolare sventolata da sempre da Magistratura Democratica, è la difesa ad oltranza della categoria, di cui si paventano sempre, e da sempre si denunciano, biechi tentativi di instaurare un «limite all'autonomia dei magistrati», che scorrono per li rami dei governi, che si impersonificano in ogni tentativo di riforma, ma financo e addirittura, nella drammatica imposizione di una diminuzione delle ferie. La teoria della divisione dei poteri ha una storia lunga, ma il suo massimo teorizzatore, da cui traggono origine i moderni assetti costituzionali, fu Montesquieu che la enunciò nel 1748, con una premessa fondamentale e, nell'attualità del tema di cui trattiamo, da tenere molto a mente: «Chiunque abbia potere è portato ad abusarne: egli arriva sin dove non trova limiti. ( ) Perché non si possa abusare del potere occorre ( ) che il potere arresti il potere.» In Italia questo principio ha trovato, in senso non metaforico, una sua concretezza quando il potere giudiziario ha letteralmente arrestato il potere esecutivo, ma, sempre in Italia, il potere giudiziario, nel nome dell'autogoverno, non ha limite e men che meno chi (metaforicamente, ma anche materialmente) lo arresti. Montesquieu non lo aveva pensato così, anzi, essendo i principali poteri fondamentali quello legislativo (formato dati i tempi, da una parte di nobili ed una parte di rappresentanti del popolo), e quello esecutivo (all'epoca il monarca), avevano comunque entrambi una possibilità di interdizione reciproca. Il potere giudiziario veniva definito un «potere nullo», che avrebbe dovuto essere affidato a giudici «tratti temporaneamente dal popolo», in pratica con una legittimazione elettiva (come avviene ad esempio negli Usa) e non sempiterna. In definitiva si potrebbe dire che l'amministrazione della giustizia era considerata come un «servizio» al popolo, sotto il controllo del popolo. Andando avanti di qualche secolo, in un sistema democratico non vi dovrebbe poter essere alcuna forma di «potere» senza un mandato del popolo (nel nome del quale, così si racconta, si amministra la Giustizia in Italia) e men che meno senza un suo «periodico» controllo esterno, comunque lo si voglia configurare, al pari di quel che sono le periodiche elezioni per potere legislativo ed esecutivo. In pratica andrebbe abolito il mito del (buon)autogoverno, e ancor più l'auspicio di una autoriforma, concetto irrealistico, che implica che la Magistratura è una specie di zona extraterritoriale dove tutto il bene e tutto il male si sviscerano (a piccole dosi per il male) solo al suo interno. Dopo aver reso il sempre dovuto omaggio al merito di «singoli magistrati che sacrificano le loro giornate [per questo son pagati n.d.a] e, a volte la loro vita [come molte altre categorie n.d.a.] per compiere al meglio un dovere esigentissimo [come quello di un medico o di un pompiere n.d.a.]», Luciano giustamente conclude che la magistratura deve cambiare e che in essa «i vizi del nostro pubblico impiego ( ) ricorrono tutti nella casta delle toghe: clientelismo, furbettismo, «demeritocrazia», pressapochismo». Luciano dimentica purtroppo un altro «vizio» alquanto diffuso: la corruzione, ché in nessun altro modo può essere definita la prassi di un concorso fasullo e truccato, ciascuno col suo segnale o scarabocchio identificativo, e che arriva peraltro anche all'onore delle cronache quando la «corporazione» si rende conto che non c'è difesa possibile, salvo, dopo, trascinare interminabili processi che comportano l'estinzione di un bel po' di reati (come abbiamo già scritto in passato su queste pagine). Sulla deriva della magistratura, politica, funzionale e disciplinare, Luciano ricorda il bel libro di Liviadotti, «L'ultracasta», ma anche altri varrebbe la pena di citare «Io non avevo l'avvocato», Mondadori, 2015, di Mario Rossetti, scritto tra l'altro proprio con Sergio Luciano, Mondadori, 2015, e, tra i tanti di magistrati (che in genere scrivono dopo essere o essersi pensionati e questo la dice lunga sulle correnti sindacali della categoria) Piero Tony, «Io non posso tacere», Einaudi 2015, che tra l'altro indica alcune indispensabili modifiche per la riforma del sistema giudiziario, a partire da quella separazione delle carriere tra accusatori e giudicanti, che, esecrata dalla categoria, sarebbe un cambiamento che darebbe un minimo di decenza al processo accusatorio con accusa e difesa simmetriche e veramente autonome, senza ibride e pregiudizievoli (per la Giustizia ancor prima che per il cittadino) contiguità. Le ricette non mancano, è il medico che non si vede e che certo non può essere il malato.
L’Italia della de-meritocrazia, scrive Giulia Cortese l'11 febbraio 2016. Futuro Europa Il concetto di “meritocrazia” è molto utilizzato nel dibattito pubblico, non solo dai giornalisti, ma anche da imprenditori, politici, insegnanti e qualche volta anche dai sindacalisti. Il termine è certamente sfuggente, controverso e si presta a numerose polemiche. Secondo la definizione sul vocabolario on line Treccani, si tratta di una “concezione della società in base alla quale le responsabilità direttive, in particolar modo le cariche pubbliche, dovrebbero essere affidate ai più meritevoli”. Almeno in linea di principio, tutti concordano che in Italia di “meritocrazia” ve ne sia ben poca. Qualche anno fa, quando Paolo Casicci e Alberto Fiorillo hanno iniziato a scrivere “Scurriculum. Viaggio nell’Italia della demeritocrazia”, hanno trovato un mucchio di storie esemplari. Storie che dimostrano in modo inequivocabile come l’attuale sistema mortifichi i più bravi costringendoli spesso a regalare la loro intelligenza e la loro preparazione alle università, alle aziende, ai Paesi stranieri e premi, al contrario, quanti hanno in tasca la tessera “giusta” o il numero del “deputato giusto”, mentre le aziende statali o comunali vengono utilizzate come sfogatoio per i trombati o premio per i fedelissimi; o ancora per agganciare vistose signorine dai curricula evanescenti. Un sistema distorto ed autolesionista che infetta la società italiana, rendendola sempre più debole e incapace di stare al passo di un mondo che cambia a velocità immensamente superiore alla nostra. Segnalazioni, suggerimenti, nomi e cognomi detti al momento giusto e alla persona giusta. L’Italia dei raccomandati funziona così. Ma quante sono nel nostro Paese le persone che devono il proprio posto alla cosiddetta spintarella? Per rispondere all’annosa questione arriva uno studio dell’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori), condotto nel 2015 su 40mila individui fra i 18 e i 64 anni. A detta degli intervistati, la raccomandazione in Italia è ancora il canale principale per entrare nel mondo del lavoro: il 30,7 per cento dice infatti di avere ottenuto l’impiego attuale grazie ad un amico o un parente che ha fatto da “intermediario”. E le cifre salgono se si considerano soltanto i lavoratori più giovani, fra i quali ci sarebbero addirittura quattro raccomandati su dieci. Si può misurare la meritocrazia? Si può cercare di farlo costruendo un indicatore che sintetizza le varie dimensioni in cui si articola un sistema sociale ed economico orientato, appunto, alla promozione del merito. Rispetto agli altri paesi europei, i risultati dell’Italia sono sconfortanti. L’associazione no-profit Forum della Meritocrazia, con la collaborazione di un pool di ricercatori ed esperti dell’Università Cattolica di Milano, ha provato a misurare lo “stato del merito – come si legge nel rapporto finale dell’indagine – in un Paese”, utilizzando dati forniti da Commissione Europea, Ocse, The Economist, World Justice Project e altri enti, rapportando il tutto a livello europeo e cercando di capire come siamo messi in Italia. E tutte le impressioni sembrano essere confermate: siamo messi male. L’Italia si colloca al non-sorprendente ultimo posto della classifica sui dodici Paesi europei presi in esame; in cima, le prime quattro posizioni sono occupate da Finlandia, Danimarca, Norvegia e Svezia. E fin qui, nulla di strano. Il dato più interessante, però, riguarda i risultati rilevati nei singoli indicatori: nonostante nessuno riesca a fare peggio di noi, dati particolarmente negativi sono stati riscontrati alle voci trasparenza, libertà e regole (il rapporto è disponibile on-line). Che vogliate essere esterofili o no, i dati parlano chiaro: in Europa siamo indietro anni luce alle spalle di Paesi – con i quali coesistiamo nella stessa Unione – che avranno sì i loro problemi, di ordine diverso rispetto ai nostri, ma rappresentano baluardi di civiltà su punti che dovrebbero costituire le fondamenta di una società contemporanea giusta e, appunto, meritocratica. Marco Pacetti, Rettore del Politecnico di Ancona, la mette così: “Negli Stati Uniti la rete di conoscenze è sì importante, ma bisogna soprattutto essere in gamba. In Italia invece, nessuno crede che coloro che si affidano alla raccomandazione abbiano anche competenza e merito”. “È questa la differenza fra una lettera di raccomandazione e una “raccomandazione”, aggiunge Pacetti con riso beffardo. In America, “chi scrive la lettera di referenze, si prende la responsabilità di segnalare una persona preparata, non un idiota.” Dal punto di vista economico, la carenza di merito si associa all’idea di un sistema poco efficiente, perché non consente un’allocazione ottimale delle risorse, cioè di far giungere nel posto giusto chi può svolgere meglio quel ruolo. Tutto ciò finisce per comprimere la mobilità sociale, come molti studi documentano, facendo dipendere gli esiti individuali più da luogo e famiglia di origine che dall’impegno personale, competenze e capacità. “All’estero la raccomandazione ha una connotazione positiva – afferma Alessandro Fusacchia presidente dell’associazione RENA – se qualcuno decide di sponsorizzarti lo fa perché sei bravo, perché crede in te, e ci mette la faccia insieme a te. In Italia è tutto l’opposto: ci si sente più forti se si riesce a piazzare uno che bravo non è”. Il “benefattore”, poi, lavora nell’ombra, contribuendo ad alimentare un sistema che è parte della cultura del Bel Paese. “Un problema che non è legato soltanto alla classe politica – conclude Fusacchia – perché in Italia alle raccomandazioni si ricorre per tutto, dal posto di lavoro al permesso per il parcheggio sotto casa”. C’è qualcosa che i politici, e in particolare il nuovo governo, dovrebbero fare? “Semplicemente cominciare a dare l’esempio, per avviare un cambiamento che dovrebbe coinvolgere gradualmente l’intera società civile”.
Meritocrazia e demeritocrazia di Eva Zenith. Una società non può essere meritocratica senza essere anche demeritocratica. Non possiamo mettere al centro di una cultura il merito, cioè il talento e l'impegno, se non mettiamo al centro anche il demerito, cioè l'incompetenza e i fallimenti. L'Italia è un Paese dove il merito viene soffocato dall'invidia, dalla svalutazione (chi studia molto è un secchione, chi lavora molto è uno stakanovista) e dalla cultura della clientela. Allo stesso tempo è un Paese dove il demerito viene premiato. Se le cose vanno bene, il merito non è di qualcuno, è di tutti. Se le cose vanno male, il demerito non è di nessuno, oppure di un bel capro espiatorio. Per essere responsabile di qualcosa, in Italia, devono trovarti mentre svuoti la cassa o uccidi qualcuno: e non è detto che anche allora tu non possa cavartela. Siamo un Paese per niente meritocratico ma molto comprensivo! In una società del merito e del demerito, i ricercatori che hanno sbagliato tutti i sondaggi delle ultime elezioni dovrebbero sparire dai mass media. Invece no. In una società del merito e del demerito, un amministratore pubblico che dopo un mandato lascia l'organizzazione in condizioni peggiori di come l'ha trovata, dovrebbe essere cancellato dalla lista degli amministratori pubblici. Invece no: noi lo confermiamo o lo promuoviamo. In una società del merito e del demerito, un politico che perde le elezioni dovrebbe essere cacciato: invece no. Vincitori e vinti si alternano restando abbarbicati alle loro sedie per vent'anni o più. In una società del merito e del demerito, un economista che sbaglia clamorosamente una previsione dovrebbe essere punito come un medico che sbaglia una diagnosi. In Italia no: i nostri economisti sostengono un'idea e il suo contrario, fanno previsioni regolarmente errate, propongono ricette fallimentari ma nessuno li priva mai di un posto da consulente ministeriale, da saggio o da Presidente del Consiglio. Unanimemente, tutti dichiarano che la legge elettorale in vigore è orribile. Ma quelli che hanno ideato e votato quella legge sono ancora sulla scena a blaterare delle future leggi elettorali. In un Paese meritocratico, i firmatari di quella legge sarebbero messi in una lista di allontanamento perenne dalla politica. Unanimemente, tutti attribuiscono la crisi dell'euro all'assenza di una Banca centrale che possa battere moneta. Lo dicono anche quelli che hanno voluto questo euro. Non sapevano allora che l'assenza di un'autorità monetaria avrebbe messo tutti nei guai? In un Paese meritocratico, i firmatari di quella legge sarebbero messi in una lista di allontanamento perenne dalla politica. Unanimemente, tutti odiano Equitalia e la considerano una sciagura. Il fatto è che Equitalia non è stata data alla luce e regolata da un folletto diabolico. La sua protervia, la sua crudeltà, i suoi interessi "usurari", i suoi modi da Kgb non sono (solo) il frutto di burocrati sadici: sono stabiliti da leggi, norme e regolamenti prodotti da ministri, governi e parlamentari con nomi e cognomi. In un Paese meritocratico, i firmatari di quelle leggi, norme e regolamenti sarebbero messi in una lista di allontanamento perenne dalla politica. Quando trova un finto invalido, un Paese che dà valore al merito, non solo punisce lui, ma anche il medico e i funzionari che hanno firmato la pratica, e magari il responsabile dell'INPS locale che non si è accorto di niente. Noi siamo così disinteressati al demerito che non divulghiamo nemmeno i nomi di tutti questi figuri. I mass media non si fanno nessun problema a mettere in piazza le vite private di donne stuprate e ammazzate, ma mai sentirete da loro il nome di un medico che ha creato 300 o 400 finti invalidi. Non è elegante. Quando trova dipendenti pubblici che fingono di stare al lavoro mentre vanno a fare la spesa, o a giocare con le slot machines, un Paese che dà valore al merito, non si limita a punire loro. Punisce anche i loro capi/reparto o capi/ufficio che non si accorgono di avere collaboratori presenti ma assenti. E punisce anche i dirigenti, strapagati per non dirigere alcunchè; e magari punisce anche gli amministratori, per manifesta incapacità. Invece no: non sarebbe rispettoso. Tutto finisce con un rimbrotto e una risata, alla faccia dei dipendenti pubblici che stanno sempre al loro posto, dei capi che li controllano davvero, dei dirigenti che dirigono sul serio, e degli amministratori capaci. D'altronde perchè i capi, i dirigenti e gli amministratori dovrebbero fare il loro mestiere sul serio visto che le loro carriere non dipendono dai meriti ma dalle affiliazioni? Quanti docenti universitari sono stati cacciati dalle loro cattedre per aver palesemente truccato un concorso? Quanti magistrati, avvocati e notai hanno pagato per i loro mostruosi errori giudiziari o legali? Quanti medici hanno dovuto cambiare lavoro dopo i 5/6 morti che non hanno salvato? Quanti segretari comunali sono stati puniti per gli appalti truccati? Quanti generali e capi della polizia hanno perso il posto per aver consentito il nonnismo fra le truppe o i pestaggi dei dimostranti? Quanti sindacalisti hanno pagato per aver taciuto sulle illegalità dell'impresa? I politici che si sono fatti derubare dai loro tesorieri, sono stati puniti per connivenza o manifesta stupidità? E ancora si presentano per chiedere di amministrare l'Italia? Insomma, è chiaro a tutti ormai che le prediche dei tromboni del regime sul necessario riconoscimento dei meriti (specie dei giovani) e delle responsabilità (specie della casta), sono un esercizio di manipolazione. L'Italia è un Paese fondato sul demerito e se ne vanta. Volete la meritocrazia? Emigrate, please!
Demeritocrazia. Perchè l’Italia merita tutti i problemi che ha, scrive il 17 gennaio 2012 "Libertiamo". Siamo così ricchi di autoironia, e probabilmente anche di scarso pudore, da aver intitolato “I raccomandati” un talent show, ovvero una gara che premia il talento, e quindi il merito. Nonostante questo, è impossibile fare a meno di notare certe facce e certi corpi deambulanti tra Montecitorio e i palazzi della Regione, i quali confermano che l’Italia è un paese fondato sulla spintarella. Come quella piuttosto evidente e vigorosa che ha sbalzato l’ormai leggendaria Nicole Minetti dalle scenette di Colorado Café ai piani alti del Pirellone. Viene in mente a proposito anche Renzo Bossi, il primogenito del leader del Carroccio Umberto Bossi, noto anche come “il Trota”. Questo perché, ci conferma suo padre, gli manca il fosforo per essere un delfino. Qualche sospetto, in effetti, verrebbe anche noi, ma non ci stupisce nemmeno che il cognome abbia favorito Renzo nel passaggio da ripetente di professione a Consigliere Regionale. Che dire, poi, degli svarioni grammaticali della deputata pidiellina Micaela Biancofiore? E’ l’ennesima conferma del fatto che nel cosiddetto “belpaese” contano ben poco la Conoscenza, anche dell’italiano, rispetto alle conoscenze, specie se berlusconiane. Arcore e Palazzo Grazioli, infatti, si sono rivelati ottimi uffici di collocamento: oltre al lavoro, in molti casi hanno garantito anche vitto e alloggio, in una strada di Milano divenuta ormai celebre: Via Olgettina. Una volta si usava spartirsi le poltrone dei Tg, e il refrain era: “assumiamo sette giornalisti: tre democristiani, due socialisti, un comunista e uno bravo”. Di questi tempi vengono lottizzate anche le fiction televisive. Abbiamo ogni buona ragione per dire che si è creata una sorta di Costituzione orale della Seconda Repubblica, che si è manifestata, ad esempio, nelle telefonate dell’ex premier Silvio Berlusconi all’ex dirigente Rai Agostino Saccà. Telefonate che avevano come obiettivo quello di sistemare in tv, ragazze di dubbia serietà come Elena Russo, Camilla Ferranti e Eleonora Giaggioli. E’ una novità di questi tempi, questo salto di qualità nella raccomandazione. La “spintarella”, di per sé, non è niente di nuovo sotto il sole, si potrebbe commentare. Il ricorso a questa arte tutta italica è uno sport nazionale, che come abbiamo visto viene festeggiato anche dalla stessa Tv e dai suoi programmi. Si tratta di una condotta, una delle tante, che ci distingue nettamente da tutti gli altri paesi europei. Certo, qualcuno potrebbe ribattere facilmente che è da moralisti indignarsi se l’Italia mantiene in vita un costume tradizionale, da furbetti è vero, ma tutto sommato utile a sopperire a delle grosse mancanze strutturali. Il fatto è che la furbizia italica e la logica che ha permesso e favorito il sistema del clientelismo, oltre a consolidare in noi italiani un’attitudine di scarso senso civico e di rigore morale, oltre a farci dimenticare principi quali giustizia e meritocrazia, sono in realtà strumenti obsoleti e inadeguati in uno scenario sociale e soprattutto economico che è mutato profondamente negli ultimi decenni. L’aspetto più drammatico dello scenario descritto finora è che la demeritocrazia non solo offende l’etica e la voglia di fare delle persone oneste e magari anche di talento, ma strozza anche l’economia. Quella italiana, non per niente, mostra di essere in frenata e di avere una grossa difficoltà di ripresa, mentre paesi dinamici e meritocratici come la Germania sono cresciuti al 5% l’anno anche in tempi di profonda crisi. A proposito di questo viene in mente una citazione dell’economista Tito Boeri: “Tutti battono sul tasto della morale, io vorrei concentrarmi su quanto ci costa ignorarla. I danni economici sono evidenti: la demeritocrazia inibisce la crescita, frustra la produttività, manda in fuga i cervelli”. Le statistiche, infatti, ce lo confermano: sono 6 mila i lavoratori italiani altamente qualificati che ogni anno scappano verso i civili Stati Uniti. Se 20 anni fa a emigrare erano soprattutto le persone con i gradi minori di istruzione, oggi l’emigrante tipo è il laureato con i voti migliori. La cosa peggiore è che, una volta espatriati, questi giovani preferiscono rimanere nel paese dove si sono trasferiti, perché lì viene maggiormente premiato il loro talento e si sentono maggiormente sostenuti, hanno maggiori chance di fare carriera e stipendi più alti. Vi è poi il problema della “stagnazione” delle università italiane, che sono notoriamente prigioniere dei baroni, nonché uno degli habitat naturali della demeritocrazia. A descrivere in modo efficace la situazione in cui riversano i nostri atenei è una frase di Indro Montanelli: “Più che sui generis, i concorsi universitari sono sui cognatis”. La competenza non conta nulla, il curriculum vitae ancora di meno, conta solo il sangue, nel senso di parentela. Qualche esempio? Alla Sapienza di Roma, il magnifico rettore è Luigi Frati, che qualcuno dava in odore di ministero (alla Sanità) nel governo Monti. Nella Facoltà di Medicina di cui è stato preside, tra l’altro, hanno ottenuto una cattedra la moglie Luciana, laureata in lettere, e il figlio Giacomo, ordinario a “soli” 36 anni (traguardo impossibile per i comuni mortali accademici italiani). A poca distanza, a Roma Due, è professore straordinario di Bioetica la figlia Paola, giurista. Viene difficile pensare che si tratti di pure coincidenze. Scendendo verso la parte bassa dello stivale, a Palermo, nel dipartimento di Economia dei sistemi agroforestali, 10 docenti su 19 sono imparentati tra loro. A Bari, poi, ci sono otto Massari, tutti consanguinei. Non si tratta della solita questione di arretratezza del meridione, e ne è prova il fatto che alla Statale di Milano i casi accertati di parentela sono 54, mentre alla facoltà di Medicina di Udine ci sono quattro Bresarola: il capostipite Fabrizio, due figli, di cui uno laureato in filosofia, e una nuora. “Parentopoli” non è nemmeno l’unica fonte di collocamento, perché a dare la “spintarella” ci pensa anche la massoneria e più in generale, le lobby (“bianche”, “rosse”, “nere” e Comunione e Liberazione). A questo punto, forse sarebbe anche il caso di abolire i concorsi, visto che in questo stato di cose non hanno alcuna credibilità. Costano 40 milioni di euro all’anno, tra l’altro, e l’esito è già prestabilito. Chi non sta alle regole, è fuori. Si tratta di un sistema tanto chiacchierato e oggetto di generale indignazione, ma che fino a oggi tutti hanno accettato. L’importante è cercare di fare meno nomi possibili, funziona così l’università italiana. Studenti, dottorandi e ricercatori, magari dopo una vita di studio, esperienze all’estero e pubblicazioni in riviste autorevoli, aspettano il loro turno, ma non è detto che ce la facciano. Per questo sono nati centinaia di blog e siti internet che danno voce alla loro frustrazione: per difendere l’università pubblica e la voglia di un futuro più onesto e più giusto. Vi è lo stesso identico andazzo anche negli ospedali, dove sono stati praticamente aboliti i concorsi per diventare primari, visto che a essere selezionati sono quasi sempre quelli con la tessera politica giusta, a scapito dei più meritevoli. Ne consegue che sono aumentate le denunce per mala sanità e gli ospedali sono a volte costretti a pagare dei risarcimenti ai pazienti-vittime. C’è solo da sperare che si smetta di promuovere gli incompetenti, visto che, oltretutto, è poco conveniente da un punto di vista economico. L’etica e la reputazione, si sa, non sono certo delle priorità. Di demeritocrazia si può anche morire professionalmente, almeno in Italia, anche nei casi di persone che, se fossero altrove, avrebbero un percorso decisamente più immediato, ma solo grazie alla loro preparazione e talento, e non certo per le conoscenze. Siamo arrivati a un punto, dunque, in cui le carriere si trasmettono per via ereditaria, come le monarchie o le malattie genetiche? Una risposta ce la dà una ricerca del think thank Italia Futura, secondo cui il 44% degli architetti è figlio di architetti, cifra che è leggermente inferiore per avvocati e notai (42%) e farmacisti (40%). Eppure, la meritocrazia è un tema che piace a un buon numero di italiani. Ne stanno parlando i blog, si fanno dibattiti in radio e in Tv, il tema è stato abbordato perfino dal Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano. L’esigenza di meritocrazia in qualche modo è “rispecchiata” dal nuovo governo di professori, tutti esperti dai capelli grigi. Nel nuovo governo sono numerose le donne ad avere ruoli di prestigio, ma fortunatamente nessuna di esse è arrivata alla politica tramite concorsi di bellezza, o ha un passato da velina. Per fortuna c’è anche chi sceglie la via del rigore e del duro lavoro, del farsi strada con le proprie forze e senza scorciatoie. Vi è un gruppo di ragazzi che vuole cambiare in meglio l’Italia, a colpi di talento e di tenacia: sono i giovani che hanno aderito al think thank “Forum della meritocrazia”, presieduto dall’imprenditore Arturo Artom, che ha come obiettivo principale quello di iniettare entusiasmo tra i giovani e di essere per loro un punto di riferimento. Vuole essere il mezzo e il messaggio, come diceva Marshall Mc Luhan. L’Italia ha bisogno che si diffonda la cultura dell’esempio, contro le mele marce che rovinano il cesto e fanno sentire sconfitti. Anche per questo, alle prossime elezioni il “Forum della meritocrazia” farà una certificazione di tutti i candidati. La cosa sarà senz’altro divertente anche per noi. Per quanto riguarda la terza repubblica, l’Italia post spread e si spera anche post raccomandazioni, possiamo solo augurarci che si venga a creare, una volta per tutte, un mantra contro caste, raccomandazioni, listini bloccati in politica, nepotismo e tutte quelle opacità che trovano spazio negli ospedali, nelle università, nell’impresa e nel palazzi del governo, dove i principali criteri di assunzione sono stati finora decisamente poco nobili e per nulla meritocratici. Se si vuole cambiare veramente le cose nel nostro Paese, sarà importante che, a poco a poco, coloro che vogliono “giocare pulito” facciano rete, radicandosi a poco a poco su tutta la penisola. Perché, la cosa è certa, l’Italia ha bisogno soprattutto di persone come loro.
“Se perdo al referendum non mi vedrete più”. Tutte le promesse non mantenute di Renzi e Pd. Siccome le parole sono importanti è tempo di pubblicare la raccolta definitiva di tutte le volte in cui l'ex premier, Maria Elena Boschi e i colleghi democratici hanno promesso di abbandonare definitivamente governo e vita politica in caso di vittoria del No al referendum, scrive Wil Nonleggerlo il 14 dicembre 2016 su "L'Espresso". “Se vince il No finisce la mia storia politica”, “cambio mestiere e non mi vedrete più”, “con che faccia potrei restare?”, “il Pd si troverà un altro segretario”. E dai democratici, in coro: “non avremmo più autorevolezza, impossibile restare attaccati alla poltrona”, “lascerei pure io”, “e pure io!”. Oggi Matteo Renzi è saldamente ancorato alla guida del Partito Democratico, il #governofotocopia di Paolo Gentiloni ha ottenuto la fiducia e Maria Elena Boschi è rientrata immediatamente a Palazzo Chigi nonostante il fallimento referendario e la promessa di andarsene in caso di sconfitta. Il No ha stravinto, sul resto giudicate voi.
- MATTEO RENZI, DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La fine dell'esperienza politica (Consiglio dei Ministri, 12 marzo 2014): "Lo dico qui, prendendomene la responsabilità, che se non riesco a superare il bicameralismo perfetto non considero chiusa l'esperienza del governo, considero chiusa la mia esperienza politica".
Fine (Tg2, 30 marzo 2014): "O facciamo le riforme, o non ha senso che io stia al governo. Se non passa la riforma del Senato, finisce la mia storia politica".
Del tutto evidente (Conferenza stampa di fine anno, 29 dicembre 2015): "È del tutto evidente che se perdo il referendum costituzionale, considero fallita la mia esperienza in politica".
Precise responsabilità (Repubblica.tv, 12 gennaio 2016): "Intendo assumermi precise responsabilità. È un gesto di coraggio e dignità. Se perdo il referendum io non solo vado a casa, ma smetto di far politica".
La dignità (Aula del Senato, 20 gennaio 2016): "Lo ripeto anche qui: se perdessi il referendum considererei conclusa la mia esperienza politica. Credo profondamente nel valore della dignità della cosa pubblica".
La borsettina (Quinta Colonna, 25 gennaio 2016): "Io non sono come gli altri, se gli italiani diranno No, prendo la borsettina e torno a casa".
E le vostre idee? (Scuola di formazione del Pd, 7 febbraio 2016): "Se vince il No prendo atto del fatto che ho perso. Dite che sto attaccato alla poltrona? Tirate fuori le vostre idee, ecco la mia poltrona".
The end (Scuola di formazione del Pd, 12 marzo 2016): "Se perdiamo il referendum è doveroso trarne conseguenze, è sacrosanto non solo che il governo vada a casa, ma che io consideri terminata la mia esperienza politica".
Non mi vedrete più (Congresso dei Giovani Democratici, 20 marzo 2016): "Io ho già la mia clessidra girata. Se mi va male, se perdo la sfida della credibilità o il referendum del 2016, vado via subito e non mi vedete più".
Se perdi una sfida epocale (Durante il #matteorisponde, Facebook, 28 aprile 2016): "Sto personalizzando? No, se perdi una sfida epocale che fai? Racconti che i cittadini hanno sbagliato? No, hai sbagliato tu".
A casa (Ansa, 2 maggio 2016): "La rottamazione non vale solo quando si voleva noi. Se non riesco vado a casa".
Vinavil (Rtl 102.5, 4 maggio 2016): "Non sono come i vecchi politici che si mettono il vinavil e che invece di lavorare restano attaccati alla poltrone".
Smetto proprio, con che faccia rimango? (Che tempo che fa, 8 maggio 2016): "Non è personalizzazione, ma serietà. Se io perdo, con che faccia rimango? Ma non è che vado a casa, smetto proprio di fare politica".
Fine carriera (Radio Capital, 11 maggio 2016): "Se non passa il referendum la mia carriera politica finisce qui. Vado a fare altro".
Destinazione paradiso (Ansa, 11 maggio 2016): "Non sto in paradiso a dispetto dei santi. Se perdo, non finisce solo il governo: finisce la mia carriera come politico e vado a fare altro".
Libero cittadino (Porta a Porta, Rai 1, 12 maggio 2016): "Se vince il No, mi dimetto il giorno dopo e torno a fare il libero cittadino".
Personalizzazione? (L’Eco di Bergamo, 21 maggio 2016): "Se perdiamo il referendum, vado a casa. Questa è personalizzazione? No. Questa è serietà".
Quel galantuomo di Napolitano (Comizio a Bergamo, 21 maggio 2016): "Non sono andato a palazzo Chigi dopo aver vinto un concorso, mi ci ha messo quel galantuomo di Napolitano con l'impegno di fare le riforme. Se non ottengo questo risultato, l'Italia continuerà a essere il Paese degli inciuci e del Parlamento più costoso del mondo. Se l'Italia vuole questo sistema, è giusto che lo faccia senza di me".
Tutti via in caso di sconfitta (In mezz'ora, Rai 3, 22 maggio 2016): "Se il referendum dovesse andare male non continueremmo il nostro progetto politico. Il nostro piano B è che verranno altri e noi andremo via". (Nel governo Gentiloni tutti confermati, tranne il ministro Giannini).
Via pure dalla segreteria Pd (Virus, Rai 2, 1 giugno 2016): "Se perdo il referendum troveranno un altro premier e un altro segretario".
Cambierò mestiere (Il Foglio, 2 giugno 2016): "Io sono fiducioso che vinceremo bene. Ma se il referendum andrà male continuerò a seguire la politica come cittadino libero e informato, ma cambierò mestiere. Vuole uno slogan semplice? O cambio l'Italia o cambio mestiere".
Pollo da batteria (eNews, 29 giugno 2016): "Secondo voi io posso diventare un pollo da batteria che perde e fa finta di nulla?".
È stato gli altri (La Repubblica, 31 luglio 2016): "Personalizzare questo referendum contro di me è il desiderio delle opposizioni, non il mio".
Governicchi mai (Ansa, 17 novembre 2016): "Io non posso essere quello che si mette d’accordo con gli altri partiti per fare un governo di scopo o un governicchio".
Curriculum (#matteorisponde, Facebook, 21 novembre 2016): "Non sto qui aggrappato al mantenimento di una carriera. Non ho niente da aggiungere al curriculum vitae".
Il boy scout (Matrix, Canale 5, 30 novembre 2016): "Io sono un boy scout, non voglio diventare come gli altri, il mio lavoro deve servire a cambiare il paese. Se vogliono un bell'inciucione, se lo facciano da soli...".
No agli accordicchi (Comizio ad Ancona, 30 novembre 2016): "Non sono quello che fa accordicchi alle spalle dei cittadini. Per questo possono chiamare qualcun altro".
I pop-corn (Repubblica.tv, 30 novembre 2016): "Se gli italiani dicono No, preparo i pop-corn per vedere in tv i dibattiti sulla casta".
- LE CONFERME DEL PD
L'allora ministro Maria Elena Boschi a Otto e Mezzo, La7, 27 aprile 2016: "Se un governo ha avuto il mandato da Napolitano a fare le riforme e queste poi non passano, è normale che ne prenda atto".
Il ministro Dario Franceschini a Repubblica, 29 maggio: "Il ritiro in caso di vittoria del No non è una minaccia, a me sembra una con-sta-ta-zio-ne. Questo governo nasce per fare le riforme. Se le riforme non si fanno chiude bottega il governo e chiude anche la legislatura, mi pare ovvio". (Franceschini è stato confermato al ministero dei Beni Culturali dal nuovo premier Gentiloni, e la legislatura prosegue).
Valeria Fedeli, da vicepresidente del Senato, a L'aria che tira, La7, 4 dicembre 2016: "Se vince il No il giorno dopo bisogna prenderne atto, non possiamo andare avanti perché non avremmo più l'autorevolezza. Sarebbe giusto rimettere il mandato da parte del premier ma anche da parte dei parlamentari: tolgo l'alibi a chi pensa 'tanto stiamo lì fino al 2018', perché pensano alla propria sedia. Io non penso alla mia sedia". (Valeria Fedeli è appena stata nominata Ministro dell'Istruzione del Governo Gentiloni).
Maria Elena Boschi a In mezz'ora, Rai 3, 22 maggio 2016: "Noi vinceremo, quindi questo problema non si porrà. Ma comunque sì, noi siamo molto serie e se Renzi perde anch'io lascio la politica, perché è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Come potremmo restare e far finta di niente?". (Maria Elena Boschi è appena stata nominata sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entrando così di fatto nel nuovo Governo Gentiloni).
Maurizio Crozza nel paese delle meraviglie, ultima puntata su La7 con il saluto finale di Maurizio, scrive Fabio Traversa venerdì 16 dicembre 2016. La Finocchiaro era relatrice della riforma istituzionale, poi bocciata al referendum, "e ora è ministro delle Riforme. Allora vale tutto!". E la Madia? "Aveva presentato la riforma della P.A., la Consulta gliel'ha stroncata, e ora lei è di nuovo ministro della P.A. In Italia vige la demeritocrazia!". Crozza ne ha anche per la neo-ministra dell'Istruzione che non sarebbe laureata: "E' solo diplomata, ma non ha il diploma di maturità bensì di tre anni di magistrali, l'hanno nominata ministro alla scuola per fargliela finire!". Crozza si è già affezionato al ministro degli Esteri Alfano: "Conosco più io la biologia molecolare che lui l'inglese". E viene mostrato il filmato mentre "parla" a Bruxelles in quella lingua con una rappresentante svedese. Crozza, ovviamente, non ha pietà...
Fedeli, un ministro all’istruzione senza laurea, scrive il 14/12/2016 La Nuova BQ. Si viene a scoprire che il neo-ministro all’istruzione Valeria Fedeli, dicastero che ricomprende anche l’Università, non è nemmeno laureata. Sul suo sito si legge che ha ottenuto un «diploma di laurea in Scienze sociali» conseguito presso la Scuola per assistenti sociali Unsas di Milano. Ma all’epoca non esisteva simile laurea. Il titolo da lei ottenuto è un semplice diploma post-maturità. Lei ribatte che oggi sarebbe considerata una laurea. Ma c’è una bella differenza tra un diploma che potrebbe essere omologato ad una laurea e l’effettiva equiparazione che nel caso della Fedeli non è avvenuta. Mario Adinolfi interviene sul caso: «Valeria Fedeli mente sul proprio titolo di studio, niente male per un neoministro dell’Istruzione. Dichiara di essere laureata in Scienze sociali, in realtà ha solo ottenuto il diploma alla Scuola per assistenti sociali Unsass. Complimenti Gentiloni: a dirigere scuola e università in Italia mettiamo non solo una che non è laureata, ma una che spaccia in Laurea in Scienze sociali un semplice diploma della scuola per assistenti sociali». E così conclude: “La spacciatrice di menzogne sul gender è abituata a dire bugie. Il problema non è neanche che non è laureata, ma che mente spudoratamente. Per un atto del genere in qualsiasi Paese del mondo dovrebbe dimettersi seduta stante o essere costretta a farlo”. E così salgono a quattro i ministri senza laurea nel presente governo: Valeria Fedeli, Beatrice Lorenzin, Andrea Orlando e Giuliano Poletti.
Fedeli: «Il diploma di laurea? Una leggerezza, ma troppa aggressività». La ministra all’Istruzione e il curriculum corretto: «Se volevo truffare non avrei mai messo diploma di laurea ma solo laurea». Dal premier Gentiloni «piena fiducia», scrive Fiorenza Sarzanini il 14 dicembre 2016 su "Il Corriere della sera". Al termine di un’altra giornata segnata dagli attacchi delle opposizioni e dall’ironia sui social network, Valeria Fedeli, neoministro all’Istruzione, si rifugia nel suo nuovo ufficio. E si sfoga. «Perché posso aver commesso una leggerezza, ma finire sotto accusa in questo modo davvero non me lo sarei mai aspettato». È affranta, ma a mollare non ha mai pensato. «Scherziamo? Io sono una persona seria. Se volevo mentire o truffare non avrei mai messo nel mio curriculum diploma di laurea, ma avrei scritto laurea e basta». Il caso è fin troppo noto. Denunciato con un messaggio inviato due giorni fa al sito Dagospia dall’ex deputato Pd Mario Adinolfi, diventato adesso uno dei leader del popolo del Family day. «La ministra — aveva evidenziato Adinolfi spalleggiato da Massimo Gandolfini, che del Family day è inventore e promotore — sostiene di avere un diploma di laurea in assistente sociale, ma mente. Quello è soltanto un diploma. Quindi deve dimettersi». Ieri la scheda ufficiale sul sito personale della ministra è stata modificata in modo, hanno spiegato i suoi collaboratori, «da evitare ogni ambiguità». Il confronto avuto con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni l’ha rassicurata, perché le è stata espressa «piena fiducia». I messaggi di solidarietà sono stati moltissimi. Ma certo gli attacchi bruciano «soprattutto per una come me che ha sempre fatto la sindacalista e non ha mai sfruttato nulla. Lo voglio ripetere in maniera chiara: questo titolo non l’ho mai usato, non mi è mai servito. Nel 1987 c’è stata la possibilità di farlo equiparare, ma io già facevo la sindacalista, avevo preso una strada completamente diversa». Fedeli ha un temperamento forte, un carattere deciso. La sua chioma rosso fuoco è diventata famosa dentro e fuori il Parlamento. Convinta sostenitrice del Sì al referendum sulle riforme era intervenuta qualche giorno prima della consultazione a L’Aria che tira, programma di La7 condotto da Myrta Merlino, per assicurare che avrebbe lasciato la poltrona. E anche per questo adesso è finita al centro delle polemiche che infuriano contro tutti coloro — Renzi e Boschi in testa — che avevano preso l’impegno pubblico di «abbandonare la politica in caso di sconfitta». Fedeli è consapevole che la bufera non passerà in tempi rapidi, ma non si scoraggia. «Io vivevo a Milano e facevo la maestra d’asilo. Poi ho frequentato la Unsas, scuola laica per diventare assistente sociale, ma è un mestiere che non ho mai fatto. Sono andata a lavorare al Comune di Milano entrando al 7° livello e andando via allo stesso livello. Io sono sempre stata sindacalista. E non ho mai avuto alcun beneficio da quel pezzo di carta. Capisco e comprendo tutto, ma sono veramente sconcertata da tanta aggressività». Due giorni fa, appena la vicenda era diventata pubblica aveva espresso la convinzione che fosse «un caso montato ad arte». Perché, aveva argomentato «guarda caso sono stati quelli del Family day a tirare fuori questa storia. Loro mi detestano per essermi schierata contro, per aver difeso la teoria del gender ed evidentemente non possono accettare che mi occupi di scuola. Eppure per me parla la mia storia politica, io sono sempre stata seria e coerente nell’affrontare i problemi. E lo farò anche adesso, senza farmi intimidire». Una posizione ribadita ieri: «Spero di potermi occupare della scuola, dei problemi veri. Di questo voglio parlare, degli studenti, degli insegnanti, di quello che si deve fare per far funzionare la pubblica istruzione». In attesa che la bufera passi davvero.
Laurea falsa, la Fedeli si auto-assolve e accusa: "Contro di me troppa aggressività". La Fedeli non chiede scusa per aver mentito sul suo titolo di studi: "Ho commesso una leggerezza". E attacca: "Sono sconcertata da tanta aggressività", scrive Sergio Rame, Giovedì 15/12/2016, su "Il Giornale". "Posso aver commesso una leggerezza, ma finire sotto accusa in questo modo davvero non me lo sarei mai aspettato". Non solo si auto-assolve ma sale addirittura in cattedra per attaccare chi giustamente le ha fatto notare che non si era mai laureata. "Comprendo tutto - tuona il neo ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, in una intervista al Corriere della Sera - ma sono veramente sconcertata da tanta aggressività". Più che di polemica, si potrebbe parlare di indignazione popolare. Perché la Valeri ha spacciato per laurea un semplice diploma. Nulla contro chi non ha conseguito un pezzo di carta all'università, ma il neo ministro è l'ennesimo personaggio che si sente in diritto di poter mentire sul proprio titolo di studio e farla franca. Come se niente fosse, infatti, si autoassolve parlando di un disguido verbale e tira dritto. Non una scusa agli italiani a cui ha provato a farla sotto il naso. Di lasciare l'incarico affidatole dal neo premier Paolo Gentiloni non le passa nemmeno per la testa. "Scherziamo? - reagisce Fedeli - io sono una persona seria. Se volevo mentire o truffare non avrei mai messo nel mio curriculum diploma di laurea, ma avrei scritto laurea e basta". Una tesi quantomeno discutibile. Ma tant'è. L'ex sindacalista resterà ancorata alla sua poltrona. Non importa se, prima del referendum sulle riforme costituzionali, ha detto che, in caso di vittoria del No, avrebbe fatto un passo indietro (guarda il video). L'ha fatto avanti. È restata e si è pure portata a casa una poltrona da ministro. Nell'intervista al Corriere della Sera, la Fedeli si lamenta degli gli attacchi ricevuti. "Bruciano soprattutto per una come me che ha sempre fatto la sindacalista e non ha mai sfruttato nulla. Lo voglio ripetere in maniera chiara: questo titolo non l'ho mai usato, non mi è mai servito". E racconta: "Nel 1987 c'è stata la possibilità di farlo equiparare, ma io già facevo la sindacalista, avevo preso una strada completamente diversa". La bugia resta ugualmente. A Palazzo Chigi, però, nessuno si è scomposto. La stessa Fedeli rivela che Gentiloni le ha espresso "piena fiducia". "Spero - conclude - di potermi occupare della scuola, dei problemi veri. Di questo voglio parlare, degli studenti, degli insegnanti, di quello che si deve fare per far funzionare la pubblica istruzione". Ma cosa insegnerà agli insegnanti e, soprattutto, agli studenti? Che si può mentire tranquillamente e, se pizzicati, si può fare spallucce e tirare dritto come se niente fosse?
Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli non ha il diploma di maturità (ma ha quello magistrale triennale). Nuova bufera sui social, scrive su "L'Huffington Post" Claudio Paudice il 15/12/2016. Nuova bufera sulla neo ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. Dopo le polemiche scatenate per le false informazioni riportate sul suo curriculum, nel quale si dava conto di una laurea in Scienze Sociali mai conseguita, ora l'attenzione si concentra sul suo trascorso scolastico. Anche questa volta a sollevare per primo il caso è il direttore de La Croce Quotidiano Mario Adinolfi: "La Fedeli non ha fatto mai manco la maturità, ma solo i tre anni per fare la maestra. Poi diplomino da assistente sociale, privato. Questo è il nuovo ministro della Pubblica Istruzione che si dichiarava 'laureata in Scienze Sociali'. Spero che studenti e docenti a ogni incontro la sotterrino di pernacchie". Lo staff del ministro, contattato dall'Huffpost, ha confermato: "Lo avevamo già spiegato nei giorni scorsi, lei ha fatto una scuola per conseguire il diploma di maestra nelle scuole materne che dura tre anni" e poi l'oramai famosa scuola per assistenti sociali. "Niente di nuovo, Adinolfi esprime legittimamente la sua opinione su quali titoli debba avere o non avere" un ministro dell'Istruzione. Differentemente dal "diploma di laurea" inserito per "leggerezza" - come lei stessa si è giustificata in un colloquio con il Corriere della Sera - il diploma di maturità non è menzionato nel suo curriculum vitae. Fedeli si è detta "sconcertata" per gli attacchi subiti in questi giorni, difendendo il suo passato di "sindacalista: lo sono sempre stata". E, ha precisato, "non ho mai avuto alcun beneficio da quel pezzo di carta". Tuttavia il fatto che il ministro dell'Istruzione non abbia conseguito il diploma di maturità, pur non essendo un requisito necessario per legge per ricoprire quel ruolo, alimenta nuove polemiche. Non a caso: il settore della scuola ha subito negli anni diverse modifiche nella normativa per l'accesso all'insegnamento, causando non pochi disagi agli aspiranti docenti. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato ad aprile scorso l'orientamento adottato con diverse sentenze dalla VI sezione consentendo l'accesso alle Gae, le graduatorie ad esaurimento, a coloro che hanno conseguito il diploma magistrale ante 2001/2002. Ma è sempre il Consiglio di Stato ad aver scritto, nel dicembre 2013, che tale titolo non è equiparabile ai diplomi rilasciati a chiusura dei corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale: solo questi ultimi consentono "l’accesso ai corsi di laurea universitari e alle carriere di concetto presso le Pubbliche amministrazioni e valgono ogniqualvolta la legge richiede il possesso di un diploma come requisito professionale". Da qui nascono le (nuove) polemiche sull'opportunità che a Viale Trastevere ci sia un ministro dell'Istruzione senza "maturità".
Lo staff della Fedeli conferma: mai fatto l'esame di maturità. Dopo le accuse di Adinolfi al neo-ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, arriva una conferma dal suo staff: il ministro non ha mai sostenuto l'esame di maturità, scrive Franco Grilli, Venerdì 16/12/2016, su "Il Giornale". Dopo le accuse di Adinolfi al neo-ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, arriva una conferma dal suo staff: "Non ha mai sostenuto l'esame di maturità". Insomma la Fedeli non solo non ha nessun titolo accademico ma di fatto non si è mai seduta tra i banchi per sostenere l'esame di maturità. Tutto parte da un post su Facebook di Mario Adinolfi che dopo aver smascherato il ministro sulla tanto contestata laurea in Scienze Sociali, ha messo nel mirino il ministro sulla maturità: "Fedeli - assicura Adinolfi - non ha mai fatto neanche la maturità, ma solo i tre anni di magistrali necessari a prendere la qualifica di maestra d'asilo e poi il diplomino privato all'Unsas da assistente sociale, quello spacciato per diploma di laurea in Scienze Sociali. Abbiamo il record mondiale di un ministro della Pubblica Istruzione che non solo mente sui propri titoli di studio, non solo non è laureato, ma non ha mai neanche sostenuto quell'esame di maturità che ogni anno agita così tanto centinaia di migliaia di studenti". E così lo staff, contattato da Libero non ha potuto far altro che confermare le parole di Adinolfi. Il corso frequentato - sottolineano dallo staff - è quello triennale della Scuola magistrale. E alla fine del percorso di studio non è previsto l'esame di maturità. Inoltre affermano, sempre dallo staff, che in questo caso il ministro non ha mai inserito nel Cv informazioni imprecise su questo punto.
Ministra Fedeli, manca la laurea e anche la maturità, scrive Chiara Pizzimenti il 16.12.2016 su "Vanity Fair". Arrivano quasi tutti dal fronte del Family Day, ma arrivano forti gli attacchi alla nuova ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli. E il campo di battaglia è la scuola. L’ultimo colpo arriva da Mario Adinolfi, ex deputato Pd, ora presidente del Popolo della famiglia. Secondo quanto dice Adinolfi non avrebbe fatto l’esame di maturità, «ma solo i tre anni di magistrali necessari a prendere la qualifica di maestra d’asilo e poi il diplomino privato all’Unsas da assistente sociale, quello spacciato per diploma di laurea in Scienze sociali». Era stato lo stesso Adinolfi a portare alla ribalta la questione della laurea in scienze sociali, inesistente, ma segnalata nel curriculum vitae della Fedeli, poi corretto con la dicitura «diploma per assistenti sociali presso Unsas». Nessuna bugia sulla maturità, da nessuna parte è scritto che l’abbia fatta. Al tempo erano sufficienti i tre anni di magistrali per fare la maestra d’asilo. Ma ogni via è buona per la polemica e ad Adinolfi si aggiungono i Cinque stelle: «Certamente i titoli di studio non sono tutto nella vita ma qui siamo di fronte a un ministro, il titolare dell’Istruzione, che ha mentito sul titolo di studio. Il Miur e il comparto istruzione non meritano anche questa umiliazione». Una polemica che è sui titoli di studio, ma riguarda più in generali il percorso della Fedeli in particolare nella lotto contro le discriminazioni di genere. Il senatore Carlo Giovanardi l’ha ricordata come prima firmataria del ddl 1680 sull’introduzione dell’educazione di genere e della prospettiva di genere nelle scuole, che lui chiama un «tentativo di colonizzazione ideologica della scuola pubblica». In realtà la vita politica della Fedeli ha le sue basi soprattutto nel movimento sindacale e in particolare nel settore tessile. Si ritrova nel posto di Stefania Giannini (una delle poche tagliate rispetto al governo Renzi da Gentiloni) a fare i conti con una riforma che non piace alla maggior parte degli insegnanti.
Fedeli: "Ho lavorato una vita nel sindacato, posso fare la ministra anche senza laurea". La titolare dell’Istruzione replica alle polemiche sul suo titolo di studio: "Il mio metodo da quarant’anni è l’ascolto, mi aiuterà anche qui", scrive Corrado Zunino il 17 dicembre 2016 su "La Repubblica".
"Posso fare la ministra - ministra, ci tengo - dopo una vita così intensa nel sindacato. Sono stata apprezzata, promossa, chiamata a Roma, poi a Bruxelles a guidare il sindacato europeo dei tessili. Ho contribuito a salvare grandi aziende, ho portato nella Cgil le competenze dei ricercatori della moda, mi sono occupata di Wto e dei round per far entrare i cinesi nel commercio internazionale. Sono diventata vicepresidente del Senato e ora sono qui, al ministero dell'Istruzione, e fino a quando questo governo esisterà cercherò di migliorare la scuola, l'università e la ricerca italiana 24 ore al giorno".
Ministra, l'esordio è stato difficile. Nel suo curriculum online aveva scritto di aver conseguito un diploma di laurea, in un secondo curriculum era evidenziata una laurea in Scienze sociali. Lei non ha la laurea.
"Non l'ho mai sostenuto. Non ricordo il curriculum con la dicitura laurea, ma quello con su scritto diploma di laurea, rilasciato dopo tre anni dall'Unsas, è stato solo una leggerezza. La laurea è una cosa a cui non ho mai pensato. Ho 40 anni di vita rigorosa nel sindacato, non ho mai usato quel diploma, sono stato sempre una distaccata di settimo livello, maestra d'infanzia distaccata".
Ministra, il giorno dopo le polemiche lei ha cambiato il curriculum: solo diplomata, si legge adesso. Definirsi laureata è dipeso forse da un complesso psicologico? All'ex sottosegretario Faraone i docenti precari hanno sempre rinfacciato il fatto che non avesse il titolo, fino a quando lui non ha ripreso gli studi e dato la tesi.
"Io non mi sono laureata perché il sindacato mi ha preso e portata via, è diventata la mia vita. Non una carriera, la vita. Alla laurea non ho mai pensato. Nel 1987 avrei potuto equiparare quei tre anni come assistente sociale al titolo di laurea, ma non l'ho fatto perché era fuori dal mio mondo. Riunioni, incontri con gli operai, viaggi a Bruxelles, e chi l'aveva il tempo per la laurea?".
Lei, dopo i tre anni delle superiori, ha fatto la maestra d'infanzia?
"Sì, ero giovanissima. E il fatto che abbia voluto studiare per altri tre anni alla scuola per assistenti sociali senza averne bisogno, avevo già un'occupazione, dimostra che il gusto della conoscenza l'ho sempre avuto. Poi, ho trovato ostacoli nella mia vita e, dopo l'esplosione del '68, è arrivato il sindacato. In quegli anni ti assorbiva completamente".
Che tipo di ostacoli?
"Non vengo da una famiglia ricca e molto presto mi sono resa autonoma: da Treviglio sono andata a vivere a Milano. Mio fratello ha fatto Giurisprudenza, io ho abbracciato la Cgil".
Non si sentirà in difficoltà quando dovrà incontrare una docente ancora precaria con due lauree o parlare di Technopole con la scienziata Elena Cattaneo?
"Il mio metodo è l'ascolto e ascolterò con attenzione chi ha competenze straordinarie. Cresceranno le mie. Ascoltare, capire, conoscere. Quarant'anni di applicazione di questo metodo mi aiuteranno anche al ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca".
A La7 lei disse: "Il giorno dopo, se ha vinto il no, tu ne devi prendere atto, non puoi andare avanti perché non hai l'autorevolezza. Io non penso alla mia sedia". Lei, però, ora fa la ministra.
"L'aver detto che bisogna prendere atto della sconfitta è coerente con la nascita di un governo che deve affrontare le urgenze del Paese".
Ministra, quale sarà il suo primo atto per migliorare la scuola italiana?
"Le prime telefonate le ho fatte ai cinque sindacati rappresentativi, lunedì li incontrerò. Vorrei il loro punto di vista sulla Buona scuola, dopo il lungo conflitto che c'è stato".
Le piace la Legge 107?
"L'ho votata, al Senato. Ha dentro cose importanti, innovative, immaginate dalla ministra Carrozza e approdate con la Giannini. È legge vigente, la si deve far funzionare senza tradire il progetto".
I sindacati le chiederanno di fermare gli spostamenti dei docenti dal Sud al Nord.
"È una questione centrale e dovremo trovare nuove soluzioni, magari sperimentali. Con grande attenzione, tocchi una cosa e ne viene giù un'altra".
La chiamata del preside?
"Cercheremo criteri oggettivi con i quali, poi, il dirigente scolastico potrà scegliere i docenti".
Ereditate nove deleghe dal governo Renzi, una Buona scuola bis: il 15 gennaio scadono.
"Voglio portarle in fondo tutte, ma prima studiarle bene. Chiederemo al Parlamento di rivotare quelle in scadenza. La legge 0-6, che prevede la materna unica e l'assunzione di maestre d'infanzia, è pronta. Sono stata la seconda firmataria".
Viva la Fedeli, abbasso la laurea. La presunta bugia della neo ministra all’Istruzione non è che la conseguenza di un rapporto malato tra l’Italia e il “pezzo di carta”. Un Paese in cui tutti vogliono essere laureati, ma in cui la laurea non serve a nulla, scrive Francesco Cancellato il 14 Dicembre 2016 su “L’Inkiesta”. E ti pareva che non succedesse di nuovo. Che qualcuno - nella fattispecie Mario Adinolfi - non tirasse fuori una presunta millantata laurea di un’avversaria politica - nella fattispecie la neoministro alla pubblica istruzione Valeria Fedeli - per delegittimarla in partenza. Che, poi, alla fine, di inciampo lessicale pare proprio trattarsi, visto che il titolo di studio della Fedeli è effettivamente un diploma di laurea, antesignano dei diplomi universitari degli anni novanta e delle lauree triennali di oggi. Ma non è qui il problema. La Fedeli, pur non essendosi mai giovata di questa bugia per fare carriera, potrebbe pure aver mentito sul suo titolo di studio per una questione di vanità personale o per un malcelato complesso d’inferiorità. Ma la bugia - da stigmatizzare in quanto tale, nel caso - non sarebbe che il triste epifenomeno di un rapporto malato dell'Italia, più che col Sapere con la S maiuscola, con il “pezzo di carta” che, in teoria, dovrebbe certificarlo. Un Paese che ha il più basso numero di laureati in Europa, ma in cui anche il più umile analfabetizzato funzionale ha avuto il suo «Buongiorno Dotto’» di celebrità. Un Paese che spende una marea di soldi per far studiare i propri figli, che non ne accetta l’inadeguatezza allo studio, che accetta di buon grado che rimangano sui banchi di scuola fino alla crisi di mezza età, pur di invitare i parenti al pranzo di laurea. E che poi non sa che farsene dei laureati e li costringe, nei fatti, a fare la fila alle agenzie interinali per un posto da magazziniere, o a emigrare. Ancora: un Paese che in coda a tutte le classifiche per la spesa in istruzione e ricerca e assente in quelle delle università migliori al mondo, con decine di atenei sotto casa costruite «per l’indotto sul territorio», in cui la baronia e la trasmissione ereditaria della cattedra sono elevate a forma d’arte. Un Paese in cui la percentuale di antivaccinisti s’impenna tra laureati e dottorati, con buona pace di chi ha frequentato l’università della vita. Un Paese con uno dei più altimismatch del mondo Ocse tra domanda e offerta di lavoro, tra professionalità sul mercato e posti di lavoro disponibili. Un Paese, per dirla in meno di dieci parole, in cui poche cose servono meno di una laurea. La Fedeli potrebbe pure aver mentito sul suo titolo di studio per una questione di vanità personale o per un malcelato complesso d’inferiorità. Ma la bugia - da stigmatizzare in quanto tale, nel caso - non sarebbe che il triste epifenomeno di un rapporto malato dell’Italia, più che col Sapere con la S maiuscola, con il “pezzo di carta” che, in teoria, dovrebbe certificarlo. E allora abbasso un’istruzione - superiore e non solo - da rivoltare come un calzino e viva chi sta provando a farlo e chi ci vorrà provare. Abbasso il valore legale del titolo di studio, strumento classista e inadeguato a valutare il merito tanto quanto lo è una raccomandazione, perlomeno ora e qui. E, nel frattempo, viva la Fedeli, il suo diploma universitario, la sua gavetta politica, se le metterà al servizio - nel poco tempo a sua disposizione - per cambiare almeno un po' le cose. E ancora: viva Oscar Giannino, che si appunti al petto come una medaglia che un Presidente del Consiglio sia costretto, per averne ragione in un dibattito da ko tecnico, a ricordare il caso dei suoi millantati titoli di studio. Viva il Premio Oscar Roberto Benigni, i Premi Nobel Dario Fo ed Eugenio Montale, direttori di giornale e telegiornale come Enzo Biagi, Enrico Mentana e Giuliano Ferrara, moloch della divulgazione scientifica come Piero Angela e dell’intrattenimento televisivo come Maurizio Costanzo, viva la spregiudicatezza visionaria di Enrico Mattei e Michele Ferrero, il talento politico di Fausto Bertinotti e Walter Veltroni e i calli sulle mani di sarti e cuochi oggi diventati stilisti e chef come Giorgio Armani e Carlo Cracco. Viva tutte quelle persone che non si sentono in diritto di accampare alcuna pretesa per una riga in più nel curriculum vitae e che hanno costruito la loro fortuna e quella del Paese usando come mattoni le loro idee, la loro ambizione, la loro cultura del lavoro. Viva chi se ne fotte dei giudizi delle aristocrazie vuote del sapere col parrucchino. Viva la loro fame e la loro follia, come disse ai neolaureati di Stanford, nel suo discorso più famoso, Steve Jobs, che laureato non era, nemmeno lui, come del resto non lo è Bill Gates. Chissà che quante gliene avrebbe dette, il Dottor Mario Adinolfi.
Ridateci Croce e Gentile come Ministri dell’Istruzione! Scrive Francesco Boezi su “Il Giornale" il 16 dicembre 2016. Una nazione che ha avuto Benedetto Croce come Ministro della Pubblica Istruzione non può giudicare un governante dai titoli. Non è questo il punto. Ognuno di noi conosce moltissime persone prive della laurea, ma validissime nei settori in cui operano. Allo stesso modo, esistono plurititolati privi di qualunque capacità. Questo è un fatto rinomato. Certo è che il settore in questione, quello dell’istruzione, meriterebbe un trattamento di favore nella scelta di persone specificatamente formate per dettarne le linee guida. Un comandante, insomma, deve sapere com’è fatta la nave per evitare che affondi. Specie nel caso in cui, come questo, la nave sia parecchio importante e sembri imbarcare parecchia acqua. La Fedeli, prescindendo dalla mancanza della laurea e dalla questione riguardante il diploma privato, viene dal sindacalismo. Cosa c’entra con la cultura italiana? Servirebbe altro. Non un tecnico, ma una persona dotata di una visione, di una Weltanschauung in grado di tirare fuori la scuola dalle sacche sessantottine in cui è tragicamente finita. Il nostro è un modello che si allontana sempre di più dalle radici umanistiche ed identitarie, per inseguire una scimmiottatura americaneggiante fatta di convenzioni con i fast food, sperimentazioni educative ed un’infinità di progetti pomeridiani poco sensati, spesso costruiti addosso alle passioni private dei docenti. Il tutto senza alcuna visione di insieme, nel breve e nel lungo periodo. Così, mentre assistiamo al ritorno del fenomeno dell’analfabetismo, noi ci occupiamo di gender, di neutralizzare i pronomi in nome del politically correct e di introdurre legislativamente forme di rispetto per le differenze di genere, partendo quindi dal presupposto che gli insegnanti non siano capaci di educare gli studenti in modo autonomo ed abbiano bisogno di direttive verticistiche. Questo dirigismo valoriale, si sa, preoccupa molto il mondo cattolico. La petizione promossa su Citizengo.org, sponsorizzata, tra gli altri, dal Comitato “Difendiamo i Nostri Figli” e da “La Manif Italia”, segnala come la scelta della Fedeli possa essere stata mossa dallo spirito di vendetta che il Partito Democratico sembrerebbe nutrire verso le organizzazioni citate, in funzione del loro impegno per il No al referendum costituzionale. Se questo fosse il movente, non sarebbe positivo. La Fedeli, d’altro canto, è la pasionaria del disegno di legge sull’educazione di genere risalente al 2014. La scuola italiana rischia di finire in una guerra ideologica di cui non ha alcun bisogno. La missione del sistema educativo dovrebbe essere quello di formare gli italiani del domani in un contesto laico e privo di strutture e sovrastrutture dottrinali imposte dai desiderata antropologici di una parte politica. Dai recenti studi dell’ex Ministro De Mauro, esemplificativamente, viene fuori che solo un terzo degli italiani avrebbe livelli sufficienti di comprensione della scrittura e del calcolo per poter vivere all’interno della società contemporanea senza enormi disagi. Spicca, soprattutto, la questione della regressione in età adulta all’analfabetismo funzionale, fenomeno che finisce per interessare l’efficienza economica-produttiva della nostra nazione. Per quel che concerne chi da scuola è uscito. Per quelli che ancora sono dentro, parlano le annuali statistiche sulla crisi della lettura, sull’analfabetismo matematico e sul livello qualitativo complessivo dell’istruzione italiana. Tutti questi fenomeni non saranno forse legati al progressivo abbandono dei classici? Alla svalutazione del sapere umanistico, etichettato tanto frettolosamente quanto stupidamente come inutile? Non sarà stato il clichè della “riforma sempre e comunque” a destrutturare dalle fondamenta un modello culturale che aveva sfornato i migliori in ogni campo del sapere umano? Oppure nessuno si ricorda più di cosa fu capace la generazione cresciuta sui banchi della riforma Gentile? Non sarà, magari, che il sapere liquido, ideologico, nozionistico, economicistico e slegato dalla storia porti con sè l’enorme problema di essere solo un mezzo temporaneo e mai un bagaglio personale definitivo? Di questo sarebbe necessario preoccuparsi, non del gender. Altro che Fedeli! Ridateci Croce e Gentile!
Quanto veleno se la poltrona va a chi non è laureato. Uno su quattro degli incaricati da Renzi non ha il titolo di dottore, ma neanche Marconi ce l'aveva e ha cambiato il mondo. Conta solo il lavoro che sapranno fare, scrive Vittorio Feltri, Domenica 23/02/2014, su "Il Giornale". Tradizione rispettata. Anche questo governo, fortemente voluto da Matteo Renzi detto Fenomeno, pur non avendo ancora mosso un dito, è già stato subissato di fischi per vari motivi, uno soprattutto: è colpevole di essere nato. Succede così da sempre. Seguo da cronista la politica da mezzo secolo e non mi è mai capitato di udire elogi unanimi diretti a un neopremier o ai neoministri. Perfino Alcide De Gasperi fu salutato con sospetto. Con l'andare del tempo divenne antipatico addirittura agli amici del suo partito, la Dc, i quali brigarono per rispedirlo in Trentino affinché cedesse il posto a giovani (si fa per dire) rampanti. Missione compiuta. Una volta morto, lo statista fu elevato agli altari. Oggi chiunque loda le sue opere. Dubito che Renzi sia la reincarnazione di De Gasperi, però non me la sento di definirlo sciocco il primo giorno di scuola. C'è chi invece si è già scagliato contro di lui e la sua squadra. Lo biasimano perché dice una cosa e ne fa un'altra, tradendo il desiderio di entrare a Palazzo Chigi anche a costo di piegarsi alle pretese delle segreterie e agli ordini del Colle, come se fosse facile ignorare le prime e i secondi. Sui nomi dei prescelti dal presidente del Consiglio si è aperta una gara a chi li bastona di più. Un esercizio abbastanza semplice. È sufficiente consultare il dizionario dei sinonimi per trovare epiteti originali con cui deridere i fortunati vincitori delle cadreghe ministeriali: otto uomini e otto donne, in omaggio alla moda delle pari opportunità. Molti responsabili di dicastero sono volti nuovi, altri meno: in linea di massima, comunque, gente sconosciuta o semisconosciuta al grande pubblico. Pertanto chi fa il mio mestiere ha indagato in fretta e furia per rintracciare qualche dettaglio biografico degno di nota e idoneo a imbastire articoli pepati su questo o su quel personaggio. Cosicché alcune penne intinte nel veleno hanno raccontato che un quarto dei 16 componenti della compagine governativa è privo di laurea. Ecco l'elenco: Beatrice Lorenzin (Sanità), Maurizio Martina (Politiche agricole), Andrea Orlando (Giustizia) e Giuliano Poletti (Lavoro e welfare). In che cosa consista lo scandalo non è chiaro. Tuttavia il tono con cui si scrive sul conto di costoro è sfottitorio. Come dire: che aspettarsi da politici che non hanno neppure concluso gli studi universitari? E si sorvola sul fatto innegabile che è più importante aver imparato a stare al mondo che non aver conseguito un diploma al massimo livello accademico. Ma, quando si tratta di prendere in giro una persona assurta ad alte responsabilità, è comodo sbattergli in faccia la patente di ignorante: non comporta nemmeno lo sforzo di verificare se ciò corrisponda a realtà. Può darsi che un signore e una signora privi di laurea siano impreparati a gestire un ministero, ma può anche essere che un laureato non sia in grado di mandare avanti un negozio di frutta e verdura. La storia ci insegna che un alto numero di autodidatti è stato premiato con il Nobel non certo perché abbia conseguito brillantemente titoli di studio, bensì per meriti legati ad attività professionali egregiamente svolte. Lo abbiamo ricordato spesso, ma giova rammentarlo ancora: a parte Luigi Pirandello, tutti gli altri Nobel italiani per la letteratura - Grazia Deledda, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale - non erano laureati. Non citiamo Dario Fo per decenza. Segnaliamo inoltre che Benedetto Croce e Gabriele D'Annunzio l'università la videro col binocolo. E Guglielmo Marconi? Mai frequentato corsi scolastici superiori con regolarità. Ciononostante, egli è lo scienziato che ha segnato una svolta nella storia dell'umanità con un'invenzione da lasciar senza fiato. Con questo non stiamo sostenendo che i quattro rimorchiati da Renzi, benché sprovvisti di titoli, siano dei geni apparecchiati per risolvere i problemi del Paese, tutt'altro. Ma siamo convinti che il loro rendimento al tavolo dell'esecutivo non dipenderà dalle pergamene (che non hanno) ma dalle capacità che ci auguriamo abbiano. Nei casi della Lorenzin e di Orlando sarebbe lecito azzardare un giudizio, poiché entrambi non sono esordienti nel ruolo di ministri. Ma ci zittiamo per prudenza, essendo consapevoli che con un capo diverso da Enrico Letta, cioè Renzi, essi potrebbero fare meglio del peggio combinato nella precedente esperienza. È solo un auspicio. Intendiamo sottolineare che polemizzare sulle lauree in mancanza di argomenti più seri è una manifestazione di meschinità. Lo è tanto più in un momento, quale il presente, caratterizzato dalla crescente disoccupazione giovanile, particolarmente accentuata fra i laureati. Dal che si evince che conviene saper esercitare un mestiere ben retribuito che non farsi chiamare dottore gratis.
Al governo senza laurea: Poletti, Orlando e Lorenzin hanno solo la maturità, scrive il 9 giugno 2014 "Corriere Università". E’ la vecchia storia dei governanti e dei governati. Sì, perché la squadra messa insieme dal premier Matteo Renzi sarà pure la più giovane in base alla media d’età (47,8 anni) ma, di sicuro, non è il massimo in termini di istruzione. Giuliano Poletti, Beatrice Lorenzin, Andrea Orlando: tre dei ministri che reggono dicasteri fondamentali, infatti, non sono laureati. Nemmeno al primo livello. Orlando, ministro della Giustizia, si è fermato alla maturità scientifica. Beatrice Lorenzin, ministro della Sanità già presente nella legislatura di Letta, vanta una maturità classica. E Giuliano Poletti, ministro del Lavoro, è perito agrario. Il grafico pubblicato da Linkiesta è lo specchio di un Paese che troppo spesso delega le funzioni importanti a chi per quei ruoli non ha nemmeno studiato. Il 23,5% di coloro che ci governano – scrive il magazine – non ha nemmeno la laurea. Pochissimi hanno un master, qualcuno un dottorato di ricerca. L’Italia, dunque, conquista un’altra maglia nera in Europa, dove invece la preparazione e la competenza contano. In Francia tutti i ministri hanno almeno la laurea, in Germania un solo non laureato viene compensato da tantissimi ricercatori. E se guardiamo agli Usa, la situazione peggiora (per noi): pochi laureati, molti con master e dottorato.
8 ministri italiani che non hanno mai preso la laurea, scrive il 14 dicembre 2016 Carmine Zaccaro su "Skuola.net". La polemica sulla laurea della neo ministra Valeria Fedeli ha scatenato il web. Nelle scorse ore infatti, il nuovo responsabile di Viale Trastevere si è dovuta difendere da attacchi e ironie, partite dopo il post di Mario Adinolfi, ex giornalista e leader del Popolo della Famiglia, che la accusava di non aver conseguito un titolo di studio equiparabile alla laurea. E mentre dal ministro sono arrivati i chiarimenti sulla vicenda - un presunto "problema lessicale" fatto in "buona fede" - quella della laurea non sembra rappresentare un elemento imprescindibile per fare carriera. Noi di Skuola.net siamo andati a spulciare nei curricula di 8 ministri ed ex ministri italiani, che ricoprono o hanno ricoperto posizioni rilevanti nella guida del paese, e di laurea non c'è nemmeno l'ombra.
8. Francesco Rutelli. Classe 54' di origine romano, Rutelli è stato co-presidente del Partito Democratico Europeo. Eletto sei volte in Parlamento. Sindaco di Roma nel 1993. E'stato Ministro dei beni e delle attività culturali. Ha ricevuto Lauree honoris causa dalla John Cabot University, dalla Temple University e dall’American University in Rome, ma non l'ha mai presa in gioventù: si è iscritto nuovamente all'università proprio qualche mese fa, con l'obiettivo di ottenere (stavolta) il titolo.
7. Altero Matteoli. Politico italiano di lungo corso. Classe 40' cresce sotto l'ala dell'On. Beppe Niccolai, esponente storico pisano del MSI. Dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011 è stato Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nel Governo Berlusconi.
6. Massimo D'Alema. Romano di origine. Sposato, con due figlie. E' un giornalista professionista e vanta collaborazioni anche con l'Unità, di cui è stato direttore nel biennio 1988-1990. Ha studiato al liceo classico. Entra alla Camera dei deputati nel 1987. Dal 21 ottobre 1998 all'aprile del 2000 è stato Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 17 maggio 2006 diventa Ministro degli Esteri nel Governo Prodi.
5. Walter Veltroni. Politico italiano classe 55' di Roma. Prima di intraprendere la carriera politica è stato giornalista professionista, ha anche diretto lo storico quotidiano l'Unità. La politica entra nella sua vita nel 1976, quando viene eletto consigliere al comune di Roma rimanendo in carica per cinque anni. Eletto in Parlamento nel 1987. Romano Prodi lo chiamò nel 1996 a condividere la leadership del partito "l'Ulivo" nell'anno della vittoria di quella coalizione, assumendo in seguito l'incarico di vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Beni Culturali e Ambientali con l'incarico per lo spettacolo e lo sport. Nel 2003 riceve la laurea Honoris causa dalla John Cabot University di Roma. Oggi scrive libri e dirige film, ma la laurea non è mai stata una priorità per la sua carriera.
4. Umberto Bossi. L'energico Umberto Bossi, capo-popolo delle fila della Lega Nord non ha conseguito la laurea durante il suo percorso formativo. Si ferma alle superiori, dove consegue il diploma di perito tecnico. Si iscrive alla facoltà di Medicina di Pavia senza conseguire la laurea. Ma questo non gli ha impedito di diventare senatore della Repubblica ed europarlamentare. Ha fondato il partito che ad oggi raccoglie il sentimento di una vasta fetta di elettori italiani. E' stato Ministro per le Riforme Istituzionali durante il governo Berlusconi.
3. Giorgia Meloni. Rampante politica e giornalista di origine romana. Ha speso gli anni della gioventù alla carriera politica. A 15 anni ha fondato il coordinamento studentesco "Gli Antenati". Diventa responsabile nazionale di diventa responsabile nazionale di Azione Studentesca, il movimento studentesco di Alleanza Nazionale e rappresentante al Forum delle associazioni studentesche. Nel 2006 entra alla Camera dei Deputati con Alleanza Nazionale e fino al 2008 ricopre la carica di Vicepresidente. Il 21 aprile di questo anno è stata impegnata nella campagna elettorale per diventare sindaco di Roma. Anche per lei la laura non è stata la prima preoccupazione, ma neanche un ostacolo ai successi personali. E' stata Ministro per la gioventù con il governo Berlusconi.
2. Giuliano Poletti. Attuale Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al centro di un putiferio che fece arrabbiare qualche studente, quando propose meno vacanze estive per fare qualche lavoretto costruttivo. Riconfermato come ministro nel Governo di Responsabilità che fa capo a Paolo Gentiloni, la carriera politica non è stata frenata dalla mancanza del titolo di laurea.
1. Beatrice Lorenzin. Tra le donne al vertice del Governo Renzi. Riconfermata con Poletti. Il ministro Beatrice Lorenzin a capo del dicastero della Sanità non ha una laurea, sebbene nel corso degli anni la sua vita sia stata segnata da vari successi personali e professionali.
Primo guardasigilli non laureato, nel 2010 gli è stata ritirata patente per guida in stato di ebbrezza, scrive il 27 Febbraio 2014 Federico Altea su "Elzeviro". Ministri discutibili. Il ministro della giustizia. Orlando, poca competenza in materia, parlò di abolizione di ergastolo e revisione del 41 bis. Il neoministro della Giustizia nel Governo Renzi è l'onorevole Andrea Orlando, già ministro dell'Ambiente del governo Letta. Una scelta piuttosto discutibile, considerato che a capo del dicastero dell'Ambiente è stato posto un signore senza particolari competenze e afferente alla formazione politica casiniana (7 deputati su 630). Andrea Orlando, signore che ha sempre mangiato a pane e politica, milita nei giovani comunisti fin dagli anni Ottanta. Dal Partito comunista fa la classica trafila nel PDS, nei Ds ed infine nel Pd. Avendo ricoperto incarichi di responsabilità negli enti locali sarebbe forse stata comprensibile una sua nomina nel dicastero degli Affari regionali. Un governo nominato (susseguente ad altri due sorti nella medesima maniera) non dovrebbe essere così spiccatamente politico, tanto più quando si parla di fare riforme (una al mese, addirittura) che siano massimamente condivise e non pronte per essere disgregate dal governo successivo. Nonostante non avesse competenze che trasparissero con evidenza dal suo curriculum in campo ambientale, Orlando si è occupato nel suo mandato annuale nel governo Letta di temi molto scottanti, come l'Ilva e la terribile emergenza ambientale che affligge la Terra dei fuochi, a proposito della quale è stato promotore di una legge. La legge in questione introduce il reato di combustione dei rifiuti abbandonati o depositati in aree non autorizzate (condanne da due a cinque anni che possono ulteriormente aumentare se ad appiccare i roghi è un'impresa). La sua applicazione, ad oggi, lascia tuttavia a desiderare: nelle periferie delle grandi città e nei parchi le prostitute, alle quali potrebbe facilmente essere applicata questa legge, seguitano a bruciare copertoni per riscaldarsi, inquinando così come non mai le aree urbane, mentre sull'operato delle aziende l'iniziativa dei magistrati si è forse rivelata troppo blanda. L'emergenza della Terra dei fuochi sarebbe stato un problema da non sbolognare all'ennesimo ministro eletto come tappabuchi (ci riferiamo al ministro Galletti). Quarantacinquenne, non ha mai toccato la giustizia in incarichi pubblici, ma è stato nominato responsabile in materia in seno alla direzione del partito di cui fa parte, nominato da Bersani di cui è fedele compagno nella corrente nei Giovani turchi. In un'intervista al Foglio si disse favorevole al carcere duro, ma anche ad una revisione del 41 bis, se così si può interpretare la frase: "Non ci sono ancora i tempi per superarlo (il 41 bis), ma è necessario fare il punto sulla sua funzionalità nella lotta alla mafia". Non è di un politico "esperto" né di un tecnico intrallazzato che il dicastero della giustizia ha bisogno, ma di un penalista serio che riformi completamente il sistema penale e restringa il più possibile la facoltà dei giudici di interpretare a loro piacimento il sistema delle attenuanti (incredibilmente quasi sempre concesse). Una persona che abbia le competenze per ricostruire il sistema penitenziario da rivedere dal primo all'ultimo articolo e nella sua applicazione, comprese le interessanti innovazioni apportate di recente all'istituto della detenzione domiciliare (braccialetto elettronico). Andrea Orlando, sempre parlando di competenze in ambito di Giustizia o giuridiche in senso lato, non solo non ha la laurea in giurisprudenza, ma non ha ottenuto un diploma di laurea di alcun genere. Nella storia della Repubblica italiana è la prima volta che il Ministero della Giustizia viene affidato ad un non laureato. Tutti i trentatré predecessori di Orlando, infatti, erano laureati e ben ventisette guardasigilli erano laureati giurisprudenza. Chissà se Orlando intende fare qualcosa sulla patente a punti andando così a meritarsi gli auspici dell'Unione delle camere penali che sperano che un politico così navigato possa essere anche in grado di "interpretare alla lettera lo spirito garantista della Costituzione": considerato che nel 2010 Orlando ha subito il ritiro della patente dopo essere stato scoperto al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito, magari vorrà essere molto "garantista" al riguardo...
La laurea dei politici italiani: ecco la classifica dei più sfigati, scrive l'1 Febbraio 2012 “Libero Quotidiano”. Dopo l'uscita del viceministro Martone, il settimanale Oggi stila la graduatoria: dal razzo Napolitano fino alla lumaca Scajola. Il più sfigato di tutti è Claudio Scajola che si è laureato a 53 anni. Giorgio Napolitano, Mario Monti, Romano Prodi erano dottori già a 22 anni. Dopo la dichiarazione choc del viceministro del Lavoro Michel Martone che ha definito sfigato chi si laurea dopo i 28 anni, il settimanale Oggi ha stilato la classifica degli sfigati. Nelle ultime posizioni ci sono Stefania Prestigiacomo, dottoressa a quarant'anni, Gianni Alemanno che ha conquistato il titolo a 46 anni, ha dovuto aspettare altri sei anni Mario Baccini che ha discusso la sua tesi a 52 anni. Chi si è laureato tardi, fa notare il settimanale, ha avuto ottime scuse: da Antonio Di Pietro studente lavoratore: di giorno era impiegato civile dell'Aeronautica e di sera alle prese coi testi di diritto. Ma nonostante tutto si è laureato a 28 anni, esattamente come Nichi Vendola che ha discusso la sua tesi di Lettere su Pasolini lavorando come dirigente dei giovani comunisti e dell'Arcigay. L'ex ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini si è salvata per il rotto della cuffia visto che si è laureata a 27 anni, meglio Mara Carfagna e Daniela Santanché entrambe sono arrivate al traguardo a 26 anni. Molte ombre sono cadute sulla laurea di Alessandra Mussolini accusata con altri 180 studenti romani di aver comprato due esami nel 1982, un anno fa è stata bocciata all'esame di abilitazione ma alla fine ce l'ha fatta. La Prestigiacomo ha dovuto rinviare i suoi studi perché a 23 anni, quando le sue coetanee andavano all'Università, lei era presidente dei giovani industriali di Siracusa e quattro anni dopo divenne deputato. Claudio Scajola si è laureato a 53 anni, in Legge. Si era iscritto nel 1967 ma poi fu attratto dalla politica e, a 27 anni, dirigeva già un ospedale. Martone quando ha chiamato sfigato chi si laurea dopo i 28 anni, dimentica i suoi colleghi acquisiti (per carità, lui è un tecnico) che non sono neanche laureati. Da Francesco Rutelli a Massimo D'Alema...
La laurea di Angelino Alfano senza quid e gli analfabeti che sanno leggere, scrive Silvia Truzzi, Giornalista, l'11 maggio 2015 su "Il Fatto Quotidiano". Il ministro dell’esterno Angelino Alfano – collezionista di gaffe e incidenti di varia natura, dalla rivelazione sull’arresto dell’assassino di Yara al ben più grave caso Shalabayeva – ha duramente attaccato il leader della Lega, con i consueti argomenti ineccepibili e ragionamenti di granitico rigore: “Basta ascoltare Salvini e si capisce perché è un fuori corso. Uno che non si è nemmeno laureato nonostante i notevoli sforzi”. Naturalmente Alfano è laureato e pure in un’università teoricamente d’eccellenza – la Cattolica di Milano – eppure, nonostante il titolo prestigioso, l’ex amico B. lo definì, con chirurgica spietatezza, un senza quid. E forse sfugge all’ex Guardasigilli che l’attuale ministro della Giustizia Andrea Orlando non dispone di laurea alcuna. Come Beatrice Lorenzin e Giuliano Poletti. Ma anche quando i ministri sono dottori, le cose non vanno meglio. Capita alla soave Maria Elena Boschi, “non sempre a suo agio con le materie costituzionali” come ha detto di lei Stefano Rodotà. La laurea (in legge a Brescia) e l’abilitazione da avvocato (a Reggio Calabria), non hanno salvato Mariastella Gelmini, ministro dell’Istruzione!; dallo scivolone sul tunnel tra Ginevra e il Gran Sasso nel 2011. E nemmeno, nel giugno dello stesso anno, da un clamoroso errore in una lettera ai maturandi nella quale ricordava il suo esame: “Ho scelto un tema su Fogazzaro, Palazzeschi e i crepuscolari. Argomenti che conoscevo bene”. Tanto bene da aver messo l’autore di Piccolo mondo antico tra i crepuscolari. E dire che nel 2010 aveva dato dello “studente ripetente” a Pier Luigi Bersani (il quale per tutta risposta aveva pubblicato su Internet il suo libretto, tutto 30 e 30 e lode) suscitando le curiosità dei cronisti sul suo curriculum accademico. Alessandra Arachi aveva fatto una chiacchierata sul Corriere della Sera con il relatore di tesi della dottoranda Mariastella, Antonio D’Andrea, docente di diritto costituzionale all’università di Brescia. Ecco come ricorda la sua studentessa: “Mariastella Gelmini si è laureata almeno tre anni fuori corso con un voto di 100 su 110. Aveva scelto una tesi con un titolo accattivante: ‘Referendum d’iniziativa regionale’. L’argomento era bello, ma lei lo ha trattato in maniera davvero sciatta. Per quella tesi non ho voluto dare neanche un punto in più alla media dei voti. Non soltanto per come era stata scritta, a tirar via, ma soprattutto per come la Gelmini venne a esporla in sede di discussione”. Per la famosa legge dell’orologio rotto, bisogna dar ragione a Salvini che ha risposto ad Alfano “meglio non avercele le lauree di Mario Monti ed Elsa Fornero”: visti i danni fatti dal governo dei professorini, non si può dargli torto. E comunque, (guarda cosa ci tocca dire), meglio Salvini di Oscar Giannino inciampato nella clamorosa balla su lauree e presunti master. Del resto Bossi, diplomato alla mitica scuola Radio Elettra, ha rifiutato una laurea honoris causa in Scienze delle Comunicazioni, liquidando l’iniziativa (sempre del ministro Gelmini, tout se tient) così: “Stupidaggini”. Tipo la memorabile uscita del brillante ex viceministro Michel Martone: “Se non sei ancora laureato a 28 anni sei uno sfigato”. Del resto Eugenio Montale, un ragioniere che non aveva fatto studi classici né si era laureato ma aveva vinto il Nobel per la Letteratura nel 1975, giustamente notava in una famosa battuta che “gli analfabeti al giorno d’oggi sanno leggere”. Potremmo dire, nel caso dei nostri dotti politici e delle loro querelle sugli studi, “asinus asinum fricat”.
Ministri senza laurea e società civile con e senza titoli, scrive Romolo Ricapito il 17 Dicembre 2016. Impazza da giorni ovunque la notizia che una nuova ministra del governo non è, non sarebbe, laureata. Secondo alcuni, non costei si sarebbe nemmeno diplomata! In un articolo di un giornale importante, ho letto che comunque altri tre ministri del governo non sono in possesso di lauree. Impazzano allora i sondaggi e le proposte. Qualcuno addirittura propone l'obbligo di avere la laurea per ministri, parlamentari. Per me si esagera: la laurea è una specializzazione in un campo specifico. Ma spesso assistiamo a un'ignoranza di ritorno: quella di chi, laureato (ma anche diplomato...) non legge libri né giornali, non va al cinema, al teatro, al museo. Questa categoria di persone è più numerosa di quanto si creda. Spesso mi è capitato di frequentare anche occasionalmente persone che ignorano anche le notizie dei i tg, quelle più importanti, o quelle delle quali più si discute. Il trend segna che costoro sono donne, spesso indifferenti a tutto per ragioni personali. Ma tornando al ministro col diploma di laurea (o senza laurea): quante persone che tutti conosciamo, o abbiamo frequentato, a livello appunto di conoscenza e amicizia, fingono titoli di studio inesistenti? E tutto per essere alla pari, o probabilmente al di sopra degli altri, secondo loro incomprensibili motivi. La colpa è anche di chi ha mitizzato questo titolo di studio, la laurea, appunto. Spesso imponendolo ai figli, magari ragazzi svogliati che non avevano nessuna voglia di proseguire con l'Università e che adesso si ritrovano fuori corso con lauree generiche, strappate con voti minimi e dalle quali non hanno attinto particolari conoscenze.
IN QUESTO MONDO DI LADRI.
In Questo Mondo Di Ladri di Antonello Venditti.
Eh, in questo mondo di ladri
C' ancora un gruppo di amici
Che non si arrendono mai.
Eh, in questo mondo di santi
Il nostro cuore rapito
Da mille profeti e da quattro cantanti.
Noi, noi stiamo bene tra noi
E ci fidiamo di noi.
In questo mondo di ladri,
In questo mondo di eroi,
Non siamo molto importanti
Ma puoi venire con noi.
Eh, in questo mondo di debiti
Viviamo solo di scandali
E ci sposiamo le vergini.
Eh, e disprezziamo i politici,
E ci arrabbiamo, preghiamo, gridiamo,
Piangiamo e poi leggiamo gli oroscopi.
Voi, vi divertite con noi
E vi rubate tra voi.
In questo mondo di ladri,
In questo mondo di eroi,
Voi siete molto importanti
Ma questa festa per noi.
Eh, ma questo mondo di santi
Se il nostro cuore rapito
Da mille profeti e da quattro cantanti.
Noi, noi stiamo bene tra noi
E ci fidiamo di noi.
In questo mondo... in questo mondo di ladri...
In questo mondo... in questo mondo di ladri...
In questo mondo... in questo mondo di ladri...
Le persone perbene non riescono a fare carriera all’interno della pubblica amministrazione. Un giudizio lapidario che viene dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, scrive “Blitz Quotidiano” il 28 ottobre 2015. Un giudizio appena mitigato dai due minuti di spiegazione dell’affermazione: Cantone spiega che, a volte, questo avviene anche per colpe dei diretti interessati. “Spesso le persone perbene all’interno della pubblica amministrazione sono quelle che hanno meno possibilità di fare – dice Cantone – Spesso fanno meno carriera. Spesso sono meno responsabilizzati perché considerati per bene”. Secondo Cantone è ora di recuperare parole che non si usano nel nostro mondo del lavoro. Una è la parola “controllo”. E il presidente dell’anticorruzione si riferisce a chi osserva i colleghi timbrare il cartellino e poi lasciare il posto di lavoro senza denunciare nulla. Quello che serve, secondo Cantone, è una “riscossa interna” e un recupero non imposto dall’alto di moralità e cultura dello Stato, il terzo settore e di conseguenza il nostro Paese si salveranno dalla mala gestione della cosa pubblica.
Commenti disabilitati su Cantone: “Non sono tutti fannulloni ma nella Pubblica amministrazione, le persone perbene hanno meno possibilità”, scrive Antonio Menna il 28 ottobre 2015 su “Italia Ora”. “Non sono tutti fannulloni nella Pubblica amministrazione. Meno che mai sono tutti corrotti. Ma è vero che le persone perbene sono quelli che vengono meno coinvolti nelle scelte, meno responsabilizzati. Sono quelli che hanno meno possibilità di fare carriera”. Lo dice chiaro e tondo, Raffaele Cantone, magistrato anticamorra, e presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Lo dice nel corso di una intervista pubblica al Sermig di Torino e il segmento sulla corruzione nella pubblica amministrazione (rilanciato da un video del Corriere della Sera) è quello che impressiona di più. Quante volte lo abbiamo pensato che essere onesti è una penalizzazione? Chi è onesto non va lontano. “A volte, però”, chiarisce Cantone, “anche per sue responsabilità. Dobbiamo trovare il coraggio di ripristinare alcune parole che nel nostro lessico si sono dimenticate: la parola controllo, per esempio. Se il mio amico, vicino di stanza, usa il badge per coprire i colleghi che magari sono in vacanza, devo stare zitto? Perché devo stare zitto? Queste apparenti distrazioni sono complicità. La società dei piccoli favori, magari banali, magari che non portano necessariamente alla corruzione, ci abitua all’idea che ci sia uno spazio dove tutto si può comprare.” “Il problema – conclude Cantone – non è solo la disonestà ma, a volte, anche non capire con chi parlare. Ci sono cento centri di costo solo nella città di Roma, cento uffici che fanno appalti e spesa. Come li controlli? La deresponsabilizzazione la fa da padrona, ed è essa stessa una delle ragioni che giustifica la corruzione.”
In Italia si fa carriera solo se si è ricattabili, scrive il 5 giugno 2015 Claudio Rossi su "L'Uomo qualunque". “Il nostro Paese sta sprofondando nel conformismo (…) siamo usciti da una consultazione elettorale che ha dato il risultato a tutti noto, ma la cosa che colpisce è questo saltare sul carro del vincitore. Tacito diceva che una delle abitudini degli italiani è di ruere in servitium: pensate che immagine potente, correre ad asservirsi al carro del vincitore. Noi tutti conosciamo persone appartenenti al partito che ha vinto le elezioni che hanno opinioni diverse rispetto ai vertici di questo partito. Ora non si tratta affatto di prendere posizioni che distruggono l’unità del partito, ma di manifestare liberamente le proprie opinioni senza incorrere nell’anatema dei vertici di questo partito (…) Queste persone, dopo il risultato elettorale, hanno tirato i remi in barca e le idee che avevano prima, oggi non le professano più. Danno prova di conformismo. (…) La nostra rappresentanza politica è quella che è (…) La diffusione della corruzione è diventata il vero humus della nostra vita politica, è diventata una sorta di costituzione materiale. Qualcuno, il cui nome faccio solo in privato, ha detto che nel nostro Paese si fa carriera in politica, nel mondo della finanza e dell’impresa, solo se si è ricattabili (…) Questo meccanismo della costituzione materiale, basato sulla corruzione, si fonda su uno scambio, un sistema in cui i deboli, cioè quelli che hanno bisogno di lavoro e protezione, gli umili della società, promettono fedeltà ai potenti in cambio di protezione. È un meccanismo omnipervasivo che raggiunge il culmine nei casi della criminalità organizzata mafiosa, ma che possiamo constatare nella nostra vita quotidiana (…) Questo meccanismo funziona nelle società diseguali, in cui c’è qualcuno che conta e che può, e qualcuno che non può e per avere qualcosa deve vendere la sua fedeltà, l’unica cosa che può dare in cambio (…) Quando Marco Travaglio racconta dei casi di pregiudicati o galeotti che ottengono 40 mila preferenze non è perché gli elettori sono stupidi: sanno perfettamente quello che fanno, ma devono restituire fedeltà. Facciamoci un esame di coscienza e chiediamoci se anche noi non ne siamo invischiati in qualche misura. (…) Questo meccanismo fedeltà-protezione si basa sulla violazione della legge. Se vivessimo in un Paese in cui i diritti venissero garantiti come diritti e non come favori, saremmo un paese di uomini e donne liberi. Ecco libertà e onestà. Ecco perché dobbiamo chiedere che i diritti siano garantiti dal diritto, e non serva prostituirsi per ottenere un diritto, ottenendolo come favore. Veniamo all’autocoscienza: siamo sicuri di essere immuni dalla tentazione di entrare in questo circolo? (…) Qualche tempo fa mi ha telefonato un collega di Sassari che mi ha detto: “C’è una commissione a Cagliari che deve attribuire un posto di ricercatore e i candidati sono tutti raccomandati tranne mia figlia. Sono venuto a sapere che in commissione c’è un professore di Libertà e Giustizia…”. Io ero molto in difficoltà, ma capite la capacità diffusiva di questo sistema di corruzione, perché lì si trattava di ristabilire la par condicio tra candidati. Questo per dire quanto sia difficile sgretolare questo meccanismo, che si basa sulla violazione della legge. Siamo sicuri di esserne immuni? Ad esempio, immaginate di avere un figlio con una grave malattia e che debba sottoporsi a un esame clinico, ma per ottenere una Tac deve aspettare sei mesi. Se conosceste il primario del reparto, vi asterreste dal chiedergli il favore di far passare vostro figlio davanti a un altro? Io per mia fortuna non mi sono mai trovato in questa condizione, ma se mi ci trovassi? È piccola, ma è corruzione, perché se la cartella clinica di vostro figlio viene messa in cima alla pila, qualcuno che avrebbe avuto diritto viene posposto. Questo discorso si ricollega al problema del buon funzionamento della Pubblica amministrazione: se i servizi funzionassero bene non servirebbe adottare meccanismi di questo genere. Viviamo in un Paese che non affronta il problema della disonestà e onestà in termini morali. (…) Se non ci risolleviamo da questo, avremo un Paese sempre più clientelarizzato, dove i talenti non emergeranno perché emergeranno i raccomandati, e questo disgusterà sempre di più i nostri figli e nipoti che vogliono fare ma trovano le porte sbarrate da chi ha gli appoggi migliori. È una questione di sopravvivenza e di rinascita civile del nostro Paese. Ora, continuiamo a farci questo esame di coscienza: non siamo forse noi, in qualche misura, conniventi con questo sistema? Quante volte abbiamo visto vicino a noi accadere cose che rientrano in questo meccanismo e abbiamo taciuto? Qualche tempo fa, si sono aperti un trentina di procedimenti penali a carico di colleghi universitari per manipolazione dei concorsi universitari (…) Noi non sapevamo, noi non conoscevamo i singoli episodi (…) e per di più non siamo stati parte attiva del meccanismo, ma dobbiamo riconoscere che abbiamo taciuto, dobbiamo riconoscere la nostra correità. Proposta: Libertà e Giustizia è una associazione policentrica che si basa su circoli, che sono associazioni nella associazione, radicati sul territorio e collegati alla vita politica. Non sarebbe il caso che i circoli si attrezzassero per monitorare questi episodi, avendo come alleati la stampa libera e la magistratura autonoma? Potrebbe essere questa una nuova sfida per Libertà e Giustizia, controllare la diffusione di questa piovra che ci invischia tutti, cominciando dal basso, perché dall’alto non ci verrà nulla di buono, perché in alto si procede con quel meccanismo che dobbiamo combattere.” Gustavo Zagrebelsky.
“I cittadini silenziosi possono essere dei perfetti sudditi per un governo autoritario, ma sono un disastro per una democrazia”. Robert Alan Dahl
Il volume più letto dai politici? Un manuale per ottenere l'immunità. Alle Biblioteca delle Nazioni Unite non hanno più nemmeno una copia. Spiega i vari tipi di immunità e chi può usufruire, scrive Gabriele Bertocchi Venerdì, 08/01/2016, su “Il Giornale”. Non è un semplice libro, è il libro che ogni politico dovrebbe leggere. E infatti è cosi, tutto lo vogliono. È diventato il libro più richiesto alla biblioteca delle Nazioni Unite. Vi starete chiedendo che volume è: magari se è un'opera di letteratura classica, oppure un trattato sulla politica internazionale. Nessuno di questi, si chiama "Immunità di capi e funzionari di Stato per crimini internazionali", è uno scritto da Ramona Pedretti, ex studentessa dell’Università di Lucerna. È una tesi di dottorato, un vademecum che spiega e illustra che tipo di immunità esistono per tali soggetti. "Più che un libro è una star" commenta Maria Montagna sulle pagine de La Stampa, una delle addette alla gestione banca dati di Dag Hammarskjold Library, libreria dedicata al'ex segretario generale, alle Nazioni Unite. "È senza dubbio il libro più richiesto del 2015, anche più di classici della letteratura Onu o grandi dossier" continua l'addetta. Il successo lo si deve anche a Twitter, infatti la Dag Hammarskjold Library ha pubblicato il "primato" del libro, creando così un vero e prioprio cult da leggere. Ma all'interno cosa si può imparare, come scrive la Pedretti, autrice del volume, si può scoprire che esistono due dtipi di immunità: quella ratione personae che mette i capi di stato al riparo dalla giurisdizione penale straniera, e quella ratione materiae che protegge atti ufficiali e funzionari che agiscono per conto dello Stato dal giudizio di tribunali di altri Paesi. La Montagna spiega che "ora però la platea di lettori si è allargata vista la pubblicità dei social", ma prima era perlopiù composta da funzionari degli uffici legali e storici Onu, interessati in particolare alle conclusioni tratte da Pedretti. La tesi è che capi o alti esponenti di Stato in carica non possono essere perseguiti da corti straniere, al contrario degli ex. E intanto, come si legge su La Stampa, arriva la conferma da parte della libreria: "Mi spiace, al momento non abbiamo neanche una copia disponibile".
Va a ruba all’Onu il libro che insegna ai leader come avere l’immunità. Esaurito in biblioteca. Tesi di laurea. Il pamphlet è stato scritto da Ramona Pedretti ex studentessa dell’Università di Lucerna, scrive Francesco Semprini su “La Stampa” l’8 gennaio 2016. Basta entrare nella biblioteca delle Nazioni Unite e menzionare il nome del libro per capire che non stiamo parlando di un volume qualunque. Maria Montagna, una delle addette alla gestione della banca data di Dag Hammarskjold Library - la libreria dedicata all’ex segretario generale - guarda la collega Ariel Lebowitz e sorride. «Più che un libro è una star - dice - aspetti qui, controlliamo subito». L’opera in questione è «Immunità di capi e funzionari di Stato per crimini internazionali», un pamphlet scritto da Ramona Pedretti, ex studentessa oriunda dell’Università di Lucerna. È una tesi di dottorato, un vademecum per capire che tipo di immunità esistono per tali soggetti. Ne esistono due, come spiega Pedretti nel suo scritto, quella ratione personae che mette i capi di stato al riparo dalla giurisdizione penale straniera, e quella ratione materiae che protegge atti ufficiali e funzionari che agiscono per conto dello Stato dal giudizio di tribunali di altri Paesi. «È senza dubbio il libro più richiesto del 2015, anche più di classici della letteratura Onu o grandi dossier», dice Maria. Twitter ha fatto il resto, visto che Dag Hammarskjold Library ha rilanciato sul social network il «primato» del libro moltiplicandone notorietà e richieste. Ma chi lo chiede in prestito? All’inizio erano soprattutto funzionari degli uffici legali e storici Onu, interessati in particolare alle conclusioni tratte da Pedretti. La tesi dell’autrice è che capi o alti esponenti di Stato in carica non possono essere perseguiti da corti straniere, al contrario degli ex. È questo il principio ad esempio che ha portato all’arresto di Adolph Eichmann da parte di Israele e Augusto Pinochet dalla Spagna. «Ora però la platea di lettori si è allargata vista la pubblicità dei social», chiosa Maria. E arriva la conferma: «Mi spiace, al momento non abbiamo neanche una copia disponibile».
Fondazioni, i soldi nascosti dei politici. Finanziamenti milionari anonimi. Intrecci con banchieri, costruttori e petrolieri. Società fantasma. Da Renzi a Gasparri, da Alfano ad Alemanno, ecco cosa c'è nei conti delle fondazioni, scrivono Paolo Biondani, Lorenzo Bagnoli e Gianluca De Feo il 7 gennaio 2016 su “L’Espresso”. Finanziamenti milionari ma anonimi. Un intreccio tra ministri, petrolieri, banchieri e imprenditori. Con una lunga inchiesta nel numero in edicola “L'Espresso” ha esaminato i documenti ufficiali delle fondazioni che fanno capo ai leader politici, da Renzi a Gasparri, da Alfano a Quagliarello, tutte dominate dall'assenza di trasparenza. Nel consiglio direttivo di Open, il pensatoio-cassaforte del premier, siedono l’amico che ne è presidente Alberto Bianchi, ora consigliere dell’Enel, il sottosegretario Luca Lotti, il braccio destro Marco Carrai e il ministro Maria Elena Boschi. Il sito pubblica centinaia di nomi di finanziatori, ma omette «i dati delle persone fisiche che non lo hanno autorizzato esplicitamente». Il patrimonio iniziale di 20 mila euro, stanziato dai fondatori, si è moltiplicato di 140 volte con i contributi successivi: in totale, 2 milioni e 803 mila euro. Sul sito compaiono solo tre sostenitori sopra quota centomila: il finanziere Davide Serra (175), il defunto imprenditore Guido Ghisolfi (125) e la British American Tobacco (100 mila). Molto inferiori le somme versate da politici come Lotti (9.600), Boschi (8.800) o il nuovo manager della Rai, Antonio Campo Dell’Orto (solo 250 euro). Ma un terzo dei finanziatori sono anonimi per un importo di 934 mila euro. Ad Angelino Alfano invece fa oggi capo la storica fondazione intitolata ad Alcide De Gasperi, che ha «espresso il suo dissenso» alla richiesta ufficiale della prefettura di far esaminare i bilanci: per una fondazione presieduta dal ministro dell’Interno, la trasparenza non esiste. Nell’attuale direttivo compaiono anche Fouad Makhzoumi, l’uomo più ricco del Libano, titolare del colosso del gas Future Pipes Industries. Tra gli italiani, Vito Bonsignore, l’ex politico che dopo una condanna per tangenti è diventato un ricco uomo d’affari; il banchiere Giovanni Bazoli, il marchese Alvise Di Canossa, il manager Carlo Secchi, l’ex dc Giuseppe Zamberletti, l’ex presidente della Compagnia delle Opere Raffaello Vignali, l’avvocato Sergio Gemma e il professor Mauro Ronco. Ma tutti i contributi alla causa di Alfano sono top secret. Invece la fondazione Magna Carta è stata costituita dal suo presidente, Gaetano Quagliariello, da un altro politico, Giuseppe Calderisi, e da un banchiere di Arezzo, Giuseppe Morbidelli, ora numero uno della Cassa di risparmio di Firenze. Gli altri fondatori sono tre società: l’assicurazione Sai-Fondiaria, impersonata da Fausto Rapisarda che rappresenta Jonella Ligresti; la Erg Petroli dei fratelli Garrone; e la cooperativa Nuova Editoriale di Enrico Luca Biagiotti, uomo d’affari legato a Denis Verdini. Il capitale iniziale di 300 mila euro è stato interamente «versato dalle tre società in quote uguali». I politici non ci hanno messo un soldo, ma la dirigono insieme ai finanziatori. Nel 2013 i Ligresti escono dal consiglio, dove intanto è entrata Gina Nieri, manager di Mediaset. L’ultimo verbale (giugno 2015) riconferma l’attrazione verso le assicurazioni, con il manager Fabio Cerchiai, e il petrolio, con Garrone e il nuovo consigliere Gianmarco Moratti. La fondazione pubblica i bilanci, ma non rivela chi l’ha sostenuta: in soli due anni, un milione di finanziamenti anonimi. La Nuova Italia di Gianni Alemanno invece non esiste più. “L’Espresso” ha scoperto che il 23 novembre scorso la prefettura di Roma ne ha decretato lo scioglimento: «la fondazione nell’ultimo anno non ha svolto alcuna attività», tanto che «le raccomandate inviate dalla prefettura alla sede legale e all’indirizzo del presidente sono tornate al mittente con la dicitura sconosciuto». Ai tempi d’oro della destra romana sembrava un ascensore per il potere: dei 13 soci promotori, tutti legati all’ex Msi o An, almeno nove hanno ottenuto incarichi dal ministero dell’agricoltura o dal comune capitolino. All’inizio Gianni Alemanno e sua moglie Isabella Rauti figurano solo nel listone dei 449 «aderenti» chiamati a versare «contributi in denaro». I primi soci sborsano il capitale iniziale di 250 mila euro. Tra gli iscritti compaiono tutti i fedelissimi poi indagati o arrestati, come Franco Panzironi, segretario e gestore, Riccardo Mancini, Fabrizio Testa, Franco Fiorito e altri. La “Fondazione della libertà per il bene comune” è stata creata dal senatore ed ex ministro Altero Matteoli assieme ad altre dieci persone, tra cui politici di destra come Guglielmo Rositani (ex parlamentare e consigliere Rai), Eugenio Minasso, Marco Martinelli e Marcello De Angelis. A procurare i primi 120 mila euro, però, sono anche soci in teoria estranei alla politica, come l’ex consigliere dell’Anas Giovan Battista Papello (15 mila), il professor Roberto Serrentino (10 mila) e l'imprenditore, Erasmo Cinque, che versa 20 mila euro come Matteoli. La fondazione, gestita dal tesoriere Papello, pubblica i bilanci: tra il 2010 e il 2011, in particolare, dichiara di aver incassato 374 mila euro dai «soci fondatori», altri 124 mila di «contributi liberali» e solo duemila dalle proprie attività (convegni e pubblicazioni). Gli atti della prefettura però non spiegano quali benefattori li abbiano versati. Espressione di Massimo D'Alema, ItalianiEuropei nel 1999 è stata una delle prime fondazioni. I fondatori sono l'ex premier Giuliano Amato, il costruttore romano Alfio Marchini, il presidente della Lega Cooperative, Ivano Barberini, e il finanziere esperto in derivati Leonello Clementi. Il capitale iniziale è di un miliardo di lire (517 mila euro), quasi totalmente versati da aziende o uomini d’affari: 600 milioni di lire da varie associazioni di cooperative rosse, 50 ciascuno da multinazionali come Abb ed Ericsson, la Pirelli di Tronchetti Provera, l’industriale farmaceutico Claudio Cavazza, oltre che da Marchini (50) e Clementi (55). ItalianiEuropei deposita regolari bilanci e ha autorizzato la prefettura di Roma a mostrarli. L’ultimo è del 2013. Gli atti identificano solo i finanziatori iniziali del 1998. A quei 517 mila euro, però, se ne sono aggiunti altri 649 mila sborsati da «nuovi soci», non precisati. Nei bilanci inoltre compare una diversa categoria di «contributi alle attività» o «per l’esercizio»: in totale in sei anni i finanziamenti ammontano a un milione e 912 mila euro. Italia Protagonista nasce nel 2010 per volontà di due leader della destra: Maurizio Gasparri, presidente, e Ignazio La Russa, vicepresidente. Tra i fondatori, che versano 7 mila euro ciascuno, c’è un ristretto gruppo di politici e collaboratori, ma anche un manager, Antonio Giordano. Dopo la fine di An, però, La Russa e i suoi uomini escono e la fondazione resta un feudo dell’ex ministro Gasparri. Come direttore compare un missionario della confraternita che s’ispira al beato La Salle, Amilcare Boccuccia, e come vice un suo confratello spagnolo. Tra i soci viene ammesso anche Alvaro Rodriguez Echeverria, esperto e uditore del sinodo 2012 in Vaticano, nonché fratello dell’ex presidente del Costarica. L’ultimo bilancio riguarda il 2013, quando il capitale, dai 100 mila euro iniziali, è ormai salito a 231 mila. Le donazioni di quell’anno, 56 mila euro, non sono bastate a coprire le spese, con perdite finali per 63 mila, però in banca ci sono 156 mila euro di liquidità. Ma sui nomi dei benefattori, zero informazioni. «Quello che è assolutamente inaccettabile è l’assenza di una regolamentazione che quanto meno adegui le fondazioni alle regole dei partiti politici», dichiara Raffaele Cantone a “l'Espresso” : «Fermo restando che la riforma Letta sulla pubblicità ai partiti si è rivelata inadeguata, perché il sistema delle verifiche è assolutamente ridicolo, ma almeno ha introdotto un meccanismo di controllo. Sulle fondazioni invece c’è totale anarchia: non si possono conoscere entrate e uscite, non c’é trasparenza sui finanziatori».
«Non si possono conoscere entrate e uscite, non c’é trasparenza sui finanziatori. I conti delle fondazioni possono essere fatti in modo semplicistico e semplificato, senza rendere noto come arrivano i soldi e come vengono spesi», scrive Gianluca De Feo il 7 gennaio 2016 su "L'Espresso". «È una situazione che ha raggiunto i limiti dell’indecenza». Un anno fa Raffaele Cantone fu il primo a lanciare l’allarme sui fondi opachi trasferiti alla politica attraverso le fondazioni. Con un’intervista a “l’Espresso” il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione sottolineò il problema della carenza di controlli. Negli ultimi mesi le indagini hanno poi evidenziato altri sospetti sui soldi passati attraverso questi canali per finanziare l’attività dei partiti.
Raffaele Cantone, ma da allora è cambiato qualcosa?
«Non è cambiato nulla. Ma questo più che un finanziamento ai partiti è un modo di sovvenzionare gruppi interni ai partiti, quelle che un tempo si chiamavano correnti. Nel tempo le correnti si sono organizzate in realtà di tipo associativo: questa scelta potrebbe essere positiva, perché in qualche modo dà una struttura evidente alle correnti. Quello che è assolutamente inaccettabile è l’assenza di una regolamentazione che quanto meno adegui le fondazioni alle regole dei partiti politici. Fermo restando che la riforma Letta sulla pubblicità ai partiti si è rivelata inadeguata, perché il sistema delle verifiche è assolutamente ridicolo, ma almeno ha introdotto un meccanismo di controllo. Sulle fondazioni invece c’è totale anarchia. Viene previsto solo il controllo formale e generico delle prefetture, che non hanno capacità di incidere sui bilanci: non si possono conoscere entrate e uscite, non c’é trasparenza sui finanziatori. I conti delle fondazioni possono essere fatti in modo semplicistico e semplificato, senza rendere noto come arrivano i soldi e come vengono spesi».
Molte di queste fondazioni politiche sono semplici associazioni, che non depositano neppure una minima documentazione.
«Bisogna tenere presente che nel nostro Paese per ragioni culturali queste realtà sono state un momento significativo della libertà di associazione. Nel diritto civile sono previste le associazioni non riconosciute, tutelate perché si tutela la libertà di associazione, che devono avere una loro possibilità di operare. Il problema è che in questi casi viene a mancare persino quel minimo di controllo esercitato dalle prefetture: sono in tutto uguali a una bocciofila. Non ci sono né regole, né rischi legali quando vengono usate per incassare finanziamenti sospetti: possono solo incorrere in verifiche fiscali della Guardia di Finanza se emergono pagamenti in nero. È una carenza normativa che si fa sentire e più volte il Parlamento ha espresso esigenza di intervenire. Sono stati presentati diversi disegni di legge, alcuni dei quali validi, ma non sono mai andati in discussione».
Negli organi che gestiscono le fondazioni politiche c’è poi una diffusa commistione tra centinaia di imprenditori e di politici. È una confusione che può alimentare i conflitti di interesse?
«In sé non è un aspetto deleterio. Che ci sia un legame nelle attività delle fondazioni tra chi svolge politica attiva e chi si occupa di attività economiche, imprenditoriali e professionali, non è un dato atipico delle moderne democrazie. Anzi, avviene in tutte le democrazie occidentali. Il problema è che i potenziali conflitti di interesse possono essere contrastati o attenuati solo attraverso meccanismi di trasparenza. Se l’imprenditore Tizio finanzia la fondazione del politico Caio e questo dato è noto, come avviene ad esempio negli Usa, questo sterilizza il conflitto d’interessi perché quando si discuterà di provvedimenti che riguardano l’imprenditore Tizio, direttamente o indirettamente, tutti potranno rendersi conto dei legami. Quello che è grave è l’assenza di pubblicità nel modo in cui le due situazioni si interfacciano all’interno delle fondazioni».
Alfano nasconde i soldi perfino ai suoi prefetti. La Fondazione presieduta dal ministro non pubblica l'elenco dei finanziatori. E il dg Rai è sponsor di Renzi, scrive Paolo Bracalini Sabato, 09/01/2016, su “Il Giornale”. Un investimento da appena 250 euro che ne rende ogni anno 650mila (di stipendio), un posto di assoluto comando nella tv pubblica e prima ancora il Cda di Poste italiane. In epoca di rendimenti bassi o negativi, l'investimento di Antonio Campo Dall'Orto è da manuale di finanza. Il nuovo direttore generale della Rai ha donato 250 euro alla Fondazione Open, la cassaforte renziana, entrando così nel cerchio ristretto degli amici dell'ex sindaco di Firenze, che poi da premier ha ricambiato quelli che aveva creduto in lui nominandoli nelle partecipate pubbliche. Dall'Orto è uno dei molti finanziatori «in chiaro» della fondazione guidata da Maria Elena Boschi, Luca Lotti e Marco Carrai. I donatori, cioè, che hanno dato il consenso alla pubblicazione dei propri nomi nell'elenco dei finanziatori del think tank legato a Renzi.Ma c'è una zona grigia. Sui 2.803.953,49 euro raccolti dalla Open, infatti, quasi un terzo (913mila euro) arriva da ignoti sostenitori del renzismo che preferiscono restare anonimi. E nemmeno tirando in ballo le prefetture, che per legge vigilano (poco) su enti di diritto privato come le fondazioni, si riesce a sapere di più. Il test lo ha fatto l'Espresso, contattando via mail sette prefetti di altrettanti città italiane (da Roma a Napoli) dove hanno sede le associazioni politiche espressione di qualche leader o presunto tale. Ma anche l'intervento dello Stato, nella figura del prefetto, non sembra illuminare granché di quella zona d'ombra che nasconde le modalità di finanziamento delle fondazioni. Il paradosso è che persino quella che fa capo ad Angelino Alfano, ministro dell'Interno e dunque riferimento istituzionale dei prefetti, «esprime dissenso» alla richiesta di fornire bilanci e informazioni sulla Fondazione De Gasperi, presieduta appunto dal leader di Ncd e capo del Viminale. L'unico patrimonio tracciabile risale all'eredità della vecchia Dc, 400 milioni di lire, passati alla fondazione intitolata al grande statista democristiano. Il resto dei finanziatori si può solo immaginare guardando i membri del consiglio di amministrazione (Bazoli di Intesa San Paolo, il miliardario libanese Makhzoumi Fouad...), visto che la fondazione del ministro non si rende trasparente ai prefetti. E donatori ne servono, visto che anche il 5 per mille per l'associazione di Alfano è andato molto male: l'ultima volta solo 59 contribuenti hanno espresso la preferenza nella dichiarazioni dei redditi, per complessivi 6.700 euro. Spiccioli. Di fondazioni politiche ce n'è un centinaio, ma le più importanti (e ricche) sono una ventina. Ricevono fondi ministeriali, accedono al 5 per mille, hanno sgravi fiscali, a differenza dei partiti possono ricevere donazioni da aziende pubbliche - munifici colossi come Eni, Finmeccanica, Poste - e non devono rendere pubblici i bilanci. Tanti vantaggi che ne spiegano la proliferazione. Una di quelle storiche è ItalianiEuropei di Massimo D'Alema. Quando nasce, nel 1999, viene innaffiata di soldi da cooperative rosse, grosse multinazionali, colossi della farmaceutica. La fondazione dell'ex premier Ds ha autorizzato la prefettura a rendere pubblici i suoi bilanci. Dai quali, però, non si ricavano le informazioni complete sui finanziatori. In totale dai rendiconti fino al 2013 risultano quasi 2 milioni di euro di donazioni, registrate genericamente come «contributi all'attività» da «nuovi soci». Ma quali siano i loro nomi non è dato saperlo.
Figuraccia italiana nella visita a Riad: rissa per il Rolex regalato a Renzi & C. I 50 membri della delegazione si sono azzuffati per i regali offerti dalla famiglia reale. Il premier li fa sequestrare ma a Palazzo Chigi non sono ancora arrivati, scrive TGCOM il 9 gennaio 2016. Monta la polemica per il viaggio diplomatico e commerciale compiuto da Matteo Renzi e una delegazione politico-economica in Arabia Saudita l'8 novembre 2015. E non c'entrano gli appalti miliardari o la crisi internazionale con l'Iran a causa delle esecuzioni capitali compiute da Riad. Il problema sono i Rolex, i regali che i ricchi sauditi avevano preparato per alcuni membri della delegazione italiana ma che alla fine tutti avrebbero preteso. Stando alle indiscrezioni di stampa questi Rolex non è chiaro che fine abbiano fatto. E' il Fatto Quotidiano a ricostruire la vicenda: i 50 ospiti arrivati da Roma (tra cui vertici di aziende statali e non come Finmeccanica, Impregilo e Salini) sono a cena con la famiglia reale. Arrivano gli omaggi preparati dagli sceicchi, pacchettini con nomi e cognomi, in italiano e arabo. C'è il pacchettino di serie A, con il Rolex svizzero, e quello, diciamo, di serie B con un cronografo prodotto a Dubai che vale "solo" 4mila euro. Il fattaccio avviene quando un furbetto della delegazione italiana scambia il suo cronografo arabo col pacchetto luccicante svizzero. Il "proprietario" del Rolex se ne accorge e scoppia una quasi rissa. Tutti vogliono il Rolex, i reali sauditi sarebbero anche pronti a cambiare tutti i regali pur di non vedersi di fronte questa scena da mercato del pesce. Ma interviene la security di Renzi che sequestra tutti i pacchetti. Ora, denuncia il Fatto Quotidiano, di questi orologi si è persa traccia. Va ricordato che il governo di Mario Monti varò una norma che impedisce ai dipendenti pubblici di accettare omaggi del valore superiore a 150 euro. I Rolex e gli altri cadeau avrebbero dovuto essere depositati nella stanza dei regali al terzo piano di Palazzo Chigi. Ma qui non si trovano. Interpellata sul caso, Ilva Saponara, padrona del cerimoniale di Palazzo Chigi, non risponde, dice di avere la febbre e di non ricordare nemmeno il contenuto dei doni offerti dai sauditi. Anche l’ambasciatore Armando Varricchio, consigliere per l'estero di Renzi, non parla ma annuisce di fronte alla ricostruzione del caso. Non dice che fine hanno fatto i Rolex ma rassicura: "I doni di rappresentanza ricevuti dalla delegazione istituzionale italiana, in occasione della recente visita italiana in Arabia Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi, dello scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio e non le cariche istituzionali". Se ne deduce che qualcuno ancora non ha restituito il Rolex in questione. E chissà se mai lo farà.
Governo in visita in Arabia Saudita. La missione finisce in rissa per i Rolex in regalo. Durante la trasferta a Ryad dello scorso novembre, i delegati italiani si sono accapigliati per dei cronografi da migliaia di euro, un omaggio dei sovrani sauditi. Per questo la delegazione del premier li ha sequestrati. Nota di Palazzo Chigi: "Sono nella nostra disponibilità", scrive Carlo Tecce l'8 gennaio 2016 su "Il Fatto Quotidiano". Parapiglia tra dirigenti del governo in viaggio con Matteo Renziper i Rolex elargiti dagli amici di Ryad. Questo racconto, descritto da testimoni oculari, proviene dall’Arabia Saudita. È una grossa figuraccia internazionale per l’Italia. È ormai la notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre. Il palazzo reale di Ryad è una fonte di luce che illumina la Capitale saudita ficcata nel deserto. La delegazione italiana, che accompagna Matteo Renzi in visita ai signori del petrolio, è sfiancata dal fuso orario e dal tasso d’umidità. La comitiva di governo è nei corridoi immensi con piante e tende vistose, atmosfera ovattata, marmi e dipinti. Gli italiani vanno a dormire. Così il cerimoniale di Palazzo Chigi, depositario degli elenchi e dei protocolli di una trasferta di Stato, prima del riposo tenta di alleviare le fatiche con l’inusuale distribuzione dei regali. Quelli che gli oltre 50 ospiti di Roma – ci sono anche i vertici di alcune aziende statali (Finmeccanica) e private (Salini Impregilo) – hanno adocchiato sui banchetti del salone per la cena con la famiglia al trono: deliziose confezioni col fiocco, cognome scritto in italiano e pure in arabo. Gli illustri dipendenti profanano la direttiva di Mario Monti: gli impiegati pubblici di qualsiasi grado devono rifiutare gli omaggi che superano il valore di 150 euro oppure consegnarli subito agli uffici di competenza. Qui non si tratta di centinaia, ma di migliaia di euro. Perché i sovrani sauditi preparano per gli italiani dei pacchetti con orologi preziosi: avveniristici cronografi prodotti aDubai, con il prezzo che oscilla dai 3.000 ai 4.000 euro e Rolex robusti, per polsi atletici, che sforano decine di migliaia di euro, almeno un paio. A Renzi sarà recapitato anche un cassettone imballato, trascinato con il carrello dagli inservienti. Il cerimoniale sta per conferire i regali. Il momento è di gioia. Ma un furbastro lo rovina. Desidera il Rolex. Scambia la sua scatoletta con il pacchiano cronografo con quella dell’ambito orologio svizzero e provoca un diverbio che rimbomba nella residenza di re Salman. Tutti reclamano il Rolex. Per sedare la rissa interviene la scorta di Renzi: sequestra gli orologi e li custodisce fino al ritorno a Roma. La compagine diplomatica, guidata dall’ambasciatore Armando Varricchio, inorridisce di fronte a una scena da mercato di provincia per il chiasso che interrompe il sonno dei sauditi. Anche perché i generosi arabi sono disposti a reperire presto altri Rolex pur di calmare gli italiani. Non sarà un pezzo d’oro a sfaldare i rapporti tra Ryad e Roma: ballano miliardi di euro di appalti, mica affinità morali. Nonostante le decapitazioni di Capodanno, tra cui quella dell’imam sciita che scatena la furia dell’Iran, per gli italiani Ryad resta una meta esotica per laute commesse. E che sarà mai una vagonata di Rolex? Il guaio è che degli orologi, almeno durante le vacanze natalizie, non c’era più traccia a Palazzo Chigi. Non c’erano nella stanza dei regali al terzo piano. Chi avrà infranto la regola Monti e chi l’avrà rispettata? E Renzi ce l’ha o non ce l’ha, il Rolex? La dottoressa Ilva Sapora, la padrona del cerimoniale di Palazzo Chigi, non rammenta il contenuto dei doni. Ha la febbre e poca forza per rovistare nella memoria. Varricchio ascolta le domande e la ricostruzione dei fatti di Ryad: annuisce, non replica. Varricchio è il consigliere per l’estero di Renzi, nonché il prossimo ambasciatore italiano a Washington. Allora merita un secondo contatto al telefono. Non svela il destino del Rolex che ha ricevuto, ma si dimostra comprensivo: “I cittadini devono sapere. Queste vicende meritano la massima attenzione. Le arriverà una nota di Palazzo Chigi. Che la voce sia univoca”. Ecco la voce del governo, che non smentisce niente, che non assolve la Sapora, ma precisa i ruoli: “I doni di rappresentanza ricevuti dalla delegazione istituzionale italiana, in occasione della recente visita italiana in Arabia Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi, dello scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio e non le cariche istituzionali”. Il racconto non finisce. Cos’è accaduto dopo la notte di Ryad? Chi non voleva restituire o non ha ancora restituito i Rolex? Da il Fatto Quotidiano di venerdì 8 gennaio 2016.
Renzi, Caporale vs Fiano (Pd): “Ci fu rissa tra dirigenti per Rolex regalati dai sauditi”. “Scena ignominiosa, ma per me non c’è notizia”, continua "Il Fatto Quotidiano tv". Polemica vivace tra Antonello Caporale, inviato de Il Fatto Quotidiano, e il deputato Pd Emanuele Fiano, durante Omnibus, su La7. Lo scontro è innescato dall’articolo di Carlo Tecce, pubblicato sul numero odierno del Fatto, circa il parapiglia esploso nello scorso novembre tra i dirigenti del governo in viaggio con Matteo Renzi in Arabia Saudita: la rissa tra i dirigenti governativi della folta delegazione italiana è stata scatenata dalla generosa elargizione di circa 50 Rolex di varia fattura ad opera del re saudita. Come spiega Caporale nella trasmissione, nella hall dell’hotel di Ryad alcuni dirigenti italiani si sono ribellati perché avevano ricevuto l’orologio meno lussuoso, peraltro in barba alla legge Monti che impone di rifiutare doni oltre i 150 euro. Successivamente la scorta di Renzi ha dovuto sequestrare gli orologi, tutti prodotti a Dubai e dal valore oscillante tra3mila e 4mila euro. Caporale commenta: “Temo che la mediocrità del gruppo dirigente e di coloro che dovrebbero guidare l’Occidente a risolvere questa crisi internazionale sia tale che anche i dettagli illustrino il pessimismo generale. E questo episodio è un dettaglio significativo”. Il giornalista definisce il caso dei Rolex d’oro donati dagli ‘amici di Ryad’ un dettaglio di costume non certo folkloristico: “E’ indicatore della nostra ambiguità che ovviamente non è solo italiana, e simboleggia la debolezza dell’Occidente. Che non riesce non solo a porre un’idea generale cu come far fronte a una guerra così asimmetrica, pericolosa, atipica, difficile da condurre, ma nemmeno a misurare le forze per far fronte a cose più banali”. Insorge Fiano, che ribadisce di aver letto l’articolo de Il Fatto Quotidiano ‘parola per parola': “Qui c’è un grande titolo, ma di notizie certe non c’è nulla”. “E’ notizia certa che i Rolex siano stati dati”, replica Caporale. “L’unica fonte che viene citata” – obietta il parlamentare Pd – “è un consigliere diplomatico di Palazzo Chigi”. “C’è la nota di Palazzo Chigi alla fine dell’articolo” – ribatte la firma de Il Fatto – “lo legga tutto”. Ma il deputato Pd, pur definendo “ignominiosa” la rissa descritta nell’articolo di Tecce, ripete che non c’è notizia, né la nota di Palazzo. In realtà, la versione del governo c’è e non smentisce nulla, ma precisa i ruoli: “I doni di rappresentanza ricevuti dalla delegazione istituzionale italiana, in occasione della recente visita italiana in Arabia Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi, dello scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio e non le cariche istituzionali”.
CHI FA LE LEGGI?
Chi fa le leggi? Tante proposte ma poche tagliano il traguardo. E otto su dieci sono del governo. Dati Openpolis: nelle ultime due legislature la percentuale di successo delle iniziative di Palazzo Chigi è stata 36 volte più alta di quelle parlamentari. L'apice con Letta. I tempi: neanche due settimane per il trattato su risanamento banche e bail in, quasi 800 giorni per Italicum, divorzio breve e anti-corruzione, scrive Michela Scacchioli il 5 gennaio 2016 su “La Repubblica”. Neanche due settimane per ratificare il trattato sul fondo di risoluzione unica, quello - tanto discusso in questi giorni di proteste dei risparmiatori - su risanamento bancario e salvataggio interno (bail in). Ben 871 giorni, invece, per licenziare il ddl sull'agricoltura sociale che ha impiegato quasi due anni e mezzo per diventare legge. Nel mezzo ci sono da un lato lo svuota-carceri, i decreti lavoro, fallimenti, missione militare Eunavfor Med, competitività e riforma della pubblica amministrazione che hanno tagliato il traguardo con - al massimo - 44 giorni di tempo. Dall'altro si piazzano Italicum, divorzio breve, ecoreati, anti-corruzione e affido familiare che oscillano tra i 664 e i 796 giorni necessari al via libera finale. Leggi lepre. E leggi lumaca. Per rimanere in tema: durante la consueta conferenza stampa di fine anno, il premier Matteo Renzi ha detto a proposito delle unioni civili che sì, il tema divide, ma che "nel 2016 queste vanno" necessariamente "portate a casa" perché "a differenza di quello che avrei voluto, non siamo riusciti ad approvare nel 2015" il ddl Cirinnà presentato in commissione a Palazzo Madama già a marzo del 2013 e successivamente modificato. "Purtroppo - ha poi aggiunto Renzi - non siamo riusciti a tenere il tempo. Da segretario del Pd farò di tutto perché il dibattito che si apre al Senato" a fine gennaio "sia il più serio e franco possibile. Un provvedimento di questo genere non è un provvedimento su cui il governo immagina di inserire l'elemento della fiducia, bisognerà lasciare a tutti la possibilità di esprimersi". In fatto di leggi, tuttavia, i numeri appaiono chiari. Sono 565 le norme approvate nelle ultime due legislature su un totale di oltre 14mila proposte. In percentuale, però, tra quelle che sono riuscite a completare l'iter, otto su dieci sono state presentate dal governo e non dal parlamento italiano nonostante - costituzionalmente - siano Camera e Senato a essere titolari del potere legislativo. Vero è che nel corso degli anni, i governi, detentori di quello esecutivo, hanno ampliato il proprio raggio d'azione. Tanto che la percentuale di successo delle proposte avanzate da Palazzo Chigi è 36 volte più alta di quelle parlamentari. Le cifre sono quelle analizzate (al 4 dicembre 2015) da Openpolis per Repubblica.it. Secondo l'osservatorio civico, infatti, "ormai è diventata una prassi che la stragrande maggioranza delle leggi approvate dal nostro parlamento sia di iniziativa del governo". Nell'attuale legislatura, come nella scorsa, circa l'80% delle norme approvate è stato proposto dai vari esecutivi che si sono succeduti. Ma cosa trattavano le oltre 500 leggi votate nelle ultime due legislature? E poi: nei pochi casi in cui l'iniziativa del parlamento è andata a buon fine, quali gruppi si sono resi protagonisti? Con che provvedimenti? Quanto ci vuole in media a dire sì a una legge?
Chi arriva in fondo. Un’analisi sulla produzione legislativa del nostro parlamento non può che partire dai numeri. Dei circa 183 disegni di legge che vengono presentati ogni mese, solo sei raggiungono la fine del percorso. Di questi sei, nell'80% dei casi si tratta di proposte avanzate dal governo. E mentre le iniziative di deputati e senatori diventano legge nello 0,87% delle volte, la percentuale sale al 32,02% quando si tratta del governo. Delle oltre 565 leggi approvate nelle ultime due legislature, ben 440 sono state presentate dai vari esecutivi che si sono succeduti. Fra i governi presi in considerazione, l’apice è stato raggiunto con il governo di Enrico Letta: in quel periodo il parlamento ha presentato soltanto l’11% delle leggi poi approvate.
I tempi. In media, dal momento della presentazione a quello dell’approvazione finale trascorrono 151 giorni se si tratta di una proposta del governo. Ne passano 375 se si tratta di un’iniziativa parlamentare. Non stupisce quindi che la top 10 delle 'leggi lumaca' sia composta per il 90% da ddl presentati da deputati e senatori, e che nella top 10 delle 'leggi lepre' vi siano soltanto quelle proposte del governo. Se in media l’esecutivo impiega 133 giorni a trasformare una proposta in legge (poco più di 4 mesi), i membri del parlamento ne impiegano 408 (oltre 1 anno). Nell’attuale legislatura si evidenziano trend opposti: mentre le proposte del governo sono più lente rispetto allo scorso quinquennato, quelle del parlamento risultano più veloci.
Tante ratifiche di trattati. Un altro elemento analizzato è il contenuto di questi testi. Delle 565 leggi approvate nelle ultime due legislature, il 36,28% erano ratifiche di trattati internazionali, il 26,55% conversione di decreti leggi. Questo vuol dire che 6 volte su 10 una legge approvata da Camera e Senato non nasce in seno al parlamento ma viene sottoposta all’aula per eventuali modifiche o bocciature.
Cambi di gruppo e instabilità. Se da un lato la XVII legislatura ha confermato lo squilibrio fra governo e parlamento nella produzione legislativa, dall'altro ha introdotto una forte instabilità nei rapporti fra maggioranza e opposizione. Il continuo valzer parlamentare dei cambi di gruppo, con la nascita di tanti nuovi schieramenti (molti dei quali di 'trincea' fra maggioranza e opposizione) ha fatto sì che l'opposizione reale, dati alla mano, fosse composta solamente da tre gruppi: Fratelli d'Italia, Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Soltanto questi tre infatti, alla fine hanno votato nella maggior parte dei casi in contrasto con il Partito democratico.
Pd in testa. Dalle politiche del 2013, sono 30 le proposte di deputati e senatori che hanno completato l’iter parlamentare (su più di 5mila ddl di iniziativa parlamentare). Protagonista assoluto è il Partito democratico, che ha presentato il 73,33% dei testi in questione. A seguire Forza Italia (10%), e poi 5 gruppi a pari merito: Movimento 5 Stelle, Scelta Civica, Per le Autonomie-Psie-Maie, Misto e Lega Nord.
I decreti. A seguire nell'analisi, con un’altra fetta importante della torta, le conversioni in legge dei decreti emanati dai vari governi che si sono susseguiti. La conversione in legge dei decreti è una delle attività principali del nostro parlamento. Succede molto raramente che un testo deliberato dal Consiglio dei ministri non venga poi approvato da Camera e Senato. Negli ultimi 4 governi, il più 'efficiente' è stato è stato quello a guida Letta, con soltanto il 12% dei decreti decaduti. I decreti deliberati dal Consiglio dei ministri devono essere convertiti entro 60 giorni. Non sorprende quindi che il 90% delle leggi che rientra nella top 10 delle più veloci sia conversione di decreti. Fra le 10 più lente invece, tutte tranne una sono state proposte da membri del parlamento. La legge di iniziativa governativa più lenta è stata l’Italicum, che ha impiegato 779 giorni dal momento della presentazione per completare il suo iter.
Le Regioni. Nelle ultime due legislature le Regioni italiane hanno presentato 119 disegni di legge. Di questi, solamente 5 hanno completato l’iter, e tutti nello scorso quinquennato. Tre dei cinque erano modifiche agli statuti regionali (di Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), uno è stato approvato come testo unificato (in materia di sicurezza stradale), mentre l’ultimo è stato assorbito nella riforma del federalismo fiscale sotto il governo Berlusconi.
Come si vota. Un altro elemento fondamentale nell'approvazione delle leggi è il voto. Soffermandosi in particolare sull'attuale legislatura, l'analisi si è concentrata su chi ha contribuito, e in che modo, all'approvazione finale di questi provvedimenti. Dalla percentuale di posizioni favorevoli sui voti finali dei singoli gruppi presenti in aula, alla consistenza della maggioranza nel corso della legislatura, passando per il rapporto fra voti finali e questioni di fiducia. Se si prende il Pd come punto di riferimento in qualità di principale forza politica all'interno della coalizione di governo, si è ricostruita la distanza (o vicinanza) dall’esecutivo degli altri gruppi parlamentari. Il primo dato che emerge è che su 435 votazioni finali, in 104 occasioni (23,01%), tutti i gruppi alla Camera e al Senato hanno votato con il Pd.
Le opposizioni. Il comportamento delle opposizioni nei voti finali regala molti spunti interessanti. Perché se su carta alcuni schieramenti nel corso dei mesi si sono dichiarati in contrasto con gli esecutivi di Letta prima e Renzi poi, i dati raccontano altro. Nei voti finali alla Camera, ad esempio, Sel, gruppo di opposizione, ha votato il 52% delle volte in linea col Pd. Al Senato, ramo in cui i numeri a favore dell’esecutivo sono più risicati, solamente due gruppi (Lega Nord e Movimento 5 Stelle) hanno votato nelle maggior parte dei voti finali (più del 50%) diversamente dal Pd.
Voto di fiducia: chi l'ha usato di più. Per completare il quadro sulle votazioni, non si poteva non affrontare il tema delle questioni di fiducia sui progetti di legge. Due gli aspetti analizzati: da un lato il rapporto tra blindatura e leggi approvate, dall’altro le occasioni durante le quali lo strumento è stato utilizzato più di due volte sullo stesso provvedimento. Non solo la maggior parte delle leggi viene proposta dal governo, ma emerge pure che l'approvazione richiede un utilizzo elevato delle questioni di fiducia. In media, nelle ultime due legislatura, il 27% delle leggi approvate ha necessitato di un voto di fiducia, con picchi massimi raggiunti dal governo Monti: il 45,13 per cento. Ma quali sono stati i provvedimenti che hanno richiesto più voti di fiducia? Al primo posto c'è la riforma del lavoro, governo Monti, che ha richiesto 8 voti di fiducia. Cinque voti di fiducia per il ddl anti-corruzione (sempre governo Monti) e ancora cinque per la Stabilità 2013. Quattro voti di fiducia per il decreto sviluppo e la riforma fiscale (governo Monti), tre per la legge sviluppo 2008 (governo Berlusconi). Tre voti di fiducia per la Stabilità 2014 (governo Letta), tre anche per Stabilità 2015, Italicum, Jobs Act e riforma Pa (governo Renzi).
Voti finali alla Camera. Uno dei modi per capire il reale posizionamento in aula dei gruppi parlamentari è vedere se il loro comportamento durante i voti finali è in linea o meno con quello del governo. Questo esercizio permette anche di osservare come è variato il sostegno all’esecutivo con la staffetta Letta-Renzi. Se da un lato Forza Italia durante il governo Letta votava l’86% delle volte con il Pd (al tempo in maggioranza), con il governo Renzi - e il riposizionamento dei berlusconiani - la percentuale è scesa al 64,57 per cento.
Voti finali al Senato. I numeri del governo a Palazzo Madama sono molto più risicati rispetto a quelli di Montecitorio. Non sorprende quindi che la maggior parte dei gruppi, per un motivo o per l’altro, spesso e volentieri abbia votato con il Pd nei voti finali dei provvedimenti discussi in aula. Da sottolineare come i fuoriusciti da Forza Italia, sia Conservatori e Riformisti (di Raffaele Fitto) che Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (di Denis Verdini), da quando sono nati hanno votato rispettivamente il 78,69% e il 78,13% delle volte in linea con il governo nei voti finali.
Voti finali panpartisan. Nel dibattito parlamentare può succedere che su determinati argomenti si arrivi ad una votazione panpartisan. Sono i casi i cui tutti i gruppi che siedono in aula votano a favore, con nessuno ad astenersi o votare contro. Su 435 voti finali che si sono tenuti da inizio legislatura, è successo ben 104 volte (23,91%). Più ricorrente al Senato (28,10%) che alla Camera (20%). Trattasi principalmente, nel 74% dei casi, di ratifica di trattati internazionali.
I PEONES DEL PARLAMENTO.
Meteore, dissidenti e promesse mancate: qualcuno ha visto questi onorevoli? Morani, Moretti, Picierno e Bonafè nel Pd, Capezzone e Minzolini a destra, gli ex 5 stelle Currò e Rizzetto. E poi ancora tanti altri. C'è stato un momento in cui il dibattito politico ruotava solo intorno a loro. E adesso sembrano scomparsi, scrive Susanna Turco il 6 novembre 2015 su "L'Espresso". Un Parlamento di meteore. Grandi o piccole come granelli di sabbia. Veloci come bolidi, oppure più lente: visibili giusto per il tempo del loro incendiarsi, dopo l’impatto con la notorietà o con il leader di turno, poi basta. Alcune magari torneranno a illuminare le prime pagine, chissà. Dipende. Sta di fatto che mai come in questi anni, il fenomeno dello sciame di meteore è massiccio. Sarà anche colpa di un Parlamento sbilenco e inedito: nel quale il Pd è quello selezionato da Bersani, ma governa con Renzi; dove il centrodestra è entrato unito, per poi dissolversi nei tanti rivoli della decadenza berlusconiana; o i Cinque stelle, naive (candidi ed ingenui) delle Camere, hanno aperto la scatoletta di tonno della loro prima selezione sul campo. Nell’insieme, comunque, non pochi. Come in una specie di Spoon River della rilevanza, giusto per cominciare dal Pd ci si può chiedere che fine abbia fatto una come Alessia Morani. Iniziale notorietà per un tatuaggio sul piede, poi responsabile giustizia del Pd, tanta tv e qualche gaffe, infine l’approdo alla vicepresidenza del gruppo alla Camera e la sostanziale sparizione. Una parabola terrificante, quasi brutale. E Simona Bonafè? Lanciata in orbita per le europee, agguantò un record di preferenze: oltre 288 mila, terza arrivata, prima tra le donne. Poi basta: come se non ci fosse. Eppure, era una delle fedelissime di Renzi, se la batteva con la Boschi e ne usciva persino meglio di lei. Sparita pure Pina Picierno, la terzina di sfondamento che esibiva i propri scontrini in tv, pur di dimostrare che gli ottanta euro di Renzi avrebbero cambiato la vita agli italiani. Alessandra Moretti? La sua scia luminosa è stata più lunga: prima con Bersani, responsabile della comunicazione poi renziana in lizza alle europee (230 mila preferenze, arrivò quarta) quindi in corsa per la Regione Veneto. Incarico per il quale ha mollato l’europarlamento. Dopo il flop contro Zaia, quasi nulla: fa la capogruppo dem in regione, dopo aver auspicato un profonda analisi nel partito sulle ragioni della sconfitta, e aver chiarito che un po’ è dipeso anche da look castigato da ferroviera. C’è poi la massa sempre crescente dei cosiddetti dissidenti. Si illuminano più forte via via che si avvicinano all’annuncio di una scissione: poi si scindono (o decidono di non scindersi) ed entrano nell’emisfero nero. Che fine ha fatto Roberto Speranza? La grande partita del rinnovamento nella continuità, nel Pd, pareva potersi reggere sull’aria da ragazzino dell’uomo scelto da Bersani per fare il capogruppo alla Camera. Invece, poi, ci si è messa di mezzo la battaglia sull’Italicum: all’annuncio delle sue dimissioni di protesta, Renzi invece di aprire il “dibbbattito”, ha alzato le spalle ed è andato oltre. Adesso, come certi grandi amici che si son persi di vista, ci si accorge che Speranza non è più tanto in giro solo quando capita di incrociarlo. Non poi tanto dissimile la parabola di Pippo Civati. Grande promessa dell’anti-Renzismo, da quando non sta nello stesso partito del suo antagonista filosofico, ha perso motivazione, si è come dissolto. Ma non è sparito. Certo, perché poi non tutte le meteore si dissolvono: alcune arrivano a terra, salvo diventare invisibili nel tratto terminale del percorso. E’ il cosiddetto “volo buio”. Una categoria cui si può dire appartenga Miguel Gotor: dopo sei mesi passati a parlare di derive autocratiche, è sparito. Sta ancora ben là, pronto a rispuntare, chissà quando. In Forza Italia e dintorni, per non entrare nei casi meteoritici delle giovani promesse che paiono già bruciate prima di cominciare (vedasi Silvia Sardone e i fratelli Zappacosta), si hanno pure casi di “volo buio”. Dieci mesi fa, in piena epoca di elezioni quirinalizie, impazzava il duo Raffaele Fitto e Daniele Capezzone. Sembravano i padroni prossimi venturi del centrodestra. E invece si sono scissi e hanno smesso di diventare determinanti. Spariti, fino al prossimo giro almeno. E che fine ha fatto Augusto Minzolini? L’ex direttorissimo del Tg1 dettava la linea nel partito di Berlusconi: poi si è fatto via via sempre più dissidente, fino a cadere nell’ombra. Maleficio oscuro sembra quello che ha avvolto Mario Mauro. Già possibile delfino di Berlusconi, poi montiano, quindi saggio di Napolitano e ministro con Letta, infine perno del Parlamento: fu estromesso dalla commissione Affari costituzionali, dopo che il suo voto era stato determinante per far passare l’ordine del giorno di Calderoli sulla riforma del Senato. Parlò di “purghe renziane”, poi finì a Gal. Le ultime notizie, a cercarle, lo danno partecipante al cosiddetto “gruppo di Rovereto”, insieme con Antonio Fazio, Raffaele Bonanni e Mario Tassone. Perché poi fino a poco tempo fa, diciamolo, era più semplice. Se ti eri conquistato la tua fama, che fossi un Razzi o al contrario un Follini, poi nessuno ti toglieva il ruolo, almeno fino alla fine della legislatura. Finché c’era la poltrona, c’era lo spazio. Adesso, al contrario, la poltrona resta: è semmai la sua incidenza a sparire. E soprattutto, la faccenda si brucia in tempi rapidissimi, fulminei. Meteoritici, appunto. La cosa prende un suo giro particolare tra i grillini. Qui il caso è un po’ diverso: entrati con lo slogan dell’uno vale uno, i Cinque stelle hanno attraversato il processo di selezione della classe dirigente quando erano già in Parlamento. Per questa via, si sono perse le tracce ad esempio di Vito Crimi, uno dei primi volti pentastellati quando insieme con Roberta Lombardi si incaricò da capogruppo delle estenuanti consultazioni di Bersani. Pareva lui quello con più cartucce, e invece. Ma ci sono anche casi di promesse mancate: a inizio legislatura i bookmaker puntavano parecchio su Marta Grande da Civitavecchia, in predicato addirittura per diventare presidente della Camera, prima di svanire nella quotidianità parlamentare. Ci sono quindi i casi dei mezzi leader, la cui incidenza va in combinato disposto con la critica al capo: per mesi pareva che il futuro dei Cinque stelle dipendessero dalle mosse di Tommaso Currò o di Walter Rizzetto. Poi Currò è entrato nel Pd, Grillo ha fatto il direttorio con Di Maio e Di Battista, e molti saluti.
Sempre presenti ma ininfluenti: la triste vita dei peones del PD. Sono ai primi posti per partecipazione al voto in Aula. Assicurano la tenuta del governo. Compensano le assenze dei colleghi della maggioranza. Ma vengono usati solo come stampella per far approvare le leggi. Sulle quali riescono a incidere poco o nulla. Nel dossier sulla produttività di deputati e senatori, la sorte di tanti sconosciuti onorevoli dem, scrive Paolo Fantauzzi il 18 dicembre 2015 su “L’Espresso”. Dati Openpolis. Da quando ha fatto il suo ingresso alla Camera, la deputata Pd Cinzia Maria Fontana non ha perso un colpo: in quasi tre anni è riuscita a non mancare nemmeno a una delle oltre 14 mila votazioni elettroniche d'Aula. Mai un'influenza, un imprevisto, un ritardo l'ha tenuta lontana dal suo scranno. Nessuno è stato più assiduo di lei, nell'emiciclo di Montecitorio. Eppure, a fronte di tale impegno stacanovista, questa ex sindacalista Cgil ha una produttività che è la metà rispetto a quella dei suoi colleghi. Risultato: è relegata nella parte bassa della classifica, alla posizione numero 408. Giuseppe Guerini siede sulla sua stessa fila, a pochi banchi di distanza. Anche lui del Pd, anche lui lombardo, anche lui diligentissimo. Di votazioni ne ha saltate due soltanto: lo scorso 24 novembre, durante la quarta lettura della riforma costituzionale firmata Maria Elena Boschi. Eppure - malgrado il 99,99 per cento di presenze in Aula lo collochi al secondo posto - anche lui ha un indice di efficacia molto al di sotto della media e in classifica è solo 323esimo. Come anche il terzo sul podio Tino Iannuzzi, pure lui Pd, 260esimo. È la triste vita del peone del Partito democratico, messa in luce dal nuovo dossier dell'associazione Openpolis dedicato alla produttività parlamentare e presentato in anteprima dall'Espresso. Un indice calcolato in base alla partecipazione ai lavori, alla presentazione di atti, all'approvazione di propri progetti di legge o alla capacità di raccogliere su di essi un consenso trasversale, con l'assegnazione di diversi punteggi. Il risultato è un valore che consente di valutare la capacità di incidere sulla legislazione di ogni singolo deputato e senatore. Che dimostra, ad esempio, proprio il ruolo negletto di tanto sconosciuti deputati del Pd, ridotti a schiaccia-pulsanti per conto del governo: fondamentali per assicurarne la tenuta, compensare le assenze negli altri partiti della maggioranza e convertire i decreti di Palazzo Chigi ma dall'influenza scarsa o nulla. Soprattutto alla Camera. Un male che però non sembra affliggere i senatori democratici, tutti nella parte alta della classifica. Come spiegare questa differenza? Innanzitutto col fatto che a Palazzo Madama i parlamentari sono la metà e quindi è più agevole influire sul processo legislativo. Ma anche perché al Senato il Pd ha “solo” 112 onorevoli (contro i 302 di Montecitorio) e quindi è più facile diventare relatore di qualche disegno di legge e guadagnare punteggio. Con un Parlamento ridotto da anni a propaggine del governo di turno, il risultato è comunque che tantissimi onorevoli democratici si limitano a fare presenza. Un pacchetto di mischia buono per strappare l'ovale all'avversario ma spesso incapace di fare meta. Fra i primi 50 deputati per tasso di partecipazione ai lavori d'Aula, ad esempio, quelli del Pd sono 45 ma navigano per lo più nella parte bassa della classifica. E i loro colleghi meno assidui non fanno meglio: nel complesso tre quarti degli eletti dem (ben 226) non raggiungono la sufficienza. Solo Forza Italia fa peggio. Musica simile a Palazzo Madama: fra i 20 più presenti, 17 sono del Partito democratico ma il 60 per cento dei senatori del gruppo (ovvero 67) risultano al di sotto della media di produttività. Insomma, col pallino in mano al governo, pochi riescono a ritagliarsi uno spazio. Il Pd in Parlamento, insomma, deve assicurare la tenuta del governo, in particolar modo al Senato dove i numeri sono più risicati. Con un paradosso: essendo alla Camera a un soffio dalla maggioranza assoluta (grazie al generoso premio di maggioranza assegnato dal bistrattato Porcellum) questo sforzo i democratici a Montecitorio lo reggono quasi da soli. E malgrado i tanti posti-chiave nell'esecutivo, i deputati di Area popolare (Ncd-Udc) non brillano affatto per zelo: più della metà sono sempre assenti. La lezione è chiara: in Parlamento pesa solo chi ha un ruolo istituzionale. Che sia la presidenza di una commissione o un incarico da capogruppo. Solo così si può sperare nell'approvazione di emendamenti a propria firma o su un incarico di relatore per i provvedimenti più delicati. In questo modo, anche senza essere un presenzialista dell'Aula, è possibile scalare la vetta della produttività. Lo dimostra il caso del deputato Francesco Paolo Sisto, l'ultrà berlusconiano che Forza Italia vorrebbe far eleggere alla Corte costituzionale. Presidente della commissione Affari costituzionali fino alla scorsa estate, è stato correlatore dell'Italicum e della riforma Boschi ed è il primo in classifica alla Camera. Malgrado abbia un tasso bassissimo di presenze: il 27 per cento appena. Proprio come un altro forzista doc: il presidente della commissione Giustizia del Senato, Nitto Palma, relatore del ddl Anticorruzione e di quello sul voto di scambio mafioso, che ha partecipato solo al 38 per cento delle votazioni. Sisto e Palma non sono soli. La terza classificata alla Camera, Donatella Ferranti, presiede la commissione Giustizia e ha partecipato solo a 1 votazione su 3. Ma ci sono anche eccezioni lodevoli, di parlamentari che concepiscono il loro lavoro anche sotto il profilo della presenza ai lavori. La prima classificata al Senato, Loredana De Petris (Sel), è capogruppo sia in Aula che in commissione Affari costituzionali e ha un tasso di partecipazione dell'84 per cento. Ancora più diligente Giorgio Pagliari (Pd), che al terzo posto per produttività aggiunge il 96 per cento di presenze.
I presenzialisti dell'Aula replicano al dossier sulla produttività parlamentare, che li bolla come diligenti ma ininfluenti. Citando Baresi, Oriali, il senso della squadra e la preminenza del collettivo, scrive Paolo Fantauzzi il 4 gennaio 2016 su “L’Espresso”. Da Gabriele Oriali, il calciatore dell'Inter citato da Luciano Ligabue per la sua vita da mediano e senza onori, al deputato peones del Pd il passo è breve. Il lavoro dietro le quinte, lontano dalla ribalta dei riflettori ma fondamentale, che sia per vincere una partita o far sopravvivere il governo. Senza starsi troppo a piangere se Openpolis ti cataloga come improduttivo («anche Franco Baresi segnava poco»), ti senti usato solo come schiacchia-pulsanti o al telefono il massimo che ti può capitare è di essere confuso per omonimia col vicesegretario del partito. Perché alla fine “l'importante è la Ditta”. Eccolo qui, il peones-pensiero. Un misto fra il senso del collettivo e la versione 2.0 dello spirito di abnegazione e sacrificio di marca Pci. Con un paradosso: nella falange parlamentare che sostiene il governo, nessuno dei deputati più diligenti è un renziano osservante: i tre primatisti per presenze sono infatti una ex cuperliana ora avvicinatasi alla sinistra dialogante del ministro Maurizio Martina (Cinzia Fontana), un ex civatiano orfano di Civati (Beppe Guerini) e un fedelissimo di Vincenzo De Luca (Tino Iannuzzi). Riassunto della puntata precedente: come ogni anno l'associazione Openpolis pubblica il suo dossier sulla capacità dei parlamentari di incidere sull'attività legislativa. Risultato: ai primi posti per presenze ci sono sconosciuti parlamentari del Pd dall'efficacia assai bassa. Insomma è la triste vita dei peones dem: sono sempre presenti ma ininfluenti. Replica dei diretti interessati: ma quali peones, ma quali tristezza. «È riduttivo vederla così, la maggioranza è garantita grazie a tanta gente come noi che si impegna, anche se non risulta» afferma Cinzia Fontana, un passato nella Cgil di Cremona e oggi primatista col 100 per cento di presenze. Uno stakanovismo emerso già la scorsa legislatura, quando era senatrice, finita con un tasso di partecipazione ai lavori del 99 per cento («ma solo perché eravamo all'opposizione e a volte uscivamo dall'Aula senza partecipare al voto» precisa lei). In ogni caso guai a parlare di improduttività: «Essere misurati con le statistiche rischia solo di alimentare il senso di frustrazione e l'idea di non contare nulla anziché valorizzare il lavoro dietro le quinte, che c'è pure se non si vede». Ma nessuno si sente svalutato per essere ridotto a uno schiaccia-pulsanti per conto del governo? Un minimo di insoddisfazione, fra i deputati Pd, c'è: «È normale che ci sia la consapevolezza di non poter fare il massimo perché siamo tanti. E siccome questo inevitabilmente porta a malumori e frizioni, la dirigenza del gruppo deve fare uno sforzo perché ci sia il giusto riconoscimento di chi garantisce la presenza in Aula. Ma è una questione di divisione dei ruoli: in una squadra, come in un partito, non tutti possono essere attaccanti. L'importante è la Ditta. Come direbbe Ligabue, la nostra è una vita da mediano». Esattamente lo stesso concetto, solo fronte milanista, espresso pure dal secondo classificato, Beppe Guerini: «Giudicare un parlamentare dalla produttività è come valutare un giocatore in base ai gol che fa. Se uno prende Franco Baresi e va a vedere quanto ha segnato oppure si ricorda solo il rigore sbagliato al Mondiali del '94 non riesce davvero a farsi un'idea. Il Pallone d'oro l'ha mai vinto? Eppure l'han dato ad attaccantuncoli che uno nemmeno si ricorda». In quasi tre anni questo 40enne avvocato bergamasco è mancato solo un giorno (lo scorso 24 novembre), ma perché aveva un funerale. Grazie alla fortuna è riuscito a non mancare da Montecitorio nemmeno quando è diventato papà (era il 1° Maggio). Guerini è alla prima esperienza in Parlamento e il suo finisce così per essere anche un bilancio da metà legislatura: «Abbiamo un punteggio basso perché noi del Pd siamo tanti e possiamo dividerci i provvedimenti, mentre spesso le opposizioni hanno un solo rappresentante in commissione. E anche questa storia che si lavora poco... Se hai voglia di approfondire certi temi, anche tecnici, c'è lavoro per tutti e se in commissione instauri un buon rapporto col presidente o col capogruppo, qualche soddisfazione te la prendi. Solo che magari non si vede: io ad esempio ho partecipato a tutti i tavoli di maggioranza per la legge sulla class action, dove si limava il testo con gli altri partiti, ma questo non risulta da nessuna parte». Insomma, nessuna frustrazione o senso di sottovalutazione: «In fin dei conti io sono un avvocato di provincia, chi me lo avrebbe detto che sarei arrivato fin qui. All'inizio capitava che qualcuno di importante, magari dell'opposizione, mi chiamasse attraverso la batteria della Camera. Poi, parlandoci, capivo che in realtà cercavano Guerini il vicesegretario. Adesso come telefona qualcuno che non conosco premetto sempre: "Guarda che io sono Beppe Guerini, non Lorenzo"». Infelice o no, un peone resta pur sempre un peone. A prescindere dal cognome che porta.
L'anomalia Casaleggio leader senza un voto. Si apre però un grosso problema nel M5S. Ormai Casaleggio esercita un potere assoluto sul nuovo partito, scrive Paolo Becchi Mercoledì 6/01/2016 su “Il Giornale”. Le trasformazioni all'interno del Movimento fondato da Grillo e Casaleggio sono sotto gli occhi di tutti. Grillo, dopo aver fatto togliere il suo nome dal logo, ha ormai altri pensieri (e tra questi, anche se ora non se ne parla, sicuramente lo spettacolino in programma per questo anno). A quanto pare ci siamo: Grillo è ormai assente, anche se ancora si sente la presenza della sua assenza. Si limita ormai a fare il presidente del nuovo partito che invia gli auguri di Natale, ben guardandosi dal riconoscere onestamente il fallimento del suo originario progetto rivoluzionario. Ormai è diventato, come lui stesso ammette, un ologramma in un paese di ologrammi. Più che un augurio di fine d'anno sembra uno spot pubblicitario per lo spettacolino in programma. Si apre però un grosso problema. Nonostante questi cambiamenti resta ancora Grillo, in ultima istanza, il garante delle regole? Il dato di fatto è che all'uscita di scena di Grillo non ha fatto seguito anche quella di Casaleggio, il quale a questo punto da solo esercita un potere assoluto sul nuovo partito, senza esserne il leader, anzi rivendicando di non esserne la guida, pur prendendo tutte le decisioni politiche. Da Weber in avanti è divenuto comune pensare che, nelle democrazie di massa, il leader carismatico funzioni come la reale forza che crea consenso e legittimazione. Il Movimento, volente o nolente, di fatto ne aveva uno: Grillo. E Grillo ci aveva insegnato «la nostalgia del mare vasto e infinito». Ora invece abbiamo una figura quasi invisibile sulla scena pubblica, che decide in segreto la linea politica della maggiore forza politica di opposizione. Insomma, si potrà dire tutto il male che si vuole di Berlusconi, Renzi e Salvini, ma sono leader che ci «mettono la faccia». Nel caso del Movimento, invece, abbiamo una forza politica pilotata da chi è in grado, utilizzando il blog che comunque porta ancora il nome di Grillo, di manipolare l'informazione e al contempo (come nel caso della Consulta) di controllare i parlamentari e, nell'ipotesi del futuro governo pentastellato, di controllare persino l'esecutivo. Una persona, Gianroberto Casaleggio, che non è stata mai eletta e votata da nessuno, controlla il maggior partito di opposizione, imponendo decisioni prese da lui con il ristretto gruppo del Direttorio, che funge da cinghia di trasmissione per controllare tutti gli altri parlamentari ridotti al ruolo di marionette, una persona che ormai utilizza la rete come mezzo per manipolare le coscienze e che domani potrebbe addirittura controllare dall'esterno l'intero governo. Stiamo andando verso una nuova forma di democrazia, non quella diretta, bensì quella eterodiretta. Forse per l'oligarchia finanziaria dominante è ancora meglio della democrazia di facciata di Renzi. Del resto non è un caso che sin dall'inizio la diplomazia americana e le grandi banche d'affari abbiano avuto un occhio di riguardo per il Movimento. Forse un partito ibrido, ma dichiaratamente filoatlantico e che ormai ha archiviato Grillo come un fenomeno da baraccone, è ancora meglio del partito personale di Renzi.
Vi racconto la dittatura a 5 stelle di Casaleggio. Parla Orellana (ex M5s) con Michele Pierri. Conversazione di Formiche.net del 2 gennaio 2016 con Luis Alberto Orellana, senatore, ex grillino, oggi nel gruppo Per le Autonomie. Le ultime epurazioni nel Movimento 5 Stelle, i ruoli di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, le fibrillazioni in vista delle prossime elezioni e la lotta per la leadership tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Sono alcuni degli aspetti analizzati in una conversazione di Formiche.net con Luis Alberto Orellana, senatore, ex grillino, oggi nel gruppo Per le Autonomie.
Senatore, che succede al M5s? Come mai ci sono tribolazioni mentre i sondaggi continuano a dare il partito in crescita?
«Innanzitutto va detto che i sondaggi vanno presi con le pinze. Sicuramente il movimento tiene, ma se è cresciuto davvero lo vedremo nelle urne. Molte delle fibrillazioni di questi giorni sono anche frutto di una valutazione: checché se ne dica, non si arriverà a scadenza naturale del mandato. Dopo il referendum sulle riforme costituzionali, è prevedibile che si vada al voto, probabilmente nel 2017. Quindi meglio epurare prima i parlamentari poco graditi. Per quelli in cerca di riconferma è stata un’occasione per dimostrarsi fedeli e allineati alle scelte del capo».
Da cosa dipendono, invece, le tensioni a livello locale, come nel caso di Gela?
«In alcuni posti è risultato chiaro che mentre a livello nazionale alcune carenze riescono per il momento ad essere mascherate non essendo chiamati a governare, negli enti locali è più evidente che la selezione della classe dirigente non ha funzionato. È difficile mettere mano ai problemi, anche se non è il caso del sindaco di Gela. Mentre le espulsioni e il modo in cui vengono attuate non sono altro che una parte di una strategia di comunicazione del M5s che purtroppo abbiamo imparato a conoscere bene nel tempo. Di fronte a delle divergenze, legittime in politica, si tende a rappresentare un mondo diviso in buoni e cattivi, bianco o nero. Naturalmente dalla parte della ragione c’è sempre e solo chi la pensa come i vertici del movimento, dall’altro tutti gli altri, epurati compresi. Invece la storia è ben diversa e più complessa di come viene raccontata».
Quali sono i veri motivi delle ultime epurazioni, come quella di Serenella Fucksia, ma anche del sindaco di Gela?
«Nel M5s si assiste sin dalla sua nascita a una vera e propria dittatura politica. Il sindaco di Gela ha provato a lavorare autonomamente per il bene dell’intera comunità, saltando gli steccati ideologici e di parte, come dovrebbe fare ogni amministratore locale. Evidentemente questo è bastato a farlo fuori. Ma anche il caso della Fucksia è esemplare. Nel suo caso si è trattato di differenti opinioni politiche. Ad esempio, sul voto al Jobs act si era astenuta, invece di votar contro. Non conosco le ragioni della sua scelta, ma evidentemente non condivideva la posizione del suo partito su quello specifico argomento. In quel momento il M5s, invece di aprire una discussione sul tema, come sarebbe stato giusto e normale in politica, è stata inserita nella lista nera. Poi al momento giusto è stata accompagnata alla porta, con la scusa della rendicontazione effettuata in ritardo. Una motivazione francamente ridicola».
Perché non la convince?
«Nel regolamento dei Cinque stelle non c’è nessun obbligo di rendicontazione a intervalli regolari. Paradossalmente, un parlamentare potrebbe rendicontare una sola volta al termine del suo mandato. Detto ciò, la Fucksia ha effettuato in ritardo solo una rendicontazione, adducendo fra l’altro motivi di salute. Ho fatto questo esempio, ma se ne potrebbero fare molti altri. La verità è che nel M5s si vogliono soldatini, non teste autonome e pensanti».
Perché nel caso di Gela non c’è stata una consultazione on line ma solo un comunicato del M5s regionale?
«Nel M5s le regole ci sono e non ci sono, si inventano o si usano a piacimento. La stessa Fucksia non è stata espulsa a termini di regolamento. Avrebbe dovuto essere prima decisa dall’assemblea dei parlamentari del partito e poi semplicemente ratificata dalla Rete. Senza contare che, questo modo di giudicare le persone in modo sommario, di denigrarle sul piano personale evitando il confronto politico, non fa altro che far leva sugli istinti più bassi e scatenare reazioni inquisitorie che spesso sfociano in insulti, quando non proprio in minacce, come è accaduto anche al sottoscritto».
Walter Rizzetto ha detto che ormai è Gianroberto Casaleggio a dominare mentre Beppe Grillo ormai conta poco. Lei cosa pensa a riguardo?
«Tutte le decisioni vengono prese dai Casaleggio, padre e figlio. Sono loro a gestire il blog di Grillo, che è un organo di partito a tutti gli effetti, ma sfugge ad ogni controllo interno ed esterno. Innanzitutto non si sa chi scrive, perché la maggior parte degli articoli non sono nemmeno firmati. E poi è agghiacciante che un partito sia gestito da una srl, è una cosa fuori da ogni logica democratica. Non è un caso che il M5s si opponga a qualsiasi riforma della costituzione per forme di controllo democratico e più stringenti nei partiti. Io stesso mi sono fatto promotore in Parlamento di una proposta di questo tipo. Grillo, sin dall’inizio, è stato il megafono del movimento, forse non ha mai deciso nulla. Ora però sta venendo meno anche a questo ruolo, si sta estraniando a poco a poco».
Come mai?
«Credo si sia stancato e, come ha detto lui stesso più volte, voglia tornare a fare più l’artista».
Sarà Luigi Di Maio il candidato premier del M5s alle prossime elezioni?
«In questo momento sì. Il suo teorico avversario interno, Alessandro Di Battista, sembra non essere in grado di giocarsela. Non ha la stessa capacità mediatica, a mio parere. E poi Di Maio è stato bravo a ritagliarsi un ruolo più pacato e istituzionale, mentre Di Battista è rimasto ancorato al personaggio dell’attivista».
Come si concilia l’atteggiamento intransigente e anti sistema del M5s con la votazione insieme a Pd e Area Popolare per le nomine della Consulta?
«Rappresenta di sicuro un cambiamento, anche se momentaneo e calcolato. Penso che abbiano deciso di farlo perché si sono resi conto che il danno di reputazione che stava subendo il Parlamento per quello stallo iniziava a intaccare anche loro, a causa del loro ostruzionismo. Hanno portato alla situazione al limite estremo, per poi raccogliere quello che potevano con un nome a loro gradito, nella più classica logica della politica. Vogliono comunque non fare accordi seri, perché in vista delle prossime elezioni, che credono di poter vincere, vogliono sentirsi liberi di criticare tutti senza che qualcuno possa dire loro che quando hanno governato non hanno fatto nulla. Nel caso della Consulta si può dire che nel complesso la partita l’abbiano giocata bene, a differenza di quanto è accaduto con la mozione di sfiducia al ministro Boschi».
Perché quella mozione non l’ha convinta?
«Si trattava di un testo scritto male, senza fondamento, portato poi alla Camera, dove i numeri della maggioranza sono senz’altro più ampi che al Senato. L’operazione aveva solo fini propagandistici. È servita a occupare un po’ di spazio in TV e a marcare subito una distanza dagli altri partiti dopo il voto sulla Consulta».
Ha letto l’ultimo libro di Casaleggio? Fabrizio Rondolino ci ha visto un delirio ideologico.
«Non ho letto il libro, ma ricordo bene il filmato che diffuse tempo fa, Gaia. Non mi stupiscono le frasi di Rondolino, Casaleggio ha sempre farneticato di una democrazia diretta basata sulla Rete. Per lui pare essere un dettaglio se la gente sia informata o meno di ciò che accade, basta che voti con un clic o che creda di farlo. Ma questo sistema porterebbe con sé un rischio fortissimo di derive autoritarie. La nostra, come ogni democrazia occidentale, è fondata sui partiti ed è bene che rimanga così. Le uniche nazioni a non averne sono, non a caso, i regimi totalitari, che al massimo ne hanno uno solo».
Una testata come il Financial Times ha scritto nei giorni scorsi che il M5s è cresciuto molto, anche nell’esperienza. Crede che sarebbe in grado di governare l’Italia?
«Non li ritengo assolutamente capaci di governare da soli un Paese complesso come il nostro. E non sono il solo, malgrado l’endorsement, probabilmente interessato, del Financial Times. Se già a livello locale non riescono a farlo, figuriamoci cosa potrebbe accadere sul piano nazionale. La verità è che il M5s non ha una ancora una classe dirigente degna di questo nome. I suoi parlamentari sono a stento capaci di fare buona opposizione. Non si potranno certo improvvisare ministri e sottosegretari. Sicuramente hanno compreso alcune dinamiche e hanno scelto buoni collaboratori. Ma da qui a poter governare una nazione come la nostra li separa un abisso».
Perché dico addio al Movimento 5 Stelle. Parla Paolo Becchi con Giovanni Bucchi su“Formiche” del 5 gennaio 2016. L'affondo dell'ex ideologo dei grillini: "Il Movimento si sta trasformando in un partito ibrido e ha stretto con il Pd un nuovo patto dopo quello del Nazareno facendo da stampella al governo Renzi". Ecco la conversazione di Formiche.net con il docente universitario di Filosofia del diritto. A Roma si profila un nuovo accordo in stile Patto del Nazareno, questa volta tra Pd renziano e Movimento 5 Stelle. Scaricato Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia alla deriva, il premier Matteo Renzi ha capito che sui singoli temi può trovare una sponda favorevole nei tanto avversati grillini. A differenza del precedente, il nuovo patto non viene annunciato, anzi è ripetutamente negato a gran voce e protetto dalle contrapposizioni di facciata. Si potrebbe sintetizzare così l’analisi sulla situazione del Movimento 5 Stelle fatta da Paolo Becchi in questa conversazione con Formiche.net, nella quale il professore annuncia l’addio ufficiale al Movimento con tanto di cancellazione dell’iscrizione lo scorso 31 dicembre. Un intervento che rientra nell’approfondimento avviato con l’intervista al senatore ex 5 Stelle Luis Alberto Orellana. Docente di Filosofia del Diritto all’Università di Genova, descritto in passato come l’ideologo dei 5 Stelle prima che avanzasse alcune critiche e che Beppe Grillo ne prendesse le distanze sul blog, Becchi ora parla della delusione per la piega presa dal Movimento, anticipando alcuni contenuti di un suo intervento in uscita a febbraio su Mondo Operaio dopo quello di qualche mese fa.
Professor Becchi, lei qualche mese fa ha dichiarato che il Movimento 5 Stelle si sta trasformando in un partito vero e proprio, sul modello del vecchio Pci. Ne è ancora convinto?
«Quel processo è progredito, al di là della battuta fatta. Oggi preciserei che il Movimento si sta trasformando in un partito ibrido, nel quale si cerca di fare convivere diversi aspetti. Prendiamo le elezioni amministrative: dove si può vincere ma si ha paura di farlo e magari non lo si vuole proprio, come a Roma, si sceglie di seguire l’intero e impegnativo percorso democratico per la selezione delle candidature con non so quanti passaggi in rete, facendo mostra di questo dispiegamento di energie per la democrazia diretta. Dove invece si vuole lottare per vincere davvero, il candidato e la lista vengono blindati e imposti dall’alto come accaduto con Massimo Bugani a Bologna. Questo è il partito ibrido che da un lato acchiappa chi ancora crede negli ideali di rottura del vecchio Movimento e dall’altro si avvicina alla logica partitica».
L’elezione dei giudici della Corte costituzionale rientra in questa logica?
«Certamente. Lì si è capito come il Patto del Nazareno tra Pd e Fi sia finito del tutto e ne sia nato un altro tra Pd e M5S, tenuto segretissimo tanto che chi ne parla viene ricoperto di insulti in rete, ma questa è la sostanza. Basta andarsi a leggere cosa ha scritto il blog di Grillo nel giro di due settimane: prima si critica il costituzionalista del Pd Augusto Barbera ricordando alcuni scandali concorsuali nei quali è spuntato il suo nome, poi si sposta l’attenzione sull’avversione al berlusconiano Francesco Paolo Sisto e infine si dice di aspettare le proposte di Renzi avanzando la candidatura di Franco Modugno e votando Barbera in accordo con Renzi. Tutto ciò per il sistema dei partiti è perfettamente normale, rientra nella loro logica, ma non per un Movimento che si dichiarava anti-sistema. Perché i parlamentari 5 Stelle non hanno tenuto la linea di opposizione sulle votazioni dei giudici della Consulta? Dopo 30 fumate nere sarebbe dovuto intervenire il Presidente della Repubblica, si sarebbe creato un caos istituzionale, invece loro hanno tolto le castagne dal fuoco a Renzi. Da mesi si discute su questa elezione, e Gianroberto Casaleggio va invece a dire al Corriere della Sera che non c’era tempo per coinvolgere la rete. Ma vogliamo scherzare?»
Quali altri passi prevede?
«Il prossimo sarà quello sulle unioni civili. Sulla votazione del ddl Cirinnà ci sarà l’accordo tra Renzi e l’M5S, il quale finisce così a fare nuovamente da stampella al governo, quando invece sarebbe andato incontro a grosse difficoltà. Poi la legge sullo ius soli, anche qui sconfessando Grillo. E magari per finire anche l’eutanasia. Non rendendosi conto che in questo modo si fa soltanto il gioco di Renzi».
Grillo non ha più il controllo?
«E’ stato sconfessato dal vicepresidente della Camera addirittura sul Financial Times, al quale Luigi Di Maio ha detto che loro non sono favorevoli all’uscita dell’Italia dalla Nato come invece ha sostenuto Grillo. Agli inizi del Movimento se qualcuno si fosse azzardato a dire una cosa del genere, peraltro su un giornale così importante, sarebbe stato radiato, ora invece l’intervista viene ripresa dal blog di Grillo».
E invece adesso comanda Casaleggio?
«Guardi, il mio nuovo intervento per Mondo Operaio l’ho proprio titolato “Dal Movimento liquido di Grillo al partito ibrido di Casaleggio”. Si apre però il problema del garante; Grillo ha detto che è “un po’ stanchino”, ma che sarebbe rimasto il garante delle regole. Peccato però che qui non venga rispettata nessuna regola, come sull’espulsione della senatrice Serenella Fucksia: indubbiamente c’erano motivazioni valide e l’obiettivo sarebbe stato raggiunto ugualmente, ma non c’è stata nessuna assemblea dei parlamentari con voto poi ratificato dalla rete. Ormai regna l’arbitrio, al posto del rispetto delle regole. Si critica chi non rispetta le regole e ci si comporta allo stesso modo».
E dietro l’angolo ci sono le comunali, per le quali però i sondaggi danno l’M5S in forte crescita.
«Sono convinto che alle amministrative il Movimento avrà un risultato favorevole, ma ritengo che ai vertici queste elezioni interessino poco. Ciò che conta per loro è andare al governo, ma non si sa bene per fare cosa, tranne le politiche anti-casta. Il M5S aveva una visione il nuovo partito deve ancora costruirsela».
Sono state abbandonate alcune battaglie politiche? Ad esempio quella sull’euro?
«Grillo aveva promesso agli italiani che entro il dicembre 2015 o al massimo nel gennaio 2016 ci sarebbe stato il referendum sull’euro. Ora più nessuno ne parla, salvo per i banchetti fatti in estate quando il tema appassionava di più e c’era da soffiare qualche voto alla Lega. Ma cosa pensa il Movimento sull’euro? Perché non si porta avanti con convinzione in Parlamento la legge di iniziativa popolare per il referendum? E sulla politica estera, in particolare sul tema della Nato, qual è la posizione? Grillo o Di Maio? Perché non si lancia una forte campagna di opposizione alla riforma costituzionale in vista del referendum sul quale Renzi punta tutto quest’anno? Si pensa troppo a fare opposizione di facciata, come nel caso della mozione di sfiducia alla Boschi su Banca Etruria. Insomma, il Movimento sta diventando opportunistico, nel senso che cerca di guadagnare qualcosa in ogni situazione. E per la verità al momento ci riesce benissimo. La democrazia diretta è stata da tempo accantonata e sostituita dalla democrazia eterodiretta da Casaleggio».
Becchi, è deluso?
«Sì, tanto che il 31 dicembre ho cancellato la mia iscrizione al Movimento al quale avevo aderito con grande convinzione e entusiamo; l’ho fatto perché non corrisponde più a quella speranza dell’inizio. Non sono nella testa di Beppe, e non so se questo suo progressivo farsi da parte sia sintomatico di un po’ di delusione anche da parte sua, ma è sempre più politicamente assente. Ha fatto un discorso di fine anno che era uno spot pubblicitario al suo spettacolo, un intervento teatrale nel quale dice che tutti siamo ologrammi ma, ahimé, è diventato un ologramma pure lui. Forse era inevitabile che il Movimento si istituzionalizzasse, ma il sogno è finito».
Fatti, tesi e bufale...Tutte le ultime panzane a 5 stelle del blog di Beppe Grillo, scrive Simona Sotgiu il 4 gennaio 2016 su "Formiche". Lo smog che uccide 68mila vittime in più all’anno, l’endorsement del Financial Times che definirebbe il Movimento 5 stelle “maturo per il governo”, le espulsioni e le parole di Gianroberto Casaleggio al Corriere della Sera hanno riportato i pentastellati sulle prime pagine dei giornali. Sul sito dei 5 stelle negli ultimi giorni sono apparsi alcuni articoli che si sono rivelati incompleti (nessuno studio individua lo smog come unica causa della crescita dei decessi in Italia) o falsi (il Financial Times non ha scritto che il Movimento 5 stelle è maturo per il governo, ma che vuole essere preso sul serio). “L’incremento delle morti c’è stato eccome. Ma di qui a imputare la causa solo all’inquinamento ce ne vuole”. A parlare è Gian Carlo Blangiardo, demografo, citato sul blog di Beppe Grillo a sostegno di un post in cui si legava l’aumento dei decessi in Italia allo smog. “Ci sono invece un mix di motivi – ha spiegato il docente dell’Università di Milano Bicocca – tutti fondanti. Primo, l’invecchiamento della popolazione”. Lo smog, dunque, è sì tra le possibili cause dell’aumento dei decessi, ma non certamente l’unica. Tra le cause individuate da Blangiardo e pubblicate nello studio di Neodemos ci sono l’invecchiamento della popolazione, il crollo delle vaccinazioni e, ha spiegato Blangiardo al Mattino, “a questo aggiungiamo la forte crisi del sistema sanitario: a furia di tagliare, risparmiare e spostare si è finito col costringere i pazienti a pagare di tasca propria gli esami in strutture private”. Una traduzione italo-grillesca, ha svelato l’economista Giampaolo Galli sul suo blog, quella comparsa sul blog di Grillo relativa all’articolo del Financial Times dedicato ai pentastellati, in cui il Movimento sarebbe stato definito “Maturo”, “Un partito dal passato eccentrico” che “si reinventa come seria alternativa a Renzi”. Ma la traduzione, sottolinea il deputato Galli, già in Bankitalia e alla direzione generale di Confindustria, non è troppo fedele. Sul FT, infatti, si legge: “Protest group has come a long way since its eccentric start and is now the country’s second party”. Il FT, spiega Galli, non definisce il M5s né maturo né serio, ma prende atto del percorso politico che l’ha portato dall’essere un partito eccentrico alla seconda forza politica in Italia. Nella traduzione del FT si dimentica, poi, l’aggettivo “populista” usato da giornalista James Politi proprio nelle prime righe dell’articolo, di cui Di Maio sostiene che il movimento sia l’antidoto e non la tossina. Ma è vero che il movimento di Grillo e Casaleggio aspira a governare l’Italia e così anche le principali città, come Milano e Roma. “Roma è una tappa obbligata prima del governo – ha dichiarato Casaleggio al Corriere della Sera – Un banco di prova. Se avessimo paura di governare Roma non potremmo neppure pensare di voler governare il Paese”. Ma secondo il senatore ex grillino Luis Alberto Orellana sentito da Formiche.net “La verità è che il M5s non ha una ancora una classe dirigente degna di questo nome. I suoi parlamentari sono a stento capaci di fare buona opposizione. Non si potranno certo improvvisare ministri e sottosegretari. Sicuramente hanno compreso alcune dinamiche e hanno scelto buoni collaboratori. Ma da qui a poter governare una nazione come la nostra li separa un abisso”. Il blog di Beppe Grillo ha ospitato, nel corso del tempo, numerose “notizie” considerate bufale, soprattutto relative a temi scientifici. Un articolo del 2014 di Wired ne ricorda le più rilevanti: scie chimiche, campagne contro la vivisezione che hanno rischiato di bloccare la ricerca in Italia, sostegno al metodo Stamina di Davide Vannoni, campagne anti vaccini considerati causa dell’autismo (il calo dei vaccini, peraltro, sostiene lo studio di Blangiardo, è proprio una delle cause dell’aumento dei decessi in Italia nell’ultimo anno). Le bufale a 5 stelle sembrano avere tutte un punto in comune: la critica e messa in discussione del sapere riconosciuto dalla comunità scientifica che, per quanto criticabile, viene in alcuni casi messo da parte a favore di un sapere ancora in costruzione, che per gli esperti è privo di fondamento e metodo.
C'è l'Italia a 5 stelle. Casaleggio vuole processi infiniti per tutti. Casaleggio: le prime tre cose che faremo al governo. «Via prescrizione» Grillo: «Come? Ho 40 processi aperti». Botta e risposta (a distanza) tra il guru e il comico. Tra i primi punti: “Per la pubblica amministrazione sceglieremo sulla base della fedina penale", scrive Marta Serafini su “Il Corriere della Sera” il 18 ottobre 2015. Inizia con Casaleggio che fa un giro per gli stand della piazza grillina di Imola. Pochissime parole, circondato da un servizio d’ordine severissimo, il guru del Movimento ha aggiunto qualche elemento in più rispetto a quanto detto dal palco di sabato sera, quando ha spiegato che la squadra di governo dei 5 stelle sarà scelta dagli iscritti. «Tra i primi punti del nostro programma (che sarà anch’esso votato dalla base come annunciato sabato sera, ndr), c’è eliminare la corruzione con gli onesti». Un refrain del Movimento dunque. Ma poi Casaleggio, dopo aver dribblato le domande sull’abolizione del nome di Grillo dal logo, va oltre con un annuncio più sostanzioso «Metteremo mano alla giustizia abolendo la prescrizione», dice a voce bassissima. Una notizia che però non piace troppo a Grillo. Ai microfoni di CorriereTv, il comico (anzi, l’Elevato come ha chiesto di essere chiamato ieri) sbotta: «Come abolire la prescrizione? Io c’ho 40 processi». Poi scherza e, a un cronista che gli chiede delle unioni civili, dice: «1,2,3 al mio tre ti dimenticherai le domanda». Il tutto mentre una signora tenta di baciarlo e la sicurezza la respinge in malo modo. È ancora Casaleggio a dare le risposte più politiche, ossia «mettere persone oneste nelle amministrazioni». E Il primo criterio sarà «la fedina penale», i sospettabili non sarà possibile sceglierli. A scegliere persone e proposte, ancora una volta saranno gli attivisti, attraverso la piattaforma «che è in grado di accogliere i contenuti, che possono essere tanti e diversi». Il problema sarà piuttosto fare una sintesi, è l’ammissione del guru che annuncia anche dei miglioramenti sulla piattaforma. Sui tempi Casaleggio non si sbottona. Ma assicura che lo stesso sistema sarà applicato anche per scegliere i candidati sindaco. Insomma, si preannuncia vivace la seconda e ultima giornata della kermesse grillina. E c’è anche una piccola contestazione, «chiedetegli ai grillini quanto hanno pagato per l’affitto dell’autodromo!», dice un ragazzo in rollerblade e poi scappa via. Mentre la piazza aspetta il gran finale di stasera con Alessandro Di Battista. All’ora di pranzo, Grillo torna sul palco e grida: «Non siamo un movimento siamo una finanziaria della Madonna». E poi ripete: «Siamo l’arca di Noè, siamo la salvezza. E pensate quando la moglie di Noè gli diceva che cazzo stai facendo?», scherza. Poi cita Bob Kennedy (il Pil non è indicatore di benessere). Ma anche Willy il Coyote (“che corre anche quando non c’ha il terreno sotto i piedi”) ma anche le amebe osservate da uno studioso giapponese che ad un certo punto hanno iniziato a muoversi («Sono come me e Casaleggio»). E il filo rosso della kermesse di Imola rimane l’utopia: «Non abbiamo bisogno di leader e di guru. E nemmeno di Elevati. Abbiamo bisogno di un paese in cui i nostri figli vogliano rimanere».
M5S, Casaleggio: "Se andiamo al governo eliminiamo la prescrizione", scrive “Libero Quotidiano”. "La prima cosa da fare è eliminare la corruzione con l'onestà, mettere mano alla giustizia ed eliminare la prescrizione". Lo ha detto Gianroberto Casaleggio rispondendo dalla festa dei 5 Stelle a Imola ai giornalisti che gli chiedevano le prime tre cose da fare se il Movimento 5 Stelle andasse al governo. Poi, ha proseguito Casaleggio, "bisogna mettere persone oneste nelle amministrazioni scelte in base alla fedina penale. I sospettabili - ha sottolineato - non sarà possibile sceglierli". "Casaleggio? Pura follia" - "La proposta di Casaleggio è pura follia. Con la lentezza dei processi in Italia e con l'uso politico che si fa della giustizia nel nostro Paese, eliminare la prescrizione vorrebbe dire tenere ogni singolo cittadino in ostaggio per tutta la vita", è il commento di Elvira Savino, deputata di Forza Italia. "Le parole dello stratega della comunicazione di Grillo - aggiunge Savino - dimostrano tutta la pericolosità del Movimento 5 stelle, profondamente illiberale e fondato sul giustizialismo. Il grillismo è un riadattamento ai tempi moderni di quel dipietrismo che è già fallito e che tanti danni ha prodotto al nostro Paese". «I grillini confermano la loro imbarazzante inclinazione al becero giustizialismo» aggiunge la collega di partito Gabriella Giammanco.
Il fatto che qualcuno additi qualcun altro di essere ladro è storia vecchia.
Milano e Roma, oltre il (solito) duello, scrive di Goffredo Buccini su “Il Corriere della Sera” del 29 ottobre 2015. Sembra la rivincita di tutti i luoghi comuni: capitale morale contro capitale reale, Milano operosa contro Roma infetta. Rieccolo, l’eterno duello, vent’anni dopo Tangentopoli, al tempo di Mafia Capitale. Tra gli applausi per un successo dell’Expo che tanti non prevedevano e i patemi per un Giubileo che pare cadere nel momento peggiore. Raffaele Cantone accredita questa narrazione quando, davanti a Giuliano Pisapia, condanna Roma «priva di anticorpi» e osanna Milano che «ha dimostrato di essere la città più importante d’Italia». Poche ore dopo, per effetto delle prevedibili polemiche, aggiusta un po’ il tiro: «Non volevo criticare Roma ma pungolarla». Di certo il presidente dell’Autorità anticorruzione non è salito al Nord per coniare slogan. E questa storia delle due capitali non si può ridurre a una bega tra bonari cummenda e lobbisti cacio e pepe come in una vecchia barzelletta. Nel declino di Roma e nella resurrezione di Milano ci sono percorsi dentro i quali si scorge l’altalenante destino nazionale. La Milano sterilizzata dall’inchiesta Mani Pulite, che spazzò via assieme ai ladri anche pezzi nobili di tradizione e cultura cittadina, ha compiuto infine la traversata del deserto, è tornata al centro d’Europa; non ha debellato gli scandali (basti pensare ai guai della sanità lombarda) e tuttavia s’è strappata di dosso quell’etichetta infame, mondata da venti milioni di visitatori all’Expo e preservata dalla vigilanza dell’Anac che ha messo alle corde le paranze dell’intrallazzo riapparse con il ritorno dei nonni sempreverdi Frigerio e Greganti. La Roma che fu laboratorio e modello, quella del primo Giubileo di Rutelli e dei fasti cinematografici di Veltroni, ha poi divorato se stessa negli anni del Cecato Carminati e del «compagno» Buzzi, inconfessabili partner d’affari di una politica marcia; e adesso assiste, con la crisi psico-istituzionale di Ignazio Marino, all’epilogo tragicomico d’un dramma fatto di buche, rifiuti, difficoltà del vivere quotidiano. Priva persino di un sindaco accreditato a tutelarla, si ritrova difesa da Gianni Alemanno, l’ex sindaco che con Buzzi e Carminati è inquisito. Cantone, plenipotenziario del renzismo nel mondo della giustizia, vive una condizione già sperimentata da altri in passato. Un Paese smarrito gli chiede ciclicamente di assumere qualsiasi carica, benedire qualunque impresa: il rischio di parlare troppo è umanissimo. Tuttavia sarebbe miope derubricare a «voce dal sen fuggita» un intervento chiaramente preventivo. Cantone teme che sul Giubileo la sua Anac non riesca a produrre gli stessi risultati ottenuti sull’Expo. Perché Roma è diversa, sì, a cominciare da quegli uffici della Pubblica amministrazione dove «chi è perbene non fa carriera». Ma anche perché manca la «sinergia», parola magica che nella capitale morale ha isolato i cattivi e nella capitale reale è impronunciabile per mancanza di interlocutore. Se il disastro del Campidoglio si tirasse dietro il Giubileo, le conseguenze non ricadrebbero però solo su Roma. Il duello con Milano è da sempre così, anomalo: si perde o si vince assieme, perché alla fine chi perde o vince è l’Italia.
Giustizia, questione di misura, scrive Michele Ainis su “Il Corriere della Sera” il 29 ottobre 2015. I giudici italiani hanno appena celebrato il loro 32º congresso. Ce ne rimane un’eco d’accuse e controaccuse fra politica e giustizia, secondo tradizione. Eppure quel congresso puntava a una questione ben più rilevante della polemica sulle correnti giudiziarie o sulle intercettazioni. Economia e giustizia: come coniugarle? Non lo sappiamo, però sappiamo come farle bisticciare. La sentenza costituzionale che ha annullato le promozioni di 767 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, mettendo in crisi l’Agenzia e facendo ballare la poltrona della sua direttrice, non è che l’ultimo episodio della serie. In questa baruffa non c’è un colpevole, tuttavia non c’è nemmeno un innocente. Mettiamola così: la politica fa troppe leggi, la magistratura le prende un po’ troppo sul serio. L’una e l’altra, insomma, fanno il proprio mestiere, ma senza preoccuparsi del mestiere altrui. Questo vale, innanzitutto, nei riguardi del potere legislativo. Difatti, che cos’è la legge? Uno specchio dei nostri amori, dei nostri umori. Siamo noi, la legge. Sennonché la società italiana è diventata volubile come una farfalla; la politica ne insegue gli svolazzi, disegnando norme che durano quanto un battito d’ali (esempio: il saliscendi sui limiti al contante, da 5.000 euro a 1.000, da 1.000 a 3.000); l’instabilità legislativa nuoce all’economia, gonfia la discrezionalità del potere giudiziario; e piovono i conflitti. Sulla giustizia pesa inoltre una legislazione schizofrenica, che da un lato cerca di saziare la fame di diritti, e la sazia aprendo il rubinetto del diritto (abbiamo in circolo 50 mila leggi statali e regionali); dall’altro lato rincorre la domanda d’efficienza e di risparmio che intonano in coro gli italiani, e vi risponde negando in molti casi la tutela giudiziaria. Succede, per esempio, sul fronte della giustizia amministrativa. Dove si sta verificando una fuga dalle garanzie attraverso l’uso di rimedi alternativi a quelli giurisdizionali, attraverso le regole di soft law, attraverso oneri economici che scoraggiano i ricorsi (ormai i contributi unificati dei due gradi di giudizio, per i contratti di qualche rilievo, ammontano a 15 mila euro). Contemporaneamente viene compresso il diritto di difesa; si nega l’annullamento dei contratti per l’aggiudicazione delle grandi opere, stabilendo una tutela puramente risarcitoria, che poi ricade sulla collettività mediante la tassazione; vengono ridotti i controlli preventivi di legittimità, o altrimenti si concentrano in un’unica autorità (l’Anac), che tuttavia non può controllare l’universo; e ovviamente si mette alla berlina il giudice, quando una sentenza provochi ritardi nell’esecuzione dei lavori. Però quest’ultimo tradisce la sua specifica funzione quando a sua volta divorzia dal buon senso, che nel diritto - come nella vita - coincide con il senso della misura. Nelle questioni giuridiche, difatti, la quantità diventa qualità; e questa massima vale anche per la dimensione economica su cui nuota la tutela dei diritti. Qualche esempio. A Como, nel 2004, un barbone è stato sorpreso a rovistare tra i rifiuti, venendo immediatamente denunziato per furto di cosa pubblica. A Milano, nel 2005, un marocchino è stato processato per una truffa da 28 centesimi, impegnando per mesi magistrati, cancellieri, traduttori. A Trieste, nel 2009, i giudici hanno inflitto una multa di 25 euro a un detenuto curdo: aveva tentato d’impiccarsi riducendo a striscioline due federe, e perciò distruggendo un bene della pubblica amministrazione. A Roma, nel luglio 2015, la seconda sezione penale del tribunale ha processato un romeno incensurato per furto aggravato di un bene pubblico: aveva raccolto 22 pigne. Non che il nostro ordinamento sia cieco rispetto alle grandezze su cui incide ciascun comportamento giuridicamente rilevante. Per dirne una, nell’aprile scorso è entrato in vigore il nuovo art. 131-bis del codice penale, che funziona da esimente «per l’esiguità del danno o del pericolo». Ma la via maestra passa attraverso l’uso dei principi generali, che mettono in comunicazione il diritto con la storia, con la società, con il costume, e per l’appunto con l’economia. È questa la finestra cui deve affacciarsi il giudice. Senza inventare nuove regole, senza forzare le regole esistenti; più semplicemente, adeguandole ai casi della vita.
"PADRI DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA NOSTRA ROVINA.
Lettera da Crispi a Garibaldi - Caprera. Torino, 3 febbraio 1863.
Mio Generale! Giunto da Palermo, dove stetti poco men che un mese, credo mio dovere dirvi qualche cosa della povera isola che voi chiamaste a libertà e che i vostri successori ricacciarono in una servitù peggiore di prima. Dal nuovo regime quella popolazione nulla ha ottenuto di che potesse esser lieta. Nissuna giustizia, nissuna sicurezza personale, l'ipocrisia della libertà sotto un governo, il quale non ha d'italiano che appena il nome. Ho visitate le carceri e le ho trovate piene zeppe d'individui i quali ignorano il motivo per il quale sono prigionieri. Che dirvi del loro trattamento? Dormono sul pavimento, senza lume la notte, sudici, nutriti pessimamente, privi d'ogni conforto morale, senza una voce che li consigli e li educhi onde fosser rilevati dalla colpa. La popolazione in massa detesta il governo d'Italia, che al paragone trova più tristo del Borbonico. Grande fortuna che non siamo travolti in quell'odio noi, che fummo causa prima del mutato regime! Essa ritien voi martire, noi tutti vittime della tirannide la quale viene da Torino e quindi ci fa grazia della involontaria colpa. Se i consiglieri della Corona non mutano regime, la Sicilia andrà incontro ad una catastrofe. E' difficile misurarne le conseguenze, ma esse potrebbero essere fatali alla patria nostra. L'opera nostra dovrebbe mirare ad evitare cotesta catastrofe, affinchè non si sfasci il nucleo delle provincie unite che al presente formano il regno di Italia. Con le forze di questo regno e coi mezzi ch'esso ci offre, noi potremmo compiere la redenzione della penisola e occupar Roma. Sciolto cotesto nucleo, è rimandata ad un lontano avvenire la costituzione d'Italia. Della vostra salute, alla quale tutti c'interessiamo, ho buone notizie, che spero sempre migliori. Di Palermo tutti vi salutano come vi amano. Abbiatevi i complimenti di mia moglie e voi continuatemi il vostro affetto e credetemi. Vostro ora e sempre. F. Crispi.
La verità è rivoluzionaria. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Non credo di aver fatto del male. Nonostante ciò, non rifarei oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate, essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. Giuseppe Garibaldi (da una lettera scritta ad Adelaide Cairoli, 1868)
Cronologia moderna delle azioni massoniche e mafiose.
27 marzo 1848 - Nasce la Repubblica Siciliana. La Sicilia ritorna ad essere indipendente, Ruggero Settimo è capo del governo, ritorna a sventolare l'antica bandiera siciliana. Gli inglesi hanno numerosi interessi nell'Isola e consigliano al Piemonte di annettersi la Sicilia. I Savoia preparano una spedizione da affidare a Garibaldi. Cavour si oppone perchè considera quest'ultimo un avventuriero senza scrupoli (ricordano impietositi i biografi che Garibaldi ladro di cavalli, nell' America del sud, venne arrestato e gli venne tagliato l'orecchio destro. Sarà, suo malgrado, capellone a vita per nascondere la mutilazione) [Secondo altre fonti l’orecchio gli sarebbe stato staccato con un morso da una ragazza che aveva cercato di violentare all’epoca della sua carriera di pirata, stupratore, assassino in America Latina, NdT]. Il nome di Garibaldi, viene abbinato altresì al traffico di schiavi dall'Africa all'America. Rifornito di denaro inglese da i Savoia, Garibaldi parte per la Sicilia.
11 maggio 1860 - Con la protezione delle navi inglesi Intrepid e H.M.S. Argus, Garibaldi sbarca a Marsala. Scrive il memorialista garibaldino Giuseppe Bandi: I mille vengono accolti dai marsalesi come cani in chiesa! La prima azione mafiosa è contro la cassa comunale di Marsala. Il tesoriere dei mille, Ippolito Nievo lamenta che si trovarono pochi spiccioli di rame. I siciliani allora erano meno fessi! E' interessante la nota di Garibaldi sull'arruolamento: "Francesco Crispi arruola chiunque: ladri, assassini, e criminali di ogni sorta".
15 maggio 1860 - Battaglia di Calatafimi. Passata alla storia come una grande battaglia, fu invece una modesta scaramuccia, si contarono 127 morti e 111 furono messi fuori combattimento. I Borbone con minor perdite disertano il campo. Con un esercito di 25.000 uomini e notevole artiglieria, i Borbone inviano contro Garibaldi soltanto 2.500 uomini. E' degno di nota che il generale borbonico Landi, fu comprato dagli inglesi con titoli di credito falsi e che l'esercito borbonico ebbe l'ordine di non combattere. Le vittorie di Garibaldi sono tutte una montatura.
27 maggio 1860 - Garibaldi entra a Palermo da vincitore!....Ateo, massone, mangiapreti, celebra con fasto la festa di santa Rosalia.
30 maggio 1860 - Garibaldi dà carta bianca alle bande garibaldine; i villaggi sono saccheggiati ed incendiati; i garibaldini uccidevano anche per un grappolo d'uva. Nino Bixio uccide un contadino reo di aver preso le scarpe ad un cadavere. Per incutere timore, le bande garibaldine, torturano e fucilano gli eroici siciliani.
31 maggio 1860 - Il popolo catanese scaccia per sempre i Borbone. In quell'occasione brillò, per un atto di impavido coraggio, la siciliana Giuseppina Bolognani di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Issò sopra un carro un cannone strappato ai borbonici e attese la carica avversaria; al momento opportuno, l'avversario a due passi, diede fuoco alle polveri; il nemico, decimato, si diede alla fuga disordinata. Si guadagnò il soprannome Peppa 'a cannunera (Peppa la cannoniera) e la medaglia di bronzo al valor militare.
2 giugno 1860 - Con un decreto, Garibaldi assegna le terre demaniali ai contadini; molti abboccano alla promessa. Intanto nell'Isola divampava impetuosa la rivoluzione che vedeva ancora una volta il Popolo Siciliano vittorioso. Fu lo stesso popolo che unito e compatto costrinse i borbonici alla ritirata verso Milazzo.
17 luglio 1860 - Battaglia di Milazzo. Il governo piemontese invia il Generale Medici con 21.000 uomini bene armati a bordo di 34 navi. La montatura garibaldina ha fine. I contadini siciliani si ribellano, vogliono la terra promessagli. Garibaldi, rivelandosi servo degli inglesi e degli agrari, invia loro Nino Bixio.
10 agosto 1860 - Da un bordello di Corleone, Nino Bixio ordina il massacro di stampo mafioso di Bronte. Vengono fucilati l'avvocato Nicolò Lombardo e tre contadini, tra i quali un minorato! L'Italia mostra il suo vero volto.
21 ottobre 1860 - Plebiscito di annessione della Sicilia al Piemonte. I voti si depositano in due urne: una per il "Sì" e l'altra per il "No". Intimorendo, come abitudine mafiosa, ruffiani, sbirri e garibaldini controllano come si vota. Su una popolazione di 2.400.000 abitanti, votarono solo 432.720 cittadini (il 18%). Si ebbero 432.053 "Sì" e 667 "No". Giuseppe Mazzini e Massimo D'Azeglio furono disgustati dalla modalità del plebiscito. Lo stesso ministro Eliot, ambasciatore inglese a Napoli, dovette scrivere testualmente nel rapporto al suo Governo che: "Moltissimi vogliono l'autonomia, nessuno l'annessione; ma i pochi che votano sono costretti a votare per questa". E un altro ministro inglese, Lord John Russel, mandò un dispaccio a Londra, cosí concepito: "I voti del suffragio in questi regni non hanno il minimo valore".
1861 - L'Italia impone enormi tasse e l'obbligo del servizio militare, ma per chi ha soldi e paga, niente soldato. Intanto i militari italiani, da mafiosi, compiono atrocità e massacri in tutta l'Isola. Il sarto Antonio Cappello, sordomuto, viene torturato a morte perchè ritenuto un simulatore, il suo aguzzino, il colonnello medico Restelli, riceverà la croce dei "S.S. Maurizio e Lazzaro". Napoleone III scrive a Vittorio Emanuele: "I Borbone non commisero in cento anni, gli orrori e gli errori che hanno commesso gli agenti di Sua Maestà in un anno”.
1863 - Primi moti rivoluzionari antitaliani di pura marca indipendentista. Il governo piemontese instaura il primo stato d'assedio. Viene inviato Bolis per massacrare i patrioti siciliani. Si prepara un'altra azione mafiosa contro i Siciliani.
8 maggio 1863 - Lord Henry Lennox denuncia alla camera dei Lords le infamie italiane e ricorda che non Garibaldi ma l'Inghilterra ha fatto l'unità d'Italia.
15 agosto 1863 - Secondo stato d'assedio. Si instaura il terrore. I Siciliani si rifiutano di indossare la divisa italiana; fu una vera caccia all'uomo, le famiglie dei renitenti furono torturate, fucilate e molti furono bruciati vivi. Guidava l'operazione criminale e mafiosa il piemontese Generale Giuseppe Govone. (Nella pacifica cittadina di Alba, in piazza Savona, nell'aprile 2004 è stato inaugurato un monumento equestre a questo assassino. Ignoriamo per quali meriti.)
1866 - In Sicilia muoiono 52.990 persone a causa del colera. Ancora oggi, per tradizione orale, c'è la certezza che a spargervi il colera nell'Isola siano state persone legate al Governo italiano. Intanto tra tumulti, persecuzioni, stati d'assedio, terrore, colera ecc. la Sicilia veniva continuamente depredata e avvilita; il Governo italiano vendette perfino i beni demaniali ed ecclesiastici siciliani per un valore di 250 milioni di lire. Furono, nel frattempo, svuotate le casse della regione. Il settentrione diventava sempre più ricco, la Sicilia sempre più povera.
1868 - Giuseppe Garibaldi scrive ad Adelaide Cairoli:"Non rifarei la via del Sud, temendo di essere preso a sassate!". Nessuna delle promesse che aveva fatto al Sud (come quella del suo decreto emesso in Sicilia il 2 giugno 1860, che assegnava le terre comunali ai contadini combattenti), era stata mantenuta.
1871 - Il Governo, con un patto scellerato, fortifica la mafia con l'effettiva connivenza della polizia. Il coraggioso magistrato Diego Tajani dimostrò e smascherò questa alleanza tra mafia e polizia di stato e spiccò un mandato di cattura contro il questore di Palermo Giuseppe Albanese e mise sotto inchiesta il prefetto, l'ex garibaldino Gen. Medici. Ma il Governo italiano, con fare mafioso si schiera contro il magistrato costringendolo a dimettersi.
1892 - Si formano i "Fasci dei Lavoratori Siciliani". L'organizzazione era pacifica ed aveva gli ideali del popolo, risolvere i problemi siciliani. Chiedeva, l'organizzazione dei Fasci la partizione delle terre demaniali o incolte, la diminuzione dei tassi di consumo regionale ecc.
4 gennaio 1894 - La risposta mafiosa dello stato italiano non si fa attendere: STATO D'ASSEDIO. Francesco Crispi, (definito da me traditore dei siciliani a perenne vergogna dei riberesi) presidente del Consiglio, manda in Sicilia 40.000 soldati al comando del criminale Generale Morra di Lavriano, per distruggere l'avanzata impetuosa dei Fasci contadini. All'eroe della resistenza catanese Giuseppe De Felice vengono inflitti 18 anni di carcere; fu poi amnistiato nel 1896, ricevendo accoglienze trionfali nell'Isola.
Note di "Sciacca Borbonica": Sono molti i paesi del mondo che dedicano vie, piazze e strade a lestofanti e assassini. Ma pochi di questi paesi hanno fatto di un pirata macellaio addirittura il proprio eroe nazionale. Il 27 luglio 1995 il giornale spagnolo "El Pais", giustamente indignato per l’apologia di Garibaldi fatta dall’allora presidente Scalfaro (quello che si prendeva 100 milioni al mese in nero dal SISDE, senza che nessuno muovesse un dito) nel corso di una visita in Spagna, così gli rispose a pag. 6: “Il presidente d'Italia è stato nostro illustre visitante...... Disgraziatamente, in un momento della sua visita, il presidente italiano si è riferito alla presenza di Garibaldi nel Rio della Plata, in un momento molto speciale della storia delle nazioni di questa parte del mondo. E, senza animo di riaprire vecchie polemiche e aspre discussioni, diciamo al dott. Scalfaro che il suo compatriota [Garibaldi] non ha lottato per la libertà di queste nazioni come egli afferma. Piuttosto il contrario". Il 13 settembre 1860, mentre l'unificazione italiana era in pieno svolgimento, il giornale torinese Piemonte riportava il seguente articolo. (1): «Le imprese di Garibaldi nelle Due Sicilie parvero sin da allora così strane che i suoi ammiratori ebbero a chiamarle prodigiose. Un pugno di giovani guidati da un audacissimo generale sconfigge eserciti, piglia d'assalto le città in poche settimane, si fa padrone di un reame di nove milioni di abitanti. E ciò senza navigli e senz'armi... Altro che Veni, Vedi, Vici! Non c'è Cesare che tenga al cospetto di Garibaldi. I miracoli però non li ha fatti lui ma li fecero nell'ordine: 1°)-L'oro con il quale gli inglesi comprarono quasi tutti i generali borbonici e col quale assoldarono 20.000 mercenari ungheresi e slavi e pagarono il soldo ad altri 20.000 tra carabinieri e bersaglieri, opportunamente congedati dall'esercito sardo-piemontese e mandati come "turisti" nel Sud, altro che i 1000 scalcinati eroi...... 2°)-il generale Nunziante ed altri tra ufficiali dell'esercito e della marina che, con infinito disonore, disertarono la loro bandiera per correre sotto quella del nemico eccovi servito un piccolo elenco di traditori al soldo degli anglo-piemontesi, oltre al Nunziante: Generale Landi, Generale Cataldo, Generale Lanza, Generale Ghio, Comandante Acton, Comandante Cossovich,ed altri ancora; 3°)-i miracoli li ha fatti il Conte di Siracusa con la sua onorevolissima lettera al nipote Francesco II° (lettera pubblicata in un post a parte); 4°)-li ha fatti la Guardia Nazionale che, secondo il solito, voltò le armi contro il re che gliele avea date poche ore prima; 5°)-)li ha fatti il Gabinetto di Liborio Romano il quale, dopo aver genuflesso fino al giorno di ieri appié del trono di Francesco II, si prostra ai piedi di Garibaldi; 6°)- La quasi totalità della nobiltà siciliana. Beh, Con questi miracoli ancor io sarei capace di far la conquista, non dico della Sicilia e del Reame di Napoli, ma dell'universo mondo. Dunque non state a contare le prodezze di Sua Maestà Garibaldi I. Egli non è che il comodino della rivoluzione. Le società segrete (la massoneria) che hanno le loro reti in tutto il paese delle Due Sicilie, hanno di lunga mano preparato ogni cosa per la rivoluzione. E quando fu tutto apparecchiato si chiamò Garibaldi ad eseguire i piani [...]. Se non era Garibaldi sarebbe stato Mazzini, Kossuth, Orsini o Lucio della Venaria: faceva lo stesso. Appiccare il fuoco ad una mina anche un bimbo può farlo. Di fatto vedete che dappertutto dove giunge Garibaldi la rivoluzione è organizzata issofatto, i proclami sono belli e fatti, anzi stampati. In questo modo credo che Garibaldi può tranquillamente fare il giro del mondo a piantare le bandiere tricolori del Piemonte. Dopo Napoli Roma, dopo Roma Venezia, dopo Venezia la Dalmazia, dopo la Dalmazia l'Austria, caduta l'Austria il mondo è di Garibaldi, cioé del Piemonte! Oh che cuccagna! Torino capitale dell'Europa, anzi dell'orbe terracqueo. Ed i torinesi padroni del mondo!». Dai Savoia agli Agnelli, da una famiglia di vampiri ad un altra.....per il Sud sempre lo stesso destino.......dar loro anche l'ultima goccia di sangue. Comunque la Giustizia Divina arriva sempre........i savoia son finiti nella merda e nel ludibrio, gli Agnelli nella tomba e nella droga che certamente sarà il mezzo con quale ci libereremo di questa gente maledetta.
Gli eurobond che fecero l'Unità d'Italia quando il Regno di Napoli era come la Germania, scrive Giuseppe Chiellino il 30 giugno 2012 su “Il Sole 24 Ore”. Il vertice europeo di fine giugno ha cancellato gli eurobond dall'agenda. Almeno per ora. Angela Merkel è stata drastica: «Mai finchè sarò viva» aveva detto in pubblico qualche giorno prima. Chissà se la cancelliera tedesca aveva avuto il tempo di leggere lo studio di Stéphanie Collet, storica della finanza della Université Libre de Bruxelles che è andata a spulciare negli archivi delle Borse di Parigi e Anversa per studiare l'unico precedente assimilabile agli Eurobond: l'unificazione del debito sovrano dei sette stati che 150 anni orsono, su iniziativa del Piemonte e sotto tutela di Francia e Inghilterra, costituirono il Regno d'Italia. Nella storia dello stato moderno è l'esperienza storicamente più vicina al faticosissimo tentativo di dare maggiore consistenza politica all'Unione europea, anche attraverso l'integrazione delle politiche economiche e fiscali, compresi debiti sovrani dei 17 paesi dell'euro. Un precedente prezioso, secondo la Collet, per cercare di capire – mutatis mutandis - come potrebbero comportarsi i mercati finanziari di fronte all'unificazione del debito pubblico dei paesi della zona euro. «Come l'Italia di allora, l'Europa oggi è fatta da stati eterogenei, con economie di dimensioni e condizioni diverse, che parlano lingue diverse e hanno sistemi di imposizione fiscale separati» ricorda la studiosa. Grazie al fatto che anche dopo l'unificazione i titoli del Regno d'Italia conservarono fino al 1876 l'indicazione della loro origine (per esempio, ad Anversa le emissioni del Regno delle Due Sicilie erano indicate come "Italy-Neapolitean") la Collet è riuscita a ricostruire le serie storiche dei prezzi settimanali tra il 1847 e il 1873. Un lavoro certosino di raccolta manuale dei dati dagli archivi e dai database originali per capire come si sono mosse le quotazioni, prima e dopo l'unità, politica ed economica. 25 emissioni suddivise in quattro gruppi: Regno di Piemonte e Sardegna, Lombardo-Veneto, Due Sicilie e Stato Pontificio. La prima cosa che balza agli occhi è lo spread (anche allora!) tra i rendimenti dei diversi gruppi di bond prima e dopo l'Unità. Quelli del Regno delle Due Sicilie (che erano un quarto del totale) prima del 1861 pagavano i tassi più bassi: 4,3%, 140 punti base in meno delle emissioni papali e di quelle piemontesi (che rappresentavano rispettivamente il 29% e il 44% del debito unitario dopo la conversione) e 160 in meno rispetto a quelle Lombardo-Venete (che però erano solo il 2%). Insomma, a voler utilizzare le categorie di oggi, il Regno di Napoli economicamente era per l'Italia quello che oggi la Germania è per l'Eurozona. «Come il Regno di Napoli prima dell'integrazione del debito sovrano, la Germania di oggi è l'economia più forte dell'eurozona e beneficia del costo del debito più basso in assoluto» scrive Collet. Considerazioni, queste, che faranno storcere il naso a molti, ma sicuramente non di parte. Del resto, come ricorda Collet, Napoli era di gran lunga la città più importante del neonato Regno d'Italia. E le regioni del Sud avevano una discreta struttura industriale, un'agricoltura fiorente sia pure basata sul latifondismo, e importanti porti commerciali. Subito dopo il 1861, però, lo scettiscismo dei mercati nel processo unitario italiano impose un "risk premium" comune a tutti i bond degli stati preunitari, anche a quelli che fino a quel momento avevano goduto di maggiore fiducia e dunque di rendimenti più bassi. Proprio quello che oggi la Germania teme possa avvenire con gli eurobond: l'anno successivo, infatti, i rendimenti dei titoli convertiti in "Regno d'Italia" si allinearono ben al di sopra dei tassi precedenti, al 6,9%. Per gli "Italy – Neapolitean" 260 punti base in più che diventarono 460 nel 1870, per poi cominciare a ripiegare dopo il 1871, quando cioè l'annessione di Venezia e di Roma e il trasferimento della capitale nella città del papato convinsero gli investitori, e non solo, che l'Unità era ormai irreversibile. L"Italia" non era più una mera "espressione geografica", come l'aveva definita Metternich nel 1847, ma dopo tre guerre d'indipendenza e più di vent'anni di manovre diplomatiche era diventata uno stato unitario. «L'integrazione dei debiti sovrani era stato uno strumento per portare avanti l'integrazione politica, come sarebbe oggi per l'Europa» afferma Collet, ma nota anche che «un aumento del premio di rischio aggraverebbe la crisi del debito che sta vivendo l'Europa piuttosto che risolverla. Significherebbe che, se fossero introdotti gli eurobond, la Germania perderebbe il suo rating elevato». Questo portava Collet a definire, già nei mesi scorsi, «remote» le speranze di vedere nel breve termine un mercato integrato dei titoli di debito dell'eurozona. Nel lungo termine, invece, i risultati della ricerca sul caso italiano dimostrano che «nel tempo i rendimenti dei titoli diminuirono». Alla luce di questo, oggi la domanda è: quanto tempo ci vorrà perché anche l'Europa sia considerata come un blocco unico e in grado di dotarsi di un vero e proprio piano di salvataggio per l'euro? Per l'Italia ci volle all'incirca un decennio. Considerato che quella italiana fu un'annessione anche militare e quella europea è un'integrazione consensuale, e che i mercati dei capitali si muovono a ritmi diversi rispetto alla seconda metà dell'800, anche Collet concorda che un aumento del costo del debito nel breve termine sarebbe un prezzo che potremmo permetterci di pagare se avessimo la certezza di avere, tra qualche anno, un'Europa più unita. Ma questa certezza nessuna ricerca, per quanto accurata, potrà mai darla. Serve, forse, la capacità di andare oltre il breve periodo, di guardare un po' più lontano rispetto alla prossima scadenza elettorale, superando la "veduta corta" che per Tommaso Padoa Schioppa è stata «la radice» della crisi.
MAFIA, PALAZZI E POTERE.
Il terremoto parte da Reggio Calabria. Nelle carte dell'inchiesta Breakfast la ragnatela di relazioni per promuovere prefetti, "silenziare" Bossi, lucrare sul Ponte sullo Stretto. Tutto parte dalle telefonata di Domenico Aiello, il legale (calabrese) di Maroni, scrive Martedì 08 Dicembre 2015 il “Corriere della Calabria”. Il prossimo terremoto giudiziario (non manca nulla: dai rapporti di potere tra la Lega e Berlusconi agli intrighi politici attorno al Ponte sullo Stretto, ai patti indicibili tra istituzioni, industriali e mondo dello sport) ha come epicentro la Procura di Reggio Calabria. È l'inchiesta "Breakfast", della quale il Fatto Quotidiano in edicola martedì anticipa stralci che potrebbero far tremare pezzi importanti del potere. Cominciando dalle nomine del ministero dell'Interno e dei prefetti. Tra i quali il commissario del Comune di Roma Francesco Paolo Tronca, che avrebbe chiesto una mano al potere leghista per diventare prefetto di Milano nel 2013. Il passepartout per i giochi nei Palazzi sono le intercettazioni che vedono protagonista Isabella Votino, storica portavoce del governatore della Lombardia Roberto Maroni. Colloqui che spaziano lungo tutto l'arco politico italiano, con importanti passaggi calabresi. L'incipit, innanzitutto. Il Fatto Quotidiano pubblicherà le intercettazioni telefoniche e ambientali dell'indagine Breakfast, condotte dal Centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria. L'inchiesta, condotta dal pm Giuseppe Lombardo sotto il coordinamento del procuratore capo Federico Cafiero, va avanti in gran segreto da tempo. Gli investigatori si sono imbattuti nel "terremoto politico" dopo aver attivato intercettazioni nei confronti dell'avvocato Aiello, legale di fiducia del governatore Maroni e della Lega. Ma anche compagno di Anna Maria Tavano, ex direttore generale della Regione Calabria, successivamente assunta come manager in Lombardia. L'attività di indagine era stata avviata per appurare i rapporti di Aiello con il consulente legale Bruno Mafrici, figura chiave in Breakfast, un uomo le cui relazioni spaziano – secondo le informative della Dia – dalla politica leghista al clan De Stefano. In parallelo, avanzavano le intercettazioni sulla portavoce di Maroni Isabella Votino. «A prescindere dalla rilevanza penale – scrive Marco Lillo sul quotidiano diretto da Marco Travaglio –, quelle conversazioni devono essere pubblicate perché i fatti che svelano sono di rilievo pubblico. La sensazione anzi è che qualcuno abbia messo un coperchio su un pentolone pieno di storie imbarazzanti per i poteri dello Stato». Un dietro le quinte del potere sull'asse Roma Milano, dunque. Illuminante per svelare certe dinamiche. Non c'è solo il prefetto Francesco Paolo Tronca nei brogliacci. Ci sono gli accordi tra Maroni e Berlusconi per convincere Bossi a mettersi da parte, le sponsorizzazioni dell'ex Cavaliere in vista di Expo, il presunto ricatto (sempre di B.) a Maroni. E il tentativo dell'amministratore delegato di Impregilo, Pietro Salini, di "fottere" lo stato «con la complicità della portavoce dell'allora segretario della Lega, sempre Isabella Votino, per ottenere il pagamento delle penali per un miliardo di euro della mancata costruzione del Ponte sullo Stretto». C'è molta Lega, nel passaggio tra vecchio e nuovo corso. E, ovviamente, un ruolo centrale ha l'avvocato calabrese Domenico Aiello. Un professionista che, vuole l'aneddotica più accreditata, sarebbe entrato nel "cuore" di Maroni per la comune fede milanista, per diventare un punto di snodo dei principali interessi lumbàrd. Aiello telefono a vari procuratori per tessere la sua tela, chiedendo informazioni e audizioni. E le loro risposte sono le più disparate: c'è chi chiude senza lasciare possibilità, chi apre le porte e chi, addirittura, chiede favori. Un quadretto poco edificante. L'epicentro è la Calabria. E un'inchiesta esplosiva sulla quale qualcuno ha cercato di mettere il coperchio.
Tronca e le carriere dei prefetti, a decidere è la portavoce. Le telefonate svelano il sistema delle nomine. Isabella Votino da 9 anni è la collaboratrice più stretta del governatore lombardo Roberto Maroni: a lei si rivolgono gli aspiranti a una carica, per informazioni e aiuto. In una conversazione intercettata nel 2012 racconta i retroscena sull'arrivo in prefettura a Milano dell'attuale commissario al Comune di Roma, Francesco Paolo Tronca. Che al Fatto dice: "Escludo categoricamente di averle chiesto una raccomandazione", scrive Marco Lillo l'8 dicembre 2015 su "Il Fatto Quotidiano". A chi ha chiesto una mano per agguantare la poltrona di prefetto di Milano nel 2013 Francesco Paolo Tronca? Secondo Isabella Votino, la storica portavoce di Roberto Maroni, il prefetto si sarebbe raccomandato a lei e al potere leghista. Non è l’unica questione che emerge dalle intercettazioni telefoniche di un’indagine della Procura di Reggio Calabria che oggi sveliamo. Qual è l’imprenditore che Silvio Berlusconi sponsorizza per i lavori della Città della Salute a due passi da Milano in occasione di Expo? E come ricatta Maroni per ottenere l’alleanza alla vigilia delle elezioni che determineranno l’attuale equilibrio politico italiano e lombardo? Con quali parole l’ex premier minaccia di sguinzagliare i giornali di destra alla stregua di pit bull per indurre a più miti consigli l’alleato riottoso? Come si sono accordati Berlusconi e Maroni per convincere Umberto Bossi a mettersi da parte in silenzio? Come fa l’amministratore delegato della maggiore impresa di costruzioni italiana, Pietro Salini di Impregilo, a tentare di “fottere” lo Stato (a partire dal presidente della Repubblica) con la complicità della portavoce dell’allora segretario della Lega, Isabella Votino, per ottenere il pagamento delle penali per un miliardo di euro della mancata costruzione del Ponte sullo Stretto? Come fa il presidente del Coni Giovanni Malagò a proporre alla Lega un’alleanza tra padani e generone romano? Con quali parole vanta le potenzialità di una macchina di consenso con milioni di tesserati per ottenere un voto utile a sbaragliare il rivale Raffaele Pagnozzi? E quali trattative ci sono tra Matteo Salvini e i vecchi leghisti dietro al patto del febbraio 2013 tra il nuovo segretario federale del Carroccio e Bossi? Perché la Lega ha evitato di costituirsi parte civile contro l’ex tesoriere Francesco Belsito nei processi per le ruberie dalle casse del partito? Come rispondono i vari procuratori interessati dalle manovre dell’avvocato Domenico Aiello quando il legale dei leghisti chiede con tono perentorio informazioni e audizioni? Perché un procuratore “duro e puro” chiude ogni comunicazione con parole secche mentre altri pm lasciano le porte aperte e qualcun altro chiede all’avvocato della Lega un favore? Infine, come si decidono le nomine dei commissari strapagati delle grandi aziende in crisi firmate dal ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi nel 2014? E tanto altro ancora. A partire da oggi, per molti giorni, Il Fatto Quotidiano pubblicherà le intercettazioni telefoniche e ambientali dell’indagine Breakfast della Procura di Reggio Calabria, condotte dal Centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria sotto il coordinamento del pm Giuseppe Lombardo e del procuratore capo Federico Cafiero De Raho. L’indagine va avanti in gran segreto da tempo. Tanto segreto. Troppo tempo. Probabilmente le intercettazioni nei confronti dell’avvocato Aiello (attivate nel 2012 per appurare i suoi rapporti con il consulente legale Bruno Mafrici, che era indagato) e sulla portavoce di Maroni Isabella Votino non porteranno a nulla. A prescindere dalla rilevanza penale, quelle conversazioni devono essere pubblicate perché i fatti che svelano sono di rilievo pubblico. La sensazione anzi è che qualcuno abbia messo un coperchio su un pentolone pieno di storie imbarazzanti per i poteri dello Stato. Il Fatto ha visionato le telefonate e ha deciso di far conoscere all’opinione pubblica come funziona dietro le quinte il potere sull’asse Roma-Milano. Le nomine dei prefetti spettano al Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’Interno. Però c’è una bella signorina di 36 anni, nata a Montesarchio in provincia di Benevento, che sembra avereinfluenza sulle scelte. Si chiama Isabella Votinoe gli aspiranti a una carica le chiedono informazioni e aiuto. Da nove anni è la collaboratrice più stretta di Roberto Maroni. Il suo potere però è più penetrante di quello di una mera portavoce di un governatore lombardo. Sarà per i suoi rapporti stretti con Silvio Berlusconi che poi l’ha voluta nel gennaio 2014 per vitalizzare la comunicazione del Milan, ma tra la fine del 2012 e inizio del 2014, quando è intercettata dalla Dia di Reggio Calabria, sembra una sorta di zarina del Viminale, nonostante Maroni non sia più il ministro. Il 18 dicembre del 2012 a Palazzo Chigi c’è Mario Monti e al Viminale c’è la Cancellieri. La Votino è “solo” la collaboratrice più intima del neo-segretario della Lega Nord, Roberto Maroni quando Luciana Lamorgese, Capo del Dipartimento personale e risorse del ministero dell’Interno, la chiama. Votino le racconta iretroscena della carriera del prefetto Francesco Paolo Tronca. L’attuale commissario nominato da Alfano e Renzi al Comune di Roma, secondo Votino, si sarebbe fatto raccomandare dalla Lega per diventare prefetto di Milano nel 2013, trampolino di lancio per la sua carriera.
Isabella Votino (V): Avevo incrociato Tronca, dopo di che lui mi ha chiamato dicendomi..
Luciana Lamorgese (L): Ma lui ti ha chiamato?
V: Perché io l’avevo incrociato… poi avevo parlato con te e tu, onestamente, mi avevi lasciato intendere che, come dire, non se ne faceva nulla e allora io gli ho detto guarda dico, vuoi che ti dica, cioè…
L: Ma perché lui voleva sapere da te i fatti?
V: No no lui ovviamente voleva in qualche modo che si caldeggiasse… perché non ne fa mistero che vuole venire a Milano.
L: Eh certo! (ride)
V: Ma questo cioè legittimamente e allora ma sai fuori dai giochi tu che, ovviamente voglio dire … meglio lui che un altro, cioè, che noi neanche conosciamo (…) Luciana, io non te lo devo dire che … cioè, noi preferiamo che vieni tu che…
L:(ride) (…) io voglio prima capire qual è la situazione … cioè, nel senso, anche da vedere Roma che cosa…
Il Prefetto Luciana Lamorgese in sostanza fa presente all’amica che la sua prima scelta è la nomina a Roma e Milano è per lei una subordinata. Nel luglio 2013 sarà nominata capo di gabinetto dal ministro Angelino Alfano, al posto di Giuseppe Procaccini, travolto dal caso Shalabayeva. La sera del primo giugno 2013 Isabella Votino chiama Maroni per sapere se il vicecapo della polizia Alessandro Marangoni andrà a fare il prefetto di Milano (alla fine ci andrà solo due anni dopo, pochi giorni fa, per pura coincidenza, ndr). La sta cercando Tronca e Maroni commenta che certamente Tronca la sta chiamando perché vuole sponsorizzare la sua nomina. Due minuti dopo Votino chiama Tronca. L’allora capo dipartimento dei Vigili del fuoco la invita a essere sua ospite nelle tribune riservate alla festa del 2 giugno a Roma. Lei declina l’invito e prende il discorso della nomina sostenendo che è stata rinviata a luglio. Tronca le chiede di continuare a seguire lei la vicenda. Votino conclude dicendo che però circola voce che potrebbe essere nominato Marangoni. Invece l’8 agosto del 2013 il nuovo ministro dell’interno Angelino Alfano nomina Tronca prefetto. A settembre 2013 la Dia intercetta la conversazione tra un funzionario molto importante della polizia di Milano, Maria José Falcicchia, e la sua amica Isabella Votino. Falcicchia (prima donna nominata proprio in quel periodo capo della anticrimine della Squadra mobile di Milano) chiede se Tronca è stato scelto da loro, cioè dalla Lega nord. La portavoce di Maroni risponde che loro lo hanno messo a capo dei Vigili del fuoco e che lo hanno sponsorizzato loro. Tronca non è l’unico prefetto di Milano che ha rapporti con Isabella Votino. Dal 2005 al gennaio del 2013 su quella poltrona c’era Gian Valerio Lombardi, famoso per come ha accolto nel 2010 l’amica di Berlusconi Marysthell Polanco in Prefettura e per la frase sfortunata (ma gradita a Maroni) sulla mafia che a Milano “non esiste”. Il 22 novembre 2012 il prefetto Lombardi, nato a Napoli nel 1946, chiede alla portavoce di Maroni: “Come sono i rapporti tra il nostro (Roberto Maroni, ndr) e il presidente della Regione Veneto?”. Votino risponde che con Luca Zaia i rapporti sono buoni. E Lombardi pronto: “Quindi se gli dobbiamo chiedere una cortesiola per una mia lontana parente che aveva un’aspirazione che dipende proprio da lui… possiamo vedere…”. Votino lo rinvia a un caffè nel fine settimana. Passa qualche mese e il Prefetto, dopo la scadenza del mandato, è a caccia di poltrone. Il 17 giugno 2013, dopo la nascita del governo Letta, si propone come sottosegretario perché “anche Alfano potrebbe aver bisogno di qualcuno fidato…”. Invece Alfano sceglie altre persone. E così a lui ci devono pensare i lombardi. Isabella Votino dimostra di non essere una portavoce qualunque quando suggerisce a Maroni di nominare Lombardi commissario dell’Aler, l’Azienda lombarda edilizia residenziale. Il governatore chiama il vicepresidente Mario Mantovani (poi arrestato per altre vicende) e ottiene il suo ok alla nomina. Ed è proprio Votino a comunicare la lieta notizia al prefetto che ringrazia ma aggiunge: “Si guadagna una qualcosetta?”. Rassicurato (da commissario prende il 60 per cento in meno ma oggi da presidente Aler guadagna 75 mila euro lordi all’anno) accetta l’incarico. Il 18 giugno Isabella Votino lo chiama per dirgli che appena è uscito il suo nome sui giornali è scoppiata la polemica per le sue vecchie dichiarazioni sulla mafia che a Milano non esiste. Però nessuno ferma Maroni e così Lombardi è tuttora al suo posto. Il prefetto Tronca, sentito dal Fatto Quotidiano, spiega: “Non ricordo questa telefonata con Isabella Votino. Non avevo una confidenza particolare con lei. Può darsi che le abbia detto, come mi è capitato con tante altre persone, che aspiravo a diventare prefetto di Milano. È una carica così importante che ci vuole la non controindicazione soprattutto delle istituzioni più rilevanti, e Maroni era allora presidente della Regione Lombardia”. E quella frase di Isabella Votino? Perché dice al telefono a una sua amica che loro hanno sponsorizzato Tronca e che l’avevano nominato prima anche a Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco? “Io sono stato nominato capo dipartimento da Maroni e fu un gradito fulmine a ciel sereno: da prefetto di Brescia diventavo capo dipartimento dei vigili del fuoco. C’è una spiegazione però. Io – prosegue Tronca – mi ero occupato di Protezione civile anche da funzionario alla Prefettura di Milano. Ho gestito il coordinamento dell’incidente di Linate nel 2001 e in quel frangente ho conosciuto l’allora ministro dell’interno Maroni però non ho mai chiesto una raccomandazione anche perché non avevo particolari rapporti”. Allora perché chiede a Votino di “continuare a seguire la vicenda” della nomina a prefetto? Perché la invita a Roma per la festa del 2 giugno del 2013? “Probabilmente volevo che mi tenesse informato visto che Maroni avrebbe saputo come finiva. Mentre escludo categoricamente di avere chiesto alla Votino una raccomandazione. Comunque io sono stato nominato dal ministro Alfano”. Da Il Fatto Quotidiano del 08/12/2015.
MAFIA DEMOCRATICA.
I boss sparano a Palermo ma vogliono democrazia. Le intercettazioni che hanno permesso di "fermare" sei persone svelano che i clan eleggono i capi con il voto segreto e rispetto al passato chiedono più condivisione nelle scelte scrive su “L’Espresso” Lirio Abbate l'11 dicembre 2015. A Palermo da una parte c'è una mafia melliflua, che riesce a piegare le proprie vittime del racket con l'intimidazione, e dall'altra c'è un'organizzazione criminale assolutamente sanguinaria che non ha dimenticato la violenza come parte costitutiva di Cosa nostra, dimostrando di avere ancora oggi una capacità di fuoco e una reazione militare che preoccupa investigatori e inquirenti. Perché, come dimostrano le indagini dei carabinieri di Palermo che hanno portato al fermo di sei persone su ordine dei magistrati della Procura distrettuale antimafia, ci sono uomini e mezzi capaci di reagire, armi in pugno, in poche ore e lasciare sull'asfalto le loro vittime. A Palermo è accaduto lo scorso ottobre e oggi i pm guidati da Francesco Lo Voi hanno portato le prove che i boss non hanno perso la loro caratteristica violenta e sanno formare sicari capaci di infilare cinque colpi di fila nella schiena di una persona mentre scappa. Non è da tutti. Quindi, accanto alla forma di convincimento degli imprenditori e commercianti a pagare il pizzo, c'è ancora quella violenta per la quale Cosa nostra è conosciuta in tutto il mondo. Le intercettazioni hanno svelato che la cosca più vecchia di Palermo è tornata ad essere la più pericolosa. A guidarla, uno scarcerato eccellente degli ultimi tempi, Giuseppe Greco. Consigliere del capo, Salvatore Profeta, uno dei boss condannati per la strage Borsellino e poi scagionati. Era tornato in attività anche un altro degli scarcerati del caso Borsellino, Natale Gambino, pure lui chiamato in causa dal falso pentito Vincenzo Scarantino. Le indagini riguardano la famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù e avrebbero svelato il coinvolgimento della cosca nell'omicidio di Salvatore Sciacchitano e nel ferimento di Antonino Arizzi, avvenuti a Palermo il 3 ottobre scorso. Nelle intercettazioni diffuse dai Carabinieri le votazioni dei mafiosi di Santa Maria di Gesù, una delle famiglie criminali più antiche di Cosa nostra, per l’elezione del “governo” interno. Le microspie evidenziano come il voto sia avvenuto a scrutinio palese: “Ci ammazziamo come i cani, perché non la possiamo fare ad alzata di mano?” Dalle attività investigative è emerso anche che i vertici del clan venivano designati attraverso elezioni a cui partecipavano uomini d'onore, secondo una prassi di cui i pentiti hanno parlato negli anni Ottanta. Alcuni dei fermati sarebbero coinvolti nell'agguato a Sciacchitano, punito per aver partecipato, poche ore prima di essere ucciso, al ferimento di Luigi Cona, personaggio vicino a Cosa nostra. Il contesto in cui matura il fatto è importante, perché è quello di Santa Maria del Gesù, feudo di Stefano Bontate, il principe di Villagrazia, ucciso nel 1981 e poi di Pietro Aglieri. È nella zona di Villagrazia che parte tutto. Un anno fa, in una barberia, le microspie dei carabinieri intercettano una conversazione importante che dà la svolta alle indagini. I mafiosi che parlano descrivono un sistema di elezione del capo “reggente” e dei suoi collaboratori. In questo piccolo negozio da barbiere gli affiliati al clan scandiscono i ruoli e dicono che Giuseppe Greco è “il principale”, termine utilizzato per indicare il reggente della cosca. E poi fanno il nome del sottocapo e del capodecina e del collaboratore fidato del “principale”. C'è un momento in cui parlano anche delle elezioni. Sì, perché dentro Cosa nostra si fanno anche le elezioni. E fanno riferimento agli anni Settanta in cui comandava Stefano Bontate, in cui si facevano le elezioni per scegliere il capo e vi partecipavano più di 120 affiliati. Oggi gli elettori mafiosi in questa zona di Palermo sono molto di meno, circa una ventina, ma il sistema di elezione sembra essere lo stesso: c'è come campagna elettorale che precede la scelta del nuovo capo. I votanti si riuniscono, riprendono le vecchie modalità, e indicano il nome del nuovo boss su una scheda elettorale, o un “pizzino”, come si faceva in passato, e questi biglietti, piegati venivano imbucati in una scatola di scarpe. I carabinieri adesso hanno documentato tutto, apprendendo anche i nuovi vertici della famiglia mafiosa. Ritornare ai vecchi metodi è significativo, come pure far riferimento a Bontate. Nelle intercettazioni viene citato il “principe di Villafranca” come un esempio da seguire, ma era anche visto come un dittatore la cui parola era legge. Oggi però i boss vogliono “più democrazia”. Sembrerà strano ma anche i mafiosi non vogliono sottostare alle dittature. E così nelle intercettazioni fanno capire che le cose oggi sono cambiate, e c'è condivisione delle decisioni. Il “principe”, come dicono i mafiosi nelel conversazioni registrate, governava incontrastato ma oggi si governa con una visione più democratica. Il pentito Francesco Marino Mannoia detto «Mozzarella» abbatte miti che Buscetta non aveva intaccato. Per esempio, quello "della mafia buona che non uccide" e non «tratta» l'eroina. Campione di questa categoria era stato ritenuto Bontate. «Niente vero. Don Stefano era esattamente come gli altri. Finiamola con queste sciocchezze: uccideva e si arricchiva con la droga». Parola di «Mozzarella», che di Bontate era stato angelo custode e «soldato». Qualche esempio? Un ladruncolo che lo aveva deriso per via della faccia gonfia «fu portato da Stefano Bontade che lo strangolò». Sorte analoga per un rapinatore che dava fastidio nel quartiere; in quel caso il commento del «principe» fu: «Ordinaria amministrazione». Efrate Giacinto, il francescano ucciso nella sua «cella» dentro il convento del cimitero di Santa Maria del Gesù? «Mozzarella» chiede e Bontate spiega: «Era un puttaniere». Al giudice, Mannoia aggiungerà: «In passato aveva dato rifugio a latitanti di Cosa Nostra, ma da tempo non ci servivamo più di quel convento». Adesso occorre guardare meglio agli atteggiamenti e ai comportamenti di questi nuovi boss. Gli investigatori lo hanno fatto e i pm hanno colto i nuovi segnali che arrivano dai clan. Certo fa impressione ascoltare alcune registrazioni in cui c'è un mafioso che inizia a cantare “volare” dopo aver sentito i colpi di pistola sparati da un suo compare che ha ucciso un uomo. Alcune conversazioni si sentivano trent'anni fa tra i mafiosi, adesso i toni sembrano essere tonati tali. Anche se occorre tener presente che l'omicidio dal quale parte l'indagine è stato compiuto lo scorso ottobre e in due mesi l'organizzazione è stata scoperta. I mafiosi dovrebbero capire che non hanno dove andare, che vengono beccati subito. Ma occorre constatare che questi personaggi che hanno ancora come mito Bontate non sanno cos'altro fare. Sanno solo mafiare, e l'arresto lo mettono in conto. Un po meno, però, la condanna all'ergastolo.
Mafia, ecco come vengono decisi i vertici di Cosa Nostra. L'ultima operazione del Ros svela i metodi "democratici" utilizzati a Palermo per l'elezione dei boss mafiosi dopo l'arresto di Riina, scrive l'11 dicembre 2015 Nadia Francalacci su “Panorama”. Decidevano alleanze, candidature ed esecuzioni all'interno di una sala da barba. È lì, nel cuore del feudo mafioso di Santa Maria di Gesù, che i boss di Palermo si riunivano prima di dar via alle elezioni per il rinnovo dei vertici del clan. Ed è proprio lì che è stata decisa anche la punizione di uno degli affiliati: Salvatore Schiaccitano ucciso lo scorso 3 ottobre. Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito sei arresti nei confronti di boss palermitani accusati a vario titolo di omicidio, tentato omicidio, associazione mafiosa e reati legati al possesso di armi. Le indagini sono state concentrate sulla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, e avrebbero svelato il coinvolgimento della cosca nell'omicidio di Sciacchitano e nel ferimento di Antonino Arizzi, avvenuti due mesi fa. Sciacchitano avrebbe partecipato a un agguato contro un pregiudicato vicino alla cosca. Dopo poche ore, però, sarebbe stato punito: segno della capacità militare del clan, in grado di organizzare in pochissimo tempo una reazione militare all'aggressione di uno dei suoi. Dall'inchiesta emerge il ritorno ai vecchi metodi di designazione dei capi, una sorta di "democratizzazione" criminale seguita agli anni di tirannia dei corleonesi di Totò Riina. I vertici del clan venivano designati attraverso elezioni a cui partecipavano uomini d'onore, secondo una prassi di cui i pentiti hanno parlato negli anni '80. Ma tra gli arrestati di questa mattina c'è anche uno dei sette ergastolani condannati e poi scagionati dal processo per la strage di via D'Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Si tratta di Natale Gambino finito in cella insieme a Giuseppe Greco, già arrestato e condannato per associazione mafiosa. I due, intercettati, parlano esplicitamente del rinnovo dei vertici dell'associazione mafiosa.
La mafia non abbandona i vecchi riti: un bacio in fronte per i nuovi boss. Sei arresti in Sicilia. E le indagini su un omicidio avvenuto lo scorso ottobre hanno svelato che le cosche palermitane non rinunciano ai riti dell’«onorata società», scrive su “Il Corriere della Sera” Giovanni Bianconi l’11 dicembre 2015. Passano i decenni, ma le regole della mafia restano sempre le stesse. Anche nel nuovo secolo i boss procedono a eleggere capi e sottocapi per governare le «famiglie» e i «mandamenti», come avveniva quando esisteva la Cupola. E così, nel giugno del 2014 le microspie dei carabinieri del Ros hanno registrato una riunione in cui si discute della campagna elettorale per la scelta di chi deve comandare sulla zona di Santa Maria di Gesù, periferia sud-est di Palermo. Con tanto di bacio in fronte a suggellare la scelta dei candidati. Nella riunione del 20 giugno gli uomini d’onore parlano esplicitamente di «Cosa nostra»: una delle rarissime occasioni in cui utilizzano il nome svelato per la prima volta dal pentito Tommaso Buscetta più di trenta anni fa. Quando si parla di “Cosa Nostra” non si scherza. Una circostanza considerata di importanza storica dai pm della Direzione distrettuale antimafia guidati dal procuratore Franco Lo Voi e dall’aggiunto Leonardo Agueci, emersa dalle indagini su un omicidio avvenuto nell’ottobre scorso di cui sono stati arrestati i presunti mandanti ed esecutori. «A prescindere della confidenza che abbiamo... quando parliamo di Cosa Nostra...parliamo di Cosa Nostra! Quando dobbiamo babbiare ...babbiamo!», cioè scherziamo, dice il boss Natale Gambino, intercettato con altri quattro presunti mafiosi all’interno del negozio di un barbiere nel quartiere della Guadagna. È un summit di mafia ascoltato in diretta dagli investigatori che hanno visto gli uomini d’onore arrivare e il barbiere uscire prima che cominciasse la riunione. Gambino, 57 anni, è stato scarcerato nel 2011 in seguito alla richiesta di revisione del processo sulla strage di via D’Amelio (era stato condannato all’ergastolo sulla base delle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino), come il settantenne Salvatore Profeta, anche lui presente alla riunione, riarrestato un mese fa per mafia nell’ambito di un’altra indagine della polizia. I due parlavano con Giuseppe “Pino” Greco, 53 anni, già condannato per associazione mafiosa e tornato libero dopo aver scontato la pena; secondo gli inquirenti è lui l’uomo più importante tra i presenti, tanto che Profeta, nonostante sia molto più anziano, gli si rivolge con rispetto e deferenza: «Che piacere avere u zu Pinuzzu!». Durante la lunga discussione Greco rimprovera Gambino per non aver obbedito a un suo ordine (probabilmente relativo alla riscossione dei soldi di un’estorsione): «E allora Natà... se siamo rimasti in un modo ...ma perché dobbiamo fare in un’altra maniera?»; e quello si scusa dicendo che non aveva capito: «Pino... a me mi dispiace che tu hai pensato... perché se tu mi dici una cosa ...io che fa, non ci vado?». Profeta prova a giustificare Gambino, rimproverandolo a sua volta, dopodiché la riunione va avanti sui ruoli di vertice da assegnare nel mandamento di Villagrazia. «Io incarichi non ne voglio... io voglio essere solo diretto con te...e...no ...sottocapo...», dice Gambino a Pino Greco. L’anziano Profeta si associa: «Io pure… a me che devi fare …che sono rimbambito…», e gli altri ridono. Greco spiega che si svolgeranno le elezioni, Gambino annuncia il suo voto per lui, e Profeta promette che farà campagna elettorale in suo favore. In un altro passaggio lo stesso Salvatore profeta ricorda le votazioni per i vertici dentro Cosa nostra negli anni Settanta: «All’epoca si facevano mi pare… ogni cinque anni ... ma sempre Stefano Bontade acchianava (risultava vincitore, o comunque comandava, ndr)!», riferendosi al capomafia palermitano assassinato nel 1981 su ordine di Totò Riina nella guerra scatenata dai Corleonesi. «Per fare queste votazioni ci voleva il posto buono...», interviene Gambino, e Profeta spiega: «Sì, ma... all’epoca cento... centoventi eravamo...». Oggi invece «se li sommi quanto siamo? Neanche a venti arriviamo!». Il figlio Nino, arrestato anche lui, ribatte «No, forse di più siamo», ma Salvatore Profeta insiste: «Venti… trenta». Rispetto agli anni ruggenti e degli omicidi a centinaia i numeri sono cambiati, ma i protagonisti invecchiati e i giovani epigoni continuano a perpetuare le stesse regole.
I boss tornano al voto per il nuovo governo di Cosa nostra. Le cimici svelano un omicidio. Blitz dei carabinieri a Palermo, 6 arresti. Smantellata la storica cosca di Santa Maria di Gesù. Il nuovo padrino veniva baciato in fronte. Come cambia la mafia siciliana, tra vecchi riti e nuova violenza: due mesi fa, un giovane è stato punito in modo eclatante. Mentre i sicari sparavano, i capimafia assistevano a distanza all'esecuzione. E in macchina canticchiavano, scrive Salvo Palazzolo su “La Repubblica” del 11 dicembre 2015. La campagna elettorale è stata breve, i candidati non erano molti. Ma è stata una campagna elettorale intensa a Santa Maria di Gesù, periferia orientale di Palermo: dopo tanti anni, i boss sono tornati al voto per eleggere il governo di una delle famiglie più antiche di Cosa nostra. Questo dicono le microspie disseminate nel ventre della città. Un segnale importante per le indagini dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia: è davvero finita l'era del tiranno Totò Riina che tutto decideva e imponeva, la mafia siciliana riparte dalle vecchie tradizioni. Ed è purtroppo un segnale di riorganizzazione, nonostante gli arresti e i processi degli ultimi tempi. Due mesi fa, i padrini di Santa Maria di Gesù che sono tornati al voto hanno ordinato ed eseguito l'omicidio di un giovane, Mirko Sciacchitano, aveva la sola colpa di avere accompagnato in moto l'autore di una spedizione punitiva. Questa mattina, i carabinieri del Ros e del nucleo Investigativo del comando provinciale hanno arrestato 6 persone. I sostituti procuratori Sergio Demontis, Francesca Mazzocco e Gaspare Spedale hanno firmato un provvedimento urgente di fermo. Perché la cosca più vecchia di Palermo era tornata ad essere la più pericolosa. A guidarla, uno scarcerato eccellente degli ultimi tempi, Giuseppe Greco. Consigliere del capo, Salvatore Profeta, uno dei boss condannati per la strage Borsellino e poi scagionati. Era tornato in attività anche un altro degli scarcerati del caso Borsellino, Natale Gambino, pure lui chiamato in causa dal falso pentito Vincenzo Scarantino. I boss di Santa Maria di Gesù non erano coinvolti nell'eccidio del 19 luglio 1992, ma erano mafiosi a tutti gli effetti. Gli investigatori li hanno intercettati all'interno di una sala da barba mentre discutono delle nuove votazioni. E si apre il dibattito, tra i fautori del voto palese e del voto segreto. Si discute di franchi tiratori e di alleanze necessarie per designare tutte le cariche all'interno del mandamento. Fra dichiarazioni di voto e rinunce alla candidatura: per Cosa nostra palermitana è il ritorno alle regole che raccontò il pentito Tommaso Buscetta al giudice Giovanni Falcone. Così, i mafiosi di Palermo provano a far rivivere l'organizzazione. Il capo del mandamento, Giuseppe Greco, veniva ossequiato con un bacio in fronte: nella nuova mafia i simboli servono a rinserrare le fila. E non erano solo nostalgici del passato: due mesi fa, i boss di Santa Maria di Gesù hanno deciso un omicidio nel giro di poche. Dopo il ferimento di una persona a loro vicina, la vendetta è arrivata severa. Con una gragnola di colpi in piazza. Così è morto Mirko Sciacchitano, aveva 29 anni. Mentre tre sicari gli sparavano, due dei vecchi padrini del clan assistevano a distanza all'esecuzione, all'interno di un'auto. C'era una microspia nella vettura. Si sentono i colpi a distanza, e uno dei boss che canticchia. In una sala da barba, i carabinieri del Ros hanno ascoltato la riunione in cui si discuteva delle elezioni. "Quando parliamo di Cosa nostra, parliamo di Cosa nostra... quando dobbiamo babbiare, babbiamo", diceva Natale Gambino. Un'intercettazione eccezionale per l'indagine coordinata dal procuratore Franco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci. Una delle poche intercettazioni in cui i boss parlano esplicitamente di "Cosa nostra". Gambino ossequiava il padrino, Giuseppe Greco: "Tu qua rappresenti a noialtri". E chiedeva: "Ma per fare la famiglia che aspetti?". I boss sollecitavano a gran voce le nuove elezioni. "Ma io incarichi non ne voglio", spiegava Gambino. "Io voglio essere solo diretto con te, sottocapo". "La famiglia tutta dobbiamo fare per votazione", diceva anche Salvatore Profeta. E il capomafia ribadiva: "Sì, così dobbiamo fare". Gambino era per il voto palese: "Io lo do aperto". Soprattutto, per evitare altri contrasti in famiglia: "Ci ammazziamo come i cani, ma perché non lo possiamo fare ad alzata... ad alzata di mano?". E Profeta ribadiva: "Allora, alziamo la mano e li contiamo". I boss ricordano le elezioni che si facevano negli anni Settanta, quando il capomafia di Santa Maria di Gesù era il re della mafia palermitana, Stefano Bontate, poi ucciso per ordine di Totò Riina nel 1981. "All'epoca, cento, centoventi eravamo". E il vincitore delle elezioni era sempre lui, Stefano Bontate. Perché, in realtà, quelle di Cosa nostra non sono mai state libere elezioni. "Ogni cinque anni si facevano". I boss ridono. E Gambino sussurra: "Una barzelletta".
BUROCRAZIA. LA DITTATURA DEI BUROCRATI.
Burocrazia, Aforismi e citazioni.
“Burocrazia, ovvero un gigantesco meccanismo azionato da pigmei”. Honoré de Balzac
“Non c’è furia all’inferno che eguagli la rabbia di un burocrate disprezzato”. Milton Friedman
“I burocrati temono la responsabilità personale e cercano riparo dietro le loro regole; la loro sicurezza e il loro orgoglio risiedono nella lealtà verso le regole, non già nella lealtà verso le leggi del cuore umano”. Frich Fromm
“I ceppi dell’umanità tormentata sono fatti di carta bollata. . . .”. Franz Kafka
“Quando il mondo verrà distrutto non sarà ad opera dei pazzi, ma dagli esperti e dai burocrati”. John Le Carré
“Marx ha confuso una dittatura della giustizia con la dittatura dei burocrati”. Herbert Marcuse
“La burocrazia è lo Stato immaginario accanto allo Stato reale è lo spiritualismo dello Stato”. Karl Marx
“La burocrazia tende a diventare una pedantocrazia”. John Stuart Mill
“Ciò che la gente rifiuta non è la burocrazia come tale, quanto piuttosto l’intrusione di essa in tutte le sfere della vita e delle attività umane”. Ludwig von Mises
“I burocrati sono una malattia. Si suppone che siano necessari, così come si suppone che siano necessarie alla vita certe sostanze chimiche, ma provocano la morte se crescono oltre un certo limite”. Ezra Pound
“Burocrazia. . . . una difficoltà per ogni soluzione”. Herbert Samuel
“Burocrazia, ovvero l’incapacità addestrata”. Thorstein Veblen
“La burocrazia è tra le strutture sociali più difficili da distruggere”. Max Weber
Burocrati..Dal francese “BUREAUCRATE”, impiegati, funzionari della pubblica amministrazione che esercitano le mansioni con eccesivo scrupolo . Per estensione, chi è formalista, gretto e rigido, nato soltanto per fare il Burocrate. 〈〈 La vera Casta è rappresentata dagli alti burocrati di Stato, che sopravvivono ai ministri e ai governi mantenendo intatto il loro potere per anni luce…〉〉
5 pareri sui burocrati:
Scopo della burocrazia è di condurre gli affari dello Stato nella peggior possibile maniera e nel più lungo tempo possibile. (Carlo Dossi)
I burocrati temono la responsabilità personale e cercano riparo dietro le loro regole; la loro sicurezza e il loro orgoglio risiedono nella lealtà verso le regole, non già nella lealtà verso le leggi del cuore umano. (Erich Fromm)
Marx ha confuso una dittatura della giustizia con la dittatura dei burocrati. (Herbert Marcuse)
Non c’è furia all’inferno che uguagli la rabbia di un burocrate disprezzato. (Milton Friedman)
I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare. Con la differenza che la sabbia non prende lo stipendio. (Ephaim Kishon)
La Repubblica dei mandarini. Viaggio nell'Italia della burocrazia, delle tasse e delle leggi inutili 21 mag 2014 di Paolo Bracalini (Autore). C'è il ristoratore multato per aver servito troppi spaghetti. Ci sono le 118 procedure da compilare per legge se si vuole aprire un'attività da estetista. C'è la famigerata "tassa sull'ombra", dovuta allo Stato per l'ombra che le tende dei negozi proiettano sul suolo pubblico, e la dichiarazione "peli di foca" per chi esporta un prodotto. C'è Equitalia con il suo "aggio", l'interesse praticato sulle temibili cartelle esattoriali, e le sue vittime. E poi l'Agenzia delle entrate con i premi per chi tartassa di più (spesso a torto). Ogni anno la burocrazia italiana costa 31 miliardi di euro: due punti di Pil persi in scartoffie e pratiche inutili. Si può dire che tutto manchi all'Italia, tranne le regole. Al contrario, i proverbiali lacci e lacciuoli, il groviglio di leggi - statali, regionali, provinciali, comunali - è così intricato che la giungla normativa italiana non ha paragoni in Europa e contribuisce all'indebolimento dei diritti dei "sudditi". I "mandarini", invece, comandano nell'ombra, con un potere enorme: nei ministeri, nella Ragioneria di Stato, nelle segrete stanze del Tesoro e del Quirinale, ma anche nei Tar che paralizzano il Paese. Paolo Bracalini ci guida nel mastodontico intreccio della burocrazia italiana con un'inchiesta che è anche un pugno allo stomaco: storie vere, testimonianze, documenti, cifre e resoconti di una follia tutta nostrana... Prefazione di Edward N. Luttwak.
Libri, la Repubblica dei Mandarini: lo Stato non siamo noi, scrive Giacomo Zucco il 3 giugno 2014 su “Il Fatto Quotidiano”. “Lo Stato siamo noi? No, sono loro!”. Queste sono le prime parole che ho potuto leggere aprendo il nuovo libro di Paolo Bracalini, “La Repubblica dei mandarini. Viaggio nell’Italia della burocrazia, delle tasse e delle leggi inutili”. E per un teapartysta è come un invito a nozze. Da quattro anni, ormai, andiamo ripetendo che lo Stato è altro da noi, perché se fossimo davvero noi, citando un amico, allora di certo ci tratteremmo meglio (pensateci: se noi fossimo lo Stato non ci ammazzeremmo a colpi di tasse, non ci complicheremmo la vita con tutta questa burocrazia, non faremmo di tutto per far fallire le nostre aziende, non ci metteremmo Equitalia alle calcagna)! Se a ciò aggiungiamo che nella prefazione il professor Luttwak cita direttamente i nostri cugini americani, riconoscendo i meriti delle loro battaglie, ecco che questo libro-inchiesta si va a posizionare automaticamente nella biblioteca degli attivisti del movimento. Scrive Luttwak (forse con un piccolo eccesso di ottimismo verso l’attuale situazione politica ed economica americana) che “il movimento dei Tea Party ha giocato un ruolo fondamentale in Usa permettendo di raggiungere un livello di crescita, superiore a quello italiano del 250%, con relativo crollo della disoccupazione, semplicemente tagliando la spesa pubblica. Democratici e repubblicani hanno fatto proprie le idee del Tea Party: se si licenziano 100 dipendenti pubblici e si tagliano le tasse, con il risparmio la disoccupazione non aumenta di 100, ma diminuisce di 300”. E conclude: “Il libro di Bracalini non è mera protesta. Offre l’unica soluzione possibile: tagliare lo Stato”. Ad ufficializzare questa vicinanza tra il libro e le idee del movimento, Tea Party Italia a partire dal 20 giugno inizierà un tour di presentazione del libro in diverse città della penisola (similmente a quanto già fatto con il precedente best seller di Bracalini: “Partiti S.p.a.”), in compagnia dell’autore e di Nicolò Petrali, un giovane e bravo giornalista che ha collaborato alla stesura dell’opera. Non vorrei comunque si pensasse che “La repubblica dei mandarini” sia una lettura consigliabile solo per chi ha delle idee simili alle nostre. Anzi, oserei dire che è proprio il contrario. Un antistatalista convinto, infatti, può solo “divertirsi” a vedere come, pagina dopo pagina e di capitolo in capitolo, le sue idee di partenza vengono confermate. Può scoprire nuovi dettagli e curiosità con un sorriso amaro stampato sul volto, crogiolandosi comunque in quello che è il suo habitat naturale. Al contrario, proprio gli statalisti (ovvero coloro che costituiscono purtroppo la gran parte della società italiana) potrebbero ricavare il miglior beneficio dall’approccio a questo libro. Perché per una volta ascolterebbero una musica diversa dal solito e una voce fuori dal coro. Il mio “consiglio alla lettura” si rivolge allora soprattutto a questi ultimi: se davvero siete così superstiziosi da credere che “lo Stato siamo noi”, che “se tutti pagassero le tasse, tutti pagherebbero meno”, che “se l’Italia è in difficoltà è colpa dell’evasione fiscale”, affrettatevi a leggerlo: potreste scoprire qualcosa.
BENVENUTI NELLA REPUBBLICA DEI MANDARINI - NEL NOSTRO PAESE LA VERA CASTA E' RAPPRESENTATA DAI BUROCRATI. E' PER QUESTO CHE E' ARDUO SE NON IMPOSSIBILE CAMBIARE VERAMENTE LE COSE IN ITALIA. Come racconta Bracalini, Bassanini, presidente della Cdp, aveva proposto, nella primavera 2013, una soluzione per il problema dei miliardi di debiti della pubblica amministrazione verso le imprese private. Ma si è scontrato con i mandarini del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, che hanno bloccato tutto…Testo tratto dal libro di Paolo Bracalini, giornalista del Giornale, "La Repubblica dei mandarini. Viaggio nell'Italia della burocrazia, delle tasse e delle leggi inutili" (Marsilio, 198 pagine, 14 euro), in libreria da pochi giorni. Da "il Foglio". Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria dello Stato. Mai sentito nominare? Probabilmente no. Eppure è l'ufficio che governa la spesa pubblica italiana, un enorme centro di potere al riparo da sguardi indiscreti, nella penombra in cui ama stare la grande burocrazia italiana, quel "mandarinato" pubblico che è il vero governo occulto del paese. "Ho fatto quattro volte il ministro e qualsiasi cosa tu possa scrivere per denunciare quanto contano queste persone sarà sempre una parte infinitesimale della realtà. Lo stato sono loro e la Repubblica è appesa alle loro decisioni", racconta Altero Matteoli, ex ministro delle Infrastrutture, parlando dei superburocrati che decidono tutto nei ministeri. "Nel 2001 nominai capo di gabinetto ai Lavori pubblici un professore, Paolo Togni, e la Corte dei conti rifiutò di registrarlo perché, dissero, non aveva i titoli. Chiesi allora che titoli servissero. Muta risposta. Ma nel silenzio fecero pressioni su Palazzo Chigi per far nominare uno dei loro: un magistrato contabile o uno del Consiglio di Stato o uno del Tar". Ci volle un mese perché Togni fosse messo nelle condizioni di ricoprire l'incarico. Ma non sempre si vince il braccio di ferro con la burocrazia ministeriale, più spesso sono loro a trionfare. "Il monopolio delle informazioni è il vero motivo della potenza della burocrazia", spiega l'economista Francesco Giavazzi. "Gestire un ministero è una questione complessa: richiede dimestichezza con il bilancio dello stato e il diritto amministrativo e soprattutto buoni rapporti con i burocrati che guidano gli altri ministeri e la presidenza del Consiglio. Gli alti dirigenti hanno il monopolio di questa informazione e di questi rapporti, e tutto l'interesse a mantenerlo". Giavazzi ha imputato alla scelta di mantenere al loro posto, "quasi senza eccezioni, tutti i grandi burocrati che guidano i ministeri", il vero motivo dell'insuccesso di Mario Monti nel taglio alla spesa pubblica. Ma il professore ricorda come questo problema sia una costante per i ministri. Anche quelli più lontani dall'apparato burocratico pubblico finiscono inevitabilmente per sbatterci la testa. Successe a Giancarlo Pagliarini, primo ministro delle Finanze della Lega Nord, nel 1994. Un marziano a Roma, un fiscalista del Nord che mai aveva avuto a che fare con quel mondo. Al suo primo giorno di lavoro Pagliarini si trovò di fronte un documento della Ragioneria generale dello Stato, a suo avviso incomprensibile: "Bisogna rifare il bilancio dello Stato da zero. Se continuano a scriverlo così, solo la Ragioneria generale lo capisce e solo loro decideranno". Inutile dire chi, tra la Ragioneria e Pagliarini, ha vinto la battaglia. L'ex ministro del Bilancio leghista ricorda perfettamente l'enorme potere di interdizione della burocrazia ministeriale. "Prendiamo come esempio la legge più importante che approva il governo", spiega Pagliarini, "e cioè la legge finanziaria. Negli ultimi anni la legge finanziaria è sempre passata con il maxiemendamento. Bene, il Parlamento lo approva di fatto senza averlo letto. Ma non l'ha letto perché non è scritto. Sì, ci sono dei punti generali, ma poi sono i burocrati che lo scrivono due o tre mesi dopo l'approvazione. E quindi come si fa a sapere come lo scrivono? In sostanza il testo che tu approvi, magari come ministro, quindi anche con delle responsabilità importanti, non lo leggi nemmeno perché non c'è, non esiste ancora". E a proposito delle sorprese che i burocrati possono riservare nell'implementare una legge, ecco che Pagliarini ci porta un esempio davvero sconcertante. "Quando si parla di burocrazia amo raccontare la storia dei Giochi del Mediterraneo di Bari. Ecco come è andata: il giorno prima del Consiglio dei ministri va in scena il preconsiglio dei ministri. Al preconsiglio ci vanno i vari capi di gabinetto che discutono e poi tornano dal ministro e gli riferiscono i risultati dell'incontro. Quindi vengono da me e mi dicono che ci sarebbero queste venti leggi da approvare e che mi consigliano di farlo poiché ci sono dei problemi da approfondire l'indomani. Il problema principale è che la destra vorrebbe 5 miliardi di lire per finanziare i Giochi del Mediterraneo di Bari. Al che mi dicono che è inutile far casino per 5 miliardi, anche perché, se il ministro si dovesse impuntare su ogni singola voce di spesa, non se la caverebbe più e che quindi sarebbe consigliato concederglieli. Il giorno dopo la prassi vuole che si approvino le voci non problematiche, si leggano solo i titoli e si approvino. C'è una cartellina con i documenti, ma di solito non si guarda mai. Bene, io quel giorno per curiosità la guardo e cosa scopro? Una cosa incredibile! Mi avevano detto 5 miliardi, ma qualcuno di notte aveva aggiunto uno zero ed erano diventati 50! E la frase non era più... "per finanziare i Giochi del Mediterraneo di Bari", ma... "per consentire l'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Bari". Io di queste cose ho le fotocopie a casa. Così funziona la burocrazia. E i giochi di Bari, dovete moltiplicarli per mille. Qualcuno negli uffici, a livello amministrativo cambia le carte in tavola! Loro sono consapevoli che nemmeno il Padre Eterno riuscirebbe a leggere sempre tutta la documentazione e se ne approfittano. Sanno che il linguaggio burocratico lo capiscono solo loro e che il politico è sostanzialmente obbligato ad approvare anche per via di pressioni esterne. Perché, per esempio, a me dicevano che bisognava approvare entro una certa scadenza sennò scattava l'esercizio provvisorio". Un po' più ottimista è invece Adriano Teso, sottosegretario del ministero del Lavoro e della previdenza sociale nel 1994. Uno che, con il ruolo che aveva, di magagne burocratiche ne ha viste parecchie. "Hai il potere di cambiare tutto", ha spiegato Teso, "se porti in Parlamento politici di una certa pasta. Ci vuole etica e capacità. Certo che se parti con politici con etica e capacità discutibili, il risultato è scarso. Pensate che io avevo addirittura portato nel mio gabinetto una mia persona per controllare i testi di legge perché capita che i tuoi dirigenti ti preparino delle leggi diverse rispetto a quelle che tu dicevi che dovevano essere fatte. E vi assicuro che sono degli artisti in questo, con il loro linguaggio criptico (come da decreto, rinviato al, la legge del... ecc.). E se un giorno ti impunti e dici di non voler firmare più niente e che vuoi vedere le carte, ti arrivano carrelli di roba alti un metro e mezzo per leggi anche di una pagina. Secondo me", prosegue, "esistono due aspetti di questa burocrazia deleteria. Uno che parte dal legislativo, perché hai un'infinità di leggi che poi, per gestirle e implementarle, ti portano per forza a un eccesso di burocrazia. Non per niente nel nostro paese c'è un eccesso legislativo. Abbiamo un impianto legislativo senza paragoni nel mondo. Poi c'è la parte organizzativa della burocrazia e quello è un processo interno dei burocrati. In più c'è anche un discorso di buona fede. Perché spesso la burocrazia non è allineata con gli obiettivi della legge, ma con obiettivi propri". A detta di Sabino Cassese, invece, il sabotaggio burocratico è una prassi. "Ricordo che Andreotti si portò come capo di gabinetto a Palazzo Chigi l'ex ragioniere generale Milazzo, e non c'è dubbio che Milazzo avesse un potere enorme", racconta Cassese intervistato da Andrea Cangini sul "Quotidiano Nazionale". "Persino Stammati, ministro del Tesoro ed ex ragioniere a sua volta, faticava a farsi ascoltare. Il fenomeno del sabotaggio burocratico è stato ampiamente studiato, accade quando le burocrazie si sostituiscono al potere politico e decidono cosa fare e quando farlo. Ricordo il caso di un noto capo di gabinetto contrario a certi cambiamenti nell'amministrazione previsti da una legge appena varata. Sapeva che il governo sarebbe durato massimo 12 mesi e fissò in 18 mesi il termine per emanare il decreto legislativo che avrebbe dovuto dare attuazione alla legge. L'Italia è caratterizzata dal fatto che i governi o durano poco, o hanno una scarsa coesione e una modesta capacità di leadership, o entrambe le cose contemporaneamente. Tutto ciò, unito all'incultura e all'inesperienza di certi ministri, fa sì che si formino sacche di amministrazione che vanno in direzione diversa da quella voluta dalla politica". La precarietà dei ministri, in confronto all'eternità dei burocrati, rende questi ultimi spesso molto più potenti dei politici, trattati con sufficienza dai mandarini di Stato che sanno di essere più forti. L'oscurità e la complessità delle leggi, invece, è fatta apposta per perpetuare il potere della casta burocratica. "I burocrati ministeriali scrivono le norme e gestiscono le informazioni in maniera iniziatica, in modo da risultare indispensabili", dice a Cangini un ex ministro che vuole restare anonimo. Franco Bassanini, presidente della Cassa depositi e prestiti, la cassaforte finanziaria del paese, aveva proposto, nella primavera 2013, una soluzione per il problema dei miliardi di debiti della pubblica amministrazione italiana verso le imprese private, ma si è scontrato con i mandarini del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, che hanno bloccato tutto. La soluzione era una semplice cartolarizzazione: i debiti, garantiti dallo Stato, vengono trasferiti dalle imprese alle banche, che liquidano immediatamente le imprese immettendo così miliardi nell'economia. Poi lo Stato garantisce, attraverso la Cassa depositi e prestiti, che le banche vengano rimborsate dalla Pa, con un piano di rientro distribuito in un arco di più anni. "Le banche italiane avrebbero comprato volentieri i 90 miliardi di euro di debiti garantiti dallo Stato", racconta Bassanini, intervistato da Alan Friedman. "Sarebbe stata un'operazione virtuosa che immetteva in un colpo solo 60-70 miliardi nell'economia italiana e dava benzina all'economia, senza incidere sul deficit neanche dello zero per cento". Le imprese verrebbero pagate subito (dalle banche), lo Stato potrebbe ripagare i debiti nel tempo, mentre le banche avrebbero la convenienza di poter compensare i propri crediti con le imprese. Tutti contenti, dunque. La Spagna lo ha fatto e ha funzionato, nel Parlamento italiano, poi, c'era la maggioranza pronta a votare il piano Bassanini. E allora, come mai non si è fatto? "C'è stata una forte resistenza burocratica... In questo caso specifico la tesi (dei vertici del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato) era che l'Europa non ce lo avrebbe permesso. La burocrazia italiana, tanto più quando è preparata e forte, spesso usa l'Europa come pretesto per non fare le cose che non vuole si facciano. Ci sono diverse cose che servirebbero alla crescita del paese e che trovano resistenze non politiche ma burocratiche". La vera casta sono i burocrati. Per questo è arduo, se non impossibile, cambiare veramente, in Italia. Prova ne sia il documento di "passaggio di consegne" affidato dal ministro dell'Economia uscente, Fabrizio Saccomanni, a quello entrante, Pier Carlo Padoan. Ventisei fogli A3, meticolosamente annotati, che illustrano la bellezza di 465 fra decreti e regolamenti previsti dalle riforme dei governi Letta e Monti, ancora da attuare, alcuni fermi da due anni. Su quel macigno di leggi immobili i funzionari dei ministeri spesso specificano: "L'attuazione (del decreto per una piattaforma elettronica per i debiti Pa, ndr) presenta oggettive difficoltà attuative". "Per un altro decreto", scrive Fabrizio Forquet sul "Sole 24 Ore", "l'annotazione a uso interno è la fotografia dello stallo burocratico: "Sollecitata Rgs da Ulf, ufficio legislativo Finanze (nota 1418 del 10 febbraio). Il Dipto Finanze concorda con l'Ag. Entrate riguardo all'opportunità di abrogare la disposizione. Anche Rgs è d'accordo. Evidenziate dagli Uffici (Ag. Entrate, Dipto Finanze, Rgs) difficoltà applicative all'adozione del decreto. Opportuna abrogazione della disposizione"". Il responso, riportato nella colonna a fianco, è inesorabile: "Non attuabile". Il sigillo dell'alta burocrazia gattopardesca italiana: riscrivere tutto, perché nulla cambi. Chi comanda nei ministeri Ci racconta un ex ministro della Giustizia di lungo corso che preferisce restare anonimo: "La legge Bassanini che ha riformato la pubblica amministrazione divide nettamente la classe politica da quella amministrativa. Il ministro può soltanto dare gli indirizzi di natura generale e politica, tutto il resto lo fa l'amministrazione del suo ministero, al punto che ormai gli atti che firma il ministro sono quasi soltanto di natura formale, mentre quelli attuativi sono in mano all'amministrazione. Faccio un esempio. Un ministro non firmerà mai una gara d'appalto o un affidamento, queste pratiche competono tutte all'amministrazione. La conseguenza è che quando sei lì, ti trovi dentro un macchinone immenso, quello del tuo dicastero, e qui c'è già il primo problema. Lei pensi che al ministero della Giustizia avevo sotto di me 120 mila dipendenti, il ministro dell'Istruzione ne ha un milione... Con queste dimensioni significa che il ministero è diviso in una serie di dipartimenti che gestiscono realtà enormi, con molti capitoli di spesa e con i funzionari che fanno passare i soldi da una parte all'altra senza che il ministro possa controllare nulla. Come la storia degli esodati della Fornero. E' chiaro che le hanno dato delle cifre sbagliate i suoi funzionari... Un ministero è un macchinone gigantesco, il ministro non sa tutto, anzi spesso sa poco. Pensi che a me avevano messo una centrale di ascolto al ministero senza dirmi nulla. I funzionari tendono a ragionar così: tu fai il ministro, ma le cose importanti le decidiamo noi, i capi dipartimento. Una figura strapotente al ministero della Giustizia è il capo del Dap, il Dipartimento di amministrazione penitenziaria. Gestisce un budget di 5 miliardi di euro su 7 totali del ministero, 50 mila poliziotti della penitenziaria. Immagini il potere che ha. Poi molto dipende anche dalla personalità dei vari ministri. Con un ministro debole i burocrati hanno uno spazio di intervento enorme... Naturalmente se sei esperto della materia puoi in qualche modo capire cosa sta succedendo nel tuo ministero. Bisogna stare molto attenti alle cifre che ti vengono date dall'apparato". Caso tipico è al ministero delle Infrastrutture. "Il nostro problema", ha spiegato al Fatto Quotidiano Alessandro Fusacchia, ex consigliere per la diplomazia economica alla Farnesina, "è fondamentalmente l'incertezza giuridica. Abbiamo migliaia di leggi e leggine che insistono sullo stesso argomento, per esempio il lavoro, e nessuno sa esattamente quali siano le regole. In questo modo nessuno si assume dei rischi e tutto diventa lentissimo". In questo caos acquista potere la casta dei giuristi di Stato, dei capi di gabinetto e degli uffici legislativi. "Stiamo parlando di circa 50 persone che controllano l'essenziale ", ha detto Fusacchia. la ragioneria (di Stato) ha sempre ragione Ma non ci sono soltanto i grandi boiardi dei ministeri: capi di gabinetto, capi di dipartimenti, esperti legislativi, consiglieri. Ci sono anche organismi terzi, composti da tecnici o da magistrati, che contano moltissimo sull'attuazione (e soprattutto sulla non attuazione) di riforme, leggi e decisioni politiche. Uno di questi è il Cipe, il comitato interministeriale per la programmazione economica. "I ministeri di spesa passano tutti dal Cipe. Le spese per l'edilizia scolastica, le infrastrutture, i fondi per l'industria, la banda larga, passa tutto da lì. E' composto dai ministri, ma anche dalla Ragioneria generale dello Stato che ha un enorme potere di veto. Se non vedono che dal punto di vista finanziario è tutto a posto, non ti danno il benestare. Se non c'è la famosa bollinatura, la bollinatura della Ragioneria, non passa niente. Allora non è più soltanto una questione tecnica, ma anche politica, perché se si decide che un'opera non va bene, non si farà mai. E capita spessissimo". Le bollinature, cioè il via libera contabile della Ragioneria a ogni provvedimento di spesa, "vengono concesse solo se il provvedimento rientra nella "visione" politica del ragioniere generale. In caso contrario vengono negate o subordinate a scelte "politiche" diverse", racconta un ex ministro diessino che vuole restare anonimo. L'ha sperimentato sulla propria pelle l'ex senatore Mario Baldassarri, che da presidente della commissione finanze provò a metter mano a quella parte di spesa pubblica, per acquisto beni e servizi (40 miliardi l'anno), che fa capo alle grandi burocrazie ministeriali. L'emendamento non piaceva al capo del legislativo dell'economia e alla Ragioneria generale dello Stato, che non gli diede la "bollinatura". Lui andò avanti, finché alcuni compagni di partito gli dissero di aver ricevuto una telefonataccia da un importante direttore generale di ministero che consigliava di ritirare quell'emendamento. Baldassarri si infuriò, minacciò di chiamare l'autorità costituita e di denunciare il ragioniere generale dello Stato per "palesi falsi e giudizi politici". Ma alla fine tutto fu insabbiato.
Dio perdona, la burocrazia no. Le pratiche burocratiche richiedono 269 ore all'anno per impresa, con un costo complessivo di 31 miliardi. I costruttori attendono 231 giorni per un permesso edilizio. A Milano servono 23 autorizzazioni diverse per organizzare un evento. Viaggio nel girone infernale italico..., scrive Matteo Borghi su “L’Intraprendente”. Hyman Rickover, il pioniere della propulsione atomica navale, diceva che “se proprio devi peccare pecca contro Dio, non contro la burocrazia. Dio perdona, la burocrazia no”. Ed in effetti, a vedere alcuni casi, pare che il nostro ammiraglio non avesse torto. Emblematica è quella storia, che abbiamo raccontato tempo fa, di un signore che – per non aver versato un centesimo – si è visto recapitare una multa cinquemila volte più alta. La burocrazia non ammette ignoranza, sbadataggine, errore umano ma pretende inflessibile a ogni logica di buonsenso, il rispetto formale di passaggi che in molti casi sono quasi impossibili da attuare. Giusto per fare un esempio fino a pochi mesi fa ci volevano ben 23 autorizzazioni per creare un evento culturale a Milano. Che non vuol dire 23 fogli ma 23 (ven-ti-tré) procedure burocratiche autonome: una molte tanto ingente che lo stesso Comune ha ammesso che, qualche volta, qualcuno saltava qualche passaggio. Ed è drammatico pensare come le code burocratiche si allunghino sempre di più. Ancora più alto e dannoso è il costo della burocrazia per le imprese. Secondo il Centro Studi Impresa Lavoro le pratiche burocratiche richiedono 269 ore l’anno con un costo medio ad impresa di 7.559 euro. Secondo un calcolo della Cgia di Mestre alle imprese la burocrazia costa ogni anno 31 miliardi di euro, che portano la pressione fiscale complessiva a 248,8 miliardi. Insomma si tratta di un vero e proprio peso insostenibile, destinato a schiacciare sotto di sé qualsiasi ipotesi di ripresa. “Se teniamo conto – si chiedeva il compianto Giuseppe Bortolussi – che il carico fiscale sugli utili di una impresa italiana ha raggiunto il 68,6%, contro una media presente in Germania del 48,2%, c’è da chiedersi come facciano i nostri imprenditori a reggere ancora il confronto. Per questo bisogna dire basta ad un fisco opprimente e ad una burocrazia ottusa. Lavorare in queste condizioni costringe gli imprenditori italiani a trasformarsi quotidianamente in piccoli eroi: questo non deve più accadere”. Ne sanno qualcosa i numerosi costruttori che devono attendere, di media, 231 giorni (con un costo che può arrivare fino a 64 mila e 700 euro) per un permesso edilizio: in Germania bastano 97 giorni, 99 a Londra, 182 a Madrid dove però il costo medio per avere il via libera a costruire è di appena 12 mila euro, ovvero ben meno di un quinto dell’Italia. E ne sa ancora di più il patron di Esselunga Bernardo Caprotti che ha dovuto attendere dal 1971 al 2014 per costruire un supermercato in un terreno di sua proprietà a Firenze. Per 43 anni politici e burocrati si sono infatti opposti a qualsiasi ipotesi di costruzione del suo polo commerciale, accampando scuse che secondo alcuni nascondevano – in realtà – un sostegno indiretto all’avversaria Coop. Sì perché se c’è una caratteristica della burocrazia è l’asimmetria: pretende molto dagli noi, ma troppo poco da se stessa. Ci considera, più che come cittadini, come sudditi.
IL LEVIATANO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E BUROCRAZIA. IL BILANCIO DEVE ESSERE EQUILIBRATO, IL TESORO RIPIANATO, IL DEBITO PUBBLICO RIDOTTO, L’ARROGANZA DELLA BUROCRAZIA MODERATA E CONTROLLATA, E L’ASSISTENZA ALLE NAZIONI ESTERE TAGLIATA, PER FAR SÌ CHE ROMA NON VADA IN BANCAROTTA. CICERONE
Quanto sono ancora attuali le parole di Cicerone? Si continua ancora oggi a parlare di semplificazioni e ammodernamenti della burocrazia in Italia ed, anche se qualche passo avanti è stato fatto, è evidente che ancora molto ci sia da fare. Il problema è che per saper organizzare in modo efficace il “da farsi” e per assumere i giusti provvedimenti è in primo luogo necessario conoscere a fondo i meccanismi e la dinamica con la quale vengono elaborati ed emanati gli atti amministrativi che fanno capo ai tanti adempimenti burocratici. In pratica per incidere concretamente sulla macchina burocratica è fondamentale capire come funziona cosa che non mi risulta sia poi così diffusa. Si mettono così in moto processi di modifica di questo o quello spezzone di attività, ma se non si ha una vera visione d’insieme si rischia di aggiungere alle carenze già esistenti ulteriori danni. E non basta sbandierare il termine “digitalizzazione” per riuscire a smuovere apparati ormai vecchi e superati, modi di lavorare anacronistici, approcci ai problemi farraginosi e complicati, alla fine può anche succedere che riusciamo a digitalizzare tutta una branca di attività, ma poi siamo costretti a conservare negli uffici e negli archivi pubblici moli sempre crescenti di materiale cartaceo, perché le regole che sottostanno al processo di digitalizzazione che abbiamo creato sono talmente complicate ed incomprensibili che i nostri interlocutori non ci capiscono nulla, sbagliano, si perdono ed allora meglio far consegnare loro ancora tanta e tanta carta. Inoltre manca la connessione tra archivi e sistemi informativi che il più delle volte non sono in grado di dialogare tra di loro perché ciascun Ente ha scelto in autonomia senza considerare l’interconnessione dei sistemi, e si è venuta a determinare così una sorta di moderna babele telematica. Quante volte si assiste allo sbandieramento da parte del politico di turno del provvedimento risolutivo per la semplificazione amministrativa? Che fine fanno poi queste iniziative? Restano per lo più semplicemente lettera morta perché manca il decreto attuativo, manca la circolare interpretativa, una qualche sentenza ne inficia l’efficacia: il tutto si perde nelle nebbie di qualche Ministero preposto alla cosiddetta semplificazione …MARX HA CONFUSO UNA DITTATURA DELLA GIUSTIZIA CON LA DITTATURA DEI BUROCRATI. HERBERT MARCUSE. Come scriveva Marcuse analizzando la filosofia di Marx si corre il rischio di creare una vera e propria “dittatura dei burocrati”, una dittatura ancor più pervasiva e invadente, ma soprattutto insidiosa perché nascondendosi dietro a moduli farraginosi e carta bollata in triplice copia costringe comunque l’individuo a sottostare alla sua potenza egemone. La “dittatura dei burocrati” risulterebbe così la dittatura più compiuta, si trasforma uno strumento amministrativo che dovrebbe servire alla parificazione degli individui di fronte allo Stato in uno strumento costrittivo dove i ceppi e le catene sono fatti di autorizzazioni, protocolli e commi. Per riuscire a modificare davvero le cose come si è già detto si richiederebbe innanzitutto una conoscenza approfondita di ciò che si intende modificare, ma la “macchina” della Pubblica Amministrazione è in realtà un moloch che pochissimi conoscono a fondo, ed inoltre è qualcosa che nel tempo si è talmente resa complicata da sortire l’effetto di “bloccare” e “paralizzare” a volte perfino chi ci lavora all’interno e che magari per primo avverte la necessità di un cambiamento davvero radicale. Così questo mastodonte in Italia incombe sulle nostre vite, per rendercele ogni giorno più difficili con qualche cavillo, o con qualche nuova regola, stare dietro a tutto, e questo secondo quanto affermano persone molto preparate in campo giuridico, diventa un’impresa che non ha mai termine e quel che è peggio che non consente neanche brevi momenti di pausa, una tregua per prendere come si dice almeno un po’ di fiato. Lo Stato Leviatano di Hobbes è tra noi, ci sovrasta ogni giorno, ci costringe forzosamente in fila, ci cataloga, si nutre del nostro tempo. La complessità del Leviatano lo rende intangibile all’azione del singolo cittadino che si trova ad essere in balia della “macchina” burocratica. Quante volte abbiamo la sensazione di essere assolutamente impotenti? C’è da chiedersi se tutta questa complessità è veramente indispensabile per garantire la legalità e la legittimità delle azioni, o è un modo per garantirsi una sorta di potere sui cittadini e quel che è peggio per favorire chi, e purtroppo le cronache di questi giorni ce ne hanno parlato a lungo, intende nascondere propri personali obiettivi e raggiungere finalità che vadano a proprio vantaggio e non certo della cittadinanza? Orwell in 1984 ci ha mostrato come Il Partito con la sua macchina statale persegua questa seconda finalità, siamo davvero sicuri di non vivere in una realtà del genere? Forse il Grande Fratello si è concretizzato non sottoforma di persona, ma di macchina statale impersonale? C’è quindi ancora molto da fare, la strada da percorrere è purtroppo ancora molto lunga, ma c’è poi davvero la volontà di cambiare le cose da parte di chi lo può fare? E l’apparato burocratico da parte sua è effettivamente disponibile a consentire questo cambiamento e a parteciparvi o, a sua volta, funge da freno per rallentare il tutto? Il problema è che la burocrazia è sempre più autoreferenziale in quanto lavora in prevalenza solo per giustificare se stessa. Ad esempio la P.A. non dovrebbe chiedere ai cittadini degli adempimenti che già potrebbe benissimo gestire in base alle informazioni di cui è già a conoscenza. Un caso emblematico è rappresentato in questi giorni da IMU e TASI, per le quali si chiedono calcoli complicati e compilazione di moduli quando i dati per i versamenti sono già in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Mi chiedo perché se già altri paesi europei riescono a funzionare benissimo nel campo della Pubblica Amministrazione e potrebbero fornirci, in base alla strada da loro tracciata, degli spunti utilissimi, non si riesca neppure a cogliere questi stimoli e tutto in Italia debba essere sempre così ripetitivo e pesante. La Pubblica Amministrazione dovrebbe essere uno dei settori maggiormente gratificanti per quanti vi lavorano, perché nulla può essere più appagante dello svolgere un’attività sapendo che quello che si fa sarà utile, inciderà positivamente e migliorerà la vita dei cittadini. Invece in Italia pare essere una delle attività più frustranti per quanti vi operano ed anche una delle attività che “ingrigiscono” e fanno perdere entusiasmo ai lavoratori. Allora evidentemente c’è per forza molto da cambiare, e non basteranno riforme limitate ad alcuni spezzoni per riuscire a modificare in meglio il tutto. Deve radicalmente cambiare poi l’approccio che l’apparato pubblico ha con il cittadino, perché in un ufficio pubblico è davvero difficile non sentirsi a disagio, questo ancora di più se si è anziani, disabili, o se si è in possesso di pochi strumenti derivanti dall’istruzione scolastica. Il linguaggio usato da quanti vi lavorano è spesso poco semplice e comprensibile, se si chiedono delle spiegazioni la disponibilità a darla è molto scarsa e se comunque le spiegazioni vengono date lo si fa purtroppo spesso con atteggiamento di superiorità e fastidio nei confronti dell’interlocutore che si è macchiato della colpa di non aver capito. Per non parlare della quantità di moduli, prospetti, caselle ecc. che si è costretti a compilare per ottenere qualcosa che ci spetta ed a cui avremmo diritto di avere molto più semplicemente accesso. Non voglio che questo mio intervento venga letto però come un susseguirsi di lamentele, penso solo che se riusciamo a comprendere dove si enucleano le criticità forse, se sul serio vi sarà da parte di chi ci governerà la volontà di rimuoverle, potremo fare un passo avanti per superarle. Sarà basilare in questo chiedere un contributo da parte di quanti lavorano all’interno della Pubblica Amministrazione, ascoltarli, sentire da loro cosa li fa lavorare così con difficoltà, cosa li potrebbe motivare, perché, e questo sarà bene ribadirlo, in questo settore ci sono moltissime persone che pur con tante difficoltà lavorano bene, con competenza e professionalità, ed avendo ben presente quanto sia importante uno svolgimento pronto, puntuale, efficace, scrupoloso del lavoro per l’intera comunità. Certo la campagna denigratoria sul dipendente pubblico praticata da molti non ha aiutato a risolvere i problemi, semmai li ha ulteriormente complicati, sono questi problemi estremamente delicati, da affrontare con lucidità, lungimiranza, equità, ampiezza di vedute, dopo essersi spogliati di pregiudizi e luoghi comuni, e solo una buona dose di equilibrio potrà consentirci di fornire ai cittadini dei servizi rispondenti alle loro necessità. È legittimo immaginare una burocrazia al servizio del cittadino o siamo destinati a restare rinchiusi in questa prigione senza sbarre fatta di moduli e carta bollata?
OGNI RIVOLUZIONE EVAPORA, LASCIANDO DIETRO SOLO LA MELMA DI UNA NUOVA BUROCRAZIA. FRANZ KAFKA
Hanno ragione George Orwell e Franz Kafka quando ci mettono in guardia dalla possibilità di uscire dalle costrizioni derivanti della burocrazia al punto che qualsiasi rivoluzione comporterebbe solo la restaurazione sotto altre spoglie diverse del medesimo sistema? Matteo Montagner su “La Chiave di Sophia”.
Burocrazia, ecco l'arma letale della dittatura, scrive di Rino Cammilleri su “La Nuoiva Bussola Quotidiana”. Al tiranno dà fastidio la nobiltà, perché è da questo ceto intermedio tra il potere e il popolo che potrebbe venire l’insidia. Già nel Giappone cosidetto feudale (che col feudalesimo occidentale, però, ha niente da spartire) l’imperatore obbligava i nobili a risiedere sei mesi l’anno nella capitale, e a lasciarci i familiari sempre. In Europa, l’assolutismo regio finì col fare lo stesso e trasformò i nobili in cortigiani nullafacenti. «Lo Stato sono io». La frase del Re Sole è apocrifa, ma rende bene l’idea. Il centralismo però richiede burocrazia, parola non a caso di origine francese (bureau=ufficio) rimbalzata in tutte le lingue, dall’americana Fbi (Federal Bureau of Investigation) al russo Politburo. I giacobini insomma trovarono il lavoro già fatto dall’assolutismo regio, e bastò loro impadronirsi della sola testa per prendere tutto il corpo. Il centralismo facilita e, dunque, incoraggia, i golpe. Come quello bolscevico, che la Rivoluzione la fece, semmai, dopo. Il comunismo sovietico è crollato, sì, ma il giro mentale è rimasto. E oggi l’intero Occidente si divide tra quelli che vogliono sempre più Stato e quelli che non ne possono più. I primi, ovviamente, di Stato campano, perciò comandano. Gianluca Barbera sul Giornale dell’8 settembre ha ben sintetizzato il giacobinismo che nel Terzo Millennio ancor ci opprime: «Statalismo, assistenzialismo, proliferazione burocratica, clientelismo, fiscalità oppressiva, inamovibilità del pubblico impiego, onnipresenza dei sindacati, populismo, politicizzazione della giustizia, appiattimento sociale e professionale, vittimismo cronico, buonismo autolesionistico, cultura dell’odio e dell’invidia sociali». Metteteci anche nani&ballerine per la difesa propagandistica e c’è tutto. Ora, che il sistema sia irredimibile (hai voglia di “riforme”!) è testimoniato dal fatto di Roma, dove detto sistema cerca di correggere se stesso con una pezza non molto diversa dal buco. Cioè, con un ennesimo funzionario. Il prefetto Gabrielli, mandato a vedere come si possa rimediare alla situazione della Capitale, situazione che è un mix di corruzione e inefficienza, ha relazionato al suo superiore, il ministro dell’interno Alfano. Nella relazione, tra l’altro, si segnalano i burocrati, tra dirigenti e funzionari, da rimuovere con una certa urgenza. Ora la patata bollente passa alla politica, e perciò aspettiamoci qualche giro di poltrone (non di più). Ma il punto è che, anche volendo agire con logica e pugno di ferro (cioè, chi ha sbagliato paghi, chi non ha vigilato se ne vada, chi non ha saputo fare il suo mestiere si tolga dai piedi), l’eventuale licenziato fa subito ricorso al giudice del lavoro e questo in nove casi su dieci lo reintegra. Non solo. A volere agire come una normale azienda, la quale, quando i profitti crollano, si sbarazza del manager inadeguato, si rischia anche di più. Per restare nell’esempio romano, è lo stesso assessore ai Trasporti a far osservare che l’Atac, l’azienda di trasporto, semplicemente non ha i soldi per mandare a casa quelli che senza soldi l’hanno ridotta: dovrebbe pagare loro la buonuscita come da contratto, e sarebbero centinaia di migliaia di euro. Che l’Atac non ha. Sono le leggi sul lavoro, bellezza. Quelle italiane, almeno. Chi ha provato, non tanto a riformarle, ma solo a studiare una loro possibile modifica è finito sparato. Roma? Situazione disperata, ma non seria (titolo di un film del 1965 con Alec Guinness). Restando in loco, viene in mente l’antico aneddoto della vecchietta che, unica nella folla, augurava lunga vita a Nerone. Al quale la folla, invece, augurava morte e maledizione. Eh, era vecchia e di imperatori ne aveva visti tanti. E, ogni volta, il successivo si era rivelato peggiore del precedente. Morale: se il problema è intrinseco al sistema, cambiare le facce serve a poco.
Tante leggi e poco cervello. La dittatura dei burocrati. Il caos dei balzelli sugli immobili è solo l’ultimo esempio. I ministri sono ostaggio di funzionari inamovibili che ci complicano la vita per ragioni di potere, scrive di Maurizio Belpietro su “Libero Quotidiano” il 10 gennaio 2014. Enrico Zanetti è un politico di primo pelo. Nel senso che fino a otto mesi fa non sedeva in Parlamento ma nel suo studio di commercialista a Venezia. Poi, non si sa perché, gli è venuta l’idea malsana di candidarsi alle elezioni politiche e dunque eccolo catapultato tra i banchi di Montecitorio con la maglietta di Scelta Civica, il partito non partito (nel senso che non è mai nato) di Mario Monti. Alla Camera dei deputati Zanetti riveste un compito di un certo prestigio: essendo un fiscalista l’hanno infatti nominato vicepresidente della Commissione finanze, quella che discute i provvedimenti sul fisco prima che vadano in aula. A Zanetti ho provato a chiedere come si esce del pasticcio Imu, Iuc, Tasi e Tari di cui ci occupiamo anche oggi in prima pagina. La risposta è stata la seguente: «Con le ultime elezioni abbiamo cambiato il 65 per cento dei parlamentari, ma se non cambiamo il 65 per cento dei dirigenti del ministero delle Finanze temo che non faremo molti passi avanti». Può sembrare una battuta, ma non lo è. Perché se è vero che Saccomanni come ministro dell’Economia è un disastro, è altrettanto certo che la catastrofe non è tutta farina del suo sacco: per riuscire a complicare così bene la vita degli italiani, qualcuno all’interno del suo dicastero deve avergli dato una mano. Essendo del mestiere, Zanetti alza il velo su una realtà che in pochi conoscono e cioè che i ministri vanno e vengono e i governi pure, ma i funzionari restano e sono quelli a decidere del nostro destino. Prendete il caso del prelievo forzoso sugli stipendi degli insegnanti: la Carrozza ha negato di essere a conoscenza della cosa, mentre Saccomanni si è limitato a dire che si trattava di un fatto tecnico. Dalle frasi si capiva che né l’uno né l’altro avevano la minima idea di come si fosse arrivati al taglio in busta paga, che evidentemente era opera delle retrovie ministeriali. Si può discutere sul ruolo di due tizi che non sanno neppure che cosa accade in casa loro e magari anche convenire sulla necessità di fare a meno di entrambi risparmiando i loro stipendi, ciò non toglie che fra i dirigenti dell’Istruzione e delle Finanze c’è chi usa le forbici senza collegare il cervello e soprattutto senza valutare che sta affettando la vita delle persone. Insomma, fino a che non apriamo il capitolo della burocrazia di questo Paese e non capiamo che dietro un ministro c’è un funzionario che è spesso peggio del suo capo non riusciremo a modificare nulla. Le chiavi del sistema non le ha in mano il politico ma le possiede chi sta lì da una vita e sa che ci starà anche dopo che il ministro se ne sarà andato. Sono loro che scrivono le leggi e suggeriscono le misure da adottare. E poi, fatta la legge, è il dirigente che predispone le norme attuative. E sempre alla struttura tecnica tocca il compito di predisporre le circolari interpretative. Eh già, perché noi siamo l’unico Paese dove per cambiare qualcosa non basta che il governo faccia un decreto e il Parlamento lo approvi. Né è sufficiente che Camera e Senato presentino un disegno di legge e successivamente lo votino. No, da noi serve la norma attuativa della legge, altrimenti - com’è successo per gran parte delle riforme varate da Mario Monti - è come se non esistesse. E poi, quando ci sono la legge e le norme attuative, urge la circolare interpretativa, perché la legge è così vaga, lacunosa e malfatta che un dirigente deve dire come la si interpreta. Di fatto il legislatore non è il politico, ma il burocrate. È lui che detiene il potere. E più le norme sono scritte male e dunque da interpretare, più la discrezionalità del dirigente è ampia. Grazie a questo sistema abbiamo le leggi più incomprensibili del mondo. E sempre per via di tutto ciò abbiamo una legislazione ridondante, che nessuna semplificazione è riuscita a sfoltire. E più si complica la vita dei cittadini con tasse, timbri, adempimenti, pasticci vari, più la corruzione e l’evasione avanzano, perché dove c’è discrezionalità c’è anche la possibilità di fare i furbi e di farla franca. Insomma, l’Imu, la Tasi, la Iuc, la Tari e tutte le altre tremende trappole disseminate sul nostro percorso, non nascono a caso ma servono al sistema per autoalimentarsi e per rendersi indispensabile e inestricabile. In altri Paesi l’evasione la corruzione non ci sono o ci sono di meno perché le leggi sono chiare e non consentono scappatoie. Pagare le tasse è semplice: il Comune a nome dello Stato ti manda a casa un bollettino e tu non devi fare altro che portarlo in banca e autorizzare il pagamento. La dichiarazione dei redditi è comprensibile a chiunque e per spiegarla non serve rivolgersi al Caf o compulsare testi da 700 pagine, bastano quattro paginette. Se dunque qualcuno vuole davvero ridurre le tasse e cambiare questo Paese, la prima cosa da fare è cambiare la legislazione fiscale e farne una nuova. Possibilmente non con gli stessi servitori dello Stato che prima hanno servito Padoa Schioppa e Visco, poi Tremonti, quindi Monti e infine Saccomanni. Se un politico va rottamato dopo due mandati, chi lo ha aiutato a fare danni come minimo merita la stessa sorte...
Siamo un popolo oppresso dalla dittatura della burocrazia. Così gli italiani sono oppressi dal dispotismo burocratico, scrive Piero Ostellino Venerdì 13/11/2015 su “Il Giornale”. Che al governo ci sia il centrodestra ovvero il centrosinistra, l'effetto per il cittadino è sempre lo stesso: nuove tasse. Era stato Einaudi ad imporre che per ogni nuova legge ci fosse la copertura finanziaria. Il principio è corretto ma evidentemente qualcosa ne impedisce il buon funzionamento se il processo legislativo, che dovrebbe essere a carico della fiscalità generale a pagarlo è, immancabilmente, il contribuente con una tassazione supplementare... La verità (...)(...) è che lo Stato costa troppo rispetto a ciò che rende, perché pesa su di esso la burocrazia cui deve chiedere assistenza ad ogni proprio atto. Per cui, la soluzione dovrebbe essere una grande riforma della Pubblica amministrazione che elimini la presenza eccessiva della burocrazia dall'attività legislativa, che dovrebbe cadere sotto la fiscalità generale, e dalla vita del cittadino. Lo aveva capito Berlusconi, che si era ripromesso di ridurre la pressione fiscale, lo ha promesso Renzi senza che nessuno dei due abbia tenuto fede all'impegno preso perché il difetto sta nel manico. Vale a dire nello Stato moderno. Trecento anni fa, l'uomo si è liberato dal dispotismo del monarca assoluto, che decideva a propria discrezione della vita dei propri sudditi. Sulla base del principio democratico «nessuna tassazione senza rappresentanza politica» la sovranità è passata dal monarca al popolo. Ma il risultato è stato lo stesso: in nome del popolo sovrano, il rapporto tra cittadino e potere politico si è trasformato, il cittadino è ritornato suddito come era sotto il sovrano assoluto; la fiscalità è lo strumento con il quale il potere politico esercita il proprio dispotismo. In definitiva, solo una grande riforma della Pubblica amministrazione può liberare il cittadino dalla dittatura della burocrazia, che tiene sotto il proprio controllo anche la politica. La volontà generale di Rousseau - che avrebbe dovuto realizzare la massima democrazia - si è tradotta nel suo contrario con il risultato che il cittadino conta ancor meno di quanto contava di fronte al monarca assoluto.
Quando i burocrati sono veri mostri (anche nel fantasy). Da Guerre stellari alla saga di Harry Potter, i cattivi sono armati di scartoffie e codicilli. Proprio come a Bruxelles, scrive Vittorio Macioce su "Il Giornale”. La sera li trovi a Les Aviateurs, in Rue des Soeurs, non lontano dalla cattedrale di Notre Dame, a Strasburgo. Lo stile è anni '50 e loro si ritrovano in quel locale dove davvero le nazionalità sembrano azzerarsi con il sogno di lasciarsi alle spalle carte e regolamenti e affogare le illusioni in pinte di birra, in canzoni vintage e nella speranza di una notte d'amore da cancellare il giorno dopo. Qui, almeno tre volte al mese, si ritrovano parlamentari e apprendisti burocrati, precari di palazzo e lobbisti, segretarie e gli ultimi fantasmi del grande gioco. È Strasburgo ma vale ancora di più per Bruxelles. Qui e lì c'è il cuore e l'anima dell'Europa, il volto del superstato, l'odore profondo di questo impero tecnocratico costruito sulla divinità della moneta unica. Ma per capire davvero di cosa si tratta bisogna, di giorno, passare al numero uno dell'Avenue Robert Schuman e guardare quel palazzo, con la parte superiore che dà l'idea di qualcosa ancora non finito e l'interno che ti sembra di aver visto già da qualche parte. Sì, qualcosa che ha l'odore dell'utopia corrotta, di ideali andati a male. Poi capisci. Il Parlamento europeo con quella gente che cammina veloce, in divise grigie, dove le lingue si mischiano, ma l'ossessione è la stessa, con l'emiciclo enorme che sembra sospeso nello spazio e i traduttori che vomitano parole inutili, è il remake del senato di Star Wars. E a quel punto ti viene voglia di smascherare una volta per sempre il senatore Cos Palpatine. Perché lui sta lì, non ci sono dubbi. Nascosto sotto uno di quei volti, magari con accento tedesco o francese, con il sorriso bonario di chi sembra stare dalla tua parte, quando in realtà tutti sappiamo che quel politico sacerdote dei regolamenti e faccendiere non è altro che il capo dei Sith. È Darth Sidious. È il lato oscuro della forza. Allora ti sembra quasi di sentire quella frase che segna la fine di ogni libertà: «Nell'intento di garantire la sicurezza e una durevole stabilità, la Repubblica verrà riorganizzata, trasformandosi nel primo Impero Galattico! Per una società più salda e più sicura!». È così che si chiude la Vendetta dei Sith. È così che si arriva al Ritorno dello Jedi e alla sconfitta della «Morte nera». Per recuperare un grammo di speranza è necessario, però, ritornare a Les Aviateurs. E capire che quel luogo stretto e lungo, con un bancone che occupa mezzo locale e dove i burocrati mostrano il loro vero volto, è in realtà la Cantina di Chalmun, conosciuta anche semplicemente come Cantina di Mos Eisley, popolare taverna di Tatooine. È nel «quartiere vecchio» e qui affari di tutti i tipi vengono condotti nell'ombra. È qui che Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi ingaggiarono il contrabbandiere Han Solo e il suo compagno Chewbacca per essere trasportati ad Alderaan. Solo qui questo può avvenire, nel bar della notte, quando i burocrati si riscoprono umani e l'Europa assomiglia a quello che avrebbe dovuto essere, un lungo viaggio senza frontiere sui binari dell'Interrail. È qui allora il senso di quello che fantascienza, fantasy e romanzi distopici ci hanno tramandato. È metterci in guardia da tutto questo, da questa Europa, dalle cattedrali di scartoffie, dal potere senza controlli, dalla stabilità dettata dagli indici finanziari, dalle tasse come forma di razionalizzazione dell'impresa, dove non si premia il coraggio di rischiare, ma l'adesione ai parametri burocratici, dove ogni cosa deve essere regolamentata e codificata, dove la realtà è solo una ragnatela di misure e procedimenti standard, dall'esercito dei cloni dove l'umano è ridotto a media statistica. È qui allora che si realizzano tutte le paure dell'Occidente. E come diceva Yoda è la paura il miglior alleato della parte oscura. Perché è chiaro che noi stiamo accettando questa Europa solo per paura di fare i conti con l'incertezza. Tutti gli imperi in fondo servono a questo: ci tolgono la libertà con la promessa di cancellare le nostre paure. È tranquillizzarci sul fatto che Dio non gioca a dadi. Pensateci. Pensate alla saga della Rowling. Chi è il vero nemico di Harry Potter? La risposta immediata è Voldemort, colui che non si può nominare. Ma Voldemort ingabbia i suoi nemici sfruttando gli ostacoli che, in modo consapevole o ad insaputa, produce la burocrazia. È il ministero della magia il primo avversario di Harry. Non lo riconosce, non riesce a catalogarlo, lo vive come un outsider, un incosciente, un piantagrane, uno da fermare con leggi e regolamenti e pazienza se in questo modo si apre la strada al potere rassicurante, stabile, di Voldemort. Nel Trono di Spade dove comincia la tragedia degli Stark? È ad Approdo del re, nella capitale del Regno, dove non valgono più le regole del Nord, ma quelle della corte. E il pericolo più insidioso arriva dagli intrighi del tesoriere Ditocorto. È lì, all'incrocio dei Sette Regni, che la partita per il potere si riduce a una scelta binaria, on o off, acceso o spento, uno o zero. Nel gioco dei troni o si vince o si muore. Ed è il gioco che ha sempre fatto la Germania. E l'unica consolazione è che farlo con la moneta (i denari) è meno cruento e drammatico rispetto alle spade. Il guaio è che ci sono molti modi per spargere distruzione e cancellare il futuro. C'è perfino chi lo fa spacciando cattiva poesia. Mai sentito parlare dei Vogon? Certo, proprio loro, quelli di Guida galattica per autostoppisti. La loro poesia è al terzo posto tra quelle peggiori dell'universo e il suo ascolto può provocare gravi danni fisici e mentali. È di fatto uno strumento di tortura. «I Vogon sono una delle razze più sgradevoli della galassia; non sono cattivi ma insensibili burocrati zelanti con un pessimo carattere, sì. Non alzerebbero un dito per salvare la propria nonna dalla vorace bestia Bugblatteral di Traal senza un ordine in triplice copia spedito, ricevuto, verificato, smarrito, ritrovato, soggetto a inchiesta ufficiale, smarrito di nuovo ed infine sepolto nella torba per tre mesi e riciclato come cubetti accendifuoco». Sono tutti impiegati negli uffici della burocrazia galattica, un lavoro che permette loro di vivere una vita socialmente accettabile pur seminando distruzione nell'universo. Il loro motto? Resistere è inutile.
Burocrazia, dagli obblighi inutili alle troppe leggi: ogni anno sprecati 70 miliardi di euro. A Milano 393 alloggi popolari non possono essere assegnati perché misurano meno di 28,8 metri quadrati: è solo uno degli esempi dell’ottusità delle norme, scrive Sergio Rizzo su “Il Corriere della Sera” del 16 novembre 2015. Quale intelligenza umana avrà mai stabilito che la superficie minima calpestabile per un alloggio dev’essere di 28,80 metri quadrati? Non giapponese, di sicuro: a Tokyo la dimensione media dei monolocali non supera i 16 metri quadrati. Non francese, garantito: almeno a giudicare dalle dimensioni di moltissimi appartamenti parigini. Ma lì è al potere la normalità, a differenza di qui. Infatti l’intelligenza che ha partorito quel calcolo è italiana. Magari proprio milanese visto che quel numeretto è contenuto in un regolamento della Regione Lombardia scritto quasi 12 anni fa. Una manifestazione di sopraffina ottusità burocratica, purtroppo non fine a se stessa. Tanto che sarebbe da chiedersi se l’autore di questo capolavoro (e i politici che l’hanno fatto passare) abbia mai pensato alle conseguenze della sua iniziativa. Le conseguenze sono queste: un alloggio popolare più piccolo di 28,80 metri quadrati calpestabili non può essere assegnato. Sapete quante ce ne sono nel solo Comune di Milano di queste case «sottosoglia»? Trecentonovantatrè. Mentre c’è gente che abita nei giardini e dorme sotto i portici. Gli architetti che stanno lavorando al «rammendo» del quartiere Giambellino e delle periferie ideato da Renzo Piano si scontrano anche con questa piccola follia di centinaia di alloggi inabitabili per decisione del suo stesso proprietario: lo Stato. Che quando ha costruito quel quartiere nel 1939, con tante case di 25 metri quadrati, non era ancora impazzito di burocrazia. Questa malattia scorre potente nelle vene della pubblica amministrazione, senza risparmiare nessuna parte del corpo. Dilaga dappertutto, a dispetto dei proclami di semplificazione, in un Paese nel quale 43.587 leggi regionali si sommano alle 150 mila leggi nazionali, e poi ai decreti attuativi, ai regolamenti, alle delibere, alle circolari emanate da corpi dello stato spesso l’uno contro l’altro. E i cittadini e le imprese nel mezzo. Capita allora, ricorda Federdistribuzione, che una Azienda sanitaria locale ritenga lecito conservare il pesce surgelato in buste di plastica traforate per evitare la formazione di condensa, mentre la Capitaneria di porto consideri la busta traforata alla stregua di un contenitore danneggiato, quindi inadatto agli alimenti. Il bello è che tutto questo non è gratis. Secondo Confindustria le follie burocratiche costano al Paese 70 miliardi l’anno. E come non sono gratis gli appartamenti «sottosoglia» del Giambellino o di Quarto Oggiaro che non possono essere assegnati ai senzatetto (e invece talvolta vengono abusivamente occupati) causa una regola demenziale, così non lo sono nemmeno certi apparenti risparmi per le casse pubbliche. Un caso? Tre anni fa il governo Monti ha tagliato i fondi per le commissioni d’esame che devono dare il patentino a chi fa la manutenzione degli ascensori. Niente commissione, niente esami, niente ascensoristi, e in futuro niente manutenzioni. Con 250 apprendisti che ora, denuncia la Confartigianato, rischiano di perdere il lavoro. Risparmio ottenuto: 20 mila euro. Per non parlare di quando si scivola letteralmente nel tritacarne della burocrazia. Come è capitato al signor Francesco Del Prete, pizzicato da un autovelox della polizia provinciale di Napoli a luglio dello scorso anno (quando già le province erano sulla carta abolite) a transitare a 74 chilometri orari dove c’era il limite dei 60. La multa è di 184 euro e 70, ma se pagata entro cinque giorni si riduce a 134,30. Il Nostro va prontamente alla posta ma paga solo 134,20. Ricordava male? Il verbale era stampato a caratteri microscopici? In quel momento aveva altro per la testa? Fatto sta che un mese dopo gli arriva una richiesta di integrare il pagamento: 50,50 euro. Lui cade dalle nuvole e chiede chiarimenti. Dalla Provincia di Napoli gli replicano che è vero: ha pagato soltanto 10 centesimi in meno. Ma i cinque giorni sono purtroppo passati, e la multa è aumentata a 184,70. Del Prete non abbozza e scrive di nuovo alla Provincia. Spiega di essere chiaramente incorso in un errore materiale e ricorda come la sentenza 9507/14 della Cassazione escluda che per i piccoli errori di pagamento si possa vessare il cittadino con richieste abnormi. Per tutta risposta, ecco tre mesi dopo una nuova cartella: ora l’importo che dovrebbe pagare non è più di 50,50 euro, ma di ben 219,50. La ragione? Ormai sono passati anche i sessanta giorni. E se quei soldi non vengono pagati entro quindici giorni, la pratica passa direttamente a Equitalia, con tutti i rischi del caso. Quanto è costata questa giostra ai contribuenti non è dato sapere. Ma la burocrazia che perseguita così chi per errore ha pagato dieci centesimi meno del dovuto, è la stessa capace di mettere in atto persecuzioni esattamente contrarie. Felicia Logozzo, professoressa al liceo, viene chiamata all’università con contratto a termine come assegnista di ricerca. Subito scrive alla scuola chiedendo l’aspettativa che le viene immediatamente concessa. Peccato però che lo stipendio continui ad esserle accreditato senza che lei riesca a interrompere il flusso del denaro. Di mesi ne passano almeno quattro, poi finalmente il rubinetto si chiude: però solo grazie all’intervento di un conoscente nell’amministrazione. La professoressa Logozzo restituisce i soldi e torna a scuola, ma non ha nemmeno il tempo di dimenticare la disavventura. Ecco, due mesi fa, un nuovo contratto con l’università e una nuova aspettativa, con gli stipendi del liceo che di nuovo continuano imperterriti a correre. Sconcertante la motivazione alfine scoperta: la procedura per l’aspettativa è informatizzata, quella per la retribuzione invece no. Bisogna spedire i faldoni per raccomandata agli uffici competenti che si prendono tutto il tempo necessario. Mesi. E c’è anche la beffa, perché nel frattempo lo stato paga sia la professoressa in aspettativa che chi la sostituisce a scuola. Basterebbe che fosse tutto digitalizzato, come ci promette ogni governo. Sarebbe un gioco da ragazzi... Oppure no? Le assenze per malattia dei professori, per esempio, sarebbero in teoria digitalizzate. Si possono infatti comunicare via mail. Già. Ma prima bisogna scaricare un modulo dal sito, stamparlo, compilarlo, scannerizzarlo e solo a quel punto spedirlo per posta elettronica alla scuola dove si provvederà a stamparlo e protocollarlo. Il tutto dopo che il professore avrà telefonato alla scuola, fra le 7,30 le 7,50, come dispone una recente circolare del ministero. Troppo difficile entrare direttamente nel sito della scuola?
Gli intoccabili. Il caso Saguto e la società delle caste, scrive Pino Maniaci su "Telejato" il 26 ottobre 2015. IL CASO SAGUTO E LA SOCIETÀ DELLE CASTE: L’ANTIMAFIA, I GIUDICI, I BUROCRATI, I POLITICI. E POI LA PLEBE. Di fronte a tutto quello che abbiamo visto, letto e ascoltato in questi ultimi tempi sul caso della gestione personalizzata dei beni sequestrati da parte di un nutrito numero di magistrati, componenti del CSM, cancellieri, funzionari della DIA, personale giudiziario e amministratori giudiziari, sappiamo solo che il CSM ascolterà nei prossimi giorni i giudici coinvolti (ce ne sono altri 4 che continuano ad operare a Palermo). Ci chiediamo, anche a tutela dell’immagine di migliaia di magistrati onesti: Se a un comune mortale cittadino italiano fossero stati contestati la metà dei fatti addebitati alla Saguto non sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari? Se fossero stati contestati a Renzi, piuttosto che a Crocetta o a Marino non si sarebbero dimessi? Invece nel suo caso si parla di trasferimento ad altra sede. Ci chiediamo ancora una volta, fermo restando la presunzione d’innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, ma è opportuno che a “Zà Silvana” indossi ancora la toga? È opportuno che tutte le persone coinvolte in favoritismi, raccomandazioni e assunzioni ad amici e parenti restino ancora al loro posto? È opportuno che funzionari della DIA al servizio di questo sistema continuino a svolgere ancora funzioni pubbliche? Non comprendiamo quale sia la differenza tra questi soggetti e chi incassa una tangente. Entrambi utilizzano i propri ruoli istituzionali per rubare soldi pubblici. La giustizia è davvero uguale per tutti? Non ci soddisfano più le assicurazioni che tutto sarà chiarito. Sarà chiarito da chi? Quando e davanti a chi? Tutti invece devono essere immediatamente rimossi dai loro pubblici incarichi, in modo trasparente perché come cittadini abbiamo concesso credito a giudici che abbiamo ritenuto credibili, che abbiamo rispettato per la loro vita blindata, giudici che abbiamo ascoltato e dei quali abbiamo rispettato il lavoro senza alcuna delegittimazione preventiva. Vengano rimossi senza stipendio per rispetto verso tutti quei magistrati che hanno onorato e onorano i valori di autonomia e indipendenza, assicurando credibilità alla Giustizia con i comportamenti di tutti i giorni. Vengano rimossi per rispetto a tutti quei servitori dello Stato caduti nell’adempimento del dovere. Vengano rimossi e gli vengano sequestrati i beni per rispetto a tutti coloro che chiamati a collaborare con l’autorità giudiziaria con compiti delicatissimi e complessi lo fanno con coraggio. Pochi giorni fa i deputati della nostra regione hanno approvato in Commissione in tempo record il ddl salva burocrati e nominati. La finanziaria del 2012 ed un parere del Cga del 2014 hanno stabilito la gratuità degli incarichi nelle società partecipate dalla Regione e vietato le superindennità aggiuntive agli alti dirigenti. Fatto questo che avrebbe comportato anche la restituzione delle somme. Ebbene la stessa Ars che fa le pulci ai gettoni di presenza ai consiglieri comunali per cifre irrisorie ha varato un ddl in 10 minuti per salvare i maxicompensi aggiuntivi agli alti burocrati e ai blindati. Il presidente della lotta alla manciugghia, Crocettino, è diventato il Santo protettore della casta. Ricordiamo che negli anni ’80, ’90, il sogno di tanti giovani era quello di una società nella quale se sei bravo e se ti impegni, farai strada. Adesso se nasci parìa crepi parìa. Tra una casta e l’altra ci sono muraglie cinesi. Non esiste più la media borghesia e neanche la piccola. Ci sono le caste e poi la plebe, il volgo. Hanno fatto quadrato tra di loro. Le caste hanno fatto rete, si coalizzano tra loro. La casta degli antimafia, come se l’antimafia fosse una categoria dello spirito, gli intoccabili ed unti dal Signore per antonomasia si è coalizzata con quella dei politici e spesso con quella dei burocrati. Ovunque ti giri ci sono i privilegiati che si fanno beffe di chi è dall’altra parte dello steccato. Ogni loro gesto è uno sputo in faccia a chi fatica onestamente, a chi si suda lo stipendio, a chi pur sudando non avrà mai un diritto. Le caste sono intoccabili. E in quanto tali trattano gli altri con arroganza e sfacciataggine. Ci sentiamo come si sentivano i poveracci alla vigilia della Rivoluzione francese, anzi peggio, perché adesso ti prendono in giro con l’ipocrisia della democrazia e l’illusione della libertà. Nella Francia della Rivoluzione c’era Maria Antonietta che ha detto “Se non c’è pane non possono mangiare grissini?”. Adesso abbiamo a “Zà Silvana” che dall’alto della casta dice: “18 mila euro di spesa non pagata al supermercato? Che sbadata. Mica faccio io la spesa”. È la Rivoluzione Francese ai tempi da “Zà Silvana”. Un ultimo e accorato appello a tutte le Associazioni Antiracket e Antimafia che non sentono la necessità di proferire parola neanche davanti a delle gravissime minacce ricevute dal Direttore di Telejato, Pino Maniaci, da parte della Saguto (a “Zà Silvana”) e del Prefetto Cannizzo, che parlando tra di loro hanno affermato: “Pino Maniaci ha le ore contate”. E ai ragazzi di Addiopizzo. Forza ragazzi fate sentire la vostra variopinta presenza e alzate in coro la voce organizzando graziosi sit-in di protesta nelle pubbliche piazze e davanti al Tribunale di Palermo, datevi da fare ad appendere sui pali e le vetrine di Palermo la scritta: “Un Magistrato e un Prefetto che usano il loro potere per fini personali sono persone senza dignità”.
Il caso Saguto e la società delle caste: l'antimafia, i giudici, i burocrati, i politici. E poi la plebe. L'inchiesta che riguarda il giudice Saguto, insieme ad una serie di altri fatti di cronaca mi hanno convinta che viviamo in una società divisa in caste. Da un lato gli intoccabili, i privilegiati, dall'altro la plebe. Ai tempi di Maria Antonietta lei diceva "mangiate biscotti se non avete pane", oggi c'è un giudice che non si accorge di 18 mila euro di conto non pagato al supermercato..., scrive domenica 25 Ottobre 2015 Rosaria Brancato su “Tempo Stretto”. Il caso Saguto non mi ha fatto dormire la notte. Per 10 giorni ho avuto il panico temendo quale cosa raccapricciante avrei letto il giorno dopo a proposito dell’inchiesta su Silvana Saguto, ormai ex presidente della sezione misure preventive del Tribunale di Palermo. L’indagine su quel che accadeva nella gestione dei beni confiscati alla mafia (che in Sicilia rappresentano il 43% del totale) sta facendo emergere di tutto. La Saguto spaziava dalle nomine di amministratori giudiziari nelle società confiscate in cambio di incarichi per il marito, i parenti e gli amici, all’utilizzo dell’auto blindata come taxi per prelevare la nuora e accompagnarla nella villa al mare, o delle sue ospiti per non incappare nel traffico palermitano, oppure dal farsi recapitare a casa per le cene 6 chili tonno fresco, lamponi, (di provenienza da aziende sotto sequestro) al conto da quasi 20 mila euro non pagato al supermercato confiscato (“una dimenticanza, non sono io quella che va a fare la spesa..”). La “zarina” delle misure preventive si è data da fare per la laurea del figlio ottenuta grazie all’aiuto del docente della Kore di Enna, Carmelo Provenzano che in cambio veniva nominato consulente. Il giovane laureato, stando alle intercettazioni, la festa proprio non la voleva “questa laurea è una farsa, gli altri sgobbano per averla” ma il giudice non sentì ragioni e affidò l’organizzazione proprio al professore Provenzano che oltre a scrivere la tesi ha provveduto al menù, così come avverrà per la successiva festa di compleanno della Saguto. Gli agenti della scorta infine venivano utilizzati per andare in profumeria a fare acquisti. Ciliegina sulla torta del dichiarazioni del giudice antimafia a proposito dei figli di Paolo Borsellino, Manfredi e Anna. Il 19 luglio, anniversario dell’assassinio di Borsellino, Silvana Saguto partecipa come madrina alla manifestazione Le vele della legalità, fa il suo bel discorso antimafia, poi sale a bordo dell’auto blindata ed al telefono dice ad un’amica: “Poi Manfredi che si commuove, ma perché minc...a ti commuovi a 43 anni per un padre che è morto 23 anni fa? Che figura fai? Ma che... dov'è uno... le palle ci vogliono. Parlava di sua sorella e si commuoveva, ma vaff....o". Di fronte a tutto questo sappiamo solo che il CSM ascolterà nei prossimi giorni i giudici coinvolti (ce ne sono altri 4 che continuano ad operare a Palermo). Mi chiedo, anche a tutela dell’immagine di migliaia di magistrati onesti ma se a Donna Sarina fossero stati contestati la metà dei fatti addebitati alla Saguto non sarebbe stata agli arresti domiciliari? Se fossero stati contestati a Renzi, piuttosto che a Crocetta o a Marino non si sarebbero dimessi? Invece nel suo caso si parla di trasferimento ad altra sede. Mi chiedo, fermo restando la presunzione d’innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, ma è opportuno che indossi ancora la toga? La giustizia è davvero uguale per tutti? Leggo anche dell’arresto per corruzione dell’ex direttrice del carcere di Caltanissetta Alfonsa Miccichè. La signora affidava progetti con somme inferiori ai 40 mila euro (quindi non soggetti ad evidenza pubblica) a società che in cambio assegnavano incarichi alla figlia ed al genero. Sempre in questi giorni scopro che al Comune di Sanremo il 75% dei dipendenti è assenteista e c’è chi è stato filmato mentre timbrava il cartellino in mutande e poi tornava a letto o lo faceva timbrare da moglie e figli. Il sindaco di Sanremo dichiara: “sto valutando i provvedimenti da prendere. Forse ANCHE il licenziamento”. A prescindere dal fatto che se licenzi questi ladri di lavoro almeno puoi assumere qualcuno onesto che ti fa funzionare il Comune e adesso è disoccupato, mi chiedo signor sindaco: che significa ANCHE il licenziamento? Che vorresti fare? Premiarli? Che differenza c’è tra questi assenteisti e l’impiegato che incassa la tangente? Entrambi rubano soldi pubblici. Torniamo in Sicilia dove pochi giorni fa i deputati hanno approvato in Commissione intempo record il ddl salva burocrati e nominati. La finanziaria del 2012 ed un parere del Cga del 2014 hanno stabilito la gratuità degli incarichi nelle partecipate e vietato le superindennità aggiuntive agli alti dirigenti. Fatto questo che avrebbe comportato anche la restituzione delle somme. Ebbene la stessa Ars che fa le pulci ai gettoni di presenza ai consiglieri comunali per cifre irrisorie ha varato un ddl in 10 minuti per salvare i maxi compensi aggiuntivi agli alti burocrati e ai blindati. Il presidente della lotta alla manciugghia è diventato il Santo protettore della casta. A Roma mentre la sottosegretaria alla cultura Francesca Barracciu viene rinviata a giudizio per peculato per rimborsi da 81 mila euro il presidente del Consiglio Renzi annuncia di voler togliere l’Ici sulla prima casa a TUTTI, sia che abbiamo un castello che un tugurio. E si definisce di sinistra….Ricordo negli anni ’80, ’90, il sogno della Milano da bere era quello di una società nella quale se sei bravo, se ti impegni, farai strada. Adesso se nasci parìa crepi parìa. Tra una casta e l’altra ci sono muraglie cinesi. Non esiste più la media borghesia e neanche la piccola. Ci sono le caste e poi la plebe, il volgo. Hanno fatto quadrato tra di loro. Le caste hanno fatto rete, si coalizzano tra loro. La casta degli “antimafia”, gli intoccabili ed unti dal Signore per antonomasia si è coalizzata con quella dei politici e spesso con quella dei burocrati. Ovunque ti giri ci sono i privilegiati che si fanno beffe di chi è dall’altra parte dello steccato. Ogni loro gesto è uno sputo in faccia a chi fatica onestamente, a chi si suda lo stipendio, a chi pur sudando non avrà mai un diritto. Le caste sono intoccabili. La Barracciu era la candidata che Renzi voleva ad ogni costo per la presidenza della Regione Sardegna. A causa dello scandalo, ha ripiegato per un posto di sottosegretario. La Barracciu, la Saguto, le leggi ad personam mentre la Sicilia muore di fame. E’ la sfacciataggine degli intoccabili. Mi sento come si sentivano i poveracci alla vigilia della Rivoluzione francese, anzi peggio, perché adesso ti prendono in giro con l’ipocrisia della democrazia e l’illusione della libertà. Nella Francia della Rivoluzione c’era Maria Antonietta che dice “ma se non c’è pane non possono mangiare grissini?”. Adesso abbiamo il giudice antimafia Silvana Saguto che dall’alto della casta dice: “18 mila euro di spesa non pagata al supermercato? Che sbadata. Mica faccio io la spesa”. E’ la Rivoluzione Francese ai tempi della Saguto.
LO STATO STA CON I LADRI. OVVIO SONO COLLEGHI!
Lo Stato sta con i ladri. Un 65enne spara e uccide un criminale che si è intrufolato in casa sua durante la notte. E la Procura lo accusa di omicidio volontario, alla faccia della legittima difesa, scrive Alessandro Sallusti Mercoledì 21/10/2015 su "Il Giornale". Più che perdere tempo a riformare il Senato, i nostri legislatori dovrebbero mettere mano velocemente al codice penale. Che oggi, se applicato senza buon senso da magistrati burocrati, manda in galera chi difende se stesso e i suoi cari dall'assalto di ladri e rapinatori. L'ultimo episodio è di ieri. Vaprio d'Adda, periferia milanese. Un pensionato di 65 anni dorme nella sua villetta a tre piani. Con lui c'è la moglie, al primo piano figlio, nuora e nipotino. Sente dei rumori, impugna la pistola regolarmente detenuta. Fa per uscire e nel buio del corridoio si trova davanti un uomo. Spara e colpisce l'intruso, un romeno di poco più di vent'anni. Due complici fuggono dopo che lui spara in aria altri due colpi. Un solerte pm lo incrimina prima di eccesso di legittima difesa, poi di omicidio volontario. Pena prevista: da 21 anni all'ergastolo, salvo attenuanti. Non so voi, ma io penso che quell'uomo aveva il diritto di sparare e ha fatto bene a farlo. Ha percepito un pericolo di vita imminente per sé e per i suoi cari, non poteva accertarsi in sicurezza se gli aggressori fossero armati o no. La cosa, per altro, è irrilevante. Decine, se non centinaia di volte, queste bande di criminali hanno massacrato di botte, ferito o ucciso con coltelli magari recuperati in casa chi ha provato a opporsi all'intrusione. Non c'è nessun nesso tra il grado di pericolo reale ricostruito a tavolino dalla polizia scientifica e quello percepito durante una aggressione. In una frazione di secondo quel pensionato doveva decidere se mettere al sicuro la vita di sua moglie, suo figlio e suo nipotino. Lo ha fatto e oggi ha tutta la nostra solidarietà. Meglio un brutto processo di tre bei funerali, con tanto di autorità in prima fila a piangere lacrime di coccodrillo. Non provo alcuna pietà per chi di notte entra nelle nostre case. Anche a ladri e rapinatori possono capitare incidenti sul lavoro. Quello che non deve capitare è che lo Stato stia dalla loro parte e si accanisca contro chi è costretto, proprio per le lacune e l'incapacità dello Stato stesso, a difendersi da solo.
Lo Stato sta con i ladri? Ovvio, sono colleghi, scrive Nicolò Petrali su "Il Giornale". Mi si chiede di scrivere un pezzo sulla vicenda di Vaprio d’Adda in quanto figlio del tabaccaio milanese che nel 2003 sparò e uccise un rapinatore. E’ successo già diverse volte nel corso degli anni e quando accade significa purtroppo che qualcuno ci ha rimesso la vita, sia esso il ladro o il cittadino onesto. Se accetto sempre, nonostante rivangare sempre quella storia faccia male, è perché da qualche parte, dentro di me, si annida ancora l’illusione che un foglio di carta e una penna possano contribuire a cambiare questa nostra società in meglio. Di fronte ad episodi di questo tipo, il copione che si recita a casa mia è sempre lo stesso. Ci si siede a tavola per la cena, io, mio padre, mia madre, mia sorella e mio fratello e qualcuno, più spesso mio papà, butta lì la solita domanda: avete sentito del tabaccaio/gioielliere/benzinaio/pensionato che ha ucciso il ladro? Tutti facciamo un cenno affermativo con il capo e continuiamo a mangiare. Appena dopo il servizio del tg, però, non si riesce a resistere e riparte la consueta discussione. “In questo caso il delinquente era disarmato, quel poveretto passerà delle rogne”. Oppure: “Qui lo assolvono sicuramente, è evidente la legittima difesa”. Ancora: “Lo ha rincorso, questa volta dipenderà dall’interpretazione del giudice”. Finito il primo atto, parte il secondo. Discutiamo di diritto, di modello culturale USA, di proporzionalità della reazione e altro ancora. Finché qualcuno, generalmente mio padre, chiede che al poveretto di turno venga inviato un telegramma a nome della famiglia. La vicenda di Vaprio d’Adda è ancora tutta da chiarire nella sua dinamica, anche se per me è il succo che conta più che il contorno. E il succo è che un ladro che non doveva nemmeno trovarsi in Italia ha tentato di derubare un onesto cittadino che si è difeso come ha ritenuto opportuno. Punto. Tutto il resto è chiacchiera. Quel che è certo però è che, comunque vada, il povero Sicignano, oltre a convivere con il dramma umano di aver ammazzato una persona, inizierà anche a vivere un calvario giudiziario che durerà circa una decina d’anni. Perizie su perizie, giornali che scriveranno ogni genere di falsità basandosi su rilievi scientifici che mai, e lo dico per esperienza, ricostruiranno esattamente ciò che sia realmente accaduto, giornalisti sotto casa a qualsiasi ora del giorno e tutto il resto. Non so se il pensionato fosse o meno un uomo di Chiesa. Se sì, si prepari: se è fortunato il prete della comunità gli offrirà conforto e sostegno, ma i giornali cattolici non avranno pietà. Forse fu proprio questo che fece più male a mio padre tant’è che lo dice ancora oggi. Si sentì abbandonato proprio dai mass media dai quali invece si aspettava maggior comprensione. Nonostante provassi a fargli capire che la vera chiesa, quella con la “c” minuscola, non è quella roba lì, purtroppo da quella storia la sua fede ne uscì compromessa in modo irreparabile. Tornando a Sicignano, se è fortunato troverà un Pm dotato di buon senso, altrimenti si sentirà attribuire accuse e aggettivi di ogni tipo. Il dibattito politico ovviamente sarà feroce e il suo caso verrà tirato in ballo ogni volta che accadrà un fatto simile almeno per i prossimi 10 anni. Il consiglio che posso dargli è quello di non arrendersi e di concentrarsi sul fatto che non saranno perizie, pm e giudici a definirlo come uomo. E che alla fine, dopo tante sofferenze e sacrifici, ne uscirà vincitore. Nel caso non andasse così sono pronto a scendere in piazza personalmente. E credo con me molti altri italiani. Tre o quattro anni fa, a notte fonda, mi affacciai casualmente alla finestra. Vidi all’interno del mio cortile due uomini che stavano tentando di forzare la porta di casa di mia sorella. Sapevo che in quel momento lei non era in casa, così andai quatto quatto a svegliare mio padre. “Papà adesso chiamo la Polizia e li facciamo arrestare, tanto Maria non è in casa. Questa volta li facciamo beccare”. La reazione del mio vecchio mi colpì incredibilmente, tanto da farmi pentire di averlo svegliato. Era buio, perché non avevo acceso di proposito le luci, ma lo vidi iniziare a tremare. Mi rispondeva quasi balbettando e aveva il respiro corto. Non lo avevo mai visto così. “Chiama la Polizia, veloce”, mi disse in qualche modo portandosi a fatica verso la finestra. Ubbidii. Purtroppo non riuscimmo nel nostro intento per pochissimo. E i ladri riuscirono a dileguarsi. Ma nel tempo ho pensato e ripensato parecchio a quell’episodio. Come avrei reagito se mia sorella fosse stata in casa e avessi avuto una pistola? Sarei stato così lucido da sparare dei colpi in aria, o così esperto da mirare alle gambe da molto lontano, oppure avrei pensato solo all’incolumità di mia sorella e avrei fatto fuoco ad altezza uomo? Non lo posso sapere. Magari, se avessi avuto un’arma, oggi sarei anch’io sotto processo. L’ho scritto tante volte e lo ripeto. Sono favorevole all’interpretazione della legittima difesa all’americana, che a sua volta dipende da una visione culturale liberale/libertaria della vita. Non chiedo più Stato perché piazzare un soldato in ogni casa è impossibile oltre che terribile, ma soprattutto perché ritengo che lo Stato non sia la soluzione ma semmai il problema. Auspico, invece, che sia data a tutti la possibilità di difendersi proprio come avviene al di là dell’oceano. Con tutti i rischi che questo comporta, ovviamente. D’altra parte la libertà non è per sua stessa essenza più rischiosa della schiavitù? (Guarda caso, proprio ieri, in Svezia, un uomo armato di spada ha ucciso due persone in una scuola. Mettiamo al bando anche spade, coltelli e forchette?). Si potrebbe ad esempio decidere di tenere dei corsi che addestrino il privato cittadino che acquisti un’arma a gestire, per quanto possibile, quel tipo di situazioni. Ma sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano. Purtroppo è più facile che siano gli Usa ad europeizzarsi, fenomeno che in parte sta già avvenendo, che noi a diventare come loro. In conclusione, invito tutti a riflettere su un punto. Che è secondo me quello fondamentale. Provate a pensare a chi è il ladro per eccellenza. Quello cioè che ci deruba tutti di oltre la metà del nostro guadagno non restituendoci quasi nulla in cambio. E’ presto detto perché ci voglia tutti disarmati. Per il fatto che, in ultima istanza, potrebbe essere lui a cadere sotto i colpi di chi tutela i propri beni. Gli statunitensi lo capirono ai tempi di Re Giorgio ed è per questo che difendono con le unghie e con i denti il loro secondo emendamento. Mentre qui da noi, la culla della civiltà come dice qualcuno, vengono processati i cittadini onesti. Colgo l’occasione per esprimere la mia totale solidarietà alla famiglia Sicignano e per dire loro che se dovessero mai aver bisogno di qualche consiglio da parte di chi ci è già passato, noi siamo qua. P.s. A chi obietterà che parlo così sull’onda dell’emozione, perché personalmente coinvolto e quant’altro, rispondo leopardianamente. Non attribuite alla mia condizione ciò che è responsabilità del mio intelletto. Contraddite piuttosto le mie tesi, se ci riuscite.
La difesa è sempre legittima. I cittadini non si sentono più sicuri. E si difendono da sé. Viaggio nella giustizia italiana che tutela ladri e malviventi e condanna chi si difende, scrive Giuseppe De Lorenzo su “Il Giornale”. La spiegazione è tutta nei numeri. C'è un motivo se gli italiani hanno deciso di difendersi con le armi, se i casi di rapine e furti finite in tragedia stanno occupando televisioni e giornali nazionali. I cittadini non si sentono più sicuri. E difendono chi si è difeso: Il 73% degli intervistati di un sondaggio Ixè per Agorà (Raitre), infatti, trova sbagliata l'accusa di omicidio volontario per il pensionato che ha ucciso con un colpo di pistola un giovane ladro a Vaprio D'Adda, nel milanese. Il 21% trova invece giusta l'accusa. Nel rapporto sulla sicurezza, diramato dall'Istat nel 2014, si evince chiaramente che ad essere aumentata non è solo è la percezione di insicurezza degli italiani. Ben 18 milioni sono quelli che si sono detti insicuri e solo il 55% è pronto ad uscire da solo di notte (mentre nel 2010 era il 59% e nel 2011 addirittura il 60,8%). Ma non è solo questo. Ciò che preoccupa è l'aumento delle rapine in casa (+65,8% rispetto al 2010), dei reati contro il patrimonio e dei borseggi. Gli ultimi casi di cronaca sono solo una piccola parte di quelli realmente accaduti. Alcuni sono i più noti: Graziano Stacchio, il benzinaio che per difendere una donna e un gioielliere ha sparato contro i ladri; Ermes Mattielli, il pensionato che scaricò il caricatore contro i rom entrati nella sua ricicleria; e - in ultimo - il caso di Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio D'Adda che ha ucciso un 22enne albanese sorpreso mentre rubava nella sua casa. Abbiamo recuperato uno di quelli dimenticati. Giuseppe Caruso il prossimo 27 ottobre rischia 21 anni di carcere per omicidio volontario, solo perché dopo numerosi furti ha tentato di difendere la sua proprietà. La legge. Bisogna essere chiari. L'articolo 52 del codice penale, quello sulla legittima difesa, sembra far acqua da tutte la parti. In particolare, ci spiega l'avvocato penalista Paolo Pesciarelli, "occorre togliere dal secondo comma l'inciso 'quando vi è desistenza o pericolo di aggressione'. Perché è una valutazione che è impossibile fare per chi si trova in quelle situazioni specifiche". "Il problema è il limite di eccezione di proporzionalità - conferma l'avvocato Marco Tomassoni - è un concetto anacronistico: bisogna dare facoltà di difendersi con tutti i mezzi a disposizione". Una legge, però, si interpreta, e il potere di punire o meno chi nell'atto di proteggersi uccide o ferisce un ladro è in mano alla magistratura. Le colpe della magistratura. Non a caso, infatti, Giuseppe Lipari, difensore di Caruso, non ha remore nel dire che "è l'ideologia di certi magistrati a decidere se questo o quel caso è omicidio volontario e non legittima difesa". Ed è per questo che la Lega Nord ieri ha manifestato di fronte ai Tribunali di tutta Italia: "Se i magistrati non riescono a interpretare correttamente la norma - ha detto Salvini davanti al Palazzaccio di Milano - allora aboliamola". Una buona idea. La difesa deve essere sempre legittima. Quella della propria vita, quella dei propri cari e anche della proprietà privata. Quale arma? I cittadini lo sanno. Tant'è che negli ultimi anni stanno aumentando in maniera considerevole le iscrizioni ai poligoni di tiro. Sarà l'effetto mediatico degli ultimi tempi, ma soprattutto nelle zone dove si verificano più frequentemente furti, i cittadini si rivolgono agli esperti del grilletto per imparare a sparare. "Un po' di rapine e la gente dice che non capisce più quello che succede - dichiarava Efren Dalla Santa, presidente del poligono di Laghetto (Vicenza) - Magari non la useranno mai, ti spiegano, ma vogliono sentirsi più sicuri a casa". E senza star troppo a pensare se conviene usare una pistola o un fucile a canne mozze, la cosa fondamentale è saperle maneggiare con cura. Conoscerne i segreti e l'utilizzo in totale sicurezza. "Nel momento in cui si sia costretti ad utilizzare l'arma da fuoco - ci spiega dettagliatamente l'esperto Tony Zanti - non si può improvvisare". Potenzialità dell'arma, manutenzione, puntamento, utilizza al chiuso e all'aperto: per difendersi da soli bisognerebbe prima seguire un corso. Anche questo, però, potrebbe non bastare. Perché di notte, con il buio, con la paura di avere un malintenzionato vicino, ogni conoscenza potrebbe venir meno e fare spazio alla legittima paura che genera l'altrettanto legittima difesa. L'Italia dovrebbe capire che chi commette rapine non è un disgraziato o un pover uomo. Ma un criminale. E se c'è qualcuno da compatire, quelli sono i pensionati che hanno avuto il coraggio di sparare e ora hanno la vita distrutta. Chi viola un domicilio e chi di lavoro fa il ladro, deve sapere che potrebbe uscirne steso. Non significa essere violenti. Ma desiderare un Paese dove la sicurezza viene garantita. E con essa la legittima difesa.
Sel: vietato pubblicare i crimini commessi dagli immigrati, è razzismo, scrive "Imola Oggi". I deputati di Sel hanno chiesto in un’interrogazione al Ministero dell’Interno, prima firmataria Annalisa Pannarale, di assumere ogni iniziativa di competenza affinché sia valutata la sussistenza dei presupposti per l‘immediata chiusura del sito internet tutti i crimini degli immigrati (tuttiicriminidegliimmigrati.com/) che si propone quale sito d’informazione ed è basato su fatti di cronaca nera che avrebbero come protagonisti cittadini stranieri, migranti, rom e sinti. I deputati ritengono che la pagina web in questione abbia l‘esito potenziale di incitare all’odio razziale e alla discriminazione, in aperta violazione dei principi della nostra Carta Costituzionale e della normativa in materia”. Infine si legge nell’interrogazione come l’iniziativa del sito Gli altri parlano d’integrazione, noi ve la mostriamo “si colloca peraltro nel solco di quanto sollevato con allarme dal Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (CERD) nelle osservazioni conclusive e raccomandazioni all’Italia del 9 marzo 2012; il Comitato, infatti, aveva fatto riferimento esplicito alla diffusione preoccupante nel nostro Paese dell’incitamento all’odio razziale e di forme violente di razzismo attraverso i mass media, internet, e i social network, invitando le autorità italiane a una applicazione severa delle normative di contrasto penale alla discriminazione e all’incitamento all’odio razziale”.
Chi delinque può fare qualsiasi cosa, tanto la sfanga sempre! Gentile Severgnini, colgo l’occasione dell’ultimo fatto di sangue legato ad un tentato furto in casa per fare alcune considerazioni. Abito a Parma, ma lavoro in provincia di Brescia. Per lavoro mi devo fermare alcune volte fuori casa e ho da anni un appartamento vicino al lago di Garda. Da circa 3 settimane il residence dove abito viene regolarmente visitato dai ladri, che hanno già ripulito almeno 9 appartamenti su 18. Questa sera, all’uscita dal lavoro, dovendomi fermare, andrò con ansia a verificare il mio destino. E’ un bollettino di guerra che va aggiornato quotidianamente. Dal punto di vista storico ho già subito un furto in appartamento nel 2000, e in seguito due furti in auto. Sempre in questi paraggi. Ho lasciato sul campo 3 computer portatili, alcuni strumenti di lavoro, alcune coperte… Vedrò se devo aggiornare a breve il mio bilancio. Orbene, nella mia esperienza, posso solo dire che il mio necessario rivolgermi alle forze dell’ordine ha sempre comportato in me la sensazione di creare fastidio nei vari addetti che ho incontrato: mai sgarbati, per la verità, ma esasperati e pignoli. Con quella faccia che ti fa sentire tu il colpevole di esser stato derubato! Pronti anche a puntualizzare che la denuncia andava fatta presso la tenenza di competenza, come se non sapessi che lo avrei potuto fare su tutto il territorio nazionale, aggiungendo così al danno anche la beffa della perdita di tempo. Forse demotivati dalla loro impotenza? Mah!… Direi che sono servitori di uno Stato da sempre impegnato per motivi ideologici, che accomunano da decenni i settori della sinistra DC, poi ex, e di tutti i settori della sinistra e di parte della destra sociale, nel condannare, con fermezza a volte, spesso subdolamente, la proprietà privata come frutto del diavolo. Ora senza soldi, questo Stato ha smesso anche di tentare di assicurare quella parvenza di sicurezza sociale che sarebbe quantomeno doverosa, in un momento in cui frotte di immigrati, obtorto collo nullafacenti, non sanno come tirare a sera. Invece si richiede a gran voce la scarcerazione di migliaia di detenuti con la risibile motivazione che sono in troppi. Ma che glieli ho mandati io a delinquere?! Ebbene, se questo Stato non vuole darci sicurezza, perché mai non ci libera dallo scomodo ruolo di vittime inermi e non ci permette di prendere le armi (come direbbe Amleto: “Or to take arms against a sea of troubles?”)? Ah già, il principio dello Stato di diritto! Peccato che valga solo per noi! Chi delinque può fare qualsiasi cosa, cosciente di poterla sfangare quasi sempre! Peccato che chi ha grandi possibilità economiche venga solo raramente colpito. I colpiti siamo noi piccoli e medi borghesi, anche proletari, nell’indifferenza di chiunque guidi questo Stato sfasciato e sgarruppato. Spesso sottoposti al pubblico ludibrio di chi assurge a maestro delle nostre menti, e che, assiso sulla inarrivabile cattedra del qualunquismo benpensante (cattolico o ex comunista poco importa) ci viene a fare anche la morale! Enrico Groppi su “Italians” de “Il Corriere della Sera”.
Se il bruto viene da lontano la stampa «dimentica» di dirlo. Sui media una pesantissima cappa di "politicamente corretto" nella trattazione della realtà degli immigrati. Così agli italiani è preclusa la conoscenza della verità, scrive Magdi Cristiano Allam su "Il Giornale". Leggiamo insieme i titoli di due fatti di cronaca di queste ultime ore. «Torpignattara. Aggredita sul pianerottolo mette in fuga lo stupratore. L'aggressore arrestato grazie all'identikit fornito dalla vittima». Solo leggendo l'articolo scopriamo che la vittima è una ragazza italiana di 29 anni, mentre lo stupratore è un clandestino afghano di 24 anni. «Fiuggi. Violenza di gruppo in casa famiglia. Arrestati un 16enne e due 17enni. Vittima un'operatrice della struttura». Solo leggendo l'articolo scopriamo che la donna stuprata è un'italiana di 48 anni, mentre gli stupratori sono tre clandestini egiziani. L'indicazione di non segnalare la nazionalità o la religione di chi delinque rientra nell'impegno sottoscritto dai giornalisti italiani (Federazione Nazionale della Stampa Italiana e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti) nella «Carta di Roma», firmata nel 2011, con una madrina d'eccezione, Laura Boldrini, all'epoca portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. È nella «Carta di Roma» che si accredita la mistificazione della realtà, vietando ad esempio di usare il termine «clandestino», che giuridicamente connota lo specifico reato di chi si introduce illegalmente all'interno delle frontiere nazionali, e di sostituirlo con il termine neutro di «migrante» o «richiedente asilo». Ebbene questa pesantissima cappa di «politicamente corretto» nella trattazione della realtà degli immigrati, fa sì che agli italiani sia preclusa la conoscenza della verità, così come si impongono loro delle scelte in contrasto con i propri interessi. Quanti italiani sanno che rispetto ad una presenza complessiva di 5.364.000 immigrati in Italia, pari al 7,1% della popolazione residente, la presenza degli stranieri nelle nostre carceri è invece di circa 22mila detenuti, pari a circa il 35% della popolazione carceraria? Quanti italiani sanno che l'80% dei crimini commessi dagli stranieri è perpetrato da clandestini o irregolari? Quanti italiani sanno che, considerando che per l'Osapp (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), un carcerato costa quanto un deputato, ovvero 12mila euro al mese, il costo complessivo dei detenuti stranieri ammonta a circa 264 milioni di euro al mese, ovvero 3 miliardi e 168 milioni di euro all'anno? Quanti italiani sanno che, anche limitandoci a considerare gli 80mila clandestini ospitati nei centri di accoglienza a spese nostre, con un costo giornaliero pro-capite di circa 40 euro, significa che complessivamente noi spendiamo 3.200.000 euro al giorno, che al mese diventano 96 milioni di euro, che all'anno diventano 1 miliardo e 152 milioni di euro, solo per l'alloggio, il vitto, le sigarette e la ricarica telefonica? Quanti italiani sanno che considerando che nel 2014 sono sbarcati circa 180mila clandestini e che nel 2015 ne sono già arrivati quasi 57mila, complessivamente 237mila, e calcolando che nei centri di accoglienza ce ne sono 80mila, anche tralasciando le decine di migliaia di clandestini che sono sbarcati negli anni scorsi, significa che almeno 157mila clandestini sono scomparsi nel nulla? Quanti italiani sanno che solo al 5% dei clandestini viene riconosciuto lo status di rifugiato, e ciò significa che il 95% dei clandestini che abbiamo generosamente accolto con i nostri soldi sarebbe dovuto essere bloccato alla frontiera? Ebbene riscattiamo la verità prima che gli italiani insorgano legittimamente per questo crimine che stanno subendo. Chiamiamoli correttamente clandestini e diciamo basta ai clandestini!
Raccomandazione alle Questure: nascondete i crimini dei profughi. Necessario "tutelare" i richiedenti asilo, anche se delinquono. È discriminazione al contrario, scrive Salvatore Tramontano Venerdì 23/10/2015 su "Il Giornale". La gogna non è uguale per tutti. Le Questure italiane, e i comandi dei carabinieri, hanno ricevuto una strana raccomandazione, un consiglio disceso da molto in alto, una sorta di velina a uso interno. Se un profugo, un richiedente asilo, viene denunciato o addirittura arrestato mentre sta commettendo un reato non dovete raccontarlo a nessuno. Acqua in bocca. Omertà. Silenzio. Niente comunicati stampa, nessuna soffiata ai giornalisti. L'obiettivo è tutelare il migrante. Se, infatti, uno sta chiedendo aiuto allo Stato perché magari è perseguitato in patria significa che la sua vita è in pericolo. Nome, cognome e residenza sarebbero informazioni pericolose, notizie che i «regimi» potrebbero usare per colpire lui o la sua famiglia. Uno viene a sapere una cosa del genere e pensa: bello, uno Stato garantista. Non c'è più il mostro in prima pagina. Solo che il principio vale solo per gli ospiti. Gli italiani devono solo pagare le tasse. Niente garantismo, nessuna tutela, neppure uno straccio di presunzione di innocenza. Anzi, quando poi si va a processo c'è la gara a far scappare dalle procure notizie, intercettazioni, frullati di vita privati, perfino di chi è capitato in quelle carte per caso, senza neppure essere indagato. E c'è anche una strana regia che calcola e razionalizza i tempi politici delle indiscrezioni. Questo è il Paese dove la condanna arriva per mezzo stampa prima dei processi e dove la carcerazione preventiva viene usata come arma di ricatto e addirittura di tortura. Per gli italiani, insomma, il garantismo è un lusso che non si possono permettere. Siano essi personaggi famosi o sconosciuti, potenti o povera gente. È una forma di democrazia della gogna. Ora perché i profughi vengono risparmiati? Non per bontà. A quanto pare il governo non vuole turbative alla linea politica sull'immigrazione. Non parlate dei delitti dei profughi perché siccome accogliamo tutti, senza alcun controllo, pubblicizzare le loro malefatte potrebbe intaccare il consenso del governo e portare voti a chi critica le maglie larghe di Alfano e company. Meglio nascondere la realtà e continuare a raccontare agli italiani che tutto va bene, che tutto è sotto controllo. E se una notizia scappa dalle Questure, nessun problema, ci penserà Renzi a coprire Alfano. La colpa sarà stata di un gufo. Magari profugo.
I crimini dei richiedenti asilo? Censurati "per la pace sociale". Forze dell'ordine invitate a non diffondere le generalità dei rei Si vuole garantirne la riservatezza, ma così si discriminano gli italiani, scrive Nadia Muratore Venerdì 23/10/2015 su "Il Giornale". Il politicamente corretto imbavaglia le forze dell'ordine e crea disparità tra i cittadini. Almeno per quanto riguarda la divulgazione di certe informazioni di reato. Se infatti la prassi vuole che siano le stesse forze dell'ordine a fornire agli organi di stampa la notizia di un'indagine che ha portato alla denuncia o all'arresto di una persona, questo non accade quando il responsabile del reato è un richiedente asilo. Se il fatto di cronaca non è eclatante e può «passare in sordina», allora la notizia viene taciuta. Censurata. Così, se a rubare o a spacciare stupefacenti è un cittadino italiano, l'indagine diventa di dominio pubblico, con tanto di riferimento alle generalità del reo. Diverso invece è il trattamento se chi delinque ha in tasca una richiesta di status di rifugiato. Il perché è presto detto: interpretando alla lettera la legge sulle disposizioni in materia della richiesta di asilo - che rientra nel Testo Unico dell'Immigrazione - una persona che si trova nello «status» di richiedente dev'essere tutelata. Basandosi sul presupposto che chi chiede protezione in uno Stato diverso dal suo ritiene di essere in pericolo di vita, renderne pubbliche le generalità e il luogo di residenza, potrebbe mettere a rischio la sua incolumità in Italia e anche creare dei problemi di sicurezza alla famiglia, che magari è rimasta nel Paese di origine. Un riserbo che viene mantenuto anche se il richiedente è coinvolto in una operazione di polizia. Ci troviamo quindi di fronte a un garantismo all'ennesima potenza che può anche essere comprensibile, ma che di fatto porta ad una disparità di trattamento tra italiani e rifugiati, accolti in Italia e in attesa di essere regolarizzati. Una disparità di trattamento che viene giustificata osservando che, in uno Stato di diritto come è quello italiano, nessuno è colpevole fino al terzo grado di giudizio. Per questo le forze dell'ordine sono invitate a non divulgare notizie di operazioni di polizia in cui vi siano coinvolti dei richiedenti asilo. Cosa che però non avviene quando a essere arrestato è un cittadino italiano. Considerando che la maggior parte dei profughi, una volta sbarcati sulle coste italiane, inoltrano la richiesta di asilo, è facile immaginare quanto è alto il numero di persone che possono godere di questo «scudo» che altri invece non posseggono. «Non esiste una norma scritta che imponga di non divulgare la notizia - precisa Giovanni Pepè, questore di Cuneo -, si tratta semplicemente di una direttiva politica basata sul buon senso. Vengono cioè usate delle precauzioni in più nel caso in cui ad essere arrestato sia un rifugiato, solo perché rivelare il suo luogo di residenza, potrebbe mettere a repentaglio la sua incolumità e quella della sua famiglia. Sarà poi la Commissione territoriale che valuta le richieste a stabilire se il fatto di essere stato arrestato e magari un'eventuale condanna, possa determinare la non accettazione della richiesta». Una maggior precauzione che però non viene applicata in altri casi. «Si, è vero - conclude il questore - quando non siamo di fronte a un richiedente asilo, la notizia viene divulgata, spesso subito dopo la convalida dell'arresto, con tanto di iniziali ed età». Eppure ogni cittadino dovrebbe essere uguale davanti alla legge e per tutti dovrebbe valere la regola dell'essere innocenti fino al terzo grado di giudizio. «Non esiste una circolare interna in cui viene richiesto di non rendere note le indagini se l'arrestato è un richiedente asilo - spiega un sindacalista torinese - ma ci viene caldamente suggerito, per non aumentare la tensione e allarmare maggiormente l'opinione pubblica, già esasperata dai disagi e dalla diffidenza dei profughi che hanno invaso le nostre città».
"Se denunciamo i migranti ci accusano di razzismo". Il sindacato di polizia Coisp: a poche ore dall'arresto, i richiedenti asilo già liberi di spostarsi con vitto e alloggio garantiti, scrive Nadia Muratore Sabato 24/10/2015 su "Il Giornale". «Lo spaccio di droga, le rapine ed i furti, ormai sono reati commessi per lo più da stranieri richiedenti asilo e la nostra criminalità organizzata è ben contenta di poter contare su questa bassa manovalanza. Tutto ciò, però, non risulta dalle statistiche, perché quando a delinquere è una persona che si trova in questo particolare “status”, previsto dalla nostra Costituzione e tutelato per legge, noi non possiamo dirlo. Rischiamo di essere tacciati di razzismo. Così dobbiamo arrenderci al politicamente corretto che piace tanto a questo governo ma falsa la realtà». A denunciare la difficoltà a redigere un mattinale o un comunicato stampa che deve necessariamente essere attento più alle parole usate che non ai fatti accaduti è Patrizia Bolognani, rappresentante sindacale del Coisp. Assistente capo al reparto prevenzione del crimine della polizia di Padova, Bolognani combatte ogni giorno contro i ladri e gli spacciatori, pattugliando le strade del Nord Est italiano e poi, una volta tornata in questura, la sua battaglia si sposta sulla tastiera del computer, alla ricerca delle parole da usare, che non devono neppure lontanamente suscitare sentimenti di razzismo o di discriminazione nei confronti di nessuno. Soprattutto quando si parla di un profugo. «Profugo? Non so se questa parola si può usare. Nel dubbio meglio di no - precisa Bolognani -. Soprattutto sono vietate le parole rom e clandestini ma anche richiedente asilo, perché la vita dello straniero arrivato nel nostro Paese non può essere messa a rischio, svelando che è in Italia a spacciare droga. Il termine extracomunitario, invece, va sempre bene, non indispettisce nessuno. Peccato però che la maggior parte delle volte viene usato per, non dico mascherare, ma sicuramente addolcire la realtà». Secondo una statistica non ufficiale ma che è ben chiara agli operatori di polizia, così come ai mediatori culturali, la maggior parte delle persone che sbarcano sulle coste italiane, sono richiedenti asilo ma soltanto una minima parte di loro hanno la speranza di ottenerlo. L'iter però, che prevede una valutazione da parte della Commissione territoriale di competenza - e consente anche il ricorso al Tar in caso di diniego, con un allungamento esponenziale dei tempi - è talmente lungo che permette, a chi ha intenzione di vivere di espedienti, di organizzarsi come meglio crede. Soprattutto è la vendita di sostanze stupefacenti ad essere per lo più in mano loro, ed il perché è presto detto: spacciare è il reato che permette guadagni alti ed immediati, la droga trova ovunque un buon giro di vendita e lo spacciatore può contare su un rischio relativamente basso di essere fermato dalle forze dell'ordine. E quando accade, dopo alcune ore dall'arresto e dalla sua convalida, il richiedente asilo è libero di spostarsi su tutto il territorio nazionale senza controlli, oppure di ritornare nell'albergo o nella cooperativa che lo accoglie a spese dello Stato. Perché vitto e alloggio, più paghetta settimanale, sono sempre garantiti. Sono ragazzi giovani, hanno sempre meno di trent'anni e provenienti per lo più da Nigeria, Gaga e Gambia. Per loro lo spaccio è il modo più veloce per ottenere il denaro da spendere soprattutto in abbigliamento, oppure in bottiglie di vino e birra. Molti, infatti, sono alcolizzati e per questo, per procurarsi da bere, commettono furti e borseggi, oppure vengono fermati per molestie, per lo più nei confronti delle donne e spesso, in preda ai fumi dell'alcol, commettono danneggiamenti ed atti di vandalismo.
Una simile situazione diventa un terreno fertile per la criminalità organizzata, al Nord come al Sud, dal quale pescare giovani che non hanno nulla da perdere e vogliono soprattutto guadagnare soldi facili e veloci. In questo momento le aree più a rischio si stanno spostando dalle coste italiane verso le zone settentrionali del nostro Paese, infatti un numero sempre maggiore di profughi arriva in Italia non con i barconi ma attraverso i valichi montani, diventati ormai aree a forte rischio per la sicurezza pubblica. Di notte attraversano a piedi le montagne di Tarvisio, Gorizia, Belluno, Udine, Trieste: tutte zone di frontiera che con l'applicazione del trattato di Schengen e la diminuzione dei controlli da parte delle forze dell'ordine, sono diventate tratte di passaggio incontrollato.
LA LIBERTA'.
La libertà? Bella storia Iniziata 40mila anni fa, scrive Dino Cofrancesco su “Il Giornale”. Nella Collana dell'Istituto Bruno Leoni, Mercato, Diritto e Libertà, esce in traduzione italiana un saggio davvero esemplare, la Breve storia della libertà di David Schmidtz e Jason Brennan, con una Prefazione acuta e divertente di Guido Vitiello. Il titolo va preso alla lettera, non si tratta di una storia delle teorie sulla libertà ma di una storia della libertà. Nel loro rapido excursus, gli autori cavalcano i secoli con una competenza mai disgiunta da uno stile leggero e da un distacco ironico tipicamente anglosassone: dalla preistoria della libertà al rule of law apparso agli inizi dell'XI secolo, dalla libertà religiosa del secolo XVI alla libertà di commercio del secolo successivo, fino alla libertà civile, trionfante nel '900 e all'ultima frontiera, la libertà psicologica, il lettore entra nel vivo di una vicenda esaltante desinata a non concludersi mai e ne riporta un senso di gratitudine per chi gli ha consentito di chiarirsi le idee e di liberarsi da vecchie idee e inveterati pregiudizi. Schmidtz e Brennan, però, non si fermano alla storia ma nei sei densi capitoli del libro, mettono a fuoco il nucleo centrale della teorica liberale contemporanea in modo da dissipare i tanti equivoci che i fautori della comunità chiusa, soprattutto nel nostro paese, hanno riversato sulla «società aperta», sulla sua natura, sulle sue caratteristiche. A dare l'incipit non poteva non essere l'ombra di Isaiah Berlin, il filosofo delle «due libertà»: la libertà negativa - intesa come non impedimento, libertà da, posta alla base del liberalismo- e la libertà positiva -intesa come dotazione di risorse che consentono di realizzare quanto si desidera, libertà di, posta a fondamento della democrazia. Da tempo immemorabile, i critici del liberalismo vedono nella libertà negativa, nel migliore dei casi, una sorta di visconte dimezzato, riproponendo, senza variazioni sostanziali, lo stesso ritornello: «Io potrei essere libero dalle interferenze dello Stato, libero dall'oppressione di un rigido sistema di caste e così via, eppure potrei restare nell'impossibilità di fare granché a causa della mancanza di ricchezza. La libertà negativa è la libertà di essere poveri, di dormire su un marciapiede pubblico». Schmidtz e Brennan non sottovalutano l'argomento e prendono quasi le distanze da Berlin, citando tra l'altro con rispetto l'inconsistente teorico del neo-republicanism Philip Pettit. Berlin, scrivono, e molti liberali classici «sono sospettosi nei confronti della libertà positiva, pensando che riconoscere il suo valore può essere interpretato erroneamente come un avallo del socialismo, o più in generale, come una licenza che diamo ai burocrati perché ci costringano a essere liberi». Il problema, però, non è quello di negare che non me ne faccio niente della libertà (negativa) di andare a Roma, se mi mancano i soldi (la libertà positiva) per il biglietto, bensì di stabilire chi ce li può dare quei soldi. «Riconoscere semplicemente la libertà positiva come una specie pregiata del genere libertà non ci impegna ad accogliere nessuna particolare idea su quale regime la promuove meglio». In altre parole, si potrebbe scoprire che lavoro, salute, benessere sono più garantiti là dove c'è meno Stato e più mercato. «Le società commercialmente più avanzate di ogni epoca», l'antica Atene, Venezia e Firenze nel Rinascimento, o New York, «non assicurano solo il cibo», ma moltiplicano per tutti le possibilità di vivere una vita più umana e confortevole. Il discorso è convincente anche se non farei troppo affidamento, per confutare i critici del liberalismo, sulla domanda: «Anche la libertà positiva è importante ma la garantisce di più un'economia aperta o un regime collettivista?». In un'ottica liberale, la libertà negativa avrà sempre uno status ontologico superiore giacché se nessuno m'impedisce di fare alcunché ma io non ho i mezzi per farlo, posso sempre rimboccarmi le maniche, organizzarmi con altri per procurarmeli (nessuno, appunto, me lo impedisce) laddove la libertà positiva, rinviando all'eguaglianza anche dei punti di arrivo, per garantire a tutti «dignità e benessere», deve consegnare ad alcuni un potere politico e legislativo così grande da rendere problematica la libertà negativa: più si rendono alcuni individui «eguali», infatti, più diminuisce la sfera di azione di quanti, con la loro abilità e il loro ingegno, potrebbero reintrodurre le diseguaglianze. «Gli ingredienti fondamentali della libertà negativa» scrivono del resto gli autori parlando delle riforme di Turgot, «erano la chiave per stimolare l'ingegnosità e la perseveranza grazie alle quali» i lavoratori «avrebbero potuto liberarsi della deprivazione materiale, e quindi passare dalla libertà negativa alla libertà positiva». Appunto, come volevasi dimostrare.
Il credo liberale di Berlin contro la tirannia delle idee. La convinzione che i conflitti si possano superare e tutti i valori umani siano conciliabili è falsa. Ed è la base dei totalitarismi del Novecento, scrive Giancristiano Desiderio su “Il Giornale”. C'è qualcosa di commovente in questo breve scritto di Isaiah Berlin che Adelphi ha pubblicato: Un messaggio al Ventunesimo secolo. Il volumetto, piccolo e prezioso, è composto di due discorsi: il primo, già pubblicato in Il legno storto dell'umanità , è La ricerca dell'ideale : Berlin lo considerava il suo testamento spirituale e fu pronunciato in occasione della consegna del Premio Giovanni Agnelli nel 1988; il secondo è Un messaggio al Ventunesimo secolo : Berlin in una lettera all'amico John Roberts lo definì «breve credo» e fu scritto nel 1994 in occasione della laurea ad honorem in Giurisprudenza conferitagli dalla Università di Toronto. Il lettore, se accetta un consiglio, inverta l'ordine dell'indice e legga prima il credo e poi il testamento. Il «breve credo» è non solo commovente - un moto d'affetto lo attraversa tutto dalla prima all'ultima riga - ma fulminante e il lettore si troverà davanti il cuore del pluralismo liberale di Berlin e il volto della verità che così si può riassumere: l'idea di conciliare tutti i valori umani è non solo ardua ma falsa e chi la persegue sta riproponendo il totalitarismo del Novecento. Gli uomini si ammazzano da sempre, tuttavia le imprese di Attila, di Gengis Khan, di Napoleone e perfino i massacri degli armeni «impallidiscono di fronte alla Rivoluzione russa e ai suoi postumi». Infatti, l'oppressione, le torture, gli assassinii, gli stermini «di cui si resero responsabili Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, e la sistematica falsificazione dell'informazione mediante la quale si occultarono per anni quegli orrori - dice Berlin che fu testimone della Rivoluzione d'Ottobre e attraversò tutto il “terribile Novecento” - sono cose che non hanno precedenti». Perché? Perché gli stermini di massa e l'annientamento dell'umanità sono stati concepiti e realizzati - tenetevi forte - per il bene dell'umanità. È in questo paradiso tramutato in inferno che sir Isaiah si cala per smontare pezzo per pezzo l'insana sintesi di Verità e Potere che l'ideologia per eccellenza della modernità - il marxismo - ha perseguito con ogni mezzo. Una volta Heine disse che se Kant non avesse distrutto la teologia forse Robespierre non avrebbe ghigliottinato il re di Francia. Le idee hanno un gran potere sul potere e le idee del XX secolo sono assassine. I gulag e i lager - dice Berlin - «sono stati causati dalle idee; o meglio, da una specifica idea». Marx, proprio lui che svalutava l'importanza delle idee, ha «provocato con i suoi scritti la trasformazione del Ventesimo secolo, sia nella direzione che egli auspicava, sia, per reazione, nella direzione opposta». Cosa vi era in quegli scritti? Un sogno rivelatosi un incubo: l'idea del compimento necessario della storia umana e della realizzazione della perfezione. È sotto l'influsso di questa idea - o alibi - che gli uomini hanno ucciso e sterminato con la «coscienza tranquilla». È un meccanismo infernale: se hai in mano la soluzione di tutto, allora, nessun prezzo è così alto da pagare per avere il paradiso. Neanche lo sterminio di massa: «Lenin se ne convinse dopo aver letto Il capitale. Predicava risolutamente che se coi mezzi da lui propugnati si poteva creare una società giusta, pacifica, felice, libera e virtuosa, allora il fine giustificava qualunque mezzo, letteralmente qualunque mezzo». Sennonché, questa verità è falsa giacché è falsissimo il convincimento che le domande basilari della vita umana, individuale e sociale, hanno una ed una sola risposta. E così è un dio falso e bugiardo quello che sostiene che i valori fondamentali dell'umanità siano armoniosi mentre sono inconciliabili: sono non conciliabili, per esempio, libertà e uguaglianza, libertà e sicurezza, giustizia e misericordia, ragione e spontaneità, Stato e Chiesa, verità e felicità. L'idea che si possa superare il conflitto è peggiore del (presunto) male: è proprio l'esistenza del conflitto che garantisce la nostra libertà. Dunque, per dirla con Lenin, che fare? Bisogna star calmi, far compromessi, accordi, baratti e - dice Berlin - «so bene che questa non è una bandiera sotto la quale molti giovani idealisti ed entusiasti vorrebbero marciare - è troppo ragionevole, troppo borghese - ma dovete credermi, non si può avere tutto ciò che si vuole, e non solo in pratica, anche in teoria». Insomma, la risposta migliore è la democrazia liberale che, nonostante tutto, si sta diffondendo: «Le grandi tirannie sono cadute, o presto cadranno - anche in Cina il giorno non è troppo lontano».
Croce, quando la libertà viene prima del liberismo. Il "Papa laico" della cultura italiana scomunicò persino Luigi Einaudi in tema di mercato. Ma la sua lezione sui "valori comuni" è attualissima, scrive Dino Cofrancesco su “Il Giornale”. Sessant'anni fa, il 20 novembre 1952, si spegneva, nell'austero Palazzo Filomarino, il Senatore Benedetto Croce, un pensatore epocale, un protagonista unico della storia della cultura occidentale. Unico a prescindere dalla sua concezione del mondo - analizzata, criticata, integrata in una saggistica, italiana e straniera, a dir poco, sterminata - giacché non s'era mai visto uno scrittore capace di far scuola sia nella storia dell'estetica e della critica letteraria, sia nella storiografia politica, sia nella filosofia. Anche nel Settecento, Hume e Voltaire si erano occupati della storia del loro Paese - e il secondo anche di quella svedese e russa - ma non avevano fondato nessun laboratorio di ricerca. Croce, al contrario, tra i suoi allievi non ebbe soltanto filosofi devoti, come il grandissimo Carlo Antoni, ma, altresì, storici tra i maggiori del XX secolo come Federico Chabod, Rosario Romeo, Adolfo Omodeo, Vittorio de Caprariis, Nicola Matteucci, allievi autentici e, in quanto tali, pensosi e problematici, non mere fotocopie sbiadite, se non caricature, del Maestro. Una personalità così ingombrante e multiforme non poteva arare lo scibile umano senza offrire il fianco a critiche e riserve spesso non prive di fondamento. Nelle sue teorie estetiche, non v'era spazio per la comprensione del decadentismo europeo, di Charles Baudelaire, di Gabriele D'Annunzio, di Giovanni Pascoli o di un gigante del teatro contemporaneo come Luigi Pirandello. Nel suo pensiero filosofico venivano liquidati, con eccessiva disinvoltura, non soltanto il vecchio positivismo - oggetto di ironia per il suo versante umanitario e riformista - ma, altresì, il pragmatismo, il neocriticismo e lo stesso esistenzialismo tedesco e francese. Nella sua concezione storiografica, venivano svalutate le nuove metodologie della ricerca che avevano trovato in Italia, nella scuola economico-giuridica, due esponenti di elevata cifra morale e intellettuale come Gioacchino Volpe e Gaetano Salvemini. E nondimeno, tra le tante critiche mosse al filosofo napoletano ve ne sono alcune che il tempo va forse ridimensionando. Il suo liberalismo è decisamente «superato» come hanno scritto politici intellettuali, come Giovanni Malagodi o accademici come Giovanni Sartori? È proprio vero che, nel confronto critico con Luigi Einaudi su liberalismo e liberismo, iniziato nel 1931, lo sconfitto è Croce? Come si ricorderà, la polemica tra i due giganti del liberalismo italiano verteva sul ruolo del libero mercato in una coerente teorica liberale. Per Einaudi, la libertà imprenditoriale è, come la libertà politica e la libertà civile, incorporata nel liberalismo dei moderni; per Croce, al contrario, il liberismo è uno strumento al servizio della Libertà, un mezzo di cui occorre misurare, di volta in volta, l'adeguatezza al fine. «La libertà come la poesia, come la morale, come il pensiero, non si lega mai a nessuna particolare condizione di fatto, istituzione e costume, sistema economico o altro che sia, ma tutti questi adopera secondo la situazione delle cose ossia il corso della storia, come mezzi pratici dell'opera sua». Per noi, le argomentazioni di Einaudi restano ineccepibili: come si può pensare, infatti, una società aperta senza mercato, ingabbiata da uno stato protezionista all'esterno e dirigista all'interno? Sennonché anche le ragioni di Croce cominciano ad apparirci come quegli scogli che dopo essere stati sommersi da ondate di chiacchiere riemergono più irremovibili e saldi di prima. In realtà, il rispettoso interlocutore di Einaudi non era suo contemporaneo ma restava un uomo dell'Ottocento. Alexis de Tocqueville aveva scritto: «Chi cerca nella libertà altra cosa che la libertà stessa è fatto per servire. Essa soltanto è in grado di strapparli al culto dell'oro e alle meschine faccende giornaliere dei loro affari privati, per far loro sentire e vedere, in ogni momento, la circostante e sovrastante presenza della patria; essa soltanto può sostituire di tempo in tempo all'amore del benessere passioni più energiche ed alte, offrire all'ambizione scopi maggiori che non quello di far quattrini, creare la luce che permette di scorgere e giudicare i vizi e le virtù degli uomini». Ebbene, al fondo, non era la stessa libertà di Croce, quella che gli artefici del Risorgimento avevano vissuto come «un principio religioso, che rende forti i cuori e illumina le menti e redime le genti e le fa capaci di difendere i loro legittimi interessi»? Croce ci richiama a una lezione dimenticata: senza valori comuni, in assenza di una identità comunitaria forte - per lui, l'Italia di Cavour e di Giolitti - si costruisce sulla sabbia. Indubbiamente questa idea rischiava di fargli sottovalutare l'analisi puntuale delle istituzioni politiche, economiche, culturali (le a torto detestate sociologia e scienza politica) ma, ad approfondirla, ci spiega assai bene perché sul patriottismo costituzionale alla Jürgen Habermas si fondano solo i villaggi Potemkin delle buone intenzioni.
Un Belpaese dal liberismo impossibile, scrive Piero Ostellino su "Il Giornale". Nel Novecento - sulla tracce dei tre totalitarismi che avevano dominato il secolo - era stata la politica a dettare principi e procedure all'opinione pubblica che ad essi doveva adeguare il proprio consenso. Nel secondo millennio, con l'allargarsi della base democratica prodotta dal '68, è il populismo, diffuso soprattutto nelle sfere più basse e meno attrezzate culturalmente, più sensibili alla demagogia della popolazione, a dettare alla politica, che vi si adegua, le condizioni del proprio consenso. È la conseguenza dell'abbandono dello studio della storia - che era stata la base sulla quale si era sviluppata la filosofia politica moderna - che ha fatto perdere di vista i fatti, la realtà effettuale che, da Aristotele a Machiavelli, aveva empiricamente condizionato la diffusione della filosofia politica moderna. Ora, sono posti sotto accusa liberalismo e capitalismo - che pur sono stati fondamento delle libertà e del benessere dei quali ha goduto l'umanità dalla fine del Settecento - in nome di una regressione, se non alla contrapposizione ideologica ottocentesca fra liberalismo e comunismo, quanto meno a quella fra liberalismo e comunitarismo, che è la versione attenuata del collettivismo, condannato e sconfitto dalle «dure repliche della storia». È singolare che istanze collettive, di matrice marxiana, smentite e condannate dalla storia, pretendano di avere il sopravvento sull'individualismo liberale, negandone attualità e validità, per ripristinare contrapposizioni ottocentesche, se non fra liberalismo e comunismo, quanto meno fra liberalismo e comunitarismo. Il fenomeno è soprattutto acuto da noi, in Italia, non a caso il Paese che ha generato, e coltivato, il più forte comunismo occidentale fino alla sua dissoluzione e anche il Paese più in ritardo rispetto ad un approccio empirico di matrice anglosassone. L'Italia paga il prezzo di non aver sviluppato una cultura liberale, quando ce n'erano le condizioni storiche, ai tempi della Riforma protestante, e di essere stata influenzata da una controcultura cattolica, che aveva trascurato il contributo individuale del protestantesimo alla formazione di una mentalità politica liberale diffidente di ogni autorità costituita, compresa quella della Chiesa, oltre a quella dello Stato. Il liberalismo - che con Cavour e i Savoia ha contribuito alla nascita e allo sviluppo dell'unità nazionale - non è contrario allo Stato, come una vulgata popolare tende a far credere in funzione del dominio di una sinistra demagogica, bensì è a favore di uno Stato centrale sufficientemente forte da fissare le regole del gioco alle quali l'opinione pubblica deve poi attenersi. L'esperienza dei Paesi anglosassoni insegna. Il nodo della questione sta tutto nella differenza fra un approccio alla realtà di tipo empirico e uno di tipo ideologico, là dove il primo si fonda sulla realtà storica, sulla realtà effettuale, e genera autonomia e libertà, mentre il secondo su un'idea della realtà come dovrebbe essere, che genera sudditanza.
La libertà non accetta consigli. Nel suo “Saggio sulla libertà”, John Stuart Mill, scrive Mariagrazia Gazzato su “L’Espresso”: " …l’argomento più forte contro l’interferenza del pubblico nella condotta puramente individuale è che, quando si verifica, si verifica con ogni probabilità, sia nei modi sbagliati che nel posto sbagliato. Nella questione di moralità sociale, di doveri nei confronti degli altri, l’opinione del pubblico, cioè della stragrande maggioranza, è più spesso giusta che sbagliata, poiché si tratta soltanto di giudicare sui propri interessi, su come verrebbero coinvolti da un dato comportamento, se venisse consentito. Ma l’opinione di una simile maggioranza, imposta come legge ad una minoranza, in questioni di condotta strettamente individuale, ha uguali probabilità di essere giusta o sbagliata, poiché nel migliore di questi casi, opinione pubblica significa l’opinione di alcuni su che cosa sia bene o male per altri e molto spesso non significa neanche questo, il pubblico con la più perfetta indifferenza, ignora i sentimenti e le esigenze di coloro di cui biasima la condotta e pensa solo alla propria preferenza. Molti considerano lesiva dei propri interessi qualsiasi condotta che loro dispiaccia e se ne risentono come di un oltraggio ai loro sentimenti, simili a quel bigotto che, accusato di disprezzare i sentimenti religiosi degli altri, ha ribattuto che sono loro a disprezzare i suoi persistendo nel loro abominevole culto e credo.” E qui seguono vari esempi, ma mi sembra sufficiente per esprimere la mia opinione sul tema della libertà individuale in rapporto ai doveri che ciascuno ha verso la società. E’ fuor di dubbio che qualsiasi azione individuale che non comporti alcun danno a terzi, non possa e non debba essere in alcun modo sanzionata o semplicemente frenata senza incorrere nella limitazione della libertà personale che attiene al singolo giudizio dell’individuo. Non occorre portare esempi, l’attuale società costringe il legislatore ad imporre leggi che limitino azioni che ledono la libertà altrui di godere appieno della propria individualità in base ai gusti, alle preferenze e alla condotta di vita che ciascuno ritiene più idonea per sé. Un caso molto evidente è il reato di stalking come quello di mobbing che, il legislatore, usando due parole mutuate dalla lingua inglese, ha recentemente introdotto nella nostra giurisprudenza. Sono due reati gravissimi perché limitano in maniera ossessiva e sistematica l’altrui libertà di azione. Ma ci sono esempi continui di limitazione della libertà personale anche in casi considerati di scarsa importanza, che non necessitano di una legge per essere regolamentati ma che attengono al generale “buon senso comune” e ad un etica comportamentale della quale alcuni sono completamente digiuni. Alcuni si arrogano (del tutto arbitrariamente) il diritto di giudicare, di consigliare, addirittura in alcuni casi di imporre, comportamenti da questi giudicati più giusti o più consoni per il mantenimento di una dignità nell’ambito societario, più confacente ai propri schemi mentali. Ma imporre i propri schemi mentali mediante suggerimenti o consigli non richiesti, soprattutto quando questo avviene additando palesemente o nascostamente, sconfinando nel pettegolezzo, colui il quale in base al proprio giudizio, si comporta in maniera riprovevole arrivando persino all’estrema ratio (irrazionale) di gridare allo scandalo è, a mio avviso e a giudicare da quanto espresso in uno dei saggi più popolari sul tema della libertà, davvero riprovevole. La cosiddetta dittatura della maggioranza che impone le proprie regole, a volte assurde, a chi non le condivide è una delle storture più evidenti e deformanti della democrazia. Ed è deteriore al punto di frenare le potenzialità individuali che altrimenti si svilupperebbero più armoniosamente e renderebbero un maggior beneficio alla società che dalle differenze, dalle molteplicità di stimoli, dalle diverse opinioni non può che trarre indubbio vantaggio.
LA DEMOCRAZIA E' PASSATA DI MODA?
Le piazze si affollano di gente che protesta, le cabine elettorali si svuotano, gli esecutivi si riempiono di tecnocrati. Tutti sintomi del fatto che la forma di governo più amata dall'Occidente versa ormai in crisi conclamata. Come spiegano molti pensatori nei loro libri più recenti, scrive Angiola Codacci Pisanelli su “L’Espresso”. La democrazia? «Non è una vetta conquistata per sempre, ma l’instabile punto d’arrivo di un processo intrinsecamente esposto al rischio di crisi e di catastrofe». Parola di Raffaele Simone, linguista e politologo, che dopo aver messo a fuoco nel 2008 il vero volto della nuova destra in ascesa (“Il mostro mite”), oggi si concentra sulla forma di governo che ancora sentiamo nostra ma che attraversa una fase molto difficile. Una crisi mondiale: dovunque cresce l’astensione e calano le iscrizioni ai partiti, cresce il peso politico di organismi finanziari sovranazionali (Fmi, Bce...) e cala la fiducia nelle istituzioni democratiche, mentre le piazze sempre più piene di proteste testimoniano il senso di distacco dell’elettorato da quelli che dovrebbero essere i loro rappresentanti. Una crisi dimostrata anche in Italia da un ricco filone editoriale - lo si vede in questo articolo, che si limita a citare testi usciti nelle ultime settimane - e da manifestazioni come la Biennale Democrazia che nel marzo scorso a Torino ha festeggiato la quarta edizione. Dove porterà questa fase, la nuova analisi di Simone lo dichiara già dalla copertina: “Come la democrazia fallisce” (Garzanti). Un titolo scelto dall’editore («Io avevo proposto “La fata democratica”, che sarà usato nelle tre edizioni straniere già in corso di stampa») che corrisponde perfettamente all’ultimo capitolo del libro. Dove lo studioso mostra come e perché l’Italia del governo Renzi sta facendo da apripista verso quella «democrazia assertiva» o francamente «autoritaria» che si va delineando in molti stati occidentali. La “Fata democratica” di Simone è il corrispondente “buonista”, progressista e di sinistra, del “Mostro mite” di destra che si è andato affermando negli ultimi anni fino a conquistare seggi su seggi in tutte le recenti elezioni europee. «La democrazia è diventata gradualmente un’entità benefica e onnipotente, una fata alla quale si può chiedere tutto anche a costo di sfiancarla». Il Mostro e la Fata: sembrano due personaggi da commedia dell’arte. E in effetti in tutto il saggio i rimandi allo spettacolo sono frequenti, fin dalla tesi di base: la democrazia si regge non su concetti realmente esistenti ma su finzioni. Solo che, a differenza di uno spettacolo teatrale in cui lo spettatore crede a quello che vede pur sapendo che non è la realtà, nel momento in cui le finzioni della democrazia mostrano la corda, secondo Simone il «gigantesco gioco di simulazione» crolla non come un castello di carte - che implicherebbe un progetto razionale e preciso - «ma come gli stecchini dello shangai». Di legame tra democrazia e teatro avevano già parlato diversi studiosi, da Hans Kelsen a Georges Balandier. Di «palinsesto che Renzi e gli altri insieme e dopo di lui sono chiamati a recitare» parla il politologo Mauro Calise, in un recente saggio sul “Mulino”. «Il titolo di questo palinsesto è lo stesso che, da anni, governa la grande maggioranza dei nostri partner occidentali: siamo diventati anche noi una “democrazia del leader”»: e Calise intitola così un volume in uscita da Laterza nel 2016. Anche Geminello Preterossi, direttore del Festival del diritto di Piacenza, denuncia l’incombere di una «politica come fiction, che distrae dalla consegna della decisione a logiche non democratiche». In “Ciò che resta della democrazia” (Laterza), Preterossi scrive che «l’inaridirsi degli spazi di partecipazione effettiva determina, per compensazione, il bisogno che nutre l’illusione della democrazia “immediata”, “veloce”, “semplice”». Una deriva pericolosa («Lo scivolamento verso una forma di neoautoritarismo elettivo, nell’indifferenza di un’opinione pubblica sfiancata, può essere molto breve») che secondo Preterossi può ancora essere evitata: «Per impedire che questa espropriazione si compia del tutto, occorre interrompere la fiction, tornare alla forza della politica in carne e ossa, come conflitto e alternativa». Simone è meno ottimista: «Del resto la mia è un’analisi, non un libro propositivo», sottolinea, anche per prendere le distanze da chi lo ha definito reazionario. E allora ecco quali sono le finzioni che reggono il “gioco delle parti” democratico: «È fittizia la cessione della sovranità: con il voto io cedo la mia volontà in forma inarticolata - mettendo solo una croce su una scheda - a qualcuno che posso anche non aver mai visto e che fino alle elezioni seguenti, non avendo vincoli di mandato, potrà fare quello che vuole. Non è realistica l’uguaglianza: siamo uguali solo in quanto viene permesso a tutti di mettere una croce sulla scheda, poi l’uguaglianza si esaurisce. Ed è irrealistica la formazione di una opinione pubblica informata, che è il presupposto di una libera scelta politica: noi cittadini in realtà andiamo avanti tra stereotipi, informazioni manipolate, notizie false e non controllabili». Il risultato è una crisi che scatena allarmi in tutto il mondo. In un recente articolo sul “New York Times” che partiva da un sondaggio del World Values Survey sull’importanza dei valori democratici, Roberto Foa e Yascha Mounk hanno collegato al calo di fiducia la tentazione dei cittadini di «lasciar prendere le decisioni al presidente senza preoccuparsi del Congresso e di affidare le decisioni più importanti a esperti e non a eletti, alla Federal Reserve o al Pentagono». Per i due giovani politologi di Harvard, il cuore del problema è economico e può essere risolto con «ambiziose riforme istituzionali che pongano un freno al potere politico dei ricchi». Ma con Donald Trump in testa ai sondaggi per le prossime presidenziali, una proposta del genere sembra arrivare platealmente troppo tardi. Se Foa e Mounk temono che all’orizzonte si stia materializzando un “governo dell’esercito”, altri politologi invece vedono di buon occhio alcune forme di “democrazia senza elezioni”: perfino il sorteggio delle cariche, come propone David Van Reybrouck nel suo libro appena tradotto da Feltrinelli (e recensito da Giuseppe Berta due settimane fa sull’“Espresso”). Reybrouck, che i lettori italiani già conoscono per il magistrale reportage “Congo”, e che anima una piattaforma politica chiamata G1000, in “Contro le elezioni” lancia una provocazione: rinunciare al voto e sorteggiare le cariche, come facevano i greci. Una provocazione stroncata sul “Corriere della Sera” da Luciano Canfora (che alla “Democrazia” ha dedicato un longseller pubblicato da Laterza). «Le cariche decisive della città erano elettive», ha ricordato. Ma Reybrouck - che di formazione è archeologo - lo sa, e da Atene parte per un excursus che passa dalla Venezia dei Dogi per finire nell’Islanda di oggi, dove la costituzione è stata modificata attraverso un lungo processo che ha permesso la partecipazione diretta dei cittadini. Secondo Simone invece «in Italia alla democrazia senza elezioni ci stiamo arrivando a poco a poco. Del resto, da vent’anni non esprimiamo preferenze sui candidati. Il nuovo senato non è eletto dai cittadini e una parte dei deputati saranno nominati dal partito. Il nostro presidente del Consiglio non è stato eletto e la formazione del governo, così ricco di tecnocrati, ricorda la designazione dei componenti di un consiglio di amministrazione». La frecciata contro i tecnocrati ricorda che i veri nemici, secondo Simone, non sono tanto i politici che vogliono tenersi il potere, ma i tecnici. «In astratto i tecnici sono risorse strumentali a cui il politico - che è per definizione un “incompetente”, uno del popolo - si rivolge per affrontare un determinato problema. Oggi però i tecnocrati non si fidano più dei politici e governano da soli. Lo fanno indirettamente - attraverso la Banca centrale europea o il Fondo monetario internazionale, o peggio ancora attraverso lobby invisibili - o direttamente: Dick Cheney, vicepresidente di George W. Bush, era tra i capi di una multinazionale che prima vendeva le armi e poi bonificava i terreni danneggiati dai bombardamenti». Ma forse la crisi della democrazia è una fase di crescita inevitabile: in fondo tanti politologi la considerano solo una fase di un ciclo che per Polibio va dalla monarchia al caos (il “potere della plebe”), per Kelsen da guerra a guerra - una fase che il giurista austriaco misurava in circa 60 anni. «E certo», continua Simone, «non aiuta questo quadro storico eccezionalmente avverso. Gli effetti della globalizzazione, che tolgono sempre più potere e sovranità alle amministrazioni dei singoli Stati. La crescente impossibilità di arrivare a una conoscenza dei fatti che già prima era difficile ma oggi è impossibile per la proliferazione di fonti data dalla Rete. E per finire l’immigrazione di massa, che superata una certa soglia di percentuale di immigrati porta la società al collasso. Un etologo, Irenäus Eibl-Eibesfeldt, ha calcolato il limite sostenibile al 30 per cento. Lui ha studiato i topi, e noi non siamo esattamente uguali ai topi, però...» Simone ricorda che in molti casi la democrazia è «un modo per raggiungere il potere con il consenso del popolo e senza spargimenti di sangue», e in effetti anche la sua crisi ha un percorso bonario: per la sua dissoluzione non serve la violenza, basta la paura. Lo “Stato di paura” che permette di “tenere buoni” i popoli, denunciato da un maestro del thriller come Michael Crichton nel libro che è stato il suo testamento spirituale: «Tutti gli elementi del quadro storico avverso sono elementi di paura», spiega Simone. «E la Grande Paura spinge a destra. Del resto la democrazia presuppone un mondo tranquillo, pacificato. È stato il primo tipo di governo che non solo lasciava vivere i nemici - cosa che colpiva molto i pensatori classici - ma addirittura permetteva loro di alternarsi al potere. Qualche volta, storicamente, è andata male: Mussolini e Hitler sono arrivati al potere con “quasi libere” elezioni». E allora, possiamo solo stare a guardare mentre la democrazia preme verso l’antidemocrazia o il caos?Non è possibile ipotizzare dei “lavori di manutenzione” anticrisi? «Dovrebbe pensarci la scuola, che però in Italia è sempre meno in grado di farlo. Non solo per la cronica svalutazione dell’insegnamento dell’educazione civica, ma anche per le pressioni esterne che spingono verso un insegnamento pratico e non critico». Viene da pensare che tutto si tiene, che un governo che viaggia verso una “democrazia assertiva” ha tutto l’interesse a minare il pensiero critico che dovrebbe essere il frutto di una scuola veramente “Buona”. E anche questo fa sì che, per chiudere come il libro di Simone, proprio in Italia oggi la democrazia appaia così «malconcia, mal coltivata e malprotetta».
A PROPOSITO DI TIRANNIDE. COME E QUANDO E' MORTO HITLER?
Hitler non è morto nel 1945. Per l'Fbi era in Argentina dopo la guerra, scrive “Libero Quotidiano”. History Channel ha realizzato una serie di documentari sulla presunta fine di Hitler. Il network ha messo insieme un pool di ricercatori davvero particolare. A guidarlo c’è una leggenda della Cia, Robert Baer. Con lui John Cencich, esperto di indagini scientifiche e regista dell’inchiesta internazionale che ha portato all’incriminazione del presidente serboSlobodan Milosevic. Nel gruppo anche un incursore, Tim Kennedy, che ha partecipato alle missioni delle forze speciali in Afghanistan per cercare il rifugio di Osama Bin Laden. Il gruppo ha analizzato file desecretati, tracce, testimonianze per rispondere alla domanda del XX: Hitler è morto nel bunker della cancelleria a Berlilno nel 1945 L’inchiesta si basa sui files resi pubblici dall’Fbi lo scorso anno, in cui si registrano molte decine di segnalazioni sulla fuga di Hitler tra il 1945 e il 1950. Baer le ha analizzate con i programmi informatici usati dalla Cia per scovare i terroristi islamici, incrociandole con le notizie raccolte dagli storici e col database degli interrogatori alleati fino a creare una mappa dei possibili nascondigli. Poi i risultati sono stati verificati sul campo. Il primo passo è come lasciare il bunker della cancelleria senza essere visti. A Berlino c'erano centinaia di chilometri di passaggi sotterranei, gli unici sicuri durante l’assedio dell’Armata Rossa. Dal 1999 questi cunicoli vengono esplorati da un’associazione di speleologi. L’aeroporto di Tempelhof era l’unica installazione nazista risparmiata dai raid alleati e dall'avanzata russa. Qui hangar a prova di bomba proteggevano i quadrimotori Condor, che erano in grado di raggiungere la Spagna senza scalo. Il 21 aprile 1945 ne sono decollati diversi, trasferendo alcuni alti ufficiali in Baviera, baluardo del Reich. Su alcuni velivoli erano imbarcate 'le proprietà personali di Hitler'. Secondo le fonti ufficiali l'ultimo decollo risalirebbe al 23 aprile, mentre altri Condor sono stati presi intatti dai russi cinque giorni dopo. Ma fino ad oggi non era stato individuato un collegamento diretto tra l'ultimo quartier generale di Hitler e questo punto di decollo. Il bunker comunicava con le gallerie della metropolitana. Tutti i superstiti dell’entourage hitleriano hanno negato però l'esistenza di un percorso diretto per Tempelhof. Usando un georadar tattico, il team di History ha scoperto un cunicolo che collega l’aeroporto alla stazione del metro. È bloccato dal 1945 e adesso si attendono le autorizzazioni per demolire gli accessi ed esplorarlo. Restava poi il problema di sparire, cosa non facile per un uomo tanto famoso. L’esame dei files Fbi porta a escludere la rotta sudtirolese, sfruttata da molti nazisti per raggiungere il Sudamerica. La pista dell'Fbi porta nella Spagna Franchista, amica del Reich. Le segnalazioni hanno portato ad un monastero molto particolare, perché unito con un lungo tunnel sotterraneo al comando della polizia militare. Dalla spagna il viaggio sarebbe proseguito verso le Canarie, ultimo approdo degli U-boot che non volevano arrendersi agli alleati: tre salparono dalla Germania dopo la resa, consegnandosi in Argentina quasi tre mesi dopo. È nel paese sudamericano che gli avvistamenti di Hitler si sono moltiplicati. L’analisi dei files ha portato il team in una cittadina isolatissima, Charata, e in un altro bunker. La struttura si trova sotto una fattoria, lontana centinaia di chilometri da tutto. In questo luogo era presente una vasta colonia tedesca che negli anni '40 iscriveva i figli alla locale Hitlerjugend. Ma i dossier dell’Fbi indicano anche un covo a Misiones al confine di tre stati. A Misiones una spedizione archeologica sta esplorando i resti di tre edifici degli anni ’40 nel cuore della giungla. Uno è un’abitazione con finiture di pregio. L’altro un impianto idroelettrico. La residenza era quindi autonoma. In una parete è stata trovata murata una scatola di biscotti. Dentro il contenitore c'erano monete del Terzo Reich e delle foto. Una ritrae una giovanissima recluta delle SS. Un’altra mostra il primo incontro tra Benito Mussolini e Hitler, a Venezia nel 1934: l’unico in cui il cancelliere è in abiti civili. Indizi, ricostruzioni verosimili e segnalazioni che però non sono in grado con assoluta certezza, neppure con le più moderne tecnologie, di stabilire se Hitler sia veramente morto nel 1945 o no.
Mancano prove della morte del dittatore. E gli ultimi dossier Fbi desecretati descrivono la sua fuga da Berlino. History Channel li ha fatti esaminare da un ex agente Cia e da uno dei cacciatori di Bin Laden. Scoprendo che la sua presenza fu segnalata in Argentina negli anni Cinquanta, scrive Gianluca De Feo su “L’Espresso”. Un tunnel dove una persona riesce a camminare solo piegandosi, il segmento finale per completare un puzzle di passaggi sotterranei. E cercare di trovare una chiave nascosta per riaprire il mistero del XX secolo, che resiste intatto da settanta anni. Perché nemmeno le ultime tecnologie riescono a offrire una sola prova oggettiva della morte di Adolf Hitler. Gli storici hanno pochi dubbi. Per loro il führer si è ucciso il 30 aprile 1945 nel bunker della Cancelleria, con un colpo di pistola alla testa e forse una dose di veleno. Anche i testimoni diretti dell’epilogo però sono scomparsi nell’apocalisse del Terzo Reich: restano solo racconti di seconda mano o di figure dall’attendibilità relativa. Nulla che oggi potrebbe permettere a un giudice di attestare il decesso. Dal 26 ottobre al 14 dicembre, ogni lunedì alle 21.00 History Channel (canale 407 di Sky) presenta 'Hunting Hitler' il progetto documentaristico in otto puntate di un'ora sul mistero della morte del dittatore tedesco. Il corpo infatti non fu ritrovato nel bunker di Berlino. Il team di History Channel, che include la 'leggenda' della Cia Robert Baer, ha indagato sui file dell'Fbi sulla presenza di Hitler in Argentina negli anni Cinquanta. Non a caso Thomas J. Dodd, capo delle delegazione americana al processo di Norimberga, ha usato parole chiare: «Nessuno può dire con certezza che Hitler è morto». C’è un vuoto di riscontri, scientifici e fotografici: i resti del dittatore e della donna che aveva sposato alla vigilia della fine sono stati definitivamente inceneriti e dispersi dal Kgb nel 1970. Ventitré anni dopo dagli archivi di Stato moscoviti sono ricomparsi due frammenti di cranio, che il test del dna realizzato nei laboratori americani ha attribuito nel 2009 a una giovane di età compatibile con Eva Braun. In quel teschio però c’è anche il segno di un proiettile in uscita, mentre i racconti tramandati dal bunker hanno parlato sempre di avvelenamento. I documenti desecretati nel corso del tempo non aiutano a fare luce, anzi infittiscono l’enigma. Quelli usciti un anno fa dagli schedari americani sono zeppi di rapporti dell’Fbi consegnati personalmente al gran capo Edgar Hoover che segnalano la presenza del führer in diversi paesi. Come se i detective federali, monopolisti dell’intelligence statunitense nell’immediato dopoguerra, avessero dato fede alle parole di Stalin, a quel “no” con cui durante la conferenza di Potsdam aveva risposto alla domanda diretta del presidente Truman: «Hitler è morto?». Da allora decine di saggisti e romanzieri di alterno valore si sono misurati con l’ipotesi di un’odissea nazista verso un nascondiglio remoto dove attendere la rinascita della follia ariana. Ad affrontare la questione con un approccio diverso arriva adesso un progetto voluto da History Channel, presentato in anteprima a “l’Espresso”. Invece di affidare le ricerche a un pool di accademici, il network dei documentari ha messo in campo una squadra di veri investigatori d’ultima generazione. A guidarla c’è una leggenda della Cia, Robert Baer, che ha ispirato l’agente interpretato da George Clooney in “Siriana”. Un veterano ancora in attività: l’ultima missione è stata a Beirut, indagando sull’omicidio dell’ex premier Rafik Hariri per conto del Tribunale speciale del Libano. John Cencich invece è un esperto di indagini scientifiche ed è stato il regista dell’inchiesta internazionale che ha portato all’incriminazione del presidente serbo Slobodan Milosevic. Al loro fianco un incursore: Tim Kennedy, un sergente dei ranger statunitensi che ha partecipato alle missioni delle forze speciali in Afghanistan per stanare il rifugio di Osama Bin Laden e in Iraq per catturare Zarqawi. Un pool pragmatico, che si è servito di esperti specializzati per affrontare i singoli problemi: giornalisti investigativi britannici, cacciatori israeliani di criminali, studiosi argentini delle comunità tedesche o ricercatori spagnoli sui rapporti tra Franco e il Reich. Il lavoro di questo pool è durato un anno, con un budget multimilionario e un dispendio di strumenti hi-tech, dai georadar ai droni: dotazioni e risorse che difficilmente i ricercatori universitari possono ottenere. Il risultato è un lunghissimo documentario, “Hunting Hitler”, otto puntate di un’ora che saranno trasmesse su History a partire da lunedì 26 ottobre (ore 21, canale 407 di Sky). La resa televisiva è estremamente dinamica, con un passo da grande film d’azione. Sicuramente troppo movimentata per trovare consensi tra gli storici, ma non si tratta certo di un prodotto di nicchia: è un investimento per catturare pubblici vasti. Il punto è capire se dietro la spettacolarizzazione c’è sostanza, ossia se questo approccio innovativo può offrire un contributo reale alle ricerche. Gli esiti sembrano interessanti, anche se neppure le tecnologie più avanzate e i software elaborati per la sfida mondiale ad Al Qaeda sono riusciti a dare una parola finale sulla sorte di Hitler. È sorprendente ad esempio notare come le ricerche sul campo ancora oggi abbiano dovuto fare i conti con muri di reticenza forti in diversi paesi. E comunque con la volontà di non riaprire un capitolo che si preferisce dimenticare: è il caso degli ultimi familiari di Eva Braun, che non accettano il confronto tra il loro codice genetico e quello dei resti riscoperti a Mosca. «Siamo nati dopo la guerra, per noi quella storia è chiusa», spiegano. L’architrave dell’inchiesta sono i files che l’Fbi ha reso integralmente disponibili lo scorso anno: molte decine di segnalazioni più o meno accurate sulla fuga di Hitler trasmesse tra il 1945 e il 1950. Baer le ha analizzate con i programmi informatici che la Cia utilizza per scovare le tracce dei terroristi islamici, incrociandole con le notizie raccolte dagli storici e col database degli interrogatori alleati fino a creare una mappa dei possibili nascondigli. Per poi andare a verificare sul terreno ogni informazione. Si parte dalle vie per lasciare il bunker della Cancelleria senza essere visti. Nella Berlino dei bombardamenti continui esistevano centinaia di chilometri di passaggi sotterranei, gli unici percorsi sicuri durante l’assedio dell’Armata Rossa. Sono catacombe che dal 1999 vengono sistematicamente esplorate da un’associazione di speleologi. Ma finora mancava l’anello finale dell’itinerario tra la residenza corazzata del führer e l’aeroporto di Tempelhof: l’unica installazione nazista risparmiata dai raid alleati e dalle cannonate sovietiche, con hangar a prova di ordigno che proteggevano i quadrimotori Condor, aereo in grado di raggiungere la Spagna senza scalo. Il 21 aprile 1945 ne sono decollati diversi, trasferendo un manipolo di alti ufficiali nel caposaldo bavarese del Reich: in alcuni di questi velivoli erano imbarcate “le proprietà personali di Hitler”. L’ultima partenza nota avviene il 23 aprile, mentre altri Condor sono stati catturati intatti dai russi cinque giorni dopo. Sotto l’aeroporto c’è un alveare di locali blindati con impianti idrici ed elettrici autonomi, una sorta di monastero di cemento e acciaio, con decine di celle cubiche su tre livelli. In parte custodivano negativi e filmati raccolti dalla ricognizione tedesca: chilometri di pellicole incendiate poi dall’esplosivo dei genieri sovietici nell’ultimo assalto, con un rogo durato giorni che ha incenerito tutto. «Senza vie di fuga, un bunker diventa una trappola», sottolinea Baer. Dal comando della Cancelleria infatti si entrava nelle gallerie della metropolitana. Tutti i superstiti dell’entourage hitleriano hanno negato però che esistesse un percorso diretto per gli hangar di Tempelhof. Usando un georadar tattico, identico a quello impiegato per ispezionare le caverne di Tora Bora dove a lungo si è pensato fosse morto Bin Laden, il team di History ha scoperto un cunicolo che unisce l’aeroporto alla stazione del metro. È bloccato dai giorni della battaglia e adesso si attendono le autorizzazioni per demolire gli accessi ed esplorarlo. In ogni caso, c’erano altri modi per sottrarsi all’attacco sovietico. Robert Ritter von Greim e Hanna Reitsch sono atterrati in una pista improvvisata a pochi metri dalla porta di Brandeburgo e ripartiti il 30 aprile dopo avere incontrato Hitler nei meandri della Cancelleria. Già, ma dove poteva andare un uomo così famoso e così odiato? L’esame dei files Fbi porta a escludere la rotta sudtirolese, sfruttata da molti nazisti per raggiungere il Sudamerica attraverso i porti italiani e la copertura della gerarchia cattolica. Nel caso del führer i rischi dovevano essere ridotti al minimo, contando su rifugi predisposti da tempo in paesi ancora amici. Come la Spagna di Francisco Franco. Lì le segnalazioni raccolte dai detective di Hoover hanno portato la squadra di Robert Baer in un monastero molto particolare, perché unito con un lungo camminamento sotterraneo al comando della polizia militare. Poi le Canarie, ultimo approdo degli U-boot che non volevano arrendersi agli alleati: tre salparono dalla Germania dopo l’annuncio della resa, consegnandosi in Argentina quasi tre mesi più tardi. È nel paese sudamericano che gli avvistamenti di Hitler si sono moltiplicati. L’analisi dei files ha portato il team in una cittadina isolatissima, Charata, e in un altro bunker: una struttura costruita sotto una fattoria, lontana centinaia di chilometri da tutto. Lì negli anni ’40 una vasta colonia tedesca iscriveva i figli a centinaia nella sede locale della Hitlerjugend. Ma i dossier dell’Fbi indicano un altro “covo” ancora più a nord, a Misiones, terra di predicatori gesuiti al confine di tre stati: una posizione da sempre sfruttata per traffici e contrabbandi. A Misiones dallo scorso marzo una spedizione archeologica sta esplorando i resti di tre edifici costruiti negli anni ’40 nel cuore della giungla. Uno è un’abitazione di qualità, con vasca da bagno e decorazioni. L’altro probabilmente un impianto idroelettrico con alcune officine. Insomma, una residenza autonoma: gli scavi finora hanno riportato alla luce riserve di cibi in scatola e medicinali, tutti di quel periodo. In una parete era stata murata una scatola di biscotti, contenente monete del Terzo Reich e alcune foto. Una ritrae una giovanissima recluta delle SS, forse non tedesca, forse uno dei volontari europei accorsi a combattere sotto la svastica. Un’altra mostra il primo incontro tra Benito Mussolini e Hitler, a Venezia nel 1934: l’unico in cui il cancelliere indossa abiti civili. Indizi, piccoli e grandi, di una rete di protezione dei fuggitivi nazisti. Che però non scalfiscono il mistero del secolo.
L'ANTIPOLITICA E L'ASTENSIONISMO.
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Da sempre diffido di chi, vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I saccenti giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del difensore civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro, per poter metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da anni mi batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano nemmeno di rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A sbraitare son bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci. Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e mai parlano di libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione umana nefasta si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli permettiamo di farle.
Parlare nei miei libri del caso singolo del semplice cittadino significa incorrere nell’accusa di mitomania, pazzia o calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece parlo di loro, delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera mafia. Cosa posso dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono? Credo che quanto divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime, non potendo avere altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui interessa solo di loro stessi e se ne fottono degli altri.
Una cosa è certa, però. Per i poveri cristi vale “Colpevole fino a prova contraria”. Per gli intoccabili vale "Innocente fino a prova contraria o fino all’archiviazione o alla prescrizione".
Nel "palazzo dello scandalo". Un giorno con i giudici indagati, scrive Riccardo Lo Verso Mercoledì 23 Settembre 2015 su “Live Sicilia”. Da Silvana Saguto a Tommaso Virga, passando per Lorenzo Chiaromonte e Dario Scaletta. Alcuni hanno cambiato incarico, altri hanno rinunciato a parte dei loro compiti, ma è negli uffici giudiziari palermitani che attenderanno il giudizio del Cms sulla loro eventuale incompatibilità ambientale. Tommaso Virga è nella sua stanza al primo piano del nuovo Palazzo di giustizia di Palermo. Due rampe di scale lo separano dalla sezione Misure di prevenzione finita sotto inchiesta. Siede alla scrivania dopo avere appeso la toga e tolto la pettorina, il bavaglino bianco che un regio decreto del 1865 impone di indossare ai giudici in udienza. Questioni di forma e decoro. Virga parla con i cancellieri e prepara il calendario delle udienze della quarta sezione penale. Fa tutto ciò che deve fare un presidente che si è appena insediato. Archiviata l'esperienza di consigliere togato al Consiglio superiore della magistratura aspettava che si liberasse una sezione a Palermo. Un incrocio, quanto meno insolito, ha fatto sì che andasse a prendere il posto di Mario Fontana, chiamato a sostituire Silvana Saguto, l'ex presidente delle Misure di prevenzione travolta dall'indagine in cui è coinvolto lo stesso Virga. Che si mostra disponibile con il cronista che bussa alla sua porta. “Nel rispetto del ruolo che ricopro non ho mai fatto dichiarazioni”, dice il presidente chiarendo subito la sua intenzione di non cambiare idea proprio adesso. Inutile chiedergli dell'indagine che lo coinvolge, della credibilità della magistratura che vacilla, della perplessità legittima di chi si chiede se questa storia possa intaccare la serenità necessaria per chi deve amministrare la giustizia al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'opportunità di continuare a fare il giudice a Palermo. Perché tutti i magistrati coinvolti nell'indagine sono e resteranno a Palermo. Alcuni hanno cambiato incarico, altri hanno rinunciato a parte dei loro compiti, ma è negli uffici giudiziari palermitani, nei luoghi dello scandalo, che attenderanno il giudizio del Csm sulla loro eventuale incompatibilità ambientale. Virga è tanto garbato quanto ermetico. Si limita a fare registrare un dato incontrovertibile: “Sono al mio posto, a lavorare”. I suoi gesti e il tono della voce sembrano rispondere alla domanda sulla serenità. Qualcuno degli addetti alla cancelleria si spinge oltre le impressioni con una frase asciutta: “L'autorevolezza del presidente Virga è fuori discussione”. Già, l'autorevolezza, al centro delle discussioni che impegnano gli addetti ai lavori nell'apparente normalità di una mattinata al Palazzo di giustizia. Apparente perché è profondo il solco tracciato dalla domanda che anima ogni capannello che si forma nei corridoi o davanti alle aule: può essere credibile una magistratura segnata da un'indagine, fastidiosa oltre che grave visti i reati ipotizzati? Nello scandalo dei beni confiscati sono coinvolti quattro magistrati. Uno è Tommaso Virga, gli altri sono Silvana Saguto e Lorenzo Chiaramonte (vecchi componenti della sezione Misure di prevenzione, azzerata con l'arrivo di Fontana) e il pubblico ministero Dario Scaletta. Hanno ruoli diversi nella vicenda. Per tutti vale il principio della presunzione di non colpevolezza su cui si basa il nostro stato di diritto. La Saguto sarebbe il vertice del presunto sistema affaristico - i pubblici ministeri di Caltanissetta ipotizzano i reati di corruzione, induzione alla concussione e abuso d'ufficio - creato attorno alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. Un sistema che avrebbe finito per favorire alcuni amministratori giudiziari piuttosto di altri. Fra i “favoriti” ci sarebbero Gaetano Cappellano Seminara, il principe degli amministratori, e il giovane Walter Virga, figlio del Tommaso di cui sopra. A detta dei pm nisseni, il primo sarebbe stato nominato in cambio di consulenze assegnate al marito della Saguto e il secondo per "ringraziare" Virga padre che, quando era consigliere del Csm, avrebbe calmato le acque che si agitavano sull'operato della Saguto. Un aiuto smentito nei giorni scorsi da Virga, tramite il suo legale, l'avvocato Enrico Sorgi: “Durante il proprio mandato al Csm non risultano essere stati avviati procedimenti disciplinari a carico della Saguto. I fatti che formano oggetto della notizia diffusa sono del tutto privi di potenziale fondamento”. Chiaramonte, invece, è indagato per abuso d'ufficio perché non si sarebbe astenuto quando ha firmato l'incarico di amministratrice giudiziaria a una persona di sua conoscenza. Infine c'è Dario Scaletta, pm della Direzione distrettuale antimafia e rappresentante dell'accusa nei processi in fase di misure di prevenzione. Scaletta avrebbe fatto sapere alla Saguto che era stata trasferita da Palermo a Caltanissetta l'inchiesta su Walter Virga e cioè il fascicolo da cui è partito il terremoto giudiziario. Il pubblico ministero ha chiesto di non occuparsi più di indagini su Cosa nostra e di misure di prevenzione. Tutti i magistrati, coinvolti nell'indagine a vario titolo e con profili diversi, restano a Palermo. Silvana Saguto, appena avrà recuperato da un infortunio fisico, andrà a presiedere la terza sezione della Corte d'assise. Chiaramonte, ultimate le ferie, prenderà servizio all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Sarà il Csm a decidere se e quando trasferirli. Sul caso è stato aperto un fascicolo, di cui si occuperà la Prima Commissione, competente sui trasferimenti per incompatibilità ambientale e funzionale dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura per tradizione non spicca in velocità. In una giustizia spesso lumaca non fa eccezione il procedimento davanti all'organismo di autogoverno della magistratura che somiglia molto, nel suo svolgimento, ad un processo ordinario. A meno che non venga preso un provvedimento cautelare urgente ci vorrà tempo prima di conoscere il destino dei magistrati, forse più di quanto ne servirà ai pubblici ministeri di Caltanissetta per chiudere le indagini o agli stessi indagati per chiarire la loro posizione. Il “forse” è dovuto al fatto che le indagini affidate ai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Palermo sembrano essere appena all'inizio e i pm non hanno alcuna intenzione, al momento, di sentire i magistrati che avevano chiesto di essere interrogati. Oggi, però, son arrivate le parole del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini durante il plenum. "Oggi parlerò con il presidente della Repubblica", ha detto ribadendo la volontà di "procedere con la massima tempestività e rigore".
L’antipolitica: le urne sono sempre più vuote, scrive Piero Miolla su “La Gazzetta del Mezzogiorno” I lucani non hanno fiducia nelle autorità locali. La tendenza, comune al resto d’Italia, emerge dai dati resi noti da «Eurobarometro 2015» che, con riferimento alle istituzioni regionali e alle autorità locali, in particolare i comuni, mostrano che il 68% degli italiani non ha fiducia in tali istituzioni: una quota superiore di 22 punti al dato medio europeo, che è pari al 46%. Si tratta, in realtà, di un trend discendente, poiché nella precedente rilevazione «Eurobarometro», relativa a novembre 2014, gli sfiduciati erano il 70% e, nel 2013, addirittura il 78. La sfiducia connota il nostro Paese in maniera peculiare, se si pensa che in Francia il dato della sfiducia è al 41%, in Germania al 24 e nel Regno Unito al 42. Il crollo della fiducia rispetto agli attori istituzionali dei territori è in linea con il dato sugli effetti sociali e territoriali della devolution: infatti, il 53,6% degli italiani ritiene che in sanità, assistenza e servizi pubblici, nel trasporto pubblico locale, e più in generale, nel welfare, la devolution come trasferimento di poteri a Regioni e Comuni vuol dire un aumento delle differenze di copertura sociale tra regioni e comuni; questa opinione è fatta propria da oltre il 62% dei residenti al Sud-isole, dal 55 di quelli del Centro e da quote inferiori nelle due ripartizioni del Nord. In buona sostanza, gli italiani ritengono che la devolution finisca per approfondire le disuguaglianze territoriali nel welfare, piuttosto che garantire una modulazione dell’offerta rispetto alla composizione dei bisogni locali. Visti i numerosi casi di cronaca, di cui la «questione romana» è solo un l’ultimo esempio, non sorprende quindi che la sfiducia dei cittadini abbia ormai colpito anche i livelli istituzionali più prossimi con una pericolosa erosione della legittimazione. Di fatto un patrimonio di fiducia localistica è stato dissipato in questi anni da Regioni, Province e anche Comuni, mettendo in pericolosa discussione dal punto di vista della credibilità sociale attori istituzionali fondamentali per la dinamica dello sviluppo locale. Ma la crisi di fiducia coinvolge anche le istituzioni politiche nazionali: del proprio Governo non si fida il 76% degli italiani, e il 63 di quelli europei. Il Parlamento nazionale non suscita fiducia al 73% degli italiani e al 62 degli europei. Dei partiti nazionali non si fida l’85 per cento degli italiani e il 78 degli europei. Nell’ultimo biennio, però, si registra comunque una lieve tendenza alla riduzione della sfiducia, sebbene gli ultimi dati si riferiscano a maggio 2015, vale a dire prima della calda estate romana. Il disincanto cresce invece nei confronti del sistema giudiziario nazionale, verso il quale gli scettici in Italia balzano dal 52 al 60%, mentre in Europa calano dal 49 al 43%. Dalla critica degli italiani si salvano solo poche istituzioni, e in particolare l’esercito, di cui si fida il 62%, e la polizia con una percentuale di stima che si attesta al 61%.
Astensione, l'antipolitica non c'entra, scrive Francesco Jori su “Nuova Venezia” Un pizzico di preoccupazione: q.b., quanto basta; e basta davvero poco. Gli apprendisti masterchef dell'insipida cucina politica italiana non hanno tempo né voglia per dedicarsi a capire come mai metà dei clienti rifiutino il loro sgangherato menu: liquidano la questione con due battute a caldo, sull'onda dei risultati elettorali; poi l'astensione sprofonda in un silenzio tombale. A loro basta essersi garantiti il posto per altri cinque anni; nel corso dei quali continueranno a impiegare gli stessi mediocri ingredienti e a propinare le stesse scadenti ricette. Se la cavano spiegando che all'estero l'indice di gradimento (si fa per dire) è lo stesso. Si guardano bene dall'aggiungere che altrove vigono regole diverse (per esempio, negli Usa bisogna iscriversi al voto preliminarmente, da noi basta andare ai seggi), e soprattutto che i trend di affluenza sono consolidati da tempo; in casa nostra, si è verificato un autentico crollo dalla stagione, tutt'altro che remota, in cui nove elettori su dieci andavano alle urne. E il calo è costante ad ogni livello, politiche comprese che pure sono il momento di massima mobilitazione: dal 93,4 del '76 si è scesi all'87,3 del '92, all'81,4 del 2001, al 72,2 del 2013. Peggio ancora alle europee dell'anno scorso: 58,7. Peggio-bis alle ultime regionali: 52,2. In mezzo, segnali parziali ma inequivocabili: vedi lo choccante 37,7 dell'Emilia nel novembre scorso. Stavolta il turno era parziale (7 Regioni su 20); ma è diventato egualmente significativo, come segnala l'analisi dell'autorevole Istituto Cattaneo. Per la prima volta, infatti, l'astensione è diventata l'opzione maggioritaria o quasi: in nessuna delle sette si è arrivati a quel 60 per cento che nel 2010 era stato superato da tutte e sette. Se poi guardiamo al fenomeno in prospettiva lunga, c'è un aspetto ancor più indicativo che emerge: le elezioni regionali, che un tempo erano quelle con maggior richiamo dopo le politiche, sono diventate le meno attrattive, perfino peggio delle europee che erano tradizionalmente le meno sentite. Il dato emerge in particolare nelle cinque regioni del centro-nord andate domenica scorsa alle urne: di solito le aree con più elevata mobilitazione (tipo la Toscana). D'accordo, è un tracollo sul quale hanno pesato i comportamenti tra il disinvolto e il criminale di tanti, troppi consiglieri regionali di ogni colore e di ogni zona geografica. Ma non basta a spiegare la disaffezione dilagante, specie se la si raffronta con gli altri appuntamenti elettorali. A fronte di questo inequivocabile trend, la reazione di molti professionisti della poltrona è tacciare gli astensionisti di qualunquismo e antipolitica, se non addirittura di autentica ignoranza; naturalmente impartendosi l'auto-assoluzione, e scaricando le colpe sui mass media cinici e bari, sui disfattisti cronici, sugli immancabili grandi vecchi occulti. Nulla di più falso. I cittadini italiani hanno dimostrato e dimostrano di mobilitarsi a colpi di grandi numeri quando c'è da dare prova di impegno civico. L'hanno fatto in tante grandi emergenze nazionali, dai terremoti alle alluvioni; raccogliendo firme a centinaia di migliaia per referendum che magari i partiti boicottavano; rispondendo agli appelli a scendere in piazza quando sono in gioco temi strategici, dai beni comuni al lavoro alla scuola. Lo fanno ogni giorno impegnandosi in massa nel volontariato; di cui, per inciso, il Veneto è primatista nazionale. Oltre 9 milioni di italiani domenica scorsa sono rimasti a casa: tutti qualunquisti, cialtroni, ignoranti? Troppo comodo. Con tutta evidenza, gli odierni mandarini di palazzo confidano che prima o poi si avveri la micidiale battuta di Corrado Guzzanti: se i partiti non interpretano più gli elettori, cambiamoli questi benedetti elettori. Un fastidio di meno.
Lo sguardo del Colle, scrive Antonio Polito su “Il Corriere dela Sera”. Giorgio Napolitano ha dedicato gli anni della sua presidenza alla difesa della politica democratica. Si capisce dunque che, forse anche cominciando a trarne il bilancio, indichi oggi con toni accorati nell’antipolitica «la più grave delle patologie del nostro vivere civile», e la bolli addirittura come «eversiva». Non è un fenomeno di questi giorni, e non può essere nemmeno esclusivamente identificato con gli ultimi arrivati come Grillo, che se ne è adombrato, o come Salvini, che lo ha fuso in una miscela esplosiva con l’antieuropei-smo, esplicitamente condannata da Napolitano. E infatti il presidente ricorda correttamente come l’antipolitica alberghi tra noi almeno dal 1992, al punto che essa è stata tra le fondamenta su cui è stata edificata la Seconda Repubblica, una Repubblica senza partiti e contro i partiti, il cui frutto non è stato però una rigenerazione democratica ma la degenerazione di una politica che Napolitano ha definito «senza moralità», predatoria, personalistica, non meno ladra di quella che c’era prima, ma per di più scalabile dai poteri criminali, come i fatti di Roma dimostrano. È il punto che merita di essere approfondito nell’analisi del presidente: tra la degenerazione della politica e la degenerazione nell’antipolitica, quale viene prima? E, soprattutto, qual è oggi «la più grave delle patologie»? Napolitano mette l’accento sulla seconda; e sui media, rimproverando loro di essere stati corrivi con l’onda antipolitica, così alimentandola. Ci prendiamo il rimbrotto: perfino in fisica è ormai accertato che l’osservatore modifica la realtà anche semplicemente descrivendola. Ma ci sono davanti a noi numerosi esempi in cui l’antipolitica si è affermata da sola, senza aiuti esterni, e per ottime ragioni, al punto tale da sfociare in una reazione squisitamente politica contro la decadenza morale, come è stato evidente nel voto che gli elettori emiliani hanno dato alla loro Regione, non votando. È difficile perciò sfuggire alla sensazione che Grillo e Salvini siano l’effetto, più che la causa, di quella patologia. L’unico sollievo è che finora l’antipolitica si è rivelata meno violenta di quanto non sia stata la violenza politica in anni non troppo lontani. Del resto perfino nei rimedi che la parte migliore del sistema sta cercando a questa grave crisi della rappresentanza si sentono gli echi di un senso comune antipolitico, che oggi chiede più delega e meno partecipazione, meno eletti e più nominati, più uomini soli al comando e meno minoranze fastidiose. Oggi il successo politico ha bisogno dell’antipolitica, al punto che anche per il prossimo inquilino del Quirinale va di moda fare nomi di non politici. L’allarme lanciato ieri da Napolitano avrebbe dunque bisogno di una discussione spietatamente autocritica da molti versanti per produrre gli effetti di rigenerazione che giustamente auspica. Dobbiamo augurarcela con l’ottimismo della volontà.
"Quando c'era Berlinguer", c'era già l'antipolitica. Quello che Veltroni non dice, scrive Carmelo Palma su "Strade On Line". Più che un ritratto di Berlinguer è l'autobiografia sentimentale di uno dei suoi "ragazzi". La storia del PCI tra l'inizio degli anni '70 e la metà degli anni '80 ridotta ad apologo morale. A prudente distanza dall'attualità e dalla parentela imbarazzante tra il moralismo politico e il qualunquismo antipolitico. Poteva essere un film catartico, invece è solo agiografico. Non ci si sarebbe potuti aspettare da Veltroni un film revisionistico della mitologia berlingueriana che, prima e soprattutto dopo la morte sul campo del segretario del PCI, ha costituito la vera identità morale e politica della sinistra post-comunista. Ci si sarebbe però potuti attendere un film meno autobiografico, meno interessato a raccontare i sentimenti dei "ragazzi di Berlinguer" e degli altri protagonisti di quella stagione politica e più disponibile a indagare la duplice anomalia rappresentata, tra l'inizio degli anni '70 e la metà degli anni '80, da un partito e da un segretario comunisti che si dicevano "diversi", ma che nel prendere (lentamente) congedo da Mosca e nell'accomodarsi disciplinatamente sotto l'ombrello della Nato, non rinunciarono all'intransigenza anticapitalista e all'ostilità nei confronti dell'altra sinistra (quella socialista, liberale, radicale...) e si isolarono in una resistenza antropologica alla modernità (alla società dei consumi e della comunicazione di massa, alla rivoluzione tecnologica, alla personalizzazione del costume sociale, al disgregarsi dell'identità di classe....), così intrappolando la sinistra, anche nei decenni a venire, in un culto della diversità risentito e moralistico e in una scontrosa incomunicabilità con il mondo esterno, proprio come "quando c'era Berlinguer". Un politico meno implicato di Veltroni e più determinato al parricidio avrebbe potuto spiegare come (per usare il lessico della destra) quella berlingueriana sia stata una "mitologia incapacitante", che trattenne gli epigoni di quella stagione dal riconoscere la realtà (e le possibilità per la sinistra) che Berlinguer non sapeva e non voleva vedere e dall'incamminarsi lungo la strada, quella socialista-democratica, ostruita dall'anatema pronunciato, anche in articulo mortis, dall'ultimo grande segretario del PCI. Veltroni, che pure nel film accosta subito la figura di Berlinguer a quella di Pasolini, si guarda bene dall'approfondire le analogie "reazionarie" tra i due personaggi e sceglie una chiave di analisi più indulgente. Berlinguer era il segretario troppo forte di un PCI ormai troppo debole, un'icona comunque capace di trascinare con sé un terzo degli italiani di sconfitta in sconfitta – da quella alla Fiat, con la marcia dei quarantamila, a quella, postuma, sul referendum contro il decreto di San Valentino – conservando un'orgogliosa unità interna e una riconosciuta legittimazione esterna. Il PCI, sembra dire Veltroni, non poteva che essere berlingueriano, perché in caso contrario non sarebbe stato più nulla. Tutti gli errori e le conseguenze di questa scelta rimandano a una necessità storica, come un effetto alla sua causa naturale e dunque non meritano giudizi di responsabilità politica. Era così – questa è la morale di Veltroni – e non poteva essere diversamente. Berlinguer è stato il modo in cui i comunisti hanno potuto continuare a riconoscersi tali – ma soprattutto a sentirsi qualcosa – anche dopo la fine del PCI e dunque non si può far colpa né all'uno, né agli altri di avere voluto serbare quella tenace "diversità" e identificarsi indissolubilmente con essa. Veltroni, che tra i dirigenti ex comunisti è stato probabilmente il meno incline alla nostalgia e il più disponibile a contaminare l'identità della sinistra traghettandola oltre le colonne d'Ercole del separatismo ideologico, si guarda bene dal prendere politicamente posizione sulle ragioni e sui torti di Berlinguer e racconta al contrario la storia del suo PCI come una sorta di apologo morale, rendendo un tributo personale alla grandezza del protagonista. Il film di Veltroni esce a trent'anni dalla morte di Berlinguer e all'indomani delle primarie del PD, che segnano per la prima volta la fine dell'egemonia berlingueriana sulla cultura della sinistra italiana. Si tratta di una svolta non solo generazionale, che però paradossalmente non supera quella peculiare "ideologia del nemico", a cui Berlinguer aveva condannato il PCI e che oggi il PD si trova a dovere fronteggiare non in sé, ma fuori di sé. Un Veltroni più coraggioso, e (possiamo dirlo?) psicologicamente più libero, avrebbe dovuto dar conto dell'imbarazzante parentela tra la politica berlingueriana e l'antipolitica grillina e della trasformazione della cosiddetta questione morale, fondata pur sempre sul culto dell'inestinguibile differenza politica comunista, in un qualunquismo trasversale privo di qualunque connotazione ideologica. Berlinguer, che è diventato segretario quando dall'orizzonte comunista era ormai tramontata la speranza della rivoluzione proletaria, schierò le truppe del partito nella lotta di liberazione dalla mala politica. Il suo PCI smise di minacciare la lotta di classe, ma dichiarò una sorta di guerra civile fredda contro la corruzione, l'abuso dell'interesse privato e i condizionamenti dei poteri forti – in pratica, contro l'intero sistema politico italiano – da cui i comunisti promettevano all'Italia un possibile riscatto umano e civile. Il suo PCI si sentiva e pretendeva di essere riconosciuto – lo scriverà, appunto, Pasolini – come "un Paese pulito in un Paese sporco, un Paese onesto in un Paese disonesto, un Paese intelligente in un Paese idiota ...". Era già tutto scritto. A Grillo è bastato aggiungervi l'utopia fantasy e post-democratica di Casaleggio e un sovrappiù di protervia ignorante, per ricavarne un prodotto politico di massa e tornare a innamorare anche milioni di elettori di sinistra pronti a rimproverare al PD il "tradimento di Berlinguer". Sono questi i voti – ricordiamolo – per cui Bersani ha perduto lo scorso febbraio elezioni che sembravano già vinte. Da questo terreno minato Veltroni, che pure ha scritto e diretto un film per l'oggi e non per il passato, e che lungamente racconta il Berlinguer della "questione morale", si tiene però prudentemente alla larga, praticando quella forma di doppiezza che non consiste nel dire il falso in luogo del vero, ma nel tacere la parte più problematica della verità. Insomma, "Quando c'era Berlinguer" poteva essere un film politicamente catartico, un modo per riappropriarsi di un'esperienza ambigua, per prenderne pienamente coscienza e insieme per congedarsi definitivamente da essa. È invece diventato un film agiografico, un modo per rinnovare il rimpianto di "qualcosa", e non solo di qualcuno, che non c'è più e per rimuovere l'effetto fatale di quell'antica illusione.
"L' antipolitica al governo. De Gaulle, Reagan, Berlusconi", libro di Donatella Campus. Negli ultimi decenni l'antipolitica, ovvero il discorso di leader che si oppongono a un establishment politico tacciato di immobilismo, inettitudine e corruzione, si è diffusa in modo cosi rilevante che sembra ormai rientrare nella "normalità" della democrazia. Ciò induce a chiedersi - come fa Donatella Campus in questo volume - se l'antipolitica sia solo un efficace esercizio di demagogia o possa invece diventare un vero e proprio strumento di governo, al servizio di un progetto capace di trasformare il sistema politico. Fondamentale, da questo punto di vista, è la capacità di utilizzare i mass media, e in particolare la televisione, come tribuna da cui suscitare nei cittadini l'identificazione con una leadership forte e incisiva. Il confronto fra tre leader - de Gaulle, Reagan e Berlusconi - che, presentatisi come outsider, hanno poi ricoperto le massime cariche di governo e lasciato una traccia profonda nella vicenda politica dei rispettivi paesi, permette non solo di comprendere meglio il fenomeno dell'antipolitica, ma anche di tracciare un bilancio inedito del percorso politico di Silvio Berlusconi e della sua, vera o presunta, eccezionalità.
Prima contro i partiti, poi dentro i partiti. Così cambia l'antipolitica. All'inizio era solo di destra e si opponeva, da fuori, al Palazzo Poi diventa di sinistra. E col M5S partecipa alla cosa pubblica, scrive Roberto Chiarini su “Il Giornale”. Per gentile concessione dell'editore, pubblichiamo un estratto del saggio L'antipolitica in Italia. Un tentativo di concettualizzazione del professore Roberto Chiarini che apre il nuovo numero della rivista Nuova Storia Contemporanea diretta da Francesco Perfetti in libreria da oggi (Le Lettere, pagg. 168, euro 12). Ogni democrazia ha dovuto fare i conti con una parte dell'opinione pubblica contraria a un coinvolgimento nelle istituzioni. Si parte con le difficoltà incontrate, ancor prima che a gestire, a capire la complessità della politica. Si continua con la fatica che un'attivazione partecipativa comporta. Si termina con la contestazione della legittimità stessa dell'esercizio della sovranità popolare. Puntualmente tutte queste declinazioni dell'antipolitica si ritrovano nel caso italiano in tutta la storia nazionale, anche se ovviamente dotate di una rilevanza differente a seconda delle varie congiunture politiche. Di massima si può comunque affermare che il rilievo assunto da alcune sue espressioni abbiano raggiunto, comparativamente alle altre democrazie occidentali, livelli da primato. L'antipolitica ha conquistato, comunque, la scena in Italia e, più o meno, in quasi tutte le democrazie occidentali solo negli ultimi decenni. A lungo l'antipolitica si è alimentata prevalentemente dalla protesta contro una politica o troppo partigiana o troppo inefficace o troppo sorda alle invocazioni venute dai ceti in sofferenza, da parte degli interessi locali o settoriali in affanno. Col tempo si è rivolta, invece, contro la troppa politica, una politica non solo ingombrante ma anche invalidante della società civile. Finché dura la Prima repubblica, il tratto distintivo tra politica e antipolitica è la difesa o meno della terna parlamentarismo-proporzionalismo-partitismo. A nulla servono, il riscontro dell'invadenza crescente dei partiti nell'apparato dello Stato o il reiterarsi di scandali che vedono i partiti di governo colti sul fatto nel momento di accaparrarsi risorse pubbliche o di procurarsi finanziamenti illeciti. È lo scandalo di Tangentopoli a chiudere con un botto fragoroso una parabola declinante dei partiti da tempo in crisi di credibilità. In quel momento la critica alla partitocrazia che per mezzo secolo è stata appannaggio quasi unicamente del Msi e della stampa di destra (da Guareschi a Montanelli) fa breccia nell'opinione pubblica e nei media innestando una spirale che si auto-alimenta allargandosi vertiginosamente. L'antipolitica si popolarizza conquistando d'autorità la scena politica nazionale. Riemerge dal confino in cui dal 1947 era stata relegata. Da mass level , risale a élite level , da qualunquistica si fa democratica. La grande stampa (da Il Corriere della sera a Il Giornale), inusitatamente concorde senza distinzioni di proprietà o orientamento politico, nonché la tv, sia pubblica che privata (da Samarcanda e Il rosso e il nero di Michele Santoro o Retequattro con Funari news) conquistano nuova audience e quasi «un'identità» brandendo la «questione morale». L'antipolitica dilaga. Esonda dall'argine della destra e invade redazioni, talk show, salotti, santuari del politicamente corretto. Si assiste a un vero e proprio ribaltamento nella considerazione del ruolo storico assolto dai partiti nella vita della Repubblica. La svolta si consuma nei primi anni '90 quando il movimento referendario di Segni sdogana una battaglia sino allora monopolizzata dalla destra, facendo irrompere sul palcoscenico politico la protesta antipartito. L'imprenditore politico che pionieristicamente avanza un'offerta capace di intercettare la domanda antipolitica ormai dilagante negli anni '80 è la Lega lombarda. Quella della Lega è un'antipolitica, non ipo, ma iper-politica. Non decreta il bando, ma il rientro in grande stile della politica. Boccia «Roma ladrona» ma incorona la Padania industriosa. Invoca le manette per i partiti tutti, tanto di governo quanto di opposizione, ma allestisce l'ultimo partito di massa della storia repubblicana: insediato nel territorio e forte di una militanza di cui s'era persa memoria. La novità degli anni '90 è che si profila «una vasta area di cittadinanza competente» portatrice di una nuova declinazione dell'antipolitica, non più caratterizzata dalla «contestazione dell'autorità», ma dalla critica verso le modalità con cui essa in concreto viene esercitata. La lotta alla partitocrazia diventa la parola d'ordine anche a sinistra. Ma quel che impressiona maggiormente è che le stelle del nuovo firmamento politico sorgono in nome di questa battaglia. È il caso di Antonio Di Pietro. Ma anche le nuove formazioni, per lo più movimentiste, che sul finire del secolo agitano il mondo di sinistra, come i girotondini, il Popolo Viola o la stessa Rete di Leoluca Orlando, fanno del rifiuto delle forme consolidate della democrazia rappresentativa. L'antipolitica domina incontrastata il campo, a destra e a sinistra. Con una differenza significativa. Mentre quella destrorsa viene bollata come populista o plebiscitaria, l'antipolitica «progressista» si mette al riparo dalla delegittimazione auto-qualificandosi «positiva», non meno accesamente ostile nei confronti della «nomenklatura spartitoria», della «degenerazione della politica in partitocrazia», dell'«occupazione dello Stato e della cosa pubblica». Da ultimo, l'antipolitica trova una sua nuova espressione nel Movimento 5 Stelle. L'attacco al «sistema dei partiti» risulta ancor più penetrante per le dimensioni inusitate del seguito elettorale raccolto il M5S e per la radicalità delle sue posizioni. Esercita un'antipolitica passiva nel senso che oppone al sistema dei partiti una sorda resistenza, chiamandosi fuori da ogni possibile interlocuzione con qualsiasi forza politica e anche da qualsiasi responsabilità istituzionale. Interpreta un'antipolitica attiva, in quanto si fa proponente di una forma di democrazia diretta tutta nuova, centrata sulla partecipazione attiva dei cittadini via web, postulando con ciò che «l'uomo qualunque» non debba estraniarsi dalla politica ma diventarne addirittura il protagonista assoluto.
L’antipolitica degli italiani è un antico menefreghismo, scrive Marco Milani su “Verona in”. L’antipolitca in Italia viene ontologicamente prima degli scandali e del malaffare, perché è condizione necessaria affinché questi possano avvenire. Quello che il senatore Antonio Razzi diceva a telecamere spente (“fatte licazzi tua”) è in soldoni quello che Silvio Berlusconi ha sempre messo in pratica nella sua vita politica. E nonostante questo fosse evidente, molti italiani gli hanno consentito di farlo, simpatizzando con il suo continuo disprezzo del bene comune. Grillo e Salvini non sono l’antipolitica, perché questa non è quella cosa che è nata dalla cattiva politica. Essi piuttosto usano l’antipolitica, un sentire da sempre presente in molti italiani che non hanno mai riconosciuto fino in fondo l’importanza delle cose comuni, né dell’autorità che promana dalle istituzioni dello Stato. Qualche mese fa, quando i media raccontavano lo scandalo di “mafia capitale”, l’allora capo dello stato in carica Giorgio Napolitano fece un discorso in cui parlò della necessità una grande battaglia contro l’antipolitica. Più di qualcuno sembrò sorpreso e trovò fuori luogo l’obiettivo di quel richiamo. Crozza, come spesso gli accade, puntò deciso sul senso comune degli italiani e ridicolizzò quel ragionamento con la metafora che per curare il cancro non serve a niente abolire l’aspirina. Pare che questi commentatori e comici abbiano identificato l’antipolitca con il Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo. E quest’ultimo, anche se incapace di cambiare le cose davvero, è visto comunque una reazione quasi fisiologica al degrado etico e civile della nostra classe politica. Questa interpretazione del fenomeno dell’antipolitica è la più diffusa tra elettori, giornalisti e commentatori di destra e di sinistra. Ma è davvero questa l’antipolitica di cui ha parlato Napolitano? Io credo fermamente di no. L’antipolitca in Italia è un fenomeno molto più antico ed esteso di quanto gli italiani vogliano ammettere. Essa viene ontologicamente prima degli scandali e del malaffare, perché è condizione necessaria affinché questi possano avvenire non destando forte allarme sociale. L’antipolitica, in questo senso, è una mancanza di civismo da cui discendono direttamente condotte irrispettose delle regole comuni. Da questi atteggiamenti e comportamenti diffusi discende a sua volta una sfiducia di fondo verso tutte le istituzioni dello Stato. Questo è il nocciolo dell’antipolitica, e ha origini molto più antiche del movimento di Grillo. Essa mina la partecipazione vera dei cittadini alle istituzioni e alla gestione della cosa pubblica. E sullo sfondo di questo atteggiamento diffuso, non c’è meccanismo democratico che si possa salvare. Le preferenze vengono spesso ridotte a un vile commercio di voti, e le elezioni primarie, sempre meno partecipate soprattutto a livello locale, difficilmente potranno sottrarsi a tale destino. Questo antico atteggiamento fa si che gli italiani siano sempre più convinti della necessità di difendere a oltranza i propri interessi personali. Quello che il senatore Antonio Razzi diceva a telecamere spente (ovvero “fatte licazzi tua”) è in soldoni quello che Silvio Berlusconi ha sempre messo in pratica nella sua vita politica. E nonostante questo fosse evidente, molti italiani gli hanno consentito di farlo, simpatizzando con il suo continuo disprezzo del bene comune. I due atteggiamenti che hanno consentito a questo modello di proliferare anche a sinistra sono il coinvolgimento di elettori mossi da interessi personali in comitati elettorali, e il disfattismo dei tanti che evitano la partecipazione perché schifati o perché da sempre distanti dalla politica. È solo con il disinteresse dei molti che i pochi appartenenti a certe consorterie riescono a inquinare partiti dagli ideali ispirati e dall’elettorato per gran parte onesto e consapevole. Il tirarsi fuori dalla discussione politica, il non impegnarsi all’interno di associazioni o partiti, non è un atto neutro. Esso ha un costo, specialmente in un Paese dove molti sono gli appetiti che mirano a deviare il corso regolare delle decisioni pubbliche. Similmente, ha un costo anche votare per salvaguardare in maniera miope i propri interessi immediati. Il votare per interesse non equivale a partecipare. Al contrario, esso è un atto che mira a condizionare i comportamenti di chi ha il potere in maniera non troppo difforme da ciò che fanno i lobbisti o gli imprenditori poco onesti. Dopo che questi atteggiamenti diffusi hanno portato il paese vicino a un disastroso default, ė diventato popolare il M5S. Questo partito, assieme alla Lega di Matteo Salvini, mira a difendere i molti italiani che hanno da molto tempo agito in questa maniera menefreghista ed egoista, scoraggiando, in questo modo, la partecipazione attiva a ogni sorta di dialogo politico democratico. Grillo e Salvini non sono l’antipolitica, perché questa non è quella cosa che è nata dalla cattiva politica. Essi piuttosto usano l’antipolitica, questo sentire da sempre presente in molti italiani che non hanno mai riconosciuto fino in fondo l’importanza delle cose comuni, né dell’autorità che promana dalle istituzioni dello Stato. Ciò che sfugge ai più è il legame forte che c’è tra il “vaffa” e la tangente, tra il linguaggio da bar e la corruzione in politica a tutti i livelli. Ebbene, il legame consiste nel fatto che mentre molti cittadini latrano su internet o al bar contro le istituzioni, c’è qualche altro cittadino che prova a usare i partiti e le cariche pubbliche per i propri interessi, non trovando ostacoli reali alla sua azione. La controprova è che nei paesi dove la corruzione è più alta, in genere la dialettica politica è infarcita di “vaffa” e di “tutti a casa”. Tra il farsi gli affari propri e il farseli a spese degli altri, c’è sì una differenza etica che spesso è anche sancita dalla legge, ma a livello di effetti sulla cosa pubblica essi sono entrambi atteggiamenti dannosi. Questa è davvero l’antipolitica. E’ questa che da sempre lascia il campo libero a gruppi di affari, mafie e consorterie varie mentre l’uomo comune si autoassolve con una scrollata di spalle o una battuta da osteria.
L'antipolitica? Colpa della sinistra! Lo dice Michele Ainis. Che nel suo ultimo libro parla delle ingiustizie che avvelenano la vita. Non si occupa più delle disuguaglianze ma delle poltrone, scrive Goffredo Pistelli su “Italia Oggi”. Per uno che ha fatto del diritto la sua vita, come ricerca ma anche come pubblicistica, l'uguaglianza non è una questione ma «la» questione. Per Michele Ainis, messinese, 60 anni, costituzionalista a Roma Tre e firma del Corriere e di L'Espresso, è così vero che ci ha scritto sopra un libro, appena uscito per Einaudi: La piccola eguaglianza.
Domanda. Professore, lei nella prima parte del libro elenca tanti esempi di diseguaglianza diffusa che possono avvelenarci la vita. Perché?
Risposta. Intanto perché, come tutti, non vivo sulla Luna, ma sulle strade, anche difficili, di una città come Roma. La molla, insomma, viene dal mio vissuto.
D. In che senso?
R. Per esempio, qualche anno fa, per una serie di contravvenzioni non pagate, dato che non mi erano mai state notificate, mi sono trovato la casa ipotecata.
D. All'insaputa...
R. Esatto. L'ho scoperto andando in banca a chiedere uno scoperto irrisorio ma per il quale occorreva al funzionario una visura patrimoniale.
D. E che successe?
R. Che la direttrice mi chiamò dicendomi: «Professore, non possiamo, perché lei ha la casa ipotecata». E quando risposi che ne ero consapevole, avendo acceso un mutuo per acquistare proprio quell'abitazione, la direttrice mi spiegò che si trattava di un'altra ipoteca. Ne scrissi sul giornale e finii in tv per quella vicenda, con l'Agenzia delle entrate che mi rispose. Ho sperimentato anche io la mia dose di ingiustizia.
D. E quindi si è applicato, di buzzo buono, a catalogare un bel po' di misfatti.
R. Sì, ma il senso di questa brutta favola è che molta parte del malanimo e del risentimento del cittadino verso chi ci governa nasce anche dallo stillicidio di vessazioni burocratiche e fiscali, come quelle dei molti casi che cito. Alcune delle quali derivano anche da una falsa idea di eguaglianza, che non distingue fra casi diseguali.
D. Per esempio?
R. Per esempio che se a me fanno una multa da 100 euro e la fanno al pensionato da 500 al mese, la cosa può apparire giusta, ma non lo è.
D. C'è un errore prospettico. Ma lei lo ripete spesso nel libro, quando cita don Lorenzo Milani, il quale diceva che non si può far parti uguali fra diseguali. O Anatole France..
R. Sì, quando diceva che «la legge, nella sua maestosa equità, proibisce tanto ai ricchi quanto ai poveri di dormire sotto i ponti».
D. Esatto.
R. Ma, vede, io vengo interpellato anche due volte al giorno per parlare di legge elettorale.
R. E quindi?
R. E quindi ci sono questioni molto più centrali, come queste, che invece passano in sordina. Ora, è facile dire che la questione non riguarda solo l'Italia ma tutta l'umanità, ma si deve anche ammettere che, se non si affrontano e si temperano il più possibile le diseguaglianze fra Nord e Sud del mondo, avremo guerra, terrorismo e crisi economica. Perché va ricordato che la grande depressione del 1929 la avemmo quando negli Stati Uniti si registrarono punte di diseguaglianza mai viste prima. Senza dimenticare che le eccessive diseguaglianze, all'interno degli Stati sviluppati, generano il fenomeno dell'antipolitica.
D. Ci sono fatti, forse meno drammatici di quelli appena evocati, che sono più avvertiti di altri, in fatto di eguaglianza oggi. Penso alle differenze di genere per le quali oggi, in Italia, c'è una spiccata sensibilità.
R. Noi arriviamo sempre dopo e sempre tardi. E spesso facendo la caricatura di esperienza altrui.
D. Vale a dire?
R. Facciamo l'esempio di questo governo che quando si occupa delle differenze sessuali, meritoriamente peraltro, lo fa promuovendo in posizione apicali molte donne.
D. Allude alle molte ministre dell'esecutivo di Matteo Renzi?
R. Non solo a loro, penso anche ai vertici di Eni, Poste e Enel, con Emma Marcegaglia, Luisa Todini e Patrizia Grieco.
D. Non va bene?
R. Va benissimo, spesso un gesto è piú potente di una legge, perché la parità di genere, quando viene praticata nei fatti, anziché declamata in astratto, esprime un valore pedagogico, concorre a rovesciare il pregiudizio che ha fin qui ostacolato la piena emancipazione delle donne. Purché...
D. Purché?
R. Purché non diventi regola perenne, impermeabile rispetto alle situazioni e alle stagioni della storia. Purché non sia una regola di ferro, senza flessibilità, senza capacità d'adattamento ai casi della vita.
D. Le quote non van bene...
R. Le quote sono offensive perché, alla fine, impediscono la gara. Meglio l'affirmative action, ossia l'azione positiva, che consiste in un vantaggio di legge per la categoria svantaggiata. Ciò permette di rendere quella gara giusta senza negare la competizione.
D. È il sistema, cosiddetto dei goals, ossia nel dare un bonus di partenza in più a chi è penalizzato, per genere o appartenenza etnica.
R. Sì, bisogna battere quel pregiudizio sociale che, come un tarlo, lavora sotto la superficie, per cui una donna non può fare il primario. E il bonus aiuta, dopodiché quella donna deve dimostrare di essere brava.
D. In politica, si è fatto, nei congressi del Pd, ma anche nelle preferenze alle europee, col sistema dei ticket, un uomo-una donna.
R. Forse si potrebbe assegnare un pacchetto di preferenze automatiche alle candidate e poi comunque contare le preferenze complessive, ossia stabilire dei goals anche in quel caso.
D. Sempre in tema di attualità, nel libro lei si spinge a riproporre le gabbie salariali che, nel nome dell'eguaglianza, furono abolite nel 1969.
R. Certo, perché con uno stesso stipendio a Milano o a Ragusa, dove il costo della vita è molto diverso, si finisce per pagare qualcuno il doppio.
D. Lo dice anche la Lega di Matteo Salvini.
R. Massì, perché la sinistra ha scelto da tempo di non occuparsi più di diseguaglianze. Lo scrivo nell'ultimo capito: l'eguaglianza è orfana della sinistra, per cui lascia ai radicali il compito di declinare quel tema in fatto di religione, o a certi circoli liberali quello delle diseguaglianze economiche che hanno a che fare col sistema degli ordini professionali.
D. È accaduto perché la sinistra, sulla via del riformismo, ha finito per smarrire una certa idealità?
R. Temo di sì. Norberto Bobbio diceva che l'eguaglianza è la sua stella popolare e invece la sinistra si occupa ormai del giorno per giorno, della pratica quotidiana, del mettere gli uomini nelle poltrone. E ignora questo tema.
D. Senta, siccome questo profilo di sinistra si presta a evocare Renzi, osservo che con gli 80 euro il capo della sinistra ha fatto, secondo alcuni, una grande operazione di redistribuzione, ossia di giustizia.
R. È vero, stando ai governi a guida di sinistra, nessuno aveva messo in pista un'operazione così imponente, perché si è trattato di alcuni miliardi. Però...
D. Però?
R. Però è anche vero che si è data una banconota a una categoria più garantita di altre. C'è tutta una classe di persone senza reddito, che non incassano gli 80 euro. Come se si trattasse di persone perdute, non recuperabili. A meno che il messaggio non volesse essere anche di dare un po' di ossigeno al ceto medio.
D. Che lei, citando Amartya Senn, ricorda essere il motore della democrazia. Sempre sulla politica, lei rammenta le diseguaglianze diffuse fra elettori ed eletti. E cita il famigerato «uno vale uno» grillino.
R. Un'utopia inattuabile, però non sarebbe male arrivare almeno a «uno e mezzo vale uno», ossia bisognerebbe fare qualcosa per ridurre la distanza fra chi governa e chi è governato.
D. Propone di limitare i mandati, cosa che in Italia non è contemplata.
R. E invece negli Stati Uniti è rigorosa ma lo si potrebbe anche fare armando i cittadini di strumenti di controllo autentici come i referendum abrogativi che, da noi, sono figli di un Dio minore: il voto popolare, come nel caso dell'abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti, può essere anche frodato.
D. Lei parla anche del cosiddetto recall, previsto in America e in Svizzera, ovvero la possibilità di richiamare gli eletti, praticamente di dimissionarli, quando indegni o inefficaci.
R. In maniera regolata, con una parte importante, circa un quarto, degli elettori, in modo che non siano a deciderlo tre persone al bar, e in un certo periodo, evitando così che non sia possibile innescare il meccanismo, da parte di chi perde, a pochi giorni dal voto.
D. Le devo fare anche io la domanda sulla legge elettorale, professore.
R. Prego...
D. Che tasso di ingiustizia c'è in questo Italicum, che alcuni vedono come il fumo negli occhi? R. Non entro nelle questione dei premi di maggioranza, ma osservo che avremo un partito col 54%, da una parte, e, dall'altra, una marmellata di partiti di minoranza perché, con una soglia al 3%, potranno entrare in tanti. Sarebbe stato meglio uno sbarramento dell'8%.
D. Ma non sarebbe stato più ingiusto?
R. Avrebbe ridotto e concentrato i partiti di opposizione e quindi creato una possibilità maggiore di controllo e di bilanciamento. Però, da costituzionalista, devo dirle che questa legge ha un altro problema, tale che Sergio Mattarella si potrebbe trovare in difficoltà a firmarla.
D. E quale, professore?
R. Che è tagliata su una camera elettiva quando, a oggi, ne abbiamo due. E la clausola di salvaguardia, che ne prevede l'applicazione solo dopo il 2016, non regge. Nessuno può garantire che, a quella data, la riforma del senato sia andata in porto.
D. Un libro, professore, che contiene molti ragionamenti politici, alla fine.
R. L'altro giorno, presentandolo, Laura Boldrini, Giovanni Pitruzzella e Massimo Giannini mi hanno detto tutti, più o meno, che sembra quasi un manifesto politico.
D. E lei?
R. Ho tranquillizzato tutti. Non fondo un partito (ride).
L’ANTIPOLITICA E LE SUE VITTIME. IL PACIFISMO.
L’antipolitica ha fatto un’altra vittima: il pacifismo, scrive Piero Sansonetti su “Il Garantista”. Non si riesce a capire come mai in Italia non ci sia nessuna reazione politica alla guerra di Israele in Palestina. Non dico a livello di governo, o di diplomazie. Dico in piazza. Dove sono finiti i pacifisti, dove sono i movimenti, le associazioni, il popolo arcobaleno? Svaniti. Eppure l’Italia è sempre stata la terra d’elezione del pacifismo. Dagli anni Cinquanta. Prima perché c’era un fortissimo pacifismo anti-americano, guidato dal Pci, dai socialisti e anche dai radicali e dai laici di Capitini. Poi perché, dopo gli anni sessanta – con il Concilio, con Paolo VI e ancora con Woytijla – era cresciuto enormemente il pacifismo cattolico. Vi ricordate nel 2002 l’oceano pacifista che travolse Roma e scosse persino l’immaginazione del New York Times, che parlò di seconda potenza mondiale? Beh, roba del passato. Come mai? La spiegazione è molto semplice: l’avanzata inarrestabile dell’antipolitica. Noi magari talvolta pensiamo che l’antipolitica sia qualcosa che si oppone alle burocrazie, alle caste. Non è esatto. L’antipolitica si oppone alla politica, a tutta la politica, la detesta, la considera il male dei mali. E l’antipolitica si diffonde, si insinua nello spirito pubblico, lo modifica, cambia il senso comune e il modo di pensare del popolo. Non sono solo i signoroni del governo, i deputati, le vittime dell’antipolitica; sono anche i movimenti, le passioni dei movimenti, le capacità di analisi dei movimenti, delle associazioni, dei gruppi rivoluzionari. Pagano all’antipolitica lo stesso prezzo che pagano i ministri. Non c’è più la mobilitazione civile: c’è il vaffanculo. Non c’è più il grido di lotta, c’è lo sberleffo, la maledizione. Non c’è più il pensiero, c’è l’ira. Non c’è più il manifesto di Rossanda, Pintor, Gagliardi, Parlato. C’è Il Fatto. Guidato da un allievo di Indro Montanelli e del giudice Woodcock.
IL PARTITO INVISIBILE. ASTENSIONISMO, VOTO MIGRANTE E VOTO DI PROTESTA: I MOTIVI DI UNA DEMOCRAZIA INESISTENTE.
50% circa di astensione al voto; 5% circa di schede bianche o nulle; 25% di voti di protesta e non di proposta ai 5Stelle. Solo il 20% di voti validi (forse voti di scambio). Chi governa ha solo un elettore su 10 che lo ha scelto e si vanta pure di aver vinto. Che cazzo di democrazia è?
Elezioni 2015. Il partito invisibile, scrive Alberto Puliafito, direttore responsabile di "Blogo.it" e Carlo Gubitosa su “Polis Blog”. Un viaggio nel mondo di tutti coloro che non vengono raccontati dalla comunicazione politica, che non vengono rappresentati, che non votano. Dopo il voto regionale, la comunicazione politica si è concentrata, come al solito, su "chi vince". E hanno vinto tutti, chi per un motivo chi per l'altro. Noi, per un primo commento, ci siamo concentrati su chi ha perso. E fra i motivi della sconfitta annoveravamo l'impressionante tasso di astensionismo. I dati che proponiamo qui, grazie al lavoro di Carlo Gubitosa, dovrebbero, secondo chi scrive, essere pubblicati ovunque. Il giornalismo dovrebbe, una volta per tutte, dedicare i propri titoli alle rappresentazioni numeriche realistiche della situazione della rappresentanza politica in Italia, invece di rincorrere le dichiarazioni di Renzi, Grillo, Salvini o altri. Invece di pubblicare i tweet con il presidente del consiglio che gioca ai videogiochi, sapientemente diffusi da chi si occupa di comunicazione per conto di Palazzo Chigi, le gallery per fare click potrebbero essere, senza alcun problema – lo sappiamo che i click vanno fatti – gallery di grafici come questi. Guardare quelle fette grigie di non rappresentati fa rabbrividire ma è necessario per impostare una narrazione giornalistica corretta. Ecco perché, quando Carlo mi ha proposto questo lavoro, ho accettato con entusiasmo. Per offrire un servizio ai nostri lettori e per imparare io stesso. Questo è vero data journalism. Per i partiti contano i propri voti, per la politica contano solo i voti validi, per il ministero dell'interno contano solo gli elettori. E se invece provassimo a contare le persone? I grafici che nessuna formazione politica vorrà mai mostrarvi rivelano il peso numerico della "maggioranza invisibile", quella che non può, non vuole o non sa indicare una rappresentanza nelle urne. Sono gli astensionisti, i delusi dalla politica, ma anche gli stranieri e i minori, una fetta di popolazione che diventa “invisibile” nei sondaggi, nel dibattito politico e nelle analisi post-voto. Abbiamo provato ad analizzare i dati ufficiali del voto alle regionali incrociandoli con i numeri dell’ISTAT e aggiungendoci una semplice curiosità di partenza: scoprire cosa succede se oltre ai SEGGI ASSEGNATI e ai VOTI VALIDI misurati dalle percentuali iniziamo a contare anche i VOTI TOTALI (includendo anche chi ha votato scheda bianca, nulla o annullata), il NUMERO TOTALE DI ELETTORI (includendo anche chi è stato a casa), e anche il NUMERO TOTALE DI RESIDENTI, stranieri inclusi (per contare anche chi subisce le conseguenze delle decisioni politiche senza esercitare il diritto di voto). Per semplificare l’analisi del voto, operare una indispensabile sintesi sulla varietà di liste e di coalizioni presenti nelle varie regioni, abbiamo individuato sette macroblocchi politici per il conteggio dei voti validi: Renzisti - Berlusconiani - Salviniani - Grillisti - Sinistra - Destra - Altri. Sono state introdotte delle approssimazioni per eccesso che sovrastimano l’affluenza alle urne, ad esempio contando come due elettori anche il “voto doppio” espresso da una stessa persona per una lista e per il candidato presidente. Anche con queste approssimazioni, tuttavia, la consistenza numerica dei “non rappresentati” resta notevole. Trattandosi di nostre elaborazioni su dati ufficiali (con la fatica di dover trasporre numeri strappati a fatica da PDF, pagine web e ogni tipo di dato in formati non aperti che la pubblica amministrazione e’ stata in grado di produrre) non possiamo escludere refusi ed errori, e ringraziamo in anticipo tutti quelli che vorranno segnalarci eventuali imprecisioni.
La Campania e il partito della scheda bianca. Nel disinteresse generale (tanto le poltrone si sono già spartite) a ben quattro giorni dal voto arrivano i dati definitivi della Campania, dove chi conta le persone e non le poltrone registra 170mila tra schede bianche e nulle, un partito che vale il 7% dei voti validi, ben più del valore previsto dal sistema elettorale campano come soglia di sbarramento per le liste. Potremmo chiederci se questo 7% di Campani è composto da quella gente egoista, pigra e disinteressata alla cosa pubblica descritta dai partiti che fomentano l'astensionismo per poi demonizzare chi lo pratica, o più semplicemente si tratta di persone a cui è negata rappresentanza politica e quel minimo di alfabetizzazione necessaria a non farsi annullare la scheda. Un dettaglio interessante per la Campania è quello della lista "SINISTRA AL LAVORO", l'unica lista tra quelle esaminate finora ad avere un numero di preferenze inferiore a quelle ricevute dal candidato governatore, presumibilmente frutto di un voto disgiunto che ha indicato come candidato presidente quello di un grande partito di massa con maggiori probabilità di vittoria, ma ha voluto comunque esprimere un voto "ideologico" con preferenze di lista collocate nettamente a sinistra. A quanto pare, quando si tratta di scegliere un candidato col voto "utile" l'elettorato si sposta verso il centro e verso i partiti acchiappavoti, ma il nostro panorama politico potrebbe essere ben più variegato se si potesse esprimere un "voto di orientamento" per chi ci convince, in abbinamento al "voto utile" per chi ci dà maggiori probabilità di vincere. E' quello che nell'era pre-italicum e pre-porcellum avveniva col voto proporzionale di lista, che nel vecchio sistema elettorale si affiancava al voto maggioritario come "correttivo".
Il Veneto e il suo invisibile "partito migrante". In Veneto il dato di rilievo è il "partito dei senza voto", quel 21,9% di persone che pur vivendo in quella regione non può votare perché non ne ha ancora il diritto o perché essendo straniero quel diritto non ce l'ha mai avuto. Un blocco di elettori pressoché equivalente al 22,9% di astensionisti, a sua volta speculare al 22,9% di Salviniani, dove la componente migrante pesa per il 12,4% della popolazione residente, più del consenso raccolto dal PD che in questa regione si ferma al 12,1%. Il dibattito politico ci mostra a seconda degli schieramenti il ritratto di una regione Leghista, o di una regione dove trionfa il disimpegno e l'astensionismo, ma nessuna delle "fotografie politiche" mostrate dai mezzi di comunicazione di massa si allarga ai dati sull'intero insieme della popolazione, per mostrare la fotografia di una regione dove un veneto su cinque non può esprimere rappresentanza politica, e il 12,4% della popolazione residente con tutta probabilità sarebbe ben contento di prendere le distanze sia dal blocco leghista che da quello astensionista, esprimendo un "voto migrante" che molti temono, qualcuno auspica, ma nessuno si decide a garantire. Nel frattempo un qualunque italiano che si trasferisce in uno dei paesi dell'eurozona può istantaneamente godere di tutti i diritti civili e politici del paese che lo ospita, anche se non vi aveva messo piede fino al giorno prima, diritti che invece sono negati ai "veneti col passaporto sbagliato", anche se vivono e lavorano in Italia da anni.
Elezioni comunali 2015, l’Italia senza quorum: ecco i paesi allergici alle urne, scrive “Il fatto Quotidiano”. A Castelvecchio Calviso, in provincia dell’Aquila, si è registrato uno solo voto valido e quattro schede bianche a fronte di 277 potenziali elettori. A Platì e San Luca, due centri reggini sciolti per mafia vince l'astensione: non si presentano candidati, figurarsi gli elettori. Nel Vibonese, a Spilinga, solo uno su dieci va a votare. E il sindaco non viene eletto. C’è un’Italia senza quorum. Mentre si affastellano analisi e reazioni sul dopo voto un piccolo pezzo di Paese ha preso il largo dalla politica. Sono i cittadini di piccoli e medi comuni che nel dieniego dell’urna hanno ingrossato il dato dell’astensione, fino a produrre risultati emblematici e paradossali. Tra i tanti spicca Castelvecchio Calviso, in provincia dell’Aquila, dove si è registrato uno solo voto valido e quattro schede bianche a fronte di 277 potenziali elettori. Cinque voti in tutto. Quorum, non pervenuto. Accade anche questo alle amministrative in Abruzzo: colui che, peraltro, era l’unico candidato, Roberto Di Pietrantonio della lista civica “Tricolore”, ha incassato un solo voto valido, a fronte di 2 schede bianche e 2 nulle. Il piccolo centro montano dell’Aquilano dovrebbe quindi essere retto da un commissario prefettizio reggente fino a nuove elezioni. Non è l’unico caso. Questa tornata è stata un tripudio di candidati, con quasi mille aspiranti consiglieri solo in Puglia. Ci sono comuni con numerosi candidati a sindaco, ma anche tanti comuni dove i candidati si contano sulle dita di una mano e anche meno. In Sicilia, ad esempio, c’è ne sono addirittura due con un unico candidato per comune. Si tratta dei candidati di due comuni del palermitano: Domenico Giannopolo, a Caltavuturo, e Giuseppe Abbate, a Lascari. Per potere essere eletti andava superato il quorum dei due comuni. E il quorum è stato raggiunto in entrambi i comuni del palermitano. Passando alla Lombardia il caso più strano, forse, è quello dei quattro candidati unici nessuno dei quali ha raggiunto il quorum. Sembrava una vittoria facile invece Daniele Boldrini, l’unico candidato sindaco che si è presentato alle elezioni a Brezzo di Bedero, comune con circa 1.200 abitanti della provincia di Varese, non è stato eletto per mancanza del quorum. E lo stesso è accaduto a Claudio Terzi che era l’unico in lizza a Filago nel Bergamasco, a Mario Locatelli, che correva da solo a Locatello (Bergamo) e a Massimiliano Sacchi a Giussago (Pavia). Vai a sapere il perché. Sono invece note le ragioni che hanno portato in Calabria a un risultato pari a zero: nessun sindaco è stato eletto in due comuni sciolti per mafia. Il turno elettorale del 31 maggio non ha portato all’elezione di un’amministrazione comunale a Platì e San Luca, due dei diversi centri reggini dove si tornava alle urne dopo un periodo di commissariamento a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. A Platì non sono state presentate liste, mentre a San Luca ne era stata presentata una ma non ha raggiunto il quorum. Il 43,09 per cento dei cittadini che si è recato alle urne non è stato sufficiente a decretare sindaco Giuseppe Trimboli, a capo di una lista civica. Nell’unico comune capoluogo al voto, Vibo Valentia, a poche sezioni da scrutinare alla fine, Elio Costa si impone con oltre il 50 per cento sugli altri candidati, distaccando di oltre dodici punti il candidato de Pd Antonio Lo Schiavo. Tra i comuni con oltre quindicimila abitanti, a essere eletto con l’82,04 per cento è Pietro Fuda a Siderno (Reggio Calabria). Politico di lungo corso, era sostenuto dal centrosinistra. Primo partito nella cittadina jonica è il Centro Democratico che supera di poco il Pd. Vince l’Italia senza quorum anche a Spilinga, secondo quanto riporta il sito del Ministero dell’Interno, non si è raggiunto il quorum del votanti e le elezioni comunali non sono valide. L’unico candidato sindaco era Francesco Dotro, con la lista civica Insieme per Spilinga. Gli elettori complessivi sono 1.884 ed i votanti sono stati 576, pari al 30,57%. Dotro ha ottenuto 552 voti. Dieci le schede bianche e 14 le nulle. I cittadini, nonostante i movimenti estemporanei come i 5 Stelle che attraggono i voti di protesta, non vanno a votare e molti di quelli che ai seggi ci vanno presentano scheda bianca o, addirittura, annullano la scheda con segni di disapprovazione e scherno. Il messaggio è chiaro. Perché schifati dagli impresentabili presentati e/o da una democrazia ”virtuale” costruita nei salotti televisivi e dai TG in barba a qualsiasi forma di democraticità della comunicazione elettorale. Senza elettori non c’è democrazia e l’attuale offerta politica che c’è sul campo non riesce ad attrarre e a convincere gli elettori che non vanno più a votare. Altre offerte politiche sul campo sono ignorati, pur avendo una specifica proposta politica utile – se solo fosse possibile conoscerla e discuterla – a far uscire il Paese dalla sua ”flagranza criminale”. Vero è come «media di regime asserviti al governo» (ma io direi al regime della partitocrazia), hanno la gravissima responsabilità di negare – in modo sistematico – agli italiani di conoscere le proposte politiche di riforma e le visioni di nuovi leader. Tutto ciò porta il singolo, non avendo la forza dirompente, ad avere disgusto.
Il disgusto che porta a non andare più a votare. L'astensionismo è il vero vincitore delle elezioni regionali. E colpisce anche le regioni rosse, ma sono sempre di più quelli che ritengono la politica italiana impotente e incapace di risolvere i problemi. Mentre i flussi elettorali spiegano che i travasi di voti tra i partiti sono limitati. Il vero vincitore delle elezioni regionali 2015 è stata l’astensione, scrive Alessandro D’Amato su Next Quotidiano”. Su quasi 19 milioni di elettori chiamati alle urne, appena il 45%, 8 milioni e mezzo, ha espresso un voto valido ad una lista; oltre 9 milioni, il 48%, si sono astenuti. E la tendenza al non voto diventa sempre più impressionante nella crescita dei numeri, e comincia a colpire anche le aree più affezionate al rito elettorale. In queste tabelle pubblicate oggi da Repubblica l’Istituto Cattaneo analizza storicamente la crescita dell’astensione al voto dalle Regionali del 2010 fino a quelle del 2015 nelle regioni chiamate al voto. I ricercatori dell’Istituto Cattaneo Dario Tuorti e Maria Regalia hanno messo insieme le serie storiche del voto regionale confrontandolo con quello per le politiche ed europee. E alla fine cifre e grafici rivelano che l’astensionismo alle Regionali è ormai di lunga durata. Ma soprattutto che domenica si è manifestato in maniera più forte nelle “regioni rosse”. Il primato è della Toscana, dove rispetto alle politiche del 2013 c’è un calo dell’affluenza del 30,9%. Il raffronto con le Europee dell’anno scorso dice meno 18%. Anche nelle Marche manca all’appello il 30% per cento dei votanti delle politiche e il 15,8% delle Europee. E in Umbria le due percentuali dicono meno 24,1% e meno 15,1%. E anche in Liguria la disaffezione si è fatta sentire con un meno 10 per cento rispetto alle due precedenti tornate elettorali. Tuorti spiega che «il fenomeno si spiega con il fatto che in queste regioni c’erano aspettative molto elevate che sono state tradite. Ovviamente incidono anche la crisi che va avanti dal 2008 e gli scandali che hanno colpito i consigli regionali, la delegittimazione complessiva dell’istituto regionale». E in effetti, dicono al Cattaneo, anche se potrebbe sembrare un paradosso, gli elettori oramai percepiscono più importanti le elezioni Europee che quelle regionali. Interessante anche il ragionamento dei ricercatori dell’Istituto a proposito delle regioni del sud: «Nel passato – spiega Tuorti . una certa astensione esprimeva una forma di protesta verso il partito di appartenenza, un messaggio di disapprovazione. C’era insomma una forma di partecipazione attiva anche nell’astensione e si poteva tranquillamente tornare a votare al turno successivo». Oggi, continua il ricercatore del Cattaneo «siamo di fronte ad una massa di elettori che scivolano dall’astensionismo “attivo” verso l’altra forma, quella dell’apatia che tende a tenerli costantemente lontano dai seggi. I cittadini cominciano ad essere sempre di più disillusi davanti alla mancanza di risposte».La cosa grave di questo fenomeno -continua il ricercatore del Cattaneo, «è che l’astensionismo non è distribuito equamente fra le diverse fasce degli elettori,ma rappresenta solo certe fasce sociali che coinvolge disoccupati, marginali non garantiti». Ancora più interessante è l’analisi dell’istituto Demopolis presentata ieri a Otto e Mezzo nel Punto di Paolo Pagliaro. Nella prima tabella si nota che anche nel computo dei votanti c’è chi ha scelto di votare solo per il governatore o ha espresso un voto non valido. Si tratta del 7% del computo totale dei voti, e anche qui si tratta di persone che hanno scientemente deciso di non votare per un partito pur presentandosi alle urne. Ancora più interessante è la tabella delle motivazioni che fa parte dell’analisi dell’istituto. Il 40% ha deciso di non andare a votare perché, a suo parere, la politica in Italia non incide più sulla vita reale dei cittadini. E qui sarebbe interessante chiedere a chi ha risposto in questo modo se invece ritiene che la politica europea sia più incisiva di quella italiana nella vita dei cittadini: la sintesi del ragionamento sarebbe stata più interessante. Il 27% invece dice che non si sente rappresentato dai partiti votati in precedenza, mentre il 25% ha scarsa fiducia nei candidati a livello locale. Rimane un buon 8% che dice che l’esito delle elezioni appariva scontato, e quindi probabilmente si presenterà alle urne in occasioni in cui ci sarà un maggiore equilibrio alle urne o si voterà per le elezioni politiche. Infine, l’istituto Demopolis analizza i flussi elettorali del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle e della Lega di Salvini: Quasi tutte le liste sono risultate fortemente penalizzate dall’astensione in termini di voti assoluti. Secondo l’analisi dei flussi elettorali e sugli spostamenti del consenso, realizzata dall’Istituto Demopolis, su 100 elettori che avevano scelto il PD alle Europee del maggio scorso, 62 hanno rivotato nelle 7 Regioni il partito di Renzi o le liste dei candidati Presidenti; 8 hanno preferito altre liste, 3 elettori su 10 hanno optato per l’astensione. Quadro non dissimile quello del Movimento 5 Stelle: 6 su 10, tra quanti avevano votato Grillo alle Europee, hanno confermato il voto al Movimento alle Regionali, 11 su 100 hanno scelto altre opzioni; 29 su 100 sono rimasti a casa. L’Istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato la composizione del consenso al partito di Salvini in base al voto espresso alle Europee: su 100 elettori odierni alle Regionali (quasi un milione e 300 mila incluse le liste Zaia), poco più di 500 mila avevano già scelto la Lega un anno fa. 8 su 100 avevano votato il M5S, 5 il PD, 14 altre liste o si erano astenuti. Secondo l’analisi post voto di Demopolis, 33 su 100 degli attuali elettori leghisti avevano scelto Forza Italia alle Europee. Un flusso che conferma, anche a livello regionale, i mutati equilibri nell’area di Centro Destra.
Vince l’astensione: siamo noi giovani a non votare più. Il partito dell'astensione cresce a ogni elezione di più. Ma è un problema che va affrontato, perché riguarda soprattutto i più giovani. Troppo lontani dalla politica, scrive Michele Azzu su "Fan Page". “Il vero vincitore è l’astensionismo”, anche a queste elezioni regionali ripeteremo questa solita frase fatta per chissà quanto tempo. Frase che, elezione dopo elezione, sembra sempre più veritiera. Alle elezioni regionali di Veneto, Campania, Marche, Umbria, Toscana, Puglia, Liguria ha votato solo il 51.4 per cento degli aventi diritto. Nel 2010 era il 64 per cento: si sono persi il 10 per cento di voti. Una persona su due non ha votato, e questa volta non è stato certo per colpa del bel tempo e delle gite di primavera: nel fine settimana ha piovuto in quasi tutto il paese. È un dato che fa spavento. Confrontiamolo coi dati delle più recenti votazioni del nostro paese. Lo scorso novembre si votava alle regionali in Emilia Romagna e Calabria. Anche in quel caso l’affluenza al voto fu bassissima: in Emilia Romagna votò il 37.7 per cento contro il 68 delle elezioni precedenti, e contro il 70 per cento delle europee di solo sei mesi prima. Sono 30 punti percentuali in meno. In Calabria a votare furono il 43.8 per cento degli aventi diritto contro il 59 per cento del 2010 (15 per cento in meno). Alle scorse elezioni europee, invece, l’affluenza fu più alta: circa il 60 per cento degli aventi diritto. E alle scorse elezioni politiche? Quelle del giugno 2013, in cui vinse per un soffio il PD guidato da Pierluigi Bersani che poi però non andò mai al governo. In quell’occasione, votò il 55 per cento degli elettori rispetto al 62.6 per cento di cinque anni prima, nel 2008. Le elezioni hanno ormai imparato a convivere con alti tassi di astensionismo. E allora, se va così dappertutto, forse è un segno dei tempi. Chi non vota rinuncia coscientemente a un proprio diritto – dirà qualcuno – e allora perché porsi il problema? L’astensionismo è un problema perché il dato della disaffezione al voto riguarda principalmente i più giovani. Certo, è ancora presto per avere i dati precisi da queste votazioni, ma sappiamo già che è a loro che riguarda questo 48 per cento di astensione. Ce lo dicono i dati delle elezioni più recenti. Alle recenti elezioni europee – quelle del tanto sbandierato 41% di consensi al PD – trionfò proprio l’astensione dei giovani. Mentre, come dicevamo, il dato di affluenza rimase discreto, con circa il 60% di votanti, in tutta Europa solo il 28% dei giovani europei andò a votare. “Le elezioni europee del 2014” hanno mostrato che esiste ancora un alto livello di astensione, con solo il 28% dei giovani fino ai 25 anni che si è recato a votare”, commentava Johanna Nyman, presidente dell’European Youth Forum. In Italia solo il 40% dei giovani è andato a votare alle europee. E alle politiche? Secondo il Centro Italiano di Studi Elettorali, alle ultime politiche del 2013 l’astensione ha riguardato principalmente i giovani. “Con l’eccezione di Torino, emerge che i neoelettori sono stati più propensi all’astensione”, scrive l’ente accademico. “In misura marginale nella capitale, più significativa a Milano e Firenze e ancor più spiccata a Palermo. Nel capoluogo siciliano, quasi la metà dei cittadini fra i 18 e 24 anni ha deciso di astenersi”. in foto: l'astensione dei giovani alle elezioni europee 2014 Anche il presidente del Senato Pietro Grasso si è rivolto in questi giorni ai più giovani, invitandoli a votare: "Alcuni di voi domenica saranno chiamati per la prima volta ad esprimere il proprio voto alle elezioni amministrative: fatelo, non lasciate che siano altri a decidere per voi". Ma non c’è niente da fare: ai più giovani votare non interessa. È davvero così difficile capire perché? Così come per la elezione del Presidente della Repubblica, il momento del voto non viene ritenuto capace di cambiare qualcosa di significativo nella vita di tutti i giorni, e viene vissuto come una cosa lontana e irrilevante. Una scocciatura. Ma cosa è ritenuto rilevante dai giovani d’oggi? Se è difficile capire perché i giovani si disinteressano della politica, e del voto, forse possiamo chiederci cosa interessa i giovani. Una recente ricerca del programma Erasmus – che da ormai 20 anni permette ai giovani universitari di studiare per un anno in un altro paese dell’Unione Europea – ha di recente pubblicato i risultati di un sondaggio esteso alla popolazione di ex e attuali studenti migranti. Giovani laureati e di respiro europeo, insomma, proprio quelli da cui ci si aspetterebbe un interesse alla politica. Secondo i risultati del sondaggio le priorità dei giovani Erasmus sono crescita e posti di lavoro, col 60 per cento di preferenze. Al secondo posto vengono le preoccupazioni sui cambiamenti climatici. Al terzo posto la lotta alla corruzione. Dati molto simili a quelli raccolti durante le ultime elezioni politiche italiane dalla campagna “Io voto”, realizzata dall’emittente televisiva Mtv. Secondo cui il 74 per cento dei giovani associa la politica alla corruzione, il 67 per cento a una sensazione di disgusto. Per il 60 per cento la classe dirigente italiana è considerata: “anacronistica e incapace di rinnovarsi”. L’astensione al voto cresce ogni elezione di più. E riguarda principalmente i giovani. Laureati, occupati, disoccupati, nelle grandi città come alla provincia del sud. Cambia poco. Perché ai giovani, oggi, interessa porre fine alla corruzione, interessa trovare lavoro, e migliorare le condizioni in cui si lavora. Ai giovani interessa porre riparo al riscaldamento globale che sta modificando la temperatura del pianeta, e quindi la fuoriuscita dai carburanti fossili, la ricerca di stili di vita più sani. Di tutte queste cose nei manifesti elettorali non si è trovata traccia: non alle europee, non alle politiche più recenti, non a queste regionali. Perché la politica non parla ai giovani, non è fatta dai giovani, e ai giovani non pensa proprio. Non a caso il Movimento 5 Stelle rimane il primo partito fra i giovani. Perché è un soggetto nuovo, che ha fatto della lotta alla corruzione la propria bandiera, così come le battaglie per l’ambiente, e per il reddito di cittadinanza – anche se sul lavoro latita. Ma questo dato di astensione, prima ancora dell’esito negativo della Liguria, Campania e Veneto, non è una grande sconfitta per Matteo Renzi, che ha solo 40 anni e che doveva rottamare la politica dei vecchi e dei poteri forti? E riportare i giovani alla politica? Dalle regioni, fino al governo, passando per le europee, insomma, dove diavolo è la politica che dovrebbe interessare i giovani?
Votano pochi anche in Germania. In Italia non si vota per disgusto, in Germania per noia, scrive Roberto Giardina su “Italia Oggi”. Perché preoccuparsi dell'astensione di domenica scorsa in Italia? Avviene così altrove, perfino in Germania. Metà dei votanti è rimasta a casa? Claudio Velardi cita la Baviera, ma, per la verità, qui in Germania, all'ultimo appuntamento elettorale, l'astensione si è fermata al 46%. Comunque è vero, a casa della Merkel gli elettori sono sempre più pigri, nelle elezioni dei Länder, le regioni, si continua a calare, sfiorando il 50%. Soltanto che qui ci si preoccupa della pigrizia elettorale. I nostri politici fanno finta di niente. Ma le cause sono diverse: i tedeschi disertano le urne per noia, gli italiani, temo, per disgusto e rassegnazione. Nel '72, al primo voto anticipato nella storia della Repubblica Federale, che era una sorta di referendum su Willy Brandt e la sua Ostpolitk, andò a votare oltre il 90%. Nel 2013, al terzo round per Frau Angela, fu il 71,5, un 1,3 in meno rispetto a quattro anni prima. Ma l'esito era scontato: una Grosse Koalition, una grossa coalizione. E se i due grandi partiti si alleano dopo il voto, perché devo andare alle urne? Inoltre, il programma della sinistra socialdemocratica e dei conservatori della Cdu-Csu è diverso soltanto per sfumature. Quanti sperano che se nel 2017 ci sarà un cancelliere socialdemocratico cambierà la politica europea di Berlino, avrà un'amara sorpresa. Un'altra considerazione: la Germania è uno stato federale basato sulla storia. In Italia, la riforma delle regioni è stata abborracciata per populismo e per accontentare Bossi. I Länder corrispondono agli antichi stati tedeschi prima che Bismarck riuscisse a creare il Reich. Alcune regioni come la Baviera sono immense, e il Land meridionale ha un pil superiore a quello di Olanda e Belgio messi insieme. Altre sono minuscole come di Amburgo o di Brema, le città dell'Ansa. Da noi, le Repubbliche marinare hanno forse una coscienza, come dire?, nazionale più antica di un Molise. Dovremmo avere una regione delle Due Sicilie, e anche il Granducato di Toscana, mentre la Padania non è mai esistita (quando lo scrisse mio fratello, lo storico, credendo di dire un'ovvietà, fu minacciato di morte). Infine, le preferenze. Io, come ex abitante di Roma, non ero chiamato alle urne domenica. Ma se avessi dovuto votare in Liguria, o nel Veneto, o in Campania, sarei rimasto a godermi il weekend di tarda primavera a Berlino. Non avrei mai potuto votare per la signora Moretti, né per i suoi avversari. Neanche per la signora Paita a Genova, o per De Luca, in Campania. Anch'io sarei entrato nel branco degli astensionisti, ma per costrizione e non per libera scelta, per noia, o pigrizia. In Germania, a livello nazionale, il sistema del doppio voto è geniale. Il primo, va al partito, e con questo si eleggono i candidati presentati dai partiti, con una lista chiusa come tanto piace ai nostri leader che non sopportano i gusti degli elettori. Ma il secondo voto è personale per un candidato di nostro gradimento, anche di un altro partito. Allora la Cdu o l'Spd devono stare molto attenti nel compilare la loro lista, ed evitare di essere punite alle urne. Infine, il nuovo Senato che Renzi sostiene sfacciatamente di aver copiato dal Bundesrat tedesco, la camera delle regioni. Da noi sarà formato da senatori designati dall'alto, scelti nelle regioni. In Germania vi partecipano i rappresentanti dei Länder, che già fanno parte dei parlamenti regionali, in proporzione ai risultati locali. Il Bundesrat ha diritto di veto su tutte le leggi del Bund, la federazione, che hanno importanza locale. Quindi su quasi tutte, dai trattati firmati a Bruxelles alla proroga o chiusura delle centrali atomiche. Votando nelle regioni in momenti diversi, al Bundesrat si forma, di solito, una maggioranza di segno opposto rispetto al Bundestag, il parlamento federale. Per ogni legge, o quasi, il governo è dunque costretto a sentire il parere dell'opposizione. Si crea una sorta di Grande coalizione non ufficiale. Un voto di Land è influenzato ovviamente dalla situazione locale, ma nessun politico a Berlino oserebbe commentare ciò che non riguarda il governo centrale. Quando Schröder avviò la radicale riforma dello Stato sociale, dovette trattare con i cristianodemocratici. E quando la Merkel lo battè e divenne cancelliera, non poté, e neanche volle, riformare le riforme del predecessore, perché realizzate con il consenso del suo partito. Un sistema che favorisce la continuità. In Germania chi ha la maggioranza non fa quel che vuole, come si sostiene a parole in Italia. Ma questo principio non può essere garantito dalla legge. Dipende dalla coscienza democratica.
I GRILLINI CANTANO VITTORIA. MA ANCHE LORO FAREBBERO BENE A CHIEDERSI PER CHI SUONA LA CAMPANA, scrive Antonio de Martini su “Il Corriere della Collera”. Un lettore mi ha scritto ripetutamente invitandomi a commentare la vittoria del movimento cinque stelle alle recenti elezioni. Turani nel suo giornale presenta questi numeri:
1) Alle elezioni politiche del 2013 , nelle stesse sette regioni in cui si è votato, il movimento cinque stelle raccolse 3.274.571 suffragi.
2) Alle elezioni Europee del 2014 , sempre nelle stesse regioni, gli elettori scesero a 2.211.384.
3) Alle regionali appena trascorse i votanti 5 stelle sono stati 1.320.885.
Sempre che la matematica non sia diventata di parte anch’essa, il movimento 5 stelle non ha avuto un successo, ma una perdita di votanti che si sono dimezzati rispetto alla prima apparizione sulla scena politica. Molti cittadini cercano di illudersi e vedere in “ogni villan che parteggiando viene ” il messia salvatore che rimetta le cose a posto senza che ci si scomodi più di tanto. Un voto, una richiesta di favori e via….Ebbene, non è così. Non è più così. La tendenza chiara ogni giorno di più è che dal 1976 in poi la sola cifra in crescita alle elezioni è quella dei cittadini che si rifiutano di essere presi in giro da questi ladri di Pisa che di giorno litigano e di notte rubano assieme. I cittadini che si astengono dal voto e di cui tutti fingono di non capirne le motivazioni. Il Cardinale Siri ( arcivescovo di Genova, città che si appresta a subire l’ennesima delusione) – mi dicono – ebbe un bon mot: ” esiste personale politico di due tipi: quelli che rubano per fare politica e quelli che fanno politica per rubare. Da un po' vedo in giro solo questi ultimi”. Appunto. Arrestarli? Inutile. Sono più numerosi dei carabinieri e in costante crescita. Per uscire da questo maleolente pantano è necessario che tutti i cittadini – dopo aver fatto il proprio dovere – decidano di esercitare i loro diritti costituzionali partecipando alla vita nazionale in forma attiva, propositiva e continuativa. Ad ogni livello. Fino a che aspetteremo il “deus ex machina”, la “rigenerazione” ed altre minchiate consimili resteremo dove siamo. Tra tutte le soluzioni miracolistiche proposte, quella di far governare l’Italia da un gruppo di giovani somari è la più stravagante. I dirigenti della Nuova Repubblica dovranno essere selezionati uno a uno in base al sapere, all‘esperienza e sopratutto al carattere. Oggi si scelgono in base alla fedeltà, l’ignoranza e alla disponibilità al compromesso. La politica delle etichette (delle camicie, dei distintivi ecc) si addice ai prodotti commerciali, non alle persone.
L'utopia dell'onestà e la demagogia della proposta politica irrealizzabile, presentata come panacea di tutti i mali, sono le prese per il culo che il cittadino non tollera più.
Una Repubblica fondata sulla trattativa. Gli accordi tra Stato e criminalità vanno avanti da due secoli. Così i padrini si sono visti riconoscere la loro forza. Che ora si è spostata nell’economia, scrive Giancarlo De Cataldo su "L'Espresso". Ci sono in molti paesi delle fratellanze, specie di sette che diconsi partiti, senza riunione, senz’altro legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni, ora di far esonerare un funzionario, ora di proteggerlo, ora di conquistarlo, ora d’incolpare un innocente. Il popolo è venuto a convenzione coi rei”. Così scriveva, nel 1838, don Pietro Ulloa, Procuratore borbonico di Trapani. E Leonardo Sciascia poteva annotare, sconsolato, oltre cent’anni dopo: “Leggeremo mai negli archivi della commissione parlamentare antimafia attualmente in funzione, una relazione acuta e spregiudicata come questa?”. Se il popolo sia “venuto a convenzione coi rei”, e per mezzo di alcuni dei suoi più alti rappresentanti, lo stabiliranno i giudici di Palermo, chiamati ad accertare se vi fu, fra il ’92 e il ’93, una “trattativa” fra mafia e Stato, e se furono commessi dei reati. Ma la verità giudiziaria è un conto, quella storica un altro, e non sempre le due verità coincidono. I giudici sono obbligati ad attenersi agli atti, gli storici non conoscono questo limite. La Storia è una grande risorsa, non foss’altro perché quasi sempre, per comprendere il presente, è doveroso guardare al passato. E il passato - a partire da don Pietro Ulloa - ci insegna che, sin dagli albori dello Stato unitario fra settori dei pubblici poteri e organizzazioni criminali si instaurarono accordi occulti e inconfessabili. “Patti scellerati”, li definisce lo storico francese Jacques de Saint Victor. Non ne furono immuni i sovrani assolutisti prima dell’Unità, i governanti che succedettero a Cavour, appartenessero alla Destra o alla Sinistra storiche, e nemmeno qualche rivoluzionario. Si avvalsero della “collaborazione” delle mafie coloro che intendevano mantenere l’ordine e quanti auspicavano il cambiamento. E sempre, costantemente, si potrebbe dire ossessivamente, costoro furono combattuti, troppo spesso senza successo, da leali servitori dello Stato che, oltre a fronteggiare il nemico dichiarato, dovevano guardarsi le spalle da quello interno. Il termine mafia compare per la prima volta in un documento ufficiale nella relazione redatta nel 1865 dal prefetto (orvietano) di Palermo, Filippo Antonio Gualterio. “I liberali del 1848, i Borboni nella restaurazione, i garibaldini nel 1860, ebbero tutti la necessità medesima, si macchiarono tutti della istessa colpa”. Si legarono alla trista associazione malandrinesca, determinando un legame indissolubile fra mafia e potere (o contro-potere) politico. Gualterio lascia intendere che, infine, le cose dovranno cambiare, grazie al nuovo governo: del quale egli, ovviamente, fa parte. Per Gualterio, “mafioso” è chi si oppone al nuovo ordine, sia egli garibaldino, repubblicano, nostalgico dei Borboni o autenticamente criminale. E le sue parole, per un verso nobilmente allarmate, per un altro ambigue, sono l’ennesima rappresentazione di un’altra costante del rapporto fra mafie e poteri in Italia: ciò che potremmo definire “il buon uso della mafia”. È una partita che Gualterio ha giocato in prima persona quand’era patriota, con la stessa spregiudicatezza di tutti gli altri attori. Le bande di bonache e picciotti che scortano Garibaldi nella trionfale impresa dei Mille sono, a un tempo, squadre a protezione dei latifondisti improvvisamente convertiti al nuovo che avanza, aggregazioni para-mafiose ma anche espressione di un sogno sociale di riscatto, quasi rivoluzionario, che presto le fucilazioni sommarie di Nino Bixio e dei piemontesi trasformeranno in incubo. Negli stessi giorni, a Napoli, mentre il regime borbonico si sfarina, il ministro liberale Liborio Romano promuove la camorra a Guardia Civica: per evitare disordini, dirà lui, e c’è da credergli. Ma sta di fatto che Garibaldi, a Napoli, è accolto da una folla festante in cui si mescolano allegramente democratici e tagliagole. La mossa di Romano sancisce, ancora una volta, il ruolo “politico” del crimine organizzato e la necessità, da parte dei pubblici poteri, di trovare un accordo. A proposito dei rapporti fra politica e mafie nell’Italia postunitaria, c’è un paragrafo impressionante nella “Storia della Mafia” di Salvatore Lupo: “Il partito governativo non escludeva il delitto politico e il ricorso ad una sorta di strategia della tensione (...) con la finalità di favorire la divisione della sinistra criminalizzandone l’ala estrema e conquistando a una collaborazione subalterna il gruppo che privilegiava la difesa delle conquiste risorgimentali dai pericoli reazionari”. E per conseguire questo obbiettivo si agita lo spettro di congiure inesistenti, oppure se ne impiantano di autentiche grazie al ricorso a spregiudicati agenti provocatori. Si dà per scontato che, a fini politici, ci si possa avvalere di metodi criminali in accordo con un sistema che di per sé è già criminale. Sembra delinearsi, insomma, un copione che ricorrerà più volte: con i pubblici poteri che cambiano e le mafie che restano sempre se stesse. Viene da pensare alla repressione del movimento dei Fasci a fine Ottocento, alla collaborazione dei mafiosi allo sbarco anglo-americano del ’43, agli ancora oscuri risvolti della Strage di Portella della Ginestra del 1947, all’esecuzione taroccata del bandito Giuliano, alle morti per avvelenamento di Pisciotta e Sindona, all’ascesa cruenta dei Corleonesi, ai delitti eccellenti degli anni Ottanta, giù giù sino alle stragi del ’92-’93. Tutti esempi di “buon uso della mafia” o ci si può spingere oltre, e usarla, questa benedetta parola: trattativa? Nessuno, pure, la pronuncia mai in sede ufficiale. Ma qualcosa di simile, grazie a un evidente sinonimo, “transazione”, pure affiora, a scavare nel passato. È il 1875 quando il deputato (ex-magistrato) calabrese Diego Tajani, durante un infocato dibattito parlamentare, così definisce la situazione dell’ordine pubblico in Sicilia: “Là il reato non è che una transazione continua, si fa il biglietto di ricatto e si dice: potrei bruciare le vostre messi, le vostre vigne, non le brucio ma datemi un tanto che corrisponda alle vostre sostanze. Si sequestra e si fa lo stesso: non vi uccido, ma datemi un tanto e voi resterete incolume. Si vedono dei capoccia della mafia che si mettono al centro di taluna proprietà e vi dicono: vi garantisco che furti non ne avverranno, ma datemi un tanto per cento dei vostri raccolti”. Transazione: come quella fra prefetti e comandanti militari e banditi, ai quali, talora, si concedeva un salvacondotto perché ripulissero il territorio. Da altri banditi. Transazione. Con le mafie si possono fare affari, si può servirsene per l’ordine (o, alternativamente, per il disordine), e la cosa è sotto gli occhi di tutti. Impensabile che i vecchi malandrini non si siano resi conto, col tempo, di essere assurti, essi stessi, da compagnia di raccogliticci accoliti a “forza politica”. E la stessa sensazione di essere “potere”, o comunque di giocare un ruolo determinante negli assetti strategici della nazione, magari a colpi di esplosivo, traspare da più di un verbale degli odierni collaboratori di giustizia. Da qualche anno a questa parte, le mafie sparano di meno, e quindi, verrebbe da dire, sono più forti. L’accumulazione del capitale che garantiscono i proventi delle attività illecite è un fattore di potente condizionamento del gioco economico. Le “transazioni” sembrano essersi spostate dal piano dei rapporti con gli Stati a quello dei mercati finanziari. Il governatore della Banca d’Italia ha denunciato l’enorme danno arrecato dal fattore criminale agli investimenti stranieri in Italia. Ma le mafie sono da tempo un fenomeno transnazionale, globalizzate più rapidamente, e con esiti spesso più soddisfacenti, dell’economia “legale”. Bisognerebbe girare il monito a quei santuari del denaro che periodicamente patteggiano ingenti penali per aver chiuso un occhio (e a volte tutti e due) sui movimenti sospetti di capitali. A quanto pare, non disdegnano di “venire a convenzione coi rei”. Le mafie sono partite dalle campagne o dalle periferie, ma hanno risalito il mondo, scalandolo con estrema facilità. Eppure, restano sempre mafie. Quelle descritte da don Pietro Ulloa nel lontano 1838. È ancora Sciascia a rivendicare l’ultima parola: “Gli elementi che distingueranno la mafia da ogni altro tipo di delinquenza organizzata, l’Ulloa li aveva individuati. Questi elementi si possono riassumere in uno: la corruzione dei pubblici poteri, l’infiltrazione dell’occulto potere di un’associazione, che promuove il bene dei propri associati contro il bene dell’intero organismo sociale, nel potere statale”.
Onestà (e non solo) la risposta politica contro la corruzione. Dopo tante inchieste sulle malefatte degli amministratori, bisogna chiedersi perché nulla sia cambiato: come diceva Croce, non basta invocare le virtù personali, occorrono strategie adeguate, scrive Giovanni Belardelli su “Il Corriere della Sera”. «Di nuovo?». È questa la domanda che, di fronte agli sviluppi giudiziari dell’inchiesta «Mafia capitale», molti cittadini si sono fatti, sempre meno fiduciosi circa la possibilità che si possa ridurre l’intreccio tra politica e malaffare. È uno stato d’animo comprensibile, ma da superare: occorre chiedersi se non c’è stato anche qualcosa di sbagliato nel modo in cui, per tanti anni, abbiamo evocato la questione morale. L’appello all’onestà, tante volte ripetuto, non basta infatti di per sé a risolvere i mali della politica: e il sentimento «anti casta», pur animato da giustificato sdegno, ha diffuso nel Paese l’idea che della politica e dei partiti si possa fare a meno, per affidarsi alla magistratura. Così non è. E anche se la qualità del ceto dirigente, locale e nazionale, è evidentemente scadente (quanti sono coinvolti nelle inchieste sembrano spinti solo da miserabili aspirazioni di arricchimento), l’onestà personale non è, né sarà sufficiente a risolvere un problema di grave inadeguatezza politica. Dopo vent’anni di inchieste giudiziarie sulle malefatte dei politici e di denunce della corruzione formulate anche in sedi autorevolissime (dai più alti scranni della Repubblica al soglio di Pietro), ancora a questo punto siamo? Questo è ciò che mestamente devono essersi domandati tanti italiani, sempre meno fiduciosi circa la possibilità che si possa quanto meno ridurre l’intreccio tra politica e malaffare. È uno stato d’animo comprensibile ma che andrebbe superato, per cominciare a chiedersi se non ci sia stato anche qualcosa di sbagliato nel modo in cui per tanti anni abbiamo evocato la «questione morale». Una parte del mondo politico e dell’informazione, prevalentemente orientata a sinistra, lo ha fatto, ad esempio, accreditando l’idea che ad essere disonesti fossero gli «altri», i politici - e dietro di loro, si lasciava intendere, gli elettori - di centrodestra. Era l’idea di una frattura antropologica tra destra e sinistra che, prima ancora di Mafia Capitale, altri scandali bipartisan si sono incaricati di dimostrare infondata; ma è tuttavia un’idea cui una parte del Paese ha creduto a lungo, evitando anche per questo di riflettere seriamente sulle ragioni per cui in Italia guardiamo spesso con indulgenza e comprensione a certi comportamenti illegali. Osservò una volta Benedetto Croce che la «petulante richiesta» di onestà nella vita politica è l’«ideale che canta nell’anima di tutti gli imbecilli». Personalmente onestissimo, Croce non voleva certo fare l’apologia della disonestà in politica ma segnalare come l’appello all’onestà sia di per sé insufficiente a risolvere i mali della politica, che hanno anzitutto bisogno di rimedi - appunto - politici. Invece - ecco un altro errore di questi decenni - il sentimento «anticasta», pur animato da sdegno giustificatissimo per i privilegi e le malefatte del ceto politico, ha diffuso nel Paese l’idea che della politica e dei partiti si possa fare a meno, per affidarsi ai controlli e alle inchieste della magistratura, magari con un inasprimento delle pene cui pochi peraltro riconoscono una vera capacità dissuasiva. Le notizie che si vanno pubblicando sull’inchiesta di Mafia Capitale mostrano, al di là di quelle che saranno poi le risultanze finali dei processi e al di là della congruità (per molti dubbia) del riferimento alla mafia, la qualità scadente del ceto politico locale, romano e non solo. Come lasciano trasparire anche altre inchieste di questi anni, si tratta spesso di un personale politico (quasi esclusivamente maschile: sarà un caso?) privo di ogni aspirazione od obiettivo di natura politica, come non era invece nella Prima Repubblica, che avrà avuto molti difetti ma non questo. Quanti sono coinvolti nelle inchieste di cui si occupano i giornali in questi giorni sembrano infatti spinti in via esclusiva da miserabili aspirazioni di arricchimento personale: se non è (solo) il denaro, sono magari le assunzioni di parenti e amici (chi ne chiede due, chi tre, chi dieci). Il fatto è che un tempo l’accesso alle carriere politiche locali operava dentro un quadro di relazioni e controlli nazionali che ormai non esistono più o si sono indeboliti notevolmente. Tranne evidentemente nel caso delle primarie per il Pd, che però hanno spesso finito con l’esaltare proprio il potere e l’influenza dei «capibastone» (il termine era usato tre mesi fa da Fabrizio Barca in quella sua diagnosi sul Pd romano «pericoloso e dannoso» di cui forse i vertici del Nazareno avevano sottovalutato la drammaticità). Se le cose stanno così, i partiti - e in primo luogo, il principale partito di governo - non possono limitarsi alla (ovvia) esortazione affinché la giustizia faccia il suo corso, ma dovrebbero prendere delle decisioni politiche adeguate. Il Pd, in particolare, dovrebbe rendersi conto di quanto sia poco giustificabile agli occhi dell’opinione pubblica continuare a sostenere il sindaco Marino solo perché non personalmente coinvolto nell’inchiesta giudiziaria. Non c’è bisogno di citare ancora Croce per osservare che l’onestà personale non è sufficiente a risolvere un problema di grave inadeguatezza politica.
Nel paese dove è inutile essere onesti. La politica è da sempre incapace di fare pulizia prima che arrivino le inchieste giudiziarie. Così si arriva alle liste compilate con criteri discutibili, scrive Roberto Saviano su “L’Espresso”. Elezioni all'insegna del “in fondo sapevamo già tutto”, le Regionali di domenica scorsa. Certo, banalizzare l’esito del voto talvolta può essere un’operazione scontata, ma non in questo caso, in cui le premesse dicevano già molto. Ma non le premesse dei sondaggi, non i dibattiti sui giornali, non i comizi da talk show. Bensì gli umori in strada, i discorsi tra le persone, la delusione da bar. Eh sì, perché ormai le “chiacchiere da bar” è in questo che si sono mutate, in “delusione da bar”. Alla politica ormai si applica la stessa “sindrome Trapattoni” che il nostro paese conosce per il calcio: tutti allenatori e tutti delusi dalla classe politica. Abbiamo letto ancora una volta titoli come “Il vero vincitore è l’astensionismo” che mette in luce quel 52% di affluenza al voto che ormai non scandalizza più. E se in Italia la politica, tutta, non cambia rotta - ma evidentemente non lo farà - è un dato destinato a decrescere soprattutto se alle urne si è chiamati in una domenica di sole, la prima dopo freddo e pioggia. Ma cosa significa cambiare rotta? Significa forse non candidare “impresentabili”? Significa forse smetterla di assecondare le pulsioni più ancestrali come la difesa del proprio nido dallo straniero aggressivo ma soprattutto diverso? Significa smetterla di credere che determinate regole valgano per gli altri e non per noi? Significa pesare ogni parola, ogni esternazione pubblica, e farlo sul serio? Significa iniziare a dialogare con la società civile e farlo non mettendosi alla lavagna, gessetto in mano, a dare lezioni? Tutto questo, ma significa anche non dare per morta una forza politica quando non lo è: per 20 anni in Italia abbiamo visto vincere il berlusconismo senza davvero riuscire a spiegare al paese come potesse accadere. Il voto di scambio non può essere un alibi che la parte “buona” della società, dell’informazione e della politica trova ogni volta per giustificare le proprie incapacità. La vittoria di Giovanni Toti in Liguria dimostra quanto abbiamo visto ormai talmente tante volte da poterlo considerare in fondo un copione già scritto: una forza politica data per morta può farcela contro una forza politica data per viva, ma divisa. Ed ecco che Berlusconi è stato ancora una volta in grado di unire, assecondando utili convenienze come ai bei tempi. Tutti quanti a parole sono contro una fantomatica “Sinistra” che dal 1989 esiste solo nei discorsi e nelle fantasie del satrapo di Arcore. Ed ecco il PD, ancora una volta, ha consapevolmente perso in Veneto e la Liguria e ha vinto in Campania chiudendo tutti e due gli occhi sulla candidatura di De Luca. Ed ecco il M5S, che per la prima volta ha fatto campagna elettorale senza gli eccessi verbali di Beppe Grillo, ha recuperato parte del voto moderato e si è attestata come terza forza politica del Paese. A Napoli con un’unica lista ha sfidato due coalizioni ottenendo risultati encomiabili con 20 mila euro di campagna elettorale provenienti da donazioni private. Come accade che un movimento dato per defunto risorga dalle proprie ceneri, o meglio, dalle ceneri con cui lo avevano erroneamente ricoperto? Il M5S è nato come movimento di protesta e di cambiamento. Non essendo ancora mutato nulla, nonostante la rottamazione, resta un catalizzatore di consenso che si nutre di sfiducia verso tutto il resto. È l’unica forza politica ad aver mantenuto fermo un punto essenziale: candidare solo chi non abbia pendenze giudiziarie. Per un garantista come me non è ammissibile pensare che se sono sotto processo perché il mio cane avrebbe morso un passante e ancora non sono stato né assolto né condannato, questo possa rappresentare motivo di incandidabilità. Ma l’umore in Italia è questo: “Se hai problemi con la giustizia, senza entrare nel merito, noi non ti vogliamo a rappresentarci. Punto”. Alla fine si è diventati più realisti del re, a causa dell’incapacità che la politica italiana ha da sempre di fare pulizia prima che arrivino inchieste giudiziarie o Commissioni parlamentari antimafia. Perché alla fine non basta più il buon senso, ma occorre, per catalizzare fiducia, ricorrere a metodi estremi. E ormai anche io, da osservatore, non so davvero se temere di più la retorica dell’onestà o che si realizzi quanto disse Corrado Alvaro: «La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile».
La finanza, gli impresentabili e i parrucconi, scrive Nicola Porro su “Il Giornale”. Questo paese di parrucconi è veramente una schifezza. Parrucconi buoni solo a declamare principi favolosi di onestà, correttezza ed eticità ci sono sempre stati per carità. Il problema è che abbiamo sempre pensato che sotto queste profumate parrucche, si celassero solo teste di rapa. Alzi la mano chi è a favore della disonestà? Faccia un passo avanti chi è favore della corruzione? Nessuno è ovvio. Il nostro parruccone moderno fa di più, questiona i quarti di nobiltà. Tipo alla Caccia. Vabbè tutti sapete della genialata democratica della commissione antimafia, guidata da Rosy Bindi. Non è pietanza da Zuppa, ma nel Giornale se ne parla. Eccome. Mentre la Bindi e soci si incipriavano la parrucca, anzi il parruchino, pensando a chi potesse entrare nella lista degli impresentabili, a Roma si teneva l’assemblea dell’Enel. Una delle più importanti società italiane e tra i leader mondiali dell’energia elettrica. Cosa decidevano gli azionisti dell’Enel? I soliti conti e ricchi dividendi. Ma anche (brevina sui giornali) di allentare la cosiddetta clausola di onorabilità dei propri amministratori. In sostanza, fino a ieri, se un membro del cda dell’Enel fosse stato raggiunto da un avviso di garanzia e poi rinviato a giudizio, si sarebbe dovuto dimettere subito dalla società.. Ebbene ieri l’assemblea, quasi al 100 per cento, approvava l’allentamento della norma: non basta il semplice rinvio a giudizio, ma è necessaria almeno una condanna in primo grado. Tutto bene quel che finisce bene dunque. Mica tanto. E così ritorniamo alle parrucche. Questa assurda clausola societaria non è stata introdotta ai tempi del fascismo, ma l’anno scorso dal ministro del Tesoro di Renzi. Gli uomini di Padoan, in rappresentanza appunto delle quote detenute in Enel, Eni, Finmeccanica e Terna, si erano presentati nella primavera del 2014 nelle assemblee delle società partecipate proponendo l’introduzione negli statuti della tagliola. Tutte le più importanti società avevano poi bocciato la proposta del Tesoro in assemblea. All’Enel ciò non avvenne, anche perché in quell’assemblea c’era rappresentato solo il 52% del capitale e il Tesoro da solo ne deteneva più del 30. L’enel fu l’unica dunque a diventare il fenomeno della legalità. La baggianata era talmente grande che i fondi internazionali, quelli che una certa pubblicistica avrebbe voluto a favore di questa norma statutaria, votarono in maggioranza contro alle volonta etiche del Tesoro. Chiunque abbia parlato con questi investitori sa che sono più preoccupati del funzionamento della giustizia italiana (che non nega un rinvio a giudizio a nessuno) che dell’onorabilità dei manager delle grandi società quotate. L’Enel peraltro ha poi applicato questa norma ad un suo consigliere rinviato a giudizio (Salvatore Mancuso) che con il nuovo statuto approvato ieri non avrebbe dovuto fare alcun passo indietro. Ora infatti serve come minimo una condanna. Qual è la morale di questa storia? Da parrucconi. Perché il tesoro del governo Renzi l’anno scorso fa il giustizialista con le sue partecipate (colpo che gli riesce solo all’Enel dove i fondi internazionali non riescono ad opporsi) e dopo solo un anno fa marcia indietro? Non che la norma fosse meno assurda nel 2014: da Scaroni, all’epoca all’Eni, ai grandi gestori dei fondi, tutti avevano spiegato la pericolosità della norma a Renzi&co. Eppure gli uomini di Padoan continuarono per la loro strada, per poi cambiarla, alzando la manina in assemblea, un paio di giorni fa. Ritornando al principio. Viene da pensare che il Tesoro nel 2014 si sia comportato come la Commissione Bindi (quella che si dovrebbe occupare di mafia) si comporta oggi. La stessa commissione che dalla parti di Renzi oggi viene così fortemente criticata. E vai con il cambio di parrucche. Olè.
Il rapporto che fa tremare Angela Merkel: anche i tedeschi imbrogliano l'Europa, scrive Libero Quotidiano”. Non siamo i soli nella lista dei Paesi europei in cui si è registrato e perseguito il maggior numero di frodi a danno dei fondi europei. Con noi ci sono anche Bulgaria, Spagna, Belgio e, sorpresa, la Germania. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) presentato a Bruxelles, dal direttore, Giovanni Kessler. "Nel 2014 - si legge nel rapporto - si sono raggiunti risultati eccellenti nella lotta contro le frodi nell'Unione: un anno record con il numero di raccomandazioni più alto, ben 1417, dalla sua creazione. L'Olaf avvia, in media, il 60% di indagini in più rispetto al 2012. Solo nel 2014 ha raccomandato alle autorità nazionali della Ue il recupero di ben 901 milioni di euro, fondi che dovrebbero essere progressivamente restituiti al bilancio europeo, contribuendo a finanziare altri progetti". Complimenti da Kessler alla nostra Guardia di Finanza: "La nostra struttura ha con la GdF una cooperazione eccellente, ormai tradizionale, che ha portato ottimi risultati. Un rapporto molto forte e proficuo che spiega anche i tanti casi di indagini. Con loro s'è stabilito un circolo virtuoso di scambi di informazioni che purtroppo non troviamo in altri Paesi". Dall'Italia sono arrivate 42 segnalazioni di frode. Ma l'Oscar delle truffe spetta alla Romania, con 79 casi. In classifica Bulgaria (59), Spagna (56), Belgio e Polonia (52), Germania (35), Slovacchia (12). In Estonia e in Svezia non è stata invece riscontrata alcuna irregolarità è stata riscontrata.
"Me lo merito un Rolex?". Ancora: “Vado a vedere un po’ di Rolex per Antonia”. E tre: “Vuoi prendere il Daytona?” E quattro: “Ma un orologio, ti prego, prendilo tu”. E cinque: “Un Nautilus mi piace molto di più”. E sei: “Mamma mia che bello, segna le fasi lunari, il quadrante è blu, vero? Sono eccitato”. E sette: “Mi scoccia darle il Royal Oak (un Piguet ndr)”. L’amministratore delegato di Rolex non si affligga, ma il migliore testimonial della portabilità, dell’eccellenza e della qualità dell’investimento da polso si chiama Antonio Lollo, 46 anni, nato e residente a Latina, capelli lunghi, dall’aspetto ambivalente: preso da destra assomiglia al cantante Gianluca Grignani, solo un po’ più pienotto, da sinistra è goccia d’acqua di Marzullo, ma meno crepuscolare. Sportivo e perennemente coperto da una selezione di aromi profumati, scia chimica che avanzava prima di lui e segnava il suo passo. L’apparenza inganna però. Il dottor Lollo fino al 22 marzo scorso è stato giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Latina. Uomo di diritto ma, come vedremo, soprattutto di rovescio. “Qua abbiamo mosso un milione di euro, tra un cazzo e un altro”. Tra un orologio e un altro, un braccialetto e un altro, un viaggetto e un altro, un fallimento e un altro, Lollo e il suo complice, il commercialista Marco Viola, hanno raccolto un po’ di quattrini. E hanno bisogno di spenderli: “A me frega solo dei soldi, e mia moglie è della partita. Non mi sento affatto sporco”. Le cronache nazionali si sono occupate con superbia di questo straordinario scandalo dell’agro pontino, concedendogli pochi onori. Invece hanno sbagliato. Nell’agro pontino il caso fatto giustamente registrare colonne umane alle edicole: “Abbiamo fatto un balzo nelle vendite”, comunica entusiasta il direttore di Latina Oggi. E infatti sembrano cronache marziane. Non già per la tipologia del reato commesso, ma per le personalità coinvolte e soprattutto per i dialoghi che registrano come al fondo non ci sia fondo. Mai. Il giudice arrestato, sua moglie arrestata, sua suocera, già capo di gabinetto della Questura e presidente provinciale del comitato Unicef (bambini di tutto il mondo, attenti al lupo!) arrestata. Deve giustificare la presenza di 360 mila euro in contanti nella cassetta di sicurezza. È stupefacente la narrazione che il giudice fa della sua opera di delinquenza. E l’atteggiamento ossessivo verso l’acquisto degli orologi. Lui si difende: “Pensi che se io avessi potuto mi andavo a comprare orologi?”. Parla col complice e spiega che proprio non sa cosa combinare con i soldi che acchiappa, imbosca, inguatta. Ha già la proprietà di case e auto e non può derogare oltre nel codice etico. Quindi: orologi! Bisogna arraffare presto e bene. Lui è il capobanda: “Il leader è il leader, la responsabilità è mia… loro devono fa quel che dico io… con i colleghi me la vedo io”. Il giudice si fa gangster e la legge diviene trappola per topi, il tribunale luogo dove si scuciono soldi e si scuoiano anime. Un trattato perfetto di antropologia criminale, un mix di gangsterismo di provincia, un unico sacro fuoco: li sordi!. “Ho rischiato il culo fino a mò, che faccio me ne vado mò che devo raccoglie? Rischio fino alla fine, no?”. Lollo intuiva di essere pedinato eppure insisteva nell’agire da malfattore. “Ta ta ta. E pagano!”. Commovente il colloquio tra moglie e marito. Lei: “Va bene così, fatti dà dodicimila euro e basta, su! Non insiste, te rifai dopo”. Lui ascolta e decide di accogliere per il caso in esame, piuttosto modesto nella sua entità economica, il consiglio alla prudenza: solo dodicimila euro questa volta. Una tangentuzza piccola così. Cosa avesse in testa questo giudice imbizzarrito sarà materia da psicologi del crimine e anche tema di riflessione del Csm che purtroppo però non si occuperà del caso perchè l’arrestato ha deciso di dimettersi dalla magistratura. Certo lui è un dandy. Ama la bella, anzi bellissima vita. I viaggi. “Volevamo andare a maggio a Londra, a giugno c’ho New York, a settembre Sardegna”. E ama soprattutto gli orologi: i poliziotti lo pedinano fino a Roma, in via Cavour dove abitualmente si approvvigiona. Rastrella ogni brand d’altura, memore che un Rolex vale nel tempo “è moneta contante”. Può stare al polso o in una cassetta di sicurezza. Chiuso e nascosto o lucente ed esibito. Vale soldi, non perde peso. Si distingue tra gli altri. E conserva intatto il suo augusto segno di ricchezza. Certo, all’uomo poi viene di fare “un tetris con orecchini e anello, o coi rubini. Mi piacerebbe l’idea di un anello, di un diamante. E bracciali”. Oro che luccica per la sua amata consorte. Del resto, “mica ci siamo comprati la villa all’Eur?”. Già, si sono tenuti bassi. Questi soldi sono frutto dell’ingegno, raccolti tra i fallimenti delle società che questa crisi ha fatto lievitare. Quindi solo orologi, meravigliosi orologi. Con le fasi lunari e senza, col quadrante blu o bianco, tondi o rettangolari. “Me lo merito un Rolex?”. da: Il Fatto Quotidiano 13 maggio 2015.
Altri giudici sapevano del sistema di tangenti messo in piedi da Antonio Lollo nella sezione fallimentare del Tribunale di Latina. A confermarlo lo stesso ex magistrato durante uno dei tre interrogatori ai quali è stato sottoposto durante la sua detenzione tra il carcere romano di Rebibbia e l’Ospedale Pertini. Lollo avrebbe vuotato il sacco e fatto nomi e cognomi. Ma i verbali sono pieni di omissis e come al solito nient’altro è trapelato né dagli inquirenti né dalla difesa. In una elaborazione di un articolo de Il Fatto Quotidiano del 31 Dicembre 2013 apparsa l’1 Gennaio 2014 sul sito malagiustiziainitalia.it, si parla di “Perizie affidate a consulenti dall’ampio potere discrezionale e dai compensi stratosferici, mazzette spartite anche con i giudici. Un crocevia affaristico in cui è coinvolto il vertice dell’ufficio [quello di Roma]”, in riferimento alla vicenda che ha visto coinvolta Chiara Schettini di cui abbiamo appena accennato. La stessa Schettini, chiama in causa (è il caso di dire) anche la magistratura umbra, passivamente prona ai desiderata di quella romana: insabbiare gli esposti, far finta di nulla ed attendere che trascorrano i tempi era l’ordine da eseguire. Sotto interrogatorio, la Schettini ha confessato al giudice (onesto e che ringraziamo a nome di tutti i lettori e le lettrici di signoraggio.it): “Si entrava in camera di consiglio e si diceva questo si fa fallire e questo no”. Chi si esprime così non è un temibile boss della mala ma è sempre lei, il veramente temibile giudice Schettini, lei sì appartenente al ramo pulito del potere, proprio quello!!! Nella sua crassa arroganza venata di ottusa prosaicità, ella ricorreva sovente ad uscite agghiaccianti, sfornando un gergo truce da gangster matricolato. Intercettata telefonicamente mentre parlava col curatore fallimentare Federico Di Lauro (anche lui in galera) minacciava di farla pagare al suo ex compagno: “Guarda, gli ho detto, sono più mafiosa dei mafiosi, ci metto niente a telefonare ai calabresi che prendono il treno, te danno una corcata de botte e se ne vanno” (da Il Fatto, 8 Luglio 2013, R. Di Giovacchino). Non finisce qui. Sempre questo giudice donna, in un’altra intercettazione che ha lasciato di stucco gli inquirenti che l’hanno più e più volte riascoltato il nastro, parlando con un ignoto interlocutore, minacciava il “povero” Di Lauro in questi termini: “Io a Di Lauro l’avrei investito con la macchina… Lui lavorava con la banda della Magliana”. Ciliegina sulla torta: parlando al telefono con un perito del Tribunale, riferendosi all’insistenza di un Avvocato che non aveva intenzione di piegarsi supinamente al comportamento della Schettini, commentava: “Il suo amico Massimo ha chiesto la riapertura di due procedimenti. Una rottura senza limiti. Gli dica di non insistere perché non domani, né dopo domani ma fra 10 anni io lo ammazzo”. Alla faccia della magistratura a cui tocca attenersi!
Pino Maniaci: “Vi spiego la mafia dell’antimafia….”, scrive Laura Bercioux per "Il sud online" il 28 maggio 2015. Laura Bercioux, conduttrice e giornalista, si occupa di cronaca, di ambiente con un occhio speciale al sociale e allo spettacolo. Ha collaborato con Telenorba, Stream Tele+Inn, Rai Tre, Rai Uno. Ha lavorato a reportage televisivi per Rai Uno in "Ladri di Vento"- Petrolio, inviata per la trasmissione di inchiesta di Telenorba "Patto per Il Sud", ha condotto la trasmissione tv sociale per Telelibera 63 "SoS Campania", ha condotto per Rai Tre con Fernando Balestra e Tosca D'Aquino "Cocktail" e "Strano ma falso" di Fabrizio Mangoni, Francesco Durante. Collabora anche per La Voce di New York. Nella Giornata della Legalità, l’inchiesta di Pino Maniaci, giornalista siciliano di Tele Jato sui patrimoni sequestrati e gli amministratori giudiziari, rimbalza sulle cronache dei giornali. Noi avevamo già intervistato Maniaci sulla “Mafia dell’Antimafia” come lui stesso definisce gli scandali della gestione dei beni sequestrati. Dove indaga Pino? Pino Maniaci porta alla luce il malaffare della gestione dei beni sequestrati (a Palermo sono gestiti quasi il 50% dei beni sequestrati in tutta Italia): società, aziende, terreni, capitali immensi affidati a un pugno di prescelti amministratori giudiziari, in barba ai 4000 iscritti all’albo che puntualmente si vedono esclusi perché i 20 fortunati, e spesso in conflitto di interesse, hanno un’esclusiva fuori legge. Come succede a Seminara Cappellano, amministratore giudiziario di beni sequestrati, che acquista quote azionarie dei beni di Massimo Ciancimino in Romania o, da gestore di albero gestisce alberghi sequestrati. Maniaci descrive la storia nei dettagli, Seminara è sotto processo ma continua a gestire questi beni. L’inchiesta giornalistica parte da un bene sequestrato che è affidato da 7 anni dal Tribunale Sezione di Prevenzione sui patrimoni sequestrati, secondo la legge Pio La Torre. Il sequestro deve stabilire se la provenienza degli affari è illecita o meno, ci vogliono 3 anni di giudizio e troppi per capire se il proprietario dei beni ha a che fare con la mafia. Maniaci è sotto protezione dal 2008 per le sue inchieste e dichiara, qualche giorno fa, a resapublica.it: “Ci sono casi di beni con anche 16 anni di amministrazione giudiziaria. I danni che gli amministratori procurano al bene che amministrano a volte sono devastanti e i loro compensi milionari. L’avvocato Cappellano Seminara, in un solo incarico ha guadagnato 7 Milioni di euro”. La mafia dell’antimafia, dunque, scatena polemiche dopo il sevizio andato in onda alle Iene e, distanza di tre giorni dal servizio televisivo, i servizi segreti avvertono che la d.ssa Saguto è “a rischio attentato per la sua attività”. Ci sono troppi dubbi e punti di domanda, sentite cosa dichiara Pino Maniaci a resapubblica.it: “Uno dei casi più eclatanti è quello del patrimonio dei Rappa sottoposto a sequestro. Il patrimonio era stato sequestrato a Ciccio Rappa, ma da allora a adesso sono trascorsi decenni e ancora non si sa se e quale parte dell’immenso patrimonio che si stima in 800 milioni di euro, sia da confiscare. Nel frattempo, scopriamo che la d.ssa Saguto ha nominato amministratore giudiziario un giovane avvocato, Walter Virga, che è figlio di Vincenzo Virga, giudice componente del Csm”. Pino parla di un giro devastante di comportamenti al limite della legalità negli affidamenti o deontologicamente poco corretti. “Finora non è arrivata nessuna querela da parte di nessuno – racconta Maniaci -, nonostante le gravi accuse alla Saguto e al marito che lavora nello studio dell’avvocato Cappellano Seminara, cioè l’amministratore giudiziario che amministra un numero considerevole di beni posti sotto sequestro. Al Csm c’era una richiesta di un provvedimento disciplinare nei confronti della Saguto, riguardo proprio alle procedure di nomina dell’amministratore giudiziario di una discarica in Romania, che appartiene al patrimonio di Massimo Ciancimino, e affidata al solito Cappellano Seminara. Ma il giudice Vincenzo Virga, componente del Csm e responsabile dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, archivia la richiesta e 15 giorni dopo il figlio diventata amministratore giudiziario dell’impero dei Rappa. A me pare un comportamento deontologicamente poco corretto”. La d.ssa Saguto è adesso nel mirino della ritorsione mafiosa e Pino manifesta la sua solidarietà ma anche le sue perplessità per una nota dei servizi pubblicata 3 giorni dopo il servizio delle Iene. “A me – dice Maniaci – l’accostamento tra la Saguto e Falcone sembra deprecabile. Noi puntiamo il dito sulle attività della sezione misure di Prevenzione del Tribunale diretto dalla Saguto da un pò di tempo ma nessuno ci ha mai querelato, mi chiedo perché. Ci sono tantissime associazioni che hanno scoperto l’antimafia per guadagnare e fare soldi, e l’antimafia dovrebbe fare parecchia introspezione dentro se stessa. Io posso dire che l’emittente Telejato rischia sempre di chiudere per mancanza di fondi. La nostra antimafia è gratis. Io vado in giro per l’Italia senza prendere un euro. Anzi, io non faccio antimafia. Io considero un errore avere istituzionalizzato l’antimafia. Con il Capo dello Stato antimafia, il Presidente del Senato antimafia, il politico antimafia. A me da fastidio questa distinzione, perché l’antimafia e il rispetto della legalità dovrebbero essere nel cuore di ogni cittadino onesto. A volte la legalità è usata a proprio uso e consumo. Noi facciamo un lavoro giornalistico. Denunciamo l’illegalità secondo la lezione di Pippo Fava. Una buona informazione incide, corregge diventa determinante per un territorio. Diventa punto di riferimento per chi non ha voce. Senza infingimenti politici e distinzioni tra destra e sinistra. La merda può essere a destra ma a sinistra non si scherza nemmeno e va pestata tutta”. Maniaci non si arrende e continua a battagliare, a raccontare, i magistrati gli sono accanto e dice “C’è una sottoscrizione su change.org, che ha già raggiunto 40.000 firme. Abbiamo chiesto al Csm di essere ascoltati in merito ai comportamenti deontologici della d.ssa Saguto ma nessuno vuole ascoltare e nessuno ci querela. Quello che noi abbiamo detto è soggetto a un grave reato, vilipendio a corpo dello Stato. É previsto anche l’arresto immediato per questo. Ma io sono ancora a piede libero. Io sono stato ascoltato dai magistrati di Caltanissetta, perché c’è una loro inchiesta sulle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo che non ha ancora prodotto risultati. Mi chiedo che fine abbia fatto quell’inchiesta”. Nella Giornata di Falcone, se ne parla tra i colleghi, fuori dall’Aula Bunker di questa brutta storia, sembra che una certa “antimafia” si beffi di quei morti, di quelle persone che, per combatterla ci hanno rimesso la vita. Intervista a Fabio Nuccio – Giornalista Mediaset.
Anche se sembra non siamo un popolo di disonesti. Facciamo di tutto per dimostrare di essere i peggiori, ma in altri Paesi la corruzione non è inferiore a quella presente da noi, scrive Piero Ostellino su "Il Giornale". Siamo il popolo più disonesto al mondo? Certamente non lo siamo, anche se – a giudicare dalle cronache quotidiane - facciamo di tutto per dimostrarlo. In altri Paesi la corruzione non è inferiore a quella presente da noi. Ma è, come si suol dire, il contesto quello che, da noi, conta, cioè il ruolo che la politica svolge anche nel campo dell'economia e delle transazioni di mercato. Il fatto è che, da noi, l'intermediazione politica occupa un posto di preminenza rispetto a quello che altrove occupa il mercato. E dove la politica ha a che fare con i soldi è pressoché inevitabile che qualcuno ne approfitti, perché la politica non va tanto per il sottile quando si tratta di conquistare consenso e il consenso è spesso strettamente associato ai quattrini di cui si può disporre. La regola politica è questa. Più quattrini hai da spendere, maggiore è il consenso che puoi ottenere. Se, poi, i quattrini non sono neppure i tuoi, ma di coloro i quali li usano e li spendono in funzione dei loro interessi politici, allora, l'equazione «politica e quattrini uguale corruzione» funzionerà alla perfezione. Le cronache parlano molto degli scandali collegati a tale uso dei quattrini, peraltro senza spiegarne le ragioni, ma non è un problema che preoccupi il mondo della politica perché in gioco non è l'onestà personale dei politici, che non interessa nessuno, ma la natura strutturale del nostro sistema. Non abbiamo la classe politica più corrotta al mondo; abbiamo solo la classe politica più esposta alle tentazioni. E, come è noto, sono le occasioni che fanno l'uomo ladro. Come ho detto, quando l'intermediazione politica prevale sulle logiche del mercato e che qualcuno, sul versante politico, ne approfitti è nella logica delle cose. Questa è anche la ragione per la quale tutti i governi che si sono ripromessi di riformare il Paese e i suo sistema politico non ce l'hanno fatta. Non ce l'ha fatta Berlusconi; non ce la fa Renzi malgrado predichi ogni giorno l'intenzione di cambiare l'Italia. Da mesi andavo scrivendo che l'immigrazione si era trasformata nell'«industria dell'immigrazione» in quanto l'arrivo di migliaia di immigrati era diventata l'occasione, per la politica, di utilizzare i quattrini stanziati per l'accoglienza dei nuovi arrivati a proprio esclusivo beneficio e delle proprie organizzazioni sociali. Sembrava una mia fissazione. Invece, gli scandali scoppiati in successione ai margini del fenomeno hanno confermato che non si è ancora regolamentata l'immigrazione perché non conviene a chi ci fa sopra dei guadagni più o meno leciti. Lasciamo perdere gli scafisti – che sono dei veri e propri criminali – e chiediamoci se la solidarietà di certi ambienti cattolici e di sinistra non sia pelosa: gli immigrati sono manodopera a basso costo che le cooperative che prosperano attorno al mondo cattolico e della sinistra hanno finora utilizzato impedendo qualsiasi tentativo di regolamentarne l'arrivo. È perfettamente inutile approvare marchingegni burocratici che dovrebbero impedire la suddetta speculazione. Prima o poi diventano essi stessi occasione di corruzione perché dove è possibile evitare monitoraggi e controlli è pressoché certo che la politica troverà il modo di eluderli. Finora è quello che è accaduto ed è probabile che l'andazzo non cambi. Potrebbe esserci qualche speranza di cambiamento se i media facessero il loro mestiere di cani da guardia del potere politico e, perché no, anche di quello economico. Se la proprietà, o il controllo, dei media serve da moneta di scambio con la politica per goderne del sostegno, è evidente che la politica prevarrà sempre a dispetto delle migliori intenzioni perché eludere monitoraggi e controlli conviene a troppa gente. Non è col moralismo a basso prezzo che si moralizza il Paese, bensì con riforme che ne mutino radicalmente la struttura, eliminando l'eccesso di intermediazione politica. Ma toglietevi dalla testa che Renzi le faccia. Continuerà a prometterle, senza farle. La furba retorica del presidente del Consiglio ha incominciato a deludere gli italiani, anche quelli che gli credevano, e il consenso di cui ha goduto sta calando. C'è anche un'altra regola che presiede a quest'ultimo fenomeno: non si possono imbrogliare tutti e sempre.
Chi è Giuseppe Pignatone, l'uomo che ha scoperto Mafia Capitale. "Scopritore di nuove mafie", il procuratore capo di Roma è conosciuto come un "mastino gentile". Sue le principali inchieste di lotta a mafia e 'ndrangheta, scrive Claudia Daconto su “Panorama”. Lo chiamano lo "scopritore di nuove mafie". L'ultima è quella "Capitale". Giuseppe Pignatone, siciliano, classe 1949, in meno di 3 anni ha dato una scossa al “porto delle nebbie”, come venivano chiamati gli uffici giudiziari della Procura di Roma fino al momento del suo arrivo, e svelato la presenza di un “mondo di mezzo” in affari con uno “di sopra” per conto di quello “di sotto”. Quando nel 2012 sbarcò a Roma da procuratore capo, sindaco era ancora Gianni Alemanno. L'accoglienza fu calorosa: “con lui – disse l'ex sindaco - la Capitale potrà giovarsi di un magistrato di indiscussa competenza che grazie alla sua lunga esperienza nella lotta contro la criminalità organizzata rappresenta un segnale importante per la sfida che questa città è chiamata a vincere per la sicurezza dei suoi cittadini”. Sentendosi chiamato in causa, Massimo Carminati non riuscì a nascondere la sua preoccupazione: “ha già buttato all'aria la Calabria, butterà all'aria anche Roma”. Magari “Cecato”, come viene soprannominato l'ex Nar della Banda della Magliana e presunto capo di "Mafia Capitale", ma con la vista lunga. Due anni dopo infatti, era il 4 dicembre scorso, i nomi di Alemanno e dello stesso Carminati finiranno nell'elenco degli arrestati e indagati per associazione mafiosa e altri innumerevoli reati insieme a quello del ras della cooperazione sociale capitolina Salvatore Buzzi e di decine di dirigenti pubblici, segretarie, ex amministratori delegati di municipalizzate, assessori, consiglieri, portaborse, faccendieri, intermediari, passacarte, palazzinari, esponenti politici di centrodestra e centrosinistra tutti membri di diritto del grande partito del malaffare che per anni ha governato Roma arricchendosi sulle spalle dei cittadini e sulla pelle dei più deboli tra i deboli: gli immigrati. Entrato in magistratura già nel 1974, Giuseppe Pignatone è tra i più esperti di lotta alla mafia senza aver mai voluto essere anche un professionista dell'antimafia. Schivo, riservato, allergico alla mondanità, la ribalta se l'è conquistata sempre e solo attraverso le sue inchieste. Dopo Caltanissetta e Palermo, dal 2008 al 2012 Pignatone è a Reggio Calabria. Poi Roma. Nel capoluogo siciliano collabora con Pietro Grasso, allora procuratore capo e poi procuratore nazionale antimafia. Qui fa condannare numerosi capi e gregari dei clan; segue l'indagine sulla Strage di Capaci che porterà all'arresto di Totò Riina, coordina quella su Bernardo Provenzano; fa incriminare, negli anni '80, l'ex sindaco Vito Ciancimino, poi condannato per mafia e firma l'inchiesta che porterà alla condanna a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra dell'ex presidente della regione Totò Cuffaro. In Calabria ha dato talmente fastidio che il 3 gennaio del 2010 l'Ndrangheta gli ha fatto esplodere una bombola a gas collegata a un panetto di tritolo proprio davanti all'ingresso della Procura di Reggio Calabria. Anche lì, come poi nella Capitale, aveva trovato una situazione di immobilismo quasi totale. Poi, a costo di minacce, intimidazioni, proiettili, bazooka, è riuscito a fare luce sul nuovo volto e il modo di operare di una delle organizzazioni criminali più potenti, ricche e armate del mondo. Un'holding con sede centrale nel cuore della Calabria alla quale rispondono le numerosissime succursali sparse nel Nord Italia, in Germania, svizzera, Canada e fino in Australia svelata dalla famosa inchiesta “Crimine”, condotta insieme alla Procura di Milano e che ha portato all'arresto di oltre 300 persone. Rigorosissimo nella costruzione del quadro accusatorio, pignolo nella ricerca delle prove, Pignatone è un mastino gentile. Nessuno è più distante di lui dall'immagine dello “sceriffo” solo al comando. Gli piace e ritiene più proficuo lavorare in team. Nella sua squadra romana ci sono magistrati, investigatori, poliziotti, carabinieri e finanzieri che lo hanno affiancato anche in passato: da Michele Prestipino (suo braccio destro a Palermo) a Sara Ombra (sua l'inchiesta calabrese sull'ex governatore Giuseppe Scopelliti), da Renato Cortese (ex capo della mobile di Reggio, poi di quella romana, oggi capo dello Sco e già membro del gruppo che ha acciuffato Provenzano) a Stefano Russo (capo dei Ros di Reggio Calabria e poi del Lazio). Poche ore prima che il mondo intero sapesse che secondo la Procura di Roma a Roma c'è la mafia e che da anni i politici di ogni schieramento ci fanno affari insieme per farsi eleggere nelle amministrazioni e poi ripagare il favore con gli appalti del verde, dei rifiuti, delle strade, degli immigrati, Pignatone lo anticipò, tra le righe, al Pd riunito al Teatro Quirino per una conferenza programmatica alla quale era stato invitato. Non disse, ovviamente, che a breve la città sarebbe stata travolta da uno scandalo che avrebbe avuto risalto planetario e che metà del partito di cui era ospite quel giorno sarebbe stato spazzato via, ma descrisse così la situazione della criminalità in città. E quando la notizia piombò come un macigno, lui preferì frenare l'enfasi: “Mafia Capitale non è la Cupola di Roma”. Piuttosto continuò a lavorare. E infatti, come lui stesso aveva annunciato, “nuove operazioni” sono arrivate e ieri altri 44 sono finiti in carcere. Sbagliato però pensare che Pignatone sia un “manettaro”: piuttosto che sbattere un innocente in galera preferisce lasciare un colpevole fuori. Nemmeno pensa che il compito dei magistrati sia altro che quello di fare le inchieste. “Io faccio processi, non scrivo articoli sui giornali”, ha ripetuto spesso. Il vero marziano a Roma è lui: Giuseppe Pignatone.
Mafia Capitale, i rapporti oscuri di Massimo Carminati con i servizi segreti. Anche nell'ordinanza che ha portato agli ultimi arresti, il giudice sottolinea i rapporti tra l'ex Nar e gli 007. Però poi l'affermazione non viene chiarita. E' un modo per non pregiudicare il ramo più delicato delle indagini? Scrive Gianluca Di Feo su “L’Espresso”. Il lato oscuro di Mafia Capitale, quel capitolo di cui continua a comparire traccia nei documenti investigativi, ma che resta sommerso con il suo carico di mistero: il ruolo degli 007. Anche nell'ordinanza dei 44 arresti il giudice Flavia Costantini scrive: «Massimo Carminati mantiene rapporti con appartenenti e ai servizi segreti». Un'affermazione, non un'ipotesi. Che eppure poi non viene circostanziata nelle centinaia di pagine che compongono l'atto d'accusa sul gruppo che aveva preso il controllo di settori decisivi dell'amministrazione comunale e regionale. Un tema sollevato anche da Matteo Orfini, presidente del Pd e commissario del Partito a Roma: «È curioso che una persona come Carminati abbia potuto costruire un sistema criminale di tale entità. Nei prossimi giorni chiederò al Copasir di occuparsi di questa vicenda per capire come i servizi segreti non si siano accorti di cosa stesse facendo una persona a loro evidentemente nota». Di sicuro, l'attività di prevenzione non ha funzionato. E il provvedimento del giudice ripropone il sospetto che il mancato allarme non sia stato casuale. Già nello scorso ottobre, in occasione della prima retata, i magistrati avevano sottolineato l'esistenza di un legame tra agenti dell'intelligence e l'ex pistolero dei Nar. Ma nelle decine di relazioni investigative e nelle centinaia di conversazioni intercettate depositate dopo quegli arresti, l'affermazione non è mai approfondita. C'erano nomi di poliziotti che fornivano dritte sulle inchieste in corso o offrivano i loro favori a Carminati, senza esplicitare in cosa consistessero le relazioni pericolose con i servizi. Lo stesso procuratore capo Giuseppe Pignatone, interpellato dalla Commissione antimafia e dal Copasir, il comitato parlamentare di controllo sull'intelligence, aveva negato che questi rapporti fossero provati. «Agli atti c’è – ha detto a dicembre il procuratore – c’è una lunga conversazione tra Carminati e una persona non identificata con certezza in cui lui si abbandona ai ricordi, risalenti agli anni ’70 e ’80 e racconta di un viaggio in Libano, dove fu mandato da qualcuno dei Servizi a fare attività di vario tipo e natura. Però questa è una traccia insignificante. Poi, nelle conversazioni di altri, emerge la convinzione diffusa che lui mantenga questo tipo di contatti, ma non vi è nulla di più». Sono elementi sufficienti per indicare senza condizionali in un atto giudiziario «rapporti con i servizi segreti»? Oppure si è trattato di una smentita tattica per non pregiudicare il settore più delicato delle indagini? Tutta la biografia di Carminati è segnata da accuse clamorose sempre seguite da assoluzioni, vicende che spesso si intrecciano con le più oscure trame italiane: dal terrorismo neofascista dei Nar alle esecuzioni per conto della Magliana, dall'omicidio di Mino Pecorelli alla raid del caveau all'interno del palazzo di giustizia, fino alla frequentazione con figure chiave di Finmeccanica, il colosso statale degli armamenti più sofisticati. Eppure era riuscito sempre a uscirne a testa alta, costruendo indisturbato la sua rete di potere nella capitale tra ricatti, corruzioni e minacce. La malavita romana lucra sulla pelle dei più poveri, e gli ultimi arresti dimostrano quanto il sistema fosse capillare. Per fortuna c'è anche chi si ribella all'omertà che dilaga a Roma. Il nostro inviato spiega come si evolve l'inchiesta "Mondo di mezzo". A dicembre due ex poliziotti della Squadra Mobile, Gaetano Pascale e Piero Fierro, hanno dichiarato a SkyTg24 che nel 2003 le loro indagini sulla nuova mafia di Roma erano state insabbiate. E questo – hanno sostenuto – grazie alle coperture dei servizi vantate da Carminati e da un altro boss del litorale laziale. Senza che però emergessero riscontri alle loro parole.
Questa volta ha ragione il Pd. Loro sono diversi: sono peggio. Nonostante Roma sia diventata una "cloaca massima, il Partito democratico insiste nel riaffermare la propria diversità: "Non è vero che siamo tutti uguali". Almeno questa volta ha ragione: il Pd è peggio, scrive Salvatore Tramontano su "Il Giornale". Renzi doveva cambiare l'Italia, non ha cambiato nemmeno il suo partito. Mezzo Pd romano è coinvolto nello scandalo di Mafia capitale, ma per Orfini, presidente del Pd, la colpa è di Alemanno, Maroni e dei servizi segreti. Guerini, vice segretario del Pd, ritiene addirittura strampalate le richieste di dimissioni del sindaco: «Marino è considerato un nemico di chi vuole fare affari». Sarà strampalato, ma due settimane prima degli arresti di Salvatore Buzzi, Massimo Carminati & C., il capo della coop «29 giugno» replicava così ai collaboratori che parlavano delle richieste di dimissioni per il sindaco Marino, impelagato con la grana delle multe alla Panda rossa: «Ti dico una cosa - annotano gli uomini del Ros - lui (Marino) se resta sindaco altri tre anni e mezzo, con il mio amico capogruppo ci mangiamo Roma». Alla faccia di chi lo considera un nemico degli affaristi. Per Renzi, però, paladino a parole della legalità, il problema Marino non esiste. D'altra parte, come dimostra anche il caso Campania, meglio una poltrona in più che un impresentabile in meno. L'ordine, quindi, è blindare Marino, altrimenti addio sogni di gloria: ci penserebbero i romani a rottamare quel che resta dei Democratici. «Falso», urlano quelli del Pd. Dimenticate che a Roma abbiamo Zingaretti, il governatore della Regione Lazio. Forse sarebbe stato meglio dimenticarlo. Per evitare strumentalizzazioni, citiamo cosa ha scritto ieri Fiorenza Sarzanini su Il Corriere : «Un patto tra maggioranza e opposizione per spartirsi l'appalto più remunerativo della Regione Lazio, quello sul Recup, il centro unico di prenotazione. A siglarlo il consigliere del Pdl Luca Gramazio e Maurizio Venafro, il capo di gabinetto del governatore Nicola Zingaretti. Il giudice lo definisce un “accordo corruttivo” che ha consentito “all'organizzazione riconducibile a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati di inserirsi, divenendo infine aggiudicataria del terzo lotto” in un affare da oltre 60 milioni». E dire che sei mesi fa Renzi aveva nominato Orfini commissario straordinario per ripulire Roma. Considerati i risultati, ha sbagliato mestiere: invece del commissario, Orfini avrebbe dovuto fare l'avvocato d'ufficio. Anche se la sua linea difensiva non brilla. Come si fa a dichiarare che: «Il Pd è il partito dell'antimafia» quando De Luca, il candidato del Pd appoggiato da Renzi, diventato governatore della Campania in barba alla legge Severino, denuncia il presidente della commissione Antimafia? Eppure, nonostante Roma sia diventata una «cloaca massima» (copywright Il manifesto ), il Partito democratico insiste nel riaffermare la propria diversità: «Non è vero che siamo tutti uguali».
Mafia Capitale: quello che la sinistra non vuole capire, scrive Giampaolo Rossi su “Il Giornale”. Ridurre lo scandalo di Mafia Capitale ad un derby tra destra e sinistra su chi ha rubato di più, è francamente patetico; chi lo fa non si rende conto che la posta in gioco non è un titolo sui giornali o un secchiello d’acqua al proprio mulino arrugginito. In gioco c’è ben altro: la tenuta di una democrazia, la legittimità della politica come funzione sovrana, il ruolo dei partiti come strumento fondante di partecipazione alla res publica. Per questo, di fronte ad alcune dichiarazioni di esponenti del Pd, sorge il dubbio che la sinistra italiana sia attraversata da un timor panico di fronte alla consapevolezza di non poter più rivendicare la sua presunta superiorità morale. Prendete per esempio Matteo Orfini, il commissario straordinario del Pd romano ed esponente di spicco del partito nazionale; lui, baldo giovane renziano, ex figgiciotto del Mamiani (il liceo romano dei fighetti radical-chic) ed ex dalemiano, tra una dichiarazione alla stampa ed una partita alla Playstation con Renzi, ha operato una medioevale reductio ad unum della complessità dello scandalo: Mafia Capitale è “Carminati con un banda di destra”. Sarà come dice lui ma se uno scorre l’elenco degli arrestati scopre che la maggioranza dei politici coinvolti sono del suo partito: il Presidente del consiglio comunale di Roma (del Pd), l’assessore alle Politiche Abitative della giunta Marino (del Pd), il presidente della Commissione Patrimonio di Roma (del Pd), il Presidente di uno dei più importanti Municipi di Roma (del Pd) e il capogruppo di Scelta Democratica partito che appoggia la giunta Marino; senza contare l’ex potentissimo vice-capo di Gabinetto di Veltroni già arrestato nel giro precedente e un coinvolgimento totale di quel sistema delle cooperative rosse da sempre fonte finanziaria, elettorale e spesso clientelare della sinistra italiana. Sono questi i componenti della “banda di destra” di cui parla Orfini? E non abbiamo dubbi che il sindaco di Roma Marino sia sincero quando dice di voler eliminare monopoli che esistono da decenni; ma in questi decenni, chi ha governato Roma? Tranne la breve, incolore ed inquietante esperienza della destra romana, ad occhio e croce diremmo la sinistra; ergo, quella “politica antica gravemente colpevole” che Marino si vanta di allontanare è quella dei suoi compagni? La sinistra vive sotto una costante forma di rimozione della realtà; non so se i suoi esponenti facciano uso di funghi allucinogeni, certò è che sembrano vivere in un universo psichedelico. Forse sarebbe utile abbandonare il tentativo di mostrarsi sempre migliori e provare a riflettere insieme sulla crisi della politica e delle regole democratiche; sull’inadeguatezza di una parte della classe politica, sulla fine dei partiti, sulla scomparsa delle leadership, sull’eccesso di malaffare che nasce sicuramente da anime sporche ma anche da un sistema sballato dove l’oppressione dello Stato (sotto forma di dittatura burocratica) favorisce le pratiche illegali, secondo quell’assioma che dai tempi di Tacito lega la corruzione all’eccesso di leggi (“Corruptissima re publica plurimae leges”). Allora, cari amici e compagni del Pd, aprite gli occhi: la narrazione degli “antropologicamente superiori” con cui vi hanno bevuto il cervello i vostri intellettuali, è una balla, meno vera di una striscia di fumetto. Siete come gli altri: tra voi albergano persone oneste e farabutti, persone capaci e imbecilli, persone responsabili e miseri intrallazzatori. La politica (e con essa la democrazia) non si aiuta alzando il dito medio, come fa Grillo, ma neppure con il solito indice puntato da maestrini, come fate voi. È ora che la classe politica capisca che la crisi di legittimità democratica dei partiti è un punto di non ritorno che uccide la partecipazione consente a poteri illegittimi di sostituirsi alla sovranità popolare; e questo non è un problema di destra o di sinistra.
Onestà non significa neanche mancanza di libertà. "Vietato esprimere opinioni autonome sui social": il regolamento del Partito comunista. Il decalogo del partito di Marco Rizzo per il comportamento (di iscritti e dirigenti) da seguire su Twitter e Facebook è un condensato di divieti e doveri: dalle bandiere ai tag, scrive Matteo Pucciarelli su "La Repubblica". Bastava la promessa per capire l'antifona: "La natura dei social network spinge oggettivamente all'individualismo e alle peggiori performance di protagonismo. Serve quindi regolamentare il loro uso, seguendo le ispirazioni della dottrina leninista dell'organizzazione". Il Partito Comunista di Marco Rizzo (famoso per l'esaltazione dello stalinismo e di esperienze di "socialismo" come la Corea del Nord) ha varato una sorta di decalogo per l'utilizzo di Facebook, Twitter e affini da parte dei propri dirigenti e militanti. Il risultato è una serie di divieti e compiti che ricorda il settarismo comunista dei tempi andati, anche se fuori tempo massimo: "È fatto assoluto divieto a ogni iscritto al partito (tanto più se dirigente) a fare considerazioni e analisi politiche generali autonome", è la prima regola, approvata dal Comitato centrale dell'organizzazione fondata dall'ex europarlamentare di Rifondazione prima e del Pdci poi. Poi: "È vietato taggare altri membri del partito sempre su questioni politiche, storiche, filosofiche e culturali". Dopo: "È fatto assoluto divieto ad usare bandiere o simboli del Partito nell'immagine del proprio account personale. Le bandiere ed i simboli del partito sono esclusivamente rappresentate negli account di partito ad ogni livello (da quello centrale sino a quello di cellula)". Per fortuna non esistono solo divieti, ai quali vanno aggiunti i doveri: "È invece auspicabile che i membri del partito e del comitato centrale promuovano, condividano e tagghino i post degli organi nazionali". Detto questo, "tutti gli account di partito (da quelli regionali a quelli della singola cellula) devono comunicare riservatamente alla direzione centrale (nella persona del coordinatore) la password". Al tutto va aggiunta una considerazione: "La pubblicazione di fotografie e filmati di manifestazioni del partito devono esser improntate alla massima efficacia propagandistica e consapevolezza politica dell'evento". E una minaccia: "Qualunque violazione verrà da ora in poi deferita alla CCCG", con quest'ultima parola che probabilmente significherà commissione di garanzia. Nel preambolo della lettera pubblicata sul sito nazionale del movimento, c'è scritto che "i pareri e le elaborazioni dei singoli compagni andranno ad arricchire la linea elaborata collettivamente". L'importante è non esprimerli, perlomeno via social...
Bufala capitale n. 2, retate, arresti e foto, scrive Errico Novi su “Il Garantista”. Ecco il sequel: Mafia Capitale 2. In realtà l’inchiesta è la stessa, alcuni dei 44 nuovi provvedimenti cautelari sono notificati a soggetti già colpiti dal primo uragano, ed è il caso di Salvatore Buzzi. Ma questo secondo filone scoperto dalla Procura di Roma aggiunge al vecchio romanzo criminale qualche tratto nuovo. Resta il primo teorema: i consiglieri comunali ma anche regionali sono ordinariamente “in vendita”, pronti a concedere piaceri, a spianare appalti per la Coop regina, la 29 Giugno, e non solo. Secondo, che l’irresistibile e greve humor romanesco pervade ogni parola. Soprattutto quando i responsabili delle società, che gestiscono il business dei migranti come quello delle case popolari, si esprimono sui politici: trattati ora con disprezzo, altre volte con considerazione per la «serietà» e la «discrezione», in certi casi con rabbia. Gli inquirenti,e il gip di Roma Flavia Costantini che firma le ordinanze, ci mettono il carico da novanta, soprattutto per i personaggi più in vista. Il top della classifica spetta in questo senso a Luca Gramazio, consigliere regionale eletto con il Pdl dopo esserne stato capogruppo anche al Comune. Lui è tra i 19 che finiscono materialmente dietro le sbarre (ad altri 25 toccano i domiciliari, mentre la lista dei 48 indagati si completa con 4 nomi che non subiscono in questa tornata ulteriori provvedimenti restrittivi). Gramazio sarebbe l’uomo capace di mettere in comunicazione la rete di Carminati e Buzzi con le istituzioni. Tutte le istituzioni capitoline, evidentemente. Un’opera diplomatica condotta con una competenza non limitata a poche specializzazioni, dicono i pm. Secondo i quali l’esponente del centrodestra sarebbe persona di «straordinaria pericolosità». Gramazio è una delle icone di questa bufera, in effetti la più appariscente. Anche a lui vengono contestate l’associazione a delinquere di stampo mafioso, la corruzione e la turbativa d’asta. Altri reati che ricorrono nelle ordinanze eseguite ieri sono la turbativa d’asta, le false fatturazioni e il trasferimento fraudolento di valori, sempre con l’aggravante delle modalità mafiose. Ma se Gramazio è la star di questa seconda puntata, c’è un esempio ancora più calzante, per comprendere che considerazione avevano i capi delle coop dei loro interlocutori politici. Si tratta dell’ex presidente del Consiglio comunale Mirko Coratti, del Pd. Uno che insieme con il capo segreteria Franco Figurelli avrebbe ricevuto soprattutto una promessa, 150mila euro, in pratica un modesto anticipo, 10mila euro, e che soprattutto, secondo Buzzi, «non fa gioco di squadra». Da qui il soprannome: «Balotelli». Ecco, pare di vederlo, il ghigno irridente tipico della romanità un po’ triviale ma implacabile, geniale nel ritrarre le persone con un nomignolo. In tutto questo la mafia non c’è. Ma nessuno tra il procuratore aggiunto Michele Prestipino e i pm Giuseppe Cascini, Paolo Ielo e Luca Tescaroli, si fa venire lo scrupolo di precisare che stavolta c’è sì tanta ”Capitale” ma di mafia davvero poca e collaterale. Peraltro resta ancora da capire quale fosse la tara mafiosa del troncone principale, quello che ripercorreva anche le gesta dell’eminenza grigia Massimo “ er cecato” Carminati. Qui si incrocia appena una conversazione telefonica tra l’instancabile Buzzi e un presunto ambasciatore della famiglia Mancuso, organizzazione ’ndranghetista. In ballo il sostegno alla campagna elettorale di Gianni Alemanno per le Europee di maggio 2014. Il capo della coop 29 Giugno dice a tale Giovanni Campennì: «Basta che non sia voto di scambio… tutto è legale… uno po’ votà gli amici?!». E quell’altro non si sottrae: «Va bene… allora… è qua la famiglia? La famiglia è grande… un voto gli si dà». E poi però, come fa notare lo stesso Alemanno, «nei due comuni controllati dalla famiglia Mancuso ho preso un numero ridicolo di preferenze». Più che mafia calabrese, una classica sòla romana. Però lo spettro del malaffare, della tangentopoli alla vaccinara, quello sì è amplissimo. Ci sono di mezzo pure le coop bianche, in particolare una piuttosto nota, ”La Cascina”, che si è vista arrivare ieri mattina i carabinieri per una perquisizione. Quattro manager dell’azienda sono stati arrestati: si tratta di Domenico Cammissa, Salvatore Menolascina, Carmelo Parabita e Francesco Ferrara. Solo quest’ultimo finisce in carcere, gli altri tre vanno ai domiciliari. Questo particolare segmento dell’inchiesta romana vede tornare in scena un altro nome forte della prima ondata, Luca Odevaine. Che avrebbe ricevuto anche lui una «promessa», così definita: «Una retribuzione di 10.000 euro mensili, aumentata a euro 20.000 mensili dopo l’aggiudicazione del bando di gara del 7 aprile 2014». La Cascina si occupa dell’accoglienza dei migranti. E si sarebbe messa d’accordo con le coop rosse di Salvatore Buzzi su una «gara per l’individuazione dei centri in cui accogliere 1278 migranti già presenti a Roma e altri 800 in arrivo». Odevaine però è tra quelli per i quali il gip non accoglie la nuova richiesta di custodia cautelare, per quanto l’ex vice capo di gabinetto di Walter Veltroni sia comunque, da 6 mesi, in carcere a Torino. La vicenda sciocca i politici e c’è da crederlo. In ore non semplici per il Pd Matteo Renzi reagisce con uno stentoreo «in galera chi ruba». L’altro Matteo, Salvini, chiede la testa di Marino, il quale si fa spalleggiare dall’assessore magistrato Sabella per ricordare che da quando c’è lui è tutto diverso. Matteo Orfini dice che è solo una «banda di destra». Copione prevedibile, e non troppo appassionante. Sempre colorite sono invece le conversazioni tra Buzzi e Carminati, di cui le ordinanze offrono nuovi estratti (in una l’ex Nar adombra vaghe ipotetiche minacce, del tipo che se i politici non rispettano «gli accordi» lui proromperebbe in un «ahò», seguito dall’ovvio «te ricordi da dove vengo?». Ma stavolta la telefonata del giorno è tra Buzzi e Figurelli, quello che stava nella segreteria del Coratti-Balotelli. Si parte sempre con un «ahò», seguito da un haiku: «Ma la sai la metafora? La mucca deve mangiare». Buzzi rafforza: di’ al tuo capo (sempre quello che «non fa squadra» finché Buzzi nun s’o compra) che «qui la mucca l’amo munta tanto». Quell’altro abbozza e media: «Ahò, ma questa metafora io gliela dico sempre al mio amico, mi dice: non mi rompere il cazzo perché se questa è la metafora lui ha già fatto, per cui non mi rompere». Tradotto: Buzzi, che sarebbe grossomodo la mucca, aveva già avuto appalti, favori e così via. Alla fine è una trattativa come tutte, è consisteva nel tentativo di Coratti, per interposto Figurelli, di pagare un prezzo non eccessivo per far assumere alla 29 Giugno una ragazza. In un’altra telefonata Buzzi si sperticherebbe in complimenti non proprio da galantuomo per una «fica da paura» che avrebbe preso in cooperativa. Secondo i pm è la stessa della telefonata precedente. Di sicuro sono gli stessi il linguaggio e le scene della prima volta.
Le immagini dei blitz firmate dai Ros, scrive Angela Azzaro su “Il Garantista”. Il copia e incolla i giornalisti ormai non lo fanno solo rispetto alle ordinanze dei pm. È nata una nuova moda. Anche le immagini vengono dalle procure e dalle questure. Gli arresti per mafia capitale sono stati fatti a uso e consumo dei media e per evitare che qualche giornalista avesse un guizzo di autonomia e facesse riprese non consentite, hanno filmato tutto loro, i Carabinieri Ros. Le immagini che accompagnano le notizie erano rimaste, fino a qualche mese fa, l’ultimo baluardo in difesa dell’autonomia dei giornalisti. Sì, è vero quando ci sono rinvii a giudizio o ancora meglio arresti, gli articoli sono il copia e incolla delle ordinanze. Da tempo immemorabile ormai il lavoro dei giornalisti è diventato quello di riportare ciò che dicono i magistrati: gli operatori dell’informazione si sono dimenticati che il giornalismo nasce come contropotere non solo della politica e degli affari, ma anche delle procure e dei tribunali. Ma anche se la situazione era tragica, si poteva sperare in una rinascita legata alle immagini che coraggiosi videomaker andavano a fare sul luogo del “delitto”. Adesso anche questa piccola luce, questa flebile speranza si è dissolta. Non so se lo avete notato, ma adesso anche le immagini vengono “passate” direttamente dalla procura. Non sono fatte dai cameraman di Rai, Mediaset o La7 ma direttamente dai carabinieri o dalla polizia che compiono gli arresti per poi distribuirle insieme alle ordinanze. Copia e incolla anche per le immagini. Non vogliamo essere a tutti i costi innocentisti o garantisti. È invece una questione di metodo. Le accuse, non solo non sono una condanna come dice la Costituzione, ma vanno sempre verificate… andrebbero sempre verificate facendo un lavoro di inchiesta autonomo da quello dei pm e delle forze dell’ordine. Invece, anche nel caso di mafia capitale, tutto ciò che esce dalla Procura viene considerato oro colato, a tal punto da essere riportato senza nessuna distinzione o considerazione autonoma. Ora si è aggiunto un nuovo tassello. Gli arresti vengono fatti in diretta tv, filmati da coloro che dovrebbero avere un altro ruolo. Non è un passaggio qualsiasi. E un ulteriore deterioramento del ruolo che dovrebbe svolgere l’informazione. Ma non solo. In primo luogo testimoniano la gestione spettacolare di un’inchiesta, la cui valenza stabiliranno i diversi gradi di giudizio, ma che indubbiamente è stata condotta in modo da fare breccia nei media. In questi anni è stato usato dalle procure ogni mezzo: intercettazioni sbattute in prima pagina, vite private rovinate, avvisi di garanzia che arrivano prima ai giornali che ai diretti interessati. L’aggiunta delle immagini che sfociano direttamente da procure e forze dell’ordine incrina ancora di più la nostra capacità di comprensione. L’immagine gode di uno status di oggettività. Pur essendo un punto di vista sulla realtà ha un’immediatezza che tende a confondersi con la “verità”. Ho visto quindi è. Per questa ragione il lavoro sulle immagini è simile alle intercettazioni: lasciano poco spazio al dubbio, alla verifica, alla possibilitàdi ricostruire il contesto. Ma finché erano immagini che nascevano da un occhio terzo, quello dell’operatore dell’informazione, si creava un’alterità che dava la possibilità di ragionare, di usare il senso critico, di non fermarsi a una sola versione. Questo lavoro, che è non il succo del garantismo ma del giornalismo, sta diventando sempre più difficile, complicato per chi lo fa e per chi legge, sente o vede le notizie. Ieri le immagini degli arresti che avete visto non godevano di questa alterità, non provavano minimamente a essere un occhio terzo tra chi arresta e chi viene arrestato. È vero che negli ultimi anni l’uso delle immagini è diventato sempre più descrittivo rispetto al testo della voce fuori campo. Non un’aggiunta, non uno strumento in più, ma quasi una sorta di sottofondo privo di vita propria. Oggi è peggio. Anche quel poco di autonomia è perduta: ci dobbiamo accontentare delle immagini con sopra il timbro Carabinieri-Ros.
Coltello e tangente, la lingua della suburra. Dalle minacce alle battute sessiste, il romanesco criminale dei signori dell'arraffo. Nella intercettazioni diventano protagonisti tangenti, appalti e volgarità. E il rispetto che si deve a chi manovra denaro, scrive Francesco Merlo su “La Repubblica”. Non bastano le manette. Roma, "'a mucca che amo munto tanto", va espugnata e affidata allo Stato, come Berlino e come Washington. Ci vuole una legge speciale che dia a Palazzo Chigi i pieni poteri sul cuore della capitale, nel territorio dentro le mura aureliane per esempio, come Berlino appunto che è Stato nell'ansa della Sprea, dalla Porta di Brandeburgo alla Siegessäule, e come Washington, tra il Lincoln Memorial e il Congresso. Tocca insomma al governo strappare Roma non solo ai Carminati, ai Buzzi agli Odevaine, alle cooperative rosse come la "29 giugno" e a quelle simoniache di Cl che si chiamano piamente Cascina e Domus Caritatis, ma anche ai Consigli comunali che "devono stare ai nostri ordini perché li pago e vaffanculo ", e alle Giunte che sono "la mucca che se non mangia non può essere munta". Da decenni queste istituzioni di Roma sono corrotte o inadeguate, con i sindaci complici o ignavi: "Se Marino resta sindaco altri tre anni e mezzo, col mio amico capogruppo ce magnamo Roma". Il presidente del Consiglio come il papa re, dunque. Solo un'amministrazione statale, infatti, può ridimensionare, nella città-universo ormai degradata a suburra, i capibastone e i sovrastanti che marcano il territorio come il consigliere comunale Giordano Tredicine, che è stato arrestato ieri: "Se non t'arrestano - gli dice Buzzi - tu diventi primo ministro". E quello: "Perché? Me possono arresta'? ". E Buzzi ridendo: "Li mortacci tua, se te possono arrestà!". Fumantino e minaccioso Giordano Tredicine ha infatti portato nelle istituzioni la selvaggia illegalità degli ambulanti sparsi per Roma, il pittoresco delle roulotte che vendono cibo, con il loro minestrone di esseri umani: pakistani e armeni, cingalesi e tailandesi e filippini, tutti sotto il controllo di una sola grande famiglia, appunto. Dice di lui Carminati: "Quello viene dalla strada! Lui è serio, e poi è uno che è poco chiacchierato, nonostante faccia un milione di impicci ". Ed è degradato a mafia anche il tradizionale romanesco criminale di "Er più" che era un capo brigante, ma non un padrino. Il linguaggio d'amore e di coltello che Dumas racconta nel Conte di Montecristo diventa infatti linguaggio di appalto e di tangente con "zozzo e zozzone" al posto di "cornuto e sbirro". Mentre "l'elenco della mangiatoia" sostituisce "gli amici degli amici". E "o li cacci o li compri" a proposito dei consiglieri comunali è quel che dice don Mariano Arena a proposito dei carabinieri. La mucca poi è un'ossessione perché è la cresta, il pizzo, la ricotta, è keynesismo mafioso: "la mucca se non mangia non può essere munta", "se la vuoi mungere gli devi dare da magnà", e "quanto l'amo munta", "la mucca in tre mesi deve magnà...". Come si vede, più che una metafora è un'equazione, è il saggio di profitto, non l'arraffo bruto ma un arraffo che è già impresa. Qui è degradato a popolo di mafia anche il popolo dei quartieri. È stato per esempio arrestato Luca Gramazio che, secondo l'accusa, con una mano dà alla mafia quello che con l'altra prende dalla politica istituzionale "perché - dice Buzzi - una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso". E questa sarebbe una frase perfetta anche in bocca al padrino di Corleone. Buzzi racconta che "Gramazio ha dato un milione di euro al comune di Ostia... per il verde. E ora il verde ce deve tornà tutto a noi". E infatti "il presidente del Municipio, che io c'ero andato a parlà, sta facendo gli atti per darceli tutti a noi". Anche Luca Gramazio appartiene, come Tredicine, ai cani di razza che fiutano gli umori grassi del territorio romano. È figlio di Domenico Gramazio detto "er pinguino" che nel Msi era il popolano un po' goffo e intransigente, una specie di comparsa del Rugantino, un fascista sociale di quelli moralisti e spaccamondo che prendevano tantissimi voti. Partecipò al famoso lancio delle monetine contro Craxi davanti all'hotel Raphael, gridava "ladri ladri" al tempo di Tangentopoli, mostrava le manette in Parlamento. Ecco: la legge del contrappasso ha saltato una generazione. Papà Gramazio non è indagato anche se, si racconta nell'ordinanza, "andava con il figlio a trovate Carminati, er cecato". Chi ha trascritto le intercettazioni nota che il nome Carminati "viene pronunziato, per precauzione, a bassa voce", proprio come accade nella mafia siciliana con i nomi degli uomini d'onore, della gente di rispetto: Totò Contorno persino arrossiva quando, d'un fiato, diceva "don Masino". Ed è "il rispetto" che Carminati pretende dai consiglieri comunali, "quei pezzi di merda" che "non vogliono obbedire" anche se, dice Buzzi, "io li pago e dunque vaffanculo ". Ma cos'è il rispetto secondo Buzzi e Carminati? "Se tu non rispetti gli accordi, tu lo sai chi sò io. Te ricordi da dove vengo". Ed è la fedina penale che qui viene esibita come stemma nobiliare, cicatrici non di guerra ma di malavita che affascinano Gramazio junior a conferma che la destra missina, che pure aveva in testa un progetto di società e nel cuore sentimenti e ideali, a Roma è diventata mafia. Roba da far inorridire la buonanima di Almirante, che diceva: "Se qualcuno ruba va in carcere, ma se ruba uno dei nostri bisogna dargli l'ergastolo". E Teodoro Buontempo, er pecora, cercava un riscatto nell'educazione dei figli: dormiva in una Cinquecento ma li mandava a studiare nelle università inglesi. È un piccolo mondo antico che l'inchiesta Mafia Capitale archivia per sempre. In questo copione, Gianni Alemanno, pugliese sedotto dalla romanità, che posava a ideologo della destra sociale, è il primo responsabile politico del sistema criminale, una sorta di Ciancimino de Roma. Ma non è con le mille assunzioni clientelari che Alemanno ha seppellito il mondo dei camerati missini. No, l'ex sindaco era arrivato a chiedere all'organizzazione mafiosa un aiuto elettorale per le europee. E Buzzi si era rivolto alla 'ndrangheta perché, come abbiamo già sentito, "una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso". Gli chiede Alemanno: "Devo fare delle telefonate? Devo fare qualcosa?". E Buzzi: "No, no, no, tranquillo, tranquillo. Ora manderemo a... Milardi l'elenco di persone, nostri amici del sud, che stanno al sud, che ti possono dare una mano cò parecchi voti". Davvero solo una legge speciale e d'emergenza può riportare la criminalità romana a un livello fisiologico e costringere a rifugiarsi nei loro covi i pregiudicati e gli insospettabili come Luca Odevaine, quello - ricordate? - che si chiamava Odovaine e cambiò nome per non farsi riconoscere, l'ex capo di gabinetto di Veltroni formatosi in Legambiente. Dalla mafia romana percepiva uno stipendio di 20.000 euro mensili, regolarmente registrato nella contabilità da sottosuolo che la segretaria di Buzzi appuntava sul libro nero. Lo stesso Carminati, notando la copertina nera, disse: "Mamma mia, mi inquieta un po'". E non perché la disonestà gli turbava la coscienza, ma perché il nero lo depistava. I libri neri per il fascista Carminati sono quelli di Céline, di Guénon, di Evola e dei giapponesi che raccontano la morte dei guerrieri e non le pretese di Odevaine che voleva un euro per ogni rifugiato venduto: " Se me dai cento persone facciamo un euro a persona.. . Non lo so, per dire: hai capito? Ti metto 200 persone a Roma, 200 a Messina, 50 là, e le quantifichiamo ". Il traffico è odioso e il pervertimento è di ideali, questa volta, rossi. Ma c'è anche la fine della natura bonaria e cinica di Roma che è la città più grande d'Italia (20 volte Napoli) e con il centro storico più esteso del mondo, la più popolosa (più di tre milioni di abitanti censiti), la più bella ( ça va sans dire ), e ormai purtroppo la più degradata, la più corrotta e la più perduta tra le capitali dell'Occidente: un suk di illegalità, abusivismo, fogne a cielo aperto e sporcizia per le strade, sottosviluppo nei cortili, l'asfalto tutto buche e avvallamenti, il centro storico assediato dai mendicanti, le auto in terza fila, la metropolitana senza decoro, i lavori pubblici eternamente incompiuti, la cultura come enorme baraccone di incompetenze, le esecuzioni per strada ... Insomma la scenografia è perfetta per le ordinanze di Mafia capitale che come ha scritto il New York Times "sollevano nuove domande circa la capacità dell'Italia di riformarsi". Non si può infatti continuare a fingere, come fa il sindaco Marino, che Roma "città per bene" non somigli ogni giorno di più a Buzzi, a Carminati e a Odevaine e sia solo vittima e non anche complice, forse qualche volta persino peggiore di loro. Ecco perché questa seconda ordinanza della Procura non è solo un atto giudiziario, un supplemento di certificazione, l'aggiornamento della mappa dell'aporia e del sistema mafioso che controlla e plasma tutto, strade e uomini, traffico e sporcizia. Questa ordinanza è neorealismo ed è un trattato di linguistica moderna dove il codice più innocente è quello di sporcizia banale sulle "dù zinne" della "fica da paura che abbiamo preso a lavorà alla raccolta differenziata ". Questo in fondo è il Bagaglino, volgarità ordinaria, intermezzo comico da vecchia Roma: "Si chiama Ilenia". "Già si presenta bene" risponde Figurelli a Buzzi. "E se è un cesso la famo scopà da M", e qui l'iniziale del nome di battesimo del presunto bruto sessuale potrebbe aprire una faida da film di Tarantino. Con la M, per dire, comincia Massimo, che è il nome di Carminati. Questa ordinanza è infine un documento storico e le sue 428 pagine ci rimangono dentro come una preghiera. Non sarà infatti il processo, non saranno le condanne il Big Bang di una città che si prepara al Giubileo e aspira ad ospitare le Olimpiadi. Non basteranno i giudici a farla scendere dal taxi del sottosviluppo e della mafia perché, come dice Buzzi "bisogna stare attenti a scenne dal taxi: con noi sali, ma non scenni più".
Il nero e i bianchi, la torta delle coop. L'accordo globale di Mafia Capitale. Concorrenza inesistente. Consiglieri comunali compiacenti. L'unico dirigente "contro" allontanato. La squadra di Carminati godeva su appoggi trasversali per ottenere milioni di euro nel gestire emergenze abitative e migratorie. Ora sono finiti in carcere anche i rappresentanti delle reti cattoliche, scrive Francesca Sironi su “L’Espresso”. «Noi che dovemo sta sul pezzo pe’ magnasse un po' de caciotta». Ha ragione, il Nero. Il suo braccio destro Salvatore Buzzi è un lavoratore instancabile. Non conosce domeniche o festivi: è sempre al telefono per spartirsi affari, o impegnato in riunioni, incontri e strette di mano per assicurare a sé o agli amici milioni di euro dal Campidoglio e dal ministero dell'Interno. Mai una pausa. La frase la dice Massimo Carminati, “er Cecato”, ed è riportata nell'ordinanza che ha scoperchiato la seconda parte dell'inchiesta su Mafia Capitale, con 44 arresti e decine di indagati fra politici, amministratori e imprenditori. Il piatto principale è sempre la gestione delle emergenze abitative e dell'accoglienza dei migranti da parte di un ristretto gruppo d'affari. La novità è che ora sono state arrestate le controparti di Buzzi e Carminati: i rappresentanti di quelle coop “bianche” di cui l'Espresso parla da tempo , e che nella Capitale spadroneggiavano nel settore degli aiuti sociali, spalla spalla alla banda di Carminati. Il nero e i bianchi, il neofascista delle trame e le onlus che facevano riferimento al vescovo e agli ordini religiosi. Agli arresti sono finiti infatti Tiziano Zuccolo, della cattolica Domus Caritatis, e Francesco Ferrara, Domenico Cammisa, Salvatore Menolascina e Carmelo Parabita, rappresentanti del consorzio La Cascina, legata a Comunione e Liberazione. Con Buzzi si intendevano alla perfezione. Il giudice li ritiene infatti «partecipi agli accordi corruttivi con Luca Odevaine» - il funzionario stipendiato per assegnare risorse e immigrati agli amici dal tavolo del ministero dell'Interno – oltre che autori di «plurimi episodi di corruzione e di turbativa d’asta dal 2011 al 2014», dimostrando «una spiccata attitudine a delinquere, al fine di ottenere vantaggi economici nell’esercizio della loro attività imprenditoriale». Negli atti si raccolgono così gli accordi e gli intrecci che hanno intorpidito Roma per anni, chiudendola in una rete indistricabile di cooperative – bianche, rosse, nere, incensurate o indipendenti, non cambia – che si accordavano sui progetti prima ancora venissero pubblicate le gare. Nessuna alternativa aveva spazio. C'era chi si metteva d'accordo per quieto vivere, chi sotto minaccia. E chi semplicemente traeva maggior guadagni grazie all'oligopolio. Come il gruppo dei consorzi bianchi di Zuccolo e Ferrara. Uno degli episodi che meglio spiegano come sono stati spesi in questi anni i fondi per i più poveri, a Roma, riguarda 580 persone - donne, uomini e bambini finiti per strada a cui bisognava trovare un tetto per l'inverno del 2014. Il bando viene pubblicato il 14 luglio. Buzzi e Zuccolo sono molto preoccupati, perché a gestirlo è tale Aldo Barletta, un dirigente che a detta del socio di Carminati «è entrato da 10 giorni ed ha applicato tutto quello che non avevano applicato fino ad adesso», uno che «non cede nemmeno davanti a Gesù e Maria». Era un «pericolo», questo funzionario, per le sue «resistenze ad assecondare le procedure sfavorevoli agli interessi della pubblica amministrazione». E la procedura aperta da lui per trovare casa a quei 580 disperati era considerata un ostacolo: troppo trasparente e favorevole alla concorrenza. Andava aggirata. Come? Con l'alacre attività di cui Buzzi si fa coordinatore. E che consiste nel «far desistere» tutti i potenziali avversari dal partecipare alla gara. Il funzionario “nemico” aveva invitato infatti 15 società a presentare un'offerta. Alcuni nomi, fra gli invitati, risultavano nuovi a Salvatore Buzzi, ed è allora Angelo Scozzafava (indagato), direttore del dipartimento per le Politiche Sociali di Roma, a dargli i contatti necessari. Altri invece li conosceva bene. E inizia con gli sms e le chiamate. Contatta anche a Gabriella Errico, la responsabile della coop “Un Sorriso” che gestiva il centro per minori di Tor Sapienza diventato noto dopo l'aggressione e il caos con gli abitanti del quartiere. Lei risponde «tranquillo», si dichiara «a disposizione» e non partecipa al bando (ora è indagata). Altri fanno maggiori resistenze. Alcuni chiedono favori in cambio, come Alberto Picarelli che desiste dall'occasione ghiotta ma dice: «Salvato' spero che un giorno pure io ti possa... quando ti chiedo qualcosa me ne venga accolta». Con questi piccoli debiti o scambi Buzzi sistema la concorrenza. I colleghi competitor si dissolvono tutti. Rimane la rete di Zuccolo e Ferrara, La Cascina. Ma tutto è sistemato con una telefonata tra amici e un accordo che gli inquirenti definiscono "globale": «Io su quello dei 580 preferirei che andasse completamente deserto, che partecipassi solo io, capisci? Sugli altri dimme te, io ti ci vengo e tu vieni sui miei», dice il braccio destro di Carminati. E Ferrara conferma: «Secondo me tu vieni ed io vengo e poi hai capito, così almeno più è... e poi sti cazzi, cioè hai capito?». Chi ha capito ha capito: tu mi aiuti qui, io ti aiuto lì, e la spartizione è fatta. La manovra non fa una piega. E il 25 agosto alla “manifestazione d'interesse” dei soggetti sul territorio per accogliere quei 580 sfollati si presenta una sola società. La cooperativa Eriches di Salvatore Buzzi. Che si aggiudica così indisturbata l'affare da un milione e seicentomila euro. Turbativa d'asta in piena regola. Ferrara è coinvolto anche in altre pratiche, fra cui la manomissione di una gara indetta il 30 giugno del 2014 dalla prefettura di Roma per assicurare l'accoglienza a 1.278 migranti, oltre a ulteriori 800 richiedenti asilo in arrivo. Valore: 10 milioni di euro. Per ottenere le assegnazioni dei progetti, e far approvare una delibera che assegnasse i fondi fuori bilancio, Ferrara avrebbe partecipato alla «corruzione di consiglieri comunali mediante la promessa della somma di complessivi 130mila euro». La situazione di Eriches e Domus Caritatis/la Cascina era entrata infatti in crisi dopo un rapporto della Finanza, che giudicava illegittime le assegnazioni dirette del Campidoglio a quella ristretta cerchia di imprese sociali di milioni e milioni di euro. Ma né rapporti né dirigenti specchiati sono riusciti a fermarli.
Cooperative nere e cattoliche: il concordato di Carminati per il business della disperazione. Gli affaristi neofascisti e le santissime arciconfraternite pronte a spartirsi una torta da quasi 30 milioni di euro l'anno solo per rispondere all'emergenza abitativa Un servizio garantito grazie a fondi senza controllo. Nascosti in delibere, proroghe, convenzioni, scrive ancora Francesca Sironi su "L'Espresso". C'è un rapporto del gennaio 2014, firmato dagli ispettori della Ragioneria dello Stato, che dice già tutto. Che porta alla luce le irregolarità degli appalti garantiti dal comune di Roma a una maglia di tre cooperative: il consorzio Eriches di Salvatore Buzzi, braccio destro dell' ex terrorista nero Massimo Carminati, entrambi finiti in carcere per l'indagine che ha colpito la mafia fascista della capitale; il “Consorzio casa della solidarietà” e “Domus Caritatis”. Gli affaristi neofascisti e le santissime arciconfraternite pronte a fare "stecca para" - per usare il lessico di Romanzo Criminale - trasformando la disperazione in un business d'oro. Insieme, queste tre associazioni si spartivano una torta da quasi 30 milioni di euro l'anno solo per rispondere all'emergenza abitativa. Ovvero per dare un letto temporaneo a chi perde la casa. Un servizio importante, garantito però grazie a fondi senza controllo. Nascosti in delibere, proroghe, convenzioni. «Va rilevato come l'affidamento sia avvenuto in via diretta, In assenza di qualsivoglia procedura concorrenziale», scrivono i funzionari dell'Ispettorato: «sebbene l'importo sia largamente superiore al limite previsto dalla legge secondo cui il fornitore dovrebbe essere individuato mediante una gara europea». Ma quali gare: nella capitale i problemi si risolvevano fra amici, hanno rivelato le indagini della procura di Roma. E anche quando c'erano dei bandi, loro riuscivano a pilotarli. Soldi sicuri, che intascavano sempre, nonostante le casse indebitate del Campidoglio. E non solo dal municipio: ma ottenevano finanziamenti pure dalla Prefettura e da Bruxelles. I patti lateranensi di Carminati hanno resistito fino a pochi giorni fa. Perché l'allarme della Ragioneria di Stato è stato ignorato? Nessun esponente della giunta Marino lo ha letto? Nessuno si è insospettito? Grazie alle procedure “straordinarie” dettate dalle “emergenze” (che potevano durare anche anni, come quella “abitativa”, o “migratoria” o “dei Rom”) una cooperativa quale quella di Salvatore Buzzi era riuscita a raggiungere il controllo di 2.965 posti letto: servizi per minori stranieri non accompagnati, adulti richiedenti asilo, nomadi, famiglie italiane travolte dalla crisi, uomini senza tetto e madri sole. È lo stesso “Gruppo 29 giugno” di Buzzi a vantare risultati straordinari, soprattutto in termini economici, nel bilancio del 2013. L'Italia era in crisi. Loro no: le intercettazioni dei magistrati svelano quanto fosse profittevole lucrare sulle disgrazie della gente. Perché queste sofferenze, garantiva Buzzi al telefono, «rendono più della droga». "Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? C'hai idea? Il traffico di droga rende meno", così al telefono Salvatore Buzzi, braccio destro imprenditoriale di Massimo Carminati. Il sistema ha funzionato alla perfezione fino all'intervento dei magistrati. Nessuna denuncia ha fermato i nuovi padroni del business del sociale, capaci di arricchirsi anche con gli sbarchi di Mare Nostrum, la marea umana di profughi fuggiti dalle guerre in Siria e in Libia che ha raggiunto le coste italiane negli ultimi mesi. A maggio del 2014 la “Eriches” dell'ex detenuto modello Salvatore Buzzi gestiva solo a Roma 493 posti letto. Considerando una media di 40 euro di rimborso giornaliero a persona, gli stranieri portavano un introito assicurato di 20mila euro al giorno. Anche qui, dalle tabelle pubblicate proprio su Il Tempo, il quotidiano romano il cui direttore è stato intercettato dagli inquirenti a colloquio con “il Nero”, si trovano altre due sigle ricorrenti: Domus Caritatis e Casa della Solidarietà. Insieme controllano 1.436 ospiti. Un giro di denaro fra i 50 e i 57mila euro al giorno. Il fatto è che queste tre cooperative, Eriches, Domus Caritatis e Casa della Solidarietà, non sono esattamente concorrenti. Da una parte c'è Salvatore Buzzi, il braccio aziendale, secondo i pm, del fascista Massimo Carminati. Dall'altra c'è Tiziano Zuccolo (non indagato): presidente della Casa della Solidarietà e rappresentante dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e di San Trifone, la rete di Domus Caritatis. Nelle intercettazioni riportate dai Pm, Buzzi e Zuccolo commenterebbero fra loro “un patto” di divisione degli affari “al 50-50", metà e metà. Ma non è solo dalle conversazioni telefoniche che emergono intrecci fra i due. C'è una società, la Maika Immobiliare. Fondata nel 2006 per essere messa in liquidazione nel 2008. Era controllata dalla Sarim immobiliare, srl appartenente all'organizzazione di Buzzi; da Sandro Coltellacci, anche lui arrestato per l'indagine sul “Mondo di mezzo”; da altri due soci. E da Tiziano Zuccolo in persona. Registrato come proprietario del 16 per cento del capitale. Nel 2007, quando Report mandò in onda una puntata in cui i due giornalisti autori del servizio interrogavano Buzzi su degli affidamenti inusuali ricevuti dall'Università di Roma Tre, la Maika esisteva ancora. E aveva sede legale in via Castrense 51. Dove fino al settembre del 2008 ha avuto domicilio anche un'altra cooperativa emersa alle cronache negli ultimi tempi: “Un Sorriso”, l'associazione che gestiva il centro per minori stranieri di viale Giorgio Morandi, Tor Sapienza (che ha spiegato in un' intervista a Repubblica la sua estraneità al consorzio, dal quale anzi avrebbe ricevuto ripetute e gravi minacce per anni). Il luogo degli scontri. Degli scandali. Delle polemiche. Da cui gli adolescenti sono stati portati via. Per finire in un'altra struttura. Di chi? Di Domus Caritatis. «Nell’ambito dell’accoglienza, siamo cresciuti ed abbiamo continuato la gestione delle attività assistenziali in favore di immigrati, senza fissa dimora, mamme con bambini, ex detenuti, nomadi e famiglie in difficoltà», vanta il consorzio Eriches di Salvatore Buzzi nel bilancio: «e abbiamo vinto il bando promosso da Roma Capitale per 491 immigrati facenti parte dello Sprar, (la rete nazionale dei comuni per la gestione dell'emergenza) una commessa significativa che ci consentirà di stabilizzarci nel settore». La “stabilizzazione” era garantita da rapporti stretti con le istituzioni: stando agli atti, per trasferire "un numero imprecisato" di minori stranieri non accompagnati, più di 100, da una comunità considerata inagibile, «Buzzi si interessava a un edificio disabitato, nella disponibilità del Comune di Roma, coinvolgendo un collaboratore nel progetto di occupazione abusiva dell’edificio». Lo stabile, localizzato in via del Frantoio, avrebbe ospitato, una volta "squattato", gli adolescenti. «In una conversazione intercettata, il 2 gennaio 2013, Buzzi riferiva, infatti, che avrebbe interessato “Caradonna”, identificato, poi, nel presidente del V Municipio - Ivano Caradonna - competente su via del Frantoio, affinché, dopo la loro occupazione, le autorità locali non avessero provveduto allo sgombero». Nel segno della legalità. Ci sono anche altri intrecci che aiutano la stabilità. E riguardano questa volta i servizi. Nella primavera del 2013 il catering di una grande struttura per minori stranieri gestita dal consorzio di Buzzi proprio in via del Frantoio 44 viene sostituito da un momento all'altro. Al posto del fornitore precedente arriva la Unibar di Giuseppe Ietto. Come mai questa decisione? «La scelta delle aziende veniva operata da parte di Carminati», scrivono i Pm: «gli imprenditori di volta in volta selezionati venivano messi a conoscenza degli interessi del sodalizio e delle modalità con le quali ci si prefiggeva di raggiungere gli obiettivi, sicché si veniva a generare un rapporto altamente fiduciario». Una gestione interna, insomma. Poi la Unibar assume la figlia di Carminati. Il “Nero” aiuta Giuseppe Ietto in un appalto. E il sodalizio si stringe. Anche grazie alla ricchezza del business. Nel pomeriggio dell'otto gennaio del 2013, parlando con un imprenditore, «Carminati espone le consistenti possibilità di guadagno derivanti dalla fornitura del servizio di catering presso i centri di accoglienza per famiglie», riportano i magistrati: «”Qua se guadagnà qualche soldino ... cioè ...capito?"», dice: «"Siccome che stiamo a parlà di 8/900 pasti. Tre euro ciascuno. E per ogni pasto, visto che pagano in ritardo, ti danno mezzo euro in più”». Continua il Guercio: «Praticamente se ritardano a nove mesi a limite non ti frega un cazzo, ogni giorno prendi una cosa in più, sai li parliamo di un migliaio di pasti al giorno, una cosa, una cosa … calcola che st'amico mio, ogni giorno più che passa si prenderà, credo 600 Euro in più al giorno, caricato sui pasti!» Gli operatori hanno provato a lamentarsi della qualità del cibo: gli è stato detto che andava bene così. Ora sia Buzzi, che Ietto che Carminati sono in carcere. E sì che avevano pronto un progetto solidale proprio per i detenuti: «Un punto cottura per una mensa da allestire all’interno del carcere femminile di Rebibbia», riportano i Pm: «Progetto ideato da Carminati, il quale lo ha indicato a Buzzi e a Carlo Guarany (vicepresidente della cooperativa “29 giugno”), come imprenditore di riferimento per l’attuazione».
Chi specula sui profughi. Un miliardo e 300 milioni: è quello che ha speso finora lo Stato per assistere le persone fuggite da Libia e Tunisia. Un fiume di denaro senza controllo. Che si è trasformato in business per albergatori, coop spregiudicate e truffatori, scrivono Michele Sasso e Francesca Sironi su "Espresso”. Erano affamati e disperati, un'ondata umana in fuga dalla rivoluzione in Tunisia e dalla guerra in Libia: fra marzo e settembre dello scorso anno l'esodo ha portato sulle nostre coste 60 mila persone. Profughi, accolti come tali dall'Italia o emigrati in fretta nel resto d'Europa: solo 21 mila sono rimasti a carico della Protezione civile. Ma l'assistenza a questo popolo senza patria è stata gestita nel caos, dando vita a una serie di raggiri e truffe. Con un costo complessivo impressionante: la spesa totale entro la fine dell'anno sarà di un miliardo e 300 milioni di euro. In pratica: 20 mila euro a testa per ogni uomo, donna o bambino approdato nel nostro Paese. Ma i soldi non sono andati a loro: questa pioggia di milioni ha alimentato un suk, arricchendo affaristi d'ogni risma, albergatori spregiudicati, cooperative senza scrupoli. Per ogni profugo lo Stato sborsa fino a 46 euro al giorno, senza verificare le condizioni in cui viene ospitato: in un appartamento di 35 metri quadrati nell'estrema periferia romana ne sono stati accatastati dieci, garantendo un reddito di oltre 12 mila euro al mese. Ancora una volta emergenza è diventata la parola magica per scavalcare procedure e controlli. Gli enti locali hanno latitato, tutto si è svolto per trattative privata: un mercato a chi si accaparrava più profughi. E il peggio deve ancora arrivare. I fondi finiranno a gennaio: se il governo non troverà una soluzione, i rifugiati si ritroveranno in mezzo alla strada. In Italia sono rimaste famiglie africane e asiatiche che lavoravano in Libia sotto il regime di Gheddafi. La prima ondata, composta soprattutto da giovani tunisini, ha preso la strada della Francia grazie al permesso umanitario voluto dall'allora ministro Roberto Maroni. Ma quando Parigi ha chiuso le frontiere, lo stesso Maroni ha varato una strategia federalista: ogni regione ha dovuto accogliere un numero di profughi proporzionale ai suoi abitanti (vedi grafico a pag. 39). A coordinare tutto è la Protezione civile, che da Roma ha incaricato le prefetture locali o gli assessorati regionali come responsabili del piano di accoglienza. Ma, nella fretta, non ci sono state regole per stabilire chi potesse ospitare i profughi e come dovessero essere trattati. Così l'assistenza si è trasformata in un affare: bastava una sola telefonata per venire accreditati come "struttura d'accoglienza" e accaparrarsi 1.200 euro al mese per ogni persona. Una manna per centinaia di alberghi vuoti, ex agriturismi, case-vacanze disabitate, residence di periferia e colonie fatiscenti. Dalle Alpi a Gioia Tauro, gli imprenditori del turismo hanno puntato sui rifugiati. A spese dello Stato. Le convenzioni non sono mai un problema: vengono firmate direttamente con i privati, nella più assoluta opacità. Grazie a questo piano, ad esempio, 116 profughi sono stati spediti, in pantaloncini e ciabatte, dalla Sicilia alla Val Camonica, a 1.800 metri di altezza. I proprietari del residence Le Baite di Montecampione non sono stati i soli a fiutare l'affare. Anche nella vicina Val Palot un politico locale dell'Idv, Antonio Colosimo, ne ha ospitati 14 nella sua casa-vacanze, immersa in un bosco: completamente isolati per mesi, non potevano far altro che cercare funghi. I più furbi hanno trattato anche sul prezzo. La direttiva ufficiale, che stabilisce un rimborso di 40 euro al giorno per il vitto e l'alloggio (gli altri 6 euro dovrebbero essere destinati all'assistenza), è arrivata solo a maggio. Nel frattempo, la maggior parte dei privati aveva già ottenuto di più. Gli albergatori napoletani sono riusciti a strappare una diaria di 43 euro a testa. Non male, se si considera che in 22 alberghi sono ospitate, ancora oggi, più di mille persone. «La domanda turistica al momento degli sbarchi era piuttosto bassa», ammette Salvatore Naldi, presidente della Federalberghi locale. La Protezione civile prometteva che sarebbero state strutture temporanee. Non è andata così: solo all'Hotel Cavour, in piazza Garibaldi, di fronte alla Stazione centrale, dormono tutt'ora 88 nordafricani. Le stanze, tanto, erano vuote: i viaggiatori si tengono alla larga, a causa dell'enorme cantiere che occupa tutta la piazza. Ma grazie ai rifugiati i proprietari sono riusciti lo stesso a chiudere la stagione: hanno incassato quasi 2 milioni di euro. I richiedenti asilo però non sono turisti, ma persone che hanno bisogno di integrarsi. La legge prevede che ci siano servizi di mediazione culturale, che sono rimasti spesso un miraggio o sono stati appaltati a casaccio:«A Napoli sono spuntate in pochi mesi decine di associazioni mai sentite nominare», denuncia Jamal Qadorrah, responsabile immigrazione della Cgil Campania: «Ogni albergatore poteva affidare i servizi a chi voleva, nonostante ci sia un albo regionale degli enti competenti. Tutti, puntualmente, ignorati». Non solo. «A luglio di quest'anno abbiamo organizzato un incontro fra il Comune e gli albergatori», racconta Mohamed Saady, sindacalista della Cisl: «Diverse strutture non avevano ancora un mediatore». Ed era passato più di un anno dall'inizio dell'emergenza. Il business dei nuovi arrivati non ha lasciato indifferenti nemmeno i professionisti della solidarietà. Cooperative come Domus Caritatis, che gestisce otto comunità solo a Roma. Anche i suoi centri sono finiti nel mirino di Save The Children e del garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio. Dopo numerose segnalazioni l'ong è andata a controllare 14 strutture della capitale che si fanno rimborsare 80 euro al giorno per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il risultato è un rapporto inquietante, presentato a maggio alla Protezione civile e al Viminale, che "l'Espresso" ha esaminato. Si parla di sovraffollamento, ma soprattutto di senzatetto quarantenni fatti passare per ragazzini scappati dalla Libia. Durante l'indagine sono stati intervistati 145 profughi. «Più di cento erano palesemente maggiorenni», denuncia l'autrice del rapporto, Viviana Valastro: «Quelli che avevo di fronte a me erano adulti. Altro che diciassettenni. Non posso sbagliarmi». Non solo. «Molti di loro erano in Italia da tempo, non da pochi mesi. Alcuni arrivavano dagli scontri di Rosarno». Doppia truffa insomma: sull'età e sulla provenienza, per avere un rimborso più che maggiorato e intascare milioni di euro. Tutto questo da parte di una cooperativa strettamente legata all'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e di San Trifone e a La Cascina, la grande coop della ristorazione che tre anni fa è stata al centro di un'inchiesta per il tentativo di entrare nella gestione dei cpt. Save The Children non è stata la sola a denunciare la situazione romana. Anche il presidente della commissione capitolina per la sicurezza, Fabrizio Santori, esponente del Pdl, ha dovuto occuparsi di Domus Caritatis. La cooperativa infatti gestiva una comunità che dava grossi problemi al vicinato, da cui arrivavano continue proteste. Santori l'ha visitata e si è trovato davanti ad alloggi di 35 metri quadri abitati da 10 persone. Peggio che in un carcere. Eppure gli appartamentini di via Arzana, a metà strada fra Roma e Fiumicino, più vicini all'aeroporto che alla città, permettevano di incassare più di 12 mila euro al mese. Save The Children ha calcolato che in strutture di questo tipo, nella capitale, vivono quasi 950 persone. Dati incerti, perché solo cinque cooperative hanno accettato di fornirli. Domus Caritatis, dalla sua sede all'abbazia trappista delle Tre Fontane, non ha voluto dare alcuna informazione. Il dossier dell'ong internazionale descrive un caos assoluto: mancanza di responsabili, nessun servizio di orientamento e accompagnamento legale, strutture inadeguate. Al Nord la situazione non cambia. A Milano si registrano casi come quello della ex scuola di via Saponaro, gestito dalla Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi, che ha accolto 150 rifugiati. Ospitati in una comunità per la cura dei senzatetto, l'accoglienza dei minori e degli ex carcerati: 400 persone, con esigenze diverse, costrette a vivere sotto lo stesso tetto in una vecchia scuola. «Le condizioni sono orribili: 10-12 letti per ogni camerata. E pieni di pidocchi e pulci», racconta un ragazzo ancora ospite. Le stanze sono inadatte perché costruite per ospitare alunni, non profughi, né tantomeno clochard che vivono in strada. «Un contenitore della marginalità sociale dove sono frequenti le risse: nigeriani contro kosovari, ghanesi contro marocchini e la lista dei ricoverati in ospedale si allunga ogni giorno», racconta chi è entrato tra quelle mura. Anche il personale è ridotto al minimo con pochi mediatori culturali (che spesso sono ex ospiti che non disdegnano le maniere forti per mantenere l'ordine), un solo assistente sociale e una psicologa per dieci ore alla settimana. Troppo poche per chi ha conosciuto gli orrori della guerra, le botte della polizia libica e porta sulla propria pelle i segni delle violenze. Anche i disturbi psichici abbondano, insieme all'alcolismo dilagante. A sette chilometri dai frati, 440 profughi hanno trovato alloggio a Pieve Emanuele, estrema periferia Sud di Milano. Qui sono stati ospitati nel residence Ripamonti, di proprietà del gruppo Fondiaria Sai, appena passata sotto il controllo di Unipol ma all'epoca saldamente in mano a Salvatore Ligresti. I clienti abituali dell'albergo sono poliziotti, guardie del vicino carcere di Opera o postini, che non bastano a riempire i 4 mila posti letto dell'albergo. Grazie all'emergenza però nelle settimane di massimo afflusso sono entrati nelle casse di Fonsai oltre 600 mila euro al mese. Vacanze forzate in alloggi confortevoli (le camere sono dotate anche di tivù satellitare) ma dove sono mancati completamente i corsi per imparare l'italiano o l'assistenza legale e psicologica. «Si poteva trovare una sistemazione più modesta e investire in altri sussidi» dice, banalmente, un ragazzo del Ghana. Oggi a Pieve Emanuele sono rimasti in 80. Ma nel frattempo al residence sono andati quasi sette milioni di euro. Lo Stato ha speso per l'emergenza 797 milioni di euro nel 2011 e altri 495 milioni nel 2012. Solo una parte è servita per l'accoglienza: centinaia di milioni di euro sono finiti in tendopoli, spostamenti, trasferte, rimborsi agli uffici di coordinamento. Fondi di cui si è persa la traccia. E sì che proprio per il buon uso dei soldi pubblici era stato istituito un "Gruppo di monitoraggio e assistenza", con il compito di visitare le strutture e segnalare i casi critici. Ma della task force degli ispettori dopo pochi mesi non si è saputo più nulla. «Noi facevamo parte del progetto ma da ottobre 2011 non siamo più stati convocati. Considerando che è partito ad agosto, il gruppo è durato meno di tre mesi», spiega a "l'Espresso" Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: «È mancato completamente il controllo da parte delle regioni e delle prefetture». La Corte dei conti della Calabria è andata oltre: ha messo nero su bianco che le convenzioni sottoscritte nella regione sono illegittime, perché non sono state sottoposte al controllo preventivo della Corte, obbligatorio anche nell'emergenza. Non solo. I giudici contabili di Catanzaro definiscono "immotivata" la diaria: 46 euro al giorno sono troppi. E pensare che in provincia di Latina sono riusciti a intascarseli quasi tutti spendendo solo 5 euro al giorno, per garantire a 75 profughi un misero piatto di riso. I cinque avidi gestori della cooperativa Fantasie sono stati arrestati dai carabinieri di Roccagorna. Insospettiti dall'aumento di stranieri in paese, i militari sono arrivati ad un casolare dove hanno trovato 46 persone alloggiate in 70 metri quadri. Nonostante il blitz la cooperativa ha continuato a ricevere i contributi della Regione Lazio per altri sei mesi: una truffa da 400 mila euro. Con le stesse risorse Aurelio Livraghi, volontario della Caritas di Magenta, in provincia di Milano, è riuscito a fare tutt'altro. «Milioni di italiani vivono con 1.200 euro al mese, perché loro no?». Osservazione semplice. Di un pensionato, che ha dedicato ai 35 profughi arrivati in paese le sue giornate. Persone oggi indipendenti: pagano un affitto, fanno la spesa, quattro di loro hanno già un lavoro. Recitano anche in teatro. Una vita normale: altro che emergenza. E quando finiranno i fondi? «Potranno andare avanti almeno un po' perché sono riuscito a fargli mettere da parte dei risparmi». Non era difficile, sarebbe bastato un minimo di organizzazione. E di umanità.
Mafia Capitale atto secondo: "Veltroni bene, ma co' Alemanno se pija de più". Mafia Capitale nella città corrotta. La politica capitolina al servizio de "er Cecato" e del suo braccio destro Buzzi. E le mazzette come chiave per entrare nei business che contano, scrive Giovanni Tizian su “L’Espresso”. Massimo Carminati e Riccardo Brugia Rutelli? «Noi abbiamo cominciato a cresce con lui». E Veltroni? «Diciamo con Veltroni siamo andati bene noi». Alemanno? «co Alemanno sotto certi aspetti se pija molti di più.. specialmente sul sociale». La consolidata infiltrazione di “mafia capitale” nell’amministrazione capitolina spiegata a un emissario della 'ndrangheta. Un'infiltrazione «essenziale ai fini dell’assegnazione dei lucrosi appalti pubblici indetti dal comune di Roma». L'atto secondo di Mafia Capitale è soprattutto la narrazione di un città in cui la corruzione è il concime che fa crescere piccoli o grandi fortune personali. Roma corrotta da capi bastone e da manutengoli del potere locale. Roma corrotta dall'ambizione di un uomo, Massimo Carminati “er Cecato”, che da delinquente della malavita romana con il mito del Duce è diventato modello, risorsa e valore aggiunto per molti imprenditori che grazie a lui hanno piegato pezzi importanti dell'amministrazione pubblica ottenendo così «un sacco di lavori», come ha ammesso, intercettato, il manager delle coop e braccio destro di Carminati, Salvatore Buzzi. Nell'ultima retata sono stati arrestate 44 persone (tra carcere e domiciliari) e altre 21 sono indagate dalla procura antimafia di Roma che coordina i carabinieri del Ros della Capitale in questa seconda tranche dell'indagine Mondo di mezzo. Un sistema governato dal clan di Massimo Carminati. «I fatti corruttivi spiegano e sono spiegati dal contesto in cui si muove l’organizzazione a seguito del mutamento della compagine politica di maggioranza nel consiglio comunale di Roma e la conseguente rimodulazione delle attività corruttive», si legge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari, che aggiunge: «In effetti, a seguito del mutamento nella maggioranza del Comune di Roma sortito dalle consultazioni elettorali, mafia capitale investe nell’acquisizione di nuovo capitale istituzionale, decisione strategica mimeticamente rappresentata dall’espressione di Carminati, a suo dire rivolta a Buzzi, del seguente tenore: “E allora mettiti la minigonna e vai a batte co' questi amico mio, eh... capisci”». Il lessico dell'organizzazione di Carminati rappresenta l'essenza del clan dall'animo trasformista e dalle pelle camaleontica. «Poi ce pigliamo e misure con Marino», è ancora Buzzi che detta la linea politica da intraprendere una volta chiusa l'era di Alemanno al Comune. Ma sempre «nel solco della linea strategica tracciata da Carminati di una rimodulazione dell’attività corruttiva in relazione ai diversi decisori pubblici». Il primo obiettivo raggiunto dall'imprenditore del clan è il Pd Mirko Coratti, in quel periodo presidente del Consiglio comunale. C'è anche Franco Figurelli, ex capo segreteria dell'assemblea capitolina, a libro paga della cosca. «Figurelli veniva retribuito con 1.000 euro mensili, oltre a 10.000 euro pagati per poter incontrare il Presidente Coratti, mentre a quest’ultimo venivano promessi 150.000 euro qualora fosse intervenuto per sbloccare un pagamento di 3 milioni sul sociale». Insomma, per usare le parole del re delle coop, «so’ tutti a stipendio...». I politici disposti al compromesso in fondo non sono altro che bovini da foraggiare: «La mucca che se non mangia non può essere munta», una metafora che Buzzi ricorda a Figurelli, il quale promettendo di ricordare il detto a Coratti, ne approffitta per chiedergli un favore: l'assunzione di un amica. Dell'assuzione si sarebbe interessato proprio Coratti, attivato a sua volta dal compagno della madre della ragazza, un consigliere dell'VIII municipio. Per sistemare due nipoti anche un dirigente del Comune, ha accettato di scendere a patti con Buzzi. Ma oltre ai favori e ai piaceri personali, questa vicenda è anche una storia di soldi. Gli investigatori del Ros guidati dal colonnello Stefano Russo rintracciano alcuni versamenti effettuati dalla cooperativa 29 giugno di Buzzi all'associazione che faceva capo a Coratti. Una sorta di fondazione, di quelle che oggi vanno tanto di moda tra gli esponenti dei partiti, per canalizzare le donazioni. D'altronde »il finanziamento pubblico è destinato a finire», osservano due fedelissimi di Buzzi. L'ex presidente dell'assemblea in cambio del denaro ricevuto ha, secondo gli inquirenti, abbracciato la causa del clan. In che modo? Appalti per i rifiuti, fondi pubblici e certezza che il Comune pagherà i debiti verso la coop. Oltre a Coratti e Figurelli, tra gli indagati c'è anche Massimo Caprari consigliere comunale del Centro democratico. Per lui l'organizzazione di Carminati aveva previsto mille euro al mese più benefit: «la promessa di erogazioni continuative di denaro, tra le quali quella costante di una percentuale dei lavori ottenuti dal Comune da parte delle cooperative riconducibili al Buzzi». La corruzione è servita a Buzzi & Co per ingraziarsi oltre che uomini del Pd anche alcuni del centrodestra. Il nome che spicca in questo nuovo capitolo di Mafia Capitale è Giordano Tredicine, 33 anni, consigliere comunale e vice coordinatore di Forza Italia nel Lazio. Rampollo della famiglia di venditori ambulanti che gestisce la massima parte dei camion bar della città. «Buzzi lamenta, in una conversazione con Gammuto, che se avesse vinto la maggioranza di centrodestra la sua scuderia sarebbe stata pronta e in essa indicava un ruolo specifico di Tredicine, oggi consigliere di minoranza all’Assemblea Capitolina». Insomma, il giovane era uno della scuderia, uno dei cavalli pregiati a cui il clan poteva affidare alcuni compiti. Secondo il ras della coop 29 giugno a destra pescavano a piene mani: «se vinceva Alemanno ce l’avevamo tutti comprati, partivamo a razzo,... c’amo l’assessore ai lavori pubblici, Tredicine doveva sta’ assessore ai servizi sociali, Cochi andava al verde, Cochi non è comprato però è un amico, Alemanno... che cazzo voi di più». Buzzi e il clan avevano istaurato con Tredicine "un rapporto di remunerazione corruttiva". Buzzi a Carmninati: «A Giordà se non te arrestano diventerai primo Ministro» me fa’ dice: ...li mortacci tua...te possono arresta’ (ride). Però come sto sul pezzo a Giordano non c’ho mai visto nessuno ehh.. credimi, mai nessuno». Persino nel feudo dei clan del litorale romano, Fasciani e Spada in primis, Mafia capitale è riuscita a comprare politici. «Le indagini svolte hanno consentito di verificare l’esistenza, nel X dipartimento, di decisori pubblici remunerati dall’organizzazione riconducibile a Buzzi, Carminati e Testa. Le risorse economiche pubbliche erano originariamente stanziate dalla regione, attribuite al comune, che, in parte, li smistava ai municipi», scrive il gip. Nella lista degli inquirenti è così finito il mini sindaco di Ostia, Andrea Tassone del Partito democratico, che nei mesi precedenti agli arresti si era lanciato in campagne per la legalità e contro le cosche. Stando all'inchiesta, un'antimafia di facciata. «Significativa, circa la individuazione in Tassone del capo di Solvi (faccendiere del politico), è la circostanza che egli sia stato delegato dal medesimo al controllo di voti e preferenze per conto della lista civica Marino alle elezioni comunali, secondo quanto si desume da fonti aperte», annotano gli investigatori. E sempre Solvi a «raccordare Buzzi e Tassone in vista dei loro incontri». Ma è proprio Buzzi a confessare il rapporto con Tassone: «Tassone è nostro, eh…è solo nostro..non c’è maggioranza e opposizione, è Mio». E poco dopo aggiunge: «perché noi pagamo tutti come vedi”...noi nell’ambito de ste cose..nell’ambito di questa monnezza pe tenè (fonetico) i voti gia semo arrivati a 43 mila euro, eh...Tassone 30...10 Alemanno 40». Tassone stipendiato? Secondo l'imprenditore legato al boss Carminati sì, e non sembra, a suo dire, accontentarsi: «Remunerazioni che evidentemente non bastavano, posto che Buzzi, qualche giorno dopo, riceve da Tassone una ulteriore richiesta di denaro, pari al 10% del valore di un affidamento. Uno dei motivi della sua visita ad Ostia veniva svelato dallo stesso Buzzi che, si lamentava che il “Presidente” (del X Municipio, Andrea Tassone) gli avesse chiesto il “10% in nero”». Le richieste a Tassone, per il tramite del faccendiere Solvi, sono tutte finalizzate a ottenere favori e agevolazioni dal X municipio. Anche qui le «mucche» hanno bisogno di cibo per poi ottenere più latte. Secondo Buzzi l'accoglienza dei migranti è un business più remunerativo della droga. E anche meno rischioso. Tra gli espisodi di corruzione elencati negli atti della procura antimafia di Roma diversi riguardano proprio l'emergenza abitativa e l'accoglienza dei migranti. Uno degli episodi raccolti dagli inquirenti ruota attorno alla Società Cooperativa Deposito locomotive di Roma San Lorenzo, «oberata di debiti, assillata dalla necessità di dover pagare cambiali, con asset invenduti costituiti da 14 appartamenti in zona Case Rosse – Settecamini». Il politico di riferimento del clan è in questo caso Daniele Ozzimo, ex assessore comunale alla Casa, in quota Pd, mentre il dirigente comunale è Guido Magrini, Direttore del dipartimento delle Politiche Abitative. Il sospetto dei magistrati è che l'assessore abbia chiesto a Buzzi «150. mila euro per risollevare le sorti di una cooperativa, in cambio del mantenimento di una convenzione relativa all’emergenza alloggiativa assai remunerativa per Buzzi». «Tocca vede’, nei limiti del possibile, salva’ sta cooperativa. Stamo a parla’ di centocinquantamila euro entro venerdì», riferisce l'imprenditore a un sodale, che chiede chiarimenti: «Senti, ma in cambio di centocinquanta, qual è il beneficio o l’opzione per noi?». E Buzzi risponde: «che tu opzioni gli appartamenti, no? Loro c’hanno quattordici appartamenti invenduti». Luca Odevaine invece (già arrestato nel primo filone d'inchiesta), era l'esperto dell'affare immigrazione. «Aveva instaurato rapporti di natura corruttiva con esponenti del gruppo imprenditoriale “La Cascina” mettendo a disposizione di tale gruppo il suo ruolo istituzionale di appartenente al Tavolo di Coordinamento Nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché il suo ruolo di componente delle tre commissioni di gara per l’aggiudicazione dei servizi di gestione del C.a.r.a. di Mineo, ricevendo in cambio la promessa di una retribuzione fissa mensile determinata in una prima fase in 10 mila euro ed elevata a 20mila dopo l’aggiudicazione della gara del 7 aprile 2014». La cooperativa vicina a Comunione e Liberazione è una holindg con un fatturato enorme. Partita come mensa per gli studenti ora gestisce ospedali, hotel, pasticcerie, catering. Odevaine era dunque stipendiato da Buzzi e dalla Cascina. Interrogato dopo l'arresto ai pm ha dichiarato: «Quello che facevo io …. era di facilitare il Ministero da una parte nella ricerca degli immobili che potessero essere messi a disposizione per l'emergenza abitativa». E Le somme di denaro (anche nella forma di pagamento dell'affitto di immobili) che ha ammesso aver percepito da Buzzi? Semplice. Li riceveva per l'attività che svolgeva per conto della sua cooperativa, di «facilitatore dei rapporti con la pubblica amministrazione … in ragione delle mie conoscenze maturate nel tempo». Il centro per richiedenti asilo di Mineo è una gallina dalle uova d'oro per gli imprenditori dell'accoglienza. Hanno capito che speculare è possibile sul villaggio della solidarietà inventato dal governo Berlusconi e dall'allora ministro dell'Interno Roberto Maroni. Odevaine nei dialoghi intercettati spiega ai suoi interlocutori il metodo per mascherare le tangenti. Attraverso i subappalti affidati a ditte amiche che poi avrebbero gonfiato le fatture oppure attraverso la sovrafatturazione sfruttando una società di import export dello stesso Odevaine: «Altra ipotesi può darsi, può essere con la ... con l'impresa questa mia di import export, loro comprano alcune cose all'estero, tipo il caffè per esempio...quei soldi rimangono fuori e lì non ce l'ho le rotture di coglioni che ci sono qua, nel senso che se i soldi stanno lì, stanno nella società e io li prendo personalmente non succede un cazzo». E' sempre l'esperto di immigrazione, poi, a spiegare come versare le mazzette: «fallo... in più tranche però lo puoi fare, dici questi ce l'avevo in cassa». Per avere successo servono le relazioni. Odevaine conosce a fondo gli equilibri politici. Sostiene di essere stato lui a mettere in contatto La Cascina con il sottosegretario Giuseppe Castiglione. «Per cui ho conosciuto loro gliel'ho presentati a Castiglione... Castiglione si è avvicinato molto a Comunione e Liberazione, insieme ad Alfano e adesso loro ... Comunione e Liberazione di fatto sostiene strutturalmente tutta questa roba di Alfano e del Centro Destra ...Castiglione». Il suo interlocutore a questo punto gli chiede: «Comunione e Liberazione appoggia Alfano?». Odevaine ribatte: Sì, stanno proprio finanziando ... sono tra i principali finanziatori di tutta questa...questa roba si ... e Lupi è infatti è il Ministro delle Opere Pubbliche e Castiglione fa il sottosegretario ... all'Agricoltura ed è il loro principale referente in Sicilia ... cioè quello che poi gli porta i voti ... perché poi i voti loro ce li hanno tutti in Sicilia». Per vincere le gare sull'accoglienza il gruppo di Carminati non badava a spese. E pagava chiunque potesse agevolare i propri interessi. Secondo gli inquirenti anche il sindaco Fabio Stefoni di Castelnuovo di Porto avrebbe ottenuto una lauta ricompensa. Il patto, secondo gli investigatori, consisteva nel pagamento di una somma « a titolo di contributo elettorale e dalla promessa di dazione di 0,50 Euro per immigrato al giorno, da parte di Buzzi per indurre Stefoni a consentire o, comunque, a non opporsi all’apertura di un centro di accoglienza a Borgo del Grillo, nel comune di Catelnuovo di Porto».
Capitale corrotta, nazione infetta. Il celebre titolo de “l'Espresso” ha compiuto 60 anni ma continua a essere di un'attualità sconcertante.
Per il Pd a rubare sono sempre gli altri. Renzi si erge a paladino della legalità: "Chi viola le regole, deve pagare tutto". Ma il Pd non fa mea culpa. Marino: "Vado avanti, ho fatto pulizia". E Orfini chiama in causa i servizi segreti, scrive Sergio Rame su “Il Giornale”. Mafia Capitale, si sa, è cosa di tutti. Gli arresti riguardato l'intero spettro politico. Ci mangiavano tutti. Pochi erano gli esclusi dal banchetto. Ma alla mangiatoia, per usare la metafora di Salvatore Buzzi, un posto privilegiato ce l'aveva proprio il Partito democratico con i suoi esponenti locali, i suoi amministratori e le sue cooperative. Diciannove persone in carcere, 25 ai domiciliari, altre 21 indagate a piede libero e altrettante perquisizioni. Provoca l’ennesimo terremoto la seconda tranche dell’inchiesta denominata "Mafia Capitale" che già lo scorso dicembre aveva fatto scattare le manette ai polsi di 37 indagati, con il coinvolgimento di altri 40. Ancora una volta, l’ex terrorista dei Nar Massimo Carminati e il presidente della cooperativa "29 giugno" Salvatore Buzzi risultano i pezzi da novanta dell’ordinanza di custodia cautelare del gip Flavia Costantini, eseguita all’alba dai carabinieri del Ros. La novità è che sono stati chiamati in causa esponenti delle istituzioni, di destra e di sinistra, del Campidoglio a della Regione Lazio: risultano tutti a libro paga dell’organizzazione di stampo mafioso che a Roma faceva affari di ogni tipo e si aggiudicava i migliori appalti. "Un Paese solido è quello che combatte la corruzione come sta avvenendo in Italia con decisione e forza - commenta il premier Matteo Renzi - mandando chi ruba in galera, perchè è giusto che chi ha violato le regole paghi tutto e fino all’ultimo giorno". Ma sono solo dichiarazioni di circostanza. Perché, come dice anche il commissario del Pd romano Matteo Orfini, al Nazareno sono convinti che a rubare siano sempre glia altri. "Le amministrazioni di Marino e Zingaretti - commenta Orfini in conferenza stampa - sono state un baluardo della legalità". Eppure, aldilà di Luca Gramazio, ex consigliere capogruppo Pdl in consiglio comunale e poi in Regione, la seconda "retata" di Mafia Capitale ha fatto scattare le manette ai polsi di numerosi esponenti dem. Tra questi spiccano Mirko Coratti, ex presidente del consiglio comunale in quota Pd, dimessosi a dicembre dopo la prima ondata di arresti, e il suo capo segreteria, Franco Figurelli. Per i pm, avrebbero ricevuto la promessa di 150mila euro, la somma di 10mila e l’assunzione di una persona segnalata da Coratti in cambio di una serie di favori da fare alle cooperative di Buzzi. In cella anche Daniele Ozzimo, ex assessore piddì alla Casa, Angelo Scozzafava, ex capo del quinto dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della salute di Roma, e Pierpaolo Pedetti, anche lui eletto consigliere comunale nel 2013 con il Pd, presidente della Commissione Patrimonio. Insomma, al pari di altre forze politiche, il Pd continua a comparire nelle carte dell'inchiesta. Eppure Orfini resta ancora convinto che non ci siano le condizioni per sciogliere il Comune di Roma, "perché questo significherebbe andare incontro alle richieste della criminalità". Dal canto suo, il sindaco di Roma Ignazio Marino rivendica il "cambiamento epocale" della sua giunta e si dice soddisfatto "della legalità contabile che abbiamo portato nella nostra città". "Continuiamo in questo modo - commenta il primo cittadino di Roma - la linea amministrativa che abbiamo assunto in questi due anni di governo sta dimostrando che veramente stiamo cambiando tutto". Per difenderlo, Orfini chiama addirittura in causa i servizi segreti: "Chiederò al Copasir di occuparsi della vicenda per capire come i servizi segreti non si siano accorti di cosa stesse facendo una persona a loro evidentemente nota come Carminati» e di come «abbia potuto costruire un sistema criminale di tale entità". Ma il teorema non regge proprio. "Che cos’altro deve accadere perché Marino se ne vada e si torni alle urne?", replica il leader della Lega Nord Matteo Salvini che vede proprio nel sindaco piddì il primo responsabile. Anche il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni di Marino: "Questa è l’ennesima prova che il sistema dei partiti è totalmente marcio, ivi incluso il Pd romano".
Fuoriluogo, scrive Franco Corleone su “L’Espresso”. L'onestà politica secondo Benedetto Croce. L’invocazione ossessiva dell’onestà è ben giustificata da mille episodi della cronaca del malaffare e però un bagno di razionalità può essere utile. Leggere il saggio di Benedetto Croce presente nel volume Etica e politica appare dissacrante di tanti luoghi comuni. “Un’altra manifestazione della volgare inintelligenza circa le cose della politica è la petulante richiesta che si fa dell’onestà nella vita politica”, così esordisce il filosofo e prosegue contestando la deriva per un Paese di affidare la cosa pubblica a onesti uomini tecnici. Croce definisce strana la pretesa che nelle cose della politica si chiedano non uomini politici ma onest’uomini. “Ma che cosa è, dunque, l’onestà politica?- si domanderà. L’onestà politica non è altro che la capacità politica: come l’onestà del medico e del chirurgo, è la sua capacità di medico e di chirurgo, che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze”. Vale la pena di leggere gli esempi della storia che presenta Croce per giustificare la sua posizione, ma soprattutto è istruttiva la sua conclusione: la disonestà coincide con la cattiva politica, con l’incapacità politica. Una tesi paradossale che esalta la politica e in tempi di crisi, di vero abisso della politica, rappresenta una lezione aristocratica.
Mafia Capitale, la Procura: "Rubano tutti". Gli arresti posticipati per non influenzare il voto delle regionali, scrive Claudia Fusani su L'Huffington Post. "Rubano tutti, ecco il filo rosso di questa seconda parte dell'inchiesta....". A piazzale Clodio, sede della procura capitolina, il procuratore Pignatone non riceve i giornalisti e tutti i pm coinvolti, l'aggiunto Prestipino, i pm Luca Tescaroli, Giuseppe Cascini e Paolo Ielo, declinano gentilmente dichiarazioni e commenti. "Rubano tutti" resta l'amara constatazione dopo mesi di indagine e dopo aver riscontrato le dichiarazioni a verbale di numerosi manager e imprenditori che hanno spiegato "il sistema di potere trasversale ad ogni partito e maggioranza" che ha gestito ogni affare nella Capitale almeno negli ultimi dieci anni. Proprio per questa trasversalità, è stato chiaro a tutti che la seconda parte di Mafia capitale avrebbe avuto ricadute pesanti nelle settimane prima del voto già infuocate da una campagna elettorale durissima. "Abbiamo ritenuto necessario, per non influire sul voto, attendere la chiusura delle urne prima di procedere agli arresti" afferma una fonte in procura. Lo dimostrano le date: la richiesta della procura risale a marzo, l'ordinanza è stata firmata il 29 maggio, venerdì, quando già imperversava sul voto la lista dell'Antimafia. Attendere qualche giorno non avrebbe cambiato nulla. E così è stato deciso. Se in Mafia capitale parte Prima è stato protagonista Il sistema delle cooperative rosse che faceva capo a Salvatore Buzzi, nella parte Seconda la parte del leone la fanno le cooperative bianche. Al centro di molti passaggi dell'ordinanza lunga 500 pagine c'è infatti La Cascina, cooperativa bianca che fa riferimento a Comunione e Liberazione. Tra i 44 arresti di questa mattina per corruzione e concussione aggravati dalla modalità mafiosa, anche Menolascina, manager della cooperativa. Secondo l'accusa, la cooperativa garantiva un premio mensile di 10 mila a Lica Odevaine in quanto il tecnico che garantiva, dal tavolo nazionale per l'emergenza immigrazione, la gestione degli appalti per i centri profughi e immigrati. Una volta che La Cascina ha ottenuto l'appalto del Cara di Mineo (7 aprile 2014), il premio per Odevaine è stato raddoppiato (20 mila euro mensili). La cooperativa è emersa anche in un'altra delicata inchiesta del Ros dei Carabinieri: quella che ha portato in carcere Ettore Incalza, il super direttore generale del ministero delle Infrastrutture, e ha costretto alle dimissioni l'ex ministro Lupi (che non è mai stato indagato).
Il tariffario delle tangenti: “Un euro a migrante”, scrive “La Stampa”. Le intercettazioni del Ros svelano le mazzette. Il ras delle coop sociali Buzzi al telefono: «La mucca deve mangiare per essere munta». Mucche da mungere solo se ben foraggiate. Salvatore Buzzi, presidente della Cooperativa 29 giugno e in carcere per l’inchiesta di Mafia Capitale dello scorso anno, così si esprimeva al telefono con altri indagati. A pagina 21 dell’ordinanza del gip Flavia Costantini, che conta 500 pagine, si legge che «ha ricevuto l’eloquente risposta che la mucca era stata ben foraggiata dall’attività di Coratti (ex presidente del consiglio comunale ndr) considerazione alla quale altrettanto eloquentemente Buzzi ribadiva che «la mucca era stata munta tanto». Nell’ordinanza, che riporta appunto le intercettazioni telefoniche, viene evidenziato che ciò «è un’eloquente dimostrazione di un rapporto corruttivo continuativo nel tempo». «Le erogazioni di utilità di Buzzi, esecuzione della linea strategica delineata di concerto con Massimo Carminati - si legge nel provvedimento - avevano l’evidente funzione di asservire agli interessi del gruppo politici che gravitavano nei segmenti delle istituzioni maggiormente interessati ai rapporti con il gruppo medesimo». Ma la 29 giugno non è l’unica cooperativa interessata dalla «mungitura della mucca», il giudice scrive, infatti, ancora: «Gli esponenti del gruppo La Cascina (coop attiva, dal 2012, anche nel settore dei servizi per l’immigrazione, e oggetto questa mattina di perquisizione da parte dei carabinieri del Ros, ndr) avevano promesso a Luca Odevaine una retribuzione fissa mensile, concordata prima in 10mila euro al mese e poi aumentata a 20mila euro e commisurata al numero di immigrati ospitati dai centri gestiti dal gruppo». La cifra - spiega il Gip - è il «prezzo per lo stabile asservimento della sua funzione di pubblico ufficiale componente del Tavolo di Coordinamento sull’immigrazione istituito presso il ministero degli Interni» e «per il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio come componente delle commissioni di aggiudicazione delle gare indette per la gestione dei servizi presso il Cara di Mineo». L’effettiva, periodica consegna delle somme pattuite, sarebbe confermata dalle intercettazioni ambientali e, «con certezza», in «almeno cinque episodi», dalle indagini tecniche. La conferma arriva dalle stesse parole di Odevaine, intercettato nell’ambito dell’inchiesta: «...altre cose in giro per l’Italia... possiamo pure quantificare, guarda ... se me dai ... cento persone facciamo un euro a persona ... non lo so, per dire, hai capito? E ...e basta, uno ragiona così dice va be’ ... ti metto 200 persone a Roma, 200 a Messina ... 50 là ... e ... le quantifichiamo, poi...». Questo è lo stralcio di una conversazione con alcuni suoi collaboratori intercettata nella sua stanza negli uffici della Fondazione IntegraAzione, grazie al quale il gip Flavia Costantini prospetta l’esistenza di «un vero e proprio tariffario per migrante ospitato». A titolo esplicativo Odevaine parla dell’accordo stretto, tra gli altri, con Salvatore Buzzi, presidente della Cooperativa 29 giugno e spiega: «Gli ho fatto avere altri centri, in Sicilia... in provincia di Roma e quant’altro, quindi su tutto quella... quella parte là ci mettiamo d’accordo dovremo..., più o meno, stiamo concordando una cifra tipo come 1 euro a persona, ci danno, calcolando che so’ almeno un migliaio di persone, dovrebbero essere grosso modo un migliaio di persone, insomma so’ 1000 euro al giorno quindi 30.000 euro al mese che entrano...». Costantini sottolinea come Le indagini dei carabinieri del Ros abbiano evidenziato «la straordinaria pericolosità di Luca Gramazio». L’amministratore di centrodestra «potrebbe sfruttare la rete ampia dei collegamenti per fornire nuova linfa alle attività delittuose e agli interessi dell’associazione» capeggiata da Massimo Carminati, «nonostante lo stato detentivo di numerosi sodali». In un altro passaggio viene evidenziato come per le elezioni al parlamento europeo del maggio 2014, Gianni Alemanno, chiese l’appoggio a Salvatore Buzzi. Quest’ultimo si sarebbe mosso per ottenere il sostegno alla candidatura anche con gli uomini della cosca `ndranghetista dei Mancuso di Limbadi. «Un ulteriore tassello idoneo a corroborare il rapporto di reciproco riconoscimento tra le due organizzazioni - scrive il giudice - è costituito dai riscontri intercettivi effettuati in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo 2014, che hanno visto il politico Giovanni Alemanno, candidato nella lista «Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale», nella circoscrizione Sud». Buzzi, in una conversazione con Massimo Carminati, intercettata il 21 marzo del 2014, riferiva l’esito di un incontro avuto poco prima con Alemanno negli uffici della «Commissione Commercio» a Roma. «Buzzi - scrive il gip - riferiva del sostegno richiesto in quell’occasione dall’ex primo cittadino («no, no era pe’ la campagna elettorale ... una sottoscrizione e poi se candida al sud») e rappresentava al sodale come avesse individuato Campennì, indicato con il solo nome di battesimo, quale strumento idoneo per assecondare tale richiesta (».. da Giovanni ... gli famo fa ..«). Buzzi, il giorno seguente contattava «Giovanni Campennì, al fine di interessarlo per «da ’na mano a Alemanno ... in campagna elettorale ...«. Il tentativo «di Buzzi di mascherare, in maniera evidentemente strumentale con l’interlocutore («sto numero è intercettato ... però so telefonate legali ..»), l’illecita richiesta pervenutagli, facendola passare come innocua e legittima istanza volta ad ampliare il consenso elettorale (»? basta che non sia voto di scambio .... tutto è legale ... uno po’ vota’ gli amici???!!!»), nell’ambito di una circoscrizione elettorale particolarmente ampia («? mica può venire li!!! Scusa ... no perché la circoscrizione è grandissima .... è Abruzzo .... Campania .... la Calabria .... Puglia .... Basilicata ..... come cazzo fa? ... èèè ....»), veniva perfettamente compreso da Campennì, il quale, avendo evidentemente ben inteso il vero senso della richiesta («ah ste chiamate so legali??? ...»), aderiva prontamente alla richiesta, non potendo evitare, tuttavia, di sottolineare la propria capacità di poter attingere a un ampio bacino di consensi pilotabili, facendo ricorso a una metafora particolarmente espressiva («va bene .... allora .... è qua la famiglia è grande ... un voto gli si dà»).
Mafia Capitale, 44 arresti tra politica e affari. In manette anche big di Pd e Forza Italia. Seconda ondata di provvedimenti cautelari nell'inchiesta sulla malavita romana. Tra i reati contestati associazione mafiosa, corruzione, turbativa d’asta e false fatturazioni. Tanti i nomi della politica locale coinvolti, scrive Lirio Abbate su L’Espresso”. Il clan mafioso di Massimo Carminati aveva in pugno politici regionali e comunali attraverso i quali riusciva a gestire appalti e incassare milioni di euro di soldi pubblici. Su Roma si abbatte così il secondo atto giudiziario di mafia Capitale, con 44 arresti eseguiti stamani dai carabinieri del Ros che hanno condotto le indagini, coordinate dalla procura antimafia di Roma. E così, accanto al cecato, compaiono nel provvedimento cautelare il capogruppo prima del Pdl e poi Forza Italia alla Regione, Luca Gramazio, ma anche l'ex presidente del consiglio comunale Mirko Coratti e l'ex minisindaco di Ostia Andrea Tassone, entrambi del Pd. Ma c'è anche l'ex consigliere comunale del Pdl Gerardo Tredicine. E poi soci e amministratori di cooperative bianche che si erano aggiudicati incarichi per l'emergenza immigrati. Mafia Capitale secondo atto: i carabinieri del Ros hanno eseguito 44 nuovi arresti tra Lazio, Abruzzo e Sicilia. I reati contestati sono associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori ed altro. Il blitz è scatato all'alba nelle province di Rieti, Frosinone, l'Aquila, Catania ed Enna. Altre 21 persone risultano indagate. Su di loro sono in corso perquisizioni. uesta seconda tornata di arresti, secondo gli inquirenti, "conferma l'esistenza di una struttura mafiosa, operante nella capitale, cerniera tra ambiti criminali ed esponenti degli ambienti politici, amministratori ed imprenditori locali". Tra gli arrestati ci sono anche il consigliere regionale di Fi, Luca Gramazio, l'ex presidente del consiglio comunale di Roma, Mirko Coratti, l'ex assessore Daniele Ozzimo, Giordano Tredicine e l'ex presidente del municipio di Ostia, Andrea Tassone. Sono dunque 44 le persone arrestate (fra detenzione in carcere e quella domiciliare) con le accuse a vario titolo di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d’asta, false fatturazioni, con l’aggravante delle modalità mafiose. E poi ci sono altre 21 persone indagate per le quali sono scattate stamani le perquisizione. Gli interventi dei carabinieri sono stati effettuati nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, L’Aquila, Catania e Enna.Salvatore Buzzi parla con Massimo Carminati e gli dice che i consiglieri comunali dovevano stare ai loro ordini poiché vengono pagati e, pertanto, devono rispettare gli accordi perché "se non rispetti gli accordi, lo sai da dove vengo". Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, in questa nuova fase, hanno permesso di acquisire ulteriori elementi sul metodo mafioso attuato dal clan Carminati, confermato anche dalle testimonianze rese da diversi imprenditori vittime. È questa un'altra grande sorpresa: la collaborazione di molte delle vittime del clan. Gli imprenditori chiamati nei mesi scorsi dagli investigatori non hanno negato di aver subito pressioni o violenza ed hanno parlato, facendo cadere lo strano di omertà che aveva avvolto molti altri. E grazie alle indagini è stata confermata la centralità nel clan Carminati di Salvatore Buzzi, che era a capo di una rete di cooperative sociali che si sono assicurate, nel tempo, mediante pratiche corruttive e rapporti collusivi, numerosi appalti e finanziamenti della Regione Lazio, del Comune di Roma e delle aziende municipalizzate. Un giro di affari per 150 milioni di euro solo con il Campidoglio. Il consigliere Luca Gramazio è accusato di associazione mafiosa «in qualità di esponente della parte politica che interagiva, secondo uno schema tripartito, con la componente imprenditoriale e quella propriamente criminale».La malavita romana lucra sulla pelle dei più poveri, e gli ultimi arresti dimostrano quanto il sistema fosse capillare. Per fortuna c'è anche chi si ribella all'omertà che dilaga a Roma. Il nostro inviato spiega come si evolve l'inchiesta "Mondo di mezzo". Gramazio prima nella carica di capogruppo Pdl al Consiglio comunale di Roma ed in seguito come capogruppo Pdl (poi Forza Italia) presso il Consiglio Regionale del Lazio, sfruttando la propria appartenenza alle due assemblee amministrative e la conseguente capacità di influenza nell’ambiente istituzionale «poneva in essere condotte strumentali al conseguimento degli scopi del sodalizio».
Mafia Capitale, le nuove telefonate. «La mucca tu la devi mungere, però gli devi dà da mangià». La metafora di Buzzi per spiegare il sistema delle tangenti, scrive Giovanni Bianconi su “Il Corriere della Sera”. Sono ancora una volta le intercettazioni telefoniche e ambientali nelle quali Salvatore Buzzi racconta il suo ruolo di corruttore a comporre il secondo capitolo di Mafia Capitale, che arriva dritto nel governo di Roma (cinque consiglieri comunali arrestati e altri indagati, insieme a funzionari di vari livelli finiti anch’essi in carcere), della Regione dove pure sarebbero stati siglati “accordi spartitori”, e del sistema di gestione dell’emergenza immigrati. Secondo i pubblici ministeri della Procura di Roma e il giudice dell’indagine preliminare che ha concesso i nuovi arresti – basati su ulteriori accertamenti e verifiche svolte dai carabinieri del Ros – l’organizzazione guidata dal “signore delle cooperative” Buzzi e dall’ex estremista nero Massimo Carminati ha esteso la propria rete corruttiva in maniera sempre più trasversale, passando senza problemi dall’amministrazione capitolina di centro-destra, quando era sindaco Gianni Alemanno, a quella di centro-sinistra, guidata da Ignazio Marino. Continuando a comprare, attraverso consistenti somme di denaro e “altre utilità”, gli amministratori e i funzionari che servivano a pilotare le gare e ottenere l’assegnazione degli appalti. E così, per un buon numero dei nuovi inquisiti è scattata l’aggravante di aver favorito, grazie alla “vendita” delle proprie funzioni, “l’associazione mafiosa diretta da Carminati”, già riconosciuta come tale da una pronuncia della corte di cassazione. Secondo il giudice Flavia Costantini che ha firmato la nuova ordinanza d’arresto, le frasi pronunciate da Buzzi nei dialoghi con Carminati e altri personaggi coinvolti nei “di mezzo”, “di sopra” e “di sotto” scoperchiati dall’inchiesta, rivelano “circostanze veritiere”, che peraltro hanno trovato riscontro nelle indagini degli investigatori del Ros. In una telefonata del 15 ottobre 2014 – un mese e mezzo prima degli arresti del 2 dicembre – il manager delle cooperative parlava con Franco Figurelli, all’epoca appartenente alla segreteria del presidente del consiglio comunale Mirko Coratti, e prendendo spunto dalla richiesta di assunzione per una ragazza avanzata da Figurelli, rendeva chiara la sua filosofia.
Buzzi: “Ahò ma, scusa ma lo sai... la sai la metafora?
Figurelli: “Eh…”.
Buzzi: “La mucca deve mangiare”.
Figurelli: “Ahò, questa metafora io glielo dico sempre al mio amico, mi dice: ‘non mi rompere, perché se questa è la metafora lui ha già, già fatto, quindi non mi rompere’...”.
Buzzi: “Ma... fai fa... fagli un elenco...
Figurelli: “Salvatò…”
Buzzi: “Fagli un elenco della mangiatoia, digli, oh” (ridono)
Figurelli: “Salvatò, te voglio be... già me rompe… dice: ‘E’ possibile che Salvatore a noi ce risponde così?’, ho detto: ‘Ahò, che te devo di’, gli ho detto, ‘questa è la metafora che me dà il cammello e della cosa… quindi che te devo fà?’” (…)
Buzzi: “Sì, ma io investo su di te, lo sai che investo su di te”.
Figurelli “Eh, meno male” (…)
Buzzi: “Ahò, però diglielo: ‘guarda che ha detto Buzzi che qui la mucca l’avemo munta tanto… (sovrapposizione di voci)”.
In altre occasioni, e parlando con altri personaggi, Buzzi tornava spesso sulla stessa metafora, per spiegare – nell’interpretazione dell’accusa – che politici e funzionari dovevano foraggiare le sue cooperative (attraverso gli appalti) per poi ricavarne qualcosa anche per loro (le tangenti): “Se la mucca non mangia non può essere munta”; “La mucca tu la devi mungere, però gli devi dà da mangià”; “La mucca può essere munta solo se mangia”. Secondo l’accusa che ora li ha portati in carcere, Figurelli e Coratti (i quali hanno cambiato incarico dopo la retata di dicembre) ricevevano un vero e proprio “stipendio” per mettere le proprie funzioni al servizio del gruppo guidato da Buzzi e Carminati. I quali, con il cambio di maggioranza in Campidoglio, hanno dovuto “investire nell’acquisizione di nuovo capitale istituzionale”. In un’altra conversazione intercettata, dopo un lungo elenco di nomi e di cifre lo stesso Buzzi, afferma: “Perché noi pagamo tutti, come vedi”. E il 17 novembre scorso, appena 15 giorni prima di essere arrestato nell’operazione del 2 dicembre, faceva proclami agguerriti, che nel linguaggio evocano espressioni da Romanzo criminale: “Noi comunque … ti dico una cosa… lui (Marino ndr) se resta sindaco altri tre anni e mezzo, con il mio amico capogruppo ci mangiamo Roma”.
Secondo capitolo dell'inchiesta Mondo di Mezzo della procura di Roma e dei carabinieri del Ros: 44 gli arresti in corso di esecuzione in Sicilia, Lazio e Abruzzo per associazione per delinquere ed altri reati. Ventuno gli indagati a piede libero. Sullo sfondo il business legato ai flussi migratori e alla gestione dei campi di accoglienza per migranti, scrive Panorama. Il blitz dei carabinieri è scattato all'alba nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Catania ed Enna. Nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della procura distrettuale antimafia di Roma, e del gip Claudia Costantini, vengono ipotizzati a vario titolo i reati di associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori ed altro. Contestualmente agli arresti altre 21 persone sono state perquisite in quanto indagate per gli stessi reati. I provvedimenti riguardano gli sviluppi delle indagini condotte dal Ros nei confronti di Mafia Capitale, il gruppo mafioso riconducibile a Massimo Carminati, ora in carcere. Secondo gli investigatori, gli accertamenti successivi a quella tornata di arresti hanno confermato "l'esistenza di una struttura mafiosa operante nella Capitale, cerniera tra ambiti criminali ed esponenti degli ambienti politici, amministrativi ed imprenditoriali locali". In particolare le indagini hanno documentato quello che gli inquirenti definiscono un "ramificato sistema corruttivo finalizzato a favorire un cartello d'imprese, non solo riconducibili al sodalizio, interessato alla gestione dei centri di accoglienza e ai consistenti finanziamenti pubblici connessi ai flussi migratori. Secondo il magistrato, Luca Gramazio "svolge un ruolo di collegamento tra l'organizzazione da un lato e la politica e le istituzioni dall'altro, ponendo al servizio della stessa il suo 'munus publicum' e il suo ruolo politico". Un collegamento che, sul piano politico, si traduce nella costruzione del consenso necessario ad assecondare gli affari del sodalizio; sul piano istituzionale, si materia di iniziative formali e informali intese per un verso a collocare nei plessi - sensibili per l'organizzazione - dell'amministrazione pubblica soggetti graditi, per altro verso nell'orientare risorse pubbliche in settori nei quali il sodalizio, in ragione del capitale istituzionale di cui dispone, ha maggiori possibilità di illecito arricchimento. Egli, inoltre, "elabora insieme ai vertici dell'organizzazione le strategie di penetrazione della pubblica amministrazione". Infine, sostiene ancora il gip, il consigliere regionale, "riceve dall'organizzazione per un verso una costante erogazione di utilità, per altro verso protezione e sicurezza in tutti quei casi in cui si rende necessario". Secondo gli inquirenti della Procura di Roma sarebbero state versate a Luca Gramazio mazzette per oltre 100mila euro dal gruppo guidato da Massimo Carminati. In particolare nella contestazione presente nell'ordinanza del gip Costantini si spiega che il consigliere regionale avrebbe avuto "98mila euro in contanti in tre tranches (50.000-28.000-20.000)"; ma anche "15mila euro con bonifico per finanziamento al comitato Gramazio". Inoltre, anche per "l'assunzione di 10 persone, cui veniva garantito nell'interesse di Gramazio uno stipendio; la promessa di pagamento di un debito per spese di tipografia". A carico di Gramazio jr è ipotizzata "l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso indicata al capo 23". "Il ruolo di Luca Gramazio, quale personaggio vicino all'associazione in esame, era già emerso, ma è stato possibile solo successivamente, con un ulteriore e più approfondito vaglio del materiale investigativo, delineare il ruolo dello stesso all'interno dell'associazione, che può ricondursi al capitale istituzionale di Mafia Capitale" ha affermato Costantini, nell'ordinanza di custodia cautelare che riguarda anche il consigliere regionale. Delle perquisizioni in corso nell'ambito di Mafia Capitale, una riguarda la cooperativa "La Cascina", vicina al mondo cattolico. Gestisce tra l'altro il Cara di Mineo, in Sicilia. La perquisizione rientra nel quadro degli accertamenti sulla gestione degli appalti per i rifugiati. I Ros hanno poi perquisito anche gli uffici della Manutencoop a Zola Predosa (Bologna). Secondo quanto si apprende i militari del comando emiliano-romagnolo agiscono su delega della Procura di Roma e oggetto del loro interesse è il sequestro della documentazione in un ufficio, un faldone relativo ad una singola gara che si è tenuta a Roma e che coinvolge il colosso cooperativo. "Credo che la politica nel passato abbia dato un cattivo esempio ma oggi sia in Campidoglio che in alcune aree come Ostia abbiamo persone perbene che vogliono ridare la qualità di vita e tutti i diritti e la dignità che la Capitale merita". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino sulla nuova ondata di arresti per l'inchiesta su Mafia Capitale. E a chi gli chiede notizie riguardo sue possibili dimissioni, taglia corto: "Dimissioni? Continuiamo in questo modo. Stiamo cambiando tutto. Una politica antica non solo nei metodi ma anche nei contenuti, e in alcuni casi gravemente colpevole è stata allontanata da me".
Mafia capitale 2: ecco chi sono i politici arrestati. Nell'operazione Mondo di Mezzo bis dei Carabinieri del Ros finiscono in carcere 44 persone, la maggior parte esponenti della politica romana, scrive Nadia Francalacci su "Panorama". L'operazione Mondo di Mezzo Bis. Mondo di Mezzo, secondo atto. Non è stata certo una novità. Le indagini condotte dai Carabinieri del Ros e gli arresti effettuati a dicembre scorso facevano intuire che all'inchiesta di Mafia capitale ci sarebbe stato un seguito. E ,a distanza di meno di sei mesi, altre decine di arresti spaccano il mondo politico e imprenditoriale romano, abruzzese e siciliano. Il blitz dei carabinieri è scattato all'alba nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Catania ed Enna. Nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della procura distrettuale antimafia di Roma, vengono ipotizzati a vario titolo i reati di associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori ed altro. Contestualmente agli arresti, in tutto 44 e che per la maggior parte riguardano politici, ci sono state perquisizioni a carico di altre 21 persone indagate per gli stessi reati. Gli sviluppi delle indagini condotte dal Ros sono legati al gruppo mafioso riconducibile a Massimo Carminati, ora in carcere. In particolare, le ultime indagini, hanno documentato quello che gli inquirenti definiscono un ramificato sistema corruttivo finalizzato a favorire un cartello d'imprese, non solo riconducibili al sodalizio, interessato alla gestione dei centri di accoglienza e ai consistenti finanziamenti pubblici connessi ai flussi migratori.
Manette per Luca Gramazio. Tra i 44 arresti del Ros nel nuovo filone di Mafia Capitale c'è anche Luca Gramazio. Questi è accusato di partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata da Carminati, che avrebbe favorito sfruttando la sua carica politica: prima di capogruppo Pdl al Consiglio di Roma Capitale ed in seguito quale capogruppo Pdl (poi FI) presso il Consiglio Regionale del Lazio. Luca Gramazio è figlio dello storico senatore di An Domenico. E' stato consigliere comunale Pdl a Roma nella maggioranza di Gianni Alemanno.
Carcere per l'ex presidente Coratti. In carcere c'è anche l'ex presidente del Consiglio comunale di Roma, Mirko Coratti, candidato come Consigliere del Municipio III a soli 24 anni e nel 2001 entrato a far parte del Consiglio. Successivamente ha assunto la carica di Presidente del Consiglio comunale mentre era sindaco Veltroni.
In cella anche Daniele Ozzimo. In manette anche l'ex assessore alla Casa del Campidoglio, Daniele Ozzimo. Viene eletto nel 2008 al Consiglio del Comune di Roma nelle liste del Partito Democratico ricoprendo la carica di vice Presidente della Commissione Politiche Sociali e diventando membro della Commissione Lavori Pubblici, Scuola e Sanità.
Arrestato anche il consigliere comunale Giordano Tredicine. I Ros hanno posto in arresto anche il consigliere comunale Giordano Tredicine. Nel 2006, Tredicine diventa consigliere al IX Municipio con 1.576 preferenze ed è nominato Presidente Gruppo Consiliare Forza Italia. Nel 2008 è eletto in Consiglio Comunale con 5.284 preferenze, risultando il consigliere più giovane del Gruppo Consiliare del Comune di Roma. Viene nominato Presidente della Commissione Politiche Sociali e Famiglia e Vicecapogruppo del Pdl in Consiglio Comunale.
In manette anche Massimo Caprari. Gli arresti sono scattati anche per il consigliere comunale Massimo Caprari, dal giugno 2013 Consigliere dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale e membro nelle seguenti Commissioni: Lavori Pubblici, di cui è Vice Presidente Vicario, Patrimonio - Politiche Abitative e Progetti Speciali, Urbanistica, Roma Capitale e Riforme Istituzionali, Commissione Speciale Politiche Comunitarie e Commissione di Indagine Amministrativa sull’ATAC, di cui è Presidente.
In carcere anche Andrea Tassone. Le porte del carcere si sono aperte anche per l'ex presidente del X Municipio (Ostia), Andrea Tassone.
In carcere anche il responsabile anti-corruzione degli ospedali laziali, Angelo Scozzafava. Tra gli arrestati di questa mattina anche Angelo Scozzafava, ex assessore comunale a Roma alle Politiche Sociali. Dirigente azienda ospedaliera S. Andrea, Scozzafava era il responsabile anti-corruzione e trasparenza della S.Andrea, una delle principali aziende ospedaliere del Lazio.
Colpita anche la Regione Lazio. I provvedimenti hanno riguardato anche alti dirigenti della Regione Lazio come Daniele Magrini nella veste di responsabile del dipartimento Politiche Sociali... Ancora manette al Campidoglio. In manette anche Mario Cola, dipendente del dipartimento Patrimonio del Campidoglio e Franco Figurelli che lavorava presso la segreteria di Mirko Coratti. In manette anche un costruttore. Arresti domiciliari anche per il costruttore Daniele Pulcini. L'imprenditore era già finito sotto la lente d'ingrandimento della procura di Roma per una maxi-inchiesta sulle tangenti Enpam. Secondo gli investigatori avrebbe pagato una "bustarella" da un milione e 800 mila euro al parlamentare del Pd Marco Di Stefano quando era assessore al Demanio della giunta regionale guidata da Piero Marrazzo. Nuove accuse anche per la Chiaravalle. Nuove accuse per l'indagata marsicana Pierina Chiaravalle, 31 anni, nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta. Originaria di Avezzano e agli arresti domiciliari da dicembre 2014.
Migranti, il business dell'emergenza. Dalla primavera del 2014 le prefetture stanno affidando i servizi d'accoglienza per stranieri con procedure "straordinarie". Che permettono di lucrare. E aumentano il rischio di bombe sociali, scrive Francesca Sironi su “L’Espresso”. Il centro d'accoglienza di Corcolle da cui erano partite proteste violente Dopo gli scandali, forse per pudore, non è più definita “emergenza”. Il risultato però è lo stesso: fiumi di soldi, controlli inesistenti, sprechi accertati. Dalla primavera del 2014 le prefetture di tutta Italia stanno affidando per vie “straordinarie” i servizi d’accoglienza per migranti. L’impegno economico per lo scorso anno supera i 480 milioni di euro, considerando vitto, alloggio e una minima assistenza. Le altre spese (organizzazione, trasporti) non è dato saperle: il ministero dell’Interno non ha risposto a “l‘Espresso”. Intanto, grazie alle procedure direttissime del Viminale una pletora di hotel, agriturismi, bed and breakfast e persino officine si sono riempite di richiedenti asilo, con rimborsi giornalieri dai 30 ai 35 euro pro capite. Una ricca occasione: le strutture temporanee non devono rendicontare le spese; se riescono a risparmiare, tagliando magari sulle attività per i rifugiati, è tutto guadagno. I prefetti, dicono, pagano pure puntualmente. In questa rete rabberciata sono raccolte oggi 33mila persone. E se la fretta di trovare alloggi è giustificata dall’aumento choc degli sbarchi, meno comprensibile è la nebbia che circonda i contratti, a partire dal gran numero di prefetture (Calabria in testa) che dimenticano di pubblicare online affidatari e importi, come impone la legge. «L’emergenzialità favorisce chi lucra e rischia di provocare bombe sociali», sintetizza Berardino Guarino, dirigente del Centro Astalli di Roma, il ricovero per migranti fondato dai gesuiti. Il suo più che un teorema è una constatazione: nella Capitale il fiume di soldi dell’emergenza (quella sì chiamata così anche nei documenti ufficiali), dichiarata nel 2011 per le rivolte del Nord Africa , ha rimpinguato le casse del consorzio Eriches di Salvatore Buzzi , il braccio destro di Massimo Carminati. Il business ha significato anche altro. I maxi-condomini affittati di corsa nelle periferie hanno trasformato spesso l’accoglienza in disperazione, quindi in disagio, infine in scontri, come è successo a Corcolle o a Tor Sapienza . «La lezione non è servita», scuote la testa Guarino: «A Roma ci sono ancora 3500 posti “straordinari”. E manca un piano per l’integrazione». Ad approfittare dell’Emergenza Nord Africa – un miliardo e 300 milioni fra il 2011 e febbraio 2013 - e poi di Mare Nostrum non è stata solo la società di Buzzi, aderente alla rossa Lega Coop. La cattolica Domus Caritatis , che gestisce decine di centri a Roma e ha una partecipazione al Cara di Mineo, ha raddoppiato il fatturato: da 18 a 36 milioni. Come lei si sono ingranditi i gruppi di cui fa parte: il Consorzio Casa della Solidarietà, rappresentato da Tiziano Zuccolo (intercettato al telefono con Buzzi: «L’accordo è al 50 per cento, dividiamo da buoni fratelli», dicevano degli appalti) e La Cascina, vicina a Cl. Rispetto agli sprechi dell’Emergenza Nord Africa, denunciati da “l’Espresso”, qualcosa è cambiato. I costi sono più contenuti: si è passati da 45 a circa 30 euro al giorno. E il governo ha aumentato i posti “ordinari” prima di aprire il suk di quelli extra. I vantaggi sono quattro: i soldi per i servizi (denominati Sprar) arrivano in gran parte dall’Europa, non dallo Stato. Le coop sono costrette a rendicontare le spese. I controlli sono (in teoria) maggiori. E soprattutto sono coinvolti gli enti locali. L’ampliamento d’urgenza però - i Comuni sono passati in un anno da 3mila a 20mila posti – ha intaccato la qualità generale di un sistema considerato d’eccellenza, come nota Gianfranco Schiavone di Asgi (associazione studi giuridici per l’immigrazione). «Metà dei progetti finanziati per i prossimi tre anni ha ricevuto una valutazione molto bassa, lontanissima dal punteggio riconosciuto al primo, che è del comune di Parma». Su 446 progetti, poi, 226 sono in Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. «Per questo insistiamo sulla necessità di un piano nazionale», conclude il giurista. Ma con i piani si fanno meno soldi. Mentre l’emergenza è un affare d’oro. Tanto paga il prefetto.
Chi specula sui profughi. Un miliardo e 300 milioni: è quello che ha speso finora lo Stato per assistere le persone fuggite da Libia e Tunisia. Un fiume di denaro senza controllo. Che si è trasformato in business per albergatori, coop spregiudicate e truffatori, scrivono Michele Sasso e Francesca Sironi su “L’Espresso”. Erano affamati e disperati, un'ondata umana in fuga dalla rivoluzione in Tunisia e dalla guerra in Libia: fra marzo e settembre dello scorso anno l'esodo ha portato sulle nostre coste 60 mila persone. Profughi, accolti come tali dall'Italia o emigrati in fretta nel resto d'Europa: solo 21 mila sono rimasti a carico della Protezione civile. Ma l'assistenza a questo popolo senza patria è stata gestita nel caos, dando vita a una serie di raggiri e truffe. Con un costo complessivo impressionante: la spesa totale entro la fine dell'anno sarà di un miliardo e 300 milioni di euro. In pratica: 20 mila euro a testa per ogni uomo, donna o bambino approdato nel nostro Paese. Ma i soldi non sono andati a loro: questa pioggia di milioni ha alimentato un suk, arricchendo affaristi d'ogni risma, albergatori spregiudicati, cooperative senza scrupoli. Per ogni profugo lo Stato sborsa fino a 46 euro al giorno, senza verificare le condizioni in cui viene ospitato: in un appartamento di 35 metri quadrati nell'estrema periferia romana ne sono stati accatastati dieci, garantendo un reddito di oltre 12 mila euro al mese. Ancora una volta emergenza è diventata la parola magica per scavalcare procedure e controlli. Gli enti locali hanno latitato, tutto si è svolto per trattative privata: un mercato a chi si accaparrava più profughi. E il peggio deve ancora arrivare. I fondi finiranno a gennaio: se il governo non troverà una soluzione, i rifugiati si ritroveranno in mezzo alla strada. In Italia sono rimaste famiglie africane e asiatiche che lavoravano in Libia sotto il regime di Gheddafi. La prima ondata, composta soprattutto da giovani tunisini, ha preso la strada della Francia grazie al permesso umanitario voluto dall'allora ministro Roberto Maroni. Ma quando Parigi ha chiuso le frontiere, lo stesso Maroni ha varato una strategia federalista: ogni regione ha dovuto accogliere un numero di profughi proporzionale ai suoi abitanti (vedi grafico a pag. 39). A coordinare tutto è la Protezione civile, che da Roma ha incaricato le prefetture locali o gli assessorati regionali come responsabili del piano di accoglienza. Ma, nella fretta, non ci sono state regole per stabilire chi potesse ospitare i profughi e come dovessero essere trattati. Così l'assistenza si è trasformata in un affare: bastava una sola telefonata per venire accreditati come "struttura d'accoglienza" e accaparrarsi 1.200 euro al mese per ogni persona. Una manna per centinaia di alberghi vuoti, ex agriturismi, case-vacanze disabitate, residence di periferia e colonie fatiscenti. Dalle Alpi a Gioia Tauro, gli imprenditori del turismo hanno puntato sui rifugiati. A spese dello Stato. Le convenzioni non sono mai un problema: vengono firmate direttamente con i privati, nella più assoluta opacità. Grazie a questo piano, ad esempio, 116 profughi sono stati spediti, in pantaloncini e ciabatte, dalla Sicilia alla Val Camonica, a 1.800 metri di altezza. I proprietari del residence Le Baite di Montecampione non sono stati i soli a fiutare l'affare. Anche nella vicina Val Palot un politico locale dell'Idv, Antonio Colosimo, ne ha ospitati 14 nella sua casa-vacanze, immersa in un bosco: completamente isolati per mesi, non potevano far altro che cercare funghi. I più furbi hanno trattato anche sul prezzo. La direttiva ufficiale, che stabilisce un rimborso di 40 euro al giorno per il vitto e l'alloggio (gli altri 6 euro dovrebbero essere destinati all'assistenza), è arrivata solo a maggio. Nel frattempo, la maggior parte dei privati aveva già ottenuto di più. Gli albergatori napoletani sono riusciti a strappare una diaria di 43 euro a testa. Non male, se si considera che in 22 alberghi sono ospitate, ancora oggi, più di mille persone. «La domanda turistica al momento degli sbarchi era piuttosto bassa», ammette Salvatore Naldi, presidente della Federalberghi locale. La Protezione civile prometteva che sarebbero state strutture temporanee. Non è andata così: solo all'Hotel Cavour, in piazza Garibaldi, di fronte alla Stazione centrale, dormono tutt'ora 88 nordafricani. Le stanze, tanto, erano vuote: i viaggiatori si tengono alla larga, a causa dell'enorme cantiere che occupa tutta la piazza. Ma grazie ai rifugiati i proprietari sono riusciti lo stesso a chiudere la stagione: hanno incassato quasi 2 milioni di euro. I richiedenti asilo però non sono turisti, ma persone che hanno bisogno di integrarsi. La legge prevede che ci siano servizi di mediazione culturale, che sono rimasti spesso un miraggio o sono stati appaltati a casaccio:«A Napoli sono spuntate in pochi mesi decine di associazioni mai sentite nominare», denuncia Jamal Qadorrah, responsabile immigrazione della Cgil Campania: «Ogni albergatore poteva affidare i servizi a chi voleva, nonostante ci sia un albo regionale degli enti competenti. Tutti, puntualmente, ignorati». Non solo. «A luglio di quest'anno abbiamo organizzato un incontro fra il Comune e gli albergatori», racconta Mohamed Saady, sindacalista della Cisl: «Diverse strutture non avevano ancora un mediatore». Ed era passato più di un anno dall'inizio dell'emergenza. Il business dei nuovi arrivati non ha lasciato indifferenti nemmeno i professionisti della solidarietà. Cooperative come Domus Caritatis, che gestisce otto comunità solo a Roma. Anche i suoi centri sono finiti nel mirino di Save The Children e del garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio. Dopo numerose segnalazioni l'ong è andata a controllare 14 strutture della capitale che si fanno rimborsare 80 euro al giorno per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il risultato è un rapporto inquietante, presentato a maggio alla Protezione civile e al Viminale, che "l'Espresso" ha esaminato. Si parla di sovraffollamento, ma soprattutto di senzatetto quarantenni fatti passare per ragazzini scappati dalla Libia. Durante l'indagine sono stati intervistati 145 profughi. «Più di cento erano palesemente maggiorenni», denuncia l'autrice del rapporto, Viviana Valastro: «Quelli che avevo di fronte a me erano adulti. Altro che diciassettenni. Non posso sbagliarmi». Non solo. «Molti di loro erano in Italia da tempo, non da pochi mesi. Alcuni arrivavano dagli scontri di Rosarno». Doppia truffa insomma: sull'età e sulla provenienza, per avere un rimborso più che maggiorato e intascare milioni di euro. Tutto questo da parte di una cooperativa strettamente legata all'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e di San Trifone e a La Cascina, la grande coop della ristorazione che tre anni fa è stata al centro di un'inchiesta per il tentativo di entrare nella gestione dei cpt. Save The Children non è stata la sola a denunciare la situazione romana. Anche il presidente della commissione capitolina per la sicurezza, Fabrizio Santori, esponente del Pdl, ha dovuto occuparsi di Domus Caritatis. La cooperativa infatti gestiva una comunità che dava grossi problemi al vicinato, da cui arrivavano continue proteste. Santori l'ha visitata e si è trovato davanti ad alloggi di 35 metri quadri abitati da 10 persone. Peggio che in un carcere. Eppure gli appartamentini di via Arzana, a metà strada fra Roma e Fiumicino, più vicini all'aeroporto che alla città, permettevano di incassare più di 12 mila euro al mese. Save The Children ha calcolato che in strutture di questo tipo, nella capitale, vivono quasi 950 persone. Dati incerti, perché solo cinque cooperative hanno accettato di fornirli. Domus Caritatis, dalla sua sede all'abbazia trappista delle Tre Fontane, non ha voluto dare alcuna informazione. Il dossier dell'ong internazionale descrive un caos assoluto: mancanza di responsabili, nessun servizio di orientamento e accompagnamento legale, strutture inadeguate. Al Nord la situazione non cambia. A Milano si registrano casi come quello della ex scuola di via Saponaro, gestito dalla Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi, che ha accolto 150 rifugiati. Ospitati in una comunità per la cura dei senzatetto, l'accoglienza dei minori e degli ex carcerati: 400 persone, con esigenze diverse, costrette a vivere sotto lo stesso tetto in una vecchia scuola. «Le condizioni sono orribili: 10-12 letti per ogni camerata. E pieni di pidocchi e pulci», racconta un ragazzo ancora ospite. Le stanze sono inadatte perché costruite per ospitare alunni, non profughi, né tantomeno clochard che vivono in strada. «Un contenitore della marginalità sociale dove sono frequenti le risse: nigeriani contro kosovari, ghanesi contro marocchini e la lista dei ricoverati in ospedale si allunga ogni giorno», racconta chi è entrato tra quelle mura. Anche il personale è ridotto al minimo con pochi mediatori culturali (che spesso sono ex ospiti che non disdegnano le maniere forti per mantenere l'ordine), un solo assistente sociale e una psicologa per dieci ore alla settimana. Troppo poche per chi ha conosciuto gli orrori della guerra, le botte della polizia libica e porta sulla propria pelle i segni delle violenze. Anche i disturbi psichici abbondano, insieme all'alcolismo dilagante. A sette chilometri dai frati, 440 profughi hanno trovato alloggio a Pieve Emanuele, estrema periferia Sud di Milano. Qui sono stati ospitati nel residence Ripamonti, di proprietà del gruppo Fondiaria Sai, appena passata sotto il controllo di Unipol ma all'epoca saldamente in mano a Salvatore Ligresti. I clienti abituali dell'albergo sono poliziotti, guardie del vicino carcere di Opera o postini, che non bastano a riempire i 4 mila posti letto dell'albergo. Grazie all'emergenza però nelle settimane di massimo afflusso sono entrati nelle casse di Fonsai oltre 600 mila euro al mese. Vacanze forzate in alloggi confortevoli (le camere sono dotate anche di tivù satellitare) ma dove sono mancati completamente i corsi per imparare l'italiano o l'assistenza legale e psicologica. «Si poteva trovare una sistemazione più modesta e investire in altri sussidi» dice, banalmente, un ragazzo del Ghana. Oggi a Pieve Emanuele sono rimasti in 80. Ma nel frattempo al residence sono andati quasi sette milioni di euro. Lo Stato ha speso per l'emergenza 797 milioni di euro nel 2011 e altri 495 milioni nel 2012. Solo una parte è servita per l'accoglienza: centinaia di milioni di euro sono finiti in tendopoli, spostamenti, trasferte, rimborsi agli uffici di coordinamento. Fondi di cui si è persa la traccia. E sì che proprio per il buon uso dei soldi pubblici era stato istituito un "Gruppo di monitoraggio e assistenza", con il compito di visitare le strutture e segnalare i casi critici. Ma della task force degli ispettori dopo pochi mesi non si è saputo più nulla. «Noi facevamo parte del progetto ma da ottobre 2011 non siamo più stati convocati. Considerando che è partito ad agosto, il gruppo è durato meno di tre mesi», spiega a "l'Espresso" Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: «È mancato completamente il controllo da parte delle regioni e delle prefetture». La Corte dei conti della Calabria è andata oltre: ha messo nero su bianco che le convenzioni sottoscritte nella regione sono illegittime, perché non sono state sottoposte al controllo preventivo della Corte, obbligatorio anche nell'emergenza. Non solo. I giudici contabili di Catanzaro definiscono "immotivata" la diaria: 46 euro al giorno sono troppi. E pensare che in provincia di Latina sono riusciti a intascarseli quasi tutti spendendo solo 5 euro al giorno, per garantire a 75 profughi un misero piatto di riso. I cinque avidi gestori della cooperativa Fantasie sono stati arrestati dai carabinieri di Roccagorna. Insospettiti dall'aumento di stranieri in paese, i militari sono arrivati ad un casolare dove hanno trovato 46 persone alloggiate in 70 metri quadri. Nonostante il blitz la cooperativa ha continuato a ricevere i contributi della Regione Lazio per altri sei mesi: una truffa da 400 mila euro. Con le stesse risorse Aurelio Livraghi, volontario della Caritas di Magenta, in provincia di Milano, è riuscito a fare tutt'altro. «Milioni di italiani vivono con 1.200 euro al mese, perché loro no?». Osservazione semplice. Di un pensionato, che ha dedicato ai 35 profughi arrivati in paese le sue giornate. Persone oggi indipendenti: pagano un affitto, fanno la spesa, quattro di loro hanno già un lavoro. Recitano anche in teatro. Una vita normale: altro che emergenza. E quando finiranno i fondi? «Potranno andare avanti almeno un po' perché sono riuscito a fargli mettere da parte dei risparmi». Non era difficile, sarebbe bastato un minimo di organizzazione. E di umanità.
Mineo, la mangiatoia da duecento milioni. "Creiamo un gruppo e lo facciamo vincere". La procedura avviata a Ferragosto invitando pochissime aziende. Per aggiudicarsela c'era bisogno di una cucina da duemila pasti che aveva solo il consorzio vicino a Odevaine. La gara venne bandita dall'attuale sottosegretario Ncd Castiglione, allora presidente della provincia di Catania col Pdl, scrive Alessandra Ziniti su “La Repubblica”. "A 30 chilometri deve sta da Mineo... e noi quello l'abbiamo messo praticamente per fargli vincere la gara", dice Luca Odevaine vantandosi di quella trovata che gli aveva consentito di pretendere dai vincitori un raddoppio del suo stipendio-tangente: da 10 a 20 mila euro al mese. Una cucina da duemila pasti entro 30 chilometri dal Cara, una cucina in più, d'emergenza, perché all'interno del residence degli Aranci dove ha sede il più grande centro richiedenti asilo d'Europa, una cucina capace di sfornare 4000 pasti caldi due volte al giorno c'è già. Eccola la "condizione di gara idonea a condizionare la scelta del contraente", come i pm della Procura di Catania definiscono, nell'avviso di garanzia inviato al sottosegretario Giuseppe Castiglione e ad altre cinque persone tra cui Luca Odevaine, consulente del Cara, il "trucco" con il quale il mega-appalto da cento milioni di euro è stato sempre assegnato all'unico concorrente in grado di rispondere a tutti i requisiti richiesti. Un bando che il presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone definisce un "abito su misura". Al raggruppamento temporaneo d'imprese "Casa della Solidarietà" (composto dal consorzio Sisifo di Legacoop, Senis Hospes e La Cascina vicine a Comunione e Liberazione, dal consorzio Sol Calatino e dalla Pizzarotti di Parma proprietaria del residence) è bastato presentare l'offerta con un ribasso dell'uno per cento per assicurarsi la continuità in quella gestione che, a forza di proroghe, ha in mano da settembre 2011 e che, forte dell'appoggio del prefetto Mario Morcone, ha resistito ostinatamente alla "censura" di Cantone che ora annuncia l'avvio delle procedure di commissariamento.
Milioni sulla pelle dei rifugiati. Un dossier segreto commissionato dal Viminale svela il meccanismo attraverso il quale i soldi del pocket money, destinati agli ospiti dei centri d'accoglienza, non vengono distribuiti e spariscono nel nulla. La mancata erogazione dei 2,50 euro quotidiani cui ha diritto ogni migrante, nel solo Cara calabrese di Isola Capo Rizzuto, vale 3.750 euro al giorno che, moltiplicati per i 21 mesi di permanenza media dei richiedenti asilo, arrivano a superare i due milioni. Se si considera poi che la distribuzione della quota non avviene in modo regolare anche in altri centri italiani, le cifre lievitano ulteriormente. Si tratta di denaro che lo Stato versa agli enti gestori. RE Inchieste è entrata in possesso del documento che il ministero dell'Interno tiene in un cassetto da mesi, scrivono Raffaele Cosentino ed Alessandro Mezzaroma su “La Repubblica”. Illeciti e irregolarità nell'erogazione del "pocket money", la paga giornaliera ai richiedenti asilo, nell'impiego di mediatori culturali, interpreti e psicologi. E poi mancato rispetto delle procedure legali da parte di molte questure, come nel caso di quelle di Roma, Caltanissetta e Crotone che non rilasciano il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo allo scadere dei 35 giorni di permanenza nel centro. E ancora, un quadro impietoso e desolante degli alloggi in cui i migranti, in particolare i richiedenti asilo, sono costretti a vivere, da Gorizia a Trapani. È quanto emerge da un rapporto riservato rimasto nei cassetti, o meglio, nei computer perché si tratta di file Excel, del ministero dell'Interno, mai reso pubblico, di cui Repubblica.it è entrata in possesso. Presenza di armi bianche, di scarafaggi nei container, mancanza di docce e di acqua calda, servizi igienici in comune per uomini e donne, lavandini otturati, rubinetti e vetri rotti, pulizia scarsa, bambini senza assistenza pediatrica. Sono alcuni degli esiti di un doppio monitoraggio che le organizzazioni del progetto Praesidium, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, l'Unhcr (Alto commissariato Onu per i rifugiati), Save The Children e la Croce Rossa hanno realizzato nel corso del 2013 su 18 centri italiani, nove Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e nove Centri di identificazione e di espulsione (Cie), su mandato ispettivo del Viminale. Migliaia di persone costrette a vivere anche per due anni dentro un Centro di accoglienza - il tempo effettivo per l'esame della richiesta d'asilo contro i 35 giorni previsti dalla legge - senza poter avere neanche una bacinella e il sapone per fare il bucato. Perché il capitolato d'appalto del ministero prevede una serie di servizi come la lavanderia e la barberia, che spesso sono disattesi dagli enti gestori. Profughi segregati a chilometri di distanza dalle città, senza mezzi di trasporto, e dunque costretti a fare anche cinque chilometri a piedi su strade pericolose per raggiungere il primo centro abitato. Giovani rifugiati che alla fine del lungo periodo passato nei Cara, ne escono senza possibilità di inclusione sociale perché non hanno neanche imparato l'italiano. I corsi di lingua, quando ci sono, sono scarsi o mal strutturati. Sotto il profilo della gestione, merita attenzione quanto è scritto sul centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, vicino a Crotone, dove gli operatori del progetto Praesidium presenti all'interno del Cara hanno rilevato lo scorso settembre che "l'erogazione del pocket money avviene tramite la distribuzione di due pacchetti di 10 sigarette a settimana. Il migrante non ha la possibilità di acquistare nessun altro bene né gli viene fornita una chiavetta elettronica o una carta moneta per poter spendere l'importo rimanente. Da settembre 2011 a maggio 2013, gli ospiti riferiscono che il buono economico non è stato erogato". La denuncia dei migranti è stata presa sul serio da chi ha scritto il rapporto che, nella parte riservata alle raccomandazioni, chiede in caratteri maiuscoli di "riattivare immediatamente l'erogazione del pocket money" e di "costituire un sistema informatizzato che permetta di rilevare l'effettiva tracciabilità dell'erogazione del buono economico". Il pocket money è la quota di due euro e cinquanta centesimi che spetta al migrante sull'importo giornaliero pagato per ogni ospite dallo Stato ai gestori del centro. Nel caso di Isola Capo Rizzuto, la cifra complessiva erogata è pari a circa 21 euro, con i quali devono essere garantiti tutti i servizi. Il centro ha una capienza ufficiale di 729 posti, ma come gli altri Cara è solitamente sovraffollato. Al momento del monitoraggio erano presenti 1497 persone, oltre il doppio dei posti disponibili. Gli ospiti erano 1600 quando Repubblica ha visitato il Cara lo scorso 3 settembre (il rapporto porta la data del 25 settembre 2013 ma non è mai stato reso pubblico). Facendo un calcolo approssimativo di 2,50 euro per una media di 1500 persone, si arriva alla somma di 3.750 euro al giorno che moltiplicato per 21 mesi, cioè 630 giorni, fa oltre due milioni di euro. Anche con un numero di ospiti pari alla capienza, si raggiunge una cifra a sei zeri che, leggendo questo documento, sembra non sia stata erogata ai suoi legittimi destinatari, cioè i profughi fuggiti da guerre e persecuzioni ospitati nel Cara calabrese. Nel rapporto c'è scritto che andrebbe predisposto un paniere di beni da poter acquistare all'interno del centro o previste soluzioni alternative, come la possibilità di accumulare l'importo mensile del buono per pagare le marche da bollo necessarie al rilascio del primo permesso di soggiorno e del documento di viaggio. Nel file si sottolinea che quando il pocket money è stato erogato, ai migranti sarebbero stati consegnati solo due pacchetti di sigarette da 10 a settimana come equivalente di tutto l'importo settimanale pari a 17 euro e cinquanta centesimi. Il centro è gestito da dieci anni dalla confraternita della Misericordia fondata dal parroco di Isola Capo Rizzuto, il rosminiano don Edoardo Scordio, e dal suo uomo di fiducia Leonardo Sacco, attuale vicepresidente delle Misericordie d'Italia. L'ultima gara d'appalto triennale vinta dalle Misericordie (nel 2012 contratto valido fino al 2015) è stata di 28.021.050 euro iva esclusa. Nello stesso periodo in cui le organizzazioni di Praesidium realizzavano il rapporto, Repubblica aveva chiesto al direttore del Cara, Francesco Tipaldi, come venisse distribuito il pocket money. "Diamo l'equivalente dei 2 euro e cinquanta centesimi giornalieri in beni", è stata la risposta. "Dividiamo i 1600 ospiti in diversi giorni per poter accedere al pocket money, non lo diamo con cadenza quotidiana perché questa attività durerebbe 24 ore, ma lo suddividiamo in maniera settimanale". I disservizi riscontrati nel centro crotonese sono anche altri. "La distribuzione dei beni consumabili avviene ogni 20-30 giorni circa, fatto salvo per i nuclei familiari", si legge nel rapporto. "Il personale del servizio socio-psicologico non sembra essere proporzionale al numero degli ospiti presenti nel centro: ci sono tre psicologhe per circa 1400 ospiti. Il servizio di mediazione culturale non garantisce la copertura delle principali lingue parlate dagli ospiti presenti nel centro. Ad esempio non vi sono mediatori per gli ospiti provenienti dalla Somalia e dal Bangladesh. L'ente gestore ha fornito un organigramma assolutamente inadeguato perché troppo generico". Ma sono state riscontrate anche carenze sanitarie: "Non è garantita l'assistenza pediatrica ed è difficile eseguire vaccinazioni; le condizioni dei servizi igienici del centro d'accoglienza sono assolutamente inadeguate a causa della mancanza di pulizia e del danneggiamento dei sanitari". Infine, gli alloggi nei container sovraffollati e l'impianto di condizionamento non funziona. Il rapporto evidenzia problemi nella gestione del pocket money anche nel Cara di Restinco, a Brindisi, gestito dal consorzio Connecting People di Castelvetrano. I vertici del Consorzio sono stati coinvolti in un'inchiesta della magistratura su fatture gonfiate in un altro Cara, quello di Gradisca d'Isonzo. Tredici i rinviati a giudizio dal tribunale di Gorizia, di cui 11 del consorzio trapanese, fra cui Giuseppe Scozzari, ex presidente del consiglio di amministrazione, per associazione per delinquere, truffa e frode in pubbliche forniture, e due funzionari della prefettura tra cui un vice prefetto, per falso in atti pubblici. Il consorzio si è difeso affermando che esiste una relazione della prefettura di Gorizia che attesta la correttezza delle fatturazioni. L'inizio del processo è previsto per giugno. A Restinco, rileva il dossier, "l'ammontare giornaliero di 2,50 euro del pocket money può essere speso dagli ospiti nell'acquisto di beni presenti al corner shop o nell'acquisto di bibite/snack/bevande calde nei distributori automatici presenti nel centro. Gli ospiti non possono accumulare l'importo giornaliero del pocket money e devono consumarlo nel giro di due giorni, pena la cancellazione dell'importo residuo non speso". Non è specificato però che fine fanno le somme cancellate. Nel Cara brindisino: "Non sono presenti mediatori che coprano tutte le lingue parlate dagli ospiti. L'ente gestore non organizza nessuna attività ludico-ricreativa ad eccezione di partite di calcio. L'ambulatorio medico del centro presenta gravi condizioni di precarietà igienica". A Bari, in un centro che ospita 1400 richiedenti asilo, pari al doppio della capienza, gestito dalla cooperativa Auxilium "è stata riscontrata la presenza di scarafaggi in tutti i moduli visitati" e anche qui "l'ente gestore non organizza nessuna attività ludico-ricreativa ad eccezione di partite di calcio. L'attesa per l'inserimento dei migranti nei corsi è molto lunga e la durata degli stessi è scarsa". Nel cara di Borgo Mezzanone (Fg) gestito in quel momento dalla Croce Rossa, è stata rilevata "insicurezza per la presenza di ospiti senza titolo e il possesso di armi rudimentali quali coltelli da cucina e barre in legno o ferro". I migranti hanno riferito che gli alloggi non vengono mai puliti e l'igiene è insufficiente. Non c'è il servizio di lavanderia e non vengono distribuite bacinelle né stenditoi. Anche a Gradisca d'Isonzo, nel centro ancora gestito da Connecting People, "le condizioni igieniche dei servizi igienico sanitari sono piuttosto scarse. La qualità dei vestiti forniti è molto bassa e il cambio di vestiario avviene ogni 3 mesi. L'ente gestore ha attivato un corso di lingua italiana solo qualche settimana prima della visita di monitoraggio. Il corso risulta, però, inadeguato poiché i posti disponibili sono pochi e i tempi di attesa per l'acceso troppo lunghi (anche fino a due mesi)". A Caltanissetta, un Cara da 500 persone è fatto di container vecchi "in cattivo stato, e in condizione di evidente sovraffollamento", con i bagni in condizioni igieniche "estremamente carenti, soprattutto a causa della ruggine e dell'allagamento continuo del pavimento provocato dalle frequenti otturazioni dei lavandini che vengono condivisi da un elevato numero di persone". A questo contribuisce la mancanza di un servizio di lavanderia, per cui "gli ospiti lavano i vestiti nei lavabi dei bagni, con lo stesso sapone che usano per l'igiene personale". L'ente gestore era in quel momento la cooperativa Albatros (a cui è poi subentrata Auxilium dal primo ottobre) che "si è rifiutata di fornire l'organigramma dettagliato del personale". Ma, secondo il documento, "i servizi di supporto socio-psicologico e legale sono apparsi insufficienti per il numero complessivo di stranieri presenti. I corsi di lingua italiana vengono erogati dai mediatori culturali e non da personale qualificato. Nessuno degli ospiti intervistati era in grado di parlare la lingua italiana nonostante fossero ospiti del centro già da diversi mesi". Inoltre, "i migranti intervistati hanno riferito di non aver ricevuto tutti i beni che spettavano loro e che gli asciugamani non sono mai stati sostituiti durante tutta la loro permanenza al Cara". Il monitoraggio evidenzia anche alcuni elementi positivi che sono un po' ovunque la buona disponibilità degli operatori, l'adeguatezza dei pasti e l'iscrizione a scuola dei bambini.
Quelle regole non applicate su cui adesso il Viminale deve fare luce. Secondo il capitolato d'appalto dei Centri dell'immigrazione, pubblicato sul sito del ministero dell'Interno, dovrebbero essere le prefetture a controllare che i contratti stipulati con gli enti gestori vengano rispettati. Dai file, però, emergono irregolarità gestionali e procedurali, oltre che strutture fatiscenti. Ne sono responsabili, nell'ordine: le cooperative che sono gli enti gestori, le questure e il Viminale. Le organizzazioni che hanno monitorato i centri non hanno diffuso pubblicamente queste informazioni. Si tratta comunque di realtà che operano con il ministero dell'Interno. Nel caso della Croce Rossa che ha ispezionato l'ambito sanitario, c'è anche un conflitto di interessi, essendo la Cri a sua volta gestore di diversi centri nel momento in cui è stato realizzato il dossier, come i Cie di Torino e di Milano e il Cara di Foggia. Alla luce di tutto questo restano alcune domande. Sono passati sette mesi da quando il Viminale ha avuto i risultati del monitoraggio realizzato con l'uso di soldi pubblici: perché i risultati non sono stati pubblicati? Quali misure intende utilizzare per migliorare l'accoglienza? Sempre secondo il capitolato d'appalto, gli enti gestori devono garantire i servizi di barberia e lavanderia, una dotazione minima di personale per l'assistenza 24 ore su 24 e figure professionali adeguate al relativo compito. I kit igienici forniti agli ospiti (sapone, shampoo, dentifricio) devono essere costantemente sostituiti sulla base di una dose monouso giornaliera. I disservizi per "mancata o inesatta esecuzione dei servizi presenti nel contratto", rilevati in sede ispettiva, di controllo e di monitoraggio o lamentati dagli utenti con riscontri fondati, devono portare a una penale di almeno il 3% del corrispettivo mensile ma è prevista anche la possibilità di un risarcimento dei danni più alto. È stata mai applicata questa norma del contratto d'appalto? E se non lo è stata, quale è il motivo? Infine, i soldi del pocket money, che nel solo Cara di Isola Capo Rizzuto ammontano a due milioni di euro, stanziati dallo Stato e non erogati a chi ne aveva diritto, dove sono finiti?
Sulla pelle dei rifugiati bambini. Garantire un alloggio ai minori che sbarcano in Italia senza genitori, così come a quelli che vengono sottratti alle famiglie, costa alle casse pubbliche oltre 30 milioni di euro l'anno. Una massa di denaro che ha messo in moto vasti appetiti criminali: dal giro delle solite coop legate ai boss di Mafia Capitale agli intermediari senza scrupoli che spacciano per ragazzini giovani di oltre 30 anni. E destano dubbi anche alcune sentenze di affidamento al centro di una guerra legale con il governo dell'Ecuador. L'Inchiesta di “La Repubblica”.
Decine di milioni che fanno gola a molti, scrivono Daniele Autieri e Roberta Rei. Al mercato delle anime battezzato da Mafia Capitale con i centri di accoglienza, c'è una merce che vale più delle altre: gli immigrati minorenni. Nel 2014 i comuni italiani hanno dato alloggio a 10.536 stranieri under 18, un esercito di solitudini accolto da poche centinaia di associazioni e cooperative e trasformato, in molti casi, in una cambiale da riscuotere. L'articolo 403 del codice civile prevede infatti che i Msna (minori stranieri non accompagnati) debbano essere accolti ed economicamente sostenuti dal sindaco del Comune in cui vengono identificati. Ed è nelle pieghe della legge che si addensano le vischiosità di un sistema che drena denari pubblici senza un reale controllo. Ad esclusivo vantaggio dei protagonisti delle inchieste giudiziarie degli ultimi mesi, dalle cooperative di Mafia Capitale alle associazioni vicine a Comunione&Liberazione. Tutti pronti a reclamare una fetta del ricco business dei minori. Fare affari con i rifugiati bambini. Il sistema, prima di tutto. A spiegare come funziona è una qualificata fonte delle forze di polizia. "Quando i minori stranieri arrivano, i dirigenti del dipartimento politiche sociali di un qualsiasi comune italiano contattano le cooperative con cui collaborano. L'affare è grosso e queste si organizzano. Se non hanno alloggi li trovano in una notte: acquistano villette, affittano, chiedono palazzetti in prestito a costruttori amici. Pochi giorni dopo la macchina è pronta ad accogliere i ragazzi". Un banchetto ricco, distribuito lungo un tavolo dove c'è spazio per tutti. Nell'inchiesta Mafia Capitale le cimici del Ros dei carabinieri intercettano una conversazione tra Tiziano Zuccolo, consigliere e vice presidente della cooperativa Domus Caritatis, e Salvatore Buzzi, l'uomo della "29 Giugno" sodale di Massimo Carminati. "Eh bravo - dice Zuccolo - l'accordo è al cinquanta per cento, dividiamo da bravi fratelli". Lo spirito ecumenico è condensato in poche parole che spiegano come i protagonisti del sistema si preparino a spartirsi i rifugiati siriani in arrivo a Roma. Intervenendo sulle generalità anagrafiche dei soggetti coinvolti, il palcoscenico cambia, ma gli attori restano gli stessi e il copione scritto per i rifugiati viene replicato tale e quale con i minorenni. La cooperativa Osa Mayor è sconosciuta ai più, eppure analizzando i suoi bilanci si scopre che la sede è nello stesso stabile della Domus Caritatis e che a dirigerla c'è ancora una volta lui, Tiziano Zuccolo. La Domus Caritatis non è roba da poco. Fattura 36 milioni di euro, ha 15 milioni di debiti accumulati verso i fornitori e al 31 dicembre del 2013 vantava partecipazioni nel Cara di Mineo e nella Cascina, il colosso della ristorazione vicino a Comunione&Liberazione. Dalle carte dell'inchiesta di Firenze sulle grandi opere che ha portato in cella Ercole Incalza, emergono alcuni pagamenti per prestazioni poco chiare fatti dalla Domus Caritatis alla Capa srl di Francesco Cavallo, il faccendiere legatissimo all'ex-ministro Maurizio Lupi. Del resto, gli interessi del gruppo spaziano un po' dappertutto, e arrivano fino alla Osa Mayor, la piccola cooperativa che ottiene dal dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma il compito di accogliere circa 60 stranieri, tutte famiglie con minori al seguito. Gli ospiti vengono alloggiati in un villino alle porte di Roma, in via Casal Morena. Per loro il Campidoglio paga la retta completa, ma cosa offre in cambio la Osa Mayor? Una cucina di fortuna allestita nel garage con un forno a microonde, impianti non a norma, letti accatastati, mancato rispetto delle normative antincendio e soprattutto continua a dichiarare la presenza di tutti gli ospiti anche quando parte di loro ha lasciato la casa. Nessuno controlla. Il Comune paga. E la cooperativa si arricchisce. La vicenda è un puntino rispetto al grande mare dei 10.536 minori stranieri che nel corso del 2014 sono arrivati in Italia. Il loro peso economico grava soprattutto sulle casse degli enti locali. Lo scorso anno il ministero del Lavoro ha stanziato appena 14,8 milioni di euro per sostenere i comuni, mentre la fetta più grossa esce direttamente dalle casse degli enti locali. I trasferimenti statali sono stati effettuati sui conti di Tesoreria comunale, ma solo 4 amministrazioni hanno presentato i certificati di corretto utilizzo del contributo pubblico, per un valore irrisorio di 21.240 euro. Al 31 dicembre del 2014 non vi era ancora traccia di come i restanti 313 comuni abbiano usato gli altri 14,7 milioni. E in questa confusione, non sempre casuale, i mercanti di bambini si sono organizzati e hanno messo in piedi il business più redditizio. Non solo rifugiati. L'altra faccia del dramma minorile non riguarda ragazzi soli, ma famiglie comuni. Il tema è molto delicato ed è stato più volte denunciato perché tocca il sistema tradizionale degli affidamenti: un assistente sociale dichiara che il nucleo familiare non è sicuro per il bambino e questo viene immediatamente assegnato alle cure di una casa famiglia. A quel punto interviene il tribunale minorile che conferma l'affido e ne stabilisce la durata. Statistiche ufficiali non esistono, ma gli organi impegnati nel settore parlano di 30.000 minori in Italia. La macchina è complessa e, a fronte di tantissimi casi virtuosi, permangono alcuni elementi di criticità che arrivano a coinvolgere anche alcuni giudici onorari dei tribunali minorili. Secondo "Finalmente Liberi", l'associazione legata a Federcontribuenti che monitora il fenomeno, circa 200 sui 1.082 giudici onorari italiani avrebbero maturato conflitti d'interesse rispetto alla circolare del Csm che ne individua le incompatibilità, ottenendo incarichi personali dalle case famiglia mentre svolgono la loro attività all'interno dei tribunali minorili. Le inefficienze del sistema sono tali che alcuni Stati stranieri hanno avviato contenziosi legali per tutelare legalmente i cittadini stranieri residenti nel nostro Paese. È quanto ha fatto la Repubblica dell'Ecuador. "L'indicazione di avviare cause contro il sistema italiano degli affidi - spiega l'ambasciatore dell'Ecuador a Roma, Juan F. Holguìn - arriva direttamente dal Presidente della Repubblica, che segue questa vicenda in prima persona. Sono moltissimi i bambini della nostra comunità presente in Italia che vengono tolti alle loro famiglie. E a nostro parere questo avviene ingiustamente. Abbiamo quindi costituito un'equipe legale e avviato una serie di cause. Ad oggi, grazie alla nostra assistenza legale, già 10 bambini sono tornati dalle loro madri".
Il muro del pianto dei ragazzi di Termini, continuano Autieri e Rei. Stazione Termini: una ragnatela ferroviaria attraversata da 480.000 persone al giorno, 150 milioni l'anno. Molte di esse costeggiano via Giolitti, il bordo multietnico che confina con l'Esquilino. Passano e non si fermano. Sul muro di marmo che fa da argine alla scalinata del sottopassaggio un gruppo di ragazzi egiziani attende. Sono tutti minorenni. Passa qualche minuto, e un uomo di mezza età si avvicina. Ne abborda uno. Poche parole, una veloce trattativa e spariscono insieme sotto le scale. A volte il cliente arriva in macchina, carica il prescelto e lo riconsegna al "muro del pianto" solo di sera, dopo averlo portato a casa e avergli offerto un pasto caldo. Lui, come tutti gli altri, non è un clandestino. Anzi. Si prostituisce per mandare i soldi alla famiglia d'origine e quando arriva la sera torna alle cooperative dove il Comune di Roma lo ha alloggiato. Chi ha potuto parlare e passare del tempo con questi ragazzi racconta chi li ospita: "Sono sempre i soliti - confessa - Istituto Sacra Famiglia, Eriches (controllata dalla "29 Giugno" di Buzzi), Domus Caritatis, Riserva Nuova di Morena, Best House, Eta Beta. Alveari che in passato sono stati capaci di ammassare anche 100 ragazzi. E per ognuno di loro il Comune di Roma può arrivare a sborsare fino a 100 euro al giorno". Molti dei giovani di Termini vengono dal Car, il Centro agrolimentare di Guidonia dove hanno lavorato per mesi con paghe da fame. In quell'occasione il giro d'affari venne svelato da un'indagine del Corpo di Polizia di Roma Capitale guidato dal vice comandante Antonio Di Maggio (e rivelata da "REInchieste"). Anche allora, quando gli agenti della Polizia Municipale si imbatterono nel fenomeno, scoprirono che molti giovani egiziani impegnati nel lavoro nero erano affidati a case famiglia. All'interno di un'informativa riservata depositata in Procura si legge che le associazioni dove i ragazzi del Car alloggiavano erano l'Istituto Sacra Famiglia, la Eriches, la Domus Caritatis e la Virtus Italia.
Barba e capelli per sembrare più giovani, continuano Autieri e Rei. La storia di Ullah è molto simile a quella delle centinaia dei falsi minorenni alloggiati in case famiglia che, nel corso del 2013, sono stati smascherati dagli uomini della Polizia di Roma Capitale. Una volta arrivati in città i ragazzi finivano in una rete criminale che prima interveniva sul look (barbe tagliate, capelli tinti, ecc.), poi li indirizzava ad alcuni uffici comunali o ai commissariati del centro storico spiegandogli come denunciare la minore età e assicurarsi così l'alloggio nelle comunità pagate dal Campidoglio. Ullah, a differenza di molti altri, ha deciso di collaborare con la giustizia e testimoniare contro i criminali che lo avevano inserito nel giro. "Mi hanno abbordato sulla linea A della metropolitana - ricorda - e mi hanno portato a casa loro. Ho dormito lì per 8 giorni, poi mi hanno spiegato come avrei potuto ottenere il permesso di soggiorno". I trafficanti gli tolgono il passaporto e in cambio gli danno un falso certificato, rilasciato da un ospedale romano, che indica la minore età. "Mi hanno accompagnato fino alla questura - prosegue Ullah - dicendomi come avrei dovuto fare. Lì sono stato riconosciuto minorenne e spedito in una casa famiglia a Morena". Un mese dopo, quando i Vigili fanno irruzione nella casa del trafficante, scoprono decine di documenti falsi che dimostrano l'esistenza di un vero e proprio business dei falsi minorenni. Da quel momento Ullah collabora con la giustizia, ma due anni dopo attende ancora che la procura di Civitavecchia e l'ufficio immigrazione del ministero gli rinnovino il permesso di soggiorno. Come lui, tanti altri immigrati sono finiti nel giro. E oggi sono diverse le inchieste aperte su un fenomeno tutt'altro che superato. La novità è che, per la prima volta, al centro di alcune indagini è finito il presunto scambio affaristico tra le organizzazioni che garantiscono la "materia prima" e alcune cooperative conniventi. Un patto criminale, siglato in nome del denaro.
E per chi fa qualcosa arriva il taglio dei soldi, scrivono Monica D'Ambrosio ed Anna Di Russo. Il Sacrai è uno di quei posti dove ogni giorno neuropsichiatri e psicologi infantili seguono minori abusatori e abusati per sottrarli al carcere o alle case famiglia. Eppure le attività del centro, che opera all’interno dell’Università la Sapienza di Roma, hanno rischiato di concludersi insieme ai fondi governativi stanziati a favore di progetti pilota per minori svantaggiati. Con la grave conseguenza che l’interruzione della terapia vanificasse il lavoro fatto fin lì e aggravasse le condizioni dei minori presi in cura. Ora, dopo mesi d’incertezza, proprio il Sacrai è l’unico centro ad aver ottenuto un rifinanziamento (100mila euro) grazie ad un emendamento all’articolo 7 del Milleproproghe firmato dall’ex ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna. Ma il principio al momento sembra valere solo per il centro universitario. Non per le altre 26 strutture, anch’esse finanziate dalle Pari Opportunità, che a ottobre 2014 hanno esaurito la copertura economica. Eppure tutti i 27 destinatari dei fondi hanno fornito con il loro lavoro la risposta italiana alla convenzione di Lanzarote e al richiamo dell’Europa che sollecitava gli Stati membri a fare di più per l’infanzia e l’adolescenza. “L’Europa - precisa Vincenzo Spadafora, Garante per l’infanzia - ha fissato degli obiettivi economici che dobbiamo perseguire: l’Italia ha precisi obblighi anche riguardo ai piani per l’infanzia e l’adolescenza”. “Sottovalutare i traumi subiti dai minori – aggiunge – è un grave errore anche in termini di spesa pubblica. In Italia il costo sociale complessivo del maltrattamento è di circa 13 miliardi di euro, con un’incidenza annuale in incremento di nuovi casi pari a 910 milioni”. Eppure quanto un servizio psicologico integrato e multidisciplinare può fare per enti locali e aziende sanitarie lo ha dimostrato il centro Vatma in Molise, che non solo ha limitato l’ingresso di alcuni minori in case famiglie o in altre strutture ad hoc, con un risparmio di oltre 30mila euro all’anno a bambino (circa 85 euro al giorno), ma ha anche tagliato tutti quei costi diretti che gli enti locali devono sostenere. Pochi, confusi e spesi male. I finanziamenti per l’infanzia e l’adolescenza esistono, ma per capirci qualcosa bisogna districarsi tra una serie di fondi statali, regionali ed europei che non sempre vengono destinati davvero ai minori. Perché oltre a non esserci un monitoraggio a livello istituzionale, non esiste neanche una programmazione chiara e una visione di lungo periodo sull’utilizzo di queste risorse. Così, oltre ai tagli – il Fondo nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza dal 2001 al 2015 ha perso oltre il 43% dei finanziamenti, mentre non si riesce a quantificare quanto del Fondo per le politiche sociali sia stato dedicato ai minori – molte regioni, in particolare al sud, hanno difficoltà a programmare e spendere i soldi disponibili. La Campania, ad esempio, non ha ancora programmato, richiesto e utilizzato le risorse statali del 2009, 2010 e 2011, per un totale di oltre 34 milioni di euro. Eppure oggi la copertura dei suoi servizi regionali non raggiunge il 3%. Va meglio invece con i fondi europei con 227 milioni di euro (Fondo di aiuti agli indigenti 2014-2020) che nei prossimi anni saranno utilizzati per assicurare materiale scolastico e accesso gratuito alla mensa a bambini e adolescenti in condizioni di povertà e all’apertura pomeridiana delle scuole in contesti deprivati.
Dal ministero delle Pari Opportunità riceviamo e pubblichiamo .Sostegno ai minori, la precisazione del governo: Gentile Direttore, nell'articolo pubblicato sul vostro sito dal titolo "E per chi fa qualcosa arrivo il taglio dei soldi", a firma Monica D'Ambrosio e Anna Di Russo, nell'ambito di una inchiesta sui bambini rifugiati, appaiono alcune inesattezza circa il ruolo del Dipartimento delle Pari Opportunità e delle decisioni che è chiamato ad adottare, colgo dunque l'occasione per fare chiarezza sull'intera questione. Gli autori dell'articolo sostengono che dei 27 progetti pilota - finanziati con Avviso pubblico n.1/2011 per la concessione di contributi per il sostegno a progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale - soltanto uno ha avuto la proroga dei fondi scaduti a fine 2014, il Sacrai, che opera all'interno dell'Università la Sapienza di Roma. E' vero, ma questo non per decisione del Dipartimento, quanto piuttosto, come riportato nell'articolo, grazie ad un emendamento all'articolo 7 del Milleproroghe, firmato dall'ex ministra Mara Carfagna. Senza mettere in dubbio il lavoro svolto da Sacrai, va sottolineato che con quell'emendamento, presentato per un'unica struttura, di fatto non si è provveduto ad un intervento sistemico nei confronti di tutte le strutture coinvolte nei progetti pilota i cui finanziamenti erano relativi a 18 mesi di attività. Ecco perché il Dipartimento, che a questo fine dispone di propri fondi, ha avviato un monitoraggio per individuare quanti sono i minori attualmente in carico alla varie strutture e di conseguenza formulare un piano di finanziamento ad hoc per i progetti sperimentali ancora attivi. Occorre, però, precisare che la presa in carico di minori non è tra le competenze di questo Dipartimento, a cui spetta la prevenzione del fenomeno e quindi a tal fine, per gli interventi strutturali e i relativi fondi, sono altri soggetti istituzionali a doversene fare carico, come prevede la legge. Ancora qualche precisazione: l'avviso pubblico da cui nascono i progetti pilota ha avuto come obiettivo strategico quello di promuovere interventi sperimentali e innovativi a favore dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale caratterizzati dalla capacità di raccordare tutte le risorse operative e istituzionali del sistema locale. Ma il nostro impegno è mirato anche all'individuazione di livelli minimi di assistenza che siano applicabili e applicati su tutto il territorio nazionale sopperendo a quella disomogeneità che ancora purtroppo persiste. L'esperienza delle strutture impegnate nel progetto pilota, è dunque diventata una base conoscitiva anche per la redazione di apposite linee guida, come previsto dal III Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per l'individuazione delle quali è stata attivata un'azione di monitoraggio, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio il servizio delle attività a tale scopo finalizzate. Ma il Dipartimento sull'intera materia ha inteso superare la logica emergenziale, mettendo a punto politiche in grado di contrastare su più fronti il fenomeno. Due gli strumenti a cui si sta lavorando: il Piano nazionale di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento (dove si dedica grande attenzione al fenomeno dei minori non accompagnati che molto spesso finiscono nelle mani di organizzazioni criminali per essere poi destinati al mercato del sesso a pagamento e alla segregazione) e il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Entro il prossimo 9 giugno, a tal riguardo, si concluderà il giro di consultazioni che il Dipartimento ha avviato non solo con i soggetti istituzionali coinvolti nella materia ma anche e soprattutto con le associazioni del settore in vista della stesura finale del Piano antipedofilia nel quale è previsto un rafforzamento del ruolo di coordinamento unico in capo al Dipartimento stesso al fine di evitare sovrapposizioni e spacchettamenti di deleghe. Il nostro obiettivo finale è quello di mettere a sistema misure e interventi multi-livello e multi-agenzia in grado di rendere efficaci le azioni programmate e di raccordare l'operato di tutti i soggetti e gli enti coinvolti nel contrasto di tali fenomeni garantendo un servizio omogeneo sull'intero territorio nazionale. Uno degli strumenti individuati nel Piano antipedofilia è quello di centri pilota regionali per la cura e la presa in carico di minori autori e vittime di abusi valorizzando il ruolo e il lavoro delle ong e delle associazioni di settore. Altro strumento fondamentale sarà un monitoraggio costante di tutta la fase di attuazione degli interventi perché qualunque legge o progetto deve poi poter essere valutato alla luce dei risultati che effettivamente produce in ogni suo aspetto. Lo sfruttamento e l'abuso dei minori sono gravi violazione dei diritti dell'infanzia, una vera e propria forma di schiavitù che va combattuta su più fronti, un fenomeno che si alimenta sia dentro circoscritti ambiti sociali (rapporti famigliari, scolastici, amicali) sia in ambito sovranazionale (pedopornografia, pedofilia, turismo sessuale, tratta di esseri umani). Come risulta dai dati della Campagna del Consiglio d'Europa contro la violenza sessuale nei confronti dei bambini, in Europa il fenomeno riguarda quasi un minore su cinque che almeno una volta nell'infanzia subisce abusi sessuali: vittime sono i minori di entrambi i sessi anche se la maggioranza sono bambine, di ogni età con percentuali più alte a partire dalla pre-adolescenza e non ci sono particolari differenze tra etnie. L'articolazione e la dimensione stessa del fenomeno indicano la complessità degli interventi necessari, il Dipartimento sta facendo la sua parte e lo sta facendo nel rispetto della normativa nazionale ed europea, ma soprattutto garantendo in ogni passaggio la trasparenza e il rigore a cui è chiamata ogni azione della Pubblica amministrazione. Distinti saluti. Giovanna Martelli, consigliera del Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità.
"Gli immigrati rendono più della droga". La mafia nera nel business accoglienza. Così i fascio-mafiosi di Massimo Carminati si sarebbero spartiti secondo i Pm i soldi per i richiedenti asilo. Milioni di euro. Senza controlli, grazie alla logica dell'emergenza. E a rapporti privilegiati con le autorità. La parte delle indagini che riguarda il consorzio Eriches e Salvatore Buzzi, scrive Francesca Sironi su “L’Espresso”. Uno sbarco a Brindisi«Rendono più della droga». Per la mafia nera che comandava su Roma gli immigrati erano un business favoloso. Messi da parte gli ideali politici, la banda fascista che rispondeva agli ordini di Massimo Carminati, arrestato questa mattina insieme ad altre 36 persone, aveva trovato nell'accoglienza dei profughi l'occasione per intascare milioni. Il regista dell'operazione è Salvatore Buzzi, anche lui finito in carcere. L'idea di trasformare il sociale in un business gli è venuta negli anni '80 proprio in prigione, mentre scontava una pena per omicidio doloso. Oggi come presidente del consorzio di cooperative Eriches guidava un gruppo capace di chiudere il bilancio 2013 con 53 milioni di euro di fatturato. Gli incassi arrivano da servizi per rifugiati e senza fissa dimora, oltre che da lavori di portineria, manutenzione del verde e gestione dei rifiuti per la Capitale. Un colosso nel terzo settore. Che secondo gli atti delle indagini rispondeva agli interessi strategici del “Nero” di Romanzo Criminale. Buzzi infatti, secondo i pm, sarebbe «un organo apicale della mafia capitale», rappresentante dello «strumento imprenditoriale attraverso cui viene realizzata l'attività economica del sodalizio in rapporto con la pubblica amministrazione». I documenti dell'operazione che ha portato in carcere referenti politici e operativi della mafia fascista svelata da Lirio Abbate su “ l'Espresso ” in numerose inchieste, mostrano nuovi dettagli sull'attività della ramificazione nera di Roma. A partire appunto dall'attività per gli stranieri in fuga da guerra e povertà. «Tu c'hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati?», dice Buzzi al telefono in un'intercettazione: «Non c'ho idea», risponde l'interlocutrice. «Il traffico di droga rende di meno», spiega lui. E in un'altra conversazione aggiunge: «Noi quest’anno abbiamo chiuso con quaranta milioni di fatturato ma tutti i soldi, gli utili li abbiamo fatti sui zingari, sull’emergenza alloggiativa e sugli immigrati, tutti gli altri settori finiscono a zero». "Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? C'hai idea? Il traffico di droga rende meno", così al telefono Salvatore Buzzi, braccio destro imprenditoriale di Massimo Carminati. Più chiaro di così. Il suo consorzio, Eriches, dentro cui si trova anche la "Cooperativa sociale 29 giugno", nel 2011 riesce ad entrare a pieno titolo nella gestione dell'Emergenza Nord Africa: un fiume di soldi (1 miliardo e 300 milioni) gestiti a livello nazionale dalla Protezione Civile e dalle prefetture per l'accoglienza straordinaria delle persone in fuga dalla guerra in Libia e dalle rivolte della Primavera Araba. È in quel periodo che le cooperative di Buzzi, nate come progetto durante la sua permanenza in carcere negli anni '80, arrivano a fatturare oltre 16 milioni di euro solo con l'accoglienza degli stranieri. Business che continueranno a seguire. Anche che sono proseguiti fino ad oggi con la marea umana di Mare Nostrum. Per ottenere immigrati da ospitare, intascando rimborsi che vanno dai 30 ai 45 euro al giorno a persona, Buzzi s'impone nelle trattative. E può contare, stando alle indagini, su referenti di primo piano. Come Luca Odevaine, presidente di Fondazione IntegrAzione ed ex vice capo di Gabinetto di Walter Veltroni al comune di Roma. In qualità di rappresentanza dell'Upi, l'unione delle province italiane, Odevaine seide al “Tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza”, da cui, spiega in diversi incontri con Buzzi e i suoi colleghi, può «orientare i flussi che arrivano», favorendo le cooperative amiche, perché ricevano più immigrati e quindi più soldi dallo Stato. In un'altra intercettazione sostiene di poter controllare le decisioni del prefetto Rosetta Scotto Lavina «che è in difficoltà, ha troppi sbarchi, non sa dove mettere le persone», e per questo lui può aiutarla indicandole a chi affidare i fondi. Per questa attenzione, spiega Buzzi in una serie di intercettazioni riportate negli atti, Odevaine avrebbe ricevuto dal clan di Carminati uno stipendio da 5mila euro al mese. Ma non era l'unico riferimento politico del consorzio. Anche l'assessore alle politiche sociali Angelo Scozzafava in una telefonata assicura: «su Roma quanti posti c'hai? Perché me sa che sta per arrivà l'ondata...». Per controllare l'accoglienza degli stranieri, Buzzi avrebbe avuto un accordo «al 50/50», ovvero per dividersi a metà tutti gli appalti, con la rete dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e di San Trifone, network di coop cattoliche in cui rientra anche Domus Caritatis, la cooperativa di cui “ l'Espresso ” aveva raccontato le politiche spregiudicate durante l'Emergenza Nord Africa del 2012, quando barboni e adulti furono fatti passare per minorenni pur di ottenere rimborsi duplicati dal ministero (malagestione denunciata da Save The Children e dal Garante per l'Infanzia). Stando agli atti dei Pm, l'accordo per la spartizione del business dei profughi sarebbe stato sancito con Tiziano Zuccolo, rappresentante della rete dell'Arciconfraternita, con cui ancora nel maggio del 2013 Buzzi parlava del “Patto” in riferimento all'arrivo dei siriani scappati dalla guerra. «Va be’, a Salvato’, noi l’accordo, l’accordo è quello al cinquanta, no?», chiedeva Zuccolo, e Buzzi confermava: «Ok, io sto premendo per riceverne altri 140» e Zuccolo ribadiva: «Eh, bravo, l’accordo è al cinquanta per cento, dividiamo da buoni fratelli, ok?» Grazie a queste poltiche la holding dominata da Buzzi, che condivideva tutte le scelte, secondo le indagini, con il boss Carminati, è riuscito a ricevere anche fondi europei. Nel 2011 ad esempio ha avuto dal Fondo Europeo per i Rifugiati ben 234mila e 400 euro, di cui 130 direttamente da Bruxelles e gli altri dallo Stato. Nel 2012 le cooperative che rispondevano alla “mafia capitale” hanno assistito 1320 famiglie per conto del Comune di Roma nell'ambito di un'altra emergenza, quella abitativa. Ma è stato il 2013 l'anno migliore per il consorzio Eriches, come si legge nel bilancio, chiuso con un margine netto di quasi tre milioni di euro. «Nell’ambito dell’accoglienza, siamo cresciuti ed abbiamo continuato la gestione delle attività assistenziali in favore di immigrati, senza fissa dimora, mamme con bambini, ex detenuti, nomadi e famiglie in difficoltà», spiega il presidente, Salvatore Buzzi: «e abbiamo vinto il bando promosso da Roma Capitale per 491 immigrati facenti parte dello SPRAR, una commessa significativa che ci consentirà di stabilizzarci nel settore», con rimborsi garantiti da 35 euro al giorno. E pochi controlli sulla qualità degli aiuti. Nel 2013 Eriches ha vinto anche il bando della prefettura di Roma per il Cara di Castelnuovo di Porto, ovvero il centro per richiedenti asilo di Roma: centinaia di posti, continue proteste per le condizioni indegne di vita. L'appalto da 21 milioni di euro è stato però bloccato dal Tar. E nel bilancio Buzzi si lamenta, evocando il conflitto d'interessi: «nonostante le nostre giustificazioni siano state accettate dalla Prefettura, non siamo riusciti ad iniziare il servizio peralcuni “dubbi” provvedimenti adottati della Terza Sezione Ter del TAR Lazio», scrive: «presieduta da Linda Sandulli, la quale, per inciso, è proprietaria insieme al marito di una ditta edile (PROETI Srl) che effettua manutenzioni proprio all’interno del CARA; un enorme conflitto di interessi». «Siamo fiduciosi che il Consiglio di Stato possa a breve ripristinare legalità e diritto», conclude. Forse con un senso, implicito, dell'ironia.
Il nero e i bianchi, la torta delle coop. L'accordo globale di Mafia Capitale. Concorrenza inesistente. Consiglieri comunali compiacenti. L'unico dirigente "contro" allontanato. La squadra di Carminati godeva su appoggi trasversali per ottenere milioni di euro nel gestire emergenze abitative e migratorie. Ora sono finiti in carcere anche i rappresentanti delle reti cattoliche, scrive Francesca Sironi su “L’Espresso”. «Noi che dovemo sta sul pezzo pe’ magnasse un po' de caciotta». Ha ragione, il Nero. Il suo braccio destro Salvatore Buzzi è un lavoratore instancabile. Non conosce domeniche o festivi: è sempre al telefono per spartirsi affari, o impegnato in riunioni, incontri e strette di mano per assicurare a sé o agli amici milioni di euro dal Campidoglio e dal ministero dell'Interno. Mai una pausa. La frase la dice Massimo Carminati, “er Cecato”, ed è riportata nell'ordinanza che ha scoperchiato la seconda parte dell'inchiesta su Mafia Capitale, con 44 arresti e decine di indagati fra politici, amministratori e imprenditori. Il piatto principale è sempre la gestione delle emergenze abitative e dell'accoglienza dei migranti da parte di un ristretto gruppo d'affari. La novità è che ora sono state arrestate le controparti di Buzzi e Carminati: i rappresentanti di quelle coop “bianche” di cui l'Espresso parla da tempo , e che nella Capitale spadroneggiavano nel settore degli aiuti sociali, spalla spalla alla banda di Carminati. Il nero e i bianchi, il neofascista delle trame e le onlus che facevano riferimento al vescovo e agli ordini religiosi. Agli arresti sono finiti infatti Tiziano Zuccolo, della cattolica Domus Caritatis, e Francesco Ferrara, Domenico Cammisa, Salvatore Menolascina e Carmelo Parabita, rappresentanti del consorzio La Cascina, legata a Comunione e Liberazione. Con Buzzi si intendevano alla perfezione. Il giudice li ritiene infatti «partecipi agli accordi corruttivi con Luca Odevaine» - il funzionario stipendiato per assegnare risorse e immigrati agli amici dal tavolo del ministero dell'Interno – oltre che autori di «plurimi episodi di corruzione e di turbativa d’asta dal 2011 al 2014», dimostrando «una spiccata attitudine a delinquere, al fine di ottenere vantaggi economici nell’esercizio della loro attività imprenditoriale». Negli atti si raccolgono così gli accordi e gli intrecci che hanno intorpidito Roma per anni, chiudendola in una rete indistricabile di cooperative – bianche, rosse, nere, incensurate o indipendenti, non cambia – che si accordavano sui progetti prima ancora venissero pubblicate le gare. Nessuna alternativa aveva spazio. C'era chi si metteva d'accordo per quieto vivere, chi sotto minaccia. E chi semplicemente traeva maggior guadagni grazie all'oligopolio. Come il gruppo dei consorzi bianchi di Zuccolo e Ferrara. Uno degli episodi che meglio spiegano come sono stati spesi in questi anni i fondi per i più poveri, a Roma, riguarda 580 persone - donne, uomini e bambini finiti per strada a cui bisognava trovare un tetto per l'inverno del 2014. Il bando viene pubblicato il 14 luglio. Buzzi e Zuccolo sono molto preoccupati, perché a gestirlo è tale Aldo Barletta, un dirigente che a detta del socio di Carminati «è entrato da 10 giorni ed ha applicato tutto quello che non avevano applicato fino ad adesso», uno che «non cede nemmeno davanti a Gesù e Maria». Era un «pericolo», questo funzionario, per le sue «resistenze ad assecondare le procedure sfavorevoli agli interessi della pubblica amministrazione». E la procedura aperta da lui per trovare casa a quei 580 disperati era considerata un ostacolo: troppo trasparente e favorevole alla concorrenza. Andava aggirata. Come? Con l'alacre attività di cui Buzzi si fa coordinatore. E che consiste nel «far desistere» tutti i potenziali avversari dal partecipare alla gara. Il funzionario “nemico” aveva invitato infatti 15 società a presentare un'offerta. Alcuni nomi, fra gli invitati, risultavano nuovi a Salvatore Buzzi, ed è allora Angelo Scozzafava (indagato), direttore del dipartimento per le Politiche Sociali di Roma, a dargli i contatti necessari. Altri invece li conosceva bene. E inizia con gli sms e le chiamate. Contatta anche a Gabriella Errico, la responsabile della coop “Un Sorriso” che gestiva il centro per minori di Tor Sapienza diventato noto dopo l'aggressione e il caos con gli abitanti del quartiere. Lei risponde «tranquillo», si dichiara «a disposizione» e non partecipa al bando (ora è indagata). Altri fanno maggiori resistenze. Alcuni chiedono favori in cambio, come Alberto Picarelli che desiste dall'occasione ghiotta ma dice: «Salvato' spero che un giorno pure io ti possa... quando ti chiedo qualcosa me ne venga accolta». Con questi piccoli debiti o scambi Buzzi sistema la concorrenza. I colleghi competitor si dissolvono tutti. Rimane la rete di Zuccolo e Ferrara, La Cascina. Ma tutto è sistemato con una telefonata tra amici e un accordo che gli inquirenti definiscono "globale": «Io su quello dei 580 preferirei che andasse completamente deserto, che partecipassi solo io, capisci? Sugli altri dimme te, io ti ci vengo e tu vieni sui miei», dice il braccio destro di Carminati. E Ferrara conferma: «Secondo me tu vieni ed io vengo e poi hai capito, così almeno più è... e poi sti cazzi, cioè hai capito?». Chi ha capito ha capito: tu mi aiuti qui, io ti aiuto lì, e la spartizione è fatta. La manovra non fa una piega. E il 25 agosto alla “manifestazione d'interesse” dei soggetti sul territorio per accogliere quei 580 sfollati si presenta una sola società. La cooperativa Eriches di Salvatore Buzzi. Che si aggiudica così indisturbata l'affare da un milione e seicentomila euro. Turbativa d'asta in piena regola. Ferrara è coinvolto anche in altre pratiche, fra cui la manomissione di una gara indetta il 30 giugno del 2014 dalla prefettura di Roma per assicurare l'accoglienza a 1.278 migranti, oltre a ulteriori 800 richiedenti asilo in arrivo. Valore: 10 milioni di euro. Per ottenere le assegnazioni dei progetti, e far approvare una delibera che assegnasse i fondi fuori bilancio, Ferrara avrebbe partecipato alla «corruzione di consiglieri comunali mediante la promessa della somma di complessivi 130mila euro». La situazione di Eriches e Domus Caritatis/la Cascina era entrata infatti in crisi dopo un rapporto della Finanza, che giudicava illegittime le assegnazioni dirette del Campidoglio a quella ristretta cerchia di imprese sociali di milioni e milioni di euro. Ma né rapporti né dirigenti specchiati sono riusciti a fermarli.
Denuncia la "miseria ladra" col vitalizio da consigliere. Il coordinatore di Libera e braccio destro di don Ciotti invoca il reddito minimo, poi intasca 2.600 euro al mese, scrive Giuseppe Alberto Falci su “Il Giornale”. Da animatore delle campagne contro la povertà al vitalizio da 2.619 euro netti al mese il passo è breve. Addirittura brevissimo se il soggetto interessato si chiama Enrico Fontana ed è anche il coordinatore nazionale di Libera, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti. Associazione nata nel marzo del 1995 «con l'intento - si legge nel sito internet di Libera - di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere la legalità e la giustizia». Nessun imbarazzo insomma per i venerabili maestri della sinistra benpensante quando si tratta di arricchire la cassaforte di famiglia. A Fontana, classe '58, giornalista professionista, ideatore del termine «ecomafie», che fa il maestrino a destra e a sinistra pubblicando libri per Einaudi e inchieste per l'Espresso , è bastato farsi eleggere alla Regione Lazio nel 2006. Anzi, subentra ad Angelo Bonelli che nel frattempo diventa capogruppo a Montecitorio del Sole che ride, gruppo a sostegno dell'ex premier Romano Prodi. Sono gli anni di Piero Marrazzo a governatore della Pisana. Anni in cui Fontana pungola l'esecutivo sui temi più disparati, dai rifiuti passando ai beni confiscati, continuando a presenziare in convegni dal titolo «Il sole sul tetto, energie rinnovabili e risparmio energetico». Ovviamente, non perdendo mai di vista il tema della povertà, cruccio della carriera dell'attuale braccio destro di Don Luigi Ciotti. Ma la legislatura finisce con qualche mese di anticipo per le dimissioni del governatore Marrazzo, coinvolto in uno scandalo a base di festini e trans. Ciò ovviamente consente al nostro Fontana di ottenere un lauto vitalizio. Dopo cinque anni scarsi in Regione e dopo aver versato circa 90mila euro di contributi, dal 2011 Fontana ricevo un assegno mensile di 3.187 euro che, a causa delle recenti sforbiciata apportate dalla modifica della normativa sui vitalizi, si è ridotto a 2.616,32 netto (dato che è possibile reperire all'interno del sito del M5s Lazio che monitora giornalmente le evoluzioni dei vitalizi). In sostanza, facendo un calcolo di massima, Fontana ha già incassato più di 150mila euro recuperando i 90mila euro versati di contributi. Ma non finisce certo qui. Perché dal settembre del 2013 Fontana è il coordinatore nazionale di Libera. E dalla casa di Don Ciotti, non è uno scherzo, Fontana lancia e anima la campagna «Miseria ladra». Gira ogni angolo del Belpaese per diffondere il verbo del padre nobile di Libera. Ma il vero paradosso è il seguente: il 15 aprile di quest'anno - insieme a Giuseppe De Marzo, coordinatore di «Miseria Ladra» - invia una lettera a tutti i parlamentari «per calendarizzare in aula entro cento giorni una legge per il reddito minimo o di cittadinanza, per contrastare povertà e disuguaglianza, così come da tempo ci chiede l'Europa». Il virtuoso della «legalità e della giustizia» incalza Montecitorio e Palazzo Madama ma intanto incassa, senza batter ciglio, il vitalizio. D'altronde è nello stile dei vertici di Libera. Nando Dalla Chiesa, presidente onorario dell'associazione, riceve mensilmente un assegno di 4.581,48 euro. Insomma, «miseria ladra» per gli altri, non per i venerabili maestri.
Il prete delle coop fustiga tutti ma salva gli amici che lo finanziano. Questa volta don Ciotti, di fronte a scandali e corruzione, non ha lanciato scomuniche come nel suo stile. Nessuna sorpresa: sono le cooperative rosse che danno soldi alla sua associazione, scrive Stefano Filippi su "Il Giornale". Cacciate i ladri: è un vasto programma quello che don Luigi Ciotti, il sacerdote dell'antimafia, ha assegnato alla Lega delle cooperative. Era lo scorso dicembre, i giorni dello scandalo romano di «Mafia capitale». Degli arresti tra i «buoni». Dei cooperatori che sfruttano i disperati. Dei volontari (o pseudo tali) che intascano soldi da Stato e Regioni pontificando che invece li avevano usati per accogliere gli extracomunitari. Dei portaborse Pd che facevano da intermediari tra enti pubblici e malaffare. Del ministro Poletti fotografato a tavola con i capi di Legacoop poi indagati. Dell'ipocrisia di una certa parte della sinistra pronta a denunciare le pagliuzze negli occhi altrui senza accorgersi delle proprie travi. Ma don Ciotti, il custode della legalità, il campione della lotta contro le mafie, il prete che marcia in testa a qualsiasi corteo anti-corruzione e pro-Costituzione, ha trattato con i guanti le coop rosse. «Bisogna sempre vigilare - ha detto - non c'è realtà che si possa dire esente». E ancora: «Non possiamo spaventarci di alcune fragilità. Ve lo dico con stima, gratitudine e affetto: dobbiamo imparare sempre di più a fare scelte scomode». E poi: «Siate sereni, cacciate le cose che non vanno. Le notizie sulle tangenti non possono lasciarci tranquilli - ha proseguito -. Molti con la bocca hanno scelto la legalità ma dobbiamo evitare che ci rubino le parole. Non si sconfiggono le mafie se non si combatte la corruzione». Un appello generico, parole di circostanza davanti a un sistema smascherato dalla magistratura. Nulla a confronto delle scomuniche lanciate contro i mafiosi, i sì-Tav, i «nemici della Costituzione», i «guerrafondai», e naturalmente Silvio Berlusconi. D'altra parte, difficile per lui usare un tono diverso. Perché il prete veneto cresciuto a Torino è anche il cappellano di Legacoop. Il rapporto è organico. Le coop rosse (con la Torino-bene, la grande finanza laica e le istituzioni pubbliche) sono tra i maggiori finanziatori del Gruppo Abele e di Libera. L'associazione antimafia ha tre partner ufficiali: le coop della grande distribuzione, il gruppo Unipol e la loro fondazione, Unipolis. Nei bilanci annuali c'è una voce fissa: un contributo di 70mila euro da Unipolis. Legacoop collabora con il progetto «Libera terra», che si occupa di mettere a reddito i terreni confiscati ai mafiosi. «Un incubatore per la legalità», lo definiscono i cooperatori rossi che grazie a questa partnership aprono sempre nuove coop al Centro-Sud che sfornano prodotti «solidali». Don Ciotti si scomoda perfino per le aperture di qualche punto vendita, com'è successo quando le coop inaugurarono la loro libreria davanti all'Università Statale di Milano. L'agenda del prete è fittissima. Firma appelli, presenta libri di Laura Boldrini, promuove manifestazioni, guida cortei, interviene a tavole rotonde (a patto che non odorino di centrodestra), appare in tv, commemora le vittime della mafia, incontra studenti, ritira premi: l'ultimo è il Leone del Veneto 2015, ma nel 2010 fu insignito, tra gli altri, del premio Artusi «per l'originale contributo dato alla riflessione sui rapporti fra uomo e cibo». E poi inaugura mostre fotografiche e fa addirittura da padrino a rassegne di pattinaggio (è successo a Modena lo scorso 7 febbraio per il 19° trofeo intitolato a Mariele Ventre). In questo turbine di impegni, don Luigi non ha trovato il tempo di condannare apertamente le infiltrazioni della malavita organizzata nella galassia della cooperazione rossa. E non esistono soltanto «Mafia capitale» a Roma o le mazzette per il gas a Ischia; ci sono le indagini per la Tav, i lavori al porto di Molfetta, gli appalti di Manutencoop, le aziende legate al «Sistema Sesto» che coinvolgeva Filippo Penati, i cantieri Unieco in Emilia Romagna dove lavoravano famiglie della 'ndrangheta. Nei bilanci delle associazioni di don Ciotti i finanziamenti di Unipolis sono tra i pochi di cui è chiara la provenienza. Libera e Gruppo Abele rappresentano realtà consolidate. L'organizzazione antimafia ha chiuso il 2013 con entrate per 4 milioni 770mila euro raccolti in gran parte da enti pubblici: mezzo milione per la gestione dei beni confiscati, altrettanti per progetti e convenzioni internazionali, ulteriori 766mila per attività di formazione; 645mila euro arrivano grazie all'8 per mille, 200mila dalle tessere, 700mila dai campi estivi e 900mila da campagne di raccolta fondi. Maggiori problemi ha il Gruppo Abele, che ha chiuso il 2013 (ultimo bilancio disponibile) con una perdita di 273mila euro, e il 2012 era andato pure peggio: un buco di quasi due milioni su uno stato patrimoniale di circa 10. La situazione finanziaria è disastrosa, con debiti verso le banche per 5 milioni e altri 800mila verso fornitori garantiti da un cospicuo patrimonio immobiliare valutato in circa 6 milioni 300mila euro: la sede di Corso Trapani è un ex immobile industriale donato a don Ciotti dall'avvocato Agnelli. Affrontare il disagio sociale costa e molte attività assistenziali non possono essere soggette a «spending review». Indebitarsi è oneroso: 261mila euro (quasi tutta la perdita di esercizio) se ne vanno in anticipi e interessi su prestiti principalmente verso Banca Etica, Unicredit e Unipol banca. I ricavi non seguono l'andamento dei costi. Le rette delle persone ospitate in comunità e i proventi per corsi di formazione o vendita di libri e riviste fruttano 2.838.000 euro. Più consistenti sono le entrate da contributi: quasi 3.700.000 euro. Oltre tre milioni piovono da Commissione europea, ministeri, regioni ed enti locali, fondazioni imprecisate; altri generici «terzi» hanno donato 731mila euro mentre istituti bancari senza nome hanno erogato quasi 350mila euro. Don Ciotti è un campione nel fare incetta di finanziamenti pubblici. Ma non bastano. Ecco perché deve girare l'Italia e sollecitare la grande finanza progressista a essere generosa con i professionisti dell'antimafia e dell'antidroga. È uno dei preti di frontiera più famosi, con don Virginio Colmegna e don Gino Rigoldi. Dai convegni coop alle telecamere Mediaset (è andato da Maria De Filippi, ma nessuno si è indignato come per Renzi e adesso Saviano), dagli appelli per la Costituzione (con Rodotà, Zagrebelsky, Ingroia, Landini) perché «l'Italia è prigioniera del berlusconismo» fino alle manifestazioni no-Tav, don Ciotti è in perenne movimento. Non lo frenano gli incidenti di percorso: il settimanale Vita ha segnalato («legalità parolaia») che Libera e Gruppo Abele figurano tra i firmatari di un accordo con i gestori del business delle sale gioco mentre il loro leader si è sempre scagliato contro l'azzardo. Dopo che Papa Francesco l'anno scorso l'ha abbracciato e tenuto per mano alla commemorazione delle vittime di mafia, don Ciotti vive anche una sorta di rivincita verso la Chiesa «ufficiale» che a lungo l'aveva tenuto ai margini. Lo scorso Natale ha promosso un appello per «fermare gli attacchi a Papa Francesco»: è l'ultimo manifesto, per ora, proposto da don Ciotti. Ma non passerà troppo tempo per il prossimo.
Perché leggere Antonio Giangrande?
Ognuno di noi è segnato nella sua esistenza da un evento importante. Chi ha visto il film si chiede: perché la scena finale de “L’attimo fuggente” , ogni volta, provoca commozione? Il professor John Keating (Robin Williams), cacciato dalla scuola, lascia l’aula per l’ultima volta. I suoi ragazzi, riabilitati da lui dalla corruzione culturale del sistema, non ci stanno, gli rendono omaggio. Uno dopo l’altro, salgono in piedi sul banco ed esclamano: «Capitano, mio capitano!». Perché quella scena è così potente ed incisiva? Quella scena ci colpisce perché tutti sentiamo d’aver bisogno di qualcuno che ci insegni a guardare la realtà senza filtri. Desideriamo, magari senza rendercene conto, una guida che indichi la strada: per di là. Senza spingerci: basta l’impulso e l’incoraggiamento. Il pensiero va a quella poesia che il vate americano Walt Whitman scrisse dopo l'assassinio del presidente Abramo Lincoln, e a lui dedicata. Gli stessi versi possiamo dedicare a tutti coloro che, da diversi nell'omologazione, la loro vita l’hanno dedicata per traghettare i loro simili verso un mondo migliore di quello rispetto al loro vivere contemporaneo. Il Merito: Valore disconosciuto ed osteggiato in vita, onorato ed osannato in morte.
Robin Williams è il professor Keating nel film L'attimo fuggente (1989)
Oh! Capitano, mio Capitano, il tremendo viaggio è compiuto,
La nostra nave ha resistito ogni tempesta: abbiamo conseguito il premio desiderato.
Il porto è prossimo; odo le campane, il popolo tutto esulta.
Mentre gli occhi seguono la salda carena,
la nave austera e ardita.
Ma o cuore, cuore, cuore,
O stillanti gocce rosse
Dove sul ponte giace il mio Capitano.
Caduto freddo e morto.
O Capitano, mio Capitano, levati e ascolta le campane.
Levati, per te la bandiera sventola, squilla per te la tromba;
Per te mazzi e corone e nastri; per te le sponde si affollano;
Te acclamano le folle ondeggianti, volgendo i Walt Whitman (1819-1892) cupidi volti.
Qui Capitano, caro padre,
Questo mio braccio sotto la tua testa;
È un sogno che qui sopra il ponte
Tu giaccia freddo e morto.
Il mio Capitano tace: le sue labbra sono pallide e serrate;
Il mio padre non sente il mio braccio,
Non ha polso, né volontà;
La nave è ancorata sicura e ferma ed il ciclo del viaggio è compiuto.
Dal tremendo viaggio la nave vincitrice arriva col compito esaurito,
Esultino le sponde e suonino le campane!
Ma io con passo dolorante
Passeggio sul ponte, ove giace il mio Capitano caduto freddo e morto.
Antonio Giangrande. Un capitano necessario. Perché in Italia non si conosce la verità. Gli italiani si scannano per la politica, per il calcio, ma non sprecano un minuto per conoscere la verità. Interi reportage che raccontano l’Italia di oggi “salendo sulla cattedra” come avrebbe detto il professore Keating dell’attimo fuggente e come ha cercato di fare lo scrittore avetranese Antonio Giangrande.
Chi sa: scrive, fa, insegna.
Chi non sa: parla e decide.
Chissà perché la tv ed i giornali gossippari e colpevolisti si tengono lontani da Antonio Giangrande. Da quale pulpito vien la predica, dott. Antonio Giangrande?
Noi siamo quel che facciamo: quello che diciamo agli altri è tacciato di mitomania o pazzia. Quello che di noi gli altri dicono sono parole al vento, perche son denigratorie. Colpire la libertà o l’altrui reputazione inficia gli affetti e fa morir l’anima.
La calunnia è un venticello
un’auretta assai gentile
che insensibile sottile
leggermente dolcemente
incomincia a sussurrar.
Piano piano terra terra
sotto voce sibillando
va scorrendo, va ronzando,
nelle orecchie della gente
s’introduce destramente,
e le teste ed i cervelli
fa stordire e fa gonfiar.
Dalla bocca fuori uscendo
lo schiamazzo va crescendo:
prende forza a poco a poco,
scorre già di loco in loco,
sembra il tuono, la tempesta
che nel sen della foresta,
va fischiando, brontolando,
e ti fa d’orror gelar.
Alla fin trabocca, e scoppia,
si propaga si raddoppia
e produce un’esplosione
come un colpo di cannone,
un tremuoto, un temporale,
un tumulto generale
che fa l’aria rimbombar.
E il meschino calunniato
avvilito, calpestato
sotto il pubblico flagello
per gran sorte va a crepar.
E’ senza dubbio una delle arie più famose (Atto I) dell’opera lirica Il Barbiere di Siviglia del 1816 di Gioacchino Rossini (musica) e di Cesare Sterbini (testo e libretto). E’ l’episodio in cui Don Basilio, losco maestro di musica di Rosina (protagonista femminile dell’opera e innamorata del Conte d’Almaviva), suggerisce a Don Bartolo (tutore innamorato della stessa Rosina) di screditare e di calunniare il Conte, infamandolo agli occhi dell’opinione pubblica. Il brano “La calunnia è un venticello…” è assolutamente attuale ed evidenzia molto bene ciò che avviene (si spera solo a volte) nella quotidianità di tutti noi: politica, lavoro, rapporti sociali, etc.
Alla fine di noi rimane il nostro operato, checché gli altri ne dicano. E quello bisogna giudicare. Nasco da una famiglia umile e povera. Una di quelle famiglie dove la sfortuna è di casa. Non puoi permetterti di studiare, né avere amici che contano. Per questo il povero è destinato a fare il manovale o il contadino. Mi sono ribellato e contro la sorte ho voluto studiare, per salire nel mondo non mio. Per 17 anni ho cercato di abilitarmi nell’avvocatura. Non mi hanno voluto. Il mondo di sotto mi tiene per i piedi; il mondo di sopra mi calca la testa. In un esame truccato come truccati sono tutti i concorsi pubblici in Italia: ti abilitano se non rompi le palle. Tutti uguali nella mediocrità. Dal 1998 ho partecipato all’esame forense annuale. Sempre bocciato. Ho rinunciato a proseguire nel 2014 con la commissione presieduta dall’avv. Francesco De Jaco. L’avvocato di Cosima Serrano condannata con la figlia Sabrina Misseri per il delitto di Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana. Tutte mie compaesane. La Commissione d’esame di avvocato di Lecce 2014. La più serena che io abbia trovato in tutti questi anni. Ho chiesto invano a De Jaco di tutelare me, dagli abusi in quell’esame, come tutti quelli come me che non hanno voce. Se per lui Cosima è innocente contro il sentire comune, indotti a pensarla così dai media e dai magistrati, perché non vale per me la verità che sia vittima di un sistema che mi vuol punire per essermi ribellato? Si nega l’evidenza. 1, 2, 3 anni, passi. 17 anni son troppi anche per il più deficiente dei candidati. Ma gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Compiti non corretti, ma ritenuti tali in tempi insufficienti e senza motivazione e con quote prestabilite di abilitati. Così per me, così per tutti. Gli avvocati abilitati negano l’evidenza. Logico: chi passa, non controlla. Ma 17 anni son troppi per credere alla casualità di essere uno sfigato, specialmente perché i nemici son noti, specie se sono nelle commissioni d’esame. In carcere o disoccupato. Tu puoi gridare a squarciagola le ingiustizie, ma nessuno ti ascolta, in un mondo di sordi. Nessuno ti crede. Fino a che non capiti a loro. E in questa Italia capita, eccome se capita! La tua verità contro la verità del potere. Un esempio da raccontare. Ai figli non bisogna chiedere cosa vogliono fare da grandi. Bisogna dir loro la verità. Chiedergli cosa vorrebbero che gli permettessero di fare da grandi. Sono nato in quelle famiglie che, se ti capita di incappare nelle maglie della giustizia, la galera te la fai, anche da innocente. A me non è successo di andare in galera, pur con reiterati tentativi vani da parte della magistratura di Taranto, ma sin dal caso Tortora ho capito che in questa Italia in fatto di giustizia qualcosa non va. Pensavo di essere di sinistra, perché la sinistra è garantismo, ma non mi ritrovo in un’area dove si tollerano gli abusi dei magistrati per garantirsi potere ed impunità. E di tutto questo bisogna tacere. A Taranto, tra i tanti processi farsa per tacitarmi sulle malefatte dei magistrati, uno si è chiuso, con sentenza del Tribunale n. 147/2014, con l’assoluzione perché il fatto non sussiste e per non doversi procedere. Bene: per lo stesso fatto si è riaperto un nuovo procedimento ed è stato emesso un decreto penale di condanna con decreto del Gip. n. 1090/2014: ossia una condanna senza processo. Tentativo stoppato dall’opposizione.
Zittirmi sia mai. Pur isolato e perseguitato. Gli italiani son questi. Ognuno dia la sua definizione. Certo è che gli italiani non mi leggono, mi leggono i forestieri. Mi leggeranno i posteri. Tutto regolare: lo ha detto la tv, lo dicono i giudici. Per me, invece, è tutto un trucco. In un mondo di ladri nessuno vien da Marte. Tutti uguali: giudicanti e giudicati. E’ da decenni che studio il sistema Italia, a carattere locale come a livello nazionale. Da queste indagini ne sono scaturiti decine di saggi, raccolti in una collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", letti in tutto il mondo, ma che mi sono valsi l’ostruzionismo dei media nazionali. Pennivendoli venduti ai magistrati, all’economia ed alla politica, ma che non impediscono il fatto che di me si parli su 200.000 siti web, come accertato dai motori di ricerca. Book ed E-Book che si possono trovare su Amazon.it, Lulu.com. CreateSpace.com e Google Libri, oltre che in forma di lettura gratuita e free vision video su www.controtuttelemafie.it , mentre la promozione del territorio è su www.telewebitalia.eu.
Ha la preparazione professionale per poter dire la sua in questioni di giustizia?
Non sono un giornalista, ma a quanto pare sono l’unico a raccontare tutti i fatti. Non sono un avvocato ma mi diletto ad evidenziare le manchevolezze di un sistema giudiziario a se stante. La mia emigrazione in piena adolescenza in Germania a 16 anni per lavorare; la mia laurea quadriennale in Giurisprudenza presa in soli due anni all’Università Statale di Milano, lavorando di notte e con moglie e due figli da mantenere, dopo aver conseguito il diploma da ragioniere in un solo anno da privatista presso un Istituto tecnico Statale e non privato, per non sminuirne l’importanza, portando tutti i 5 anni di corso; tutto ciò mi ha reso immune da ogni condizionamento culturale od ambientale. I miei 6 anni di esercizio del patrocinio legale mi hanno fatto conoscere le macagne di un sistema che non è riuscito a corrompermi. Per questo dal 1998 al 2014 non mi hanno abilitato alla professione di avvocato in un esame di Stato, che come tutti i concorsi pubblici ho provato, con le mie ricerche ed i miei libri, essere tutti truccati. Non mi abilitano. Perché non sono uguale agli altri, non perché son meno capace. Non mi abilitano perché vedo, sento e parlo. Ecco perché posso parlare di cose giuridiche in modo di assoluta libertà, senza condizionamento corporativistico, anche a certezza di ritorsione. E’ tutta questione di coscienza.
E’ STATO LA MAFIA!
Avevo, con la mia famiglia, un bar ristorante discoteca al mare. Tutto autorizzato. Lavoravo con la pistola denunciata sotto il bancone del bar e nelle ore libere mi allenavo per ore nelle arti marziali per difendermi dai criminali, perchè le Forze dell'Ordine, quando ne hai bisogno, non ci sono mai. D'inverno qualcuno ha incendiato il tutto. Nessuna richiesta estorsiva. Solo un atto dimostrativo per gli altri. Succede anche questo, anche se i benpensanti parlano di omertà. Ti rovinano e non sai chi ed il perchè. Non mi è rimasto niente. Non ho ricevuto niente dallo Stato. Volevo riaprire con le mie forze e con coraggio ricominciare da zero. Quello Stato che prima mi ha fatto aprire, poi da vittima di mafia mi ha impedito di ricominciare, negandomi le autorizzazioni che già mi aveva rilasciato. Scegliendo la via professionale mi è stato impedito di esercitare l'avvocatura, così come la magistratura: non abilitato perchè non ero omologato. Non sopportavo corruzione ed ingiustizia nei tribunali. Mi sono ribellato difendendo le vittime, raccontando le loro storie. I Magistrati insabbiano le mie denunce e tentano in tutti i modi di condannarmi ingiustamente per diffamazione a mezzo stampa. Se sei diverso ti fanno passare per pazzo o mitomane. Non ci riescono. Ecco perchè la mia associazione nazionale si chiama "Associazione Contro Tutte le Mafie", perchè quelli come me i veri nemici li hanno nelle istituzioni. I servitori dello Stato, quindi "servi" nostri e pagati da noi, abusano dei loro poteri e nessuno li perseguita. Sbandierano leggi e sparlano di legalità: leggi e legalità che "lo stato" (s minuscola) calpesta sotto i piedi. Mi si dica: qual è la differenza tra chi ti fa chiudere l'azienda con le bombe e chi non te la fa riaprire? Io, Antonio Giangrande, non trovo differenza e per questo non sono pubblicizzato come Don Ciotti e "Libera": sostenuti da magistratura, media e politica e sindacati di sinistra. La Mafia dell’Antimafia, non solo in testi, ma anche in video sui miei canali Youtube. I veri amici condividono e fanno condividere le mie battaglie e fanno conoscere i miei strumenti di divulgazione. Chi non condivide in compagnia: è un ladro o una spia!
ITALIA MAFIOSA. IL PAESE DEI COMUNI SCIOLTI PER MAFIA SE AMMINISTRATI DALL’OPPOSIZIONE DI GOVERNO.
Scoppia il caso del senatore Fazzone: siede in Antimafia ma si era schierato con le cosche. L'inchiesta di Repubblica sui comuni sciolti per mafia solleva l'inopportunità della presenza del parlamentare di FI nell'organismo parlamentare, scrive Alberto Custodero su “La Repubblica”. "Quel senatore si schierò a favore del comune infiltrato dalle cosche, è "impresentabile", non può sedere in commissione Antimafia". E' l'inchiesta di Repubblica sullo scioglimento dei consigli comunali per mafia che fa scoppiare il caso Fazzone. Quando il ministro dell'Interno Roberto Maroni chiese lo scioglimento del consiglio comunale di Fondi, infiltrato da 'ndrangheta e camorra, il senatore Claudio Fazzone, ex Pdl, ora Fi, difese a spada tratta il comune infiltrato. Negò la presenza delle cosche accertata da una relazione di 500 pagine dell'allora prefetto di Latina, Bruno Frattasi. E attaccò lo stesso Frattasi minacciandolo di querela e chiedendo contro di lui una commissione d'inchiesta parlamentare. Ora Fazzone (il cui nome era entrato nella relazione del prefetto in quanto in affari con pezzi dell'amministrazione collusa), siede nella commissione parlamentare Antimafia presieduta dalla dem Rosy Bindi. Si tratta della commissione bicamerale che fra l'altro si pronuncia sui comuni infiltrati. E giudica - come nel caso del governatore della Campania, Vincenzo De Luca - se i candidati alle politiche siano o meno impresentabili. Fazzone (che vanta il record delle assenze: non s'è mai presentato neppure una volta ai lavori della Commissione) si presenta come "imprenditore, funzionario di Polizia in aspettativa". Residente proprio a Fondi dove gli è stata posta sotto sequestro una faraonica villa in quanto abusiva (formalmente intestata alla moglie), è un ex appuntato di pubblica sicurezza, ex autista di Nicola Mancino quando era ministro degli Interni, poi transitato nei servizi segreti. Postosi in aspettativa, ha cominciato la sua scalata politica, eletto alla Regione Lazio nel 2000 con più di 28mila preferenze, un terzo sono arrivate da Fondi proprio dove lui si è battuto per non far sciogliere il Comune per mafia. Rieletto nel 2005 con 38mila preferenze, si è poi dimesso per diventare senatore del Pdl. Eppure c'era stato chi, a inizio dell'attuale legislatura, aveva tentato di stoppare in qualche modo la nomina di Fazzone all'Antimafia. È il caso della deputata dem Laura Garavini, che, in una riunione di Gruppo Pd, sollevò ufficiosamente la questione con Rosy Bindi, presidente della Commissione. La Bindi si trincerò (e si trincera ancora oggi) dietro la scusa che esistono delle regole. Ovvero, le nomine vengono fatte dai presidenti di Camera e Senato su indicazione dei partiti. E la commissione è negata in base a un codice etico interno a chi è indagato o rinviato a giudizio. Pare che anche in Senato qualcuno abbia posto al presidente Pietro Grasso la questione. Ma non ci fu nulla da fare: Fazzone fu nominato all'Antimafia. Dunque, chi ha difeso comuni collusi e attaccato funzionari antimafia, è il benvenuto in questa Commissione? "Trovo incredibile - risponde Emanuele Fiano, responsabile Sicurezza per il Pd - che il senatore Fazzone sieda in quella commissione Antimafia che dovrebbe verificare tra l'altro le condizioni di scioglimento dei comuni a rischio infiltrazioni. Proprio lui che a suo tempo minacciò di querelare il prefetto Frattasi che, giustamente, aveva chiesto all'allora governo Berlusconi lo scioglimento del comune di Fondi infiltrato da organizzazioni criminali". "A mio parere - aggiunge Fiano - la commissione Antimafia (ovviamente nella sua autonomia) dovrebbe valutare l'opportunità che un senatore citato più volte nella relazione del prefetto di Latina relativa allo scioglimento di Fondi rimanga membro della Commissione che proprio questi fatti dovrebbe giudicare". "Cambiare la legge sullo scioglimento - commenta Laura Garavini, componente storica dell'Antimafia - rischia di essere solo un alibi. Basta applicare bene la normativa esistente. ma prima di tutto bisogna avere il coraggio di guardare al proprio interno". "Se - continua Garavini - addirittura in Antimafia ci sono persone che poco tempo fa si sono adoperate affinché la legge sullo scioglimento non fosse rispettata - come Fazzone per Fondi - allora possiamo cambiare tutte le leggi del mondo. Ma il risultato rischia di essere lo stesso". Per Claudio Fava, vicepresidente della Commissione, ex Sel, ora all'opposizione come indipendente di sinistra, "in una Commissione così delicata conta anche il senso dell'opportunità. Peraltro, l'assenza di Fazzone di fatto da un anno e mezzo in Commissione, pur essendone un componente, ci dice due cose: o il suo imbarazzo. O la sua indifferenza per le materie trattate". "In entrambi i casi - osserva Fava - non mi pare un atteggiamento di assoluta responsabilità". Dopo il codice sugli impresentabili alle politiche, ce ne vorrebbe allora uno anche per chi entra all'Antimafia, cioè per chi giudica gli impresentabili? "Non credo - conclude il vicepresidente dell'Antimafia - che un codice di autoregolamentazione possa valutare una questione di opportunità. Più che un codice, conta avere piena responsabilità: chi sceglie di sedere in questa Commissione, deve starci solo se si ritiene totalmente libero. E totalmente interessato a svolgere questa attività".
Il Paese dei Comuni sciolti per mafia. Da quasi un quarto di secolo ogni mese un municipio viene commissariato per infiltrazioni della criminalità organizzata: è questo il bilancio della speciale legge introdotta nel 1991. Una norma che oggi, sulla scia dello scandalo per il caso di Mafia Capitale, si sente l'urgenza di rivedere. Ma il problema, rivela la storia di questi anni, non è tanto nel testo del provvedimento, quanto nel fatto che troppo spesso è stato usato come strumento di lotta politica tra gli opposti schieramenti, scrivono il 25 agosto 2015 Giuseppe Baldessarro ed Alberto Custodero su “La Repubblica”.
Una norma preventiva snaturata dai governi, di Alberto Custodero. Una legge tutta da rifare? A quasi un quarto di secolo dall'entrata in vigore della norma sullo scioglimento dei comuni infiltrati dalla mafia, politica, società civile, associazioni antimafia si interrogano oggi se lo strumento dello scioglimento sia ancora attuale ed efficace. O se non sia meglio cambiarlo o modificarlo. A proposito del caso Roma, su cui il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha promesso un pronunciamento del Viminale per il 27 agosto, è lo stesso presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, del resto, a invocare addirittura un decreto legge che introduca strumenti ad hoc per affrontare le difficoltà di Comuni molto grandi. "Bisogna individuare una terza via - dice Bindi - fra scioglimento o non scioglimento, e potrebbe essere un tutoraggio dello Stato, un'assistenza verso l'ente "parzialmente infiltrato", senza che questo debba essere commissariato o debba perdere la guida politica". "È importante dunque anzitutto intervenire sulle norme in materia di scioglimento - sottolinea il presidente dell'Antimafia - alla luce di un'esigenza che ha avvertito lo stesso governo presentando un disegno di legge che è attualmente pendente al Senato in attesa di approvazione". Per capire cosa stia accadendo, è necessario fare un po' di storia. La legge 221 nacque nel 1991 da una situazione di emergenza, come risposta alla decapitazione avvenuta a Taurianova di un affiliato alla 'ndrangheta la cui testa fu lanciata in aria e fatta oggetto di un macabro tiro al bersaglio a pistolettate. La norma doveva avere valore preventivo, affidando al ministero dell'Interno il potere di sciogliere i Comuni in modo autonomo e svincolato dalle indagini della magistratura, lunghe e complesse. Da allora i governi hanno utilizzato questo strumento antimafia in modo altalentante, con una forte discrezionalità politica. Quasi mai sono intervenuti in via preventiva, quasi sempre hanno applicato la legge in seguito a indagini penali, snaturandone così il marchio di fabbrica. Hanno sciolto 258 amministrazioni locali e cinque Aziende sanitarie. Otto comuni hanno il record dei tre scioglimenti: Casal di Principe, Casapesenna, Grazzanise, Melito di Porto Salvo, Misilmeri, Roccaforte del Greco, San Cipriano d'Aversa e Taurianova. Trentotto sono stati commissariati invece due volte. Nel 2012 per la prima volta è stato sciolto invece un capoluogo di provincia importante come Reggio Calabria. Al Centro Nord gli scioglimenti sono più rari: pochissimi in Piemonte, uno, a Sedriano, in Lombardia, anche se secondo alcuni esperti non era quello più "infiltrato" dalla 'ndrangheta. Quest'anno, poi, il prefetto di Reggio Emilia ha nominato la commissione per effettuare l’accesso nel comune di Brescello, il primo passo di una lunga procedura che deve valutare l'eventuale presenza di infiltrazioni mafiose nell'amministrazione comunale, un'anteprima assoluta in Emilia Romagna, quella che dal Dopoguerra in poi è sempre stata considerata la patria del buongoverno. E sempre quest'anno, per la prima volta "un accesso", come viene detto in gergo burocratico, ha riguardato Roma, la Capitale. Sotto le scure della legge non è mai caduto invece un Consiglio provinciale e allo stesso modo sono passati indenni anche i cosiddetti "enti terzi", come le società partecipate che, invece, sono sempre più strumenti di effettivo governo del territorio e, dunque, oggetto degli appetiti mafiosi. Ma i criteri di scioglimento non sono sempre stati gli stessi. I governi tecnici degli anni Novanta, così come quelli del Duemila, non avendo interessi e finalità elettorali da tutelare, hanno fatto il massimo ricorso alla legge senza guardare al colore politico delle amministrazioni infiltrate: nel triennio 1991-94 gli scioglimenti sono stati in media 30 l'anno, 36 in 17 mesi con il solo governo Monti. Ma quando al potere vanno i politici, le cose cambiano e lo scioglimento passa, se così si può dire, da strumento, a strumentale. Strumentale per "tutelare" i Comuni del proprio colore e per prendere di mira quelli di colore opposto. È il sociologo Vittorio Mete (autore del volume "Fuori dal Comune. Lo scioglimento delle amministrazioni locali per infiltrazioni mafiose", Bonanno, 2009), a scoprire nei suoi studi questo singolare aspetto. "I governi di centrodestra e di centrosinistra - ricostruisce - sembrano comportarsi in maniera non troppo dissimile: essi tendono a sciogliere più frequentemente (quelli di centro-destra ancor più di quelli di centro-sinistra) le amministrazioni locali di opposto colore politico". Gli scioglimenti, dunque (quanti, quali, dove) ci parlano certamente della mafia, ma ci parlano, anche, di come funzionano lo Stato e l'apparato dell'antimafia. E di come lo strumento sia al contempo strumento di contrasto alla mafia e strumento di lotta politica. Gli scioglimenti, infatti, dovrebbero rispondere a una sola logica: "Se le mafie condizionano o minacciano di condizionare un comune - spiega Mete - l'amministrazione comunale va sciolta. In caso contrario, no". Purtroppo, questi 25 anni di applicazione della legge ci raccontano una storia diversa fatta, per dirla con le parole di Raffaele Cantone, il magistrato a capo dell'Autorità nazionale anticorruzione, "di estenuanti 'mediazioni' politiche sugli scioglimenti". Il riferimento, esplicito, è al caso del comune di Fondi, nel basso Lazio. Il municipio, amministrato dal Pdl e infiltrato da camorra, 'ndrangheta e mafia, il cui scioglimento fu chiesto per due volte nel 2009 dall'allora responsabile del Viminale Roberto Maroni (Lega) con la seguente motivazione: "Il Comune di Fondi presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata tali da compromettere il buon andamento dell'amministrazione, con grave e perdurante pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Emergono significative circostanze di vicinanza e contiguità al sodalizio in relazione al sindaco, a diversi esponenti della giunta. La presenza e l'estensione dell'influenza criminale rende necessario il commissariamento per 18 mesi". Nonostante ciò, Fondi fu salvato per due volte dal Consiglio dei ministri del governo Berlusconi. La maggioranza del consiglio comunale, approfittando del mancato intervento del governo, si dimise in massa, evitando i 18 mesi di commissariamento. Il ministro dell'Interno leghista avallò l'escamotage senza batter ciglio. Il comune andò subito al voto e il Pdl, con quasi tutti gli stessi amministratori oggetto dello scioglimento (alcuni dei quali riconfermati assessori), tornò al governo del comune con il 65 per cento dei voti. Il sindaco che guidava l'amministrazione collusa, Luigi Parisella, fu poi eletto in consiglio provinciale. Bruno Frattasi, il prefetto di Latina che aveva chiesto lo scioglimento, fu oggetto di pesanti intimidazioni da parte dei vertici locali del Pdl: fu definito "pezzo deviato dello Stato" dall'ex presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani. E il senatore Claudio Fazzone (ex Pdl, ora Fi), plenipotenziario di Berlusconi nel Pontino, minacciò di querelarlo, difese a spada tratta l'amministrazione infiltrata e invocò contro il prefetto addirittura l'apertura di una commissione parlamentare d'inchiesta. Fazzone, più volte citato nella relazione di Frattasi (in quanto socio del sindaco Parisella e di tal Luigi Peppe, "il cui fratello risultava in rapporti certi con una famiglia"), è attualmente componente della Commissione Antimafia che si sta occupando proprio di scioglimenti di consigli comunali. L'allora segretario Pd di Fondi, Bruno Fiore, infine, che si oppose con tutte le sue forze al mancato commissariamento, fu oggetto di un attentato intimidatorio fortunatamente fallito. Insomma, il caso Fondi ha segnato uno spartiacque, un precedente assoluto e gravissimo, ha profondamente segnato, e minato la credibilità della legge, perché in quel caso lo Stato s'è arreso di fronte alla criminalità. "E ora è a rischio - commenta l'avvocato Francesco Fusco, del comitato antimafia di Fondi - l'intero funzionamento degli anticorpi normativi ed esecutivi contro la mafia. Qualunque comune colluso con la mafia ricorrerà alle dimissioni per potersi ripresentare, ripulito, e più in forze di prima". Il dibattito sulla bontà della legge resta dunque aperto, ma, secondo Mete, il quadro va allargato ulteriormente. "L'analisi di alcune vicende - spiega il sociologo - fa emergere un altro aspetto, solitamente poco discusso: in molti casi di scioglimento per mafia il principale problema che pregiudica il buon andamento dell'attività amministrativa dell'ente locale non è quello mafioso". "Lo dichiara apertamente - aggiunge Mete - l'attuale Capo della Polizia che, in qualità di prefetto di Napoli, e riferendosi alla situazione campana, scrisse: 'Anche nei Comuni sciolti per infiltrazione camorrista, il tasso di condizionamento camorrista è sempre inferiore rispetto a quello dell'illegalità non connessa al crimine organizzato. Insomma, sembra prevalere un bieco clientelismo finalizzato in via esclusiva ad alimentare un sistema affaristico imprenditoriale di natura parassitaria, rispetto al condizionamento o alla collusione con le cosche che operano sul territorio'". Siamo sicuri, allora, che per risolvere i problemi delle collusioni mafiose nei Comuni basti una ennesima modifica della legge? Inseguire una nuova riforma normativa non è forse un alibi della politica per non affrontare il vero problema, che è il funzionamento della democrazia a livello locale in ampi territori del Paese? "L'argomento principale dei critici è che l'attuale legge 'non risolve' il problema e il suo fallimento sarebbe attestato dai doppi e tripli scioglimenti dello stesso ente locale. In verità, è sempre difficile stabilire se una legge 'funziona' o meno. Quel che è certo è che non si può far discendere il giudizio sulla bontà di una norma dalla sua capacità di risolvere definitivamente un problema, specie se così ampio". Vittorio Mete, ricercatore in Sociologia Politica presso l'università di Catanzaro, è scettico rispetto alla necessità di cambiare la normativa.
Perché la legge è così tanto criticata?
"Da punto di forza, la celerità, la discrezionalità e la 'leggerezza' probatoria della legge (la cui natura ha una matrice emergenziale) sono diventati, con il tempo, il tallone d'Achille della normativa".
Che cosa è stato fatto per porre rimedio a questo punto debole?
"Per tentare di rispondere all'onda montante di critiche, il legislatore ha più volte provato a modificare la legge del 1991. La riforma del 2009 e le proposte di modifica attualmente in discussione - come le raccomandazioni formulate nel luglio 2015 dall'Antimafia - cercano di far affannosamente convergere questo strumento di contrasto verso forme di intervento antimafia più usuali, allontanandolo ulteriormente dalla sua impostazione iniziale. Dalla originaria finalità preventiva e responsabilità collegiale si va, infatti, verso una 'personalizzazione' delle responsabilità e delle sanzioni".
Secondo lei, questa è la strada giusta?
"Com'è facile intuire, questa deriva è fonte di non pochi problemi, visto che con un procedimento di fatto tutto interno alle prefetture e al ministero dell'Interno si va ad intaccare dei diritti costituzionali. Quest'ultimo punto è di particolare interesse perché aggiunge un tassello a quella che sembra essere una tendenza di fondo delle politiche antimafia: le misure che funzionano e portano frutti sono le stesse che fanno arretrare le garanzie e i diritti. Si pensi al vasto quanto problematico tema della confisca dei beni, alle interdittive antimafia, al regime detentivo speciale del 41-bis".
Come rendere la procedura di scioglimento meno discrezionale e aleatoria e più in grado di "giustificarsi", anche durante la gestione commissariale, agli occhi dei cittadini?
"Purtroppo, non solo in tema di Comuni sciolti, l'esperienza insegna che non basta ritoccare l'impianto normativo per avere un impatto, men che meno quello auspicato, sulla realtà. Al contrario, quel che spesso conta è la prassi applicativa che in questo caso è modellata dall'impulso politico del Governo e del Ministro dell'Interno, da inerzie organizzative, dal clima di opinione, dagli incentivi offerti ai diversi attori in gioco, perfino dalla propensione dei singoli prefetti a usare (o evitare) lo strumento dello scioglimento".
Cosa pensa del dibattito sorto attorno al caso Roma sulla necessità di cambiare la normativa sullo scioglimento?
"La storia degli scioglimenti (quanti, quali, dove) ci parlano certamente della mafia, ma ci parlano anche di come funzionano lo Stato e l'apparato dell'antimafia. Ben vengano, dunque, interventi migliorativi sul piano legislativo, a patto che essi non costituiscano una trappola che potremmo chiamare 'alibi delle riforme' che da tempo caratterizza il dibattito politico nel nostro paese, non solo a proposito di mafie. È un alibi delle riforme pensare che la soluzione normativa adeguata e risolutiva esista e che se non la si adotta è solo per incapacità tecnica o per mancanza di volontà politica. Allora, prima di riporre (nuovamente) tutte le speranze in qualche salvifico articolo di legge, sarebbe opportuno soffermarsi sulla pratica applicativa e tentare di incidere su di essa. Solo così si eviterà che si generi (ulteriore) sfiducia nei confronti delle istituzioni. Quella stessa sfiducia che è uno dei presupposti stessi dell'esistenza delle mafie".
Da Reggio a Platì i tristi record della Calabria, di Giuseppe Baldessarro. Dai piccoli municipi ai comuni come Reggio Calabria, capoluogo di provincia e città metropolitana. La legge sullo scioglimento delle amministrazioni "a rischio infiltrazioni mafiose" non ha fatto sconti. Una dopo l'altra, dall'agosto del 1991 allo scorso dicembre 2014, giunte e consigli mandati a casa su richiesta delle prefetture calabresi sono state complessivamente 79. Dati alla mano si tratta della seconda regione italiana nella quale la legge è stata applicata, con una situazione migliore soltanto alla Campania e leggermente peggiore la Sicilia. Un record per nulla invidiabile che si aggrava se si tiene conto della densità della popolazione (meno di 2 milioni di abitanti). Secondo gli ultimi dati ufficiali, in questo momento, i municipi commissariati e amministrati dai funzionari dello Stato sono 15, anche se in realtà il numero va aggiornato. Dopo le ultime amministrative di primavera infatti le urne hanno ridato un governo democraticamente eletto ai comuni di Melito Porto Salvo e Siderno (entrambi nella provincia di Reggio Calabria). Resta tuttavia un dato allarmante se si considera che in tutta Italia le gestioni commissariali per questioni legate alla criminalità organizzata sono complessivamente 27, e che quindi la metà di esse si trova in Calabria. Dopo 24 anni di applicazione della legge, anche in Calabria non sono pochi i dubbi sulla validità dello strumento ideato a suo tempo per difendere i comuni dall'aggressione della criminalità organizzata e per colpire le complicità di amministratori e dipendenti infedeli. Non ha caso da mesi il Procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho, parla di legge che "va rivista e aggiornata alla luce degli anni di esperienza fatta sui diversi territori". Che la norma sia risultata spesso inefficace lo dimostrano i ripetuti scioglimenti di comuni come Lamezia Terme, Taurianova o Platì, tutti commissariati più volte. Per gli analisti è la dimostrazione che non sempre mandare a casa un'amministrazione e tornare alle urne dopo i 18 mesi (quando non ci sono proroghe) di amministrazione "controllata" sia risolutivo. In questo senso l'ultimo caso giunto alla ribalta delle cronache è quello di Platì, piccola comunità nell'entroterra della locride, nella quale nessuno vuole più fare il sindaco convinto che il comune sarebbe comunque sciolto per mafia a causa della nomea di paese ad alta densità mafiosa o delle parentele scomode che chiunque, in maniera diretta o indiretta, ha con personaggi più o meno legati alla 'ndrangheta. Di fatto, tranne qualche breve parentesi, tra scioglimenti e dimissioni, a Platì non c'è un'amministrazione dal 2003 e anche alle ultime elezioni, la scorsa primavera nessuna lista è stata presentata. Il caso più eclatante resta comunque lo scioglimento del comune di Reggio Calabria nell'ottobre del 2012, quando per la prima volta è stato sciolto un capoluogo di provincia. Non un municipio qualsiasi, ma una delle dieci città metropolitane, considerata dal punto di vista della popolazione, delle influenze politiche ed economiche il municipio più importante della regione. Insomma la capitale, anche se soltanto di una regione. Uno scioglimento decretato "per la contiguità con alcuni ambienti mafiosi", e dunque ben oltre il semplice rischio infiltrazione. Piccole e grandi città azzerate dal ministero degli Interni, ma non solo. Nel corso degli anni nel mirino della legge sono finte anche l'azienda ospedaliera di Locri, sciolta dopo l'omicidio del vice presidente del Consiglio regionale Francesco Fortugno (primario del Pronto Soccorso), e l'Asp di Vibo Valentia pesantemente condizionata dai clan della 'ndrangheta.
Dal 1990 oltre 4mila gli scioglimenti "ordinari". Non ci sono solo le amministrazioni costrette a chiudere la loro esperienza prima del tempo per motivi drammatici come le infiltrazioni mafiose. Come ricostruiva il Sole 24 Ore di qualche settimana fa sulla base di dati del Viminale, dal 1990 ad oggi oltre 4mila municipi per vari motivi hanno interrotto la loro attività in via ordinaria, così come prevede l'articolo 141 del testo unico degli enti locali (Tuoel): dimissioni dei consiglieri (1309 volte dal 2001 ad oggi), approvazioni di mozioni di sfiducia (77 volte), dimissioni volontarie del sindaco (497 volte), mancata approvazione del bilancio (84 volte) e una serie di altri casi meno ricorrenti come il mancato rendiconto di gestione (3 volte). Tornando a guardare i numeri sull'intero periodo di applicazione della legge, il risultato è davvero impressionante: la media è di 175 enti sciolti ogni anno, vale a dire un comune commissariati uno ogni due giorni. Una volta stabilito lo scioglimento con un decreto del presidente della Repubblica, viene nominato contestualmente un commissario straordinario che resterà in carica fino alle successive elezioni, fissate solitamente alla prima data utile. Fanno eccezione i caso di scioglimento per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, circostanze in cui il potere passa al vicesindaco incaricato, senza la designazione di un commissario, di condurre l'ente locale al voto per il rinnovo del consiglio.
LEZIONE DI MAFIA.
La lezione fascista: battere la mafia si può, basta appoggiare chi la combatte, scrive Antonio Pannullo su “Il Secolo D’Italia”. Su Cesare Mori, di cui ricorre l’anniversario della morte (5 luglio 1942), quel prefetto di ferro che sconfisse la mafia durante il fascismo, è stato detto e scritto praticamente tutto: su di lui sono disponibili una ventina di libri, vari film, alcuni sceneggiati, tra cui l’ultimo, una miniserie tv in due puntate, Cesare Mori – Il prefetto di ferro, è stato trasmesso nel 2012, a riprova della grande attualità dell’opera di questo servitore dello Stato che dimostrò che se una cosa si vuole fare, la si fa. Lui riuscì dove in seguito fallì l’Italia repubblicana, con gli assassinii di Carlo Alberto Dalla Chiesa, altro prefetto di ferro, dei giudici Falcone e Borsellino e di altre centinaia di uomini assassinati dalla criminalità organizzata siciliana. Su Mori oramai si sa tutto. Quello che è interessante oggi è capire come fece a debellare la mafia, come mai in seguito la mafia tornò, e quale debba essere il ruolo e il limite dello Stato nell’affrontare un’emergenza di questo tipo, emergenza che oggi, nel mondo occidentale, è presente solo nel nostro Paese, almeno a questo livello di organizzazione e di aggressività. Una delle linee-guida del fascismo era che nessun potere dovesse esserci al di fuori dello Stato, e certamente non un potere criminale. Il caso del Mezzogiorno d’Italia, dove il potere delle cosche strozzava l’economia delle regioni e dove pertanto la rivoluzione fascista non poteva convenientemente realizzarsi, convinse Benito Mussolini e i suoi collaboratori ad affrontare il problema. Sappiamo che nei primi mesi del 1924 Mussolini aveva compiuto un viaggio in Sicilia, dove alcuni fedelissimi lo avevano messo al corrente della situazione, situazione che sembrava veramente non risolvibile, in quanto il sistema mafioso era incancrenito e cristallizzato. Probabilmente Mussolini si rese conto che la credibilità del fascismo avrebbe subito un dito colpo se non avesse risolto il problema della mafia, e prese il toro per le corna. In quello stesso anno, nel corso di pochi mesi, inviò in Sicilia Cesare Mori – che prima del fascismo aveva già prestato servizio nell’isola e che quindi la conosceva bene – e il giudice Luigi Giampietro come procuratore generale e il delegato calabrese Francesco Spanò. Ecco il testo del telegramma di Mussolini al Mori: «Vostra Eccellenza ha carta bianca, l’autorità dello Stato deve essere assolutamente, ripeto assolutamente, ristabilita in Sicilia. Se le leggi attualmente in vigore la ostacoleranno, non costituirà problema, noi faremo nuove leggi». La mafia per alcuni anni fu costretta a chinare il capo di fronte al governo italiano. Il fascismo voleva veramente risolvere una volta per tutte il problema della mafia in Sicilia, e lo fece, non esitando a coinvolgere e ad arrestare anche esponenti, grandi e piccoli, del fascismo locale. Mussolini in quella circostanza non guardò in faccia a nessuno. Dapprima Mori fu mandato come prefetto a Trapani, dove aveva dato già buona prova di sé qualche anno prima, e iniziò revocando tutti i porto d’armi, e istituendo una commissione per il controllo dei nullaosta relativi ai permessi di campieraggio e guardiania, attività legate a cosa nostra. L’anno successivo Mori fu nominato prefetto di Palermo, con competenza su tutto il territorio regionale e con ampi poteri, dove iniziò sul serio la battaglia. Battaglia che fu durissima, a tutti ii livelli: sradicò abitudini, consuetudini, arrestò signori e signorotti locali, latifondisti, impiegati pubblici, banditi, briganti, fascisti. I risultati furono straordinari già nei primi anni: nella sola provincia di Palermo gli omicidi scesero da 268 nel 1925 a 77 nel 1926, le rapine da 298 a 46, e anche altri crimini diminuirono drasticamente. Intraprese varie iniziative, ma lui andava particolarmente fiero dell’aver arrestato e fatto condannare Vito Cascio Ferro, pezzo da novanta della mafia italo-americana, che nel 1909 aveva assassinato sulla Marina di Palermo Joe Petrosino. La sua azione più famosa, perché spettacolare, fu il celebre assedio di Gangi, considerata allora una delle roccheforti dei mafiosi. Con un ingente numero di militi delle forze dell’ordine, Mori rastrellò il paese casa per casa, prendendo in ostaggio familiari di mafiosi per costringerli ad arrendersi, e riuscendo a catturare decine di mafiosi, banditi, criminali e latitanti. Probabilmente allora, per la durezza dei metodi, si guadagnò il soprannome col quale è ricordato. Oggi a Gangi c’è una targa che la popolazione grata gli ha dedicato per la sua opera meritoria. Per colpire la mafia Mori non esitò a indagare negli ambienti fascisti. Contemporaneamente Mori colpì i circoli politico-affaristici e perseguì Alfredo Cucco, il numero uno del fascismo siciliano, nonché membro del Gran Consiglio del fascismo, il quale venne rinviato a processo e addirittura espulso dal Pnf. Cucco però fu assolto, e ci sono sospetti che per lui, medico stimatissimo, si fosse trattato di una trappola, in quanto molti vicino a Roberto Farinacci, che come è noto non era molto amato da Mussolini. Tuttavia la mafia era stata decapitata, ridotta all’impotenza, al silenzio: i suoi esponenti che non vennero arrestati dovettero fuggire negli ospitali Stati Uniti, da dove poi nel 1945 ritorneranno a cavallo dei cannoni dei carri armati americani, che riportarono la mafia in auge un Sicilia, dando anche ai capi mafiosi locali incarichi amministrativi importanti, come dimostra la storiografia del dopoguerra. Va anche sottolineato che dopo gli arresti e le incriminazioni, i processi si facevano, le condanne arrivavano. Insomma, la magistratura collaborava con lo Stato nella lotta senza quartiere alla criminalità organizzata. Il metodo di Mori era semplicissimo nella sua efficienza: innanzitutto riaffermò in modo vigoroso l’autorità e la presenza dello Stato; coinvolse e convinse la popolazione a ribellarsi ai soprusi della mafia; d’accordo con le istituzioni, avviò una battaglia culturale contro l’omertà, il crimine, la mentalità mafiosa, soprattutto nei confronti dei giovani; colpì cosa nostra nei suoi interessi economici; fece tramontare la leggenda dell’impunità, facendo condannare a pene durissime i capomafia; fece un uso disinvolto del confino, dove mandò i maggiori capicosche. Nel 1929 Mori fu messo a riposo (era del 1871) e per molti anni la mafia dovette chinare il capo di fronte a questa Italia nuova e moderna, che frattanto aveva anche cercato di riavviare sotto il controllo militare le attività agricole e produttive della regione. In definitiva, perché Mori sconfisse la mafia? Perché il governo italiano lo appoggiò lealmente, al contrario di quanto accadde ad altri servitori dell’Italia repubblicana.
Questo è quel che si vorrebbe far credere. Ma esiste un'altra verità.
Libri: La mafia alla sbarra, I processi fascisti a Palermo, scrive “L’Ansa”. Il Volume attinge da documentazione conservata all'Archivio Stato. Indaga sulle radici della mafia, da quelle geografiche dell'hinterland palermitano, uno dei luoghi di genesi del fenomeno, a quelle storiche: è il libro "La mafia alla sbarra - I processi fascisti a Palermo" (260 pagine, 15 euro) scritto da Manoela Patti e pubblicato dalla casa editrice Istituto Poligrafico Europeo, con una prefazione dello storico Salvatore Lupo. Il lavoro si basa sull'immensa documentazione conservata all'Archivio di Stato di Palermo e scava all'interno della retorica della repressione fascista degli anni Venti, facendo anche piazza pulita della legittimazione storica basata su paradigmi e stereotipi che nella percezione comune hanno portato a credere, negli anni, a una mafia "buona" e non sanguinaria. "Il versante giudiziario dell'antimafia fascista - scrive l'autrice - ebbe esiti di gran lunga inferiori alle forze messe in campo. La portata effettiva dell'operazione Mori si rivelò meno incisiva di quanto propagandato dal regime. Eppure, l'imponente opera di propaganda fascista sfruttò l'intera popolazione per ottenere in Sicilia quel consenso che ancora nell'Isola mancava al regime". Dal "L'Inchiesta in Sicilia" del 1876 di Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino alle difese che hanno smentito l'esistenza della mafia come associazione, puntando piuttosto a definirla come "un modo di essere e di sentire". Come quella di Giuseppe Pitrè, che diede dignità scientifica al concetto di una "mafia originaria benigna, sinonimo di spavalderia e coraggio degenerata solo in alcuni individui in delinquenza". Tesi adoperata per difendere l'Isola dagli "attacchi del governo centrale ogni volta che la questione mafiosa tornava all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale". La tesi di Pitrè verrà codificata ufficialmente nel 1901 durante il processo al l'onorevole Raffaele Palizzolo, accusato di essere il mandante dell'assassinio dell'ex sindaco di Palermo e direttore del banco di Sicilia, Emanuele Notarbartolo. "Accade spesso che le dinamiche sociali si incarichino di smentire gli scienziati sociali e la storia di smentire gli storici - scrive lo storico Lupo nella prefazione - La smentita fu particolarmente bruciante nella Sicilia dell'assaggio tra gli anni 70 e 80. La mafia si palesò in tutta la sua nuova pericolosità mentre era impegnata in modernissime forme di business. Quella mafia lì non somigliava per niente a una vaga metafora". Il libro sarà presentato all'Istituto Gramsci di Palermo. A discuterne con l'autrice saranno Salvatore Lupo, professore di Storia contemporanea all'Università di Palermo, Francesco Forgione, presidente della Fondazione Federico II e Matteo Di Figlia, ricercatore di Storia contemporanea all'Università di Palermo.
I maxiprocessi ai boss al tempo del fascismo molto rumore per nulla. Il libro di Manoela Patti ricostruisce la vicenda giudiziaria del Ventennio A fronte di migliaia di arresti e indagini le condanne furono minime, scrive Amelia Crisantino su “La Repubblica”. La campagna antimafia voluta dal fascismo, inaugurata nell'ottobre 1925 con l'invio del prefetto Cesare Mori a Palermo, è ancora ben presente nella memoria collettiva. L'inedito spiegamento di forze e i modi spesso teatrali con cui il prefetto Mori condusse le operazioni comprendevano assedi di borgate e paesi, arresti di massa, processi a centinaia di imputati, l'arresto per i familiari dei latitanti, brutalità varie anche a carico dei testimoni. Il fascismo accompagnò l'aspetto militare con un'imponente opera di propaganda, mentre da più parti si tentavano analisi: per molti mesi si continuò a dibattere se la mafia fosse un fenomeno delinquenziale, una variabile etnico-antropologica o l'indesiderato prodotto di una società arretrata. Si cercava cioè di definire la natura del fenomeno mafioso, con argomenti destinati a ciclicamente ripresentarsi nei decenni a venire. Il versante più in ombra rimase quello giudiziario. Che fu spesso deludente. Le pene inflitte nei numerosi maxiprocessi che si susseguirono sino al 1932 furono minime, di gran lunga inferiori alle forze in campo. La documentazione allora prodotta permette però di osservare la storia dell'organizzazione mafiosa in una prospettiva di lungo periodo, e adesso uno studio di Manoela Patti, "La mafia alla sbarra. I processi fascisti a Palermo" (Istituto poligrafico europeo, 260 pagine, 15 euro), analizza uno spaccato territoriale e temporale seguendo le vicende di molteplici personaggi che riservano non poche sorprese. La prima impressione, a leggere queste pagine così fitte di nomi ed episodi, è di trovarsi di fronte a un reticolo i cui molteplici intrecci richiedono molta cautela. Subito dopo, mentre l'attenzione del lettore è assorbita dalla ricchezza delle fonti, arriva una sorta di sgomento di fronte ai numeri. Leggiamo che dal 1913 al 1919 a Bagheria avvengono 55 omicidi, che nel 1928 gli arrestati nella provincia di Palermo sono cinquemila, che dal 1926 al 1932 vengono giudicati settemila imputati distribuiti in 105 processi organizzati su base territoriale, che il 25 novembre 1930 si apre il processo all'associazione della borgata Santa Maria di Gesù: sono 228 detenuti presenti nella chiesa di Santa Cita usata come tribunale, con gli stucchi del Serpotta che osservano muti le grandi gabbie affollate di imputati, i 62 avvocati, i 200 testimoni a discolpa. Nella sola provincia di Palermo vengono celebrati 56 processi e la vasta documentazione su cui si sorreggono permette di ricostruire comportamenti, struttura e attività delle cosche mafiose: non solo i rapporti interni all'organizzazione, ma anche i legami con il vasto universo "non criminale" con cui interagivano. La linea scelta nei processi fu quella di condannare gli imputati per la semplice "associazione a delinquere", anche senza valutare la responsabilità per i singoli reati; ma non di rado la magistratura giudicante si mantenne su posizioni garantiste, accogliendo le richieste della difesa. E – al di là delle accuse e della posizione dei magistrati – viene in primo piano un dato di fatto, sintetizzato dal capitano dei carabinieri al giudice che stava istruendo il processo di Bagheria: "quello era un tempo in cui tutti avevano relazioni con la mafia". Il fascismo ebbe gioco facile nel puntare il dito contro l'odiosa commistione fra cosa pubblica e violenza mafiosa, che specie nei paesi era stata favorita dall'allargamento del suffragio. I processi dimostrarono gli stretti legami fra le associazioni delle borgate palermitane e i comuni dell'hinterland, con alcuni casi esemplari come Villabate a testimoniare la capacità della mafia di infiltrarsi nell'amministrazione. Fra gli affiliati alla cosca di Villabate c'erano anche i venti componenti del consiglio comunale, e molti dei nomi ritornano negli atti della Commissione antimafia del 1972, del Maxiprocesso del 1986, nell'operazione Perseo del 2008 e Senza Frontiere del 2009. La continuità sembra essere la principale caratteristica delle cosche che dominano la Conca d'oro, i casi più emblematici li ritroviamo nella borgata di Santa Maria di Gesù dove si collocano alcune delle più antiche e potenti dinastie mafiose palermitane come i Bontate e i Greco, che attraversano età liberale, fascismo ed età repubblicana mantenendo l'egemonia. I metodi con cui viene conservato il potere, le connivenze e le strategie molto ci raccontano della storia della mafia. Che per tanti versi coincide con la storia della Sicilia.
Rocco, il fascioconservatore che rifondò lo Stato italiano. Colto, amante dell'ordine e del modello tedesco, non amava i movimentisti. A colpi di diritto mise in riga il regime e i sindacati. Persino Mussolini ne aveva soggezione. E lo cacciò, scrive Francesco Perfetti su “Il Giornale”. Al momento della sua scomparsa, il 28 agosto 1935, Alfredo Rocco non aveva ancora compiuto sessant'anni essendo nato a Napoli il 9 settembre 1875 da una famiglia che Indro Montanelli avrebbe scherzosamente definito «un allevamento di cavalli di razza» alludendo al fatto che i suoi tre fratelli - Arturo, Ugo e Ferdinando - lasciarono, pur essi, un segno importante nelle scienze giuridiche. All'epoca, Alfredo Rocco, malgrado fosse ancora nel pieno delle sue energie, era praticamente uscito dalla scena pubblica ed era tornato agli studi. Mussolini lo aveva allontanato dal governo nel 1932 nel quadro di un ampio rimaneggiamento ministeriale. La notizia della sua sostituzione al ministero della Giustizia, che guidava dal 1925, gli era giunta improvvisa. La lesse sui giornali mentre si trovava a Ginevra. Si adeguò disciplinatamente e in un telegramma al duce scrisse che il provvedimento corrispondeva al «concetto giusto avvicendamento uomini governo». In realtà non si spiegò mai i motivi del suo allontanamento tanto che, interpellato da Angelo Sraffa, rispose (come riportò subito un informatore della polizia) di non rendersene conto. Quell'anno, il 1932, ricorreva il primo decennale della «rivoluzione fascista». Il regime aveva ormai superato la fase della stabilizzazione, godeva di consenso popolare e aveva realizzato molte profonde riforme istituzionali. Mussolini riteneva fosse giunto il momento di dare inizio a un nuovo “ciclo” basato sulla centralità della sua persona (non a caso riassunse la guida degli Esteri) e sulla opportunità di sostituire personalità di governo troppo forti. L'allontanamento di Rocco, che pure stimava moltissimo e nei cui confronti nutriva un senso di inferiorità, aveva un significato preciso: esprimeva la sua diffidenza per il reazionarismo ideologico-giuridico del guardasigilli. In effetti Rocco aveva disegnato un edificio la cui sostanza reazionaria era indiscutibile. Il suo nome era legato alla «trasformazione dello Stato», dalle leggi cosiddette «fascistissime» alla legge sindacale, dalla legge sulla rappresentanza politica alla codificazione penale e via dicendo. Lo spirito con il quale si era messo al lavoro era quello di creare (son parole sue) una «nuova legalità» per «rientrare nella legalità»: una legalità di stampo monarchico, oligarchico, conservatore. Molte leggi, in apparenza miranti al rafforzamento del fascismo, prefiguravano in realtà uno Stato così rigido da rendere impossibile qualsiasi tentativo, anche di parte fascista, di stravolgerne le connotazioni conservatrici. Non a caso, in alcuni ambienti fascisti, in particolare rivoluzionari e “movimentisti”, si sostenne che stava realizzando uno Stato che sarebbe piaciuto a Metternich. Rocco proveniva dal movimento nazionalista cui era giunto tardi, alla vigilia del primo conflitto mondiale, dopo marginali esperienze socialiste e radicali. Si era subito imposto come la mente più lucida e originale di quel partito. I Corradini, i Federzoni, gli uomini cioè più significativi del nazionalismo, erano approdati alla politica dalla letteratura, avevano respirato la ventata di irrazionalismo che aveva investito la cultura europea tra la fine del secolo diciannovesimo e gli albori del ventesimo, erano rimasti sedotti dalle manifestazioni vitalistiche dell'epoca. Si erano avvicinati al sindacalismo rivoluzionario, leggendolo in chiave irrazionalistica e mitologica: nello sciopero generale e nella violenza preconizzati da Sorel avevano visto dei miti capaci di catalizzare eticamente le energie delle masse. Alcuni, poi, avevano accettato la pregiudiziale antigiacobina dei nazionalisti francesi contestando il «centralismo rivoluzionario», napoleonico prima e radicale poi, ed esaltando l'autonomismo locale contro lo straripamento del potere centrale. Rocco fu sempre lontano da posizioni del genere. Guardò con sospetto la simpatia dei compagni nazionalisti per il sindacalismo rivoluzionario e si fece banditore di un assolutismo di stampo classico che privilegiava la funzione accentratrice dello Stato e si configurava come risposta del potere politico alle tendenze disgregatrici e alle forze centrifughe della società contemporanea. In un certo senso egli si preoccupò di adeguare il pensiero reazionario classico alla realtà e alle esigenze della società di massa. In questa prospettiva, per esempio, si collocava l'idea che il sindacato potesse mutarsi da strumento di eversione in fattore di disciplina sociale attraverso la sua trasformazione in figura di diritto pubblico e, quindi, sotto il controllo dello Stato. Nel corso del dibattito sull'approvazione della «legge sindacale» del 1926 egli fu esplicito: «lo Stato non può ammettere, e lo Stato fascista meno che mai, che si costituiscano Stati nello Stato. L'organizzazione dei sindacati deve essere un mezzo per disciplinare i sindacati, non un mezzo per creare organismi potenti e incontrollati che possano sovrastare lo Stato». Il nazionalismo di Rocco fu soprattutto statualismo così come il suo fascismo. Lo Stato - come organismo economico e sociale, politico e giuridico - fu al centro della sua riflessione e della sua attività di legislatore: uno Stato, come scrisse, «sovrano e superiore agli individui, ai gruppi, alle classi», uno Stato che, però, della sua sovranità avrebbe dovuto servirsi «non per fare opera di oppressione, bensì per realizzare fini superiori». Lo Stato del quale parlava Rocco non aveva nulla dello Stato totalitario. Il suo riferimento ideale erano gli Stati autoritari classici con una non celata preferenza per il modello della Germania guglielmina o, in misura minore, per un Ancien Régime che tenesse presente il fenomeno della irruzione delle masse sulla scena politica come frutto della Grande guerra. La concreta attività di legislatore di Alfredo Rocco si rifaceva a una organica e monolitica filosofia politica, a una precisa e coerente visione dello Stato e dei rapporti di questo con i cittadini. Basta leggere le relazioni che accompagnavano i disegni di legge da lui presentati in Parlamento per rendersene conto: non solo una illustrazione tecnica del provvedimento da adottare ma, prima di tutto, una sua giustificazione teorica e di filosofia politica. Un illustre giurista, Giuliano Vassalli, ha osservato che nessun altro ministro riuscì, come Rocco, tecnico di altissimo livello, a «trasformare», nel bene e nel male, lo Stato italiano: non vi era riuscito nessuno, prima di lui, nell'Italia liberale, non vi sarebbe riuscito nessun altro, dopo di lui, nel secondo decennio del fascismo e, poi, nella nuova Italia democratica e antifascista. Le polemiche sulla sopravvivenza, nell'Italia postfascista, dei codici legati al nome di Rocco, incompatibili con lo spirito dello Stato democratico, rivelano come la capacità di resistenza alle sollecitazioni di riforma di quell'impianto normativo fosse dovuta al fatto che la legislazione di Rocco era il risultato, prima ancora della tecnica giuridica, di una compatta e organica visione della società e della politica. Che tale visione, poi, non sia più in linea con la moderna sensibilità democratica è altro discorso.
DEMOCRAZIA A SINISTRA. VOTI TRUCCATI, ELEZIONI TAROCCATE.
La Sinistra: in nome della legalità. Si fanno sempre riconoscere, dovunque.
Regno Unito, primarie laburisti nel caos: "Cancellati 40mila voti taroccati". Secondo il tabloid conservatore Daily Mail, i sindacalisti avrebbero espresso la loro preferenza due volte e quindi le loro schede sarebbero state annullate. Crescono le polemiche sulla regolarità della consultazione. Un sondaggio: il favorito Corbyn avrebbe il consenso solo del 22 per cento dei britannici, scrive “La Repubblica” il 26 agosto 2015. Le primarie del Labour nella bufera in Gran Bretagna. Le polemiche sui sospetti di voto "taroccato" si fanno sempre più violente. Il partito sta votando per scegliere il neosegretario laburista e - secondo il quotidiano conservatore Daily Mail - oltre 40.000 voti di sindacalisti sono stati cancellati, dai 190.000 già depositati, perchè si è scoperto che i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso la loro preferenza due volte: in quanto membri del sindacato (trade union) e come iscritti al partito laburista. Un risultato, scrive il tabloid, che solleva dubbi soprattutto sugli effettivi consensi di Jeremy Corbyn, il favorito e più a sinistra tra tutti i possibili successori del disastroso Ed Miliband. Sospetti di irregolarità erano già emersi quando all'inizio del mese il Labour aveva sostenuto che erano 610.753 gli aventi diritto al voto. Solo ieri tale cifra è stata ridotta a 553.954 dopo che sono state scoperte duplicazioni nelle richieste di voto, infiltrati di altri partiti (400 conservatori e 1.900 verdi) e richiedenti non iscritti alle liste elettorali. Corbyn in un intervento ha definito come "senza senso" le polemiche relative ai presunti conservatori 'infiltrati' che si sarebbero iscritti per votare il candidato socialista di vecchia data e penalizzare il partito (questa l'accusa che gli viene mossa dai suoi avversari).
Voti taroccati, la sinistra ha sempre ragione. In Puglia errori nelle preferenze di Vendola, ma il Tar rigetta il ricorso dello sconfitto Raffaele Fitto, scrive “Il Tempo”. E nell'ufficio legale di Fitto circola aria di ottimismo: «Siamo fiduciosi sull'esito della decisione del Consiglio di Stato che ci consentirà di accedere agli atti in questione», afferma il legale. Ma che cosa c'è da scoprire in quelle 84mila schede nulle che l'ex presidente pugliese e i suoi avvocati vogliono controllare? Nel ricorso elettorale, che il Tar Puglia ha rigettato, si parlava di «conclusioni errate» e «immediata discordanza dei dati comunicati dai rappresentanti di lista rispetto a quelli di proclamazione». Leggendo i verbali elettorali, i legali si sono trovati di fronte a «diverse tipologie di errori che spaziano da meri errori di calcolo fino a giungere a errori palesemente a favore del candidato Vendola». Tutti da dimostrare. L'attuale presidente pugliese ha dato mandato agli avvocati della Regione di tutelarlo in tutte le sedi, prima volta che accade in Italia dove gli enti amministrativi, quindi anche le Regioni, sono da considerare super partes. Il ricorso dell'ex governatore punta l'indice contro «la scarsissima preparazione dei componenti i seggi elettorali, in altri una assoluta certezza, da parte dei componenti il seggio stesso, di mancanza di controlli degli organi preposti, ed in altri una ben più grave manipolazione dei voti per raggiungere l'obiettivo di far vincere il candidato del centrosinistra». Affermazioni che, per stessa ammissione di chi firma il ricorso al Tar, «può lasciare sconcertati». Centododici pagine, poche quelle che hanno mandato Fitto su tutte le furie. che si parla senza mezzi termini di errori. Si legge: «Dal controllo dei verbali si sono riscontrati nella Regione Puglia 2.312.996 voti validi contro i 2.310.536 voti validi riscontrati dalla Corte d'Appello in sede di proclamazione con una differenza di 2.560 voti in meno rilevati dalla Corte rispetto ai verbali dei Comuni». E via con le «denunce», come quella dell'«impossibilità di verificare i dati e 68». «In centinaia di sezioni è praticamente impossibile, a causa delle numerosissime correzioni effettuate sui numeri e sui totali, effettuare qualsiasi tipo di verifica corretta». È il caso per esempio del verbale della sezione 14 di Martina Franca dove, si legge nel ricorso, il numero dei voti a favore di Vendola da 290 è stato corretto in 330. Più o meno lo stesso è accaduto nelle sezioni 1 e 2 di Zapponata, la sezione 28 di Brindisi, e la sezione 2 di Parabita. La parola adesso passa al Consiglio di Stato.
Liguria, primarie alla Paita. Ma Cofferati denuncia brogli. L’ex sindacalista: “Ai seggi cose gravissime, non accetto l’esito”. Polemica sugli immigrati: “Voto inquinato da cinesi e marocchini”, scrive Jacopo Iacoboni su “La Stampa”. Secondo le regole delle primarie Pd gli stranieri possono votare, purché regolarmente residenti in Liguria, e con permesso di soggiorno e carta d’identità: ma che pensare se gli stranieri al voto in alcuni seggi della Liguria, ieri, arrivavano a gruppi di dieci persone? «Società civile» o truppe cammellate? In Liguria bisognerà stabilirlo. La cosa si potrebbe trasformare nella più clamorosa rissa politica mai vista nella storia della primarie del Pd, anche perché alle dieci e mezzo di sera i due reali sfidanti - Raffaella Paita, la candidata sponsorizzata da Burlando, neorenziana, e Sergio Cofferati - erano molto vicini, con lei che si dichiara vincitrice, per pochi voti, tremila, su 50mila votanti: «Sarà un lavoro enorme - sono le prime parole di Paita a tarda sera - saranno anni rock, lavorerò per l’unità del Pd». L’unità però pare lontana (forse più del rock). Cofferati ci anticipa: «Ho chiesto un pronunciamento alla Commissione nazionale di garanzia. Fino a che non ci sarà, non accetterò nessun esito. Sono successe cose gravissime. Non solo i cinesi ai seggi a La Spezia, tra l’altro in un seggio dove la signora Paita si è intrattenuta due ore in coda per dire chi votare... Che idiozia, oltretutto». Insomma, un malcontento e polemiche che il Pd dovrà a questo punto gestire a Roma, cioè un’altra enorme grana per Renzi, la sensazione di un voto alterato. Al seggio di Bolzaneto c’erano dei rom in coda per votare, e hanno votato. Piu tardi è venuto fuori che a La Spezia ci sono stati gruppi non piccoli di cinesi in almeno due seggi. Ci sono posti troppo «bulgari», sospetti: ad Albenga su 1500 voti Paita ne ha presi 1300, e Cofferati appena 200. A Pietra Ligure 750 voti lei e solo 50 lui. La denuncia di Cofferati era arrivata per tempo: «Mi hanno segnalato numerosissimi casi di violazione delle regole», comunicava in tarda mattinata, dopo aver votato nel seggio di Palazzo Ducale, camicia aperta, senza cravatta, in una tiepida giornata genovese. «L’inquinamento è molto pesante, per i voti della destra, o con il voto organizzato di intere etnie, oltre ai cinesi alla Spezia, i marocchini a Imperia», raccontava l’uomo che in un’altra vita fu la speranza della sinistra italiana, e al quale si sono aggrappati a Genova - anche obtorto collo - un po’ tutti quelli stufi del sistema-Burlando. Storie così non sono inedite nel Pd: successe coi cinesi a Napoli nelle primarie vinte da Cozzolino e poi annullate (non perché votarono i cinesi, ma per le tantissime schede contestate); successe a Roma nel 2013, la dirigente Pd Cristiana Alicata denunciò: «Ho visto gruppi di rom accampati in fila ai seggi», in zona Magliana-Portuense, vicino al campo nomadi di via Candoni (dove, si scoprirà poi, Buzzi era impegnatissimo, a modo suo, nel «sociale»). Paita sui cinesi risponde così: «Non so se sia vero, ma non ci vedo niente di male. Io sono per l’integrazione, trovo normale che anche comunità di stranieri partecipino alle nostre votazioni. Mi stupisco che un uomo che si dice di sinistra come Cofferati non la pensi così». A un certo punto ieri alle sei la candidata è stata fatta uscire dal seggio Allende, a La Spezia, perché è vietato per i candidati intrattenersi dentro il seggio. Proprio lì, dopo, è arrivata una cinese che non sapeva come votare, e subito l’hanno instradata alcuni suoi connazionali.
Primarie Pd, i risultati definitivi. La denuncia di Vaccaro: «Sono state truccate come sempre», scrive “Il Mattino”. Le polemiche non si placano. «Sono state primarie truccate come sempre». La denuncia viene da Guglielmo Vaccaro, deputato del Pd autosospesosi in polemica con il partito che ha dato il via libera alla celebrazione delle primarie in Campania e acerrimo oppositore di Vincenzo De Luca. Intervistato da Radio 24, dove è intervenuto alla trasmissione 'La Zanzara', Vaccaro ha tirato in ballo il vincitore delle primarie campane. «I brogli - ha detto - non li ha fatti De Luca in prima persona, ma dei professori di brogliologia che appartengono alla sua area, uomini suoi sì. A Salerno e provincia hanno votato frotte di persone che sono semplicemente registrate nei seggi nel migliore dei casi, ma non ci sono mai passate. E infatti ancora una volta Salerno si afferma come capitale della partecipazione democratica». Cosa sia successo Vaccaro lo spiega così: «Orologio alla mano - ha detto - se un seggio è aperto 12 ore, in tutto fanno 720 minuti. Se poi si dichiara che sono passati più di mille elettori c'è qualcosa che non quadra, perché doveva esserci una fila perenne per 12 ore senza mai sosta con persone che votano al ritmo di 35 - 40 secondi l'uno. Ci sono stati finti elettori, questo è chiaro. Piovono i ricorsi, ma non andranno lontano perché non troveranno nemmeno le schede. In Campania per fare un broglio cambiano direttamente i verbali, mica usano le schede finte. Col piffero che tutti siamo con De Luca», dice Vaccaro che si rivolge al segretario del suo partito Matteo Renzi. «Saviano - dice Vaccaro - aveva assolutamente ragione. Renzi deve commissariare il partito e indicare un nuovo candidato. Se non lo fa me ne vado dal Pd e poi quando ci sarà il fallimento vado via dall'Italia. Ma non voglio pensare che il segretario e presidente del Consiglio presenti un candidato condannato quando non più di un anno fa abbiamo chiesto a un ministro, la Idem, di dimettersi per una multa non pagata. Renzi ci dica se vuole portare il partito su questa nuova direzione, ma non è più il mio partito. C'è da vergognarsi, perché abbiamo una condanna e bisogna rispettare gli esiti di un processo. Che vogliono fare, una legge ad personam per De Luca? Abbiamo chiesto per anni a persone con avvisi di garanzia di allontanarsi dalla vita pubblica e cosa facciamo adesso nella regione principale del Mezzogiorno dove padroneggiano i poteri criminali? Candidiamo un condannato? Ma questa è una cosa vergognosa».
Sondaggio choc: per chi vota Pd truccare le primarie è normale. Secondo una ricerca di Euromedia il 74% degli elettori democratici e di Sel non condanna le tessere false: nei partiti può accadere e i media esagerano, scrive Andrea Cuomo su “Il Giornale”. La Tesseropoli del Pd? Cose che capitano in un grande partito, roba a cui non dare troppa importanza. Peccato che a pensarla così siano gli stessi elettori del primo partito del centrosinistra, i soli a minimizzare il fatto che gli iscritti del Pd siano cresciuti in modo anomalo, che in alcune province folle di albanesi e senegalesi abbiano scoperto un'improvvisa voglia di partecipazione politica. Uno scandalo, o almeno una pessima figura, che ha costretto i vertici del Pd a sospendere il tesseramento e che getta un'ombra lunga su un partito che conferma il suo grande talento nel non azzeccarne una: dapprima ha impallinato con il fuoco amico il candidato premier Pier Luigi Bersani, poi è riuscito a perdere le elezioni di febbraio pur essendo arrivato primo, ora deve vedersela con un calo nei sondaggi e con il probabile flop delle primarie del prossimo 8 dicembre. Intanto, il sondaggio compiuto nei giorni scorsi da Euromedia Research per la trasmissione di Raidue Virus. Il contagio delle idee di Nicola Porro racconta un'Italia divisa in due. Da un lato c'è il popolo democratico che non trova nulla di scandaloso nel tesseramento allegro che potrebbe rendere una farsa le primarie del prossimo 8 dicembre; e dall'altro ci sono gli elettori degli altri partiti che invece trovano questa vicenda assai squallida. Richiesti di dare un parere sul caos iscrizioni al Pd, il 45,7 per cento degli italiani definiscono la vicenda «il solito autogoal del Pd», in grado di «delegittimare il vincitore delle primarie»; il 21,0 per cento trova tutto normale, un piccolo incidente di percorso inevitabile nell'organizzazione di un evento come le primarie di un grande partito; il 16,0 pensa poi che si tratti di un'esagerazione dei mass media, magari orchestrata; infine il 17,3 non esprime un parere. I risultati però cambiano molto stratificando il campione per orientamento politico. Gli elettori del Pd (e di Sel) sono gli unici a non esprimersi a maggioranza per la condanna del pasticcio: il 41,8 per cento degli elettori di centrosinistra pensa che siano cose che succedono, il 32,0 dà la colpa ai mass media e solo il 24,2 per cento di essi guarda con preoccupazione alla vicenda. Peraltro gli elettori del centrosinistra sembrano avere anche le idee più chiare degli altri: solo il 2,0 per cento di essi non si è fatto un'idea sulla vicenda. Gli elettori del centrodestra sono invece quelli più severi con il Nazareno: il 72,4 per cento di essi accusa il Pd, mentre solo il 3,5 giustifica il pasticcio e il 2,8 ipotizza un solo mediatico. Tra i grillini la percentuale dei colpevolisti scende ma resta elevata: il 60,2 per cento, mentre il 12,3 è composto da «giustificazionisti» e il 5,1 di «esagerazionisti». Anche tra i leghisti c'è poca comprensione per i travagli interni dei democratici: il 58,5 per cento vede il Pd infangato dalla Tesseropoli, mentre il 12,5 è incline alla comprensione e l'8,5 sospetta un complotto mediatico. Tra gli elettori di Scelta Civica scendono i critici (46,5) e salgono i fatalisti (21,5) e i complottisti (14,2). Quanto agli indecisi, rispecchiano più o meno le risposte del campione totale: il 40,9 crocifigge il Pd, il 19,1 minimizza, il 17,1 parla di fango mediatico e il 22,9 si manifesta indeciso una volta di più. Alla fine sono gli elettori della lista Ingroia i meno severi con il Pd: il 39,0 per cento parla di autogol dell'ex Pci, il 33,5 di qualche stortura fisiologica e il 22,0 di un attacco della stampa. Ma in questo caso la vera notizia è che gli evidentemente bravissimi ricercatori di Euromedia Research siano riusciti a trovare qualcuno che lo scorso febbraio ha votato per Rivoluzione civile e non ha alcuna difficoltà ad ammetterlo.
Dal Piemonte alla Sicilia: tessere false e primarie truccate. Segnalazioni di irregolarità in tutta Italia dove si è votato per i segretari locali. Migliaia di nuovi iscritti fantasma che hanno sconvolto gli stessi militanti del Pd, scrive Stefano Filippi su “Il Giornale”. Il nuovo che avanza nel Pd è fatto di una guerra delle tessere. Non si parla ancora apertamente di brogli, perché le verifiche (tutte avviate dopo denunce interne al partito) sono appena scattate. Da ogni parte d'Italia piovono segnalazioni di irregolarità nelle sezioni dove domenica sono stati eletti i segretari di circolo e provinciali in vista delle primarie nazionali dell'8 dicembre. Erano ammessi anche i non iscritti, a patto che prendessero la tessera al prezzo politico di 15 euro. Per miracolo si sono materializzate montagne di tessere last minute finite in tasca a migliaia di persone improvvisamente folgorate dalla passione politica. Quasi ovunque i risultati hanno premiato i candidati renziani. Alcuni, come Pippo Civati, antagonista di Renzi, denunciavano da tempo il sistema del «tesseramento a pacchi». «Si è presentata gente ignara di tutto - hanno raccontato vari militanti torinesi - non sapevano nemmeno chi e come votare». Il senatore Stefano Esposito attacca Salvatore Gallo, ex socialista, ex Margherita, ora Pd renziano: «È dal 1972 che fa politica così». Nel circolo di Venaria Reale a un certo punto sono finite le tessere in bianco destinate ai nuovi. Che si fa? Racconta un iscritto che l'assessore Vincenzo Russo è andato in auto ed è tornato con un pacco di tessere candide. Peccato che gli unici a disporne dovrebbero essere il segretario o il tesoriere. A urne chiuse saranno 130 i nuovi iscritti. Il campionario di irregolarità è vastissimo. A Catania è stato azzerato il congresso provinciale per il numero esorbitante di tessere fantasma. Giorni fa Valentina Spata, coordinatrice siciliana del gruppo di Pippo Civati, aveva denunciato che «un ex segretario di partito di Giarre e una ragazzina di 14 anni si sono trovati iscritti senza saperlo. Migliaia di tessere sono state distribuite fuori dai circoli, l'unica sede dove si può aderire al partito». Congresso sospeso anche a Desiana, nel Vercellese, quando si è scoperto che la lista a sostegno di uno dei due candidati alla segreteria provinciale era composta da persone mai iscritte al partito. A Lecce, provincia-feudo di Massimo D'Alema, circolano 15mila tessere a fronte di poco più di 4mila iscritti. La commissione provinciale di garanzia ha chiesto invano alla commissione regionale di sospendere il congresso: si farà un semplice «monitoraggio» sul rapporto tra numero di tessere e denaro versato dagli iscritti. Gli episodi sono innumerevoli. Roma, circolo di Trastevere: il segretario Alberto Bitonti ha scritto su Facebook una lettera aperta a Renzi puntando il dito contro «l'infiltrazione di logiche clientelari». Domenica i «nuovi» si presentavano a gruppi cammellati, e ci sono stati momenti di tensione con gli «iscritti reali», come li chiama Bitonti. Milano, corsa per la segreteria provinciale: David Gentili, escluso dal ballottaggio, ha denunciato il fenomeno delle «tessere a saldo» e chiesto che la commissione per il congresso renda noti i dati del tesseramento. Nel 2012 in provincia di Milano si contavano 10.500 iscritti, lo scorso settembre si stimava fossero dimezzati mentre ora sarebbero balzati a 7mila. Napoli, congresso provinciale. I deputati Pd Luisa Bossa e Massimiliano Manfredi hanno denunciato che a Soccavo il voto è stato anticipato di un giorno senza preavviso e a Portici «esponenti di spicco del partito stanno intervenendo in modo eccessivamente pressante sulle operazioni. Piccoli ras di provincia che fanno i picchetti, tesseramenti che si gonfiano all'improvviso, voto controllato, gruppi di potere che si spostano su interessi personali. Questo Pd non smette mai di deluderci». Parola di parlamentari Pd.
C’è chi lo fa in modo sfacciato e chi, invece, usa metodi più sofisticati e moderni, ma il mercato della compravendita dei voti è più fiorente che mai. A proposito di sfacciati, in Sardegna ancora ricordano quel signore che alle ultime elezioni regionali si presentò dalla candidata Michela Murgia con un cesto. Non conteneva frutta, ma un migliaio di certificati elettorali. Poche parole: “Siamo elettori di G.O. , e siamo delusi…Se lei riesce a convincerci…”. Quei voti sono a sua disposizione. Discorso allusivo, non esplicito fino in fondo, ma chiaro. La scrittrice, ovviamente, rifiutò sdegnata. E quel cesto fece il giro di altri candidati. “Queste sono guapperie inutili, smargiassate che non servono e rovinano la piazza. Il lavoro va fatto in silenzio…”. Il signore che accetta di parlarci lo abbiamo incontrato in una città del Sud, la condizione è ferrea: nessun riferimento né a luoghi, meno che mai a nomi. Inizia il nostro viaggio dentro i meandri del discount della preferenza. “La situazione non è più come una volta, al tempo bello delle schede lenzuolo e delle preferenze espresse a numero”. Prima Repubblica, lotta feroce all’ultimo voto tra partiti e dentro i partiti. “Il meccanismo era semplice, metti un collegio dove si esprimevano tre preferenze. All’epoca ero un giovane galoppino, non c’erano i computer ma le calcolatrici tascabili. Il capo aveva gli elenchi degli elettori seggio per seggio, li comprava dagli impiegati al Comune e valevano oro, soprattutto nelle sezioni elettorali più piccole. Era un gioco semplicissimo, in una lista con trenta candidati avevi una possibilità quasi infinita di combinazioni da assegnare. Mettiamo che portavi il numero 1, indicavi a Tizio il voto 1 e 2, a Caio 1 e 30, a Sempronio 1 e 27, e così via, invertendo i numeri assegnati. A chiusura dello spoglio, tu sapevi esattamente come aveva votato l’elettore, se ti aveva tradito. Con la preferenza unica e poi con i deputati nominati, tutto si è fatto più difficile”. Però il controllo del voto funziona ancora, con i cellulari e le schede fotografate. “Roba da dilettanti…”. Oppure con la “scheda ballerina”. In sintesi, fuori dal seggio c’è un rappresentante del “sistema” che consegna una scheda già votata, l’elettore la ripone nell’urna, si infila in tasca la scheda vergine che gli scrutatori gli hanno dato, va fuori e la consegna all’addetto di cui sopra. Metodo efficace, “ma si finisce in galera”, chiarisce il nostro uomo. E allora? “Allora bisogna essere scientifici, sapere qual è il bacino cui attingere. La campagna elettorale per le europee è stata feroce ed è difficile smuovere chi ha già deciso per Grillo o per il Pd o per Berlusconi, io devo rivolgermi a chi non vota, agli astenuti, a quelli che non hanno alcuna ragione per infilare una scheda nell’urna, a chi è schifato dalla politica che non gli offre più un motivo per votare. Io gliene offro uno e concreto assai: i soldi”. Quanti? Quanto costa una preferenza per le europee? “Da un minimo di venti a un massimo di cinquanta euro. Non è poco, mi creda”. Ma come si fa? Con collegi così ampi ci vogliono decine di migliaia di voti. Faccio qualche esempio: alle ultime europee un candidato outsider come Sonia Alfano ha rastrellato 28mila preferenze, un padrone dei voti nel Sud, il calabrese Mario Pirillo, Pd, ne ha portati a casa 110451, quanti soldi deve spendere un candidato? “Tanti, ma non compra tutti i voti da noi, nei collegi ampi ti puoi giocare l’elezione per poche migliaia di voti, noi puntiamo a quelli, offriamo l’ultimo litro di benzina che serve a fare il pieno e stare sicuri”. Il candidato paga, 50 o 100mila euro, e voi, l’organizzazione, cosa ricevete in cambio? “Non soldi, a quelli puntano i pezzenti del mestiere, ma relazioni. Farsi amico un deputato europeo che ti è grato per l’elezione, significa entrare nel gioco dei contributi, soprattutto nel Sud. Da lui puoi portare l’imprenditore che vuole investire, il sindaco alla ricerca di un sostegno per sbloccare una pratica. Insomma, le relazioni sono oro”. Sì, ma come si fa ad essere certi della fedeltà del lettore…E qui ritorna il meccanismo delle vecchie preferenze negli anni d’oro della Prima Repubblica. “Sulla scheda puoi scrivere tre nomi, due maschi e una donna o viceversa. Puoi indicare solo il cognome o il nome e il cognome, quindi li puoi invertire, prima il cognome poi il nome di battesimo. Su 17 candidati, penso alla circoscrizione Sud, puoi mettere insieme una infinità di combinazioni. E’ complicato, ma oggi ci sono i computer, basta avere gli elenchi degli elettori e il gioco è fatto”. Il mercato? “Quello dei piccoli partiti, quelli che devono superare ad ogni costo lo sbarramento, e i candidati che vengono da regioni piccole. Pensate a uno del Molise che deve raccogliere voti in metropoli tipo Napoli, in città lontane dalla sua realtà come Reggio Calabria. Per loro è una corsa difficile. Ma per fortuna ci siamo noi”. (pubblicato su Il Fatto Quotidiano del 25 maggio 2014).
Da che parte sta la ragione?
E Mussolini rimproverò l'ingegner Romeo, scrive Dario Vico su “Il Corriere della Sera”. Nasce l'Archivio della Fondazione Iri, per una storia inedita d'Italia. Il capo del fascismo non voleva che per l'Alfa si usassero strumentazioni costruite all'estero. Una lettera datata 9 giugno 1926 in cui il capo del governo, Benito Mussolini, si rivolge in modo perentorio all' ingegner Nicola Romeo per chiedergli come mai nella sua Alfa tutta la strumentazione di bordo sia straniera. «Pregiatissimo ing. Romeo, ieri tornando da Firenze ho guardato con attenzione gli strumenti della mia Alfa (che va, del resto, molto bene) e ho fatto le seguenti constatazioni: I magneti sono tedeschi (Bosch), l'orologio è svizzero, la tromba (che non funziona) è francese. È così che si aiutano i prodotti nazionali? Non si fanno, dunque, in Italia magneti, orologi e trombe?». Un' altra nota scritta dallo stesso Mussolini il 29 settembre 1934 al ministro delle Finanze Jung in cui, in maniera altrettanto drastica, gli comunica di essere contrario alla vendita agli Agnelli da parte dell'Iri di azioni Edison o Ilva. «È mia convinzione - scrive il Duce - che invece di gonfiare, parrebbe meglio deflazionare il complesso Agnelli, che va dalle auto ai cantieri, dal giornalismo agli alberghi di montagna». La lettera a Romeo e la nota per il ministro Jung sono solo due degli 800 mila dossier che l'Iri ha deciso di mettere a disposizione degli studiosi organizzando un vero Archivio storico. Gli accademici potranno così approfondire i complessi rapporti che si stabilirono tra il regime fascista e l'establishment industriale, quello che il professor Valerio Castronovo definisce «un matrimonio di convenienza» tra un Mussolini non privo di «animosità anticapitalistica, derivantegli anche dalla sua matrice di socialista rivoluzionario» e un milieu finanziario «che cerca di evitare le ingerenze del governo» e finisce per ricoprire un ruolo di fronda. Mussolini non cercò di tagliare le unghie solo alla Fiat che mirava ad acquisire le compagnie telefoniche, «ma anche alla Edison che coltivava lo stesso obiettivo, alle Generali che avevano messo gli occhi sui cantieri navali di Trieste e alla Snia Viscosa che voleva annettersi la Châtillon». La consultazione dell'Archivio Iri sarà cruciale per ricostruire le relazioni tra regime e borghesia capitalistica, ma non solo. Dalle carte dell'istituto di via Veneto gli storici potranno trovare nuova materia prima per analizzare in maniera più compiuta le vicende della ricostruzione postbellica, il piano Marshall, l'ingresso dell'Italia nel Fondo monetario internazionale fino alle politiche del miracolo economico e all' istituzione delle Partecipazioni Statali. Insomma da Mussolini ad Amintore Fanfani ed oltre.
Commemorazione di De Gasperi. 19 agosto 1954 anniversario della morte di Alcide De Gasperi scritta da Francesco Martini. La maggior parte dei lettori di questo giornale sono nati dopo la fine della guerra e non hanno conosciuto De Gasperi. Questi è stato un grande statista di dopo la fine della guerra, una guerra maledetta, una guerra fascista che naturalmente avevamo perso ed eravamo una nazione semidistrutta che aveva bisogno di tutto. Una nazione piena di miseria e disoccupazione, stretta tra due movimenti politici incomunicabili: da un lato il Partito Comunista Italiano che scimmiottava l’Unione Sovietica e voleva instaurare anche da noi il sistema russo; dall’altra gli americani che, vincitori e ricchi, avevano in mano il governo della nazione e manifestavano ad ogni momento la loro avversione per il regime rosso: con una semplice firma avrebbero potuto fare dell’Italia una colonia statunitense e nominare un commissario per amministrarla. In mezzo De Gasperi e la sua immensa capacità di mediare; ma le risorse erano poche. Lui riuscì ad ottenere aiuti alimentari (piano Marshall e piano ERP) e nel gennaio del 1947, recatosi in America, riuscì a strappare un finanziamento di 100 milioni di dollari. Era un democristiano e perciò oggetto di ogni infamia da parte dei comunisti; anche i socialisti parteciparono, ma meno. Qualcuno è ancora portatore di questo odio: chi scrive ne ha avuto una esperienza recentissima: un paio di anni fa proposi al direttore di una rivista alla quale collaboravo di effettuare il 19 agosto una piccola commemorazione di questo statista; ebbene quel direttore, comunista dichiarato, manifestò tutta la sua contrarietà intimandomi di non farlo. E’ da allora ed è per ciò che ho smesso di collaborare a quella rivista ed ho creato questo giornale: così posso scrivere quello che voglio sui vari De Gasperi e su persone come quel direttore. In gioventù anch’io ho combattuto De Gasperi, ma sbagliavo. Questo è stato un uomo equilibrato, capace ed equanime: essendo segretario del partito italiano dei cattolici ed avendo trascorso tutto il periodo della guerra a fare l’archivista in Vaticano, quando nel 1952 venne invitato dal Papa Pio XII ad appoggiare una coalizione tra Democrazia Cristiana, Movimento Sociale Italiano (il partito neofascista) e Partito Nazionale Monarchico (che sosteneva il Savoia) per l’elezione amministrativa del Comune di Roma (“ la sede della cristianità non può essere amministrata dai comunisti….”) ebbene De Gasperi, che aveva sofferto nelle carceri fasciste, disse di no. Disse “proprio a me, un povero cattolico della Valsugana, è toccato dire no al Papa….” Una lunga vita, iniziata 134 anni fa in un paesino della Valsugana allora sotto il dominio austriaco, da un padre che faceva il Maresciallo della gendarmeria imperiale, nel 1881. Amò la sua terra, il Trentino, e giovanissimo venne eletto deputato dei trentini al Parlamento di Vienna. Non partecipò alla prima guerra mondiale perché era già avanti con l’età; combattè Mussolini ed il fascismo e patì le loro galere. Fu di una onestà assoluta e manifestò sempre una gigantesca capacità politica. L’unico motivo di dispiacere: che di uomini così non ce ne siano molti.
"La politica non è forse quella che siamo stati abituati a vedere oggi, vale a dire un puzzle di ambizioni personali all'interno di un piccolo harem di cooptati e di furbi. La politica è ben altro, ma per comprenderlo è inutile prodursi in interminabili analisi sociologiche o in lamentazioni, quando è possibile guardare a esempi come quello degasperiano". Lo scrive il segretario generale della Cei, Monsignor Nunzio Galantino nella sua Lectio degasperiana. Galantino ha consegnato il testo non partecipando all'incontro previsto a Pieve Tesino (Trento). "I veri politici - continua il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, prendendo ad esempio la politica di De Gasperi - segnano la storia ed è con la storia che vanno giudicati, perchè solo da quella prospettiva che non è mai comoda, si possono percepire grandezze e miserie dell'umanità". Il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Nunzio Galantino, resta al centro delle polemiche. Per cercare di evitarle decide di non andare a Pieve Tesino, Trento, il 18 agosto 2015 dove doveva tenere una Lectio sull'eredità degasperiana. E rinuncia a intervenire alla commemorazione di De Gasperi. Monsignor Galantino scrive che la politica di De Gasperi "non è quella che siamo stati abituati a vedere oggi, vale a dire un puzzle di ambizioni personali all'interno di un piccolo harem di cooptati e di furbi", "il popolo da solo sbanda e i populismi sono un crimine di lesa maestà di pochi capi spregiudicati nei confronti di un popolo che freme e che chiede di essere portato a comprendere meglio la complessità dei passaggi della storia".
Perchè leggere Antonio Giangrande?
Ultimo atto. Esame di Avvocato 2015. A Lecce uno su quattro ce l’ha fatta. Sono partiti in 1.108: la prova scritta è stata passata da 275 praticanti. Preso atto.....
All'attenzione dell'avv. Francesco De Jaco. Illustre avv. Francesco De Jaco, in qualità di Presidente della Commissione di Esame di Avvocato 2014-2015, chi le scrive è il dr Antonio Giangrande. E’ quel signore, attempato per i suoi 52 anni e ormai fuori luogo in mezzo ai giovani candidati, che in sede di esame le chiese, inopinatamente ed invano, Tutela. Tutela, non raccomandazione. Così come nel 2002 fu fatto inutilmente con l’avv. Luigi Rella, presidente di commissione e degli avvocati di Lecce. Tutela perché quel signore il suo futuro lo ha sprecato nel suo passato. Ostinatamente nel voler diventare avvocato ha perso le migliori occasioni che la vita possa dare. Aspettava come tutti che una abilitazione, alla mediocrità come è l’esame forense truccato, potesse, prima o poi, premiare anche lui. Pecori e porci sì, lui no! Quel signore ha aspettato ben 17 anni per, finalmente, dire basta. Gridare allo scandalo per un esame di Stato irregolare non si può. Gridare al complotto contro la persona…e chi gli crede. Eppure a Lecce c’è qualcuno che dice: “quello lì, l’avvocato non lo deve fare”. Qualcuno che da 17 anni, infastidito dal mio legittimo operato anche contro i magistrati, ha i tentacoli tanto lunghi da arrivare ovunque per potermi nuocere. Chi afferma ciò è colui il quale dimostra con i fatti nei suoi libri, ciò che, agli ignoranti o a chi è in mala fede, pare frutto di mitomania o pazzia. Guardi, la sua presidenza, in sede di scritto, è stata la migliore tra le 17 da me conosciute. Purtroppo, però, in quel di Brescia quel che si temeva si è confermato. Brescia, dove, addirittura, l’ex Ministro Mariastella Gelmini chiese scampo, rifugiandosi a Reggio Calabria per poter diventare avvocato. Il mio risultato delle prove fa sì che chiuda la fase della mia vita di aspirazione forense in bruttezza. 18, 18, 20. Mai risultato fu più nefasto e, credo, immeritato e punitivo. Sicuro, però, che tale giudizio non è solo farina del sacco della Commissione di esame di Brescia. Lo zampino di qualche leccese c’è! Avvocato… o magistrato… o entrambi…: chissà? Non la tedio oltre. Ho tentato di trovare Tutela, non l’ho trovata. Forse chiedevo troppo. Marcire in carcere da innocente o pagare fio in termini professionali, credo che convenga la seconda ipotesi. Questo è quel che pago nel mettermi contro i poteri forti istituzionali, che io chiamo mafiosi. Avvocato, grazie per il tempo che mi ha dedicato. Le tolgo il disturbo e, nel caso l’importasse, non si meravigli, se, in occasione di incontri pubblici, se e quando ci saranno, la priverò del mio saluto. Con ossequi.
Avetrana lì 26 giugno 2015. Dr Antonio Giangrande, scrittore per necessità.
LE RITORSIONI DEI MAGISTRATI. Con procedimento n. 1833/13 il PM di Potenza d.ssa Daniela Pannone, chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio da parte della d.ssa Rosa Larocca per il processo tenuto dal dr Lucio Setola, ex PM.
Imputato: Antonio Giangrande, nato ad Avetrana (Ta) il 02.06.1963 ed ivi elettivamente domiciliato, ex art. 161 c.p.p., alla via Manzoni, 41.
Persona Offesa: Rita Romano, nata a Roma il 30.05.1967, magistrato in servizio presso il Tribunale di Taranto.
A) Reato previsto e punito dall’art. 595 comma 3 codice penale (diffamazione) perché, nella qualità di imputato nel procedimento n° 8486/08 RGNR e n° 5089/05 r.g.n.r, nell’atto di avocazione delle indagini indirizzato al Procuratore Generale di Taranto – depositata in data 27/01/2011 presso la Sezione Distaccata di Manduria del Tribunale di Taranto – offendeva la reputazione della dott.ssa Rita Romano, magistrato in servizio presso il Tribunale di Taranto, scrivendo che il predetto magistrato “abusando dell’ufficio adottava atti con intento persecutorio, lesivi degli interessi, dell’immagine e della sua persona, motivati da pregiudizio ed inimicizia e non sostenute da prove” e che “nei procedimenti che riguardavano direttamente o indirettamente il Giangrande Antonio, quando questi esercitava la professione forense, essa ha condannato quando le prove erano evidenti riguardo l’innocenza; ha assolto quando le prove erano evidenti sulla colpevolezza”. In Manduria (TA) il 27/01/2011 – competenza dell’A.G. di Potenza ex art. 11 c.p.p.
B) Reato previsto e punito dall’art. 368 Codice penale (calunnia) perché, nella qualità di imputato nel procedimento n° 8486/08 RGNR e n° 5089 RGNR, nell’atto di avocazione delle indagini indirizzato al Procuratore Generale di Taranto - depositato in data 27/01/2011 presso la Sezione Distaccata di Manduria del Tribunale di Taranto – autorità che ha l’obbligo di riferirne, pur sapendola innocente, accusava la dott.ssa Rita Romano, magistrato in servizio presso il Tribunale di Taranto, del reato di abuso d’ufficio, di falso in atto pubblico. In particolare, accusava il predetto magistrato utilizzando le seguenti frasi: “abusando dell’ufficio adottava atti con intento persecutorio, lesivi degli interessi, dell’immagine e della sua persona, motivati da pregiudizio ed inimicizia e non sostenute da prove” e “nei procedimenti che riguardavano direttamente o indirettamente il Giangrande Antonio, quando questi esercitava la professione forense, essa ha adottato quando le prove erano evidenti riguardo l’innocenza; ha assolto quando le prove erano evidenti sulla colpevolezza”. In Manduria (TA) il 27/01/2011 – competenza dell’A.G. di Potenza ex art. 11 c.p.p.
Il procedimento penale su denuncia di Rita Romano. Denuncia per calunnia e diffamazione, questa è l’accusa che mi si oppone. Calunnia per aver presentato in data 27/01/2011 al Presidente del Tribunale di Taranto in allegato ed a sostegno dell’atto di ricusazione, in procedimenti penali per il quale il magistrato denunciato era decidente sulle mie sorti, una richiesta motivata e circostanziata di avocazione delle indagini inviata al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Taranto, ma anche di Potenza. Avocazione delle indagini presentata il 18 aprile 2008 a Taranto e Potenza. Magistrato già precedentemente denunciato alle procure di Taranto e Potenza ben prima del 18 aprile 2008, sapendolo colpevole con prove a sostegno. Denunce presentate in data 22/03/2006 e rimaste lettera morta.
Diffamazione per aver presentato in data 27/01/2011 tale richiesta di avocazione delle indagini al Presidente del Tribunale di Taranto in allegato ed a sostegno dell’atto di ricusazione in procedimenti penali per il quale il magistrato denunciato era decidente sulle mie sorti. Diffamazione perché denunciavo la grave inimicizia causa di persecuzione. Diffamazione tardiva perché richiesta simile di ricusazione era stata presentata già il 29/09/2010. Le ricusazioni (erano tre per tre distinti procedimenti), poi, non sono state rese operative, in quanto il magistrato ricusato ha presentato la denuncia contro di me per giustificare la sua astensione. Cosa che rimarca ogni volta in tutti i procedimenti nei quali, investita come magistrato titolare, sia costretta a rinunciare: «Mi astengo dal procedimento a carico dell’imputato in quanto ho presentato denuncia penale contro lo stesso per calunnia e diffamazione.» Intanto per quei processi, sempre per diffamazione a mezzo stampa, con condanna scontata se fossi rimasto inerte, sono stato successivamente prosciolto dagli altri giudici subentranti.
La grave inimicizia, causa della ricusazione di cui si pretendeva l’impedimento dell’esercizio del diritto, era palesata dai precedenti giudizi di causa cui tale magistrato era competente ed io sempre soccombente, quando io esercitavo la professione forense, per le quali io ero imputato o difensore di parte. Dalla lettura delle sentenze si evince tale pregiudizio.
In effetti, la denuncia nei miei confronti, è un atto ritorsivo. Non tanto per la richiesta di ricusazione ed avocazione delle indagini ed atti allegati, ma per la mia attività di scrittore noto nel mondo che denuncia le malefatte dei magistrati a Taranto e pubblica quanto gli altri non osano dire. Vedi caso killer delle vecchiette, Sarah Scazzi, Ilva, ecc.
D'altronde la calunnia non sussiste, sapendo il magistrato colpevole ed evidenziandolo in più atti di denuncia, né sussiste la diffamazione, in quanto, ai sensi dell’art. 596 c.p., come pubblico Ufficiale la prova della verità del fatto determinato è ammessa nel processo penale.
Oltretutto i reati sono ampiamente prescritti e decaduti, ove vi fosse bisogno della querela.
Questa è la denuncia penale, così come richiesta in sede di avocazioni delle indagini alla procura Generale della Corte di Appello di Potenza, e per la quale è stata presentata (a dire di Rita Romano) denuncia per calunnia.
DENUNCIA ALLA S.V.
Rita Romano, giudice monocratico del Tribunale di Taranto, sezione staccata di Manduria,
domiciliata in viale Piceno a Manduria,
per i reati di cui agli artt. 81, 323, 476, 479 c.p., con applicazione delle circostanze aggravanti, comuni e speciali ed esclusione di tutte le attenuanti,
IN QUANTO
Essa, abusando del suo ufficio, ha adottato continuamente atti del suo ufficio, con “INTENTO PERSECUTORIO”, lesivi degli interessi, dell’immagine e della persona del sottoscritto, motivati da pregiudizio ed inimicizia e non sostenute da prove.
Nei procedimenti che riguardavano direttamente o indirettamente il Giangrande Antonio, quando questi esercitava la professione forense, essa ha condannato quando le prove erano evidenti riguardo l’innocenza, o essa ha assolto quando le prove erano evidenti sulla colpevolezza.
PREMESSO CHE:
Giangrande Antonio, da difensore, è stato vittima di un aggressione in casa da parte del marito di una sua assistita in un procedimento di separazione, al fine di impedirgli la presenza all’udienza del giorno successivo. Nel processo penale n. 10354/03 RGD, in data 14 febbraio 2006, la Romano assolveva l’aggressore Mancini Salvatore. In un processo istruito, in cui il PM non ha richiesto l’ammissione di alcun testimone, pur indicanti in denuncia Giangrande Antonio, sua moglie Petarra Cosima e il figlio Giangrande Mirko, la Romano sente solo i coniugi ai sensi del’art. 507 c.p.p. su indicazione del Giangrande, ma rinuncia alla testimonianza di Mirko, il vero testimone. Tale abnorme decisione di assoluzione è stata assunta disattendendo i fatti, ossia le lesioni e le testimonianze, e definendo testimoni inattendibili il Giangrande e la Petarra.
Giangrande Antonio era accusato di esercizio abusivo della professione forense e per gli effetti di circonvenzione di incapace. Nel processo penale n. 7612/01 RGPM, in data 06/03/2007, nonostante lo stesso PM riteneva il reato di esercizio abusivo della professione forense infondato e inesistente, essendovi regolare abilitazione al patrocinio legale, chiedendone l’assoluzione, la Romano condannava il Giangrande per circonvenzione di incapace. Tale abnorme decisione è stata assunta, nonostante le tariffe forensi prevedevano l’obbligatorietà dell’onorario per il mandato svolto. Tale abnorme decisione è stata assunta nonostante più volte si sia denunciata la violazione del diritto di difesa per mancata nomina del difensore, per impedimento illegittimo all’accesso al gratuito patrocinio. E’ seguito appello. Da notare che il giorno della sentenza era l’ultimo processo ed erano presenti solo il PM, il giudice Romano, il cancelliere e il difensore dell’imputato. Dagli uffici giudiziari è partita la velina. Il giorno dopo i giornali portavano la notizia evidenziando il fatto che il condannato Giangrande Antonio era il presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie. Era la prima volte che le vicende del Tribunale di Manduria avevano degna attenzione.
Giangrande Antonio era difensore di Natale Cosimo in una causa civile di sinistro stradale. Il testimone Fasiello Mario dichiara di non sapere nulla del sinistro. Esso era denunciato per falsa testimonianza. Nel processo penale n. 1879/02 PM , 1231/04 GIP, 10438/05 RGD, in data 27 novembre 2007, la Romano lo assolveva. Tale abnorme decisione è stata assunta, nonostante lo stesso rendeva testimonianza contrastante a quella contestata. Lo assolveva nonostante affermava il vero e quindi il contrario di quanto falsamente dichiarato in separata causa. Lo assolveva nonostante a difenderlo ci fosse un difensore, Mario De Marco, impedito a farlo in quanto Sindaco pro tempore di Avetrana. Il De Marco e Nadia Cavallo hanno uno studio legale condiviso.
Giangrande Antonio e Giangrande Monica erano accusati di calunnia, per aver denunciato l’avv. Cavallo Nadia per un sinistro truffa, in cui definiva, in reiterati atti di citazione, Monica “RESPONSABILE ESCLUSIVA” del sinistro. Atti presentati due anni dopo la richiesta di risarcimento danni, che la compagnia di assicurazione ha ritenuto non evadere. Il Giangrande Antonio non aveva mai presentato denuncia. Antonio era fratello e difensore in causa di Monica. La posizione del Giangrande Antonio era stralciata per lesione del diritto di difesa e il fascicolo rinviato al GIP. Nel processo penale n. 10306/06 RGD, in data 18 dicembre 2007, la Romano condannava Giangrande Monica e rinviava al PM la testimonianza di Nigro Giuseppa per falsità. Tale abnorme decisione è stata assunta, nonostante la presunta vittima del sinistro non abbia riconosciuto l’auto investitrice, si sia contraddetto sulla posizione del guidatore, abbia riconosciuto Nigro Giuseppa quale responsabile del sinistro, anziché Giangrande Monica. Tale abnorme decisione è stata assunta, nonostante Nigro Giuseppa abbia testimoniato che la presunta vittima sia caduta da sola con la bicicletta e che con le sue gambe sia andato via, affermando di stare bene. E’ seguito appello.
Giangrande Antonio era difensore di Erroi Salvatore, marito di Giangrande Monica, sorella di Antonio. In causa civile, in cui difensore della contro parte era sempre Cavallo Nadia, tal Gioia Vincenzo ebbe a testimoniare sullo stato dei luoghi, oggetto di causa. Il Gioia, in chiara falsità, palesava uno stato dei luoghi, oggetto di causa, diverso da quello che con rappresentazione fotografica si è dimostrato in sede civile e penale. Il Gioia, denunciato per falsa testimonianza veniva rinviato a giudizio in proc. 24/6681/04 R.G./mod 21. Difeso da Cavallo Nadia in proc. 10040/06 RGD. In data 16 aprile 2008 il giudice Rita Romano, pur evidenti le prove della colpevolezza, assolveva il Gioia Vincenzo.
"La pubblicazione della notizia relativa alla presentazione di una denuncia penale e alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, oltre a non essere idonea di per sé a configurare una violazione del segreto istruttorio o del divieto di pubblicazione di atti processuali, costituisce lecito esercizio del diritto di cronaca ed estrinsecazione della libertà di pensiero previste dall'art 21 Costituzione e dall'art 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche se in conflitto con diritti e interessi della persona, qualora si accompagni ai parametri dell'utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato. (Rigetta, App. L'Aquila, 10 Marzo 2006)". (Cass. civ. Sez. III Sent., 22-02-2008, n. 4603; FONTI Mass. Giur. It., 2008).
Mallegni: "Non chiamatemi più Massimo della pena". Il sindaco di Pietrasanta dopo sei processi racconta la sua Odissea. Iniziata con l’esposto di una vigilessa che Renzi ha portato a Palazzo Chigi, scrive Maurizio Tortorella su “Panorama” il 6 luglio 2015. "Ho una sola preghiera: non chiamatemi più Massimo della pena". Alla guida di una lista di centrodestra, Massimo Mallegni è stato appena rieletto per la terza volta e a furor di popolo sindaco di Pietrasanta, la città-gioiello della Versilia lucchese. Il nomignolo gliel’hanno affibbiato le malelingue toscane e non hanno tutti i torti: dal maggio 2001, pochi mesi dopo la prima elezione, Mallegni è finito sotto processo ininterrottamente per 13 anni. I processi sono stati sei e tutti duri, brutti e cattivi. Lui oggi scherza: "Silvio Berlusconi si lamentava perché da presidente del Consiglio doveva dedicare un giorno a settimana ai suoi processi. Io ero costretto ad andare in tribunale tre volte a settimana". Sorride, Mallegni. Eppure è stato accusato di decine di reati, dalla A di abuso fino alla T di truffa. Lo hanno perfino arrestato, ha fatto 39 giorni di carcere e 119 agli arresti domiciliari. Ma tutto è sempre finito in nulla: proscioglimenti in istruttoria, assoluzioni con formula piena. Per qualche reato minore, prescritto, pende l’appello: "E solo perché mi sono sempre opposto alla prescrizione". Dall’ultimo procedimento è uscito definitivamente assolto nel febbraio 2014: un abuso d’ufficio ed edilizio per il quale, a lui albergatore già nel cuore della stagione turistica, il 4 agosto 2010 la Procura di Lucca aveva ordinato il sequestro della Spa dell’hotel. "Il sequestro" sottolinea Sandro Guerra, che del sindaco è (come da nome) il battagliero avvocato "l’aveva firmato un giudice che dopo l’arresto del 2006 aveva querelato Mallegni per diffamazione. Sicuramente non ha collegato le due vicende, ci mancherebbe". Era il momento in cui il già due volte sindaco era appena stato sbattuto, con padre e cinque assessori, nel carcere di Lucca. «Sezione 4, cella numero 17» dice Mallegni. «M’ha salvato la fede. Pensavo a mio figlio, a mia moglie…». Tornato a casa, ebbe la cattiva idea di pronunciare parole di sconforto, qualcosa sulla sua vita rovinata. Bastò a quel giudice per citarlo in giudizio. Il sindaco ricorda la cella: "Ero in isolamento, come i mafiosi al 41 bis, e sempre controllato dal foro nella porta, anche quando andavo al gabinetto. Ma gli agenti erano ottime persone". Questo va detto, di Mallegni. Non porta rancore, né si ritiene un perseguitato. Anzi, continua a ripetere che con lui "la giustizia ha funzionato". Un bel paradosso, non c’è dubbio. "Ho incontrato una ventina di giudici" spiega "e sono stati indipendenti. Hanno letto le carte, mi hanno ascoltato". L’avvocato Guerra è un po’ meno conciliante. Ricorda soprattutto i duelli in aula con il pubblico ministero "fratello". No, non massone, avete equivocato: fratello in senso stretto, di sangue. Perché all’origine dei peggiori guai di Mallegni ci sono stati gli esposti firmati da Antonella Manzione, ex comandante dei vigili urbani di Pietrasanta, e gestiti a livello giudiziario dal pm lucchese Domenico Manzione. Da allora fratello e sorella hanno fatto carriera. Domenico nell’ottobre 2009 fu nominato procuratore di Alba e dal maggio 2013è sottosegretario all’Interno, scelto da Enrico Letta e confermato da Matteo Renzi; Antonella invece è divenuta prima comandante dei vigili urbani di Firenze, con Renzi sindaco, e oggi è il suo capo dell’ufficio legislativo a palazzo Chigi. Mallegni non ce l’ha nemmeno con loro: "Si vede che lei è brava e lui è ancora più bravo" commenta. Ma torniamo alla querelle con la comandante dei vigili. Tutto inizia quando il sindaco si è da poco insediato a Pietrasanta, nel 2000. "Trovo una delibera firmata dal mio predecessore che riorganizza il Comune". La delibera pone fine a un’anomalia: la comandante è anche capo dello Sportello unico attività produttive, e le viene tolto il primo incarico. Mallegni conferma la delibera: "La signora non perde un euro" dice "ma evidentemente la cosa le provoca disagio. E presenta un esposto di 20 pagine alla Procura di Lucca". È da quelle pagine che partono tre processi, con 51 capi d’accusa. Manzione accusa Mallegni di avere abusato dell’auto di servizio ("Si dimostrò che in realtà era l’auto civetta dei carabinieri della scorta: avevo ricevuto 4 proiettili calibro 38 dal Partito comunista combattente"); di avere inalberato un lampeggiante blu sulla sua auto ("Altro errore: era la vettura di Gianfranco Fini, presidente della Camera"); di avere estorto a un vigile la remissione di una multa ("Ma era un’auto del Comune"). L’esposto, firmato da altri 5 vigili, si fa più delicato in campo urbanistico: qui Antonella Manzione accusa il sindaco di avere fatto sperticati maneggi. Ed è su questo tema che partono gli arresti del gennaio 2006, chiesti da Domenico Manzione per associazione a delinquere, truffa, abuso d’ufficio, voto di scambio, estorsione… "L’ex pm oggi nega di avere avuto un ruolo importante nel processo" polemizza l’avvocato Guerra "ma non è così. Lo seguì fino al suo trasferimento ad Alba, e ci sono i verbali delle udienze. Ricordo che, indispettito, uscì sbattendo la porta dall’aula alla fine di un lungo interrogatorio nel quale ponevo a testi e parti civili domande sul ruolo della sorella comandante dei vigili". Già nel 2006 la Cassazione stabilì che gli arresti erano stati illegittimi. "Intanto" ricorda Mallegni "avevo ricevuto 755 lettere di solidarietà dai miei concittadini". In Parlamento ci fu chi si rivolse al ministero della Giustizia, allora retto dal leghista Roberto Castelli, segnalando l’anomalia di Lucca, dove un pm agiva su esposti firmati da sua sorella: in procura arrivarono gli ispettori, poi il governo cadde e tutto finì in niente. Sei anni dopo il processo terminò allo stesso modo. Oggi Mallegni è di nuovo lì. Paura? "No" risponde. "Fare il politico da imprenditore non è conveniente, ma si deve andare avanti". E con il nuovo capo dei vigili urbani è tutto a posto? O si rischiano nuovi guai? "È uno dei cinque che mi aveva denunciato con la sua comandante. Ma è un tipo in gamba. E poi io non porto rancore".
Il Cav? È l'unico corruttore al mondo. La condanna di Silvio Berlusconi per il "tradimento" dell'ex senatore De Gregorio mostra la totale parzialità di una giustizia che vede solo quel che vuole vedere, scrive Maurizio Tortorella su “Panorama” il 9 luglio 2015. A che cosa deve servire una sentenza di tribunale penale? A fare giustizia, risponderete voi. Errato: serve “a offrire una funzione generalpreventiva". Così ha detto ieri il pubblico ministero napoletano John Henry Woodcock nell'aula del processo sulla presunta compravendita dell'ex senatore Sergio De Gregorio. Il processo di primo grado si è concluso proprio ieri con la condanna di Silvio Berlusconi, il presunto corruttore, a tre anni di reclusione (ma l'accusa ne aveva chiesti cinque). L'altro condannato è Valter Lavitola, presunto tramite del passaggio di denaro (tre milioni di euro, due dei quali in nero) che pure si è visto assegnare tre anni. Strana maniera di vedere la giustizia, quella del pm Woodcock. Il processo, destinato a concludersi per l'intervenuta prescrizione, lascerà proprio per questo a metà ogni certezza giuridica. Non sarà quindi certa né l'attribuzione del reato, né la sua configurazione storica. Parlare di giustizia "generalpreventiva", in questo caso, è davvero improprio. Inoltre, la questione di cui si è dibattuto a Napoli è decisamente controversa: non solo nella verità storica dei fatti, negata con forza dagli imputati, ma anche in punto di diritto. È infatti la prima volta in Italia (ma forse anche nel mondo) che un "cambio di casacca" parlamentare viene punito con una condanna. In Italia, peraltro, la Costituzione prevede all'articolo 67 che nessun deputato o senatore possa essere soggetto a un "vincolo di mandato": questo vuol dire che è libero di esprimersi nel voto parlamentare come meglio crede, e anche di cambiare gruppo. Il procuratore di Napoli, Giovanni Colangelo, ha dichiarato però che a essere punita in questo caso "non è l'insindacabilità del voto, ma il condizionamento del voto: espresso non per libera scelta politica, ma per un pagamento. E il reato di corruzione non si riferisce all'espressione di un voto, ma alla promessa di un voto". Ma anche quella del procuratore Colangelo è una ben strana maniera di vedere le cose. Perché l'alto magistrato pare dimenticare le centinaia, migliaia di altri passaggi di campo che si sono verificati nella Storia parlamentare italiana, e pare dimenticare soprattutto che molti di questi hanno di certo avuto avuto alla loro base scambi di qualche utilità. Quante volte si è saputo (e scritto sui giornali) delle prebende o dei vantaggi ottenuti dal "traditore" di turno? Quanti senatori e deputati sono "migrati" soltanto in virtù delle garanzie di una successiva elezione, o della promessa del successivo ottenimento di posti importanti negli enti pubblici, o della facile carriera garantita in altro settore? Certo, il trasformismo è purtroppo costume trasversale, in questo Paese, fin dai tempi di Agostino Depretis. E non è certo pratica commendevole. Ma allora perché per le altre centinaia e migliaia di "cambi di casacca" parlamentari, comunque premiati con un vantaggio evidente, non si è mai ipotizzato che potesse trattarsi di corruzione? Eppure l'articolo 318 del Codice penale individua la corruzione nello scambio di un atto con "denaro o altra utilità". Non dovrebbe allora essere punito chi ha costretto decine di deputati berlusconiani a passare con il centrosinistra nelle precedenti legislature, per poi ottenere in cambio un seggio più sicuro alle successive elezioni?
Per di più, in questo caso, la ricostruzione giudiziaria del passaggio di De Gregorio con il centrodestra ha stravolto anche la verità storica. L'ex senatore infatti aveva trascorso tutta la sua vita politica nel centrodestra, per poi passare da ultimo (e strumentalmente) con il centrosinistra. Il suo "ritorno a casa" in realtà avviene nel 2006, all'inizio della legislatura. Questa circostanza nega con evidenza la "verità giudiziaria" uscita da Napoli, dove si è sentenziato che il tradimento di De Gregorio avrebbe causato la caduta del governo di Romano Prodi. In realtà il fragilissimo esecutivo di Prodi, che per lunghi mesi si era sostenuto soltanto con l'aiuto dei senatori a vita, avvenne nel 2008 per tutt'altro motivo: le crescenti turbolenze giudiziarie sul suo ministro della Giustizia, Clemente Mastella, e la sua uscita dalla maggioranza.
Compravendita senatori, Giampaolo Pansa su “Libero Quotidiano”: "Romano Prodi fatto fuori dai suoi 101". Ha ragione Maurizio Belpietro: non è stata l’eventuale compravendita di qualche senatore a far cadere il secondo governo di Romano Prodi. A ucciderlo furono gli alleati del Professore e il tragicomico ambiente dell’Unione di centrosinistra. Fu l’ennesima prova che le sinistre italiane erano inadatte, e sono, a guidare il paese. Si curavano soltanto del proprio interesse. Le meschinerie di partito prevalevano su tutto. Il loro personale di governo risultava un insieme di arroganti incapaci e di ridicole macchiette. E su tutto dominava la vocazione al suicidio, l’irresistibile piacere di impiccarsi da soli al loro stesso albero. Una specialità del socialcomunismo italico. Ancora prima che nascesse il governo, ossia all’inizio della campagna elettorale del 2006, Prodi venne trattato dagli alleati come un avversario da ostacolare. Voleva presentare una propria lista con il suo nome, ma gli dissero di no. A nome dei Ds e della Margherita, il rifiuto gli venne comunicato da Piero Fassino e da Francesco Rutelli. Per una ragione meschina: avevano il timore di rendere troppo forte Prodi, grazie a una piccola truppa di elettori che si fidavano soltanto di lui. Può sembrare strano, ma i più ostili al Professore erano i cattolici della Margherita. Non lo volevano come candidato premier. E quando fu sicuro che sarebbe stato lui a guidare il centrosinistra, lo boicottarono in tutti i modi possibili. A cominciare da Ciriaco De Mita, Franco Marini, Dario Franceschini, oggi ministro di Renzi, e Paolo Gentiloni, che adesso guida gli Esteri. Niente lista? Allora il Prof chiese di poter disporre almeno di una consistente pattuglia di parlamentari prodiani. La tirchieria ottusa dei partiti dell'Unione glie ne concesse appena cinque. Infine Prodi chiese che si presentasse la lista dell’Ulivo non soltanto alla Camera, ma pure al Senato. La risposta dei capi partito fu incredibile: a Montecitorio sì, a Palazzo Madama no. Perché? Confesso di non averlo mai capito. Il 17 maggio 2006, L’Ulivo vinse le elezioni, ma soltanto per un pelo. Alla Camera, su 38 milioni di schede scrutinate, il vantaggio fu appena di 25 mila voti, poi rafforzato dal premio di maggioranza. Ma al Senato il Prof ebbe a disposizione un margine molto ristretto: 158 seggi contro 156. In compenso, il programma di governo risultò adatto a un regime totalitario, destinato a durare vent’anni. Dopo un tira e molla estenuante fu varato un volume di trecento pagine. Ecco la prova regina che l’Unione di centrosinistra, un cartello di ben nove partiti, era un’accozzaglia di forze non soltanto diverse, ma incompatibili tra loro. A distinguersi per l’atteggiamento idiota furono le sinistre radicali. Prodi le chiamava «le mie frange lunatiche». Rifondazione comunista voleva dal Prof un’anticipazione di socialismo. Fausto Bertinotti lo definiva con un ghirigoro di parole: «L’uscita dal ciclo economico e politico degli ultimi cinque anni del governo Berlusconi, con la volontà di invertire la strada degli ultimi vent’anni». Quando le urne vennero aperte e si cominciarono a contare i voti, Prodi si rese conto di essere finito su un tavolaccio di chiodi roventi. In un’intervista che mi concesse per l’Espresso, aveva detto: «Guardi che a me non piace mediare. Io voglio governare». Ma il primo sforzo al quale lo costrinsero fu una trattativa estenuante sulla composizione del governo. Un programma obeso poteva figliare soltanto un esecutivo di dimensioni ciclopiche. Il risultato fu mostruoso: un premier, due vicepremier, 23 ministri, 10 viceministri, 66 sottosegretari. Totale: 102 eccellenze, o 101 se escludiamo il Prof. Un record mondiale. Prodi si trovò a guidare anche signore e signori che gli erano ignoti. Ma con il vantaggio di essere ben piazzati nei piani alti dei partiti che li avevano imposti. Nel corso di un’altra intervista, il Prof mi rivelò: «Avevo proposto un governo di soli quindici ministri. Mi sono ritrovato con venticinque, compresi i due vicepremier. E sa perché? Me lo ricordo bene il giorno che Fassino e Rutelli entrarono insieme nella mia stanza a Palazzo Chigi. E mi dissero: devi dare nove ministri ai Ds e sei alla Margherita. Il resto è venuto da sé». Tutti quei ministri e la corte sterminata dei sottosegretari si fecero conoscere subito dall’Italia per la voglia spudorata di esternare. Dopo la nascita del governo, sull’Italia intera cominciò un bombardamento parolaio a tappeto. Tanto violento da far sembrare quello degli Alleati su Dresda, verso la fine della seconda guerra mondiale, un’innocua scarica di mortaretti. Il ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, disse subito no al ponte sullo stretto di Messina. Il ministro Di Pietro gli replicò: tocca a me parlarne, non a te. Pecoraro Scanio aggiunse: sono d’accordo con Bianchi, investiamo nei parchi nazionali i soldi che non si devono spendere per il ponte. La Bindi esternò sui Pacs, le coppie di fatto. Gentiloni sulla legge Gasparri per la Rai. Ministri e viceministri di Rifondazione chiesero di abolire la sfilata del 2 giugno perché l’Italia era votata alla pace e non alla guerra. Un altro ministro di Rc, Ferrero, gridò no ai lager di accoglienza per gli immigrati. La senatrice rifondarola Patrizia Sentinelli chiese il ritiro della missione in Afghanistan. Paolo Cento, paracadutato all’Economia, materia a lui del tutto sconosciuta, sproloquiò sulla Tobin Tax e sulla ripresa economica che di per sé non era un bene. Il più brillante fu il bresciano Elidio De Paoli, chiamato il Leghista rosso, nominato sottosegretario alle Politiche giovanili e attività sportive. La sua prima dichiarazione sorprese l’Italia: «Sia chiaro che di sport non mastico niente. Per me il tamburello o le bocce pari sono». Contro ogni previsione, il secondo governo Prodi riuscì a durare sino alla fine del gennaio 2008. Poi cadde sotto una frana messa in moto dal ministro della Giustizia, Clemente Mastella. I pm di Napoli gli avevano spedito agli arresti domiciliari la moglie Alessandrina Lonardo, presidente del Consiglio regionale della Campania. Lo stesso Mastella era inquisito. Secondo un libro di Rodolfo Brancoli, stretto collaboratore di Prodi, il ministro si era fiondato nello studio del Prof, urlando: «Se mi vogliono fare il culo, ve lo faccio prima io!». Ma il governo appariva da tempo un malato terminale, corroso giorno dopo giorno dalle divisioni interne. E soprattutto dal continuo sabotaggio di Rifondazione comunista. Dopo le elezioni del 2006, Fausto Bertinotti aveva affrontato Prodi a muso duro: «O mi dai la presidenza della Camera o mi fai ministro degli Esteri». Ottenne lo scranno più alto di Montecitorio che doveva andare a D’Alema. Tuttavia i suoi colonnelli non smisero di attaccare il Prof. Il nuovo segretario rifondarolo, Franco Giordano, era solito dire: «Mi considero un leader dell’opposizione». E il solito Paolo Ferrero, ministro della Solidarietà sociale, riteneva «una buona notizia» che alla Fiat Mirafiori ci fosse stato uno sciopero contro il governo. Nell’andarsene da Palazzo Chigi, il premier confidò a Brancoli: «Quando fallisce per due volte lo sforzo di costruire un’alternativa riformista, per molti anni sarà impossibile governare». Una profezia azzeccata, come tutti possono constatare. Di Giampaolo Pansa.
E poi… Silvio Berlusconi è decaduto da senatore e non è stato più candidabile per effetto della legge Severino, scrive "Il Corriere della Sera". Malgrado la stessa legge, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris (eletto nelle fila dell’Idv) e il neo-governatore della Campania Vincenzo De Luca del PD possono invece restare in carica, per effetto di sentenze sospensive a loro favorevoli. Come quella del 2 luglio 2015 che di fatto consente a De Luca di prendere pieno possesso delle proprie funzioni dopo la sua sospensione decretata nei giorni prima dal governo Renzi. Una diversità di applicazione della norma che fa insorgere il centrodestra: «Dopo il trattamento favorevole a de Magistris e De Luca, non chiamatela più legge Severino ma con il suo vero nome: legge anti-Berlusconi - commenta la deputata di Forza Italia, Elvira Savino -. Ormai è chiaro a tutti che è una legge, applicata addirittura retroattivamente, che è servita solo per estromettere vergognosamente il presidente Berlusconi dal Senato». Stesso concetto ribadito da Maria Stella Gelmini, per la quale si è trattato di una legge «contra-personam» («visto che dopo il caso Berlusconi non è stata più applicata o, laddove applicata, i suoi effetti sono stati cancellati con sentenze del Tar»), che aggiunge: «Ora è chiaro perché il governo non ritiene utile una revisione della legge Severino. Per la semplice ragione che essa viene interpretata per gli amici e applicata ai nemici. Con buona pace dello stato di diritto». Il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato Brunetta, fa notare via Twitter che «la decisione del Tribunale di Napoli riabilita Berlusconi, ma il caso De Luca resta aperto. Sinistra giustizialista chieda scusa a Cav. Severino da cambiare!». E con un paio di tweet interviene anche Giorgia Meloni, già ministro del governo Berlusconi, secondo cui la legge Severino è «l’unica vera legge ad personam. #superioritamoraleuncorno». E ancora: «De Luca te lo avevamo detto che potevi stare sereno: la Severino vale solo per Berlusconi e il centrodestra. La sinistra è al di sopra della legge». In una nota, i legali del leader FI, Franco Coppi, Piero Longo e Niccolò Ghedini, parlano di «gravissima ingiustizia» osservando come siano «quasi due anni che inascoltati sosteniamo la assoluta inapplicabilità della legge Severino ai fatti precedenti, per il fondamentale principio di irretroattività. Finalmente alcune decisioni stanno riconoscendo la evidente correttezza di questa impostazione».
«Renzi può intervenire con una modifica alla legge Severino, cosa che non ha ritenuto di fare quando si è trattato di Silvio Berlusconi. - Così l’ex Cavaliere a Radio anch’io, commentando la vicenda del candidato Pd alle regionali campane Vincenzo De Luca, candidabile ma ineleggibile per la legge sulla “repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione". - Io chiedevo – ha sostenuto Berlusconi – una cosa semplice, cioè di aggiungere una norma che dice che la presente legge si applica a fatti successivi alla sua entrata in vigore. Cosa addirittura pleonastica ma che è stata dimenticata, e la legge Severino con me è stata applicata retroattivamente. Così sono riusciti a farmi decadere dal Senato e rendermi incandidabile per sei anni. Tuttavia sto aspettando la Corte dei diritti di Strasburgo e spero che la sentenza verrà ribaltata».
«Fino ad ieri potevamo, politicamente, solo sospettare che la legge Severino fosse stata fatta per espellere Berlusconi dal Senato. Da ieri, invece, dopo tre indizi abbiamo raggiunto la prova “regina”, storica e politica al tempo stesso: la legge Severino fu fatta contro e ad personam». Maria Stella Gelmini attacca nonostante siano trascorsi ormai di due anni da quando, all’indomani della sentenza Mediaset della Cassazione, il Senato espulse Silvio Berlusconi. Proprio per effetto della legge Severino, scrive Antonio Manzo su “Il Mattino”.
Quali sono i tre indizi, onorevole Gelmini, che la fanno raggiungere la prova?
«De Luca uno, con il Governo che si guarda bene dal sospenderlo subito; De Luca due, con l’ordinanza urgente del tribunale di Napoli; De Magistris tre, salvato sempre dallo stesso giudice civile del caso De Luca. Abbiamo avuto così la dimostrazione che tra ordinanze e sentenze, la legge Severino è stata interpretata, favorevolmente, per gli amici ed è stata applicata, implacabilmente, per i nemici. Altro che garantismo, qui è la morte dello stato di diritto».
Scusi, ma uno dei presupposti delle valutazioni dei magistrati è che sia nel caso di De Luca, che in quello di de Magistris fossero in gioco valori costituzionalmente protetti come quelli espressi da rappresentanti istituzionali eletti dal popolo?
«Se c’è un leader politico che in Italia può dichiarare, a piena voce, di essere un eletto dal popolo è Silvio Berlusconi. Che poi anche De Luca e de Magistris siano stati eletti dal popolo per governare la Regione Campania ed il Comune di Napoli, è altra storia. Nel caso di Silvio Berlusconi è stata minata, stracciata, distrutta la volontà popolare e il valore elettivo, quello sì costituzionalmente protetto ed universale, incarnato da un membro del Parlamento, massima espressione della democrazia repubblicana. È un vulnus più grave. Non le pare?»
La legge Severino fu votata anche da voi di Forza Italia. È mai possibile che nessuno si sia accorto all’epoca dei fatti dei profili di incostituzionalità che oggi vengono a più riprese evidenziati?
«Vogliamo ricordare in che clima e in che contesto fu varata la legge Severino? Ebbene, contestualizziamo l’epoca, è quella del Governo Monti che cacciò Berlusconi, eletto dal popolo».
Governo votato dal Parlamento, l’unità nazionale con lo spread in salita quotidiana...
«Quella fu la cacciata di Silvio Berlusconi, eletto dal popolo, che inaugurò la stagione dei nominati a Palazzo Chigi, Monti, Letta e Renzi».
Ma è anche il tempo, ricorderà, degli scandali Fiorito, Lusi, Belsito, tutta gente che aveva preso in ostaggio le casse dei rispettivi partiti rimpinguate dal finanziamento pubblico come un bancomat personale.
«Non vorrà mica farmi dire che la ricostruzione del contesto politico dell’epoca, con la cacciata di Berlusconi da palazzo Chigi, annulli le responsabilità di chi aveva fatto dei partiti un bancomat personale? E allora, che ci volesse una reazione con norme più incisive alla corruzione, che facessero riguadagnare la faccia alla politica, è cosa scontata ed ineludibile. Ma che quella della legge Severino fosse una reazione emotiva è altrettanto vero. Anzi, come poi abbiamo registrato, sottintendeva l’idea piuttosto obliqua di prefigurare una risposta repressiva contro il leader dell’opposizione parlamentare, Silvio Berlusconi. Altro che questione morale...».
La prova definitiva: in Italia la legge non è uguale per tutti, scrive Maurizio Belpietro su “Libero Quotidiano”. La legge non è uguale per tutti. Per qualcuno è più uguale di altri, nel senso che è più rigida, soprattutto se ci si chiama Silvio Berlusconi. Ricordate la sentenza con cui l’ex Cavaliere è stato condannato a quattro anni di detenzione e sospeso dai pubblici uffici? Cioè quella misura che ha consentito la sua estromissione dal Parlamento e ha stabilito la sua ineleggibilità? Per i giudici della Corte di Cassazione il fondatore di Forza Italia fu l’artefice di una frode fiscale ai danni dell’erario e per questo fu costretto non solo a lasciare il suo seggio da senatore, ma anche a risarcire l’agenzia delle entrate. Peccato che in una sentenza del 20 maggio 2014, cioè emessa dieci mesi dopo quella pronunciata contro Berlusconi, la suprema corte si rimangi tutto, sostenendo che non si può condannare un contribuente solo in base alla presunzione di colpevolezza. Per stabilire che ha frodato il fisco ci vuole ben altro, ad esempio un atto fondamentale, ossia che l’accusato abbia materialmente partecipato alla frode compiendo l’atto finale: la dichiarazione dei redditi. Testuale: «I reati di dichiarazione fraudolenta hanno natura istantanea e si consumano soltanto con la presentazione della dichiarazione annuale». Ancor più esplicita: i reati di frode non possono essere provati «dalla mera condotta di utilizzazione, ma da un comportamento successivo e distinto, quale la presentazione della dichiarazione, alla quale in base alla disciplina in vigore non dev'essere allegata alcuna documentazione probatoria». Tradotto, tutto quel che succede prima, tutta la fase di valutazione antecedente al fatto, non ha importanza, perché «il comportamento precedente alla dichiarazione, quindi si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito, e perciò non punibile». La Cassazione, assolvendo nel maggio scorso un imputato di frode fiscale, nega dunque la rilevanza penale delle violazioni «a monte» della dichiarazione e lo fa facendosi forte di una serie di pronunciamenti passati. A qualcuno il discorso potrà sembrare ostico e forse anche ininfluente, in quanto la sentenza si riferisce a un caso diverso rispetto a quello di Silvio Berlusconi e, come è a tutti noto, ogni processo fa caso a sé, anche perché ogni giudice fa caso a sé. E per questo appunto c'è la Cassazione e le sezioni unite che fissano i principi inderogabili. I principi valgono per tutti e non si possono cambiare le carte in tavola a seconda di chi finisce alla sbarra. Dunque «i comportamenti di un soggetto quando era ancora amministratore di una società e che si era dimesso prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, non possono essere valorizzati neppure in termini di concorso con colui che, rivestendo successivamente la carica di amministratore, aveva indicato nella dichiarazione gli elementi fittizi». Tutto ciò messo nero su bianco da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, un provvedimento che fa giurisprudenza e al quale ci si deve attenere.
"Ora la revisione del processo Mediaset". Una sentenza di assoluzione della Cassazione su un caso analogo a quello di Berlusconi riapre la partita. L'annuncio di Ghedini, scrive Anna Maria Greco su “Il Giornale”. C'è una sentenza della Cassazione che, dieci mesi dopo quella Mediaset di condanna di Silvio Berlusconi, la bolla esplicitamente come sbagliata. Si regge su una tesi, spiega la motivazione, «che non può essere qui condivisa e confermata, perché contraria alla assolutamente costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte e al vigente sistema sanzionatorio dei reati tributari». Il caso è del tutto analogo a quello Mediaset, frode fiscale, le conclusioni opposte: sentenza di condanna confermata per il leader azzurro il primo agosto 2013, sentenza di condanna annullata per il signor X il 20 maggio 2014. Colpisce che il relatore sia lo stesso, il giudice Amedeo Franco, che già aveva firmato precedentemente altre sentenze «conformi» a quest'ultima. E che la sezione sia la Terza penale, cui era naturalmente destinato il processo Mediaset prima di venire dirottato a quella Feriale, presieduta da Antonio Esposito, per il timore (poi, a quanto sembra, rivelatosi infondato) che nei mesi estivi potesse scattare la prescrizione. «Questo dimostra - spiega il legale di Berlusconi, Niccolò Ghedini - che la condanna Mediaset ha rappresentato un unicum nella giurisprudenza della Cassazione. Che prima e dopo la legge è stata interpretata in maniera diversa, con un orientamento univoco. Se il processo Mediaset fosse arrivato alla Terza Sezione e non in quella Feriale, e con quello stesso relatore, sarebbero cambiate le sorti di Berlusconi e del Paese, sarebbe cambiata la storia. Questo sarà un elemento importante per la decisione della Corte europea per i diritti dell'uomo, che attendiamo. Ma soprattutto, sulla base di questa sentenza e delle nuove prove che abbiamo raccolto, chiederemo la revisione del processo». La difformità nella giurisprudenza di per sé non produce effetti sulla condanna Mediaset, ma potrebbe convalidare una violazione del principio del giusto processo, tra le ipotesi che giustificano la revisione del processo. E la strada sarebbe aperta se la Corte di Strasburgo, nella pronuncia attesa dopo l'estate, affermasse appunto che questa violazione c'è stata. È vero che ogni giudice e ogni collegio fa giurisprudenza a sé, ma è anche vero che la Suprema Corte ha proprio la funzione di uniformare l'interpretazione e l'applicazione del diritto. È lecito chiedersi perché prima della sentenza Mediaset si è seguita una strada precisa per il reato di frode fiscale e anche dopo è stato così, mentre in quel caso isolato ha prevalso proprio la teoria rivelata dal presidente Esposito in un'intervista al Mattino che gli ha procurato un processo disciplinare: Berlusconi fu condannato «perché sapeva», fu informato da altri della frode, non per il principio astratto del «non poteva non sapere», essendo il capo. Proprio qui sta il punto in cui la sentenza depositata in Cassazione il 19 dicembre scorso contraddice quella Mediaset, che cita esplicitamente, con data e numero di serie. Contestando la condanna dell'imputato, i Supremi giudici scrivono: «In sostanza, la corte d'appello appare aver adottato una interpretazione (analoga a quella poi seguita dalla Sezione feriale 1-8-2013, n.35729) nel senso che per la sussistenza del reato sarebbe sufficiente la prova di un "coinvolgimento diretto e consapevole alla creazione del meccanismo fraudolento... che ha consentito... di avvalersi della documentazione fiscale fittizia", al sottoscrittore della dichiarazione». Invece, continua la sentenza, questo non è affatto sufficiente. E le massime che l'accompagnano, quelle che per il futuro indicano ai giudici come interpretare la legge, dicono chiaro che: «I reati di dichiarazione fraudolenta hanno natura istantanea e si consumano soltanto con la presentazione della dichiarazione dei redditi». Le fasi preparatorie, il sapere o non sapere, non contano.
La Cassazione si rimangia la sentenza su Berlusconi, scrive Davide Giacalone su “Libero Quotidiano”. Il condannato Silvio Berlusconi ha terminato di espiare la pena. E questo è noto a tutti. Quel che non è noto, però, è che nel frattempo la corte di Cassazione ha condannato la sentenza che lo condannava. La considera un’eccezione, da non prendere ad esempio, perché sbagliata. Il nome del condannato agita le tifoserie. Gli capitava da imprenditore, ancor più da politico. La condotta di quelle trincee vocianti non è per nulla interessante. Talora neanche ragionevole. La linea cui ci si deve attenere, quando si affrontano questioni di giustizia, consiste nel non cedere alla contrapposizione fra innocentisti e colpevolisti, ma di attenersi alla difesa del diritto e dei diritti. Solo in questo modo non ci si limita a discutere casi personali, sollevando questioni che, sempre, riguardano tutti. Il che vale anche questa volta. Ma non faccio il falso ingenuo, so bene che il nome di Berlusconi è divisivo, capace, per i simpatizzanti e gli antipatizzanti, di distorcere la percezione della realtà. Chiedo uno sforzo, però: prima si capisca quel che è successo, poi si passi alle considerazioni, anche politiche e personali, che se ne possono far discendere. Con sentenza della Cassazione, emessa il primo agosto del 2013 (numero 35729), è stata confermata la condanna inflitta agli imputati in appello. Per Berlusconi la Cassazione chiese anche il ricalcolo della pena accessoria. Il reato contestato era la frode fiscale, con violazione (scusate la pedanteria, ma fra poco ne sarà chiara la ragione) del decreto legislativo 10 marzo 2000, numero 74. Detto in soldoni: la dichiarazione dei redditi della società (Mediaset) era mendace, giacché contenente riferimenti e contabilizzazioni di documenti falsi (fatture). Il seguito lo conoscono tutti: decadenza da parlamentare e affidamento ai servizi sociali. Il 20 maggio del 2014, quasi un anno dopo, quindi, la terza sezione della corte di Cassazione si è trovata ad esaminare un caso del tutto analogo, emettendo una sentenza, depositata in cancelleria il 19 dicembre successivo. L’imputato era stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione. Osserva la Cassazione, a pagina 10 della sentenza: «In sostanza, la corte d’appello appare aver adottato una interpretazione (analoga a quella poi seguita dalla Sezione Feriale 1/8/2013, n. 35729) nel senso che per la sussistenza del reato sarebbe sufficiente la prova di un “coinvolgimento diretto e consapevole alla creazione del meccanismo fraudolento (…) che ha consentito (…) di avvalersi della documentazione fiscale fittizia” al sottoscrittore della dichiarazione» (corsivo e omissioni come da sentenza). Tenetevi forte, perché le parole che seguono vanno valutate una per una. Scrive la Corte: «Si tratta però di una tesi che non può essere qui condivisa e confermata, perché contraria alla assolutamente costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte ed al vigente sistema sanzionatorio dei reati tributari introdotto dal legislatore con il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74». Detto in altro modo: le ragioni per cui Berlusconi, assieme ad altri, è stato condannato non solo sono difformi dalla «contraria» e «assolutamente costante e pacifica giurisprudenza» della Cassazione, ma sono in contrasto con quanto stabilisce la legge. Tanto che, quel 20 maggio dell’anno scorso, la Cassazione annullò la sentenza che le era stata sottoposta. Il primo agosto del 2013, invece, la confermò. Non è finita. Alla sentenza si accompagnano delle «massime», che sono delle brevi citazioni, utili a fissare i principi di diritto che la sentenza afferma. La Cassazione, infatti, esiste quale giudice di legittimità ed ha una funzione nomofilattica, che significa: garantire l’uniformità dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto. Le massime aiutano i futuri giudici di merito (e gli avvocati, naturalmente) ad attenersi a quell’uniforme interpretazione e applicazione. Ebbene, la sentenza di cui parliamo è accompagnata da alcune massime, in calce alle quali ci sono i riferimenti a varie sentenze, sempre della Cassazione, «conformi», vale a dire che sostengono la stessa cosa. E c’è la difforme: la numero 35729. Quella che condannò Berlusconi. Nelle motivazioni e nella massime si legge la corretta interpretazione della legge: la frode fiscale nasce e si concretizza nel momento in cui è firmata la dichiarazione mendace, mentre nessuno degli atti preparatori può, in nessun caso, essere utilizzato per dimostrarla e indicarne il colpevole. Tale, del resto, è chi firma il falso, ovvero nessuno degli imputati allora condannati. Ma colpevole può anche essere chi induce l’amministratore di una società in errore, mediante l’inganno. Circostanza negata dalla sentenza d’appello, quindi, ove la si voglia contestare, sarebbe stato un motivo di annullamento (con rinvio), non di conferma. Colpevole può anche essere l’amministratore di fatto, ovvero la persona che non figura come amministratore, ma che ne esercita le funzioni. Nel qual caso, però, si deve dimostrarlo. Senza nulla di ciò non può esserci condanna, questo stabilisce la Cassazione, con «assolutamente costante e pacifica giurisprudenza». Vengo all’ultimo aspetto, che a sua volta ha un peso dirompente. I contrasti di giurisprudenza esistono fin da quando esiste la giurisprudenza. Per quanto la Cassazione s’affanni a perseguire l’uniformità, agguantarla in modo assoluto è impossibile. Quindi, se due giudici emettono sentenze diverse non è una cosa poi così terribile. Peccato, però, che la Cassazione esiste proprio per correggere, non per produrre le difformità. E peccato che, in questo caso, non ci sono due giudici, ma uno solo. I due collegi, quello del 2013 e quello del 2014, si compongono complessivamente di dieci giudici, ma, come si vede dal frontespizio delle due sentenze, il «consigliere relatore» è uno solo. La stessa persona. Che ad agosto del 2013 scrive una cosa e a maggio del 2014 la demolisce. Anche in modo sprezzante, e ben più a lungo e dettagliatamente di quanto qui riportato. Nessuno pensi di cavarsela supponendo uno sdoppiamento della personalità. Meno ancora in un cambio di opinione, perché ha messo nero su bianco che l’orientamento era univoco sia prima che dopo. In quelle parole, dure e inequivocabili, io leggo il dolore. Un cultore del diritto cui si è storto fra le mani. E siccome la legge impedisce a un giudice di manifestare e rendere noto il proprio dissenso (in altri sistemi di diritto si verbalizza il diverso parere e, anzi, lo si utilizza pubblicamente per aiutare l’interpretazione della sentenza), quello ha preso la forma di una sentenza successiva. Tutto questo dice una cosa terribile: s’è scassata la Cassazione. La prova ce l’avete sotto gli occhi, contenuta nelle due sentenze. Questo è il punto che considero più rilevante e, ovviamente, di valore generale. Ma so benissimo che tutti guarderanno al nome del condannato, sicché aggiungo un dettaglio, che le tifoserie interpreteranno da par loro, mentre a me preme perché conferma quanto appena, tristemente, constatato: quel condannato, quando ancora era imputato, sarebbe dovuto finire davanti alla terza sezione, perché così stabilisce la Costituzione, affermando che il giudice non lo sceglie nessuno, ma è precostituito per legge, invece finì davanti alla sezione feriale. Perché accadde? Allora si disse, e ovunque si scrisse, perché i reati contestati sarebbero andati in prescrizione di lì a qualche settimana. In questi casi, giustamente, non si lascia che le ferie dei giudici mandino al macero le sentenze. Ma l’autorità giudiziaria di Milano, dove si era svolto il processo e dove risiedeva la procura che aveva sostenuto l’accusa, aveva inviato un fax con il quale dimostrava che la prescrizione, correttamente conteggiata, non era così imminente. Le tifoserie pro Berlusconi grideranno d’orrore, vedendoci il complotto. Le tifoserie anti Berlusconi grideranno d’orrore, vedendoci la delegittimazione di giudici e sentenza. Lasciatemi accudire l’orrore silente, per una giustizia che si fatica a considerare tale.
I giudici Esposito e Berlusconi: il figlio gli chiedeva favori, il padre lo condannava, scrive "Articolo 3". Si torna a parlare degli anomali rapporti tra i giudici Esposito, padre e figlio, e l'ex premier Silvio Berlusconi. Il motivo è chiaro: nell'agosto del 2013, il collegio della Corte di Cassazione, presieduta da Antonio Esposito, aveva confermato la condanna di 4 anni per evasione fiscale nei confronti di Berlusconi, nell'ambito del processo Mediaset. Nello stesso periodo, però, il figlio di Antonio, Ferdinando Esposito, giudice a Brescia, aveva avuto rapporti con l'ex premier. E non solo: ci sarebbero state anche delle visite, ad Arcore, e regali. Il rapporto "sconveniente" è emerso nell'ambito di un altro processo, che con quello Mediaset non c'entra niente: Ferdinando Esposito è indagato per “tentata induzione indebita” e “tentata estorsione”. Secondo gli inquirenti, avrebbe fatto pressioni indebite per spingere un avvocato, oggi suo accusatore, a subentrare nell'affitto da 32mila euro annui della casa in cui il pm abitava. L'accusatore di Esposito, nel raccontare il tutto, aveva anche rivelato appunto i rapporti con Berlusconi. E il giudice, da parte sua, li ha confermati: ha rivelato di aver conosciuto l'ex premier attraverso la parlamentare di Forza Italia Michela Brambilla e, tra il 2009 e il 2013, vi furono anche delle visite ad Arcore che, secondo il pm, riguardavano una sua «possibile entrata in politica», cosa che poi non è avvenuta. "Io mai e poi mai nella maniera più assoluta ho trattato questioni che avessero a che fare con i processi Ruby e Mediaset”, ha precisato, pur confessando di aver anche ricevuto dei regali da Berlusconi: «Soltanto regalie d’uso che è solito dare a tutti quando si presentano lì», ossia cravatte.
Perché leggere Antonio Giangrande?
Nomina scrutatori e rappresentanti di lista: voto di scambio?
Lo scandalo dei voti di scambio: 30 euro ai ragazzi per 3 giorni di presenza ai seggi. Voto di scambio a destra, ma son peggio i permessi elettorali retribuiti dallo Stato alla sinistra.
Esiste un tariffario: 30, 40 o 50 euro. Vengono corrisposti in base ai voti conquistati dal candidato e certificati sui tabulati elettorali. E ci sono anche i comitati elettorali nei quali presentarsi per essere reclutati come rappresentanti di lista e procacciatori di preferenze. Ne ha parlato un servizio, firmato dal giornalista Francesco Iato, trasmesso dal Tg Norba e sequestrato dalla Digos. Il compito del «rappresentante di lista» non è solo quello, canonico, di controllare il corretto andamento dello scrutinio elettorale, ma anche di garantire un certo numero di voti. Il servizio di Francesco Persiani del Tg Norba delle ore 13.35 del 28 maggio 2015 dal titolo, “Taranto, scoppia lo scandalo scrutatori”, è esemplare e coraggioso. «Ultime ore utili per nominare i rappresentanti di lista. Non solo a Bari, ma anche a Taranto i giovani rappresentanti dei partiti potrebbero essere coinvolti in vicende poco lecite. Denaro in cambio di voti e del loro controllo. Alcuni lo sanno bene». Parla un ragazzo intervistato: “Per prendere voti fanno tutte cose, ormai. Si affiancano a persone della malavita. Si affiancano a persone di potere per salire anche loro al potere per legarsi alla poltrona”. «Capitolo a parte - prosegue Persiani – quello degli scrutatori, un gradino più in su. A Taranto sono stati tutti nominati dagli amici degli amici di partito: niente sorteggio. Così ha deciso la commissione elettorale usando il criterio, consentito dalla legge, delle indicazioni, dei suggerimenti. I consiglieri si sono divisi la torta. D’altra parte non è difficile in una città come Taranto DOVE E’ MESSA LA SORDINA AD OGNI DENUNCIA. IN UNA CITTA’ DOVE ALCUNE GROSSE AZIENDE MUNICIPALIZZATE SONO DIRETTE DA PERSONE CHE HANNO STRETTISSIMI LEGAMI CON I MAGISTRATI INQUIRENTI».
La verità è che in politica ci sono sempre gli interessi personali ad essere interessati e per quegli interessi si vota e per nient’altro.
Gli scrutatori sono nominati dagli amministratori, a cui render conto con i voti propri e dei parenti, ma sono pagati dallo stato: voto di scambio?
I rappresentanti di lista sono nominati dai candidati, a cui render conto con i voti propri e dei parenti. A sinistra sono numerosi. Fanno calca. Sono operai od impiegati che non hanno avuto nessuna difficoltà a trovare il loro impiego, grazie ai sindacati. I rappresentanti di lista di sinistra alle sezioni dei seggi elettorali li vedi a piantonare ed a controllare, spesso a disturbare ed a contestare. Si sentono anime pure. Additano come venduti i ragazzi dei partiti avversari, che prendono in totale 30 euro per 3 giorni di impegno ai seggi.
A sinistra parlano di volontariato politico. Ma è veramente così?
Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla L. n. 53/90, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti, quindi remunerata.
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori della scuola impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 L. 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
Hai visto le anime pure di sinistra? Prendono 10 volte la regalia dei 30 euro dati ai ragazzi dei partiti avversari, eppure parlano.
Il vero voto di scambio è quello loro: dello pseudo volontariato elettorale della sinistra.
Gli impresentabili e la deriva forcaiola.
Ognuno di noi, italiani, siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. In famiglia, a scuola, in chiesa, sui media, ci hanno deturpato l’anima e la mente, inquinando la nostra conoscenza. Noi non sappiamo, ma crediamo di sapere…
La legalità è il comportamento conforme al dettato delle centinaia di migliaia di leggi…sempre che esse siano conosciute e che ci sia qualcuno, in ogni momento, che ce li faccia rispettare!
L’onestà è il riuscire a rimanere fuori dalle beghe giudiziarie…quando si ha la fortuna di farla franca o si ha il potere dell'impunità o dell'immunità che impedisce il fatto di non rimaner invischiato in indagini farlocche, anche da innocente.
Parlare di legalità o definirsi onesto non è e non può essere peculiarità di chi è di sinistra o di chi ha vinto un concorso truccato, né di chi si ritiene di essere un cittadino da 5 stelle, pur essendo un cittadino da 5 stalle.
Questo perché: chi si loda, si sbroda!
Le liste di proscrizione sono i tentativi di eliminare gli avversari politici, tramite la gogna mediatica, appellandosi all'arma della legalità e della onestà. Arma brandita da mani improprie. Ed in Italia tutte le mani sono improprie, per il sol fatto di essere italiani.
Ci sono delle regole stabilite dalla legge che definiscono i criteri che vietano eleggibilità e candidabilità. Se un cittadino regolarmente iscritto alle liste elettorali non si trova in nessuna di queste condizioni si può candidare. Punto.
"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". (art. 49 della costituzione italiana). Alle amministrative del 31 maggio 2015 gli elettori saranno aiutati dalla commissione parlamentare antimafia che ha presentato una lista di impresentabili, spiega Piero Sansonetti. Cioè un elenco di candidati che pur in possesso di tutti i diritti civili e politici, e quindi legittimati a presentarsi alle elezioni, sono giudicate moralmente non adatte dai saggi guidati da Rosy Bindi. Le liste di proscrizione furono inventate a Roma, un’ottantina di anni prima di Cristo dal dittatore Silla, che in questo modo ottenne l’esilio di tutti i suoi avversari politici. L’esperimento venne ripetuto con successo 40 anni dopo da Antonio e Ottaviano, dopo la morte di Cesare, e quella volta tra i proscritti ci fu anche Cicerone. Che fu torturato e decapitato. Stavolta per fortuna la proscrizione sarà realizzata senza violenze, e questo, bisogna dirlo, è un grosso passo avanti. La commissione naturalmente non ha il potere – se Dio vuole – di cancellare i candidati, visto che i candidati sono legalmente inattaccabili. Si limita a una sorta di blando pubblico linciaggio. Un appello ai cittadini: «Non votate questi farabutti».
Ed i primi nomi spifferati ai giornali sono pugliesi.
Ma chi sono i 4 candidati impresentabili pugliesi, quelli che, in base al codice etico dei loro partiti o dei partiti al cui candidato sono collegati non avrebbero potuto presentare la loro candidatura?
Attenzione! Siamo di fronte al diritto di tutti i candidati ad essere considerati persone perbene fino all’ultimo grado di giudizio.
Uno di loro è semplicemente indagato, gli altri sono stati assolti dalle accuse in primo grado, anche se i pm poi hanno fatto ricorso. Nessuno di loro è incandidabile, secondo la legge Severino, e tutti e quattro fossero votati potrebbero fare i consiglieri regionali.
Il primo è l’imprenditore Fabio Ladisa della lista «Popolari con Emiliano» che appoggia il candidato del Pd ed ex sindaco di Bari, Michele Emiliano. La Commissione precisa che «è stato rinviato a giudizio per furto aggravato, tentata estorsione (e altro), commessi nel 2011, con udienza fissata per il 3.12.2015». Imputato, non condannato.
Con Schittulli c'è Enzo Palmisano, medico, accusato per voto di scambio (anche se poi il procedimento era andato prescritto). Prescrizione non vuol dire condanna, ma scelta legittima di economia processuale.
Con Schittulli c'è Massimiliano Oggiano, commercialista, della lista «Oltre» (per lui accuse attinenti al 416 bis e al voto di scambio con metodo mafioso, è stato assolto in primo grado e pende appello, la cui udienza è fissata per il 3 giugno 2015). Assolto, quindi innocente.
Giovanni Copertino, ufficiale del corpo Forestale in congedo, accusato di voto di scambio (anche se poi era stato tutto prescritto, contro tale sentenza pende la fase di appello ), consigliere regionale Udc è in lista invece con Poli-Bortone. Prescrizione non vuol dire condanna, ma scelta legittima di economia processuale.
C’è un solo caso davvero incomprensibile: quello del candidato Pd alla presidenza della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Per legge non potrà fare né il consigliere regionale, né il presidente della Regione Campania. Se venisse eletto il giorno dopo non potrebbe nemmeno mettere piede in consiglio regionale. Vittima, anch'egli di una legge sclerotica voluta dai manettari. Legge che ha colpito proprio loro, i forcaioli, appunto Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, e Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e già dell’IDV di Antonio Di Pietro. Sospesi per legge, ma coperti temporaneamente dal Tar. Tar sfiduciato dalla Cassazione che riconosce il potere al Tribunale.
Con le liste di proscrizione si ha un regolamento politico di conti che nulla ha a che vedere con la legalità, spiega Mattia su “Butta”. La legalità la stabilisce la legge, non Rosy Bindi. Se la legge vigente non piace, liberissimi in Parlamento di modificarla affrontando l’opinione pubblica. Ma non è giusto mettere un timbro istituzionale su una cosa illegale come quella che sta facendo oggi la commissione antimafia. Illegale perchè va contro ed oltre la legge vigente, e non può farlo una istituzione. Non una istituzione, che per altro si è ben guardata dall’inserire nell’elencone degli impresentabili qualcuno macchiato del reato tipico dei consiglieri regionali: il peculato, la truffa sui contributi ai gruppi consiliari. L’avessero fatto, non ci sarebbero state elezioni...
Un privato cittadino può anche dire in giro che Tizio o Caio sono impresentabili perché X, ma rimane un suo giudizio personale. Già di suo è un giudizio scorretto: al massimo puoi dire che Tizio non deve essere eletto, non che è impresentabile. Puoi cioè invitare la gente a non votarlo (così come fai con tutti i candidati che non ti garbano) ma non è corretto dire che non dovrebbe essere nemmeno presentato. Può presentarsi eccome: in democrazia non c’è nessuno che è meno degno di presentarsi.
Forse non si percepisce la gravità di questo precedente. Il fatto che un pezzo di parlamento, ossia una istituzione che avrebbe ben altro da fare, come cercare la mafia nell’antimafia, si arroghi il diritto di indicare alla popolazione chi è degno di essere eletto e chi no in base ai propri gusti e non a una legge dello Stato è aberrante. Uscire l’ultimo giorno di campagna elettorale ad additare, con la forza di una istituzione, un tizio gridando “vergogna! è un X! non votatelo” senza dare al tizio la possibilità di difendersi allo stesso livello è preoccupante. Il metodo Boffo delle elezioni.
In questo modo avremo come impresentabili tutti quelli indicati da Filippo Facci.
1) Quelli condannati in giudicato;
2) No, quelli condannati in Appello;
3) No, quelli condannati in primo grado;
4) Basta che siano rinviati a giudizio;
5) Basta che siano indagati;
6) Sono impresentabili anche gli assolti per prescrizione;
7) Anche gli assolti e basta, ma "coinvolti" (segue stralcio di una sentenza);
8) Sono quelli che sarebbero anche gigli di campo, ma sono amici-parenti-sodali di un impresentabile;
9) Sono quelli che, in mancanza d'altro, sono nominati in un'intercettazione anche se priva di rilevanza penale;
10) gli impresentabili sono quelli che i probiviri del partito e lo statuto del partito e il codice etico del partito e il comitato dei garanti (del partito) fanno risultare impresentabili, cioè che non piacciono al segretario;
11) Sono quelli a cui allude vagamente Saviano;
12) Sono quelli - sempre innominati, sempre generici - che i giornali definiscono "nostalgici del Duce, professionisti del voto di scambio in odore di camorra";
13) Sono quelli - sempre innominati, sempre generici - di cui parlano anche il commissario Cantone e la senatrice Capacchione, e ne parlano pure i candidati che invece si giudicano presentabili, i quali dicono di non votare gli impresentabili;
14) Gli impresentabili sono quelli menzionati da qualche giornale, che però sono diversi da quelli nominati da altri giornali;
15) Sono i voltagabbana;
16) Gli impresentabili sono quelli che sono impresentabili: secondo me.
Come Me. E così sia.
Chi sventola cappi finisce impiccato sui suoi patiboli. Il comportamento della commissione Antimafia non è meritorio e tantomeno pericoloso. È un demenziale passo in avanti lungo la strada dell'intolleranza, scrive Arturo Diaconale su “Il Giornale”. A differenza di quanto ha sostenuto Raffaele Cantone non trovo per nulla meritoria la decisione della commissione Antimafia presieduta da Rosy Bindi di emettere liste di proscrizione di presunti «impresentabili» alla vigilia delle elezioni regionali di domenica prossima. E, sempre a differenza di quanto affermato dal presidente dell'autorità Anticorruzione non considero soltanto «pericoloso» che a dare patenti di presentabilità sia una autorità politica e non una autorità giudiziaria. In realtà il comportamento della commissione Antimafia non è meritorio e tantomeno pericoloso (ma Cantone si rende conto della contraddittorietà delle sue affermazioni?). È un demenziale passo in avanti lungo la strada dell'arbitrio, della prevaricazione, dell'intolleranza. In una parola verso il trionfo di un giacobinismo terroristico incompatibile con il sistema democratico e funzionale ad ogni tipo di avventura autoritaria. La Costituzione stabilisce che la linea della presentabilità o meno di un cittadino nella vita pubblica è fissata dalla presunzione d'innocenza. Se si è condannati in via definitiva si è «impresentabili». Prima di questa condanna si continua ad essere titolari dei diritti civili e politici. Ma questa linea, che è quella della verità giudiziaria, è stata superata da tempo. L'egemonia giustizialista degli ultimi vent'anni l'ha ridotta a reperto archeologico, da considerare abrogata di fatto dalla Carta costituzionale. Ad essa è stata sostituita prima quella della incensurabilità delle persone. Che stabilisce la presentabilità o meno a seconda se si sia incensurati o no a prescindere dalla gravità dei reati. Una linea che è sempre legata alla «verità giudiziaria». E, successivamente, quella della eticità e della moralità del comportamento delle persone. Linea che supera il confine fissato dai giudizi della magistratura, che comunque debbono rispondere ai criteri della equanimità, della terzietà, dell'oggettività, e stabilisce che la presentabilità debba discendere dal giudizio etico e morale dato da una opinione pubblica normalmente influenzata dal circuito mediatico-giudiziario. Con la presentabilità dipendente da un giudizio etico e morale siamo già ampiamente fuori del perimetro costituzionale. Ma con la scelta della commissione Antimafia di stilare liste di proscrizione si compie un salto più lungo e decisivo. Si stabilisce che la linea della presentabilità è data dalla verità politica. Una verità che non risponde mai ai valori ma sempre alle convenienze. Che per definizione non può mai essere equanime, terza, oggettiva ma sempre di parte. Che dipende da maggioranze variabili, occasionali, aleatorie. E che, soprattutto, viene regolarmente imposta da chi urla più forte e sventola più minacciosamente cappi, forche e manette per suggestionare una opinione pubblica naturalmente portata, in tempi di crisi, a scaricare le sue paure e tensioni sui facili capri espiatori. È dai tempi di Gesù e Barabba che la verità politica provoca aberrazioni. Rosy Bindi, che si dice cattolica, dovrebbe ricordarlo. E chi lo ha dimenticato dentro la commissione Antimafia in nome di un giacobinismo strumentale e da operetta non solo dovrebbe tenerlo a mente ma anche non dimenticare mai che a lungo andare i giacobini intolleranti finiscono con salire sui patiboli da loro stessi impiantati. I puri hanno sempre in sorte di trovare i più puri che li epurano!
Una legge contro la proscrizione, scrive Maddalena Tulanti su “Il Corriere del Mezzogiorno”. Brutta giornata ieri per i candidati presidenti alla regione Puglia. Rosi Bindi, presidente della commissione antimafia, ha reso noto (per la verità nel suo staff dicono che c’è stata la solita fuga di notizie) i nomi dei candidati pugliesi che sarebbe stato meglio non mettere in lista, i cosiddetti “ impresentabili”, e sono stati dolori per Emiliano, Schittulli e Poli Bortone. Ne sono stati individuati 4, due sono schierati nel movimento di Schittulli, 1 per Poli Bortone e 1 per Emiliano. I soliti malpensanti si sono chiesti come mai sono usciti solo i nomi dei candidati pugliesi e qualcuno addirittura ha lasciato intendere che dopo la sparata di Emiliano contro la presidente Bindi di qualche giorno fa era il minimo che il quasi governatore si potesse aspettare. Noi non ci crediamo, riportiamo il pettegolezzo solo per far comprendere quanto il clima si stia avvelenando mano a mano che ci avviciniamo alla giornata del voto. I nomi degli “impresentabili” li avrete letti nelle cronache, evitiamo di farli di nuovo e non a caso. A noi le liste dei cattivi non sono mai piaciute, nemmeno a scuola quando la maestra ci chiedeva di farlo mentre lei si assentava. Come quelle di proscrizione, queste liste sono sempre fatte a fin di bene, per mantenere o un ripristinare l’ordine costituito, e abbiamo imparato da tempo quanto inferno può nascondersi dietro a un bisogno di paradiso. Detto questo, non è che ci piaccia che le liste, quelle elettorali stavolta, siano formate senza badare a chi ci fa parte, contando soprattutto sulla “quantità” dei voti che un candidato/una candidata è capace di portare invece che sulla “qualità” di quello che egli/ella rappresenta. Che si fa allora? Si fa finta di niente o si accetta il disonore pubblico? Non si può fare finta di niente, è evidente. Se la commissione antimafia si è messa a spulciare ogni lista presentata in tutte le regioni in cui si vota è probabile che il sospetto che si eleggano persone colluse con poteri criminali o semplicemente che hanno avuto a che fare con la legge, esiste eccome. Quindi ben venga la ricerca delle pecore nere. Ma non per questo si deve agire con l’accetta. Siamo di fronte a un equilibrio delicatissimo, da una parte c’è il diritto a essere considerato una persona perbene fino all’ultimo grado di giudizio; dall’altro bisogna garantire a chi si reca alle urne la certezza che su nessuna delle persone scese in campo possa essere sollevato un dubbio di nessun genere. Insomma se ne esce in un unico modo, attraverso la legge. Si cambino le regole, si decida chi può essere candidato e chi no in maniera più severa. E poi solo silenzio.
Le liste di proscrizione. La bomba illegale della Bindi sulle elezioni amministrative 2015, scrive Magazine Donna. Con una scelta che dire grottesca è poco, Rosy Bindi e la sua commissione parlamentare antimafia venerdì 29 maggio 2015 – a quarantotto ore dalle elezioni regionali – compileranno una lista di proscrizione elencando i politici inseriti in lista dai vari partiti e accettati dagli organi di controllo che invece sarebbero «impresentabili» in base a un fragile codice di buona condotta. La Bindi e i suoi avrebbero dovuto rendere nota quella lista ieri, ma hanno litigato un bel po’ in ufficio di presidenza e dopo ore hanno offerto due sole sentenze: in Liguria nessun candidato è risultato «impresentabile», e in Puglia invece ce ne sarebbero 4, rigorosamente bipartisan: Giovanni Copertino (Forza Italia, circoscrizione Bari); Fabio Ladisa (Popolari per Emiliano, circoscrizione Bari); Massimiliano Oggia-no (Oltre con Fitto, Schittulli presidente, circoscrizione Brindisi) e Enzo Palmisano (Movimento politico per Schittulli, area popolare, circoscrizione Brindisi). I soli quattro nomi apparsi nella prima bozza della lista di proscrizione fan ben capire come l’operazione sia squisitamente politica, probabilmente mira a Matteo Renzi e ai suoi candidati (la Bindi fa parte della minoranza del Pd), e di tecnico abbia ben poco. Tutti e quattro i candidati pugliesi ritenuti «impresentabili» hanno effettivamente avuto problemi con la giustizia in passato. Uno di loro è semplicemente indagato, gli altri sono stati assolti dalle accuse in primo grado, anche se i pm poi hanno fatto ricorso. Nessuno di loro è incandidabile secondo la legge Severino, e tutti e quattro fossero votati potrebbero fare i consiglieri regionali. Siccome la legge c’è, e viene applicata, la Bindi e l’ufficio di presidenza dell’antimafia sanno benissimo che qualsiasi candidato bolleranno come «impresentabile» venerdì prossimo (con un pessimo servizio anche agli elettori, visto che glielo dicono a cose ormai fatte), non lo sarà affatto: per la con-testatissima e dura legge vigente, saranno tutti sia presentabili che eleggibili. Senza stare a girare troppo intorno, c’è un solo caso davvero incomprensibile: quello del candidato Pd alla presidenza della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Per legge non potrà fare né il consigliere regionale, né il presidente della Regione Campania. Se venisse eletto il giorno dopo non potrebbe nemmeno mettere piede in consiglio regionale: perchè mai Renzi ha accettato quella candidatura e si è speso addirittura a fare campagna elettorale per un candidato-fantasma? Questa è l’unica domanda lecita che si potrebbe fare, tutto il resto fa parte di un regolamento politico di conti che nulla ha a che vedere con la legalità. La legalità la stabilisce la legge, non Rosy Bindi. E per fortuna è così, visto il tipino peperino. Se la legge vigente non piace, liberissimi in Parlamento di modificarla affrontando l’opinione pubblica. Ma non è giusto mettere un timbro istituzionale su una cosa illegale come quella che sta facendo oggi la commissione antimafia. Illegale perchè va contro ed oltre la legge vigente, e non può farlo una istituzione: i presidenti delle Camere dovrebbero intervenire e fermare quello che sembra più che altro un regolamento di conti interno ai vari partiti politici. Si può giudicare «politicamente» impresentabili dei candidati anche incensurati, o che abbiano su di loro il sospetto di una inchiesta allo stato iniziale. Questa è scelta legittima se fatta in una polemica politica, in un editoriale, in una battaglia giornalistica. Non da una istituzione, che per altro si è ben guardata dall’inserire nell’elencone che fa diventare «impresentabile» qualcuno il reato tipico dei consiglieri regionali: il peculato, la truffa sui contributi ai gruppi consiliari. L’avessero fatto, si faceva prima a buttare via tutte le liste e rinviare le regionali a migliore occasione…
Precedenti da far rabbrividire, scrive Mattia su "Butta". Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. (art. 49 della costituzione italiana). Mi sa che questa cosa degli impresentabili sia un po’ sfuggita di mano. Ci sono delle regole stabilite dalla legge che definiscono i criteri che vietano eleggibilità e candidabilità. Se un cittadino regolarmente iscritto alle liste elettorali non si trova in nessuna di queste condizioni si può candidare. Punto. Un privato cittadino può anche dire in giro che Tizio o Caio sono impresentabili perché X, ma rimane un suo giudizio personale. Già di suo è un giudizio scorretto: al massimo puoi dire che Tizio non deve essere eletto, non che è impresentabile. Puoi cioè invitare la gente a non votarlo (così come fai con tutti i candidati che non ti garbano) ma non è corretto dire che non dovrebbe essere nemmeno presentato. Può presentarsi eccome: in democrazia non c’è nessuno che è meno degno di presentarsi. Ma fin tanto che è la parola di alcuni privati cittadini, per quanto scorretta, tale rimane. Dove hanno perso la testa è stato alla commissione anti mafia. Dicono che entro venerdì usciranno con una lista di candidati impresentabili. Ohi, non sto parlando di privati cittadini, ma di una istituzione. Un pezzo del parlamento che si riunisce e fa la lista dei candidati che sono degni e dei candidati che sono non degni. Una roba da far rabbrividire i capezzoli. Ah, ma dicono, le indicazioni non sono vincolanti! E ci mancherebbe altro. Figuriamoci se un organo politico come un pezzo di parlamento avesse il diritto di decidere di espellere dalle liste chi non gli garba. Eh, però – aggiungono – si limitano ad applicare il codice di autoregolamentazione dei partiti. Che però ha il valore legale di un peto. I partiti (o meglio, alcuni partiti) possono anche trovarsi un pomeriggio sotto un albero e fare un pinchi suee decidendo di non candidare chi si trova in certe condizioni. Ma tutto il resto del paese non è tenuto a rispettarlo. Se i partiti vogliono che chi si trova nelle condizioni di Caio non sia candidabile approvino una legge in parlamento che dice proprio questo. Quando sarà legge dello Stato tutti saremo obbligati a rispettarla, ma finché rimane un pinchi suee dei partiti no. Forse non percepite la gravità di questo precedente. Il fatto che un pezzo di parlamento, una istituzione, si arroghi il diritto di indicare alla popolazione chi è degno di essere eletto e chi no in base ai propri gusti e non a una legge dello Stato è aberrante. Uscire l’ultimo giorno di campagna elettorale ad additare, con la forza di una istituzione, un tizio gridando “vergogna! è un X! non votatelo” senza dare al tizio la possibilità di difendersi allo stesso livello è preoccupante. Il metodo Boffo delle elezioni. Oggi fanno la lista di proscrizione in base al loro patto tra partiti (senza valore giuridico), domani si allargheranno e diranno che sono impresentabili quelli che hanno fatto un provino per il Grande Fratello o che nella vita fanno gli operai. Se ci fosse un presidente della repubblica degno di questo nome avrebbe già preso il telefono, avrebbe chiamato la Bindi e le avrebbe detto “senti Rosaria, adesso tu prendi un quaderno, penna e calamaio e scrivi 500 volte l’art. 49 della costituzione. Poi quando hai finito me lo porti al colle e mi prometti di non fare più certe stronzate, ok?“ Piesse: e non dico niente su quello che dovrebbe fare la Boldrini perché quella mi sa che la costituzione non l’ha neanche mai letta.
La vittoria di Pirro dei nostri politicanti. Con la metà dell'elettorato che va a votare, che è poi lo zoccolo duro della sinistra che voterebbe pecore e porci, chi vince governa con solo con il 30% dei consensi, tanto basta per non cambiare le cose...e poi la chiamano democrazia. La gente non vota perché non si sente rappresentata da quei personaggi che la notorietà mediatica, per essere eletti, l’hanno conquistata per mezzo dei loro gaglioffi che hanno occupato le redazioni di Tv e Carta stampata. Il web può solo produrre un’accozzaglia di personaggi in cerca di autore. Coacervo di idee sinistroidi che si fa movimento e che guarda solo all’aspetto finanziario-economico della debacle della società italiana.
Giampaolo Pansa su “Libero Quotidiano”: "Elezioni? No, inutile delirio. io a votare non ci vado più". Ma si tengono ancora le elezioni in Italia? Se devo stare a quel che leggo sui giornali, sembra di no. Tra due domeniche si dovrebbe votare in sette regioni, ma la battaglia tra i partiti assomiglia sempre di più a un inutile delirio. Sento parlare di futuri presidenti in teoria eccellenti, ma circondati da un corteo di impresentabili. Le cronache politiche diventano bollettini di cronaca nera. Emergono scandali a ripetizione. Dopo il voto, scommetto che in tanti urleranno ai brogli commessi dagli avversari. Se fossi un reduce delle Brigate rosse, mi fregherei le mani: quello che non siamo riusciti a fare noi, l’hanno realizzato i partiti. E senza neppure lasciarsi alle spalle qualche morto ammazzato e un po’ di gambizzati. Ma sono sempre state così le elezioni? Un signore che si chiamava Benito Mussolini le definiva «ludi cartacei». Però lui non aveva bisogno delle urne. Una volta varata la legge Acerbo, la nonna dell’Italicum di Matteo Renzi, inchiodò gli italiani al suo regime. E tirò diritto lungo una strada che avrebbe portato l’Italia verso la catastrofe della seconda guerra mondiale. Dove ci porterà il premier oggi in carica non lo sa nessuno, tanto meno il suo imponente staff di Palazzo Chigi. Dunque voglio rimanere con i piedi per terra. E rievocare le prime elezioni del dopoguerra. Quelle che videro una novità rivoluzionaria: l’irrompere sulla scena politica di una forza strapotente che avrebbe cambiato il volto dell’Italia e deciso a chi sarebbe andato il governo del paese. Questa forza erano le donne. In casa nostra, per secoli non avevano mai votato. Andare alle urne era prerogativa dei maschi, «come il pisciare in piedi», rognava la più giovane delle mie zie. Poi un decreto firmato da Umberto di Savoia il 1° febbraio 1945, tre mesi prima della Liberazione, stabilì che anche le signore potevano presentarsi ai seggi. Il primo effetto fu il raddoppio del corpo elettorale, da 11 a 23 milioni di iscritti alle liste. Un notorio dongiovanni della mia città bofonchiò a una delle sue amanti: «Non immaginavo che foste così tante. Adesso vi monterete la testa, comincerete a fare le preziose e ce la mostrerete con il lanternino!». La più spavalda delle sue morose, gli replicò: «Adesso dovrai votare il partito che ti dirò io. Altrimenti scordati il mio indirizzo». Un altro effetto fu di consentire a mia madre di andare al seggio come non aveva mai fatto. Erano le prime elezioni dell’Italia liberata. Accadde il 31 marzo 1946 e lo scopo era di decidere chi avrebbe amministrato le città. Le urne si aprirono in cinque domeniche diverse e per grandi raggruppamenti. Il motivo era semplice: occorreva presidiare i seggi, ma siccome la forza pubblica era molto scarsa, bisognava lasciarle il tempo di spostarsi da una zona all’altra. Fu una corsa a tappe e si svolse nella più assoluta normalità. Con un’affluenza alle urne assai alta per l’epoca: il 71,6 per cento, un’utopia nell’Italia del 2015. Nella mia città, un comune di 35 mila abitanti in Monferrato, si presentò al voto addirittura l’88 per cento del corpo elettorale. Contribuirono a quel record anche mio padre Ernesto e mia madre Giovanna. Lei era una femminista inconsapevole perché guadagnava più di papà. Lui un uomo dolce, operaio guardafili del telegrafo. L’arrivo di Giovanna al seggio, aperto nelle scuole elementari di via Cavour, fu memorabile. Si era messa in ghingheri come per andare a un matrimonio. In più si fece accompagnare da due giovani clienti che erano uno schianto. Disse alle ragazze: «Tiratevi su le calze, donne, perché dobbiamo mandare al tappeto gli scrutatori, soltanto maschi e di quelli stagionati!». L’ingresso in sezione del Trio Lescano lasciò tutti a bocca aperta. E non avevano ancora visto il cartello che Giovanna aveva appeso alla saracinesca abbassata del suo negozio. Diceva: «La proprietaria di questa modisteria finalmente va a votare per la prima volta. Alla bella età di 42 anni!». Mio padre Ernesto osservò: «Non ti sembra di agitarti un po’ troppo?». Giovanna gli replicò: «Mio caro Netu, oggi il troppo o il poco lo decido io!». Di quelle prime elezioni del dopoguerra ricordo un’armonia sociale che nel 1948 sarebbe svanita a causa dello scontro all’ultimo voto tra la Dc e il Fronte democratico popolare. Pur essendo una tifosa di De Gasperi, mia madre stravedeva per una nipote, figlia dell’ultimo fratello di mio padre, Francesco. Dopo essere andato a lavorare in Argentina, era tornato in Italia e aveva sposato la tredicesima figlia di un pescatore del Po, Giuseppina, detta Pinota. Piccola, mora, occhi vivaci, carattere da comandante, portava in dote soltanto una cosa di valore: la licenza per aprire una trattoria. Nacque così l’Osteria del Ponte, di fronte al Po. Francesco era comunista e quando si trattò di inaugurare la bandiera della sezione di Porta Po, lo fece in pompa magna. E chi era la madrina? Mia cugina Luigina, sedici anni, un viso incantevole, capelli neri lunghi sulle spalle, labbra perfette, sguardo da stendere tre giovanotti. Indossava un vestito intero, con la gonna plissettata che lasciava intuire una silhouette da sballo. Giovanna le aveva suggerito di tenere in mano un bouquet di fiori. Insieme all’armonia, c’era anche molto pragmatismo. Alle comunali del 1946 vinsero i socialisti con sette mila voti. I democristiani ne ebbero appena trecento in meno. Terzi i comunisti. Sindaco della città divenne il socialista Paolo Angelino, professore di inglese, con una data di nascita impossibile da scordare: 1° gennaio 1900. Giovanna confessò a mio padre: «Anch’io ho votato per Angelino». Sorpreso, lui osservò: «Ma non sei una tifosa di De Gasperi?». Lei alzò le spalle: «Che c’entra? Adesso si tratta di rimettere in ordine la città, dopo tanti anni di guerra. Il professor Angelino è l’uomo giusto per riuscire a farlo. Sai come lo chiamano? Pietrischetto Bitumato. E sai perché?». Ernesto sbuffò: «Sei tu quella che sa sempre tutto». Allora mia madre gli spiegò: «Il sindaco controlla di nascosto che i cantonieri lavorino a dovere sulle strade. Arriva a nascondersi dietro le piante o nei portoni e si accerta della consistenza dell’asfalto con la punta della scarpa. Ho fatto bene a votarlo. Quando sceglieremo il Parlamento mi comporterò in un modo diverso». Pietrischetto Bitumato era di un’onestà a tutta prova. Voleva il bilancio sempre in pareggio. Ci teneva al buon nome del municipio di fronte agli elettori che continuarono a votarlo, anche quando si presentò alla Camera dei deputati. Era un socialista colto, ottimo parlatore, lettore infaticabile di buoni libri. Com’era fatale, teneva molto alle sue tre cariche: sindaco, deputato, capo dei socialisti cittadini. Per noi ragazzacci era il Califfo. Quando gli chiedemmo la tessera del Psi, ci cacciò dal suo studio strillando: «Non sono mica matto! In un mese voi mi distruggete il partito!». Che cosa è rimasto di quel tempo? Nulla. Tanto che mi domando se devo ritornare a votare. La mia risposta è che non ci andrò più. Non ho niente da spartire con i partiti di oggi, se non i torti che potrebbero farmi. E adesso il compagno Renzi mi iscriva pure nella lista nera dei gufi e dei rosiconi. Non me ne potrebbe fregare di meno. Giampaolo Pansa.
Più di 5 milioni di italiani con la tangente o la raccomandazione, scrive Paolo Comi su “Il Garantista”. C’è una ricerca del Censis, che è stata presentata a Roma, molto interessante su svariati argomenti (la ricerca è sul rapporto tra mondo produttivo e pubblica amministrazione) e che ci fornisce in particolare un dato sul quale sarà giusto riflettere. Questo: quattro milioni e mezzo di italiani ammettono di avere fatto ricorso a una raccomandazione per ottenere una maggior velocità (e un buon esito) alle pratiche disperse nei meandri dell’amministrazione pubblica. E addirittura 800 mila ammettono di avere fatto un regalino a dirigenti e funzionari per avere in cambio un atto dovuto. Regalino, a occhio, è qualcosa di simile alla tangente. Le cifre poi vanno lette bene. Se quattro milioni e mezzo ammettono, è probabile che altri quattro milioni e mezzo non ammettono. E così per gli 800 mila. Le cifre vere potrebbero essere 9 milioni di raccomandazioni e un milione e seicentomila piccole tangenti. Se consideriamo che non tutta la popolazione attiva (e cioè circa 40 milioni di persone) ha avuto bisogno di velocizzare pratiche nella pubblica amministrazione (diciamo circa la metà) otteniamo questo rapporto: su 20 milioni di persone che hanno avuto problemi con la pubblica amministrazione, 9 milioni hanno fatto ricorso a una raccomandazione, perché conoscevano qualcuno, un milione e seicentomila ha pagato una tangente, altri 9 milioni e quattrocentomila se ne sono stati buoni buoni in fila ad aspettare. E’ abbastanza divertente intrecciare questi dati coi dati su coloro che chiedono più rigore, più pene, severità e ferocia contro la corruzione. Corrotti, corruttori e “punitori” di corruttori e corrotti, spesso, sono la stessa persona. La ricerca del Censis ci consegna una realtà nitida e incontrovertibile: almeno la metà degli italiani fa uso di forme soft di corruzione. E le forme, probabilmente, sono soft perché non esistono le possibilità che siano hard. Perché questi nove milioni non hanno né potere né soldi. Naturalmente di fronte a questo dato si può dire: colpa dei politici che danno il cattivo esempio. Beh, questa è una stupidaggine. Non c’è un problema di cattivo esempio, perché anzi, da almeno vent’anni, i politici e i giornalisti e tutti i rappresentanti delle classi dirigenti, delle professioni, dei mestieri e della Chiesa, non fanno altro che indicare la corruzione come il peggiore dei mali che ammorba la nostra società. Il problema è che spesso, gli stessi, ricorrono in qualche modo alla corruzione e non si sentono per questo incoerenti. Qualche caso un po’ clamoroso di ipocrisia è saltato fuori recentemente dalla cronaca, fior di imprenditori antimafia e anticorruzione presi con le mani nel sacco. La gran parte dei casi però non emerge. Potete star sicuri, ad esempio, che una buona parte degli opinionisti, dei giornalisti e dei politici che tutti i giorni si impancano e vi fanno la lezione di moralità, qualche mancetta l’hanno lasciata, qualche pagamentino in nero lo hanno accettato, qualche rimborso spese di troppo… L’altro giorno, in una intervista divertentissima, il vecchio Pippo Baudo raccontava, sorridendo, di quando il principe dei moralizzatori, Beppe Grillo, si faceva pagare dalla Rai il rimborso spese per il soggiorno a Roma, se lo metteva in tasca, e poi andava a mangiare e a dormire a casa di Pippo. Il vecchio Baudo se la rideva, e ha anche raccontato di quel giorno che Beppe gli ha detto: «Magari, per sdebitarmi, lascio una mancia alla Nena». La Nena era la donna di servizio di Baudo, e Baudo subito ha detto a Beppe che gli pareva un’ottima cosa, e gli ha chiesto quanto pensava di lasciarle. Grillo, vecchio genovese, ha risposto: «Che dici, cinquemila?». «Non sarà troppo?, gli ha ribattuto, ironico, Pippo Baudo. E allora Grillo ha sentenziato: «No, meno di 5000 no, allora è meglio niente». E non gli ha lasciato niente… Così il rimborso se l’è preso tutto intero. Non sarà colpa dell’esempio, ma comunque è colpa dei politici. La raccomandazione e la tangente sono un frutto del modo nel quale è organizzata la vita pubblica. E i politici di questo sono responsabili. La mancata trasparenza (nella pubblica amministrazione come negli appalti) è la causa vera della corruzione. Perché la rende possibile e perché la rende indispensabile. Però di tutto questo frega poco a tutti. Prendiamo la questione degli appalti. E’ chiaro come l’acqua che il sistema complicatissimo vigente (in Italia ci sono oltre 30 mila stazioni appaltanti, e non si sa a chi rispondano, e non si sa chi decide, e ognuna adopera criteri tutti suoi per valutare, e non sia sa chi e come può controllare ed eventualmente indagare) consegna poteri discrezionali enormi a un certo numero di persone e -spesso – ad alcuni politici. Che naturalmente esercitano questo potere. Alcuni, meritoriamente, in modo onesto – ma perché sono disperatamente onesti loro, incorruttibili – alcuni in modo meno onesto, o comunque traendone qualche utilità. Moltissime volte l’appalto viene assegnato senza gara. Altre volte col sistema del ribasso dei prezzi, che è un sistema assurdo perché consegna un potere immenso a chi decide e presuppone un rapporto forte e sregolatissimo tra impresa e stazione appaltante. Dovrebbe essere abbastanza chiaro che, in seguito a una perizia seria, si può stabilire che costruire in quel luogo una scuola con certe caratteristiche e di una certa grandezza costa una cifra tot. Diciamo 10 milioni. L’appalto non può essere dato a chi chiede meno. Se uno mi offre di fare quella scuola a 5 milioni, mi sta fregando. O pensa di fare la scuola con la carta pesta, o pensa di farla piano piano e che tra due anni chiederà una revisione prezzi e otterrà 15 milioni ( e poi magari la farà lo stesso di carta pesta…). L’appalto deve essere concesso a una cifra fissa all’azienda che da le maggiori garanzie. E da un numero ridottissimo e quindi controllabile di stazioni appaltanti. Se fosse così sarebbe molto difficile corrompere qualcuno. E la stessa cosa per le pratiche della pubblica amministrazione. Vanno semplificate, spesso abolite, deburocratizzate e risolte in tempi certi. Ottenere qualcosa del genere sarebbe una riforma seria. Una riforma dello Stato molto, molto più utile e profonda dell’abolizione del Senato e roba simile. Perché nessuno le chiede queste leggi? Perchè la politica e l’intellettualità italiana sono nelle mani di un cerchio magico (che si è costruito, trasversale, attorno al triumvirato Anm-Travaglio- Salvini) il quale se ne frega delle riforme e chiede solo pene severe. Per loro non contano le leggi, le idee, contano gli anni di carcere e basta. Adesso hanno stabilito che la pena massima per la corruzione sale da otto o dieci anni. E sono felici, e brindano, e sentono le manette tintinnare allegre. Riforma forcaiola e inutile. Il problema non è di tenere un povero cristo in prigione per due anni di più, il problema è di rendergli impossibile la corruzione. Ma questa idea non piace a nessuno. Non piace a Salvini, non piace a Travaglio, non piace all’Anm, non piace, probabilmente, neanche a Renzi, e nemmeno ai 4 o 9 o 10 milioni di italiani delle raccomandazioni e dei regalini. A loro piace solo sapere che impiccheranno Lupi con una corda d’oro.
Manifestare e Devastare in città? Un Reato ampiamente impunito!
Negozi, banche, auto in fiamme, vetrine infrante, gente e turisti in fuga terrorizzati, scontri con la polizia, alcuni agenti feriti. E' sfociata in terrore e devastazione nel cuore della città la giornata inaugurale di Expo, l'evento universale inaugurato l'1 maggio 2015, a Milano. Al corteo del No Expo Mayday Parade organizzato nel pomeriggio. Come temuto ed ampiamente previsto, hanno preso il sopravvento i pochi black bloc e le fasce più violente e la manifestazione è presto degenerata.
La polizia nei giorni precedenti ha sfoggiato mediaticamente il suo impegno, mostrando alle telecamere qualche arnese atto ad offendere rinvenuto in una casa occupata dai "No Tav", tacitando così le preoccupazioni dei milanesi. Una delle tante case di proprietà occupate abusivamente da tante sigle vicine alla sinistra.
Circa la violenza unilaterale dei manifestanti scoppiata a Milano ognuno dice la sua. A destra sono pronti a solidarizzare con le forze dell'ordine, a prescindere dal loro operato; a sinistra sono dediti a rimarcare e difendere il diritto a poter manifestare il proprio punto di vista, scambiando la locuzione con “ogni mezzo”, appunto, anche con l’uso della violenza, usata spesso contro i beni di quei lavoratori, che a parole dicono di rappresentare. Quella sinistra che si riempie la bocca del termine “Legalità”, fino ad ingozzarsi, fino a soffocarsi.
Chiediamo cosa ne pensa lo scrittore Antonio Giangrande, che, autore della collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", con decine di saggi pubblicati su Amazon, Google libri, Lulu e Create Space, dice la sua, invece, rispetto al diritto ed agli interessi dei cittadini danneggiati e trascurati.
«La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici. Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni.
Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: Art. 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
La libertà di espressione è sancita anche dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848: “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.”
La Costituzione italiana del 1948 supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all'art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Durante il periodo fascista queste leggi dello Stato diventeranno delle censure, tipiche dei regimi totalitari. L'art. 21 della Costituzione stabilisce che:
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
Ebbene, in Italia, se scrivi in stato di disomologazione al sistema mediatico o in dissenso al sistema di potere, a cui la stampa è genuflessa, i giudici te la fanno pagare.
Ma con il paraculo del diritto di manifestare in piazza si genera la più grande sorta di illegalità impunita che il paese ricordi. E dire che queste manifestazioni si palesano proprio come protesta contro le illegalità. Ognuno di noi che volesse commettere reati a iosa, sicuri di farla franca, basterebbe partecipare ad una manifestazione organizzata, spesso, dalla sinistra e l’impunità è compiuta.
"Abbiamo spaccato un po' di roba", è giusto così. A parlare è un ragazzo intervistato dalla troupe di TgCom24. Nessuna paura di ammetterlo e nessuna giustificazione, anzi, per lui è solo “bordello”. "Siamo arrivati, c'era un bordello, abbiamo spaccato un po' di roba", ha ammesso. Il giornalista chiede il perché e la sua risposta è secca: "Perché è la protesta, e alle proteste si fa bordello. È giusto così, noi dobbiamo far sentire la nostra voce. Se non lo capiscono con le buone, lo capiranno in altro modo. È stata una bella esperienza. Ero solo in mezzo a una guerriglia e mi sono preso bene, ma non ho distrutto un cazzo di nulla".
Eppure nelle manifestazioni di piazza ci sono talmente tante violazioni del codice penale che ne basterebbe una a far scattare l’arresto.
Dispositivo dell'art. 419 Codice Penale: "Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito". E poi quante violazioni penali cerchi, tante ne trovi. E comunque basta il sol travisamento a far scattare le manette.
Genova, sette studenti condannati per travisamento ad una manifestazione contro la Gelmini, scrive Genova Today. Una sciarpa che copre il volto per sfuggire all'occhio "invadente" delle telecamere Digos. Una mano sulla bocca per non respirare l'odore acre dei lacrimogeni. O un cappello "tenuto basso" per non essere del tutto riconoscibili: scene classiche da manifestazioni. Scene che da oggi potrebbero essere punite con il carcere. E' questo, in soldoni, quello che prevede una condanna del tribunale della Procura di Genova che ha disposto pene variabili fra i nove e i quattordici mesi per sette persone accusate di resistenza e "travisamento". Gli accusati, sette studenti liguri che parteciparono ad una manifestazione del 30 novembre 2010 contro l'allora ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, sono stati condannati per avere nascosto il proprio volto nelle fasi calde del corteo. Tradotto: la Procura non ha accertato che i sette ragazzi in questione abbiano partecipato a scontri o disordini, dato che nella sentenza non vi si fa riferimento, ma li ha condannati "semplicemente" perché si sono resi non riconoscibili. Nello specifico, le condanne fanno riferimento ai momenti successivi ad una carica della polizia. Azione che gli agenti non annunciarono, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del Tulps, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede la "intimazione formale al discioglimento di un corteo". Agli avvocati dei giovani, che avevano puntato su questa "mancanza" da parte delle forze dell'ordine, il pubblico ministero Biagio Mazzeo ha spiegato che "si tratta di un provvedimento desueto e comunque, con tutti i tagli che devono subire le forze dell'ordine probabilmente non avevano neppure la possibilità di portarsi dietro un megafono". Insomma, condanna sia. Condanna, giunta pochi giorni fa, che rischia di inaugurare una giurisprudenza alquanto pericolosa. Appare troppo sottile, infatti, il confine fra la giusta necessità di punire i manifestanti facinorosi e l'eccesso di condannare chiunque si renda irriconoscibile durante una manifestazione. Ma non è tutto. Sotto la Lanterna, infatti, sono in corso almeno un'altra decina di indagini su cortei e proteste simili, riguardanti in particolare lo sciopero del 6 maggio 2011 e il corteo del 28 gennaio che vide in piazza studenti e operai al grido di "noi la crisi non la paghiamo". Le indagini, a questo punto sembra scontato, si chiuderanno con un processo e con altre condanne. Ma anche qui, la procura ligure potrebbe stupire. Oltre alle "storiche" pene per travisamento, infatti, molti dei ragazzi indagati, fra "anarchici noti" e semplici studenti, rischiano una somma di condanne e quindi il carcere per la "reiterata partecipazione a cortei". Insomma, i giovani che abbiano partecipato a più di una delle proteste finite nel mirino della procura rischiano le manette, perché colpevoli in più di un'occasione di "travisamento", anche se i cortei nella realtà non si siano trasformati in guerriglia. Le condanne di questi giorni, comunque, non stanno stupendo più di tanto Genova, una città che, da due anni a questa parte, ha subito una "gestione giudiziaria della piazza". Per l'esattezza da quando, un paio di anni fa, il procuratore aggiunto Vincenzo Scolastico elaborò una "griglia" nella quale incrociare date dei cortei, nomi dei partecipanti, denunce e qualsiasi manifestazione dove la Digos avesse ripreso delle immagini. A quanto pare, la "griglia" sta cominciando a dare i suoi effetti.
Invece a Milano la polizia che fa: niente!!!
E non è certo l’alibi della nuova legge sulla tortura che li sprona a rimanere inermi di fronte alla commissione di reati, né può essere colpa degli agenti che, oltretutto, sono i primi a prender botte da manifestanti, spesso, figli di papà o figli proprio di quelle istituzioni che dovrebbero reprimere e condannare i reati.
E non sono certo gli agenti a mancare. Questo passerà alla storia come il primo maggio più lungo di sempre. Complice l'inaugurazione di Expo 2015, 6.000 uomini delle forze dell'ordine italiane sono stati mobilitati per evitare che chi vuole rovinare la festa dei lavoratori sia fermato senza conseguenze. Avendo gli occhi del mondo puntati sull'area in cui si svolgerà l'esposizione universale, una falla nella sicurezza dell'evento non può essere permessa. Per questo il Viminale ha inviato 3796 uomini di rinforzo ai reparti già mobilitati su Milano, per l'intera durata della manifestazione. Queste forze aggiuntive andranno a sommarsi ai 2.000 addetti già disposti in città per i prossimi giorni, che si preannunciano da bollino rosso.
Eppure qualche centinaio di black bloc ha sopraffatto la forza dello Stato. Alla fine il bilancio dei numeri è di 11 feriti tra le forze dell'ordine e zero tra i violenti criminali manifestanti, oltre che 10 antagonisti accompagnati in questura. Cinque gli arresti in flagranza eseguiti dalle forze dell'ordine. Durante i disordini avvenuti a Milano al corteo No Expo sono stati lanciati 400 lacrimogeni. Il dato è stato fornito dalla Questura. Un risultato risicato a favore della polizia. Un po’ troppo poco per il costo subito dei danni subiti e il costo per mantenere tutta la struttura per proteggere la città.
E non credo che la colpa sia degli agenti, ma, forse, visti i risultati è colpa di chi li comanda? Non mancano le voci critiche, come quella di Matteo Salvini che si chiede "Renzi e Alfano, i danni ai cittadini li pagate voi?". E così pensa la gente.
C'è la rabbia della gente, tra le reazioni allo scempio che i No Expo hanno fatto questo pomeriggio a Milano scrive Libero Quotidiano il primo maggio 2015. Auto incendiate, cassonetti rovesciati, negozi dati alle fiamme, vetrine sfondate. Danni per milioni di euro. E la polizia che resta a guardare gli antagonisti che sfasciano tutto, limitandosi a contenere l'avanzata dei vandali e impedendogli di accedere alla zona rossa del centro. Una strategia assai diversa da quella adottata quattordici anni fa a Genova in occasione del G8. E la rabbia della gente esplode, pensando alle tante sentenze dei giudici contro la polizia (l'ultima quella sulla scuola Diaz) e l'introduzione del reato di tortura. "Attendere! Potrebbe scattare il reato di tortura!!!" scrive Vittorio. "Sono manifestanti pacifici. Perché fermarli? Sarebbe tortura" aggiunge Vittorio. Karl: "Fa bene a non intervenire...dopo certe sentenze!!!". La polizia ormai è stata disarmata da certe sentenze, dai buonisti, dagli ipergarantisti sinistronzi, da certa stampa e non sentendosi tutelata, resta a guardare in attesa di ordini da parte di organismi superiori anch'essi congelati da certe sentenze". Angelo: "Perché tanta meraviglia? dopo la condanna come torturatori e un capo che invece di difenderli li sospende...dopo giudici che mandano sempre liberi i delinquenti che vengono catturati perché mai i poliziotti dovrebbero rischiare di essere condannati. un piffero disse "non siamo a Beirut" beh siamo peggio....". Maurizio: Quanti dei danneggiati di oggi hanno urlato contro la polizia cilena di Genova? Quanti hanno trattato il povero carabiniere Placanica come uno sfigato (loro, i ricconi radical-chic)? Quanti hanno votato per Heidi Giuliani, madre dell'eroe dei tempi moderni (emblema perfetto del gramo destino d'Italia)? Bene, spero che i danni riguardino solo loro. La polizia non faccia nulla, non meritano nulla". Giovanni: "non possono intervenire se no i giudici li condannano". Rul5646: Naturalmente grande scandalo se la polizia si permettesse di intervenire. Allora certa magistratura, certe esponentesse ed i buonisti in coro si indignerebbero infinitamente". E ancora: "E cosa potrebbero fare di più quei poveracci? Quei bastardi delinquenti sono sacri ed intoccabili per taluni magistrati e per tanti esponenti della politica italiana. Questa è l'Italia comunista!". Cheope: "La polizia aspetta......tanto sa che se anche li prendono, domani per ordine di qualche magistrato li mettono fuori. E intanto ci sono persone che hanno le auto incendiate, negozi sfasciati e tanta paura. E tutto questo con l'Expo non c'entra, è solo terrorismo". Poi c'è chi se la prende con Alfano: A O Anna 17 scrive: "Ma quel cretino di Alfano dove sta? Ah si è dimesso? Che fortuna. No no non si è dimesso, ma che schifo e non si vergogna?".
Appunto i No Expo sfasciano e incendiano, la polizia sta a guardare. Scene già viste tante volte, purtroppo: auto e negozi in fiamme, vetrine spaccate a martellate. Qualche anno fa era toccato a Buenos Aires, questa volta a via Carducci, una delle strade più eleganti e centrali di Milano. Dove i manifestanti No Global hanno bruciato due auto, sfasciato tutto lo sfasciabile e bruciato un paio di negozi con colonne di fumo nero alte decine di metri. Per mezz'ora la strada, lunga circa 500 metri tra corso Magenta e piazzale Cadorna, è rimasta in preda totale ai No Global. le forze dell'ordine sono state a guardare senza fare nulla, senza intervenire, senza impedire la devastazione. Solo dopo mezz'ora un mezzo antincendio è arrivato a spegnere le fiamme delle due auto. E solo a quel punto polizia e carabinieri hanno iniziato a intervenire con cariche e manganelli.
Una gestione "tattica" dell'ordine pubblico, non con l'obiettivo di impedire una quantità inevitabile di devastazione, ma di bloccare l'accesso al centro di Milano al blocco dei violenti senza coinvolgere negli scontri le migliaia di partecipanti pacifici alla May Day Parade contro l'Expo. Questa è stata la strategia messa in campo dalla questura di Milano - in accordo con le disposizioni del ministero degli Interni - per affrontare una giornata che fin dalla vigilia si annunciava assai critica. E che critica alla fine è stata, come vede ripercorrendo le strade del centro di Milano devastate dal passaggio dei Black bloc. Ma che ha portato al risultato che fin dall'inizio i vertici della polizia si erano dati: evitare che il giorno dell'inaugurazione di Expo si trasformasse in una specie di G8, con feriti da una parte e dall'altra. Lo scontro fisico è stato evitato. e poi...dalle 18 del primo maggio piazza della Scala è completamente blindata dalle forze dell’ordine da ogni accesso. Dopo la manifestazione con oltre 20 mila No Expo e trecento black bloc che hanno devastato Milano, la tensione è alta per l’inizio della Turandot, l’opera scelta dal teatro milanese per festeggiare l’inizio di Expo 2015.
Vuoi metter gli "Scalisti" con i cittadini danneggiati dai black bloc? Tutta un'altra musica!
E poi ci siamo noi cittadini, perché lì, a manifestare in piazza, ci vanno anche i nostri figli. Ma le mamme italiane dove sono? Perché non scendono pure loro in strada a prendere a sberle i figli che spaccano le vetrine e devastano le città? Questo si chiede Mario Giordano su “Libero Quotidiano”. Nei giorni scorsi siamo rimasti tutti colpiti da quella signora di Baltimora, di giallo vestita e di sganassoni munita: appena si è accorta che il suo adorato pargolo si era vestito da black bloc per fare a botte con la polizia, non ci ha pensato neppure un attimo. È scesa in strada, l’ha preso per la collottola, l’ha riempito di sberle e l’ha ricondotto sulla via della ragione. Un mito, certo. Ma che cosa impedisce alle mamme italiane di fare altrettanto? Si badi bene: quel che vale per la politica, vale anche per le violenze nello sport e nel calcio in particolare.»
I DEBITI SI PAGANO, ANCHE IN GRECIA !!!
Come si diventava schiavi nell'antica Grecia. Un uomo, se non era nato da genitori schiavi, quindi schiavo dalla nascita, poteva essere ridotto in schiavitù in diversi modi:
Schiavitù per abbandono: bimbi abbandonati su una collina o davanti a un cancello destinati a morire o ad essere raccolti da qualche passante. In quest'ultimo caso spesso venivano cresciuti da chi li trovava e, quando l'età lo permetteva, venivano venduti.
Schiavitù per debiti: un debitore, se non era in grado di rimborsare il proprio creditore, poteva diventare egli stesso una sua proprietà.
Schiavitù etnica: nota in Oriente anche in età ellenistica, di interi popoli sottomessi e ridotti in condizioni simili a quella dei «servi della gleba» (questa era, in Grecia, in età classica, la situazione degli Iloti spartani e dei Penesti tessali).
Schiavitù mercantile: lo schiavo, per lo più prigioniero di guerra, o vittima dei pirati o nato in casa, veniva comprato o venduto.
Schiavitù per guerra (andràpon): chi veniva catturato in battaglia dal nemico diventava bottino di guerra ed era ridotto in schiavitù.
La lezione di Solone, che Schaeuble non ha imparato. Solone e Schaeuble, scrive Roberto Petrini su "La Repubblica". All'appello manca soltanto lui: Solone. Tsipras, nei momenti più drammatici della trattativa nel luglio 2015, ha ricordato la morale che supera la legge dell'Antigone di Sofocle. Nel serrato dibattito culturale che ha accompagnato i giorni di Bruxelles, dove imperava la bassa cucina dei numeri di Wolfgang Schaeublee di Jeroen Dijsselbloem, i forti richiami all'antichità classica greca, culla della ragione e della democrazia, del logos e della polis, Aristotele e Pericle, si sono fatti giustamente sentire. Almeno a mitigare il sordido clima ragionieristico. Ma forse l'associazione più calzante con la storia greca è emersa nelle ultime 48 ore, quando a proposito delle pesanti misure adottate dall’Eurosummit e perorate dalla Germania, si è parlato di provvedimenti draconiani. Ebbene è proprio in quel periodo, intorno al VI-VII secolo avanti Cristo, che la storia segna, proprio ad Atene, una svolta decisiva in materia di debiti e crediti. Allora Dracone, da cui il noto aggettivo, arconte di Atene, varò leggi severissime nei confronti dei debitori, normalmente poveri contadini che erano obbligati a garantire i prestiti ricevuti con la propria libertà o con le proprie figlie: in caso di insolvenza scattava la vendita sul mercato degli schiavi. Fu proprio Solone, uomo probo, poeta e umanista, che succedette a Dracone, a cambiare le cose indirizzandole nel verso giusto. Si occupò di economia, riformò il censo, limitò il lusso e ritenne di punire la disoccupazione volontaria, ma soprattutto si occupò del peso dei debiti che opprimevano le classi povere ateniesi. Per farlo mise in campo una operazione che è passata alla storia come "seisachtheia", ovvero scarico dei pesi: svalutò la dracma del 30 per cento (il peso fu ridotto da 6,27 a 4,36 grammi in modo che si fecero 100 dracme con l’argento equivalente di 73 vecchie monete). I debiti espressi in termini nominali – siamo nel 594 avanti Cristo - diventarono improvvisamente più leggeri. Annotò Plutarco con acume da moderno economista nelle Vite parallele: "I debitori erano grandemente avvantaggiati e i creditori non perdevano nulla". L'inflazione negli anni successivi rilivellò i prezzi, ma nel frattempo i debitori avevano avuto una boccata d’ossigeno. Tanto più che Solone, ricordato come uno dei Sette Sapienti della Grecia, prese un'altra importante decisione: abolì le ipoteche. Nell’antica Atene vennero rimossi i cippi che, conficcati nel terreno, contrassegnavano il bene fornito a garanzia del debitore. Naturalmente ciò indeboliva la forza di riscossione del creditore e, al contempo, proteggeva i più deboli. Il bilancio di Solone, al termine dei suoi giorni, fu sereno e soddisfatto. Disse guardando agli dei: "E molti atheniesi ricondussi nella patria divina che erano stati venduti e espatriati per l'oppressione dei debiti". Della politica monetaria di Solone, fondata sul tentativo di riconciliare debitori e creditori, scrisse la Rivista di storia economica diretta da Luigi Einaudi che paragonò il governatore di Atene a Roosevelt, e lo stesso John Maynard Keynes dedicò un saggio a Solone. Purtroppo l'Europa di oggi non si è ricordata del suo insegnamento.
Debito=colpa. L’analisi. Nella Germania dell’etica protestante i due concetti coincidono, mentre nella lingua di Omero sono lessicalmente distinti È l’emblema di uno scarto storico-culturale che arriva fino a oggi. “Debito” uguale “colpa” quella parola unica che separa i tedeschi dal mondo greco, scrive Silvia Ronchey su "La Repubblica". Che cos’è il debito? In tedesco il sostantivo femminile Schuld designa insieme il debito e la colpa. «Il capitalismo è un culto che non consente espiazione, ma produce colpa e debito», scriveva già nel 1921 Walter Benjamin. La vittoria del no al referendum greco ha richiamato l’attenzione del mondo non solo sulla drammaticità della situazione politica ma anche sul conflitto culturale, sull’antinomia profonda connessa alla concezione del debito nell’evolversi della psiche collettiva: ancora una volta, sull’antica polarità tra Grecia e Germania. Debito e colpa è il titolo di un libro appena uscito (Ediesse, pagg. 240, euro 12) che Elettra Stimilli ha dedicato alla centralità della figura del debito come colpa nell’indebitamento planetario che segna la più recente fase del capitalismo contemporaneo. Le forme di consumo illimitato basate sull’indebitamento privato, partite dall’America, sono diventate, argomenta Stimilli, il motore principale dell’economia. Dal 2009, con l’immediato globalizzarsi della crisi americana, l’aumento esponenziale del debito privato ha coinvolto il debito pubblico dei paesi economicamente avanzati fino ad arrivare ai debiti sovrani. La finanziarizzazione della vita quotidiana, la “democratizzazione del credito”, ha prodotto uno stato di indebitamento generalizzato in cui ognuno, sia come lavoratore sia come consumatore, è diventato per definizione anzitutto debitore. Nella cultura attuale dell’occidente, la parola debito è eminentemente connessa a quell’etica protestante, che già Max Weber vedeva all’origine ideale e psicologica, prima ancora che materiale e sociale, del sistema capitalista, alla cui indubbia efficienza i teorici, da Karl Marx a Joseph Schumpeter, hanno sempre contrapposto, con diversi gradi di perplessità, la difficoltà etica della giustificazione teorica. Se per Max Weber il capitale nella sua forma moderna nasceva dalla concezione calvinista della grazia e del peccato per poi secolarizzarsi in ideologia profana, secondo Benjamin il capitalismo può considerarsi in sé una religione, il culto di un dio minore, privo di dogmi ma dalla legge implacabile. È proprio la connessione religiosa fra debito economico e colpa morale — attinta peraltro a un’intuizione degli scritti giovanili di Marx — che porta il povero insolvente, scriveva Benjamin, «a fare di sé una moneta falsa, a carpire il credito con inganno, a mentire, così che il rapporto di credito diventi oggetto di abuso reciproco». Se in tedesco i concetti di debito e colpa si stringono in uno stesso nodo lessicale, la lingua greca, che sta all’origine del nostro pensiero e della nostra sintassi filosofica, distingue nettamente tra l’uno e l’altra. Nel greco antico, come ancora oggi nel greco moderno, debito si dice chreos , un sostantivo che deriva dal verbo chraomai , “usare”, e dalla locuzione chre , “ciò che serve”, che si usa e di cui c’è bisogno; è inoltre connesso con chreia , la “mancanza”. Il termine chreos viene usato ampiamente dagli storici, come Tucidide, dai filosofi, come Platone, e dai giuristi, fino alle Novelle di Giustiniano e ai Basilika: il greco bizantino assicurerà la continuità e trasmetterà la certezza del diritto romano nel suo transito millenario dall’età antica a quella moderna, attraverso i secoli solo in occidente oscuri del cosiddetto medioevo dominato dal diritto barbarico. Ma la prima attestazione della parola chreos nella letteratura greca è già nell’ottavo canto dell’Odissea, nel passo in cui Efesto incatena Ares e Afrodite dopo averli colti in adulterio. Tutti gli dèi ridono tranne Poseidone, che gli intima di scioglierli. Efesto rifiuta perché, dice, se lo facesse Ares fuggirebbe eludendo insieme due vincoli, quello materiale della catena e quello morale, il chreos, che lo lega ormai a Efesto. Questo secondo legame non è una servitù, impossibile tra dèi, piuttosto una comunanza di destino, un pegno. Il dio della guerra si è indebitato con il dio del fuoco, dell’ingegneria, dei fabbri, di tutti gli artigiani: cedendo all’amore, condividendo il fascino della dea, si è sottomesso al vincolo di un reciproco scambio. Anche altrove il significato del chreos greco sfuma spesso in quello di una comunanza ferrea di destino, di una ineludibile necessità: designa “il debito che tutti devono pagare”, ossia, almeno a partire da Teognide, anzitutto e per definizione la morte. Un’accezione metaforica di chreos che si ritrova lungo tutta la letteratura greca, da Platone alla Sapienza di Salomone tradotta nella bibbia dei Settanta. La distinzione tra debito e colpa è evidente nel Nuovo Testamento, anzitutto in uno dei suoi passaggi più noti: la preghiera del discorso della montagna, che diventerà il padre nostro. Qui il greco della koiné usa, anziché chreos, il più materiale e umile sostantivo ophèilema , che si ritrova in Matteo 6, 12: “rimetti a noi i nostri debiti”. La clamorosa discrepanza dal testo di Luca 11, 4, che ha invece la variante “rimetti a noi i nostri peccati” e usa il ben distinto sostantivo amartìa ha dato luogo a infinite dispute teologiche e fatto sospettare una comune ascendenza dall’ebraico hôb , hôbot , insieme debito e colpa. Ma proprio il fatto che il dettato neotestamentario debba adottare due voci diverse sottolinea l’estraneità dei due concetti nella psiche greca. Lo squilibrio politico generato da un lungo e inestinguibile debito ha un precedente storico nel mondo greco. A provocare la caduta dell’impero di Bisanzio sei secoli fa è stato il debito con la repubblica di Venezia, incarnazione di quel capitalismo nascente che la percezione teologica e filosofica bizantina, erede di quella classica, non sarebbe mai riuscita ad assimilare né a comprendere. L’indebitamento dello stato bizantino con i banchieri dell’occidente spinse le sue élite verso l’oriente. La civiltà bizantina entrò allora nella sfera geopolitica dell’islam ottomano, da cui solo nel XIX secolo la Grecia è emersa.
Il debito inteso come dispositivo di servitù, scrive Gianfranco Sabattini. Il caso della Grecia ha provocato un revival di memorie classiche sulle differenze esistenti tra le culture dei popoli mediterranei e quelli dell’Europa del Nord; differenze, queste, che avrebbero segnato uno scarto storico-culturale che, secondo Silvia Ronchey, esperta di cultura classica, (“’Debito’ uguale ‘colpa’, quella parola unica che separa i tedeschi dal mondo greco”, in “la Repubblica” dell’8 luglio 2015) è arrivato sino ad oggi, segnando in profondità la psiche dei singoli popoli e determinando un conflitto culturale latente “sull’antinomia profonda connessa alla concezione del debito”. Secondo la Ronchey, il sostantivo tedesco “Schuld” designa insieme il debito e la colpa; il duplice significato del sostantivo tedesco sarebbe entrato nella cultura dell’Occidente per via del fatto che il fondamento etico del capitalismo (il sistema di organizzazione della vita materiale più diffuso del mondo contemporaneo, del quale il concetto di debito è parte essenziale) originerebbe, secondo la nota tesi di Max Weber, dall’etica protestante, connessa alla concezione calvinista della grazia e del peccato e secolarizzatasi successivamente in ideologia profana. Quest’ultima, nonostante le difficoltà riscontrate nei tentativi di giustificarla sul piano teorico, è stata la causa, assieme ai successi materiali conseguiti dal modo di produzione capitalistico, dell’introiezione nella psicologica individuale delle implicazioni comportamentali riconducibili a quella concezione della grazia e del peccato. “Se in tedesco – afferma la Ronchey – i concetti di debito e colpa si stringono in uno stesso nodo lessicale, la lingua greca, che sta all’origine del nostro pensiero e della nostra sintassi filosofica, distingue nettamente tra l’una e l’altra. Nel greco antico, come ancora oggi nel greco moderno, debito si dice chreos”: un sostantivo che designa “ciò che serve” e il legame che esso instaura tra debitore e creditore è “una comunità di destino”, e non una posizione di colpa del primo nei confronti del secondo che non ammette una sua espiazione, anche se si trova in difficoltà esistenziali, se non dopo aver pagato il debito. Pena, la dannazione eterna. La narrazione della Ronchey ripropone le idee avanzate dall’antropologo anarchico americano David Graeber (“Debito, I primi 5.000 anni”); notoriamente, questi mostra come l’istituzione del debito sia anteriore alla moneta e come, da sempre, sia oggetto di aspri conflitti sociali. Nell’antichità i sovrani dovevano periodicamente rimediare alla riduzione in schiavitù per debiti di ampie fasce della popolazione, per evitare l’implosione di tutta la società. Da allora, la nozione di debito, secondo Graeber, si è estesa alla religione, come “explicandum” della libertà e dell’asservimento degli uomini. Perché si chiede l’antropologo americano ci si è convinti che i debiti devono essere saldati? Perché questa idea è intesa tanto come una proposizione economica, quanto come un giudizio morale? Perché rimettere i debiti ai propri debitori è un comportamento misurabile in termini di montanti, saldi, penalità e saggi d’interesse? Per rispondere alle domande, secondo Graeber, non basta riconoscere che il debito e l’asservimento di chi non restituisce il dovuto sono tra loro connessi, bensì occorre capire come la forma peculiare dell’asservimento del debitore si trasformi in schiavitù. Il modo più frequente ed efficace di rendere schiavi gli uomini, secondo Graeber, consiste nel renderli debitori. Chi ha bisogno di un prestito, per ottenerlo deve impegnarsi a restituirlo maggiorato dell’interesse, e se si trova nella necessità di dover chiedere un altro prestito, deve anche accollarsi condizioni peggiori per fronteggiare il debito precedente. Pertanto, la ragione economica essenziale per indebitare gli uomini e conservarli schiavi sta nel metterli nella condizione di non poter pagare il loro debito e di spingerli ad entrare in una spirale perversa che li porterà a non appartenere più a se stessi: a diventare schiavi dei creditori. Sarebbe questa la prospettiva cui ricondurre, per un verso, l’interpretazione dell’inerzia dell’Unione Europea sulla via dell’unificazione politica e, per un altro verso, la comprensione dell’iniziativa più conveniente che la Grecia dovrebbe prendere, per evitare l’abbandono dell’eurozona; ciò, non solo nell’interesse dei greci, ma anche nell’interesse di chi ancora crede nell’Unione Europea come “comunità di destino” dei popoli che la compongono, e non esclusivamente come “mercato unico”, come l’intendono “Germania e compagni”. Per quanto possa essere tacciata di estremismo, l’analisi di Graeber risulta suggestiva, non solo perché apre i cuori della maggioranza degli europei alla speranza di vedere aiutato un Paese in difficoltà, ma anche perché, come suggerisce Slavoj Zizek, filosofo e psicanalista sloveno, in un articolo apparso su la Repubblica del 9 luglio (“L’eresia di Syriza può salvare l’Europa della solidarietà egualitaria”), le potenze dell’UE che “appoggiano lo status quo tecnocratico che da decenni mantiene l’Europa in uno stato di inerzia” possono essere sconfitte e tener viva l’idea dell’unione politica, a patto che si crei “nel suo corpo principale una frattura settaria”; ciò perché “solo una nuova ‘eresia’ (rappresenta in questo momento da Syriza) può salvare quello che vale la pena di salvare dei valori europei: la democrazia, la fiducia nelle persone, la solidarietà egualitaria…”. Tale evento, secondo Zizec, è ciò che l’Europa dei tecnocrati maggiormente teme, perché Syriza rappresenta una reale minaccia all’attuale governance dell’UE da parte delle sue principali potenze economiche; quindi – afferma Zizek – c’è dell’ipocrisia nelle richieste continue di austerità rivolte alla Grecia. L’intento dei tecnocrati europei è quello di tenere la Grecia in uno stato di sudditanza continua, accusando il governo di Syriza di non mostrare sufficiente senso di colpa e di sentirsi innocente. “E’ questo che disturba l’establishment UE; il governo di Syriza riconosce il debito, ma senza colpa”; se questa fosse rimossa, i tecnocrati, guardiani degli interessi dei creditori, non avrebbero più la possibilità di gestire, come sinora hanno fatto, le sorti dei popoli europei fuori da ogni controllo democratico. Per sconfiggere i tecnocrati occorre l’”eresia” della quale parla Zizek e della quale dovrebbe essere portatore Tsipras al tavolo dei futuri negoziati, per ottenere gli aiuti necessari al suo Paese; a tal fine, il premier greco dovrebbe essere il protagonista di una “scelta strategica”, con cui chiedere che si ponga fine alla richiesta di crescenti misure d’austerità, perché l’Europa si apra definitivamente alla necessità di cambiare radicalmente il modo in cui i Paesi oligarchi pretendono di esercitare la solidarietà. Sarebbe questa, secondo Zizec, la via per far compiere un sicuro “scatto” in avanti al processo di unificazione politica dell’Europa e, in questo senso, il referendum e la vittoria del “no” rappresenterebbero un “primo passo in questa direzione”; pare invece che Tzipras sia disposto a cadere di nuovo nella trappola delle trattative tecniche, che serviranno solo a dilazionare ulteriormente lo stato di dipendenza della Grecia dai tecnocrati dell’UE. La conclusione del filosofo sloveno riecheggia la “Preghiera” recitata sull’Acropoli rivolta ad Atene di Ernest Renan sul finire del XIX secolo, ricordata da Silvia Ronchey in un altro articolo comparso su “la Repubblica” del 2 luglio (“Tutto per il popolo, così l’antica Grecia creò il paradosso della democrazia”); secondo la Ronchey, l’omaggio che Renan formulava contro i “nordici colonizzatori” esprimeva un appello, la cui eco può essere riproposta ancora oggi contro i governanti dell’Europa nordica: “resistere allo scetticismo, ai calcoli e alle abitudini oligarchiche; non dubitare del popolo, dei non possidenti, non paventare il potere che abdica a favore di quell’antica e temibile espressione del kratos popolare che è lo strumento referendario”. E’ così! Nel perseguire la “comunanza di destino”, che con i Trattati europei i nostri Padri hanno inteso di lasciarci in eredità, non serve la presunta validità del calcolo egoistico del capitalismo, che, come molti grandi scienziati sociali, da Karl Marx a Joseph Alois Schunpeter, hanno sempre sostenuto la sua indimostrabilità teorica sul piano etico. La “comunanza di destino”, in altri termini la solidarietà tra i popoli, non è perseguibile sulla base di puri calcoli di convenienza di uno o più degli Stati coinvolti nel processo comunitario; la sua realizzazione implica, al contrario, valutazioni politiche, liberate il più possibile dalle ristrette valutazioni plutocratiche e tecnocratiche, quali quelle che i “nordici colonizzatori” vogliono far valere a tutti i costi ai danni della Grecia e di chi è a rischio di cadere nel baratro ellenico.
Ad ogni azione umana nefasta si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo si fa per gli animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo un'azione nefasta che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A parte il partito preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di uno, quando gli permettiamo di farle.
Quando non vogliamo onorare i nostri debiti presentiamo una denuncia per usura contro il nostro creditore se siamo singoli; votiamo a maggioranza un referendum quando siamo una collettività.
C’è chi pensa che l’euro è la causa di tutti i mali…Ma non è solo una moneta? Malevolo è chi si richiama alla moneta per creare sfascio. I Grillini, i leghisti, i comunisti ed i fascisti tutti nel calderone. Perché tutti gli sfascisti non dicono che se un buon padre di famiglia si fa bastare una certa somma di denaro per i bisogni familiari, mentre chi ruba, spreca e spande quella somma non la fa bastare, la colpa non è della moneta che ha in tasca?
Nel momento del soddisfacimento egoistico dei propri bisogni si diventa tutti comunisti: esproprio proletario della proprietà altrui. Tutti con la Grecia, insomma.
Anche noi avevamo le pensioni baby o le pensioni d’oro o l’iva agevolata che si pagavano con l’enorme debito pubblico. Anche noi avevamo una caterva di dipendenti pubblici inetti ed incapaci che, spesso, andavano in pensione con meno di 20 anni di contributi. Quindi i nostri privilegi li pagavano gli altri paesi. Poi abbiamo posto rimedio, diventando buoni padri di famiglia ed entrando nell'euro. Con l’entrata dell’euro chi si strappa oggi i capelli ha permesso la vendita dei prodotti e dei servizi allo stesso valore convertito. Un kg di mele prima 1000 lire, il giorno dopo 1 euro: colpa della moneta?
Se il debito è rimasto ed è intervenuta la crisi non è colpa della moneta ma dei governanti incapaci e ladri di tutti i partiti e di tutti quelli che li hanno votati.
Perché la Germania, pur accorpandosi la Germania dell’est, non ha sofferto la transizione?
Perché noi non possiamo essere come loro, invece di pensare sempre di fottere il prossimo o di essere incapaci di difendere i nostri diritti?
Anche il Portogallo e poi la Spagna e la stessa Italia ha sofferto un periodo nero. Oggi ci troviamo a pagare 100 volte più di 20 anni fa ed ad avere 100 volte meno in termini di servizi. E’ colpa della moneta o di chi ci ha governato e pretende di rigovernarci?
Oggi i greci hanno i privilegi che noi avevamo, ma non ci vogliono rinunciare. Pretendono che quei privilegi siano pagati con i soldi di tutti gli altri cittadini europei, compresi gli italiani che a quei privilegi hanno già rinunciato.
L’Euro è una moneta, l’unione europea è un sistema burocratico parassitario, quindi tutt’altra cosa. Il malgoverno italiano è altra cosa ancora.
Per molti è comodo diventare comunisti, specie nelle sale da barba e nei bar, ma alla fine si diventa solo degli stronzi parassiti. Più stronzi parassiti i governati che i governanti.
Ed appunto la Grecia al referendum del 5 luglio 2015 ha detto oki (no) alla trattativa dei creditori con il 61,3% (3.558.450) a fronte del nai (sì) con il 38,7% (2.245.537). Da tener conto che solo il 65% dei circa 9,8 milioni aventi diritto ha votato.
"Qui ad Atene noi facciamo così.
Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza.
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento.
Qui ad Atene noi facciamo così.
La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi l’uno dell’altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo.
Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo.
Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa.
E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso.
Qui ad Atene noi facciamo così.
Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e benchè in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla.
Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia.
Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore.
Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versalità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero.
Qui ad Atene noi facciamo così. Pericle - Discorso agli Ateniesi, 431 a.C. Tratto da Tucidide, Storie, II, 34-36. Inizialmente era stata indicata la data del 461 a.C., riportata da diverse fonti, ma in realtà il discorso, secondo Tucidide, è stato pronunciato all'inizio della Guerra del Peloponneso (431 a.C. - 404 a.C.).
Invece a Milano fanno così…
La rivolta contro le tasse che insanguinò Milano. Giuseppe Prina era l'uomo di Bonaparte. Portò allo stremo la città e nel 1814 la pagò cara Anche oggi i balzelli possono passare il limite. E la storia ci dice che si rischia grosso, scrive Matteo Sacchi su “Il Giornale”. Il finale è atroce. Perché quando la rabbia del popolo è stata a lungo compressa e, poi, si scatena su una singola persona l'efferatezza è praticamente inevitabile. E quindi in questa faccenda forse è giusto partire proprio dal finale. Nell'aprile del 1814 era ormai chiaro che il regime napoleonico volgeva al tramonto. Se ne stavano rendendo conto anche a Milano, capitale dell'effimero Regno Italico nato all'ombra dell'aquila imperiale. Tutti, dai filofrancesi ai filoaustriaci, si mobilitarono per trovare un nuovo assetto. Magari (utopia!) indipendente. I filofrancesi, capeggiati da Francesco Melzi d'Eril, avrebbero voluto affidare il regno a Eugenio di Beauharnais e convocarono una riunione del Senato per il 20 aprile. In quella mattina piovosa, fuori dal palazzo del Senato, che allora si affacciava sui navigli, si radunò una folla inferocita che brandiva gli ombrelli come fossero mazze. C'erano ombrelli di seta, di nobili e borghesi, e ombrelli di molto più vile cotone, agitati dal popolo minuto, artigiani e operai angariati dalle tasse. Fu subito chiaro che tirava una brutta aria. La riunione venne sospesa. Di restare nell'orbita francese non si parlò più. Nel frattempo la folla penetrò in Senato, devastando l'aula. I senatori si diedero alla fuga in carrozza. Stando ben attenti a non mostrarsi ai finestrini, soprattutto i più vicini alla Francia. Ma alla fine il popolo aveva già identificato un bersaglio univoco: il ministro Giuseppe Prina, responsabile del dicastero delle finanze. In Senato non c'era. Puntarono allora a casa sua. Casa in cui pensavano di trovare enormi ricchezze trafugate. L'unica spiegazione che potevano darsi per imposte, come quelle sulla carta bollata, che avevano messo in ginocchio l'economia dei territori italiani satelliti della Francia. Arrivarono a palazzo Sannazzari, in piazza San Fedele, dove Prina risiedeva, e diedero l'assalto. Devastarono stanza per stanza senza trovarlo, levarono addirittura le tegole dal tetto nella foga di scovare lui o almeno il maltolto (se c'era, non era a palazzo). Poi, in una soffitta, finalmente qualcuno gridò «è trovato, è trovato». Lo estrassero dall'interno della cappa fumaria del camino nel quale si era nascosto, travestito da prete. Cento mani gli strappano l'abito talare, cento mani lo percuotono, lo trascinano, lo gettano da una finestra dei piani inferiori. Per la strada è sottoposto a una tempesta di colpi d'ombrello. Qualcuno è mosso a pietà, interviene, lo strappa alla folla inferocita che lo ha già trascinato sino in via Case Rotte. Un coraggioso vinaio (a Milano i vinai erano uomini d'ordine e spesso facevano parte delle varie guardie civiche, in cambio di qualche esenzione dal dazio) lo accoglie nella sua casa-bottega. Non basta a calmare gli animi, c'è chi minaccia di incendiare la bottega. Da dentro cedono, la porta si apre, trovano Prina seminascosto dietro un tino. «Subito ebbe fracassata la testa, vuotata un'occhiaia, sfiancate le reni, finché spirò». Poi il corpo viene trascinato per ore per le strade verso il Cordusio. Qualcuno gli ficca in bocca un pezzo di carta: «Toh, mangia la carta bollata con cui ci hai succhiato il sangue». Fu uno spettacolo terrificante a cui assistette in prima persona anche il giovane Alessandro Manzoni, allora ventinovenne. Secondo la moglie, per lungo tempo gli provocò orribili sogni. Di certo ispirò la sua descrizione dei tumulti contro il vicario di Provvisione nei Promessi sposi. Ma non solo letteratura, ancora oggi a Milano «fare la fine del Prina» è un'espressione idiomatica che indica cose poco carine. Ma, al di là della pietà umana che resta verso il piemontese trasferito a Milano - e che a Napoleone avevano presentato così: «Ingegno prontissimo, vista estesa, moltissimi lumi teorici e pratici, caratterialmente deciso e superiormente fatto per governare subalterni...» -, che cosa si può imparare da questa vicenda? Probabilmente che esiste una soglia di tassazione oltre la quale anche il popolo più mite si trasforma in belva. Sul tema fa un'analisi serratissima e documentatissima Romano Bracalini in Prina deve Morire. Milano 1814. La prima rivolta antitasse in Italia (Libreria San Giorgio, pagg. 86, euro 12). Il saggio illustra bene sogni e speranze che le armate repubblicane fecero sorgere in Italia al loro arrivo. Liberté, Égalité, Fraternité erano temi che gli italiani capivano bene, almeno quel pezzo di società che aveva subito l'influenza del pensiero dei lumi. Ma ci volle poco a far sì che quelle speranze mutassero in disaffezione prima e in rabbia poi. Dove mettevano piede le armate francesi il saccheggio era garantito. Le richieste economiche erano sempre esorbitanti; se sotto l'Austria mancava la libertà, sotto la Francia iniziò a mancare il pane. Il solo Napoleone, una volta instaurato il regno, si riservava sei milioni di lire d'appannaggio. Il vicerè, Eugenio di Beauharnais, mise in piedi una corte fastosissima. Ma già prima la situazione era diventata molto pesante. In sei anni, dal 1796 al 1802, la tassazione, come spiega Bracalini, era passata dal 28 al 48 per cento. Il 10 settembre 1802, poi, Prina introduceva anche la sua sopracitata «tassa sul bollo della carta». Praticamente gravava su qualsiasi tipo di atto e di scrittura professionale. «Colpiva soprattutto il ceto medio produttivo». Nel 1803 il costo dell'armata francese pagato dagli italiani era salito a 25.458.750 lire, mentre l'esercito italiano costava solo 3.900.000 lire. Insomma, il rischio default, come si direbbe oggi, era alle porte. E in più gli italiani avevano chiaro che stavano andando in bancarotta per pagare guerre altrui. Dovevano ammetterlo anche pubblici ufficiali filo-francesi come Melzi d'Eril: «Ossia è una verità incontestabile che le somme versate dall'Italia alle diverse armate francesi sono state più che doppie dei loro reali e veri bisogni». Idee sintetizzate in maniera mirabile da un paio di versi di una canzoncina molto popolare ai tempi di Carlo Porta: «Liberté, égalité, fraternité. I fransé in carozza, i milanes a pè». Anche il certamente fedele Melzi d'Eril era arrivato a segnalare direttamente a Napoleone che gli italiani accettavano di buon grado il passaggio da repubblica a monarchia, ma che avrebbero voluto funzionari italiani e la cessazione dei sussidi forzosi per l'armata francese, «non avendo ancora sentito il vantaggio della loro emancipazione che per un aumento d'imposte». Abbastanza per mandare l'Imperatore su tutte le furie: «E non è giusto che gli italiani paghino almeno in parte l'esercito che versa il sangue per loro?». Una risposta che non teneva conto di tutti gli italiani finiti nelle fosse di mezza Europa combattendo sotto le sue bandiere. Di tutto questo non si avvide o non volle avvedersi Prina. Puntuale, precisissimo, di lui si diceva che si facesse stirare anche le mutande, non oppose mai un rifiuto a Parigi. Anzi... Di certo in piena crisi dell'economia lombarda i ministri avevano pensato bene di aumentare il loro trattamento da 25mila a 50mila lire e lui quanto meno lasciò fare. Lo stesso con la corte vicereale. Né si pose mai il dubbio che le sue lussuose ville aumentavano il pubblico odio. Per il resto era un uomo che sulla finanza aveva anche idee innovative. Fu lui a istituire il Monte Napoleone facendone un istituto finanziario qualificato anche all'emissione di «buoni del Tesoro», per quei tempi una novità assoluta. Parte di quei soldi che dragava finivano nelle sue tasche? Difficile dirlo. Era stato accusato di aver manomesso i libri contabili anche anni prima, quando era al servizio del Re di Sardegna. Ma almeno in quel caso nessuno poté provarlo. I milanesi non si presero il lusso di un processo. Si limitarono a dare corpo a quello che già avevano minacciato con le scritte sui muri: «Prina, Prina, il giorno si avvicina». E del resto esistono anche colpe politiche. Non capire quando una tassazione si trasforma in un capestro lo è. E Prina riuscì a causare la prima vera (e per ora ultima) rivolta fiscale italiana finita nel sangue di un ministro (di norma finiscono nel sangue dei tassati). Ma molti politici e storici di lui preferiscono non ricordarsi. O far finta che tutto sia avvenuto solo per colpa del popolo impazzito. Milano gli ha anche dedicato una via “riparatrice”. Ma i cittadini del 1814 avrebbero da ridire.
In Italia a fare la dittatura non è tanto il dittatore quanto la paura degli italiani e una certa smania di avere, perché è più comodo, un padrone da servire. Lo diceva Mussolini: «Come si fa a non diventare padroni di un paese di servitori?».
E sempre pronti a cambiar padrone…
Vi siete mai domandati perché nell’aprile 1945 il vertice del Pci decise di appendere a Piazzale Loreto i cadaveri di Benito Mussolini, di Claretta Petacci e di qualche gerarca della Repubblica sociale? Scrive Giampaolo Pansa per "Libero Quotidiano". Con il trascorrere degli anni, ne sono passati ben settanta, gli storici e i politici hanno offerto molte spiegazioni di quella scelta barbara che qualche leader della Resistenza, come Ferruccio Parri, il numero uno del Partito d’Azione, definì come un esempio ributtante di «macelleria messicana». Ma tutte le ipotesi sono, o sembrano, aperte e spesso in contraddizione. Credo che esista un’unica certezza. La decisione venne presa da Luigi Longo e da Pietro Secchia, i comandanti delle Brigate Garibaldi nell’Italia da liberare. Dopo aver interpellato il leader del Partito comunista, Palmiro Togliatti, ancora fermo a Roma. Ma perché la presero? Gli storici propendono per un’ipotesi: era l’unico modo per dare sfogo alla rabbia di una parte dei milanesi che voleva vedere il Duce accoppato e appeso come una bestia da squartare. Uno spettacolo che serviva anche a spargere il terrore tra i fascisti repubblicani ancora in libertà. Tuttavia in questi giorni emerge un’altra spiegazione, assai bizzarra. La propone un giornalista che cerca di farsi strada nel terreno impervio della guerra civile. È Aldo Cazzullo che l’ha presentata nella propria rubrica su Sette, il periodico del Corriere della Sera. La sua tesi è la seguente. Nell’Italia del 1945 non c’era la televisione. Per far sapere che il Duce era morto, non esisteva altro modo che mostrarlo appeso ai rottami del distributore di Piazzale Loreto. Conosco bene Cazzullo. È un bravo giornalista, sempre attratto dalla storia contemporanea. Era accanto a me a Reggio Emilia nell’ottobre del 2006 quando venni aggredito da una squadra arrivata da Roma su mandato di Rifondazione comunista per impedire un dibattito su un mio libro revisionista. Il comportamento di Aldo fu esemplare. Invece di scappare dall’Hotel Astoria come fece qualcuno, se ne rimase lì tranquillo, aspettando che la buriana finisse. Subito dopo cominciammo a discutere. Adesso ha pubblicato con Rizzoli una storia della Resistenza. Il suo lavoro dovrebbe dimostrare che la guerra partigiana non fu soltanto un affare dei comunisti. È una verità conosciuta da sempre. Allo stesso modo sappiamo che l’attore principale della nostra guerra civile fu il Pci, grazie alle bande Garibaldi, le più numerose, le meglio armate e le più combattive. È curioso che a ricordarlo sia proprio il sottoscritto, autore di un libro come Il sangue dei vinti. Quel lavoro rivelava la sanguinaria resa dei conti sui fascisti sconfitti. Attuata dopo il 25 aprile 1945 quasi sempre dai partigiani rossi. Il sangue dei vinti venne messo all’indice da tutta la pubblicistica di sinistra. Si disse persino che l’avevo scritto per ingraziarmi Silvio Berlusconi. In compenso il Cavaliere mi avrebbe fatto ottenere la direzione del Corriere della Sera! L’insieme delle vendette ebbe come spettatori entusiasti, e talvolta come esecutori, anche tanti italiani che per vent’anni erano stati fascisti e avevano applaudito i discorsi di Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia. Ecco un’altra verità che non amiamo ricordare. Non piace neanche a Cazzullo. Lui arriva a definirla «la solita tiritera». Ma non è così. La grande folla accorsa a piazzale Loreto, per sputare sui cadaveri di Mussolini e della Petacci, nei venti mesi della guerra civile si era ben guardata dall’uscire di casa. Osservata con uno sguardo neutrale, la Resistenza fu una guerra condotta da un’esigua minoranza di italiani che si opposero a un’altra minoranza anch’essa esigua, quella dei fascisti decisi a combattere l’ultima battaglia di Mussolini. Questi potevano contare sul sostegno determinante dell’esercito tedesco. Mentre i partigiani avevano soltanto l’appoggio cauto degli angloamericani che risalivano la penisola con grande lentezza. Negli anni successivi al 1945, il Pci seppe sfruttare con accortezza il proprio predominio sul fronte antifascista. «La Resistenza è rossa» divenne lo slogan più urlato nelle celebrazioni del 25 aprile. In due parole descrivevano una realtà. Certo, a resistere c’erano anche militari, sacerdoti, suore, internati in Germania, partigiani cattolici e monarchici. Ma la massa critica, diremmo oggi, era costituita dalle Garibaldi. Le bande del Pci erano le uniche ad avere una strategia a lungo termine: quella di iniziare un secondo tempo destinato alla conquista del potere. E fare dell’Italia un satellite di Mosca. I comunisti furono anche gli unici a giovarsi subito di una storiografia di parte. Basta ricordare Un popolo alla macchia, il libro firmato da Longo, ma scritto su commissione da un altro autore. E la Storia della Resistenza italiana di Roberto Battaglia, corretto in più parti dallo stesso Longo. Insieme a questi interventi di marketing, ci fu la conquista dell’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani, che vide l’espulsione dei cattolici e dei capi del Partito d’Azione, primo fra tutti Parri. Oggi, nell’anno di grazia 2015, si scopre che soltanto una minuscola pattuglia dei maturandi, appena il 2,5 per cento, sceglie il tema sulla Resistenza. Perché stupirsene? La crisi della memoria resistenziale è in atto da molto tempo, strozzata dalla retorica, da un’infinita serie di menzogne e dall’opportunismo cinico delle sinistre. Ed è diventata il sintomo più evidente della crisi culturale di quel mondo. Esiste un succedersi implacabile di stagioni politiche. Per prima c’è stata la fase staliniana. Poi quella togliattiana. Quindi la berlingueriana. Chi ha visto l’ultima puntata di Michele Santoro dalla piazza di Firenze, si è reso conto che Enrico Berlinguer viene ancora ritenuto un santo da venerare. Infine il caos legato alla dissoluzione dell’Unione sovietica ha prodotto la svolta di Achille Occhetto e la scomparsa formale del Pci. La mazzata decisiva è venuta nel 1992 da Tangentopoli. Una parte della sinistra, quella di Bettino Craxi, è morta. Mentre i resti del Partitone rosso si sono dispersi in tante piccole parrocchie. Adesso, nel giugno 2015, la crisi culturale è diventata identitaria. Racchiusa in una domanda: chi è di sinistra oggi in Italia? Certo, esiste il Partito democratico, ma è un’accozzaglia di politici, di programmi, di stili di vita e di idee, tutti avvolti in una nebbia che impedisce definizioni credibili. Secondo un intellettuale dem come Fabrizio Barca, autore di un’analisi che ha richiesto mesi di indagini, il Pd è anche un partito zeppo di robaccia criminale. Non mancano i militanti e i dirigenti onesti. Però l’insieme ricorda la folla di Piazzale Loreto che osserva con gli occhi sbarrati non il cadavere di un dittatore, bensì quello di una storia politica. Durata per decenni, ma oggi finita per sempre. Per ultimo ecco l’enigma di Matteo Renzi, il premier di un’Italia che, nel mondo globalizzato del Duemila, non sa più dove dirigersi. Il Chiacchierone di Palazzo Chigi è di sinistra, di destra, di centro o un renzista autoritario e clientelare? Per ritornare a Cazzullo che osserva Piazzale Loreto, oggi la televisione esiste. Ma è in grado soltanto di diffondere ansia, incertezze e non poca paura.
Scrive il 31 marzo 2015 “Lecce Cronaca”. Auguri a Pietro Ingrao che compie 100 anni. Uno dei più longevi uomini politici italiani. Nato della provincia di Latina da una famiglia di ricchi proprietari terrieri. Di lui si sa quasi tutto, è noto per essere stato all’interno del PCI uno dei compagni più duri. Ha ricoperto diversi e prestigiosi incarichi sia nel Partito comunista che nel Parlamento italiano. Quel che invece non viene detto, per ovvi motivi, e che da giovane, nonostante le tradizioni antifasciste della sua famiglia, aderì con entusiasmo al Fascismo. Tanto è vero che il secondo premio di poesia ai littoriali della cultura dell’anno XIII° và ad un ventenne del GUF di Roma, Pietro Ingrao, per la poesia STAGIONE, il testo viene pubblicato dal giornale di Telesio Interlandi “Quadrivio”. Il 16 settembre 1934 vince, ai bagni di Lucca, il premio di G. Ciano “I poeti del tempo di Mussolini”. Il 28 aprile 1935 partecipa ai Littoriali del 1935 con il GUF di Littoria, in qualità di fiduciario del GUF di Formia. Risulta 10°, dopo Luigi Longo, al Convegno di Organizzazione Politica del Partito Nazional Fascista, del 1935. Come scrive lo storico Aldo Giannuli sul suo blog: “Eterno secondo ai littoriali fascisti della cultura, Pietro Ingrao appartiene a quella seconda generazione di dirigenti comunisti che ebbe la sua prima formazione nell’Italia fascista e che scoprì solo in un secondo momento il comunismo, attraverso il tunnel doloroso della guerra, della Resistenza, per incontrarsi con Togliatti prima ancora che con Gramsci. Si tratta di un tema a lungo eluso, direi esorcizzato, dal Pci, come da tutti i partiti antifascisti, che avevano nel proprio seno, chi più chi meno, uomini passati per il medesimo cammino. E se ne comprende il motivo: il bisogno di presentare la nuova classe politica repubblicana in totale rottura con il passato fascista, reagendo con gelido disprezzo alla pubblicistica fascista (ad esempio “Italia fascista in piedi!” di Nino Tripodi) che sottintendeva, invece, conversioni opportunistiche all’antifascismo. Questo portava alla rimozione del tema ed all’enfatizzazione dell’antifascismo come negazione assoluta ed incontaminata del fascismo. In realtà le cose non stavano così (ne riparleremo) e il fascismo seminò concetti, che poi sono restati, finendo impastati con la successiva cultura politica dell’Italia repubblicana. La cosa non deve né stupire né scandalizzare (come invece accade ad una recente pubblicistica, cito per tutti il lavoro di Mirella Serri “I Redenti” che pure si basa su un’ottima ricerca d’archivio): la storia ha i suoi tornanti e le culture politiche sono corsi d’acqua che spesso si contaminano, magari attraverso passaggi carsici.” Ma leggiamo ancora sul blog aldogiannuli.it. “Ingrao, in particolare, fu influenzato dalla figura e dal pensiero di Giuseppe Bottai, il maggior intellettuale del regime (Fascista) ed, insieme, il gerarca più attivo nel promuovere la formazione delle giovani generazioni: dalle sue riviste presero le mosse alcuni dei nomi migliori dell’intellettualità post fascista ed antifascista, come Salvatore Quasimodo, Nicola Abbagnano, Enzo Paci, Carlo Muscetta, Mario Alicata, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Vasco Pratolini, Vittorio Sereni, Giuseppe Ungaretti, Luigi Salvatorelli, Giorgio Spini, Enzo Biagi, Renato Guttuso, Sandro Penna, Eugenio Montale e decine di altri. E diversi di loro, come Giame Pintor, li ritroveremo fra i primi a combattere con la Resistenza. Quella di Bottai fu una sorta di serra degli eretici, della quale, eretico egli stesso, si compiacque. E proprio questo tratto di dirigente politico-intellettuale con vocazione all’eterodossia fu, forse inconsapevolmente, quello che affascinò il giovane Ingrao. Ad avvicinare queste due figure inconsuete del Novecento italiano, non fu solo la propensione all’eresia e la profonda compenetrazione fra politica e cultura, ma anche il gusto del dubbio sistematico, la propensione all’astrattezza (per la verità, più spiccata nel secondo che nel primo), una certa sofisticatezza intellettuale, l’eterna insoddisfazione per la propria ricerca. Ma da questi stessi tratti discesero per entrambi anche il forte narcisismo, l’irresolutezza, la mancanza di tempismo politico, lo scarso coraggio.” Insomma Pietro Ingrao fu tante cose prima Fascista poi Comunista, essere definito, come ha fatto la Boldrini, “un esempio di coerenza democratica”, forse non sarebbe piaciuto neanche a lui. Auguri a questo anziano politico del passato millennio.
Più di 5 milioni di italiani con la tangente o la raccomandazione, scrive Paolo Comi su “Il Garantista”. C’è una ricerca del Censis, che è stata presentata a Roma, molto interessante su svariati argomenti (la ricerca è sul rapporto tra mondo produttivo e pubblica amministrazione) e che ci fornisce in particolare un dato sul quale sarà giusto riflettere. Questo: quattro milioni e mezzo di italiani ammettono di avere fatto ricorso a una raccomandazione per ottenere una maggior velocità (e un buon esito) alle pratiche disperse nei meandri dell’amministrazione pubblica. E addirittura 800 mila ammettono di avere fatto un regalino a dirigenti e funzionari per avere in cambio un atto dovuto. Regalino, a occhio, è qualcosa di simile alla tangente. Le cifre poi vanno lette bene. Se quattro milioni e mezzo ammettono, è probabile che altri quattro milioni e mezzo non ammettono. E così per gli 800 mila. Le cifre vere potrebbero essere 9 milioni di raccomandazioni e un milione e seicentomila piccole tangenti. Se consideriamo che non tutta la popolazione attiva (e cioè circa 40 milioni di persone) ha avuto bisogno di velocizzare pratiche nella pubblica amministrazione (diciamo circa la metà) otteniamo questo rapporto: su 20 milioni di persone che hanno avuto problemi con la pubblica amministrazione, 9 milioni hanno fatto ricorso a una raccomandazione, perché conoscevano qualcuno, un milione e seicentomila ha pagato una tangente, altri 9 milioni e quattrocentomila se ne sono stati buoni buoni in fila ad aspettare. E’ abbastanza divertente intrecciare questi dati coi dati su coloro che chiedono più rigore, più pene, severità e ferocia contro la corruzione. Corrotti, corruttori e “punitori” di corruttori e corrotti, spesso, sono la stessa persona. La ricerca del Censis ci consegna una realtà nitida e incontrovertibile: almeno la metà degli italiani fa uso di forme soft di corruzione. E le forme, probabilmente, sono soft perché non esistono le possibilità che siano hard. Perché questi nove milioni non hanno né potere né soldi. Naturalmente di fronte a questo dato si può dire: colpa dei politici che danno il cattivo esempio. Beh, questa è una stupidaggine. Non c’è un problema di cattivo esempio, perché anzi, da almeno vent’anni, i politici e i giornalisti e tutti i rappresentanti delle classi dirigenti, delle professioni, dei mestieri e della Chiesa, non fanno altro che indicare la corruzione come il peggiore dei mali che ammorba la nostra società. Il problema è che spesso, gli stessi, ricorrono in qualche modo alla corruzione e non si sentono per questo incoerenti. Qualche caso un po’ clamoroso di ipocrisia è saltato fuori recentemente dalla cronaca, fior di imprenditori antimafia e anticorruzione presi con le mani nel sacco. La gran parte dei casi però non emerge. Potete star sicuri, ad esempio, che una buona parte degli opinionisti, dei giornalisti e dei politici che tutti i giorni si impancano e vi fanno la lezione di moralità, qualche mancetta l’hanno lasciata, qualche pagamentino in nero lo hanno accettato, qualche rimborso spese di troppo… L’altro giorno, in una intervista divertentissima, il vecchio Pippo Baudo raccontava, sorridendo, di quando il principe dei moralizzatori, Beppe Grillo, si faceva pagare dalla Rai il rimborso spese per il soggiorno a Roma, se lo metteva in tasca, e poi andava a mangiare e a dormire a casa di Pippo. Il vecchio Baudo se la rideva, e ha anche raccontato di quel giorno che Beppe gli ha detto: «Magari, per sdebitarmi, lascio una mancia alla Nena». La Nena era la donna di servizio di Baudo, e Baudo subito ha detto a Beppe che gli pareva un’ottima cosa, e gli ha chiesto quanto pensava di lasciarle. Grillo, vecchio genovese, ha risposto: «Che dici, cinquemila?». «Non sarà troppo?, gli ha ribattuto, ironico, Pippo Baudo. E allora Grillo ha sentenziato: «No, meno di 5000 no, allora è meglio niente». E non gli ha lasciato niente… Così il rimborso se l’è preso tutto intero. Non sarà colpa dell’esempio, ma comunque è colpa dei politici. La raccomandazione e la tangente sono un frutto del modo nel quale è organizzata la vita pubblica. E i politici di questo sono responsabili. La mancata trasparenza (nella pubblica amministrazione come negli appalti) è la causa vera della corruzione. Perché la rende possibile e perché la rende indispensabile. Però di tutto questo frega poco a tutti. Prendiamo la questione degli appalti. E’ chiaro come l’acqua che il sistema complicatissimo vigente (in Italia ci sono oltre 30 mila stazioni appaltanti, e non si sa a chi rispondano, e non si sa chi decide, e ognuna adopera criteri tutti suoi per valutare, e non sia sa chi e come può controllare ed eventualmente indagare) consegna poteri discrezionali enormi a un certo numero di persone e -spesso – ad alcuni politici. Che naturalmente esercitano questo potere. Alcuni, meritoriamente, in modo onesto – ma perché sono disperatamente onesti loro, incorruttibili – alcuni in modo meno onesto, o comunque traendone qualche utilità. Moltissime volte l’appalto viene assegnato senza gara. Altre volte col sistema del ribasso dei prezzi, che è un sistema assurdo perché consegna un potere immenso a chi decide e presuppone un rapporto forte e sregolatissimo tra impresa e stazione appaltante. Dovrebbe essere abbastanza chiaro che, in seguito a una perizia seria, si può stabilire che costruire in quel luogo una scuola con certe caratteristiche e di una certa grandezza costa una cifra tot. Diciamo 10 milioni. L’appalto non può essere dato a chi chiede meno. Se uno mi offre di fare quella scuola a 5 milioni, mi sta fregando. O pensa di fare la scuola con la carta pesta, o pensa di farla piano piano e che tra due anni chiederà una revisione prezzi e otterrà 15 milioni (e poi magari la farà lo stesso di carta pesta…). L’appalto deve essere concesso a una cifra fissa all’azienda che dà le maggiori garanzie. E da un numero ridottissimo e quindi controllabile di stazioni appaltanti. Se fosse così sarebbe molto difficile corrompere qualcuno. E la stessa cosa per le pratiche della pubblica amministrazione. Vanno semplificate, spesso abolite, deburocratizzate e risolte in tempi certi. Ottenere qualcosa del genere sarebbe una riforma seria. Una riforma dello Stato molto, molto più utile e profonda dell’abolizione del Senato e roba simile. Perché nessuno le chiede queste leggi? Perchè la politica e l’intellettualità italiana sono nelle mani di un cerchio magico (che si è costruito, trasversale, attorno al triumvirato Anm-Travaglio- Salvini) il quale se ne frega delle riforme e chiede solo pene severe. Per loro non contano le leggi, le idee, contano gli anni di carcere e basta. Adesso hanno stabilito che la pena massima per la corruzione sale da otto o dieci anni. E sono felici, e brindano, e sentono le manette tintinnare allegre. Riforma forcaiola e inutile. Il problema non è di tenere un povero cristo in prigione per due anni di più, il problema è di rendergli impossibile la corruzione. Ma questa idea non piace a nessuno. Non piace a Salvini, non piace a Travaglio, non piace all’Anm, non piace, probabilmente, neanche a Renzi, e nemmeno ai 4 o 9 o 10 milioni di italiani delle raccomandazioni e dei regalini. A loro piace solo sapere che impiccheranno Lupi con una corda d’oro.
Perché leggere Antonio Giangrande?
POLITICA E SPETTACOLO: DIETRO LA MASCHERA C'E' IL NULLA.
Insostenibile leggerezza dell'apparire. Nel mondo d'oggi siamo tutti condannati a indossare una maschera: un saggio sui mutamenti del prestigio sociale, scrive Massimiliano Panarari su “La Stampa” Viviamo nella società dello spettacolo, dove l’abito fa decisamente (insieme con vari altri accessori) il monaco. Ce lo ha detto Guy Debord, ma ancor prima è stato, secondo un interessante libro che esce oggi, il filosofo (e vescovo) irlandese George Berkeley, al quale dobbiamo la celebre massima est percipi («essere è venire percepiti»). Nel suo Le apparenze Una filosofia del prestigio (il Mulino, pp. 222, € 20), la storica della filosofia Barbara Carnevali (ricercatrice invitata al parigino Institut d’Études Avancées) prende le mosse proprio dall’immaterialismo berkeleyano, riformulandolo ad hoc per analizzare il peso delle apparenze e dello nelle società occidentali. Ed ecco che il motto del teologo empirista che, appositamente parafrasato «in chiave mondana» diviene in societate esse est percipi aut percipere («in società esistere è essere percepiti o percepiti»), fornisce una chiave interpretativa originale per spiegare le aspirazioni e i bisogni di rappresentazione dell’aristocrazia e della borghesia europea, arrivando sino all’incontenibile e generalizzata smania postmoderna che ci vorrebbe far essere «tutti divi». «La vanità è alla base di tutto», scriveva Gustave Flaubert, uno che se ne intendeva al punto da avere creato il personaggio di Madame Bovary e diagnosticato il fenomeno del bovarismo, manifestazione patologica del «manierismo snobistico» e perfetta raffigurazione della farsa di una piccola borghesia che si mostra (e vive) al di sopra delle proprie possibilità nel disperato (e sventurato) tentativo di scimmiottare la classe sociale superiore, non avendone, però, i mezzi e le dotazioni materiali. A identificare chiaramente - e severamente - per primo il ruolo della vanity nelle umane esistenze è però, come ci racconta il volume, il sommo Thomas Hobbes, il quale designava con questa parola una malriposta sensazione di superiorità che si dedicava quasi esclusivamente a «bagatelle» e «scemenze», ma possedeva un impatto devastante sul consesso sociale; e ne era a tal punto preoccupato da considerarla tra le cause principali della famigerata «guerra di tutti contro tutti». La società occidentale prende così a ruotare sempre più vorticosamente intorno alla «fiera delle vanità» (centrifuga irresistibile di prestigio, successo, pettegolezzi, fama, mode, e chi più ne ha più ne metta, a partire dalle invidie) e all’apparire sociale; un combinato disposto che trova una serie di formidabili cronachisti in alcuni, più o meno grandi, letterati, da William M. Thackeray (autore, nel 1848, giustappunto del romanzo Vanity Fair) a Marcel Proust. La letteratura europea si popola quindi di rampanti e arrivisti, tutti in cerca del loro quarto d’ora di notorietà ante litteram, ma nessuno, più dell’autore della torrenziale Recherche, sublime narratore della «chiccosa» Café Society, saprà tradurre in scrittura il senso e il côté mondano del motto di Berkeley mediante le vicende che fanno perno sull’aristocratica famiglia Guermantes. E se Proust, ossessionato dalla memoria, cerca di configurare l’identità dei suoi personaggi sullo sfondo della trama dei loro «giochi di società», c’è chi invece, come Luigi Pirandello, alimenta la dissoluzione dell’io e proclama, malinconicamente e angosciosamente, ma senza negarsi qualche punta di umorismo, l’inaggirabilità della dimensione dell’apparenza. I suoi individui, d’altronde, sono pensati per il teatro, medium di rappresentazione per eccellenza, e il Novecento in cui lo scrittore siciliano giganteggia è secolo mediale per antonomasia, così come mediale si rivela il ruolo delle apparenze, mezzi di comunicazione e di definizione delle relazioni tra le persone, che, per loro tramite, indossano, per la maggior parte del tempo, delle maschere (come insegnano la psicanalisi e lo stesso Pirandello). Non c’è da stupirsi, allora, se il prestigio nel XX secolo (e all’inizio del XXI) passain primis attraverso i mass media, e quella loro peculiare (e spesso discutibile) filiazione che è l’industria del gossip - regno e pollaio della discussione collettiva intorno alla reputazione dei cosiddetti vip - che ha visto kingmaker e vittime illustri, da Andy Warhol a Marilyn Monroe. E qui il cerchio parrebbe (quasi) chiudersi. Le apparenze sembrerebbero infatti dettare incontestabilmente legge e mettere la parola fine alla storia della separazione tra l’Homo oeconomicus e l’uomo estetico che aveva segnato tanto fortemente la cultura occidentale. Perché la società dello spettacolo, dolorosamente intuita e stigmatizzata dal neo-russoviano e neoromantico Debord, col suo feticismo della merce e l’idolatria del valore simbolico dei beni, getta le premesse per l’affermazione di un capitalismo simbolico che tutto tiene e tutto vince. E, così, all’aristocrazia e all’alta borghesia subentra la «nuova nobiltà» dello star system che rovescia le «strategie di distinzione « di cui parlava Pierre Bourdieu, e vede i «divi» imbevuti della stessa cultura pop e di massa da cui le élite del passato erano impegnate a differenziarsi proprio mediante i gusti estetici. A questo punto, per la gioia degli apocalittici, dovremmo assistere, ahinoi, al trionfo assoluto dell’alienazione. E rimarrebbero solo gli status symbol, come la limousine superaccessoriata su cui viaggia il protagonista di Cosmopolis di Don De Lillo, intento a contemplare la fine de facto della civiltà capitalistica e, in buona sostanza, dell’Occidente per come lo abbiamo conosciuto. Ma speriamo che si tratti, per l’appunto, di una mera apparenza...
“LA CULTURA DELL’APPARENZA, LA NOSTRA DECADENZA”, scrive Nicola Vacca su "Gioia Net”. “Non viviamo una crisi economica, è una crisi morale, per questo sarà tanto difficile uscirne”. José Saramago, premio Nobel per la letteratura, qualche giorno prima di morire pronunciò queste parole. Un lascito spirituale per la nostra civiltà in agonia. Parole giuste di un grande intellettuale su cui vale la pena aprire una riflessione. Quando la morale entra in crisi una società non è più in grado di generare intelligenza e diventa sempre più difficile trovare una via d’uscita diversa dalla decadenza. L’intelligenza è un bene raro nella nostra epoca. Non se ne trova in nessun luogo. È proprio così. Se mi guardo intorno non vedo nessuno che si legge dentro. Ci affatichiamo per costruire la società dell’apparenza. Il culto dell’immagine a ogni costo è quello che conta. Tutto quello che deve emergere è quello che non siamo. “Devo fabbricarmi un sorriso, munirmene, mettermi sotto la sua protezione, frapporre qualcosa tra il mondo e me, camuffare le mie ferite, imparare, insomma, a usare la maschera”. Cioran guarda negli occhi la maschera che non riesce a infilarsi e condanna la viltà di coloro che la indossano con estrema facilità perché hanno paura di mostrarsi così come sono. Oggi quasi nessuno riesce a fare a meno della propria maschera. Si ha talmente paura di farsi vedere a cuore nudo dall’altro, mostrarsi nella propria schiettezza, aprirsi con fiducia, farsi capire per quello che realmente si sente e si prova. Tutto nasce da questo complesso di timori. Siamo soltanto maschere che non hanno il coraggio di essere. Non ci interessa l’essenza delle cose, ma il loro apparire. Preferiamo amarci male, che mostrare il volto vero dei nostri sentimenti. Sui luoghi di lavoro, come nelle relazioni sociali è più comodo indossare un’esistenza che non sia la nostra. Mostrare la propria con i suoi difetti e le sue fragilità è a dir poco sconveniente. Siamo maschere che mentono, fedeli seguaci dell’apparenza e delle convenzioni. Abbiamo paura di conoscere noi stessi, e soprattutto riteniamo pericoloso che gli altri possano conoscerci per quello che in realtà siamo. Indossando la maschera siamo gli artefici del grande inganno che mistifica tutto. Che fa diventare il tutto un cosmico niente. La maschera uccide noi stessi e il mondo. Ma preferiamo non abbassare la guardia, non mostrare quello che siamo capaci di fare con il nostro cuore messo a nudo. Gli altri non devono sapere come siamo fatti davvero dentro. Dobbiamo mentire per guadagnarci un posto al sole nella società che giudica dalle apparenze. Una maschera tira l’altra. Siamo un’inciviltà di maschere che si consuma nella menzogna. Così tutto ci sembra perfetto, fabbrichiamo un sorriso tra il mondo e noi stessi, mettiamo sempre la parte peggiore di noi, che è il modo migliore per essere accettati in società. Preferiamo essere uno nessuno e centomila, piuttosto che vivere un giorno di solitudine insieme alla parte più intima di noi. “Come mai ci sono cosi poche persone perbene? Ne ho abbastanza di questi abbozzi di umanità, di queste caricature, di questi esseri riusciti a metà”. Cioran, ancora una volta, pugnala con le sue parole questo nostro tragico tempo dell’apparenza, nel quale difficilmente avremo il coraggio di rinunciare alla maschera. È sufficiente tutto questo per affermare che una civiltà sente vicina la propria fine. Direi proprio di sì. Chiamate il prete, è ora di celebrare il funerale del nostro tempo che si è spento perché nessuno ha avuto il coraggio di chiamare le cose con il loro nome.
Nella Repubblica, Platone scrisse che uno dei maggiori pericoli che insidiano una democrazia prende corpo quando il pubblico confonde il teatro con la politica. Ecco quello che sta accadendo.
Match Grillo-Renzi: il vuoto pneumatico della politica-spettacolo, scrive Fabio Marcelli, Giurista internazionale, su “Il Fatto Quotidiano”. Non bastava il deprimente rito annuale di Sanremo, con i suoi Fazio e C. pagati a peso d’oro per dire corbellerie in diretta, alla faccia dispending review e debito pubblico. Il masochismo televisivo del nostro disgraziato popolo ha raggiunto vette inusitate con l’insulso duetto fra Renzi e Grillo, due prodotti degni dell’attuale società italiana, nati, cresciuti e politicamente (e non solo) pasciuti nel degrado generale della politica e della democrazia. Sono diversi fra di loro e Grillo dice a volte cose sensate. Eppure qualcosa di non secondario li accomuna: come due saprofiti, al pari del parassita maggiore, tale Silvio Berlusconi, questi personaggi si nutrono della crisi irreversibile della democrazia italiana, determinata dai continui tentativi di affossare la Costituzione e dar vita a leggi elettorali truffaldine che distorcono la volontà popolare, dalle scelte di politica economica compiute all’ombra dei poteri forti, della corruzione dilagante, del potere inamovibile delle alte burocrazie ben pagate per non fare nulla di serio e positivo. Un elemento che li accomuna è l’assoluta vacuità, che emerge con grande nettezza dal duetto che essi hanno intrecciato per la delizia degli italiani spettatori. Vacuità che si declina diversamente. Per Renzi è vacuità del fare, un dinamismo senza scopo e senza contenuto, riproduzione caricaturale in salsa nostrana del pragmatismo alla Blair. Perfino il programma, peraltro pretestuosamente rivendicato da Alfano, altro personaggio dello zoo politico dell’Italia in decadenza, diventa un inutile ammennicolo. Quel che conta è l’attivismo fine a se stesso, magari condito da qualche parolina inglese, tipo Job Act, per fare maggiormente colpo sui demuniti che ascoltano a bocca aperta le meraviglie enunciate dal profeta, novello Messia della rediviva e sempiterna Democrazia Cristiana. Per Grillo è vacuità dell’invettiva. La denuncia fine a se stessa, capace di banalizzare e rendere insulse anche le verità meno contestabili, tipo l’assoggettamento della politica e della società alla finanza. Manca la proposta concreta, la capacità di mettere con le spalle al muro l’avversario incalzandolo sui problemi reali, di dimostrare all’audience lobotomizzata da anni di passività che si può cambiare a partire dalle piccole cose, sapendo coniugare la necessaria prospettiva di opposizione globale e senza compromessi alla lotta per cambiare la realtà. Resta la vuota soddisfazione dell’invettiva. L’italiano medio vessato dai poteri forti e maltrattato dalla burocrazia può ora in poi ricevere la sua dote quotidiana di soddisfazione politica low-cost immedesimandosi nelle urla di Grillo e, sublime realizzazione, votare Movimento Cinquestelle alle elezioni. Quest’ultimo, sia detto per inciso, può diventare una risorsa per il popolo italiano, sottraendolo alla micidiale e infame morsa dei Pd con e senza elle, solo liberandosi di Grillo e del suo compare Casaleggio, come ho già avuto occasione di scrivere più volte. Sarebbe ora che il buon Beppe, che in fondo è una persona onesta e intelligente (almeno speriamo), se ne rendesse conto e alzasse le tende ovvero si rassegnasse a vivere nel movimento su di un piede di parità con tutti gli altri e le altre che vi partecipano. I quali non tutti peraltro vanno bene, se è vero che il Movimento in questione conta fra le sue file anche un tale sindaco di Pomezia che ha mandato la celere contro gli operai in lotta: un vero democratico, non c’è che dire. Sullo sfondo dei due insulsi litiganti si prospetta il vecchio volpone, inopinatamente resuscitato dall’incauto Renzi. Forse è sempre lui, in questo squallido contesto di politica spettacolo, a meritare ancora una volta l’Oscar degli Italiani lobotomizzati. Non a caso si è premurato di chiedere ed ottenere garanzie dal giovane democristiano precocemente invecchiato in ordine agli aspetti che più gli stanno a cuore: mettere sotto controllo la magistratura, mantenere il controllo delle televisioni e prospettare un’ipotesi di presidenzialismo all’italiana. Su quest’ultimo tema in particolare pare si registri ampia sintonia. Le sorti del nostro Paese sono oggi più che mai legate alla possibilità di costruire una vera alternativa alla casta rantolante e alla falsa opposizione grillina. A tale fine è importante che la popolazione si svegli, s’indigni e riprenda in mano il proprio destino. Mai più spettatori, specie di spettacoli di così basso livello.
Grillo, Renzi e Landini. Benvenuti nella politica-spettacolo, scrive Michele Magno. Il Bloc Notes di Michele Magno su “Formiche” oggi si concentra su un certo populismo un po' stonato...Quando nel 1967 pubblica “La società dello spettacolo”, Guy Debord era un giovane artista, cofondatore di una delle numerose avanguardie letterarie fiorite nel Novecento, il Situazionismo. I situazionisti, che si richiamavano al verbo del surrealismo, concepivano l’intervento politico come costruzione appunto di “situazioni”, ovvero di momenti di vita collettiva volti alla realizzazione, attraverso l’uso creativo di tutte le forme di espressione artistica, di una autentica e spontanea comunicazione tra le persone. Per molti Cassandra del nostro tempo, profeta della società consumistica e postmoderna, Debord è stato un pensatore tra i più saccheggiati dalla sociologia del dopoguerra, quasi sempre senza un cenno di riconoscenza. Ma cosa era per lui la società dello spettacolo? Debord non la identifica solo con i mezzi di comunicazione di massa: “Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale fra individui, mediato dalle immagini”. In altre parole, è una sorta di velo che nasconde la realtà, che la altera in una rappresentazione, che la falsifica irrimediabilmente. Ne deriva che tutta la vita delle “società nelle quali predominano le condizioni moderne della produzione si presenta come un’immensa accumulazione di spettacoli” (affermazione che allude al famoso incipit de “Il Capitale” di Marx). A quasi cinquant’anni di distanza, le sue tesi appaiono per larghi aspetti discutibili, estreme in alcuni punti e troppo semplicistiche in altri. Del resto, il Sessantotto parigino era alle porte, e il “grande rifiuto” della società tecnologica teorizzato dalla Scuola di Francoforte e da Herbert Marcuse mieteva proseliti in tutta Europa. Ciononostante, la sua proposta di lettura ha profeticamente anticipato quel processo di spettacolarizzazione della politica che oggi è sotto gli occhi di tutti. Come il calcio si spettacolarizza spostandosi dagli stadi ai salotti televisivi, così la politica si spettacolarizza spostandosi dalle sedi istituzionali e di partito ai talk-show. Il leader politico si trasforma in un’icona pubblicitaria, e per prevalere nella competizione elettorale non deve produrre argomentazioni razionali a sostegno del proprio programma, quanto proiettare davanti a un pubblico di cittadini-consumatori un’immagine gradevole, rassicurante e accattivante. Si celebra in questo modo il trionfo di quel “vuoto delle apparenze”, che ormai si è incuneato nel cuore stesso delle procedure democratico costituzionali. Come è noto, a fungere da battistrada a questa mutazione in senso pubblicitario della politica è stato Silvio Berlusconi. Il Cavaliere l’ha suggellata già col “nome-slogan” (Forza Italia) del movimento da lui creato. Poi è stato scalzato da Beppe Grillo e Matteo Renzi. Adesso un altro Matteo (Salvini) prova a scalzare Grillo (i cui voti gli fanno gola) e un nuovo astro nascente del piccolo schermo (Maurizio Landini) è pronto a farlo con Renzi. Cambiano i suonatori, ma la musica è la stessa. Di destra o di sinistra, sono sempre sette note di populismo un po’ stonato.
La politica spettacolo non l’ha inventata Grillo, scrive Gianluca Giansante. Nell’estratto di Le parole sono importanti pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano ecologista Terra parlavo del successo di Beppe Grillo inserendolo nel contesto di una generalizzata tendenza alla spettacolarizzazione della politica. Vale la pena ritornare sull’argomento anche con l’ausilio di qualche immagine. Il successo di Beppe Grillo non è un caso isolato ma fa parte di un fenomeno più ampio: nell’incontro con i media – e in particolare con la televisione – la politica cambia le proprie caratteristiche, accentuando i caratteri di spettacolarizzazione. Questo incontro – analizzato con attenzione nel libro Politica Pop, di Gianpietro Mazzoleni e Anna Sfardini – dà origine a un nuovo fenomeno, definito politainment, neologismo che deriva dalla crasi fra le parole politics ed entertainment (in inglese, divertimento).
Il politainment si manifesta in due direzioni:
Da una parte il politico assume i codici dello spettacolo, partecipa a trasmissioni di intrattenimento, è ospite dei varietà del sabato sera, prende parte a programmi sportivi. Mazzoleni e Sfardini (Politica Pop, il Mulino) ne elencano alcuni esempi eloquenti: Piero Fassino partecipa al programma C’è posta per te per rincontrare e abbracciare la sua vecchia tata, Pier Ferdinando Casini e Francesco Rutelli rilasciano un’intervista doppia a Le Iene per dar conto in dettaglio delle loro goliardate giovanili, Antonio Di Pietro e Renato Schifani si tirano letteralmente Torte in faccia nel corso di una puntata dell’omonimo varietà (Le parole sono importanti, pp. 110-111). Non si tratta di una assoluta novità, già nel 1983 Giulio Andreotti partecipava al film Il tassinaro, con Alberto Sordi.
La seconda tendenza del politainment conduce alla trasformazione delle star televisive in politici: I personaggi della tv, forti della visibilità e della notorietà garantita dal piccolo schermo, entrano nell’arena politica dalla porta maestra; allo stesso tempo i programmi di intrattenimento – pensiamo a Striscia la notizia o a Le iene – svolgono anche un ruolo informativo e sociale (Le parole sono importanti, p. 111). Anche in questo caso non si tratta di una recente innovazione, nè di un caso tutto italiano. Due esempi in questo caso sono eloquenti. Il primo riguarda la Francia e la vicenda politica dell’attore e comico Coluche: L’annuncio della sua candidatura alle presidenziali del 1981 suscitò grandi entusiasmi nel paese. I sondaggi gli attribuivano ampi consensi (16% secondo una rilevazione pubblicata da Le Journal du Dimanche). Il suo ritiro dalla competizione elettorale non è esente da punti interrogativi e pare sia stato causato dalle forti pressioni ricevute (Le parole sono importanti, p. 156). Il secondo è più recente: nelle elezioni politiche del 2010 in Brasile il pagliaccio Tiririca, candidato a deputato federale per lo stato di São Paulo è risultato primo eletto con 1 milione e mezzo di voti.
Beppe Grillo si inserisce in questo contesto e ne porta alle estreme conseguenze i tratti distintivi. Il ruolo di critica sociale da sempre svolto dalla satira viene sfruttato e impiegato per sostenere la sua proposta politica: la comicità di Grillo non è fine a sé stessa, ma viene impiegata per rinforzare gli elementi chiave della sua strategia di comunicazione. Parallelamente, le storture della società vengono utilizzate per promuovere uno spettacolo di intrattenimento (Le parole sono importanti, p. 111). Non è un fenomeno da sottovalutare, come scrivevo nel libro, uscito prima della tornata delle amministrative: in uno scenario in cui la disaffezione per la politica tradizionale cresce e in un contesto fertile per le ibridazioni fra politica e spettacolo, la sua [di Grillo] figura conquista attenzione e seguito. I suoi risultati, anche in termini di consensi, potrebbero crescere ulteriormente (Le parole sono importanti, p. 111). L’avanzamento dei grillini nella recente tornata elettorale conferma questa lettura: i successi del centrosinistra ai ballottaggi non devono far perdere di vista il contesto in cui queste vittorie sono maturate, altrimenti si rischia di non cogliere un segnale forte che gli elettori hanno voluto inviare con il voto al MoVimento Cinque stelle.
La politica spettacolo fu inventata da Pertini, scrive Pierluigi Magnaschi su “Italia Oggi”. L'assoluzione, trent'anni dopo, di Sophia Loren dal reato di evasione fiscale ha riesumato le cronache del tempo. Da esse si è appreso, ad esempio, che il presidente della Repubblica di allora, Sandro Pertini, era intervenuto pubblicamente sulla direttrice del carcere femminile di Napoli perché era indignato del fatto che l'attrice napoletana fosse stata messa in una cella singola, anche se di un carcere che era malfamato e pericoloso. Pertini, in quell'occasione, chiese una relazione accurata sui motivi che avevano giustificato questa scelta. Il presidente infatti si atteggiava a Robin Hood. Era in contatto con il feeling della gente. Oggi, se si collocasse a destra, lo denominerebbero un populista. Pertini non commissionava sondaggi (come ha poi fatto, all'ingrosso, Berlusconi) ma fiutava lo stesso cosa pensava la gente. Era un grande demagogo che, per di più, godeva del favore incondizionato e inossidabile di tutti i media che gli perdonavano tutto. Franco Evangelisti, il braccio destro di Giulio Andreotti, fu tenuto sulla graticola per tutta la vita dopo che, a un bar, il costruttore Caltagirone, gli disse: «'A Frà, che te serve?». Da allora, Evangelisti, diventò 'a Frà, mentre la gente si dava di gomito. Di Pertini ricordo un aneddoto che, se non avesse riguardato lui, avrebbe polverizzato la carriera politica di chiunque. Non si riusciva a nominare il presidente della Repubblica. L'ultimo candidato era Pertini, socialista. Ma Craxi non ne voleva sapere: diceva che Pertini era troppo vecchio. In compenso, proprio perché era inviso a Craxi, i comunisti lo sostenevano. In un primo pomeriggio, verso le due e mezzo, Pertini è seduto da solo su un divano a tre posti nel Transatlantico. Davanti di lui c'erano venti giornalisti. Pertini era imbufalito. Agitava per aria il suo bastone da passeggio e gridava: «Craxi dicce chè ssono vvvecchio. Poortàttèmi 'na ddonna che vi faccio vedere io se sono vecchio». Altro che 'a Fra'. Davanti a lui c'erano venti parlamentaristi, tutti sempre assatanati alla ricerca di ghiottonerie politiche. Ma, il giorno dopo, nessun giornale scrisse niente. Pertini era coperto dalla gabbia di Faraday del pregiudizio a lui favorevole.
La politica e la società dello spettacolo, scrive Luciano Lanna su "Ideazione". Qual è oggi la sede più specifica della politica? Quali sono i linguaggi contemporanei della politica? Qual è, infine, il ruolo dell’informazione di fronte alle novità emerse negli ultimi anni? Sono domande che coinvolgono direttamente i politici, i giornalisti, i portavoce governativi, i responsabili della comunicazione dei partiti, i conduttori televisivi. Al cuore di tutto, il rapporto tra la capacità di rappresentanza della politica e quella del giornalismo di rappresentarla. Ma è possibile oggi scindere artificiosamente tra politica da una parte e informazione politica dall’altra? Scindere, insomma, nel senso di una separatezza neutralizzante tra i tre poteri classici della teoria liberale e il famigerato “quarto potere”? Un fatto è certo: nell’ultimo decennio la politica, il sistema dell’informazione e la televisione sono state oggetto in Italia di una serie così veloce e continua di trasformazioni e di innovazioni che proprio per il loro carattere di novità forse cercano ancora un loro equilibrio e una loro regolarizzazione definitiva. E' cambiata la modalità di comunicare dei politici; si è rivoluzionato il giornalismo politico - una su tutte: nei giornali è scomparso il tradizionale “pastone”, il resoconto quotidiano di ciò che avviene nel Palazzo - e si sono imposte nuove forme di approccio agli eventi della sfera pubblica; la televisione, soprattutto, è diventata la sede privilegiata per comunicare ai cittadini decisioni e fatti destinati a cambiare i rapporti di forza e a scuotere l’opinione pubblica. Su tutto, è importante rendersi pienamente consapevoli del processo che, su questo piano, si è sviluppato nell’ultimo ventennio. Indietro, infatti, non si può tornare, e sembrano davvero passati anni luce da quando i partiti e i loro leader in Tv erano appannaggio esclusivo dei vari Jader Jacobelli, Gianni Granzotto e Ugo Zatterin: quel lungo periodo durato fino alla fine degli anni Settanta, quando la politica in casa era relegata alle fredde e inamidate tribune politiche, con leader che apparivano sul video attenti a non fuoriuscire dal loro ambito istituzionale e discussioni sin troppo misurate e composte. Arrivò solo nel ’77 la prima rottura di quella separatezza: improvvisamente l’uomo politico diventava confidenziale, uscendo dal ruolo canonico e da spazi rigidamente recintati. A inaugurare quella “rivoluzione” fu Maurizio Costanzo, allora ideatore e conduttore del primo talk show della nostra storia, quel Bontà loro dove i politici, finalmente, mescolati a varia umanità, rinunciano alla loro aura protocollare per svelare nel salotto anche il privato della loro personalità. Memorabile fu quella “prima” intervista con Giulio Andreotti, così come è rimasta alle cronache, con un seguito di vivaci polemiche e addirittura un’interpellanza parlamentare, la puntata nella quale il conduttore aveva chiesto a Tina Anselmi perché non si fosse mai sposata. Non fu da meno quando, sempre in una trasmissione di Costanzo, il deputato comunista Antonello Trombadori, rivolgendosi alla radicale Emma Bonino con l’appellativo di “cocca mia”, suscitò le ire delle femministe. Ed è ancora datato ’77 un altro episodio “rivoluzionario”, un vero e proprio media event, avvenuto questa volta nel corso di Portobello, la trasmissione-mercatino condotta da Enzo Tortora. Davanti a una platea di dieci milioni di telespettatori, una signora milanese di ottantuno anni parla della sua situazione di anziana in Italia. A quel punto suona il telefono, e si sente la voce del primo “acquirente”: “Sono l’onorevole Bettino Craxi, il segretario del Partito socialista…”. Al di là dei contenuti della conversazione in sé, il gesto apre un varco: per la prima volta un autorevole uomo politico fa sapere la sua attraverso un gioco televisivo. E' il via libera a quella che verrà chiamata la “politica spettacolo”. Da allora in un crescendo oggi ben evidenziabile col senno di poi, una nuova forma di personalizzazione diventa il leit motiv dello scontro politico e la televisione, prima che i giornali, ne diventa il media privilegiato. E' un processo che le allora nuove emittenti private, affacciatesi improvvisamente nel panorama comunicativo italiano, contribuiranno a rafforzare nel corso della campagna elettorale del 1979. Arrivano nuove soluzioni mutuate dai network americani e, tra tutte, comincia a prevalere il confronto diretto tra leader antagonisti. Una formula che la Rai riprenderà soprattutto con Mixer, in onda dal 1980: in particolare nei “faccia a faccia” condotti da Giovanni Minoli vennero sperimentati, attraverso moduli di “botta e risposta”, veri e propri contraddittori all’americana che molto contribuiranno a imporre il carisma di molti leader. La televisione, il medium, che spettacolarizza tutto, impone a questo punto una sorta di assunzione piacevole, estetica, del mondo politico: oltre che le idee e i programmi comincia a contare il modo in cui le si presentano. E siamo nel pieno degli anni Ottanta, il decennio del look e dell’edonismo di massa, e i politici sono come costretti a uscire dalle tristi stanze delle Tribune per entrare nei salotti nella necessità di “bucare il video”. Gli uomini del Palazzo danno definitivamente l’addio al vecchio comizio come strumento privilegiato di comunicazione con gli elettori, e trionfa la tv campaign, nel senso di un reciproco conferimento di status: l’interesse dei mass media per un nuovo tipo di uomo politico lo rende non solo conosciuto, ma soprattutto lo fa esistere, lo rende autorevole per il pubblico. E la stampa deve adeguarsi a questo approccio alla politica, rendendo in qualche modo televisive le sue pagine. Già nelle consultazioni politiche del 1983, del resto, vent’anni fa le principali reti private, ormai consolidate, lanciavano una propria programmazione elettorale tutta all’insegna della “spettacolarizzazione”: Rotocalco elettorale, Prima pagina e Obiettivo su Canale 5, Braccio di ferro e Italia parla su Retequattro, Perché sì, perché no e Voti e volti su Italia Uno. E nel 1987 l’ulteriore innovazione: la figura dell’uomo politico fa il suo ingresso normale tra gli ospiti fissi settimanali di un contenitore della domenica pomeriggio, il Va pensiero di Raidue condotto da Andrea Barbato. E, sempre quell’anno, la telepolitica arriva a definirsi come un genere televisivo vero e proprio, soprattutto con due trasmissioni di Rai Tre: Linea rovente, che inizia a gennaio condotta da Giuliano Ferrara, e Samarcanda, che parte ad aprile condotta da Michele Santoro. Se con la trasmissione di Ferrara ci si apriva agli interventi del pubblico, con quella di Santoro si arrivava alla programmazione in prima serata: il successo è crescente, paragonabile alle platee del sabato sera. E con queste formule si avviava un nuovo periodo, quello degli anni Novanta, quello della televisione che diventa il principale strumento di informazione politica che, oltretutto, direttamente legittima e spesso determina quelli che saranno i nuovi soggetti della politica.
Dalla centralità del Palazzo a quella del video. Nei primi anni Novanta il video diventa lo specchio quotidiano privilegiato per conoscere una serie di eventi fondamentali per una società italiana in velocissima trasformazione. Conseguenza anche del crollo dei vecchi partiti, delle inchieste giudiziarie, di appuntamenti elettorali nei quali la gente vuole avere voce in capitolo, la politica si prende una sua clamorosa rivincita e obbliga reti e tg, editori e redattori a confrontarsi con nuove realtà e soprattutto con un nuovo pubblico di telespettatori più esigenti, ritornati a interessarsi della vita pubblica dopo anni di apatia e stanchezza. S’impone così l’ennesimo quadro di cambiamenti nell’ambito dei rapporti tra politica e sistema informativo. Si impone, soprattutto, un radicale processo di apertura dei palinsesti televisivi rispetto alle nuove aspettative di comunicazione politica: un processo di semplificazione e di modernizzazione della comunicazione da parte dei politici, garantita a tutto il pubblico di massa e non solo ai lettori dei giornali. Trasmissioni come Milano, Italia e Il Rosso e il Nero riscuotono successi di audience impensabili per generi tradizionalmente poco digeribili a un pubblico che fino a qualche tempo prima aveva decretato il successo della sola televisione d’intrattenimento. E' in questo scenario che nuovi soggetti politici si affermano anche, spesso soprattutto, attraverso il video. E' dagli studi di Profondo Nord di Gad Lerner che nel ’91 la Lega acquista parte di quella forza comunicativa che la imporrà impetuosamente nell’arena politica. Così come è attraverso le immagini congiunte dei simboli del Carroccio, del Pds e del Msi davanti a una manifestazione a Palazzo di Giustizia a Milano che, nel maggio ’92 una puntata di Samarcanda legittima televisivamente un nuovo quadro politico. Sarà nel corso di una puntata de Il Rosso e il Nero che nella primavera del ’93 verrà lanciata l’ipotesi di quella candidatura di Gianfranco Fini a sindaco di Roma che sarà la premessa per l’avventura di Alleanza nazionale. Insomma: in quel biennio è come se alla centralità del Palazzo fosse subentrata quella del video. E la politica entra da protagonista assoluta anche in ambiti inediti: basti pensare all’irruzione dei politici veri insieme alle loro copie-comiche nel cabaret televisivo di Castellacci e Pingitore, alle impietose riproposizioni di volti e frasi in Blob, alle interviste “corsare” di Piero Chiambretti, alle conversazioni nell’Harem di Catherine Spaak, al politico nel nuovo ruolo di “uno contro tutti” nel Maurizio Costanzo Show. Negli stessi anni comincia a trionfare, come non si era mai visto, il gossip sui politici nei settimanali e nei rotocalchi. Con la campagna referendaria del ’93 e l’introduzione della legge elettorale basata sui collegi uninominali, si compie poi un passaggio ulteriore. Crescono d’importanza il fattore “personalizzazione” e la competizione a due: e il video finisce per determinare direttamente i temi e i termini stessi dello scontro. Saltando il vecchio ricorso all’appartenenza ideologica ed entrando in crisi il “voto di scambio”, il cittadino-elettore deve scegliere tra ciò che la tv propone secondo la sua logica comunicativa: il dibattito si impone sempre più come confronto “spettacolare” che non come dialettica ideologica. Così, soprattutto, alle battute, ai tentativi di “bucare il video” dei politici tende a uniformarsi l’informazione politica nel suo complesso. E i giornali - riprendendo e mettendo in pagina le discussioni in tv della sera prima, titolando sugli esiti dei talk show - finiscono per imporne la centralità all’opinione pubblica. Non a caso, nelle elezioni politiche del ’94 e in quelle del ’96 molto verrà giocato proprio sul terreno televisivo, sia nello scontro tra programmi e leader che sul ruolo dell’immagine delle due coalizioni contrapposte. E non sarà un caso che in quegli anni entrerà in politica Silvio Berlusconi, un leader il cui know how si era costruito proprio sui linguaggi dell’epoca televisiva. In questo processo di osmosi tra politica, televisione e sistema informativo generale, è interessante non solo il numero di personaggi televisivi e giornalisti del video che passano direttamente ai partiti e al Parlamento, ma anche il fenomeno contrario di nuovi politici che si impongono come abili comunicatori. La prova del nove di questa tendenza generale, è il sostanziale fallimento del decreto sulla “par condicio”, del marzo ’95, imposto cercando di “bloccare” gli spazi e i tempi offerti agli schieramenti contrapposti. Il provvedimento non ha infatti inciso minimamente sui trend della videopolitica. Fenomeno che anzi conosce il suo trionfo nel risalto che la stampa dà ai confronti televisivi della primavera ’96. Da allora “Chi vincerà le elezioni?” è sempre più diventato “Chi vincerà in tv?”. E la coalizione di centro-destra che dal maggio del 2001 governa l’Italia, ha presentato ufficialmente - attraverso il suo leader Silvio Berlusconi - il suo “contratto con gli italiani” proprio dagli studi di una trasmissione televisiva. La tv è diventata, in qualche modo, garanzia e strumento non solo di contatto diretto con l’opinione pubblica ma anche come sede privilegiata della comunicazione e dell’informazione politiche.
Dal “teatrino” al “teatrone” della politica. In tutto questo non va sottovalutato il ruolo dei conduttori televisivi, che si sono spesso regolati tenendo conto di ciò che avrebbero scritto i loro colleghi giornalisti della carta stampata. Non solo gli argomenti e le domande dei dibattiti derivano da ciò che i quotidiani hanno ripreso dalle trasmissioni precedenti, ma l’obiettivo dei talk show è spesso quello di ammiccare in modo sfacciato alla carta stampata. Tanto che i giornali, a loro volta, riportano fedelmente gli accordi, gli scontri, le opinioni emerse nei vari salotti televisivi. Il tutto corredato da titoli ad effetto e grandi fotografie dei politici sul piccolo schermo. Certo, non mancano i rischi: l’amplificazione della chiacchiera televisiva operata dai quotidiani, riproducendo l’ultima forma di auto-referenzialità della politica, potrebbe nuovamente allontanare i cittadini dall’interesse per la vita pubblica. Un giornalista acuto come Filippo Ceccarelli ha introdotto la nuova formula di “teatrone della politica” per evocare uno scenario in cui lo spettacolo potrebbe mettere sotto scacco il potere politico, rendendolo prigioniero, pallida ombra di se stesso, di una nuova subordinazione. L’osservazione riguarda la propensione degli uomini politici a disertare a volte i luoghi istituzionali per affollarsi invece negli studi televisivi: da Bruno Vespa, da Mauro Mazza, da Anna La Rosa, da Luca Giurato, da Maurizio Costanzo, da Antonio Socci, da Giovanni Floris, da Piero Vigorelli, da Giuliano Ferrara. Ma i media sono, appunto, strumenti di comunicazione, o un elemento vincolante, necessario, della nuova politica? Ha scritto Aldo Grasso: “La politica italiana è anche Anna La Rosa o Bruno Vespa o Maurizio Costanzo. La politica è oggi uno specchio che si specchia nelle facce di tutti i suoi protagonisti”. La palla passa ai politici, ai giornalisti, ai responsabili dei palinsesti e ai conduttori. Cercare nuove soluzioni per la politica in tv, individuare nuove formule che tengano conto anche delle nuove tecnologie e della nuova informazione in tempo reale, è oggi una sfida necessaria. Anche sui giornali e sul piccolo schermo la transizione non può durare all’infinito.
La politica è spettacolo, la pazza idea di Boldi e i precedenti illustri, scrive Americo Mascarucci su “Intelligonews”. Massimo Boldi è pronto a candidarsi sindaco di Milano. Il popolare attore questa sua “pazza idea” l’ha lanciata dalle colonne del settimanale “Panorama” dichiarandosi pronto a scendere in campo con chiunque dovesse dichiararsi disponibile a sostenerlo. Boldi è stato in passato un simpatizzante del Partito Socialista Italiano, grande amico di Bettino Craxi, dal quale accettò una candidatura alla Camera dei Deputati nelle elezioni politiche del 1992: l’esperimento tuttavia non ebbe successo perché il numero di preferenze raccolte non fu sufficiente a far scattare il seggio per lui. Migliore fortuna aveva avuto invece cinque anni prima Gerry Scotti, anche lui candidato con il “Garofano” che ebbe così il privilegio di ricoprire un mandato da deputato; esperienza che però Scotti ha sempre dichiarato non essere stata esaltante e di averla accettata soltanto per fare un favore a Craxi. Con lui in Parlamento nel 1987 entrò anche il celebre cantante Gino Paoli che si candidò e fu eletto nelle liste del Partito Comunista Italiano. Nel 1992 Paoli ritentò l’elezione con il Pds di Occhetto ma stavolta gli elettori della vecchia falce e martello mandata in soffitta per essere sostituita dalla Quercia, non si mostrarono granché generosi con lui. In seguito Boldi si avvicinò a Forza Italia soprattutto per stima e amicizia nei confronti di Silvio Berlusconi ma limitandosi a dichiarare il suo voto per il partito azzurro e senza accettare nuove proposte di candidature. Oggi questa improvvisa quanto inaspettata uscita che molti ritengono concordata proprio con Berlusconi sempre più irritato per le alzate di testa della Lega Nord che ha puntato i piedi per avere il candidato sindaco, scatenando diversi mal di pancia in Forza Italia. “Hanno già il Governatore della Lombardia, adesso vogliono prendersi tutto” accusano i forzisti irritati con il leader maximo colpevole di aver proposto a Matteo Salvini stesso la poltrona di Pisapia pur di estrometterlo dalla partita per Palazzo Chigi. Non a caso Boldi ha dichiarato di non essere disposto a candidarsi né con la Lega Nord né con il Movimento 5Stelle di cui non condivide i toni urlati. Insomma alla fine l’avvertimento ai leghisti da parte di Berlusconi potrebbe essere proprio questo; “attenti, che se puntate troppo i piedi noi abbiamo un candidato vincente”. Anche perché Boldi, ormai settantenne sembra aver chiuso con il cinema e sarebbe pronto a dedicarsi a tempo pieno ai problemi della città. Ma per tutti comunque la sua resta una boutade, amici e colleghi sono convinti che abbia fatto questa dichiarazione più per animare il dibattito nel centrodestra che per reali velleità politiche. Però a Boldi va riconosciuto il merito di aver avanzato la sua candidatura senza attendere che siano stati gli altri a buttare il suo nome in pasto alla stampa. Accadde così ad Alberto Sordi proposto come sindaco di Roma da Forza Italia nel 1997. L’indimenticabile “Albertone” si affrettò subito a smentire l’indiscrezione chiarendo che mai e poi mai avrebbe accettato di sfidare il suo amico Francesco Rutelli. Un altro che invece si buttò direttamente in campo ma senza poi concretizzare il proposito, fu il popolare conduttore Gianfranco Funari; nel 1993 accettò l’invito della Lega Nord a candidarsi sindaco di Roma, salvo poi ritirarsi dalla competizione a poche settimane dalla presentazione delle liste. Persino il Movimento Sociale Italiano si dichiarò disponibile a sostenere una sua eventuale candidatura, ma poi scese in campo direttamente il leader Gianfranco Fini che finì al ballottaggio con Rutelli. Funari ci riprovò anni dopo a Milano addirittura arrivando a dichiarare di essere andato in missione segreta ad Hammamet per incontrare Bettino Craxi e farsi consigliare da lui. Anche in questo caso poi non ne fece più nulla. In tempi più recenti è toccato a Giancarlo Magalli ritrovarsi, niente meno, che candidato al Quirinale. Se anziché in Parlamento l’elezione fosse avvenuta sui social network oggi al posto di Sergio Mattarella sul Colle ci sarebbe il conduttore de “I Fatti Vostri” il più votato dal popolo della rete. Alle ultime elezioni regionali in Puglia invece è sceso in campo, ma stavolta soltanto in quello politico, l’ex calciatore del Lecce, della Roma, dell’Inter, del Napoli e della Nazionale Francesco Moriero che si è candidato consigliere regionale nelle liste di Forza Italia a sostegno della candidatura di Adriana Poli Bortone raccogliendo 157 preferenze. E non è l’unico calciatore ad aver scelto la politica dopo aver piantato le scarpe al chiodo. Il vizio di rivolgersi ai personaggi del cinema, dello spettacolo e dello sport per conquistare consenso politico è molto diffuso in Italia nonostante poi l’elettore dimostri chiaramente di saper distinguere il bravo attore, il bravo conduttore e il bravo atleta dal politico rifiutando quindi l’automatismo “lo ammiro come artista o come sportivo, quindi lo voto”. E’ vero che oggi anche la politica è spettacolo, ma fino ad un certo punto.
Da Cicciolina a Massimo Boldi, quando la politica cerca consenso col candidato vip. Una volta, politica e spettacolo non si mescolavano quasi mai (e la Dc rifiutava di candidare Gino Bartali) Adesso siamo a un frullatore che ogni tanto sputa qualche nome illustre: Iva Zanicchi, Lilli Gruber o Luca Barbareschi. Chi trionfa, chi non ce la fa: di solito, una gran delusione, scrive Susanna Turco su "L'Espresso". Qualche settimana fa, forse presentendo l’odor di bruciato, Matteo Renzi in tv aveva già storto il naso, quando Bruno Vespa gli aveva annunciato che l’ospite a lui successivo sarebbe stato Massimo Boldi: “Niente di personale, ma a me i cinepanettoni non sono mai piaciuti”, aveva sentenziato il premier, prima di alzarsi dagli studi di Porta a Porta. Preveggenza si diceva perché adesso l’attore e comico, quello de “Cipollino” e “Bella gioia” – giusto per citare due dei suoi tormentoni storici – si (auto) candida come sindaco di Milano per il 2016. “Mi presento, con chi mi vorrà”, esclusi Cinque stelle e Lega, annuncia Boldi, 70 anni, attraverso le colonne di Panorama. Peraltro ricambiando a distanza il complimento del premier: “Renzi mi piace, sa fare cabaret”. In ogni caso il dato è significativo: adesso che a Roma Ignazio Marino non si sente tanto bene (ma resiste), a Milano Giuliano Pisapia ha già gettato la spugna con un anno d’anticipo e in generale, come dice il deputato politologo Pino Pisicchio, “la stagione dei sindaci come risorsa della politica sembra davvero lontana”, adesso insomma spunta sotto la Madonnina nientemeno che il nome di un ex pilastro di Yuppies e Vacanze di Natale. Il che, accanto al papabile per il centrodestra del filosofo Paolo Del Debbio, subito per la verità dichiaratosi non interessato all’articolo (“ci sono zero possibilità che corra per Milano”), racconta che la storia di quella categoria che il Foglio definì “l’illustre candidato” in prestito alla politica – vip, attore, cabarettista, celebre o bizzarro che sia – è giunta forse a un altro stadio, è pronta a un capitolo nuovo. Che la storia sia antica, in effetti, è fuor di dubbio. “Per un reale sviluppo economico di Ariccia, votate per Teddy Reno”, era lo slogan del noto cantante che si presentò alle amministrative locali all’inizio degli anni Cinquanta, non disdegnando peraltro di girare per la cittadina con l’utilitaria e gli altoparlanti ad annunciare il proprio comizio in piazza. Uno dei primi, un precursore, in tempi nei quali i partiti erano gelosissimi dei propri apparati e i divi non si sognavano neanche di mollare la carriera per fare politica, disposti al massimo a fungere da sponsor occasionali (vedasi ad esempio Silvana Pampanini a Sora con Giulio Andreotti, Sofia Loren e De Sica con Pietro Nenni, Claudio Villa col colbacco). Per il resto, nessuna assimilazione, nessuna contaminazione: i politici non ballavano né cantavano, i personaggi dello spettacolo e dello sport non si candidavano. Si racconta, per dire, che nel 1948, sia stato addirittura Pio XII a suggerire, attraverso l’Azione cattolica, la candidatura di Gino Bartali nella Dc: ma, decenni prima dello sbarco in politica di Pietro Mennea e Gianni Rivera, Manuela Di Centa e Valentina Vezzali, lo Scudocrociato decise che candidare il campione del ciclismo era meglio di no. Le prime contaminazioni vere arrivano quando gli anni Ottanta bussano alla porta. La credibilità dei partiti piano piano va giù, sale la moda dei candidati vip. Chiamati a dar lustro, purché si tratti di nomi davvero noti, rispettabili, nel pieno della loro conoscibilità mediatica: Ottavia Piccolo e Giorgio Strehlerper il Psi, Ettore Scola e Luigi Squarzina per il Pci,Giorgio Albertazzi e Tinto Brass per i radicali, Renato Pozzetto per il Pri, e via dicendo, ciascun partito secondo le proprie inclinazioni e i propri mezzi. Ma, insomma, ancora una roba “alta”. Che poi a un certo punto si allarga anche al piccolo schermo, e pian piano cambia di segno: nel 1987 in Parlamento il Pci elegge deputato Gino Paoli, il Psi Virginio Scotti detto Gerry (ancora non così famoso come lo poi), i radicali Ilona Staller detta Cicciolina (20 mila preferenze: qualche anno dopo, col Partito dell’amore con Moana Pozzi, non le andò altrettanto bene). E poi, ancora, Enrico Montesano consigliere comunale per il Pds con Rutelli alla guida del Campidoglio (per la cronaca: finirà a tifare per Alemanno). Fino all’apoteosi – nel bel mezzo della bufera tangentopolesca – nella quale la faccenda assume un segno preciso: la politica abbranca tutto ciò che si muove fuori di lei, per cercare credibilità e popolarità che altrimenti latita. Sono gli anni in cui, per dire, sia Leoluca Orlando che Umberto Bossi corteggiano Gianfranco Funari come uno statista: il “giornalaio”, come amava definirsi, si candiderà in proprio a sindaco di Milano nel 1997, ritirandosi solo all’ultimo. Dopo, quando politica e spettacolo finiscono a mangiare nello stesso piatto (il famoso risotto ai funghi di D’Alema a Porta a porta è in questo senso il precursore di un’epoca), la tendenza diventa semmai l’esatto opposto: è il vip appannato, o in momentanea crisi, che semmai cerca la politica. E così sempre Funari, per dire, finisce nel 2004 a candidarsi per la presidenza della provincia di Napoli per la lista “Magna Grecia Sud Europa”, si immagini con quale successo. A seguire, l’impazzimento completo. Politica, spettacolo, vip e intellettuali vari fanno come parte di un unico frullatore, che di volta in volta sputa fuori qualcosa: Franca Rame senatrice dell’Italia dei Valori, Lilli Gruber e Michele Santoro europarlamentari col centrosinistra, Iva Zanicchi quasi eletta con Fi, e poi la ex soubrette e attrice da fiction Barbara Matera ormai alla seconda eurolegislatura (130 mila preferenze la prima volta, 70 mila la seconda), Alessandro Cecchi Paone alla seconda euro bocciatura, mentre almeno per ora si ferma alla prima Fabrizio Bracconieri, ex “ragazzo della III C” e “Forum”, candidato con Fratelli d’Italia. Non si sa più, arrivati a questo punto, chi cerchi chi e perché. Nani e ballerine, candidati e parlamentari, non sono più categorie sempre esattamente distinguibili fra loro. E così, mentre Mara Carfagna diventa ministro, Flavia Vento, dopo un periodo filo Margherita, finisce candidata nelle liste del Partito liberale della Regione Lazio, con tanto di comizi in discoteca e proverbiale candore: “Il Partito liberale è un partito storico, antico, di Cavour e forse di Garibaldi. Comunque, sicuro di Cavour”, riporta fedelmente il Corriere dell’epoca. Come dimenticare poi il caso di Luca Barbareschi? Eletto nel Pdl nel 2008 dopo aver dimostrato in varie modi l’insipienza dei parlamentari, l’attore in una unica legislatura cambia due casacche per poi dirsi delusissimo e pronto a giurare che in politica non rimetterà mai piede. Perché poi, alla fine, la storia dei vip prestati ai partiti o alle candidature– salvo naturalmente qualche eccezione – è proprio questa. Una gran delusione, una gran noia, la voglia di tornare a fare ciò che si faceva prima. Se ci si riesce, per chi può. Lo stesso Boldi, del resto, tanti anni fa si fece convincere da Craxi a correre per il Psi: “Prendi la macchina, vieni giù, vedrai sarà divertente”, gli aveva spiegato Bettino al telefono. Ma era il 1992, “e cazzo è crollato il Partito socialista”, raccontò poi lo stesso Boldi su Sette. Come gli sia tornata la voglia, vent’anni dopo, è francamente un mistero.
E’ TUTTA QUESTIONE DI COSCIENZA.
A’ Cuscienza di Antonio de Curtis-Totò
La coscienza
Volevo sapere che cos'è questa coscienza
che spesso ho sentito nominare.
Voglio esserne a conoscenza,
spiegatemi, che cosa significa.
Ho chiesto ad un professore dell'università
il quale mi ha detto: Figlio mio, questa parola si usava, si,
ma tanto tempo fa.
Ora la coscienza si è disintegrata,
pochi sono rimasti quelli, che a questa parola erano attaccati,
vivendo con onore e dignità.
Adesso c'è l'assegno a vuoto, il peculato, la cambiale, queste cose qua.
Ladri, ce ne sono molti di tutti i tipi, il piccolo, il grande,
il gigante, quelli che sanno rubare.
Chi li denuncia a questi ?!? Chi si immischia in questa faccenda ?!?
Sono pezzi grossi, chi te lo fa fare.
L'olio lo fanno con il sapone di piazza, il burro fa rimettere,
la pasta, il pane, la carne, cose da pazzi, Si è aumentata la mortalità.
Le medicine poi, hanno ubriacato anche quelle,
se solo compri uno sciroppo, sei fortunato se continui a vivere.
E che vi posso dire di certe famiglie, che la pelle fanno accapponare,
mariti, mamme, sorelle, figlie fatemi stare zitto, non fatemi parlare.
Perciò questo maestro di scuola mi ha detto, questa conoscenza (della coscienza)
perchè la vuoi fare, nessuno la usa più questa parola,
adesso arrivi tu e la vuoi ripristinare.
Insomma tu vuoi andare contro corrente, ma questa pensata chi te l'ha fatta fare,
la gente di adesso solo così è contenta, senza coscienza,
vuole stentare a vivere. (Vol tirà a campà)
IL MONDO SEGRETO DEGLI ITALIOTI.
In Italia, come in tutto il mondo, la legge è la volontà della maggioranza di Governo e Parlamentare, se democrazia, o del monarca, se monarchia, nel regolare i rapporti tra cittadini o tra cittadini e Stato.
Bene. La norma, quindi non è altro che un’insieme di disposizioni scritte, a cui spesso segue una sanzione in caso di loro violazioni.
Di fatto, però, la legge è uno scritto su foglio bianco.
In realtà in tutto il mondo non vige la forza della legge, che varia con il variare dei legislatori, ma vige la legge del più forte.
La legge scritta nei codici deve essere conosciuta ed applicata, quindi i giudici, corretti o corrotti, la interpretano per gli amici e la applicano per tutti gli altri.
I sistemi giuridici prevedono che, in caso di abusi o errori di applicazioni della legge, ci si possa rivolgere agli organi sovraordinati rispetto all’autorità decidente. L’appello, nel merito o nella legittimità, spesso ribalta la prima decisione, sempre che i giudici superiori applichino criteri diversi rispetto ai primi giudici.
Comunque, ogni ingiustizia che si ritiene aver subito, si rileva e si contesta nei Tribunali, nei tempi, nelle fasi e nei gradi previsti e con avvocati onesti e preparati, se ve ne sono. Non vi sono autorità politiche od amministrative nazionali, né vi sono organismi internazionali che intervengono nei fatti interni degli Stati. Organismi, oltretutto, espressione e nomina delle autorità contestate. L’intervento esterno agli Stati da parte degli organismi preposti interviene solo quando vi sia un potere od un principio leso talmente forte, che li obblighi a scardinare l’abuso. Se nulla cambia è una ingiustizia che resta, taciuta ed impunita, e nulla si può fare, tenuto conto che, quando l’ingiustizia è diffusa, essa è un male che la gente pavida è contenta di subire.
«Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in 2 e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Parlano lingue incomprensibili, forse dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina; spesso davanti alle chiese donne e uomini anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano sia perché poco attraenti e selvatici, sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano dal lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, di attività criminali. Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano pur che le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione».
____________________________
Fonte: Relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso degli Stati Uniti sugli immigrati italiani, ottobre 1919.
Razzismo, la gaffe di Germano: falso il testo letto ai bimbi rom. Elio Germano, attore figo, impegnato e perciò di sinistra, ha pensato bene di dare il suo contributo alla mobilitazione contro Salvini. Ma ha fatto una clamorosa gaffe, scrive Giampaolo Rossi su “Il Giornale”. Elio Germano, attore figo, impegnato e perciò di sinistra, ha pensato bene di dare il suo contributo alla mobilitazione delle anime belle contro Salvini e il pericolo della destra intollerante e, soprattutto, ignorante. Per questo ha realizzato un video contro il razzismo; ha preso un gruppo di bambini Rom sullo sfondo di una roulotte, si è seduto in mezzo a loro e ha iniziato a leggere un documento con tono recitato (come si addice ai grandi attori) e l’aria di chi sta svelando al mondo una verità nascosta ma scontata. Il testo è una descrizione offensiva e razzista degli italiani emigrati in America agli inizi del ‘900, definiti ladri, puzzolenti, stupratori, abituati a vivere dentro baracche fatiscenti e organizzati secondo regole di clan. Elio Germano spiega che quel testo è un documento dell’allora Ispettorato per l’Immigrazione degli Stati Uniti. L’obiettivo dell’attore è ovvio: dimostrare che certi italiani di oggi sono razzisti verso gli immigrati e i Rom, come lo erano gli americani verso gli italiani all’inizio del secolo. Tutto molto bello e politically correct, se non fosse che, a quanto pare, quel documento è una patacca, un falso. Il testo, che gira da molti anni su internet, fu già utilizzato nel 2013 da Roberto Saviano (uno che di patacche se ne intende) nel salottino televisivo di Fabio Fazio. Più recentemente, Carlo Giovanardi, l’agguerrito deputato di centrodestra, ha pubblicato il vero documento originale della Commissione Dillingham sull’Immigrazione, che non contiene nulla di quanto letto dagli antirazzisti di mestiere, ma al contrario è un’attenta analisi dell’immigrazione italiana del periodo. Che giudizi sprezzanti e spesso offensivi contrassegnassero l’opinione pubblica americana nei confronti degli italiani (soprattutto meridionali) è cosa appurata storicamente da diversi studi. Ma quel documento che i fulgidi artisti di sinistra si passano di mano in ogni occasione per dare del razzista a chiunque contesti l’immigrazione clandestina, è una patacca degna della loro inutile demagogia.
Saviano va in tv a spiegare che una volta eravamo noi italiani gli zingari d’America. Ma è una bufala. Giugno 12, 2013 Carlo Giovanardi. Ospite di Fabio Fazio, lo scrittore cita «un documento dell’Ispettorato per l’immigrazione Usa» che tratta gli italiani come zecche. Peccato che sia una patacca Domenica 26 maggio Roberto Saviano, intervistato da Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa, per combattere quella da lui definita l’ondata di «odio morale verso gli immigrati» ha letto un testo. Cito testualmente le sue parole: «Avevo visto e trascritto qui alcune parole della relazione dell’Ispettorato per l’immigrazione del Congresso americano, quindi un documento ufficiale del governo americano del 1912, così descrive gli italiani». Ecco il testo letto da Saviano: «Gli italiani sono generalmente di piccola statura e di pelle scura, non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane, si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Si presentano di solito in due, cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci, tra loro parlano lingue a noi incomprensibili probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina, fanno molti figli che poi faticano a mantenere. Dicono siano dediti al furto, e le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si parla di stupri o agguati in strade periferiche. Propongo che si privilegino le persone del nord, veneti e lombardi, corti di comprendonio e ignoranti, ma disposti più degli altri a lavorare». Concludeva poi Saviano: «Incredibile che il nostro paese tutto questo non lo ricordi, non ne faccia memoria attiva, ma lo trasferisca quando si rivolge ad altre comunità o “etnie”». Conosco bene la storia dell’emigrazione italiana e delle terribili discriminazioni e umiliazioni di cui i nostri connazionali sono stati vittime all’estero ma, trovandomi per caso quella sera davanti alla tv di Stato, mi è parso del tutto evidente il fumus di “patacca” che emanava da frasi così volgari ed offensive in un documento ufficiale del Senato degli Stati Uniti nei confronti di un intero popolo. Una rapida ricerca su Google mi ha permesso di scoprire che già Paolo Attivissimo sul sito del CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale), aveva a suo tempo verificato che di quel testo erano in circolazione varie versioni, una delle quali, lanciata da Rainews24, citava come fonte il giornalista e conduttore televisivo Andrea Sarubbi che nel 2009 aveva pubblicato un articolo con quella citazione. Sarubbi, interpellato, aveva precisato di non aver tratto la citazione direttamente dal documento statunitense originale. La sua frase: «Ho fra le mani un documento dell’Ispettorato per l’immigrazione», non era quindi letterale, ma derivava da una fonte italiana, «un articolo pubblicato un anno fa sul giornale Il Verona dall’avv. Guarenti». Guarenti, a sua volta, dichiarava di averlo trovato «in un libro di un anno fa» ma non era in grado di citare il titolo del libro. Insomma, concludeva Attivissimo: «Siamo di fronte ad una situazione almeno di terza mano di cui non si sa la fonte intermedia». Sulla traccia di Attivissimo ho interpellato pertanto formalmente l’ambasciata americana che mi ha risposto il 30 maggio: «La commissione sull’immigrazione degli Stati Uniti conosciuta come la Dillingham Commission dal nome del senatore del Vermont che l’ha presieduta ha lavorato dal 1907 al 1911 e ha pubblicato 41 volumi di rapporti contenenti dati statistici sull’immigrazione negli Stati Uniti, l’occupazione degli immigrati, le condizioni di vita, la scolarizzazione dei bambini, le organizzazioni sociali e culturali, delle comunità degli immigrati e la legislazione sull’immigrazione a livello statale e federale». Continuava poi l’ambasciata americana: «Questi sono gli unici rapporti ufficiali sull’immigrazione elaborati in quegli anni e disponibili al pubblico. Da una visione superficiale, la citazione da lei riportata nella sua mail non appare in nessuno di questi rapporti, ma per esserne certi bisognerebbe eseguire una ricerca più accurata, per la quale purtroppo noi non siamo in grado di aiutarla in questo momento». Aiutati che Dio ti aiuta, ho consultato tramite la mail inviatami dall’Ambasciata tutti i volumi senza trovar traccia del documento citato da Saviano, ma viceversa una interessantissima disamina sull’immigrazione dell’Italia che ho fatto tradurre dall’inglese e si può leggere sul sito www.carlogiovanardi.it. Per il resto ringrazio Saviano che mi permette di aggiungere il XII ed ultimo capitolo al libro intitolato Balle che sto pubblicando, dove spiego come l’opinione pubblica italiana fonda le sue convinzioni su vere e proprie bufale che vengono troppo spesso disinvoltamente spacciate come verità.
61ª legislatura, Documento n. 662, RELAZIONI DELLA COMMISSIONE SULL'IMMIGRAZIONE. DIZIONARIO DELLE RAZZE O POPOLI. Presentato da DILLINGHAM il 5 dicembre 1910 alla Commissione sull'immigrazione [...] ITALIANO. La razza o il popolo dell'Italia. L'Ufficio dell'immigrazione [Bureau of Immigration] divide questa razza in due gruppi: Italiani settentrionali e Italiani meridionali. Fra i due gruppi vi sono delle differenze materiali, riconducibili a lingua, aspetto fisico e carattere, e delle differenze relative, rispetto alla distribuzione geografica. Il primo gruppo identifica gli italiani nativi del bacino del Po (compartimenti del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emelia [sic], i distretti italiani in Francia, Svizzera e Tirolo (Austria) e i loro discendenti. Tutti i popoli della penisola geograficamente definita e delle isole della Sicilia e della Sardegna sono Italiani meridionali. Anche Genova è meridionale.
Linguisticamente, l'italiano rappresenta una delle grandi divisioni del gruppo di lingue romanze derivate dal ceppo latino della famiglia ariana. Esso è articolato in molti dialetti, la cui separazione e conservazione è favorita dalla configurazione geografica dell'Italia. Hovelacque divide questi dialetti in tre gruppi: superiore, centrale ed inferiore. Il primo comprende i dialetti genovese, piemontese, veneto, emiliano e lombardo; il gruppo centrale comprende toscano, romanesco e còrso; il gruppo inferiore comprende napoletano, calabrese, siciliano e sardo. Questi dialetti differiscono fra di loro molto più che i dialetti inglesi o spagnoli. Si dice che è difficile per un Napoletano o un Sardo farsi capire da un nativo della pianura padana. Forse più che in qualsiasi altro paese, le classi colte restano tenacemente aggrappate all'uso del dialetto in àmbito familiare, preferendolo alla forma letteraria nazionale della lingua. Tale forma letteraria è rappresentata dal dialetto toscano di Firenze, come codificato nella letteratura di Dante, Petrarca e Bocaccio [sic] nel XIV secolo. Anche altri dialetti, tuttavia, hanno una considerevole letteratura, soprattutto il veneto, il lombardo, il napoletano e il siciliano. Quest'ultimo ha una poesia particolarmente ricca. Tutto il gruppo superiore di dialetti – per restare alla definizione di Hovelacque – tranne il genovese, è settentrionale. Tali dialetti contengono molti elementi gallici o celtici e mostrano affinità con le lingue provenzali e retoromanze (ladino e friulano), con le quali confinano ovunque tranne che al sud. Il genovese e i dialetti del gruppo centrale ed inferiore sono parlati dagli Italiani meridionali.
Fisicamente, gli Italiani sono una razza tutt'altro che omogenea. La catena montuosa degli Appennini forma una linea geografica che costituisce un confine fra due gruppi etnici distinti. La regione a nord di questa linea, la valle del Po, è abitata da persone – i Settentrionali – abbastanza alte e con la testa larga (la razza "alpina"). Gli abitanti delle zone orientali ed occidentali di questa regione mostrano apporti teutonici in Lombardia ed un'infusione di sangue slavo in Veneto. Tutta l'Italia a sud dell'Appennino e tutte le isole adiacenti sono occupate da una razza "mediterranea", di bassa statura, scura di pelle e con il viso lungo. Si tratta dei "Meridionali", che discenderebbero dall'antica popolazione italica dei Liguri, strettamente imparentati con gli Iberici della Spagna e i Berberi del Nordafrica. Il principale etnologo italiano, Sergi, li fa derivare dal ceppo amitico (v. Semitico-Amitico) del Nordafrica. Bisogna ricordare che gli Amitici non sono negritici, né veri africani, sebbene si possa rintracciare un apporto di sangue africano in alcune comunità in Sicilia e in Sardegna, oltre che in Nordafrica. L'Ufficio dell'immigrazione pone gli Italiani settentrionali nella divisione "celtica" e quelli meridionali in quella "iberica". La commistione fra i due gruppi etnici è stata relativamente scarsa, anche se molti Italiani settentrionali hanno doppiato gli Appennini ad est, facendo ingresso nell'Italia centrale. Pertanto, la linea di demarcazione fra Emiliani e Toscani è molto meno netta che fra Piemontesi e Genovesi. Un sociologo italiano, Niceforo, ha indicato che questi due gruppi etnici differiscono profondamente fra di loro, da un punto di vista sia fisico sia caratteriale. Egli descrive il Meridionale come irritabile, impulsivo, molto fantasioso, testardo; un individualista poco adattabile ad una società ben organizzata. Al contrario, descrive il Settentrionale come distaccato, risoluto, paziente, pratico e capace di grandi progressi nell'organizzazione politica e sociale della civiltà moderna. Sia i Settentrionali sia i Meridionali sono dediti alla famiglia, d'animo buono, religiosi, artistici ed industriosi. Sono quasi tutti di religione cattolica. La maggior parte dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti è reclutata fra le classi contadine ed operaie. In America, tuttavia, essi non hanno conseguito successo come agricoltori, con l'eccezione della frutticoltura e dell'enologia, soprattutto in California, dove figurano ai primi posti.
L'esperto di statistica italiano Bosco ammette che l'Italia è tuttora al primo posto in termini di numero di reati contro la persona, anche se questi sono diminuiti notevolmente in seguito al miglioramento del sistema di istruzione e all'ampio flusso di emigrazione. Su questo versante l'Italia è seguita nella graduatoria dall'Austria, dalla Francia e, a una certa distanza, dall'Irlanda, la Germania, l'Inghilterra e la Scozia. Niceforo indica, sulla base dei dati statistici italiani, che tutti i reati, soprattutto i crimini violenti, sono molto più numerosi tra i Meridionali che tra i Settentrionali. Il gioco d'azzardo è diffuso. Il gioco del lotto è un'istituzione nazionale che viene utilizzata per alimentare le casse dello Stato. Il brigantaggio è ormai pressoché estinto, fatta eccezione per alcune parti della Sicilia. Le organizzazioni segrete come la Mafia e la Comorra [sic], istituzioni molto influenti tra la popolazione che esercitano la giustizia in proprio e sono responsabili di molta parte della criminalità, prosperano nell'Italia meridionale. La maggiore difficoltà nella lotta alla criminalità sembra risiedere nella propensione degli Italiani a non testimoniare contro alcuno in tribunale e a riparare i torti ricorrendo alla vendetta (v. Còrsi).
E' indicativo il fatto che l'Italia sia uno dei paesi con il maggiore tasso di analfabetismo in Europa. Nel 1901 il 48,3% della popolazione dai sei anni in su non sapeva leggere e scrivere. In quell'anno in Calabria, la parte più meridionale della penisola, il tasso di analfabetismo tra le persone dai sei anni in su era pari al 78,7%. Il tasso di analfabetismo più basso si registra nella valle del Po, nell'Italia settentrionale. I Lombardi e i Piemontesi sono gli italiani più istruiti. La situazione è tuttavia migliorata dopo che il governo ha reso l'istruzione gratuita e obbligatoria tra i 6 e i 9 anni nei comuni dove vi erano le sole scuole elementari e dai 6 ai 12 anni nei comuni dove erano presenti scuole di più alto grado.
Tra le classi più umili la povertà è estrema; le persone vivono in alloggi miseri e hanno accesso a un'alimentazione carente, basata principalmente su granoturco mal conservato. Perfino a Venezia sembra che un quarto della popolazione viva ufficialmente di carità.
I confini geografici della razza italiana sono più ampi di quelli dell'Italia. Gruppi numerosi sono presenti in paesi vicini come Francia, Svizzera ed Austria. Le province del Tirolo e dell'Istria, in Austria, sono per un terzo italiane. Ampi gruppi sono inoltre presenti nel Nuovo Mondo. L'Italia stessa è quasi interamente italiana. Ha una popolazione di 34 milioni di persone e comprende solo piccoli bacini di altre razze (circa 80.000 Francesi nell'Italia nordoccidentale, 30.000 Slavi nell'Italia nordorientale, circa 30.000 Greci nell'Italia meridionale, circa 90.000 Albanesi in Italia meridionale e in Sicilia e 10.000 Catalani (Spagnoli) in Sardegna. Un certo numero di Tedeschi, forse meno di 10.000, è presente nelle Alpi italiane. Circa due quinti della popolazione dell'Italia si trovano nella valle del Po, ovvero in meno di un terzo della lunghezza del paese. Suddivisa approssimativamente in compartimenti, la popolazione di quest'area, occupata da Italiani settentrionali, conta circa 14 milioni di persone. Questa cifra include i Friulani dell'Italia nordorientale i quali, pur parlando una lingua latina distinta dall'italiano, sono difficilmente distinguibili dagli Italiani settentrionali. Il loro numero si situerebbe, a seconda delle diverse stime, tra 50.000 e 450.000. La popolazione dei distretti meridionali è di circa 19.750.000 persone, di cui 125.000 appartengono ad altre razze. La maggior parte degli Italiani della Francia, della Svizzera e dell'Austria sono sul piano della razza Italiani settentrionali. Quelli della Corsica, isola appartenente alla Francia, sono Italiani meridionali.
Distribuzione degli Italiani (stima riferita al 1901)
In Europa:
Italia 33.200.000
Francia 350.000
Svizzera 200.000
Austria 650.000
Corsica 300.000
Altre parti d'Europa 300.000
Totale 35.000.000
Altrove:
Brasile 1.000.000
Rep. Argentina 620.000
Altre parti del Sudamerica 140.000
Stati Uniti 1.200.000
Africa 60.000
Totale 3.020.000
Totale nel mondo (cifra approssimata) 38.000.000
A partire dal 1900, in alcuni anni oltre mezzo milione di italiani è emigrato nelle diverse regioni del mondo. All'incirca la metà di tale flusso ha come destinazione altri paesi europei ed è di carattere temporaneo, in quanto riguarda sopratutto la popolazione maschile. Dal 1899 fino a tutto il 1910 negli Stati Uniti sono stati ammessi 2.284.601 immigrati italiani, ed è stata altresì consistente l'immigrazione italiana verso l'America del Sud. La maggior parte delle persone che giunge negli Stati Uniti rientra successivamente in patria. Tuttavia, soprattutto a New York e negli altri Stati dell'Est il numero di coloro che rimangono è elevato. Nel 1907 gli immigrati provenienti dall'Italia meridionale sono stati oltre 240.000, un numero più che doppio rispetto alla razza di immigrazione che come consistenza si colloca subito dopo quella degli immigrati italiani meridionali. Il numero degli arrivi di Italiani settentrionali è solo un quinto di tale cifra. La notevole capacità della razza italiana di popolare altre parti del mondo risulta evidente dal fatto che la presenza italiana supera numericamente quella degli Spagnoli nell'Argentina spagnola e dei Portoghesi in Brasile, nonostante quest'ultimo sia un paese "portoghese". (vedi Ispanoamericani). Attualmente, ai fini dello studio del fenomeno dell'immigrazione il flusso migratorio degli Italiani verso gli Stati Uniti è forse il più significativo, e non solo perché risulta essere molto più consistente di ogni altro gruppo nazionale in qualunque anno di riferimento e perché è elevata la percentuale degli Italiani per ogni mille immigranti che entra sul territorio degli Stati Uniti. Ancora più significativo è il fatto che questa razza è più numerosa di qualsiasi altra tra la decina di razze che figurano ai primi posti come tasso di immigrazione. In altre parole, in virtù di una popolazione di 35.000.000 e di un elevato tasso di natalità, questa razza continuerà a primeggiare anche quando la spinta delle altre razze, attualmente responsabili dell'ondata di immigrazione, tra cui gli Ebrei (8.000- 000[sic]), gli Slovacchi (2.250.000) e il gruppo Sloveno-Croato (3.600.000), sarà esaurita, come di fatto sta già avvenendo per gli Irlandesi. Un fatto non necessariamente noto è che nel decennio 1891-1900 l'Italia era il principale paese di origine dell'immigrazione in America. All'inizio degli anni ottanta, ovvero quasi trent'anni fa, l'Italia aveva già cominciato a guadagnare terreno rispetto ai paesi dell'Europa settentrionale. Tuttavia bisognava attendere il 1890 per vedere gli Stati Uniti sorpassare l'America meridionale come destinazione privilegiata dei flussi migratori provenienti dall'Italia. Nel decennio precedente e nei periodi antecedenti il Brasile ha accolto più italiani della Repubblica Argentina, sebbene si ritenga erroneamente che sia quest'ultima ad ospitare la più grande comunità italiana dell'America meridionale. Nel 1907 gli Stati Uniti hanno accolto 294.000 dei 415.000 Italiani emigrati oltreoceano. Nello stesso anno le persone emigrate, per lo più temporaneamente, dall'Italia verso altri paesi europei sono state 288.774. L'immigrazione italiana negli Stati Uniti è stata finora prevalentemente di carattere temporaneo. Mosso calcola che il periodo medio di permanenza degli Italiani negli Stati Uniti sia di otto anni. L'emigrazione più consistente verso oltreoceano dall'Italia ha la sua origine nelle regioni a sud di Roma, abitate dagli Italiani meridionali. Gli emigrati provengono soprattutto dalla Sicilia e dalla Calabria, ovvero dai territori meno produttivi e meno sviluppati del paese. L'emigrazione dalla Sardegna (Vedi) è scarsa. Il compartimento della Liguria, territorio di provenienza dei Genovesi, anch'essi appartenenti alla razza degli Italiani meridionali, registra più emigrazione di qualsiasi altra provincia dell'Italia settentrionale. Il flusso complessivo dell'immigrazione verso l'America da alcuni compartimenti italiani ha raggiunto proporzioni ingenti, al punto da superare più volte il tasso di crescita naturale della popolazione. Questo ha già causato il parziale spopolamento di alcuni distretti agricoli. Se confrontati con altre razze di immigrati e con il numero assoluto degli arrivi, gli Italiani meridionali sono i più numerosi: 1.911.933 nei dodici anni compresi tra il 1899 e il 1910, seguiti dagli Ebrei, 1.074.442, dai Polacchi, 949.064, dai Tedeschi, 754.375 e dagli Scandinavi, 586.306. I Settentrionali sono al nono posto nell'elenco relativo allo stesso periodo: 372.668, subito dopo gli Inglesi e gli Slovacchi, ma prima dei Magiari, dei Croati e degli Sloveni e dei Greci. Per quanto riguarda il tasso del movimento transatlantico, è piuttosto evidente un contrasto tra Settentrionali e Meridionali: ad esempio, nel 1905 l'emigrazione dalla Calabria è stata undici volte maggiore di quella proveniente dal Veneto. Nel 1907 l'indice dello spostamento dei Settentrionali verso gli Stati Uniti è stato di circa il 3 per 1000 della relativa popolazione presente in Italia, mentre quello degli Italiani meridionali è stato del 12 per 1000. L'indice di movimento dei Settentrionali è stato più o meno lo stesso di quello degli Svedesi e dei Finlandesi, è stato il triplo di quello dei Tedeschi, ma solo la metà di quello dei Ruteni provenienti dall'Austria-Ungheria. Il tasso di movimento dei Meridionali verso gli Stati Uniti, d'altra parte, è superato solo dal gruppo Croato-Sloveno, che nel 1907 è stato del 13 per mille della popolazione, e dagli Ebrei e dagli Slovacchi che, nello stesso anno, è stato del 18 per mille della popolazione. Gli immigrati italiani giungono negli Stati Uniti, oltre che dall'Italia, principalmente dai seguenti paesi: il Nordamerica britannico (3.800 nel 1907), l'Austria-Ungheria (1.500), il Regno Unito (600), il Sudamerica (600) e la Svizzera (200). Quelli provenienti dalla Svizzera e dall'Austria-Ungheria generalmente sono Settentrionali.
Nei dodici anni tra il 1899 e il 1910, le principali destinazioni negli Stati Uniti dei due gruppi di Italiani sono state le seguenti:
Settentrionali
New York 94.458
Pennsylvania 59.627
California 50.156
Illinois 33.525
Massachusetts 22.062
Connecticut 13.391
Michigan 13.355
New Jersey 12.013
Colorado 9.254
Meridionali
New York 898.655
Pennsylvania 369.573
Massachusetts 132.820
New Jersey 106.667
Illinois 77.724
Connecticut 64.530
Ohio 53.012
Louisiana 31.394
Rhode Island 30.182
West Virginia 23.865
Michigan 15.570
California 15.018
Una poesia per i pataccari di sinistra, scrive “L’Anarca” (Giampaolo Rossi ) su “Il Giornale”. I discepoli intellettuali del politically correct hanno l’abitudine di prendersi troppo sul serio; succede sopratutto quando si cimentano nel nobile mestiere dell’impegno sociale mettendo la loro fama e la loro arte a disposizione della lotta all’oscurantismo reazionario. È successo anche a Elio Germano, l’attore militante che ha realizzato il video-patacca contro il razzismo di cui abbiamo denunciato il falso in questo articolo di ieri. Il video si conclude con l’attore che legge, ad un gruppo di bambini Rom visibilmente annoiati e usati come scudi della sua vanità ideologica, una poesia di Trilussa in romanesco. Per non essere da meno, ho deciso di scrivere una poesia anche io, proprio nel dialetto di Trilussa, dedicandola a Elio Germano, ai maestrini radical-chic e alle loro false “verità assolute” diffuse come un virus. Un piccolo omaggio ironico all’abitudine pataccara della sinistra intellettuale e artistica di spargere scemenze spacciandole per verità.
L’ARTISTA DE SINISTRA
Il razzismo, se sa, è brutta robba.
È segno de incivile intolleranza tipica de chi ragiona co’ la panza.
Ma, di certo, ‘na cosa assai più brutta
è l’intellettuale quanno rutta.
Quanno se erge cor dito moralista
e come er Padreterno,
dei buoni e dei cattivi fa la lista.
Filosofo o scrittore, poeta o cantautore, attore o saltimbanco,
è come se la storia s’inchinasse all’astio livoroso e intelligente
de chi se crede sempre er più sapiente.
Spesso nun sa manco de che parla, ma parla per parla’
e per l’impegno preso e coltivato con lo sdegno
de chi è convinto che deve lascià un segno.
L’artista de sinistra in tracotanza,
dall’alto del suo ego trasformato,
diventa un drogato de arroganza.
Lui se convince de esse come un Faro,
invece, spesso, è solo un gran Cazzaro.
Ecco l'Italia che trasforma il Tricolore in uno straccio. La bandiera nazionale va esposta per legge davanti a scuole e uffici pubblici. Ma nessuno se ne cura. E lo spettacolo è avvilente, scrive Nino Materi su “Il Giornale”. L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui la Bandiera nazionale, invece che garrire al vento, rantola in aria. Come un impiccato sul pennone più alto. Tanto in alto che nessuno si premura di prendersene cura. Triste, tristissima la vita del nostro glorioso Tricolore: tradizionale simbolo di (dis)amor di Patria. Un vessillo di cui ci ricordiamo solo in occasione dei Mondiali di calcio, almeno quelli in cui gli Azzurri non fanno figuracce. Ma poi nella vita di tutti i giorni il vessillo Bianco, Rosso e Verde tende a virare in commedia, assumendo i toni del bianco, rosso e verdone. Un film tragicomico (più tragico che comico) che va «in onda» quotidianamente su ogni edificio pubblico: scuole, biblioteche e uffici. Da Nord a Sud l'Unità d'Italia è fatta, ma si incarna in quel pezzo di stoffa che viene vergognosamente esposto alla stregua di uno straccio con cui si è appena smesso di fare le pulizie. E dire che nella Costituzione figura un preciso dettato normativo sancito dalla Legge 5-02-1998 n.22 e dal Dpr 07-04-2000 n. 121, il cui capo IV (punto 9) recita testualmente: «Le Bandiere vanno esposte in buono stato e correttamente dispiegate». Roba che se la violazione venisse effettivamente perseguita, dovrebbe essere denunciata la maggior parte dei funzionari statali. Non fanno eccezione neppure gli edifici sedi di istituzioni «prestigiose» come prefetture, questure, tribunali. Ma anche qui il Tricolore sventolante appare in salute come un moribondo. Non c'è spettacolo più avvilente per un cittadino orgoglioso di essere italiano che vedere la Bandiera della propria nazione ansimare sporca e stracciata. Fateci caso. Quando entrate in un ufficio alzate lo sguardo e, nove volte su dieci, sulla vostra testa vedrete curvo su se stesso un Tricolore sdrucito e sozzo. Nessun direttore, funzionario, dirigente, impiegato, segretario (fin giù a all'ultimo degli inservienti) che si ponga il problema non dico di lavare una bandiera annerita o sostituirne una a brandelli. No. Si cambiano con periodica perizia le merendine dalle macchinette degli uffici, ma del Tricolore non frega nulla a nessuno. Lui può morire d'inedia nell'indifferenza generale. Beh, quasi generale. Considerato che, almeno una persona, ha deciso di levare un urlo di dolore in difesa di un simbolo per il quale sono morti migliaia di soldati. Si tratta del Maggiore Gennaro Finizio, dell'Unuci (Unione ufficiali in congedo) che in una lettera aperta al sito Basilicata24 denuncia lo scandalo-Bandiera: «Se si vuol valutare l'orgoglio di un Popolo e pesarne il livello di diffusione e condivisione del concetto di identità nazionale, è sufficiente osservare se, ed in quale modo, espone la propria Bandiera; nel nostro caso, il Tricolore. Ebbene, le condizioni in cui sono esposte le nostre Bandiere, sulle facciate degli edifici pubblici e sedi di Istituzioni, riflettono chiaramente il livello di crisi sociale e di sfiducia, segnalando la dimensione di un Paese che ha perso i suoi punti di riferimento; un Paese impoverito nei Valori». Chi disonora il Tricolore, infanga la propria Storia. E poi: «Non sfuggirà, all'osservatore attento, che un po' ovunque sono presenti Tricolori laceri, sporchi e, nella migliore delle situazioni, esposti in modo errato; Bandiere offese indecorosamente sino al punto da sembrare private della forza di sventolare. Come si legge questo degrado sociale? Abbiamo, forse, perso la nostra dignità e la volontà di sentirci orgogliosamente italiani? Forse non crediamo più nel nostro simbolo, perché derubricato a semplice icona della Nazionale di calcio?». Il Maggiore Finizio prova anche a dare delle risposte: «Temo che tutto questo sia da ascrivere a semplice, ma deleteria, incuria e mancanza di sensibilità. Quella stessa sensibilità che troviamo ad esempio negli statunitensi, negli inglesi, francesi e tedeschi». Da noi, invece, fino a qualche tempo fa, l'ex leader della Lega poteva impunemente urlare in piazza contro una signora che esponeva il Tricolore alla finestra: «Signora, con quella bandiera può anche pulirsi il culo...».
Un Paese invivibile, scrive Livio Caputo su “Il Giornale”. Nei due mesi scorsi mi sono dedicato a un esercizio che si è rivelato molto deprimente: ho chiesto a cinquanta amici e conoscenti quanti di loro avessero subito, negli ultimi tre anni, scippi, furti in casa o in strada, truffe, vandalismi, violenze,richieste di pizzi o tangenti, o altri “attacchi” da parte dei vari tipi di delinquenza, organizzata e non. Ebbene, il risultato è stato 47, cioè quasi il 95 cento. Tra i racconti che ho raccolto c’era di tutto e di più, perfino quello di due sedicenti dipendenti comunali che si sono introdotti con un pretesto nell’abitazione di una signora e, forse ipnotizzandola, forse drogandola, l’hanno persuasa a consegnare “spontaneamente” tutti i suoi preziosi. Comunque, il campionario dei reati subiti, che peraltro avrei potuto mettere insieme anche compulsando attentamente la cronaca nera dei giornali, era talmente vario da poterci scrivere un trattato di criminologia. L’impressione complessiva, comunque, era che il Paese, nonostante le statistiche che danno un certo numero di reati in calo, sia sempre più fuori controllo e che un senso di insicurezza si sia ormai impadronito della maggioranza dei cittadini. Un altro dato inquietante emerso dalla mia indagine è che buona parte delle vittime ha ormai rinunciato a denunciare i reati subiti se non ci sono esigenze assicurative di mezzo. Che senso, infatti, ha perdere tempo a denunciare il furto di una bicicletta, lo scippo subito in un parco, una casa svuotata dagli zingari, quando le possibilità di recuperare la refurtiva sono pari a zero? E, comunque, che soddisfazione ricava il cittadino se l’autore del reato, nell’ipotesi remota che venga individuato e arrestato, viene poi subito messo in libertà, libero di reiterare il suo crimine anche l’indomani? O, se anche viene processato, se la cava con pene lievi con la condizionale, o esce comunque di galera assai prima di quanto dovrebbe per condoni, buona condotta, eccessivo affollamento delle carceri o quant’altro? Una delle mie interlocutrici si è particolarmente infuriata leggendo che una donna rom che l’aveva derubata è stata arrestata – mi pare – una dozzina di volte e sempre rilasciata. In effetti, una delle cause principali per cui non solo aumenta la delinquenza nazionale, ma bande di ladri, rapinatori e scassinatori arrivano da ogni parte d’Europa per operare nel nostro Paese è la quasi impunità di cui, alla fine, finiscono di godere. Come reagiamo di fronte a questi fenomeni, che ci rendono tutti più timorosi e insicuri? Riducendo i mezzi a disposizione delle forze dell’ordine, abbastanza numerose se confrontate con quelle degli altri grandi Paesi occidentali, ma spesso impegnate in altre funzioni, come le scorte a politici, ex politici e compagnia cantante, che li distolgono dai loro compiti primari. Depenalizzando una serie di reati cosiddetti minori, che in realtà colpiscono la cittadinanza nella sua esistenza quotidiana anche peggio di altri. Svuotando periodicamente le carceri perché eccessivamente affollate e non in grado di garantire i diritti dei detenuti, invece di costruirne di nuove o utilizzando quelle già esistenti, ma lasciate vuote per carenza di guardie penitenziarie. Tenendoci gli innumerevoli stranieri che delinquono (la loro percentuale tra i detenuti è molto superiore a quella degli italiani) invece di espellerli appena espiata la pena. Se la percentuale di cittadini carcerati rispetto alla popolazione è metà di quella della Francia e della Gran Bretagna e addirittura un decimo di quella degli Stati Uniti non ci si può poi meravigliare se il tasso di delinquenza, denunciata e non denunciata, è così alto. Un altro scandalo è quello dello scarsissimo numero di cosiddetti colletti bianchi, e in particolare di esponenti di rilievo della burocrazia e della finanza, anche accusati di reati infamanti, di furti e truffe milionari o di reati particolarmente dannosi per la comunità che finiscono effettivamente in galera. Tra appelli, prescrizioni, condoni, sono pochissimi, e nei (rari) casi in cui ciò avviene fa addirittura notizia. La maggior parte, anche se, sulla carta, condannata ad anni di reclusione, continua a godersi la vita in perfetta libertà, con un effetto negativo sulla credibilità della giustizia, specie tra i giovani, che può riuscire devastante. La durata infinita dei processi, e i mille cavilli che la nostra legislazione consente di usare agli avvocati difensori, non fanno che rendere la situazione ancora più insostenibile. Potrei continuare per pagine e pagine, riprendendo episodi incredibili che si incontrano quasi ogni giorno sui giornali, ma sarebbe superfluo. La conclusione sarebbe comunque la stessa, che la qualità della vita dei cittadini onesti va continuamente peggiorando. Ricordo che, ormai molti anni fa, un mio amico inglese, corrispondente di un grande giornale da Roma, soleva dirmi:”Il vostro è il Paese in cui si vive meglio in Europa, basta non avere a che fare con l’autorità (intendendo fisco, burocrazia, vigili, tribuanli, ecc.). Oggi non è più vero. Bisogna aggiungere “….se si ha la fortuna, sempre più rara, di non imbattersi in qualche malfattore”.
I nuovi mostri dei Soliti Idioti "L'Italia? Un inferno da ridere". Biggio e Mandelli rivisitano Dante nel film: «Abbiamo raccontato con affetto le deformità di ciascuno di noi», scrive Cinzia Romani su “Il Giornale”. Nati non foste a viver come bruti. Lo rammentano i Soliti Idioti con la rappresentazione plastica degli abominevoli peccati italiani al giorno d'oggi. Tipo abbruttirsi al bar alle otto di mattina, uccidere per questioni di traffico all'ora di punta, travolgere gli altri al supermercato, stare sempre connessi o farsi irretire dalla pubblicità invasiva. Per forza, poi, ci vuole il Ministero della Bruttezza a dirimere le controversie dei consumatori di laidume. Così col loro terzo film, La solita Commedia. Inferno (da giovedì in sala), Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli puntano alla versione 2.0 de I nuovi mostri , accatastando sketch e personaggi come in pista sul web, dal quale provengono. Pur essendo relativamente giovani (Biggio è classe '74, Mandelli è del '79), gli infernali registi, qui in tandem con Martino Ferro, nonché protagonisti e sceneggiatori d'un racconto corale, rimpiangono il passato. Quando si usava il telefono a gettoni, come fa Minosse (Mandelli) per chiamare il suo superiore, un Dio che tracanna whiskey e fuma. O quando si picchiavano i tasti della macchina per scrivere, come fa un tenente (Biggio), pronto a scagionare due poliziotti dal reato di abuso di potere nei confronti d'una macchinetta che non dà resto. Perché prima era tutto più bello, ancora non ci aveva invasi la Grande Bruttezza: altro che Isis. Siamo dalle parti della surrealtà più dichiarata, con tanti attori che interpretano dai 21 ai 7 ruoli a testa per raccontare una società malata. E c'è pure Tea Falco, già musa di Bertolucci, nei panni d'un Gesù tosto, quando sequestra a un precario di nome Virgilio (ancora Biggio) i suoi attributi. Che riavrà se accompagnerà Dante (ancora Mandelli) a catalogare i nuovi peccati commessi sulla terra, segnatamente a Milano, postaccio caotico zeppo di hackers, pornomani e tecno-incontinenti. «Volevamo raccontare con affetto l'Italia e gli italiani. E la mostruosità di ognuno di noi, guardando a I nuovi mostri », dice Biggio. Ironia a parte, alcune categorie vengono prese di petto. Quella dei poliziotti, per esempio, raffigurati come paranoici violenti. Diverte l'interrogatorio stile Csi della macchinetta del caffè, rea di non rendere gli spicci ai piedipiatti, ma fa pensare a un certo tipo di giudizio. «Ci piace provocare e dar fastidio, però non vogliamo descrivere tutta la polizia così. Come ci piace l'idea d'un Dio indaffarato nei suoi casini. Il nostro padre Pio, non me ne voglia Castellitto, è il migliore. Non temiamo le risposte dei cattolici», spiega Mandelli. E in effetti, l'idea d'intruppare i santi in una specie di Camera, a decidere come procedere per catalogare nuovi peccati terreni, non è male. «Ci piace forzare il pubblico, vedere come rispondono i cattolici», butta lì Biggio. Di sicuro, il duo comico è maturato e cerca un nuovo sbocco. «Ci avevano proposto di fare il terzo film dei Soliti idioti , ma ci siamo messi alla prova con una cosa diversa. Chi fa il nostro mestiere, cerca sempre di uscire dalla zona comfort. Come abbiamo fatto a Sanremo: stare su quel palco, è stata una sfida», puntualizza Mandelli. Colpisce, a ogni modo, che per smarcarsi dall'ennesima commedia all'italiana, i Soliti Idioti abbiano realizzato un'idea semplice e geniale: sciorinare i più brutti vezzi italioti contemporanei, in stile Nanni Loy, dopo aver riferito tic e nevrosi del Bel Paese nei loro lavori precedenti. È andato in questo senso pure Maccio Capatonda con Italiano medio e non a caso il duo pensa a una collaborazione col comico abruzzese. Costato 3 milioni e finanziato pure dalla Film Commission del Lazio (la maggior parte delle scene, tuttavia, si svolge a Milano),il film è prodotto dalla Wildside di Mario Gianani, marito della Madia e di Lorenzo Mieli, figlio di Paolo. E non a caso il Ministero della Bruttezza Biggio&Mandelli lo affiderebbero «a Gasparri, Alfano e Salvini», che non è gente di sinistra.
L’italiano medio è volgare e squallido, ma diverte. La recensione di Marita Toniolo su “Best Movie”. Sbarca al cinema l’opera prima del comico Maccio Capatonda, che vuole farci ridere e vergognare di come siamo diventati. Dopo i successi stratosferici di Zalone al botteghino, si torna a puntare forte su un volto “televisivo” con Maccio Capatonda e il suo Italiano medio, prossimo a sbarcare al cinema con 400 copie al suo esordio (il 29 gennaio). Maccio Capatonda, al secolo Marcello Macchia, è un fenomeno di culto del web amatissimo dai cinefili grazie ai suoi trailer parodia: un centinaio di secondi e poco più in cui Capatonda riesce a comprimere mirabilmente genio e follia, cinefilia e non-sense, giochi di parole e travestimenti, raggiungendo una popolarità che lo ha portato a sbarcare anche su MTV con la serie Mario. Lo attendeva al varco la sfida più tosta: il lungometraggio. Riuscire a essere altrettanto esplosivo in un tempo dilatato. Italiano medio, diretto, scritto e interpretato da Maccio, è infatti lo sviluppo del finto trailer di Limitless con Bradley Cooper: due minuti, in cui era un uomo intelligente e socialmente responsabile, che assumeva una pillola che gli cambiava totalmente la vita. Parodisticamente, rispetto alla Lucy di Besson che si ritrova ad avere a disposizione il 100% del cervello, Maccio deve capire cosa riuscire a fare con solo il 2%… E proprio da questa domanda prende il via il racconto. Giulio Verme è il perfetto emblema dell’uomo socialmente impegnato: allergico alla televisione sin da bambino, avverso a ogni massificazione, vegano convinto, sempre pronto ad aiutare gli emarginati, con la fissa per l’ambiente e le scelte etiche ed ecosostenibili. Addetto allo smistamento dei rifiuti a Milano, cerca di inculcare un po’ di senso civico nei colleghi, che gli rispondono a suon di scoregge. La radicalità delle sue scelte finisce per creare un muro tra lui e le persone che lo circondano: i genitori in primis, gli amici, i vicini e persino la fidanzata Franca, esasperata dal suo atteggiamento da uomo frustrato e ostile, ma fondamentalmente passivo. Giulio si ritrova isolato e disperato, sopraffatto dal “lerciume” che lo circonda, sempre più nevrotico e ansioso. Finché nella sua vita non approda l’amico Alfonzo, un ex compagno antipatico delle elementari che gli offre una pillola straordinaria, che gli permetterà di usare solo il 2% del cervello, invece che il 20%. La metamorfosi sarà da Dottor Jekyll e Mr Hyde: da attivista rompiscatole e fanatico, Giulio diventerà un tronista beota con il mantra fisso dello “scopare”, della disco e del lusso cafonal, volgare e ignorante, carnivoro e menefreghista, guadagnandosi – impresa becera dopo l’altra – il diritto alla partecipazione al reality show più di culto del momento. L’apoteosi dell’italiano medio. Capatonda ha messo tutto se stesso in questa opera prima e il primo punto a favore gli deriva dall’enorme cura del dettaglio che il film mostra. Nulla è lasciato al caso, a partire dagli esilaranti titoli di testa (Tratto da una storia finta), che fanno partire in quinta il film e che denunciano da subito il pedigree cinefilo dell’autore. Che ha di fatto disseminato tutto il film citazioni filmiche facili da riconoscere via via. Tuttavia, il triplo salto carpiato dai video di 1/2 minuti al lungo di 100 equivalgono a passare dallo sguazzare in una piscina a nuotare nell’oceano. C’è un traccia coerente di fondo, ma i raccordi tra una scena comica e l’altra si stiracchiano troppo, portando con sé come conseguenza negativa la reiterazione di situazioni e tormentoni per allungare il brodo (amechemmenefregame, Sant’Iddio, Scopare…). Raccontare una metamorfosi in un video di 130 secondi risulta efficace, dilatarla con un continuo sdoppiamento di personalità ed esplicitando la lotta interiore sempre più opprimente che Verme si ritrova a combattere tra i suoi istinti primari da bifolco e gli intenti nobili, produce l’effetto di frammenti anche geniali, ma non ben incollati in un mosaico coerente. Se la struttura narrativa è il punto debole più evidente di Italiano medio, va invece segnalata – come altro punto a suo favore – il peso specifico delle riflessioni, per nulla superficiali. Lo sguardo di Maccio sull’Italia e i suoi concittadini è amaro e disilluso, quasi crudele. Con un disgusto e un disprezzo maggiore di quello dello storico Fantozzi verso l’impiegato piccolo piccolo, Maccio non risparmia colpi a colti e ignoranti, ricchi e poveri, impegnati e menefreghisti. Giulio Verme sdoppiato sintetizza le sublimi vette dell’arte del compromesso toccate dell’italiano, capace di essere vegano e mangiare il pollo fritto; andare in chiesa e avere mogli e amanti; difendere il bio e inquinare. Opposti apparentemente inconciliabili, che – come vedremo nel finale – invece, per gli abitanti del Bel Paese sono assolutamente ricomponibili, abituati come siamo ad accettare obbrobri edilizi che radono al suolo parchi bio, scandali sexual-politici, indecenze cultural-mediatiche dei reality (memorabili lo scandalo del bianchino nel privè, che ha portato all’esclusione di Kevin, e la “prova pippotto”), come se fossero parte integrante e inalienabile del sistema. Maccio non ce le manda a dire, ma stigmatizza tutti i nostri vizi, costringendoci a ridere (amaramente) di essi. Come sempre, è circondato dai soliti attori fidati: l’inseparabile Herbert Ballerina, che si trasforma in tre personaggi diversi; Rupert Sciamenna, imprenditore squalo con i capelli rosa; Ivo Avido, anche lui triplice. Molti i colleghi che si sono prestati per differenti camei: lo Zoo di 105, Raul Cremona, Andrea Scanzi, Pierluigi Pardo e il principe assoluto del non sense Nino Frassica. L’impiego degli stessi attori in più ruoli e con costumi diversi, pur se giustificato dal surrealismo che ìmpera, genera spesso un effetto cabaret innestato nel cinema che non giova alla dimensione estetica del film. Sebbene gli vada anche riconosciuta una fotografia curata (di Massimo Schiavon), che alterna colori diversi quando la personalità di Giulio cambia, non abbiamo sempre la sensazione di trovarci di fronte a un film tout court, limite più forte dei comici italiani importati dalla Tv. Eppure, pensiamo che l’opera prima di Maccio vada premiata (anche per incoraggiamento, affinché continui a perfezionarsi, per giungere a una scrittura più equilibrata), perché regala sane risate, momenti di genio surreale (il folle “piano” finale degli attivisti) ed è una satira feroce che invita alla riflessione, come non accadeva da tempo in un film comico italiano. Da Rodotà-tà-tà a onestà-tà-tà, viaggio pre-Quirinale nella spaesata piazza grillina senza capo né nome, scrive Marianna Rizzini su “Il Foglio”. Da Rodotà-ta-tà a onestà-tà-tà. Dopo quasi due anni di Parlamento e alla vigilia di una nuova elezione presidenziale, la piazza a Cinque Stelle parla d'altro ( la "mafia capitale" da non dimenticare: da cui la pubblica lettura delle intercettazioni tratte dall'omonima inchiesta – per la gentile interpretazione di Claudio Santamaria e Claudio Gioè, attori e volti da romanzi criminali su piccolo e grande schermo). Onestà-tà-tà, dunque, al posto del nome che non si farà, non si vuole fare e non si vuole neanche ascoltare (il deputato e membro del direttorio a Cinque Stelle Alessandro Di Battista a un certo punto legge e fa leggere alla pizza la dichiarazione-gran rifiuto: caro Renzi ecco la risposta del popolo – e pare quasi di sentir parlare un robot, la famosa futuribile app che renderà possibile conversare con amici virtuali come nel film "Her" con Scarlett Johansson nella parte dell'amante fatta di web, solo che qui il tono non è suadente: lei ha già deciso, Renzi, e al Nazareno non veniamo). Onestá-tá-tá, e altre parole di un lessico chiama-applauso in una Piazza del Popolo che all'inizio era mezza vuota e percorsa da interesse per l'altrove del sabato pomeriggio: gente che faceva vedere l'acquisto da saldo e giovani rapper -break dancer con tappeto di plastica per performance estemporanea sul selciato. "La gente è arrivata", esclama una signora quando il suo wishful thinking, finalmente, diventa realtá, e arriva pure Sabina Guzzanti comica non più comica, ché, prevale, nel suo intervento, l'invettiva-imitazione in teoria civile in realtá elitaria contro Maria De Filippi, emblema del paese in cui da vent'anni, dice Guzzanti, si è perduto ogni " stimolo intellettuale", e sembra impossibile fare qualcosa: le persone colte riescono a stare insieme per combinare qualcosa, è il concetto espresso da Sabina, le persone ignoranti no. Colpa della tv, è la sentenza che alla fine dell'invettiva tutti si aspettano, e le ragazze del bar all'angolo della piazza si domandano perché mai "Sabina se la prenda con la De Filippi". Ma gli applausi a quel punto sono già stati tributati alla divinità nascosta che la piazza omaggia a intervalli regolari: l'onestà, rieccola, parola buona per tutto e piena in fondo di niente, se non della generica riprovazione per le altre bestie nere della serata (persino il rapper Fedez le dice e non le canta: corruzione, resistenza, vergogna, marciume, e mafia mafia mafia). Tutto è mafia, dicono i deputati, senatori e consiglieri comunali grillini che sfilano sul palco (Roberta Lombardi, la veterana dei primi streaming a Cinque Stelle, dice che una mattina si è svegliata e ha trovato non l'invasore ma una città che diventa proprio quello che ora, chissà perchè, tutti evitano di ricordare: il teatro della mafia capitale. La senatrice stornellista Paola Taverna, in strana inversione di ruoli con Fedez, pare quasi una rapper quando intona lo slogan degli slogan: fuori la mafia dallo Stato. Fedez invece, sempre senza cantare, dice la frase che qualcuno nel pubblico trova "un po' cosi" nel giorno in cui l'Isis decapita un altro ostaggio, di nazionalità giapponese: abbiamo il nemico in casa ma non è di fede musulmana, dice Fedez, e le grandi stragi sono di matrice italiana. Il più grande nemico dell'Italia sono gli italiani, continua, e a quel punto l'applauso arriva, forse per riflesso condizionato (sono già due ore che gli astanti sentono dire peste e corna dell'universo mondo nazionale). "Fuori i nomi, Renzi"', grida il tribuno Di Battista, e alla fine Beppe Grillo esce per dire la stessa cosa, ma con il marchio di fabbrica: vaffanculo! (Vaffanculo e fate i nomi). Il resto è uso traslato (e a volte insensato) di termini impossibili a odiarsi: valori, costituzione, libertà, partecipazione (povero Gaber), cultura. Grillo invece parla di sottocultura, insultando qui e lì Giorgio Napolitano per non aver riconosciuto "il miracolo" a cinque stelle, anche se il miracolo Grillo se l'è sfasciato da solo. Resta solo da dire no al "Nazareno", demone antropomorfo. Ed è subito sabato sera mentre gli attivisti sbaraccano, e sulla piazza che si svuota si diffonde, incongrua, la più classica canzone dei Pink Floyd ("another brick in the wall").
IL MONDO SEGRETO DELLE CASTE E DELLE LOBBIES.
È la bestia nera delle banche. "Errori nei conteggi e usura". Giovanni Battista Frescura: "Ho visto fallire bellissime aziende per insolvenze inesistenti. Le Procure archiviano le denunce perché colluse con il potere finanziario: è un cancro", scrive Stefano Lorenzetto su “Il Giornale”. «Tutti i conti delle banche sono sbagliati. Le prime a saperlo sono le banche stesse». Con tale premessa, s'intuisce perché Giovanni Battista Frescura, consulente tecnico nei processi sul contenzioso bancario, sia diventato la bestia nera degli istituti di credito. Quando lo denunciò, una decina d'anni fa, gli italiani disposti ad assumersi l'onere di un'affermazione così temeraria si contavano sulle dita della mano sinistra di Capitan Uncino. In pratica, lui solo. E subito ne aggiunse un'altra: «Tutte le banche hanno praticato o praticano l'usura». Era più scusabile, all'epoca, una bestemmia in duomo. A sconsacrare le chiese laiche dove la religione dei soldi celebra i suoi riti è stato Frescura, che in questo momento sta seguendo circa 200 casi di clienti presi per il collo da Bolzano a Messina. Lo ha fatto dapprima con il libro Usura e anatocismo nelle operazioni di credito finanziario e poi con un secondo tomo di 698 pagine, L'usura nei prestiti di banche e finanziarie, che nel sottotitolo in latino riprende la definizione attribuita a Carlo Magno nel capitolare di Nimega dell'anno 806, Usura est ubi amplius requiritur quam datur, si ha usura quando si richiede più di quanto si dà. Quasi 2 connazionali su 10 hanno qualche problema con le banche. La stima è di un banchiere, Dino Crivellari, amministratore delegato di Uccmb, gruppo Unicredit, che si occupa di crediti deteriorati. Per l'esattezza il contenzioso coinvolge 10 milioni di cittadini su 60. Frescura, 61 anni, residente a Valdagno (Vicenza), sposato, tre figli ormai adulti, è uno di questi. «Nel 1995 comprai una casa con un mutuo di Unicredit, poi rimborsato in 15 anni. Per ristrutturarla, chiesi un finanziamento quinquennale di 40 milioni di lire ad Antonveneta. Ebbi qualche difficoltà a pagare le rate. Dopo tre anni il debito era salito a 60 milioni. Avete sbagliato i conti, protestai, e ne restituii 40. Invece, secondo loro, l'anatocismo, cioè il calcolo degli interessi sugli interessi, pesava solo per 1 milione di lire. Per cui mi fecero un decreto ingiuntivo di 19 milioni. Con le spese legali, la somma da restituire superava addirittura i 20 che, a loro dire, ancora gli dovevo. Mi rifeci da solo i conteggi. Alla mia minaccia di denunciarli per usura, reagirono con violenza: "La quereliamo per diffamazione". Querela mai arrivata. In compenso, per un contenzioso da 10.000 euro, mi hanno venduto all'asta la casa, che ne vale 350.000. Ho denunciato per usura ed estorsione la banca, l'avvocato dell'ingiunzione, il notaio che ha gestito l'asta e anche l'acquirente. Per il momento abito ancora dentro la mia abitazione, in attesa che il tribunale di Vicenza decida chi ha torto e chi ha ragione». A differenza dei giudici, quasi tutti usciti dal liceo classico e quindi impermeabili alle formule matematiche, Frescura sa far di conto, avendo frequentato lo scientifico: «Non è un vantaggio da poco, mi creda». All'abilità contabile unisce una solida preparazione giuridica: si è laureato in giurisprudenza quando all'Università di Padova ancora insegnava Giuseppe Bettiol, docente di diritto penale che attirava l'attenzione degli studenti picchiando il bastone da passeggio sulla cattedra. Concluso un master al Politecnico di Torino, è diventato perito e consulente tecnico del tribunale di Vicenza. Si occupava di immobili messi all'asta dagli uffici giudiziari, argomento sul quale ha scritto un libro per le edizioni del Sole 24 Ore. Poi la crociata contro le banche. «Nonostante in Italia siano in corso innumerevoli inchieste penali - 300 solo nel Veneto - a carico degli istituti di credito, con centinaia di amministratori, dirigenti e funzionari coinvolti, finora le condanne pronunciate sono state appena quattro».
Cane non mangia cane, è questo che mi sta dicendo?
«Sì. Le Procure di solito archiviano con la motivazione che l'usura c'è stata però non si può dimostrare il dolo da parte della banca. Siamo arrivati all'assurdo per cui a Vicenza un caso di usura su un mutuo casa, già sanzionato in sede civile, non approda alla sentenza penale perché il Pm non sa a chi affibbiare l'imputazione. Ma come? È così difficile sapere il nome del presidente di una banca? E guardi che l'usura è un reato gravissimo».
Non lo metto in dubbio.
«Non mi riferisco all'aspetto etico. Gravissimo per le conseguenze sul reo: da 2 a 10 anni di reclusione. E nel caso delle banche sono contemplate tre aggravanti specifiche che possono portare a una condanna fino a 20 anni».
Ma le condanne scarseggiano.
«Già. A parte il caso Parmalat, in cui quattro funzionari dell'Ubs hanno patteggiato e il presidente della Banca di Roma è stato assolto in Cassazione per prescrizione. Il rappresentante italiano di Bank of America è ancora sotto processo a Parma. Nel frattempo la Svizzera, dove costui ha subìto una condanna per reati finanziari, l'ha fatto estradare dalla Slovenia e l'ha sbattuto in galera. Giusto per darle un'idea delle differenze tra la giustizia elvetica e quella italiana».
Il suo mestiere precisamente qual è?
«Aiuto i clienti ad accertare se i calcoli degli interessi presentati dalle banche sono esatti oppure no. Vado a caccia di tassi usurari e costi occulti. All'inizio lo facevo per passione civile, una forma di volontariato che è diventata un mestiere».
Lei sostiene che le banche sbagliano i conti intenzionalmente.
«È così. Vuole un piccolo esempio? Il conteggio degli interessi sui mutui va fatto con divisore 365. Invece alcune banche arrotondano a 360. È illegale. Un anno ha 365 giorni, non 360. Pensi che mostruose cifre complessive genera quest'arbitraria decurtazione».
Sarà perché tre dei miei quattro fratelli ci lavoravano, ma ho sempre pensato le banche fossero infallibili con la calcolatrice.
«Fino agli anni Novanta lo pensavano tutti, perché gli imbrogli venivano compensati dall'inflazione alta. Con l'avvento dell'euro, la gente s'è messa a leggere gli estratti conto con più attenzione e sono venuti alla luce gli imbrogli».
Che genere di imbrogli?
«L'uso piazza, l'anatocismo e l'usura. Tralascio la commissione massimo scoperto, che pure incide parecchio».
Parla ostrogoto. Andiamo per ordine. L'uso piazza che cos'è?
«Pochi sanno che tutti i contratti per i conti correnti aperti prima del 1992 erano standard. L'articolo 7 rinviava a un inesistente tasso "uso piazza" per il calcolo degli interessi a debito e a credito. Però la magistratura non l'ha mai contestato. Nel 1992 una legge ha stabilito che o nel contratto viene fissato un tasso preciso oppure va applicato il tasso legale. Questo significa che i conteggi a partire da allora, su tutti i contratti stipulati prima di 23 anni fa, vanno rifatti. Crede che le banche abbiano avvisato la clientela? All'epoca il tasso legale era del 5 per cento, mentre loro applicavano sui passivi un'aliquota dal 15 al 20 per cento».
Uno sbilancio pazzesco.
«Le dico solo questo: il mio elettrauto è andato in pensione e le tre banche con cui lavorava pretendevano da lui la restituzione di debiti per 100.000 euro. Rifatti i conteggi solo sull'ultimo decennio, perché le carte precedenti le aveva buttate via, è andato a credito. Devono dargli indietro parecchi soldi».
Veniamo all'anatocismo.
«Era ritenuto lecito nei conti correnti, ma nel 1999 la magistratura ha precisato che è vietato. Le banche lo calcolavano ogni tre mesi sugli interessi a debito e una volta l'anno su quelli a credito, quindi a svantaggio del cliente. Una legge ha stabilito che l'anatocismo è valido solo se applicato paritariamente. Per i contratti antecedenti al 2000 i conteggi sono tutti da rifare. Solo che gli istituti di credito si rifiutano di pagare anche quando perdono le cause».
Be', esiste il pignoramento.
«Lo sa come sfuggono quando il cliente lo chiede? Si fanno pignorare un assegno circolare con l'importo che dovrebbero versargli. Ma, anziché a suo favore, lo intestano alla cancelleria del tribunale. Quindi, finché non arriva la sentenza della Cassazione, il cliente non vede un euro».
Parliamo dell'usura.
«In Italia fu reintrodotta come reato penale dal codice Rocco del 1930 per punire lo sfruttamento dello stato di bisogno. Dal 1996 la tutela è estesa anche ai soggetti in stato di necessità economica o finanziaria. Ma le banche si sono prontamente autoescluse, sostenendo che la normativa non le riguardava».
Possibile che istituti quotati in Borsa, vigilati dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si arrischino a praticare tassi fuori legge? Vuol dire che pensano di poter contare sull'impunità.
«È così. Giustizia e sistema bancario sono collusi, è questo il grande cancro».
Ma i tassi usurari vengono applicati da singoli dipendenti oppure costoro obbediscono a ordini di scuderia?
«Entrambi i casi. Vincenzo Imperatore, un ex funzionario di Unicredit, lo ha confessato in un libro, Io so e ho le prove. Ma si guarda bene dal restituire il maltolto».
Qual è il tasso d'interesse oltre il quale scatta l'usura?
«Magari ce ne fosse uno soltanto. Sono una trentina. Dipendono dall'importo in ballo e dalla categoria del prestito: mutui ipotecari, leasing, prestiti personali, cessioni del quinto, anticipi e via di questo passo. Nel primo trimestre del 2015 il più basso è quello dei mutui ipotecari a tasso variabile: 8,33. Il più alto è quello delle carte di credito revolving: 24,9. L'usura scatta sostanzialmente quando gli interessi applicati da banche e finanziarie superano del 50 per cento il tasso medio rilevato ogni tre mesi».
Rilevato da chi?
«Dovrebbe essere il ministero dell'Economia. Ma, con un abuso, ha delegato a computarlo la Banca d'Italia».
Il carnevale di Viareggio.
«No, è una guerra civile, questa dell'usura. Per non parlare della grande rapina chiamata cessione del quinto».
Di che si tratta?
«Di un prestito che il lavoratore riceve e che è garantito dallo stipendio. Fino al 2005 lo potevano chiedere solo i dipendenti pubblici, con un tasso d'interesse molto basso. Ma ora lo concedono anche al personale delle imprese private e ai pensionati, con un tasso soglia che va dal 18,55 al 19,57. Si sono infilate nel business finanziarie e mediatori senza scrupoli. Bankitalia sarebbe dovuta intervenire, ma fino al 2010 non ha mosso un dito. Nello spingere la povera gente a farsi tosare ci hanno guadagnato tutti, persino i sindacati, che ricevono cospicue provvigioni dalle banche, e l'Inps, che per ogni pratica evasa incassa 10 euro».
Conosce casi di imprenditori portati al fallimento o, peggio, al suicidio?
«Parecchi. Le banche hanno fatto fallire un orafo di Trissino che aveva 50 dipendenti. Una ditta bellissima. Ho rifatto i conteggi e ci siamo accorti che l'insolvenza non esisteva. Ma è molto difficile rimediare: il fallimento è come una sentenza passata in giudicato. Ha quasi perso il lume della ragione, poveretto».
Però anche le banche hanno problemi con la clientela insolvente. In sette anni di crisi le sofferenze hanno raggiunto i 181 miliardi di euro.
«Ma sarà vero credito? I conteggi sono stati fatti tenendo conto degli errori? Perché Unicredit ha messo prudenzialmente a bilancio un passivo di 17 miliardi di euro per cautelarsi da brutte sorprese? È l'unica banca ad averlo fatto».
Come si fa a chiudere questo buco?
«Ci vorranno dieci anni».
Esisterà pure una banca virtuosa.
«No, tutte applicano gli stessi trucchi. Le uniche sarebbero le banche arabe, che non possono compiere operazioni con gli interessi, come prescritto dal Corano, ma in Italia non le lasciano entrare».
E di che campano le banche arabe?
«Invece dei mutui, fanno vendite con patto di riscatto. La banca acquista una casa, me la consegna, per 20 anni pago l'affitto, trascorso il termine diventa mia. Non molto diverso da quanto fece Amintore Fanfani all'epoca del boom, senza bisogno degli arabi».
Il caso più clamoroso di cui s'è occupato?
«Due fratelli di Empoli che hanno dovuto chiudere un'azienda di pelletteria per colpa dell'anatocismo. Si sono ritrovati indebitati per 300.000 euro con la banca e per altri 300.000 con Equitalia. Ho rifatto i calcoli. La prima ha dovuto riconoscere d'aver praticato l'usura. Perciò s'è detta disposta a rinunciare ai 300.000 euro di credito, a versarne al fisco altri 300.000 al posto dei clienti e a offrirne 100.000 a titolo di risarcimento».
Ma lei si fida delle banche?
«Certo. Basta non chiedergli prestiti».
Quindi i nostri soldi depositati nelle banche sono al sicuro.
«Sì, perché il denaro non esiste. È una creazione normativa».
Il mondo segreto delle lobby. Negli Usa sono legittimi e radicati nella cultura nazionale, in Italia agiscono nell'ombra e in assenza di regole. Nel racconto di un "insider", ecco come i gruppi di interesse riescono a influenzare la vita politica del Paese, e, in assenza di norme chiare, rischiano di restringere il diritto di rappresentanza democratica, confondendo il legittimo lavoro dei lobbisti con quello ambiguo dei faccendieri, scrive “La Repubblica”.
Terra di nessuno in attesa di regole, scrive Carmine Saviano. L'accordo è raggiunto. Il testo è scritto. Il voto in aula è solo una formalità. Poi ecco l'emendamento dell'ultimo minuto, la modifica che non ti aspetti. E la legge passa mentre il coro pronuncia una sola parola: "Lobby". Lo abbiamo visto nell'ultimo decreto sulle liberalizzazioni: "Vincono le lobby", "perdono le lobby", "colpa delle lobby". Ne è piena la storia recente, almanaccarle tutte un'impresa: le pressioni, indebite o meno, cui sono sottoposi i decisori pubblici rappresentano un capitolo a sé della prassi politica. Aziende di stato sospettate di scrivere interi decreti - il caso Enel, smentito, sul taglio degli incentivi alle energie rinnovabili - multinazionali che finanziano in modo bipartisan, aziende che cercano di influenzare l'iter dei provvedimenti. Ordini professionali con il loro "paladini" tra i parlamentari. E poi tassisti, case farmaceutiche, operatori del gioco d'azzardo. Una terra di nessuno, quella dei rapporti tra politica e lobby. Di nessuno perché nessuno l'ha mai regolata: in Italia non esiste una legge per questi rapporti. Una zona grigia in cui solo il 20% - i dati sono di una ricerca ancora inedita dell'Università Unitelma Sapienza - delle attività di lobbying è parzialmente in chiaro, riconducibile a determinati soggetti: dalle società di lobbying ai lobbisti in house, i rappresentanti di grandi gruppi economici, pubblici o privati. Il restante 80% è coperto dall'ombra: qui ricostruire l'identità dei lobbisti che l'hanno generata è impossibile se non per macro-categorie: dalle società di comunicazione (circa il 60% del totale dei casi), ai grandi studi legali (il 30%) o da liberi professionisti individuali (il 10%). Ma come si svolge la giornata di un lobbista? A raccontarlo a Repubblica è Luigi Ferrata, di SEC relazioni pubbliche ed istituzionali, una delle società che opera in chiaro e che chiede al più presto una legge sui gruppi di pressione. Lo incontriamo nel suo studio, centro di Roma. Sommerso da giornali, da monitor accesi sui siti di Camera e Senato, diagrammi e grafici, telefoni che non smettono di squillare, Ferrata racconta: "Il nostro lavoro è legato all'attività del Parlamento e del governo. Durante l'approvazione della Legge di Stabilità c'è molto da fare. E nelle ultime settimane c'è stata grande attenzione sul tema delle liberalizzazioni". Si inizia raccogliendo informazioni. "Si parte con l'analisi dei provvedimenti presentati. Dopo possiamo contattare un eventuale cliente per proporre un'attività di lobbying. Ovviamente capita anche il contrario: le aziende a cui interessa sottoporre il proprio punto di vista ai parlamentari o ai membri del governo, ci chiamano e ci commissionano il lavoro". Alla fine di questa fase è tutto pronto per l'aggancio: si individuano i soggetti che possono influire sul processo decisionale e si parte alla ricerca del contatto. "Attualmente l'approccio migliore, quello più efficace, è durante la discussione nelle Commissioni: ci sono meno persone, i provvedimenti vengono discussi sul serio e c'è maggior interesse a recepire ulteriori informazioni dai soggetti che possono essere coinvolti dall'eventuale legge". Ma quello parlamentare è solo uno dei piani. Un piano secondario. Perché il reale obiettivo è l'esecutivo. Ancora Ferrata: "Qui ci si muove su due livelli: quello dei dirigenti del ministero e quello dello staff del ministro. Il nostro compito è sollecitare l'interesse, raccontare una storia, suggerire modi possibili per affrontare determinate tematiche". E dopo l'analisi dell'oggetto e l'individuazione del soggetto è tempo dell'aggancio vero e proprio. "L'approccio avviene in molti modi. Mail, telefonate, messaggi. Di solito però cerchiamo il contatto personale, magari durante un incontro in cui sappiamo che sarà presente l'uomo che ci interessa". Poi ci si siede intorno a un tavolo: "In genere si organizza un convegno sul tema d'interesse. O si pranza insieme in qualche posto". Dopo l'incontro, se si è fortunati, la posizione del portatore di interesse particolare viene "accolta" in un disegno o in una proposta di legge. Più spesso in qualche emendamento. E nell'assenza della possibilità di tracciare il lavoro del lobbista, esistono alcuni segnali che possono far comprendere se una "pressione" è stata attuata. "Non c'è un metodo per scoprire un'attività di lobbying", conclude Ferrata. "A occhio ci si può accorgere di un lavoro simile quando emergono delle posizioni trasversali che coinvolgono parlamentari di diversi schieramenti. O quando il progetto di legge presentato è molto specifico". "A occhio". Perché nel Paese dove la logica diventa ossimoro il processo che conduce alla formazione delle decisioni pubbliche non è pubblico, si può solo intuire. Non esiste un registro dei lobbisti. Ministri e politici non hanno nessun obbligo di rendere pubblici i loro incontri con rappresentanti di interessi particolari. E le porte tra grandi aziende e politica sono sempre aperte: nessuno vieta a un manager di diventare capo di gabinetto di un ministero e viceversa. Negli altri paesi il periodo di raffreddamento, il cooling off, è di due anni: in questo periodo di tempo le porte tra pubblico e privato devono restare chiuse. Perché le informazioni acquisite durante il proprio incarico governativo potrebbero essere utilizzate per favorire la propria azienda. E i rapporti costruiti al di fuori del pubblico potrebbero influenzare decisioni e scelte che riguardano la totalità dei cittadini. Eppure, una legge sul lobbying è stata spesso ricercata. Cinquantotto disegni di legge presentati nella storia della Repubblica, quasi uno all'anno: tutti lasciati marcire in attesa di finire nel dimenticatoio. Nelle ultime settimane la Commissione Affari Costituzionali del Senato, guidata da Anna Finocchiaro, sta procedendo all'esame congiunto di ben sei proposte che arrivano da tutte la parti politiche. La volontà è quella di arrivare a un testo unico da portare in aula. Perché oramai la necessità è stringente: stabilire quelle regole in grado di eliminare ogni ambiguità nel rapporto tra chi decide e chi si batte per portare al tavolo delle decisioni interessi determinati e particolari. L'obiettivo delle proposte di legge è dare un abito giuridico a chi ogni settimana compie il proprio pellegrinaggio nel Transatlantico di Montecitorio e nelle sale d'attese delle aule delle Commissioni Parlamentari. A chi incontra, giorno dopo giorno, decine di deputati, senatori, dirigenti dei ministeri, staff dei capi dei dicasteri. Distinguere, insomma: mettere dei paletti che possano aiutare a tracciare una linea di separazione tra chi offre competenza e chi traffica relazioni. Tra lobbista e faccendiere, appunto. Una legge che servirebbe a fare chiarezza, contribuendo a illuminare un contesto reso ancora più indecifrabile grazie anche all'assenza del vincolo di rendicontazione per le donazioni di privati ai partiti politici: fino a 100 mila euro e per quattro mesi, sempre che il privato acconsenta a rendere pubblico il suo nome. In definitiva: l'assenza di questa legge è un'eccezione alla trasparenza che non ha simili nel contesto dei paesi democratici. In Europa è prevista l'esistenza di un registro dei lobbisti: gli italiani iscritti, tra persone fisiche e giuridiche, sono oltre 650. Nel nostro Paese niente di simile. L'unico caso a livello nazionale è l'elenco previsto dal ministero dell'Agricoltura: lanciato con il governo Monti con gli ultimi due esecutivi è semplicemente scomparso. E negli ultimi mesi il viceministro Nencini ha messo online l'agenda dei suoi incontri. Un primo passo. Per il resto, solo promesse. L'ultima in ordine di tempo è quella del governo Renzi: nel Def la legge sul lobbying era prevista per giugno del 2014. Otto mesi fa. Perché su questo terreno la politica professa trasparenza ma sceglie di far proliferare l'opacità?
"Un comodo capro espiatorio per i politici", scrive Carmine Saviano. Ci prova da anni. Da quando fu coinvolto dall'ultimo governo di Romano Prodi per lavorare a una legge che regolasse i gruppi di pressione. Pier Luigi Petrillo è professore associato di Diritto pubblico comparato all'Università Unitelma Sapienza di Roma. E da 8 anni insegna Teoria e tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli. Non solo: è consulente per l'OCSE in materia di lobbying e trasparenza. Con il governo Letta il suo ultimo impegno nelle istituzioni: era l'estate del 2013 e la legge sui lobbisti sembrava realmente a un passo dal vedere la luce.
Professor Petrillo, cosa comporta la mancanza di questa legge per il tessuto democratico del Paese?
"Questa assenza consente alla politica di scaricare la responsabilità della propria inefficienza proprio sui lobbisti. Un provvedimento non viene approvato? Colpa delle lobby. Un disegno di legge si ferma? Colpa delle lobby. Le lobby sono diventate un paravento della politica che non vuole scontentare taluni soggetti e non vuole assumersi la responsabilità della scelta".
Con una normativa sul tema la politica guadagnerebbe in efficienza?
"Una legge sul lobbying, rendendo pubblici gli interessi particolari contrapposti, toglierebbe alla politica qualsiasi alibi: il decisore dovrebbe decidere, sotto gli occhi di tutti. Nei 18 paesi dove il processo decisionale pubblico è regolato dalla legge avviene tutto in trasparenza: gli incontri con i portatori d'interesse sono pubblici e la politica alla fine deve assumersi la responsabilità di indicare quale o quali interessi soddisfare. La zona d'ombra che esiste nell'ordinamento del nostro paese consente alla politica di non scegliere: e quindi di non scontentare nessuno, salvo i cittadini ai quali si fa credere che è colpa delle lobby anziché della politica".
Nel 2013 il governo guidato da Enrico Letta sembrò a un passo dall'approvazione di un decreto legge...
"Da marzo 2013 a maggio 2013 il governo chiese a un gruppo di esperti, di cui facevo parte, un lavoro preparatorio per un disegno di legge. Alla fine della fase di studio, maggio 2013, presentammo il nostro lavoro, basato essenzialmente sui principi indicati dall'Ocse. Successivamente, per redigere il testo, furono incontrati, il 5 giugno, a Palazzo Chigi, alcuni lobbisti così da analizzare l'impatto delle norme ipotizzate sui destinatari della stessa. Il provvedimento venne calendarizzato per essere approvato dal consiglio dei ministri del 5 luglio. Fino a ventiquattro ore prima sembrava filare tutto liscio. Ma durante la seduta, il Consiglio decise di rimandarlo senza approvarlo. E la successiva crisi del governo Letta mandò in soffitta il lavoro fatto".
Da dove arrivano le maggiori resistenze alla legge?
"Oggi ci sono dei soggetti facilitati nell'accesso ai decisori perché, ad esempio, rappresentano interessi di società pubbliche o a partecipazione pubblica. Una legge sul lobbying metterebbe sullo stesso piano questi lobbisti 'privilegiati' con gli altri: per questo l'OCSE ha più volte detto che una legge in materia serve per assicurare la concorrenza".
Un privilegio che esiste solo finché esiste una zona d'ombra...
"Uno studio realizzato dall'Università Unitelma Sapienza evidenzia come solo il 20% delle attività di lobbying è in chiaro nel senso che è possibile conoscere chi ha fatto lobbying e per cosa. L'altro 80% è composto da lobbisti 'di fatto': da chi gestisce le relazioni esterne delle aziende fino agli studi di comunicazione o legali. Questo 80% non è tracciabile".
La soluzione legislativa più veloce?
"Il governo potrebbe intervenire in materia senza nemmeno aspettare la legge. Con un decreto del premier - che necessita solo di una veloce approvazione in Consiglio dei ministri - finalizzato a regolamentare l'attività di lobbying diretta verso tutta l'amministrazione esecutiva, dal governo agli enti pubblici economici. Se solo si volesse...".
Allarme corruzione: "Urgenti norme chiare", scrive Carmine Saviano. Tra pochi mesi non si potrà più farne a meno. Perché l'assenza di una legge sul lobbying rischierà di incidere in modo negativo sul sistema degli appalti pubblici. Le nuove norme, infatti, sono contenute in un disegno di legge delega presentato dal governo e in discussione al Senato che recepiscono tre direttive europee: la 2014/23, la 2014/24 e la 2014/25. Tra i principi contenuti in queste direttive si prevede la "partecipazione di portatori qualificati d'interesse nell'ambito dei processi decisionali finalizzati all'aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche". Vale a dire: lo Stato potrà coinvolgere privati nella stesura stessa dei provvedimenti che danno il via ai lavori. La legge sui gruppi di interesse diventa quindi essenziale: è inimmaginabile, infatti, non mettere al corrente l'opinione pubblica circa i rapporti tra istituzioni e portatori d'interesse in relazione alla realizzazione di opere pubbliche. E' necessario prevedere registri consultabili, agende e resoconti degli incontri. Apparentemente: niente di più semplice se i nuovi strumenti di cui si avvale anche la comunicazione politica fossero presi sul serio: la pubblicità che la rete può fornire è enorme. Un veicolo di trasparenza. E la regolamentazione delle attività lobbistiche è un'esigenza avvertita anche - e soprattutto - dall'Anac, l'Autorità Anti Corruzione presieduta da Raffaele Cantone. Il cui team sta lavorando a un Libro Bianco da presentare al governo. Proposte e indirizzi per migliorare la gestione della cosa pubblica. Michele Corradino è uno dei quattro consiglieri di Cantone. E non utilizza mezze misure: "Dobbiamo parlarci chiaro: le lobby entrano nelle stanze della politica, nei luoghi dove vengono prese le decisioni che riguardano la totalità dei cittadini". E più i gruppi di pressione sono forti "più riescono a incontrare interlocutori che sono ai vertici delle istituzioni". Una proporzione diretta: al massimo di forza economica corrisponde la massima capacità di influenzare il decisore pubblico. Una legge che regolamenti questi incontri, che riesca a mettere in luce il percorso incontrato da una legge diventa quindi essenziale anche in relazione alla lotta contro la corruzione: "Abbiamo stabilito una sorta di equazione, accettata da tutti: l'arma migliore per combattere la corruzione è la trasparenza". E se la trasparenza è un metodo, questo metodo non può essere circoscritto alla retorica politica.
Diamanti: "Trasparenza significa democrazia", scrive Carmine Saviano. Dalle cause storiche che possono spiegare l'assenza in Italia di una cultura delle lobby alle classi in cui possono essere divisi i gruppi di influenza. Metodi di pressione, impatto sull'opinione pubblica, il ruolo del governo. La zona d'ombra tra scena e retroscena delle decisioni pubbliche. Ne abbiamo parlato con Ilvo Diamanti, professore di Scienza Politica all'Università di Urbino e di Régimes Politiques Comparés a Paris 2, Panthéon Assas. Partendo da come incide, in questo contesto, l'assenza di norme sulla qualità della democrazia italiana.
Professor Diamanti, regolamentare le lobby innalzerebbe il grado di democraticità del nostro sistema?
"Assolutamente sì. La democrazia ha diverse facce ma tutte prevedono forme di controllo sulle decisioni della politica. E' evidente che quando esistono ambiti di discrezionalità sottratti al controllo dei cittadini viene indebolita la possibilità di controllo sui decisori. Viene indebolita la rappresentanza".
Nell'opinione pubblica, lobbista è sinonimo di faccendiere...
"E' una questione di tradizione politica e culturale. E mi riferisco sia a quella cattolica che a quella comunista che condividono un'idea negativa della ricchezza. Quasi fosse necessariamente un peccato. Peraltro, scontiamo un approccio fariseo: il denaro lo si fa ma non ci importa come. Così il lobbista è un peccatore e fare lobby significa raggiungere risultati con ogni mezzo. Più o meno lecito".
Un governo non dovrebbe porre tra i suoi obiettivi primari una legge sui gruppi di pressione?
"Dovrebbe. Se non avviene è perché le lobby all'italiana sono molto forti".
Lobby all'italiana, appunto. Abbiamo provato a dare i voti...
Possiamo indicare due classi diverse. Esistono grandi sistemi di interessi che riguardano prodotti e servizi di largo interesse pubblico. Come quelli che gestiscono le fonti energetiche: risorse che dipendono da regole e concessioni della politica. E nella percezione generale questi gruppi sono sicuramente quelli in grado di influenzare maggiormente il potere politico".
L'altra classe?
"Le professioni: dispongono di altri mezzi, possono mettere in campo altre forme di lotta. Forme 'materiali' che però riguardano beni immateriali. Pensiamo ai tassisti: gestiscono la mia 'mobilità'. Possono interromperla. E con questo possono bloccare la mia possibilità di comunicare. Anzi, possono bloccare i movimenti e la mobilità del Paese. Come, peraltro, i camionisti".
Cosa accomuna queste due classi?
"Entrambi le classi hanno lo stesso bersaglio. Intervengono sugli stessi attori politici. Tendono a esercitare pressione sulle decisioni e i decisori politici".
Ma, a oggi, la maggior parte di questi interventi resta nell'opacità...
"Naturalmente c'è differenza fra chi esercita una pressione esplicita attraverso scioperi e forme di lotta aperte e chi, invece, agisce esercitando pressioni e influenza sul ceto politico, nel retroscena. Il problema italiano è qui. E dipende dall'assenza di una cultura delle lobby. E quindi dall'esistenza di lobby implicite. Che non sono regolate ma sono contigue con il potere politico. Contiguità che è difficile da modificare: rendere pubbliche determinate procedure - pensiamo agli appalti - farebbe saltare la procedura stessa. E metterebbe in discussione gli interessi e le posizioni di potere esistenti. Per questo rendere trasparente il mercato è operazione difficile".
Usa, scandali a raffica ma è nel Dna del paese, scrive Alberto Flores D'Arcais. "Ero coinvolto profondamente in un sistema di corruzione. Corruzione quasi sempre legale". Quando alla fine del 2010 - dopo aver scontato quattro anni di carcere e aver lavorato per sei mesi a 7,5 dollari l'ora in una pizzeria - Jack Abramoff chiuse i suoi conti con la giustizia, affidò a quelle poche parole il riassunto di cosa fosse il lobbyism negli Stati Uniti. Il pentimento (con relativo libro di denuncia) del più famoso lobbista americano degli ultimi venti anni - al centro di un altrettanto famoso scandalo che avrebbe coinvolto 21 potenti uomini della Washington politica (compresi un paio di funzionari della Casa Bianca di George W. Bush) - diede il via a feroci polemiche, accuse e contraccuse, editoriali indignati e (spesso) ipocriti, su una delle attività che più condizionano (nel bene e nel male) la vita politica e finanziaria del più potente paese del pianeta. Attività del tutto legittima e legale ma che ha offerto spazio, nei dettagli di regole complicate, anche ad azioni che hanno sfiorato la soglia della criminalità. Negli Stati Uniti il lobbismo nasce insieme alla Costituzione e al free speech (protetto dal Primo Emendamento che tutela in generale la libertà di espressione e che vieta al Congresso di approvare leggi che limitino "il diritto che hanno i cittadini di inoltrare petizioni al governo") ed è un lavoro (ben remunerato) a tempo pieno grazie al quale i cosiddetti 'gruppi d'interesse' (politici, religiosi, morali e soprattutto commerciali) fanno pressione sul Congresso per approvare questa o quella legge, per difendere posizioni acquisite, per condizionare una scelta piuttosto che un'altra. Dagli anni Settanta è un fenomeno in costante crescita e oggi a Washington ci sono oltre 13mila lobbisti registrati come tali, più diverse altre migliaia che lavorano sotto-traccia e fanno spesso il lavoro 'sporco' e più rischioso. Con un volume di affari che, nel corso degli ultimi decenni, è cresciuto in modo esponenziale e che nel 2010 ha raggiunto la cifra record di 3,5 miliardi di dollari. Un'attività, quella di lobbying, che è talmente connaturata al sistema politico-costituzionale degli Stati Uniti da essere scherzosamente definita (con una tipica espressione slang) as American as apple pie, americana come la torta di mele. Ma chi sono i lobbisti? In gran parte avvocati (o comunque persone uscite dalle Law School e dalle Business School dei migliori college degli Usa), assoldati da famose corporation (JP Morgan ha un team che costa oltre tre milioni di dollari all'anno), da grandi studi legali, sindacati e organizzazioni varie, ma soprattutto da società che nascono ed operano con l'unico scopo di fare lobbismo. La loro attività è riconosciuta da una legge bipartisan del 1995 (Lobbying Disclosure Act) - varata dopo una serie di scandali e azioni che vennero definite "poco chiare" - e i lobbisti (sulla carta tutti) devono registrarsi presso la Rules Committee, la commissione delle regole del Congresso, hanno un badge permanente che gli permette di girare tranquillamente negli uffici di deputati e senatori a Capitol Hill (può essere revocato in caso di violazioni di legge) e sono identificati come "gruppi portatori di interesse da tutelare", un giro di parole che rende bene l'idea. Un lavoro che ha come interlocutori membri del governo, parlamentari ed amministratori pubblici (a livello federale, statale e locale) e che è, o meglio dovrebbe essere, ben distinto da chi lavora in una campo contiguo come quello delle public relations. Ed è qui, quando questi due mondi si intersecano, che si trovano i confini tra il lobbismo 'buono' (e assolutamente legale) e il mondo 'grigio' del sottobosco politico-affaristico che, ogni tanto, sfocia in un grande scandalo come quello di Abramoff. Un sottobosco che (stando ad alcuni studi recenti) arriva ad impiegare una manodopera di quasi centomila persone e dove il cosiddetto metodo delle 'tre B' (booze, broads, bribes, ovvero alcol, donne e bustarelle) non è stato mai del tutto abbandonato. Un mondo che è stato combattuto in epiche battaglie da uomini come Ralph Nader, lo scrittore-avvocato-attivista (e cinque volte candidato senza speranza alla Casa Bianca) diventato un simbolo della difesa dei consumatori e una decennale spina nel fianco delle lobby anche più potenti. Un mondo (e i critici non mancano mai di ricordarlo) che deve il suo nome all'atrio degli alberghi: un posto visibile a tutti ma che nasconde qualche inconfessabile segreto.
Rosa o gay, una per ogni stagione, scrive Filippo Ceccarelli. Saranno ormai quarant'anni che si parla di regolamentare le lobby. Allora, era la metà degli anni 70, bisognava spiegare cosa significasse quella parola; nel frattempo "lobby" ha fatto a tempo a dilatarsi e insieme a rattrappirsi, comunque moltiplicando i suoi valori d'uso oltre ogni ragionevole significato. In questi casi, anche se il termine suona un po' ricercato, si dice che la lobby, anzi le lobby sono divenute polisemiche. I politici e i giornalisti, categorie per loro natura e vocazione abbastanza orecchianti, adorano le polisemie, specie quando gli lasciano le mani libere - un po' meno la testa, ma è un altro discorso. Può esistere dunque una lobby rosa, nel senso di un gruppo che favorisce gli interessi e il potere delle donne nelle istituzioni e nell'economia: "Emily", il "branco rosa" e così via. Ma anche esiste una agguerrita lobby delle armi, cioè gente che cerca di piazzare mine, cannoni e micidiali sistemi di puntamento in giro per il mondo, soprattutto ai paesi africani, cosa non proprio simpatica. Le aziende dispongono di professionisti ad hoc che battono anche il Parlamento. In una raccolta di vignette su Montecitorio, già alla metà degli anni 80 il disegnatore Vincino raffigurò "il lobbista dell'Aeritalia" che svolazzava per il Transatlantico con delle eliche che gli uscivano dal retro della giacca, come un drone ante litteram. Insomma tante cose diverse. Nell'economia la faccenda è più pacifica che in politica o nella cronaca giudiziaria. Si tratta di tutelare degli interessi, come spiegano benissimo i protagonisti dell'inchiesta di Carmine Saviano. Le Camere sono la palestra, il giacimento, l'arena, la serra, la taverna e il giardino zoologico dei lobbisti. Qualche mese fa i cinquestelle hanno beccato un ex funzionario di Montecitorio che scriveva, al volo e brevi manu, un emendamento per modificare un provvedimento in commissione, e l'hanno fatto cacciare. Hanno poi esposto il suo volto in aula con dei cartelli. Quello, poveretto, ha cercato di sminuire il suo ruolo, pure definendosi "un giuggiolone". Ma ai tempi in cui Marcello Pera presiedeva il Senato, 2005, nel depliant della sua fondazione "Magna Carta" era esplicitamente contemplata l'attività di lobbying; e l'ex presidente della Camera Irene Pivetti, adesso, cosa fa? Semplice, fa lobbying. Dal che si intuiscono gli effetti non tanto forse della mancata regolamentazione, ma della implicita e magari anche connaturata confusione che reca in sé l'ambiguo tragitto della parola "lobby", nella sua variante "all'italiana". Così alla caduta del governo Berlusconi l'ex ministro Mastella, l'ineffabile, evocò la "lobby ebraica"; ma qualche mese prima, quando alla presidenza della Rai era arrivata Letizia Moratti, venne lanciato un allarme contro la "lobby di San Patrignano", che sarebbe una nota comunità di recupero per tossicodipendenti, ma si disse così per intendere che direttori di rete o dei tg si diventava solo previo assenso della Moratti, appunto, che dell'iniziativa di Vincenzo Muccioli (poi con il figlio e la moglie hanno ferocemente litigato) era e seguita a restare la grande patrona e finanziatrice. Altre lobby entrate più o meno di straforo nella cronaca: la "lobby di Lotta continua" (ai tempi dei processi Sofri); la "lobby gay" (in Vaticano); la "lobby dei tesorieri di partito" (che continua a bussare a quattrini aggirando leggi e referendum). Si tratta di esempi per lo più negativi. Ma per anni il progetto educativo del cardinal Ruini è stato presentato anche dai suoi fautori come strutturalmente connesso a un'opera di lobbying a favore dei principi irrinunciabili. Bizzarro perciò è il destino dei grimaldelli semantici, sempre sul punto di trasformarsi in piè di porco. Questo, per dire, è un Lele Mora d'annata, già proteso a togliersi dagli impicci: "Io - diceva - non piazzo le starlette nei letti, faccio solo incontrare gente, lobbying, altro che festini!". Era la fine del 2006, poi è finita con qualche anno di galera. Nel frattempo le lobby crescono e si moltiplicano a loro indeterminato piacimento. E ciascuno le consideri un po' come meglio ritiene: se e quando verranno regolamentare, sarà probabilmente troppo tardi.
"Università, altro che merito. E' tutto truccato. Vi racconto come funziona nei nostri atenei". Fondi sperperati, concorsi pilotati, giovani sfruttati. Un ex dottorato spiega nel dettaglio come si muove il mondo accademico tra raccomandazioni e correnti di potere. E qualcuno non vuole che il libro in cui riporta tutti gli scandali venga pubblicato, scrive Maurizio Di Fazio su “L’Espresso” Non è un Paese per giovani docenti universitari. E' quanto ha scoperto sulla sua pelle da Matteo Fini, classe 1978, appena riemerso da quasi dieci anni di esperienza accademica come dottore di ricerca in statistica nel Dipartimento di scienze economiche dell’Università degli studi di Milano. “Tante illusioni svanite via via nel nulla”. Alla Statale si occupava di metodi quantitativi per l’economia e la finanza. “In pratica facevo tutto: lezioni, ricerca, davo gli esami, mettevo i voti – ci dice Fini – Ero un piccolo professore fatto e finito, senza titolo. E questa è una roba normalissima”. La sua è la storia di un giovane italiano che non ce la può fare nonostante tutto. “Non si sopravvive al sistema universitario italiano” aggiunge. E ne esce, e pensa di raccontarlo. Di dissacrarlo. Ne fa la sostanza del suo libro: la vita accademica vista dall’interno, nei suoi gangli ordinari. Episodi quotidiani che non danno scandalo abbastanza se presi singolarmente. Comincia a scriverlo, e ne posta qualche estratto su Facebook. Un giorno riceve una diffida legale, girata anche all'editore con cui aveva già fatto un libro ("Non è un paese per bamboccioni"), che gli intima di non pubblicare e di eliminare tutti i post “allusivi” dal social: tra questi, una citazione di Lino Banfi/Oronzo Canà. “I post non li ho affatto tolti, e tra l’altro erano generici e astratti – racconta Matteo Fini –. Questa è censura preventiva”. Il libro è pronto, anzi c’è tutta una piccola community sul web che ne attende l’uscita; ma non si sa più quando, né con chi vedrà la luce. Abbiamo incontrato l’autore per saperne di più di questo suo pamphlet arrabbiato, rimandato a settembre per “condotta”. L’inizio del percorso da ricercatore universitario è comune a tutti. “È il professore stesso che ti precetta, quando tu magari nemmeno ci pensavi alla carriera universitaria. Ti dice: “ti va di fare il dottorato?”. E tu rispondi ok, e cominci. E pensi che sei davvero bravo. Un eletto. A quel punto però vieni risucchiato e la strada si fa cieca”. Al “meccanismo” ci si abitua subito. Prendere o lasciare. I più, prendono, compreso Matteo Fini. “Ho capito subito che c’erano delle regole bislacche, ma le ho accettate: sai benissimo che lì dentro funziona così, è un sistema che non puoi cambiare, immutabile, e sai anche che la tua carriera è totalmente indipendente da quello che dici o che fai: conta solamente che qualcuno voglia spingerti avanti”. Anche Matteo ha il suo protettore. “Fin dal primo giorno, mi ha detto: Tu fa’ quel che ti dico, seguimi, e alla tua carriera ci penso io”. Va avanti così per anni. Ma le cose non sono eterne. “All’improvviso la sua attenzione si è completamente spostata altrove. Dal chiamarmi quattro volte al giorno, l’ultimo anno è scomparso. Fino al gran finale: il dipartimento bandisce il concorso per il posto a cui lavoravo da otto stagioni,“che avrei dovuto vincere io”. Lui nemmeno me lo comunica. Io ne vengo a conoscenza e partecipo lo stesso, pur sapendo che, senza appoggi, non avrei mai vinto. In Italia, prima si sceglie un vincitore e poi si bandisce un concorso su misura per farlo vincere. Anche per un semplice assegno di ricerca. All’università è tutto truccato”. In questo volume intra–universitario che non c’è, ma c’è, Fini spiega gli ingranaggi universitari più comuni. Talmente elementari che nessuno aveva mai pensato di raccontarli. Sfogliamolo virtualmente.
Concorsi, primo esempio. Il blu e il nero. “Tutti i concorsi a cui ho partecipato erano già decisi in partenza. Sia quando ho vinto, sia quando ho perso. Vinci solo se il tuo garante siede in commissione. Il concorso è una farsa, è manovrato fin dal momento stesso in cui si decide di bandirlo. A me una volta è capitato che a metà prova si siano accorti che alcuni stavano scrivendo in blu e altri in nero. A quel punto ci hanno consegnato delle penne uguali per tutti, e siamo ripartiti daccapo. A fine prova mi sono accorto che c'erano degli stranieri che avevano scritto nella loro lingua natìa... Ma con la penna uguale alla nostra, eh!”.
Concorsi, secondo esempio. Gli ultimi saranno i primi. “M’iscrissi al bando e mi presentai al test d’ammissione che era composto esclusivamente da un colloquio orale in cui si ripercorreva la carriera dei candidati. Era un concorso per titoli. I candidati erano tre: io, una ragazza del sud di trentun’anni neolaureata e una ragazza del nord che stava discutendo la tesi. I posti erano sei, le borse di studio in palio due. Indovinate in graduatoria in che posizione mi piazzai? Esatto, terzo. E ultimo. In un concorso esclusivamente per titoli, cioè non vi erano delle prove d’esame che avrebbero potuto mostrare la preparazione di un candidato piuttosto che l’altro, contava solo il curriculum vitae; in un concorso per titoli tra due neolaureate, o quasi, e io che una laurea, come loro, ce l’avevo e che possedevo anche un titolo di dottore di ricerca, pubblicazioni scientifiche, manuali didattici e un’esperienza di oltre cinque anni in accademia tra lezioni, lauree, seminari e convegni, ecco in gara con loro due mi classifico terzo, dietro di loro…”.
Concorsi, terzo esempio. La salita è in discesa. “Qualche anno fa sono andato a fare un concorso per un contratto di un anno fuori sede. Fuori sede lo dico perché ogni ricercatore, o simile, è come affiliato al dipartimento di provenienza, ogni volta che prova a partecipare a un concorso in un altro ateneo è come se andasse in guerra. Con lo scudo e la fionda contro i fucili e i cacciabombardieri. Il posto era per un assegno di ricerca in Economia e gestione delle imprese. Ci presentiamo in tre. Il vincitore, il fantoccio e io. C’è sempre un fantoccio. Quello che deve fare presenza, ma perdere. Per non dare l’idea che il concorso sia ad personam. Purtroppo per loro però, inavvertitamente, mi ero iscritto pure io. E risultavo tremendamente più titolato degli altri due, vincitore compreso. Questo capitava non perché io fossi particolarmente genio, ma perché, essendo ormai da anni attorcigliato nel meccanismo universitario senza sbocchi in attesa del posto mio, mi ritrovavo a partecipare a concorsi per retrocedere. Scendi di categoria, e sembri un fenomeno. Così succede che devono trovare un modo per fermarmi. E non potendo dire che non ho i titoli o che il mio curriculum mal si relazioni col loro progetto di ricerca. sapete cosa s’inventano? Provano con la psicologia. Anzi la psicologia inversa, il metagame. “Tu sei un ricercatore affermato, ormai hai anni di esperienza, il nostro progetto dal punto di vista quantitativo non presenta una sfida entusiasmante, saranno sì e no due calcoletti, per cui non credo che questo sia il posto adatto a te... E così ho perso un’altra volta”.
Concorsi, per concludere. Così fan tutti.“E così risulta penalizzato anche chi vince perché è più bravo e perché se lo merita. Chi vincerebbe un concorso anche in una molto ipotetica gara alla pari. Senza padrini. Pensate a quanto possa essere frustrante, anche per loro, sapere che nonostante gli anni di studi, i sacrifici, nonostante siano pronti, in realtà si sono ritrovati vincitori perché qualcuno ha deciso così. Per delle logiche che continuano a esulare dalla loro preparazione e ricerca. Tutti penseranno che tu, come tutti, il posto non te lo sei guadagnato. Puoi urlarlo forte quanto vuoi, ma nessuno ti crederà. Tutti ti vedranno come l'abusivo, il solito infame”.
Assegnazione dei fondi. Specchietti per le allodole. “Quando vengono assegnati i fondi di ricerca, i professori e i dipartimenti si associano e mettono su un progetto alimentato dal blasone dei docenti unitisi (professori che magari fino al giorno prima neanche si salutavano). Dentro questi bandi vengono infilati anche dei ragazzi giovani, con la promessa che verranno messi poi a lavorare. Il bando viene vinto, arrivano i fondi, ma del progetto che ha portato ad accaparrarseli nessuno dice più niente. Viene accantonato, e i quattrini sono dilapidati nelle maniere più arbitrarie (pubblicazioni, acquisto di pc all’ultima moda ecc.). Che fine fanno i ragazzi coinvolti? Bene che vada si spartiscono le briciole”.
Libri universitari. Self–publishing.“Molti docenti scrivono libri che poi adottano a lezione, naturalmente, e molto spesso gli editori glieli fanno pagare fino all’ultimo centesimo, della serie “Ti pubblico, ma tu devi comprarne 5 mila copie”. Ma mica li acquistano con portafogli personali, i suddetti saggi; no, ordinari e associati amano invece attingere liberamente dai fondi di dipartimento, che pure magari erano destinati a qualche ricerca seria e pluripremiata”.
Cultore della materia. Il purgatorio dei tuttologi. “Più in basso ancora di assegnisti e dottorandi, c'è la figura del “Cultore della materia”: per permetterti di affiancare un Prof. in università se non hai titoli tuoi, questo ti fa "cultore", e tu così guadagni il diritto di aiutarlo in aula con gli esami o addirittura di fare lezione. La cosa divertente è che la decisione del docente è insindacabile. E così se un domani il tuo supervisor decide che tu debba essere un cultore in Fisica applicata o Letteratura greca medievale, e lo fa soltanto perché gli servi… il giorno dopo tu sarai legittimato ad andare in Aula a parlarne. Anche se non ne sai un fico secco”.
Didattica. Il fanalino di coda. “Viene vista come un fastidio. Un intralcio. È che da noi diventi docente solo dopo aver fatto il ricercatore. Ma il ricercatore dovrebbe fare ricerca, e il docente insegnare. Ci vorrebbe una separazione delle carriere. Un ottimo ricercatore può essere un pessimo docente, e viceversa”.
Seminari e riviste. Tutto fa brodo. “Spesso i dipartimenti organizzano seminari (sempre coi soldi dei fondi) il cui unico scopo è quello di presentare i propri lavori, perché così quel lavoro finirà dritto ne "gli atti del convegno", che è una pubblicazione, e che quindi va a curriculum, fa massa, valore, prestigio, carriera, altri soldi. C’è una lunga teoria di riviste che esistono solo per pubblicare gli atti di questi convegni: periodici clandestini, che pubblicano indiscriminatamente. Ci sono poi dipartimenti che le riviste se le creano da sé. È un circuito drogato, che lievita, ma su impasti veramente fragili. Basti vedere i curriculum dei docenti italiani: le pubblicazioni sulle riviste internazionali, quando ci sono, sono messe in bella mostra, mentre quelle sulle riviste nazionali vengono liquidate sotto la dicitura “altre pubblicazioni”... Come se ce se ne vergognasse”.
I baroni regnano sull'università. Raccomandazioni, scambi di favori, meriti negati, titoli ignorati. Il concorsone per scegliere i professori è sommerso di ricorsi. Il consiglio di stato ha accolto le proteste di un bocciato e potrebbe annullare l’intera tornata di nomine. Ecco come naufragano gli atenei italiani, scrive Emiliano Fittipaldi su “L’Espresso”. Ah porci!”, esclamò Perpetua. “Ah baroni!”, esclamò don Abbondio». I lanzichenecchi che distrussero la Lombardia nel 1630 Alessandro Manzoni li chiama proprio così, «baroni». Dal latino “baro - baronis”, termine che, dice la Treccani, indicava “il briccone, il farabutto, il furfante”. I mammasantissima delle nostre facoltà non hanno portato la peste come i soldati tedeschi che assediarono Mantova, ma di certo il loro dominio incontrastato ha contribuito a devastare l’università italiana. Dove, al netto delle eccellenze e dei tanti onesti, è sempre più diffuso il morbo del familismo, della raccomandazione e del corporativismo, a scapito del merito, delle capacità dei più bravi, della fatica dei volenterosi. Per i baroni la strada maestra per mantenere il potere e gestire il reclutamento è, ovviamente, quella di controllare i concorsi. Come dimostra l’inchiesta “Do ut des” della procura di Bari, che sta indagando per associazione a delinquere decine di professori di diritto costituzionale: «Carissimo, consegno un’umile richiesta al pizzino telematico. Ti chiederei il voto per me a Roma... sono poi interessato a due concorsi di fascia due, d’intesa con Giorgio che ha altri interessi. Scusa per la sintesi brutale, ma meglio essere franchi. A buon rendere. Grazie», si legge in una mail che il bocconiano Giuseppe Franco Ferrari ha mandato qualche anno fa a un collega, missiva ora al vaglio della Guardia di Finanza. La riforma Gelmini varata nel 2010 doveva mettere fine agli scandali e modernizzare finalmente gli italici atenei, da tempo in coda a ogni classifica delle eccellenze europee. Ahinoi, non sembra essere andata come si sperava. La nuova abilitazione scientifica nazionale (che ha da poco chiuso la tornata del 2012: i promossi a professori di prima e seconda fascia sono quasi 24 mila, i bocciati circa 35 mila) è stata un flop colossale. Nonostante un costo stimato superiore ai 120 milioni di euro, il concorso ha generato proteste a catena, incredibili favoritismi, migliaia di ricorsi al Tar e - come risulta a “l’Espresso” - anche i primi esposti mandati alle procure. La lista di presunti abusi basta leggere le accuse che arrivano da ricercatori esclusi, docenti e persino premi Nobel - è impressionante: se in qualche caso sono stati promossi candidati che vantano solo dieci citazioni (in articoli e pubblicazioni varie) a discapito di altri che ne hanno oltre seicento, tre commissari di Storia medioevale avrebbero truccato i propri curriculum attribuendosi monografie mai scritte pur di far parte della “giuria”. A Storia economica, invece, sono stati esclusi specialisti apprezzati in tutto il mondo, ma privi evidentemente dei giusti agganci: un gruppo di dodici studiosi stranieri, tra cui un Nobel, hanno così spedito al ministro Stefania Giannini una lettera indignata in cui si dicono «inquietati» dall’esito delle selezioni. I casi sono decine: da archeologia a biochimica, da architettura a chirurgia, passando per storia economica e latino, quasi in ogni settore sono stati denunciati giudizi incoerenti e comportamenti al limite dell’etica. Che spesso nascondono, sussurrano i ricercatori frustrati, la volontà dei baroni di cooptare, al di là delle reali capacità dei singoli, i predestinati e gli “insider”, cioè i candidati già strutturati nelle facoltà. Andiamo con ordine, partendo dal concorso di Diritto privato. L’abilitazione è finita sulle pagine di cronaca perché il commissario straniero (il membro Ocse è una delle novità più rilevanti della riforma) parlava solo spagnolo. Come abbia fatto Josè Miguel Embid a leggere e valutare i complessi tomi di diritto prodotti dai candidati è un mistero. “La conoscenza della lingua italiana”, ha spiegato in una nota il ministero dell’Istruzione, “non è prevista dalla legge”. I giudici del Consiglio di Stato si sono però fatti beffe delle giustificazione, hanno accolto un ricorso sul merito e sospeso tutto. Le stranezze non si contano. Se il commissario Maria Rosaria Rossi, ordinaria a Perugia, prima di essere sorteggiata componente della commissione aveva annunciato di voler sabotare la riforma Gelmini («a chi lavora nell’università spetta ora il compito di operare interstizialmente tra le pieghe della legge e oltre la legge stessa e sperimentare pratiche quotidiane di sabotaggio dell’ideologia che la sostiene», ha ragionato carbonara sul “Manifesto”), il ricercatore napoletano Andrea Lepore è stato promosso anche se il giudizio scritto, inizialmente, sembrava ipotizzare ben altro epilogo: «La qualità della produzione è limitata sotto il profilo dell’originalità e dell’innovatività, nonché per il rigore metodologico... Si rinvengono, tra l’altro, ampie frasi riprodotte alla lettera da lavori di altri autori precedentemente pubblicati». Andrea Lepore, in pratica, è accusato di essere un copione. Da promuovere, però, «all’unanimità». Francesco Gazzoni, professore della Sapienza e maestro indiscusso della materia (è suo il manuale di Diritto privato più venduto d’Italia), all’abilitazione nazionale ha dedicato un saggio, intitolato “Cooptazioni: ieri e oggi”: «Il potere accademico è una vera e propria piovra mafiosa», si leggeva sulla rivista online “Judicium” prima che l’articolo fosse repentinamente rimosso. «Cooptare, in sé, non è un male, lo diventa quando la scelta avviene, come sempre avviene, in base a criteri che prescindono dal merito... I professori di università sono novelli Caligola, con in più il fatto di promuovere, all’occorrenza, anche asini patentati in difetto di cavalli». Il luminare fa nomi e cognomi, e se la prende con l’intera commissione di Diritto privato «inidonea a giudicare, essendo priva di autoritas sul piano scientifico». I più bravi, in sintesi, sarebbero stati bocciati perché «non avevano un’adeguata protezione accademica e perché non tutti i commissari erano in grado di leggere e capire i loro titoli». Forse il professore esagera, ma di certo qualche candidato di Diritto privato è stato più fortunato di altri. Come l’avvocato Claudia Irti, che ha scoperto che il presidente della commissione, Salvatore Patti, era stato suo tutor alla tesi di dottorato. Un conflitto di interesse non da poco per il docente, tanto più che è la Irti in persona a rispondere al telefono della sede milanese dello studio Patti: «Sì, sono stata promossa, ma ci tengo a dirle che io non lavoro per il professore. Perché rispondo al telefono del suo studio? È una situazione particolare, a Milano presidio la sede, ma faccio solo da rappresentanza. Il professore si sarebbe dovuto astenere dal giudicarmi? Significa che tutte le persone che collaborano con i membri della commissione non avrebbero dovuto presentare domanda al concorso. Le assicuro che sono tante». È il sistema, dunque, a permettere che possa accadere di tutto: se Patti, oltre alla Irti, ha potuto valutare i titoli di tre magistrati di Cassazione che potenzialmente possono essere giudici delle sue cause (tutti abilitati), il collega Francesco Prosperi dell’Università di Macerata ha promosso a ordinario il giovane Tommaso Febbrajo, un tempo suo allievo, e figlio dell’ex rettore dell’ateneo dove lo stesso Prosperi insegna. Non è un caso che il concorso di diritto privato conti già un centinaio di ricorsi al Tar. Un professore associato dell’università di Tor Vergata, Giovanni Bruno, ha già avuto soddisfazione dal Consiglio di Stato. I magistrati hanno accolto alcune censure decisive, tanto che qualcuno ipotizza che l’intero svolgimento dell’abilitazione nazionale sia a rischio: il regolamento ministeriale pubblicato nel 2011 sarebbe illegittimo, perché avrebbe dato alle commissioni un eccesso di discrezionalità nella valutazione dei candidati. Bruno ha pure mandato un esposto alla procura di Roma, accusando Prosperi di non aver partecipato a una delle riunioni in cui si definivano i giudizi: a leggere un programma accademico dell’Università di Macerata, risulta che il 29 novembre 2013 il sociologo abbia partecipato (almeno fino alle 13) a un convegno nelle Marche. Anche un altro candidato trombato, l’avvocato Giuseppe Palazzolo, ha mandato una denuncia ai pm (stavolta a Napoli) in cui chiede il sequestro della piattaforma elettronica usata dai membri della commissione. Già, alcuni candidati avrebbero voluto controllare se i loro giudici hanno davvero letto i loro titoli (mandati in formato elettronico) o abbiano promosso e bocciato alla cieca, senza nemmeno effettuare il download. Il ministero ha rigettato, però, tutte le richieste d’accesso ai tabulati. Nel 1898, in una cronaca del “Corriere della Sera”, si raccontava che il ministro della Pubblica istruzione del governo Pelloux, Guido Baccelli, “impaurito e seccato dagli scandali occorsi nelle commissioni chiamate a giudicare pe’ i concorrenti alle cattedre vacanti d’università, abbia in animo di abbandonare il sistema adottato quest’anno per l’elezione delle commissioni”. Cos’era successo? “Qualche concorrente” spiegava il cronista “non aveva trovato miglior mezzo per riuscire, di domandare la mano di sposa alla figliola di un commissario: il matrimonio si combinava per il dopo concorso; il fidanzato, manco a dirlo, riusciva primo, e festeggiava in un giorno medesimo la cattedra e la moglie”. Dopo centosedici anni e una quindicina di riforme, dopo gli scandali dell’ultimo ventennio (citiamo quelli che travolsero il concorso nazionale del 1993, le inchieste che hanno svelato le appartenenze militari alle cosiddette “scuole” e le tristi vicende dei concorsi locali, dove spesso e volentieri il candidato indigeno vince a mani basse), il legislatore sembra aver toppato anche stavolta. La legge 240, quella della riforma Gelmini, ha sì previsto dei parametri oggettivi che gli aspiranti avrebbero dovuto superare per passare l’esame (le cosiddette “mediane”), ma molti professori hanno deciso come sempre: di testa loro. In effetti gli studiosi della “Voce.info” hanno scoperto che per i concorrenti con un profilo scientifico più debole “la conoscenza di un membro della commissione ha migliorato significativamente le chance di successo”. A parità di curriculum, per esempio, in Politica economica “gli insider hanno avuto il 14 per cento di probabilità in più” di passare rispetto a coloro che non frequentano gli atenei, una percentuale che sale al 23 per cento in Scienza delle finanze. Polemiche a go-go anche nella macroarea di Archeologia, dove un gruppo di accademici (tra cui Salvatore Settis, Fausto Zevi ed Ermanno Arslan) hanno scritto una lettera in cui prima attaccano «lo strumento mostruoso delle mediane, ridicolo artifizio blibliometrico che rinuncia alla qualità e fa discendere i giudizi delle quantità», poi se la prendono con i colleghi della commissione, che avrebbero aiutato le scuole più forti «privilegiando alcuni candidati, non sempre di evidente alta qualità, e danneggiato altri, con scelte valutative a dir poco opinabili». «I talenti sono stati bocciati, i “peggiori” sono stati sistematicamente promossi, anche a Latino» ha attaccato l’ordinario perugino Loriano Zurli. Un meccanismo che non solo è amorale ma anche anti-economico, dal momento che il rilancio dell’università e della ricerca sono fondamentali - secondo tutti gli esperti - per la crescita della ricchezza nazionale. Se il professore di Biochimica Andrea Bellelli definisce «una farsa» il concorso del suo settore e ricorda che «uno dei cinque commissari sorteggiati pare non avesse le mediane», un gruppo di prof e ricercatori dell’associazione Roars (presieduta da Francesco Sylos Labini) ha sottolineato alcune scellerate scelte dell’Anvur che ha considerato “scientifiche” ben 12.865 riviste tra cui spiccano “Alta Padovana” del Comune di Vigonza, “Delitti di carta” specializzata nella giallistica, “L’annuario del liceo di Rovereto”, il mensile della parrocchia di San Domenico, “Cineforum” e “Stalle da latte”. Ma è capitato di peggio. A Progettazione architettonica i commissari hanno fatto letteralmente a pezzi alcuni candidati pubblicando online giudizi (leggibili da tutti) in bilico tra ironia e insulto. Il professor Giuseppe Ciorra, ordinario all’università di Camerino, bocciando una ricercatrice a Torino scrive, letteralmente, che «la candidata non è scema, ha dimestichezza con la scena internazionale e rivela curiosità in tutte le direzioni... Incoraggiabile ma non recuperabile, temo». Il collega Benedetto Todaro ha definito una collega associata di Napoli, Emma Buondonno, una «candidata sconcertante, che si impegna volenterosamente in lavori completamente privi del necessario acume critico». Ciorra (che arriva a liquidare un esaminando con un definitivo «sparisca, per favore»), sembra assai più gentile quando si tratta di valutare candidati che conosce di persona. Quando è costretto a bocciare la sua ex dottoranda Rita Giovanna Elmo spiega che lo fa «con dolore umano», mentre non si fa specie nel promuovere (il suo sarà l’unico “sì”) Anna Rita Emili, ricercatore in forza alla sua stessa università poi bocciata da tutti gli altri colleghi. La Emili si può consolare, è in ottima compagnia: la commissione ha fatto fuori i migliori progettisti italiani. Anche stavolta qualcuno si è lagnato con la Giannini: l’Associazione italiana di Architettura e critica «manifesta un totale dissenso contro qualsiasi atteggiamento sessista e maschilista della commissione d’esame volto a schernire le ricercatrici. Suggeriamo ai membri della commissione di mostrare anche più rispetto, in futuro, per la grammatica italiana». Il barone che sbaglia le congiunzioni, in effetti, è davvero troppo.
Ma quant'è bella la vita dei docenti universitari. In un pamphlet in libreria in questi giorni, Stefano Pivato traccia un ritratto tagliente e autocritico della tribù degli ordinari, associati e ricercatori, immutabile e soprattutto insondabile, scrive Maurizio Di Fazio su “L’Espresso”. È alto il tasso di mortalità studentesca negli atenei italiani. La colpa viene di norma attribuita agli studenti stessi; e delle responsabilità didattiche dei docenti universitari nessuno dice niente. “Al limite della docenza” di Stefano Pivato, “piccola antropologia del professore universitario” (Donzelli Editore), ricalibra questo assunto. Ed è un ritratto-pamphlet divertente, tagliente e autocritico della tribù degli “ordinari, associati e ricercatori”, immutabile e soprattutto insondabile. L’autore, certi aspetti, atteggiamenti, tic identitari e collettivi, li conosce bene, dall’interno: insegna lui stesso, da quarant’anni, Storia contemporanea all’università. Ha ricoperto anche il ruolo di rettore. Entrò in ruolo subito dopo la “liberazione del ’68”. Misteriosa creatura stanziale, a differenza di quanto accade in America o nel resto d’Europa: addio clerici vagantes, “il docente, nella generalità dei casi, si laurea, cresce e progredisce in carriera nella stessa università”. Ma i nostri radar letterari non l’hanno mai intercettato: De Amicis narrava di un maestro elementare e Don Milani di insegnanti delle scuole medie. Idem al cinema: tranne “Morte di un matematico napoletano” di Mario Martone, non viene in mente altro. La stessa cronaca si ricorda dell’“homo academicus” nostrano solo quando c’è da rovistare dentro casi di parentopoli, concorsi truccati e “sex for 30” sul libretto. Eppure la prima Università occidentale è tricolore, quella di Bologna risale, infatti, al 1088; e subito dopo la Chiesa, l’Accademia è la più antica tra le istituzioni, “nel tempo ha perfezionato i propri meccanismi, chiusi e non contaminati col mondo esterno, fino a renderli perfetti. Anche nelle loro storture” scrive Pivato. Fuori dal tempo, statico ma adattivo, il barone o baronetto nazionale è il più anziano del Vecchio continente: anche adesso che la sua età pensionabile è stata anticipata a 70 anni, tra i lamenti dei 75enni e le invidie dei non ancora quarantenni che restano una frangia simbolica, il 12 per cento del totale. In “Al limite della docenza”, Stefano Pivato apre passando in rassegna i fondamentali “tipi da cattedra”. Come il prof. “Come sto io?”. “Solitamente, quando due persone si incontrano, si chiedono vicendevolmente Come stai? Una certa tipologia di docente, se ti incontra, senza chiederti nulla, ti dice “Come sto io?”. Segue elencazione dei saggi che ha scritto, dei convegni a cui ha partecipato, delle lodi che ha ricevuto. “L’Accademia è fatta così. Ancor prima che di riconoscimenti scientifici, si nutre di solleticamenti a uno smisurato ego”. L’egolatria, e la vanità, sarebbero le due pietre angolari della mentalità del docente. Insieme a un’eterna conflittualità tra simili: “Litigo, dunque sono”. “Litigare è una forma assoluta per certificare la propria presenza; e magari, giustificare la propria assenza”. Così i professori più attaccabrighe sono spesso i più assenteisti. E in pochi ambienti come quello accademico l’insinuazione maliziosa, la diceria, la diffamazione giocano un ruolo tanto importante. Proliferano, come cellule impazzite che si penserebbero radicate in ben altri strati della società, le lettere anonime; vedersi dare dello iettatore può pregiudicare una carriera già avviata. I docenti universitari si sentono tutti autori di bestseller, anche se “hanno pubblicato presso un anonimo stampatore” e si ingegnano in mille modi per costringere i propri studenti a comprarne qualche copia. Uno dei loro mantra più comuni, al ritorno da una lezione, è questo: “Era piena zeppa di studenti” . In verità, a volte, non c’era quasi nessuno. Il “tribalismo universitario” si è formato e consolidato nel corso dei secoli. Ecco allora il “Chiarissimo” (professore ordinario), il “Magnifico” (rettore), l’“Amplissimo” (preside di facoltà). Anche l’apparato iconografico non scherza, e non muta. La liturgia del potere non conosce strappi. Potere talvolta lungo una vita: ci sono stati rettori che hanno governato per decenni. Non appena possibile, gli Insegnanti Massimi sfoggiano toghe, ermellini e altri paramenti. E se c’è un qualcosa che li manda in visibilio, è la parola (sempre più in disuso) “concorso”. “Perché il concorso gratifica il vincitore ma, in misura non minore, anche chi lo fa vincere”. Il docente-tipo necessita di uno spazio sempre più agevole: anche se ha pochi studenti, vuole un’aula più grande e uno studio personale sconfinato. È singolare la sua concezione del tempo. Il semestre universitario dura circa tre mesi e mezzo, e l’ora quarantacinque minuti. E “talvolta, secondo un’antica consuetudine, se ha impegni di varia natura e deve chiudere in fretta”, reintroduce d’imperio la lectio brevis. Sui generis anche la sua settimana lavorativa, che copre la prima o la seconda parte, in corrispondenza delle ore di lezione: “per chi svolge la lezione durante la prima parte, la settimana inizia il lunedì pomeriggio e termina il mercoledì mattina; per quanti svolgono lezione nella seconda parte, la settimana inizia il mercoledì pomeriggio e termina il venerdì mattina”. Bella la vita del professore universitario nella penisola, impiegato pubblico a se stante, “non esistono cartellini da timbrare e gli impegni di lavoro sono interpretati in maniera alquanto lasca”. Il suo obbligo è di 350 ore annue, cifra che comprende le lezioni, le attività collegiali e le commissioni d’esame e di laurea. Il carico di lezioni può oscillare invece tra le 60 e le 120 ore, soglia molto più bassa di quella di un qualsiasi suo omologo europeo: 192 ore in Francia, 240 in Gran Bretagna, da 248 a 279 in Germania, da 252 a 360 in Spagna. E le stravaganze non cessano qui: “alcuni docenti mettono in calendario la prima lezione settimanale alle 18 e la seconda alle 8 del mattino successivo, esaurendo così, in breve tempo, la loro permanenza settimanale in Facoltà”. Tanto i codici etici introdotti dalle singole università sono, più che altro, petizioni di principi: le sanzioni restano sulla carta, e i docenti peggiori e improduttivi al loro posto. Anche se questo significa un cospicuo danno d’immagine e un minore trasferimento di risorse all’ateneo interessato. Stefano Pivato racconta poi che ai professori universitari come lui non viene richiesto di essere abili nell’insegnamento. Come se conoscere equivalesse automaticamente a saper insegnare. L’esame di abilitazione nazionale se ne disinteressa; i metodi sono cristallizzati ad almeno un secolo fa. In tempi in cui tutto scorre vorticosamente, sarebbero consigliabili nuove strade, ma invece si ricorre ancora alla lezione ex cathedra, “che è rimasta la stessa, di fronte a un pubblico di studenti aumentato a dismisura dal punto di vista quantitativo e qualitativo”. Mille anni dopo la fondazione dell’Università bolognese, a quindici anni di distanza dalla “riforma-spezzatino Berlinguer”, e a un tiro di binocolo dalla babelica “riforma Gelmini”, per l’opinione pubblica esterna “il docente è misurato dalla validità dei suoi studi, dall’attenzione che ricevono i suoi libri e dal prestigio delle case editrici che li fanno uscire”. Per la tribù universitaria, invece un docente vale esclusivamente per la funzione che occupa all’interno dell’Accademia. Anche se ha pubblicato un solo libro in decenni di “ricerca e insegnamento”. Anche se è di destra. O di sinistra. “Per la sua strenua difesa del territorio, dell’identità e dello jus loci è assimilabile al tipo antropologico leghista”. O lepenista. Uscire dal guado e aprirsi al mondo, anche fisicamente. Più doveri e meno diritti acquisiti. Perché “prima di qualsiasi riforma, bisogna riformare se stessi”. E perché spetta a loro il compito di formare le classi dirigenti del futuro. È questa la proposta, docente, di Stefano Pivato.
Università, paradossale guerra ai fuori corso. "Gli atenei finiranno per regalare gli esami". Il ministero, nell'erogare i fondi, adesso penalizza i centri con troppi studenti in ritardo con le materie. E a subire le peggiori decurtazioni sono le grandi università. Che, per correre ai ripari, hanno solo due strade: aumentare le tasse o promuovere con più facilità, scrive Roberta Carlini su “L’Espresso” Caccia grossa al fuoricorso. L’eterna lamentela sul numero eccessivo di studenti italiani che non si laureano “in tempo” è diventata un problema contabile serio. Da quando dalle stanze ministeriali è uscita la tabella che assegna i fondi pubblici agli atenei, mettendo in pratica la grande novità del “costo standard per studente in corso”. Che di fatto cancella dall’università italiana almeno 700.000 persone, perché fuori corso. Risultato: gli atenei con maggior numero di studenti che non si laureano nei tempi dovuti hanno un danno economico consistente, e crescente. E crescono i timori per due conseguenze perverse del nuovo meccanismo: da un lato, l’aumento a tappeto delle tasse per i fuori corso; dall’altro, la tentazione di abbassare l’asticella delle prove d’esame, in modo da accelerare il percorso verso la laurea. “Nella nostra università ci sono circa 20mila studenti fuori corso: è pensabile che non pesino per niente? A loro non dobbiamo dare servizi, offerte, insegnamenti?”. Il rettore di Pisa Massimo Mario Augello è stato uno dei primi a protestare contro le nuove regole. L’ateneo che lui guida è uno dei più penalizzati: “non è questione di virtuosi o no”, afferma, ricordando classifiche internazionali sulle università che vedono Pisa tra le prime italiane. Il problema è un altro: “il numero dei fuori corso è più alto nei grandi atenei, quelli con un bacino di utenza più ampio”. Se in percentuale, nella classifica delle università, abbiamo quote di fuori corso superiori al 40 per cento in molte piccole università soprattutto del Sud, sopra la media ci sono anche alcune grandi, dalla Sapienza di Roma all’università di Pisa, da Napoli a Palermo.
I dati per singolo ateneo si possono vedere nel grafico: il numero degli studenti in corso è quello risultante dalla tabella di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario 2014, mentre il numero complessivo degli iscritti è da Anagrafe degli studenti. Tutti i dati si riferiscono all’anno accademico 2012/2013.
Atenei dai numeri imponenti, nei quali gli studenti messi fuori con il nuovo calcolo dei fondi sono migliaia e migliaia: alla Sapienza si “perdono”, ai fini delle entrate di bilancio, 42 mila iscritti, a Palermo 20 mila, alla Federico II di Napoli oltre 30 mila, alla Statale di Milano 18.000. In soldi, la differenza è dolorosa: per fare un esempio, la prima università d’Italia e d’Europa, la Sapienza, ha perso una decina di milioni di euro di fondi con il nuovo meccanismo. E siamo solo all’inizio: infatti se per quest’anno solo il 20 per cento del finanziamento è attribuito sulla base di questo calcolo, entro cinque anni si salirà al 100 per cento. Cioè, i fuori corso saranno solo un “peso morto” per gli atenei, un costo che c’è ma non conta nulla ai fini del finanziamento pubblico. “Il problema si può risolvere alla radice, con decreto del rettore: regaliamo ogni anno un esame a ogni studente, così molti di più si laureano in tempo”, ha detto provocatoriamente il rettore di Pisa. Ma non è solo una battuta. Anche il Cun – il Consiglio universitario nazionale – ha denunciato il rischio di “comportamenti non virtuosi per ridurre il numero degli studenti fuori corso”. Che vuol dire? Un occhio più benevolo nella valutazione degli esami? “Qui a Milano abbiamo circa 18 mila fuori corso: cerchiamo di ridurli, investendo su orientamento, diritto allo studio, tutoraggio, servizi – dice Giuseppe De Luca, prorettore alla didattica della Statale di Milano - Ma molti piccoli atenei non hanno un soldo per fare queste cose, potrebbero reagire semplicemente abbassando l’asticella degli esami”. Perché spesso un alto numero di fuori corso deriva dalla serietà e selettività delle lauree. O anche dal fatto che si tratta di studenti lavoratori. O addirittura “che hanno impiegato più tempo perché sono andati a fare degli Erasmus”, denuncia Alberto Campailla della rete Link degli studenti. “Tutti questi diventano fantasmi, non esistono. E però pagano sempre di più”, aggiunge Campailla. E’ questa l’altra possibile conseguenza “non virtuosa” del nuovo meccanismo. Infatti, dai tempi del governo Monti le università hanno meno vincoli nell’aumento delle tasse: se in generale i contributi chiesti agli studenti non possono salire oltre una certa quota del Ffo, per i fuori corso il tetto è saltato. Risultato: i soldi persi per “eccesso” di fuori corso si possono recuperare tassando il loro ritardo. Già in alcuni atenei questi pagano di più degli altri: alla Sapienza, dopo il terzo anno fuori corso si paga il 50 per cento in più; anche Palermo ha introdotto un aggravio per chi non si laurea in tempo, che era allo studio anche a Pisa ma è stato bloccato in extremis. “Lo abbiamo rifiutato, è un modo per fare cassa che non riteniamo giusto – dice il rettore Augello – Ma questo è uno degli effetti distorsivi delle nuove regole: tutte le università stanno guardando al serbatoio dei fuori corso per cercare risorse”. Chi è stato alle ultime riunioni dei rettori, dopo la stangata del “costo standard”, racconta che l’idea di aggravare la tassazione sui fuori corso è generalizzata. Giustificata da urgenze di cassa, e dal fatto che è una delle poche leve che gli atenei hanno; e dal vecchio stigma su quelli che l’allora sottosegretario Michel Martone (governo Monti) definì “gli sfigati”. Mentre cresce il numero di quanti lavorano e studiano, o restano indietro per altri motivi, spesso riconducibili proprio alla disorganizzazione delle università. “Il concetto di fuori corso è cambiato – dice Guido Fiegna, già direttore generale del Politecnico di Torino ed esperto dei numeri dell’università italiana – già si farebbe molta pulizia se si utilizzassero di più le iscrizioni a part time, per gli studenti lavoratori, per le quali però le università fanno resistenza, proprio per non perdere iscritti e fondi”. Non solo: “non si capisce perché nel costo standard si calcolano solo gli studenti iscritti ai corsi, e non chi sta facendo il dottorato di ricerca, come se questi non studiassero”.
La caduta (parziale) degli Dei, scrive Piero Sansonetti su "Il Garantista". Il segretario dell’Anm, il dottor Maurizio Carbone, dice che la riforma delle norme sulla responsabilità civile dei magistrati, approvata l’altro ieri dal Parlamento, «è un tentativo di normalizzare la magistratura». Lo ha dichiarato ieri, durante la conferenza stampa dell’ Anm, che è su tutte le furie per questa piccola riforma. Già: «normalizzare». Cioè rendere normale. Oggi la magistratura non è normale: è l’unica istituzione dello Stato ad essere al di sopra dello Stato, della legge, ad essere – nell’esercizio delle sue funzioni – immune dalla legge, e insindacabile, e non dipendente dallo Stato ma sovraordinata allo Stato. «Normalizzare» la magistratura, cioè toglierle la sua caratteristica di ”deità” (che non è la ”terzietà” di cui spesso l’Anm parla) non sarebbe una cosa cattiva. Libererebbe forse l’Italia da un sovrappeso ”feudale” che ancora ne condiziona profondamente la struttura democratica, e che probabilmente è in contrasto con lo spirito della Costituzione, che è una Costituzione Repubblicana e che prevede l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Alcuni magistrati dicono: ma noi siamo magistrati, non cittadini. E su questa base pretendono di non dover sottostare alla legge. Ritengono – temo in buona fede – che la saldezza di una società, e la sua moralità, e il suo essere ”società etica” (successivamente si passa all’idea dello ”Stato Etico”) non possono che essere affidati ad una entità e ad un gruppo di persone migliori degli altri (”aristoi”) i quali siano in grado di ”sapere” la vita degli altri, valutarla, giudicarla, punirla. Non è questa una funzione – pensano – che possa essere affidata alla democrazia, o al libero svolgimento delle relazioni umane e sociali, perché la democrazia è un buon sistema di governo ma è viziato da corruzione. E l’eccesso della libertà, della deregolamentazione, sono pericolose per la collettività. La democrazia deve essere ”corretta”, o comunque controllata, e anche la società, da qualcosa di superiore e di ”certamente morale”: e cioè da i giudici. Contestare questa funzione dei giudici vuol dire contestare la loro indipendenza. E mettere in discussione l’indipendenza dei giudici vuol dire correre il rischio che la magistratura finisca per non essere più autonoma dalla politica. L’autonomia dalla politica non è vista come una condizione di funzionamento della magistratura, o come un elemento necessario nell’equilibrio dei poteri, ma come un valore assoluto al quale una società ”morale” deve sottomettersi, e in assenza del quale la società diventa ”immorale” e la democrazia, e le istituzioni, scendono in una condizione di subalternità alla politica. La politica è ”il male” , la giustizia (lo dice la parola stessa) è il bene, e il bene può governare il male, e può redimerlo, correggerlo, sottometterlo. Il male non solo non può governare il bene, ma non può aspirare ad essere alla pari col bene. Ecco, questo ragionamento è alla base delle molte dichiarazioni rilasciate ieri dal dottor Carbone, e anche dal presidente dell’Anm Sabelli. Il quale ha rimproverato al governo di avere promesso una riforma della Giustizia in 12 punti, e di avere realizzato invece l’unico punto che non va bene, e cioè la riforma della responsabilità dei giudici. I magistrati invece – ha spiegato – vogliono cose diverse: per esempio la riduzione della prescrizione, l’estensione dei poteri speciali ”antimafia” anche ad altri reati, il processo telematico (cioè la cancellazione del diritto dell’imputato ad essere presente al suo processo), la riduzione dei gradi di giudizio, eccetera. In sostanza, la proposta dell’Anm (che più o meno è stata organicamente strutturata nella proposta di riforma del dottor Nicola Gratteri) è quella di escludere norme che riportino alla normalità la magistratura, ristabilendo la legittimità dello Stato liberale e dell’equilibrio dei poteri, ma, viceversa, decidere un forte aumento dei poteri della magistratura, un ridimensionamento drastico dei diritti dell’imputato, e un rafforzamento della condizione di preminenza e di insindacabilità dei pubblici ministeri. Sabelli ha anche annunciato che l’Anm ha chiesto un incontro al Presidente della Repubblica. Per dirgli cosa? Per esprimere le proprie rimostranze contro il Parlamento. Già nella richiesta dell’incontro c’è un elemento di scavalcamento dell’idea (puramente platonica in Italia) dell’indipendenza dei poteri. La magistratura ritiene che il suo compito non sia quello semplicemente di applicare le leggi, ma di condizionarne il progetto e la realizzazione. L’associazione magistrati chiede al Presidente della Repubblica di frenare, o condizionare, o rimproverare il Parlamento. E vuole discutere nel merito delle leggi. La magistratura considera inviolabile la propria indipendenza dagli altri poteri, e inaccettabile la pretesa di indipendenza degli altri poteri dalla magistratura. Devo dire che la passione con la quale i magistrati hanno reagito alla miniriforma della responsabilità civile mi ha colpito soprattutto per una ragione: questa riforma è quasi esclusivamente simbolica. La responsabilità dei giudici resta limitatissima. L’unica vera novità è la rimozione del filtro che in questi vent’anni aveva permesso solo a 4 cittadini di ottenere un risarcimento per la mala-giustizia (nello stesso periodo sono stati processati e condannati 600.000 medici). Tutte le altre barriere restano. I magistrati saranno giudicati solo in caso che sia accertata una colpa grave, o addirittura un dolo nel loro comportamento, saranno giudicati non da una autorità esterna ma dai loro colleghi (visto che oltretutto non esiste una divisione delle carriere) e se alla fine saranno ritenuti colpevoli pagheranno con una sanzione che in nessun caso potrà superare la metà dell’ammontare di un anno di stipendio. Voi conoscete qualche altra categoria professionale protetta fino a questo punto? La probabilità di essere condannati per i magistrati è così bassa, e l’esiguità della pena così forte, che chiunque può mettersi al riparo pagando una assicurazione con poche decine di euro. Cosa che non vale per i medici, o gli ingegneri (non parliamo dei giornalisti) che essendo espostissimi al rischio di condanna (anche senza dolo e senza colpa grave) se vogliono sottoscrivere una assicurazione devono pagare migliaia e migliaia di euro. Diciamo che il privilegio non è affatto toccato da questa riformetta. Appena appena scalfito. E allora? Il fatto è che comunque la riforma ha un valore ideale, è una specie di metafora. Il Parlamento, per una volta, non si è inginocchiato davanti alla magistratura. E’ questa la novità che ha messo in allarme i settori più corporativi della magistratura. Il timore è che davvero possa cambiare il clima politico e possa essere aperta una via alle riforme vere, e al ridimensionamento della ”Divina Giustizia”. No, la riforma non comporterà la caduta degli Dei. Solo che gli Dei non sopportano gli oltraggi. Sono permalosi. E’ sempre stato così, dai tempi di Omero. E questa legge è uno sberleffo inaccettabile, anche se innocuo.
Magistrati: ecco perché non pagheranno mai. La nuova riforma della responsabilità civile dei magistrati? Non cambierà nulla. Perché l’arma è già spuntata in partenza, scrive Maurizio Tortorella su “Panorama”. Vi hanno detto che adesso cambia tutto? È un bluff. Non hanno pagato un euro negli ultimi 26 anni e non pagheranno nemmeno domani. Il 25 febbraio la Camera ha approvato la nuova legge sulla responsabilità civile, e da allora magistrati e giudici gridano all’indipendenza violata, strepitano all’attentato alla Costituzione. I più vittimisti ne parlano addirittura come di una «punitiva ditata negli occhi». Tutti paventano «uno tsunami di ricorsi». Ma è solo una pantomima. Ne sono convinti molti giuristi e ne sono certi soprattutto gli avvocati, che continueranno a non utilizzare lo strumento. Perché non funziona e non funzionerà. Sergio Calvetti, penalista di Vittorio Emanuele di Savoia, ha appena incassato 39 mila euro dalla Corte d’appello di Roma che ha riconosciuto al suo cliente l’ingiusta detenzione del 2006, più danni accessori e d’immagine. Calvetti, però, non è riuscito nell’impresa invocando la responsabilità civile del magistrato che a Potenza condusse l’indagine, quell’Henry John Woodcock che fu star di cento inchieste tanto roboanti quanto avare di risultati: «Abbiamo ottenuto questo risultato come risarcimento da ingiusta detenzione» spiega il legale «e questo anche se subimmo la pervicace volontà di trattenere in quella sede il processo, pur senza alcuna competenza territoriale». Francesco Murgia, con Calvetti difensore storico di Vittorio Emanuele, aggiunge che in realtà una citazione per responsabilità civile fu presentata nei confronti di Woodcock nel dicembre 2011, quando cadde l’ultima accusa contro il loro cliente. Ma fu dichiarata inammissibile perché il tribunale stabilì fosse «non tempestiva»: avrebbe dovuto partire nel giugno 2006, ai tempi dell’ordine di custodia cautelare. Perché questo, assurdamente, prevede la legge (e oggi viene confermato dalla sua riforma): che per agire il cittadino aveva due anni, ora tre in base alla riforma. Con il trucco, però: perché l’orologio scatta dal momento in cui l’arresto o il primo provvedimento cautelare viene respinto. «Ma come faccio a iniziare un’azione di responsabilità, se sono ancora sotto scacco?» protesta Murgia. È con ostacoli come questo che la Legge Vassalli, varata il 13 aprile 1988 come (inadeguata) risposta al referendum radicale che un anno prima, con l’80 per cento di sì, aveva cancellato tre articoli del codice che proteggevano come un castello medievale magistrati e giudici dalle azioni civili dei cittadini, ha continuato a garantire piena protezione alla categoria. Da allora sono state appena 410 le azioni intentate da vittime di malagiustizia, e sono state più che decimate dalla valutazione di ammissibilità, il cosiddetto «filtro»: un giudizio preventivo svolto nel tribunale competente per territorio. C’è chi, come Piercamillo Davigo, giudice di Cassazione e fondatore della nuova corrente giudiziaria Autonomia e indipendenza, nonché nemico della riforma, analizza il dato con sarcasmo: «La responsabilità civile dei magistrati non è un problema, visto che i cittadini fanno poche domande». Altri numeri in realtà dimostrano che in Italia un problema di malagiustizia esiste, ed è grave. Prima della Legge Vassalli, dal 1945 al 1988, l’Eurispes e l’Osservatorio permanente sulle carceri calcolano 4,5 milioni di errori giudiziari. Possibile che dopo il 1988 il fenomeno sia scomparso? Certo che no. Il punto è che le citazioni per responsabilità civile sono state poche perché la legge non ha mai funzionato. Dal 1988 a oggi la Cassazione ha stabilito sette risarcimenti in tutto, uno ogni 7,5 milioni di processi penali aperti nel periodo. C’è il caso di un’azienda agricola grossetana fallita nel 1998 per l’errato sequestro di una tenuta, deciso in un’inchiesta per reati ambientali (500 mila euro risarciti). C’è il caso di un pm siciliano che nel 2002 non tenne nel debito conto una serie di lettere, acquisite dai Carabinieri, che avrebbero potuto evitare un omicidio-suicidio di coppia: i familiari della donna uccisa, nel 2009, hanno ottenuto 95 mila euro. Ma in nessun caso, mai, lo Stato si è rivalso sui pm o sui giudici ritenuti colpevoli di dolo o colpa grave. Nessuno di loro ha mai pagato nulla. L’ultima pronuncia, per ora ferma al primo grado, riguarda un’inchiesta guidata nel 2004 dall’ex pm calabrese Luigi De Magistris, poi migrato in politica. Lo scorso 3 dicembre il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato a pagare meno di 25 mila euro a Paolo Antonio Bruno, un magistrato di Cassazione che nel 2004 fu ingiustamente accusato di associazione mafiosa da De Magistris. Si vedrà come finirà il caso. Non ha mai nemmeno pensato di avvalersi della Legge Vassalli, invece, l’imprenditore calabrese Antonio Saladino, che pure dal 2006 si proclama vittima di un’altra, mitica inchiesta di De Magistris: la «Why not», che nel 2006 piazzò Saladino al centro di una ragnatela di presunte corruttele ma poi si risolse praticamente in nulla: «Citarlo in giudizio? Quell’inchiesta mi ha rovinato economicamente» dice Saladino «però io non ci ho mai nemmeno pensato. Sarebbe stata una povera battaglia contro i mulini a vento, e credo lo sarebbe anche oggi». È così. Avvocati e presunte vittime di giustizia hanno presto capito che la Legge Vassalli era utile come un cucchiaio bucato e hanno scelto altre strade. Dal 1991, per esempio, cioè da quando esistono i risarcimenti per l’ingiusta detenzione, in 23.326 hanno ottenuto un risarcimento: in 23 anni lo Stato ha versato loro 581 milioni di euro. La riforma, purtroppo, rischia di non cambiare nulla. «Oggi i magistrati si lamentano, ma è lo stesso vacuo bla-bla di 26 anni fa, con le medesime parole d’ordine» dice Gian Domenico Caiazza, penalista romano e presidente della Fondazione Piero Calamandrei. Caiazza è un’autorità, in materia. Nell’aprile 1988 era nel collegio che, a nome di un Enzo Tortora morente di cancro, chiese il risarcimento per il disastro giudiziario che cinque anni prima, a Napoli, aveva coinvolto il giornalista in un’inchiesta su camorra e droga. Era stato proprio il caso di Tortora, riconosciuto innocente dopo sette mesi di custodia cautelare e una gogna aberrante, a dare il là al referendum e a garantirne il successo. Nell’aprile 1988 la Legge Vassalli, appena varata, conteneva un articolo che ne impediva l’applicazione retroattiva. Poiché il referendum aveva abrogato le norme antecedenti, i difensori di Tortora si trovarono nella peculiare situazione di agire senza limiti. «Per la prima e forse unica volta nella storia di questo Paese facemmo causa ai magistrati come se fossero normali cittadini» ricorda Caiazza. «Ma poi il Tribunale di Roma passò la palla alla Consulta. Questa stabilì che l’articolo sulla irretroattività della Legge Vassalli era incostituzionale nella sola parte che riguardava il filtro sulla fondatezza delle nostre pretese: quella mancanza violava il principio d’indipendenza e autonomia della magistratura». Insomma: il filtro del giudizio di ammissibilità doveva esserci, per forza. Risultato? «A quel punto per il risarcimento avremmo dovuto partire daccapo» dice Caiazza «ma con quella pagliacciata avevamo perso due anni. Decidemmo di lasciar perdere». Il ricordo dell’avvocato di Tortora è preciso (la sentenza della Consulta è la n. 468 del 22 dicembre 1990) e oggi fa scoppiare come una bolla di sapone la principale, presunta innovazione della riforma appena varata. Caiazza ne è certo: «La questione sull’abolizione del filtro potrà essere sottoposta in ogni momento alla Corte costituzionale, che con tutta probabilità confermerà il suo orientamento di 25 anni fa». Anche Davigo è d’accordo: «La Consulta si è già pronunciata: l’eliminazione del filtro, con tutta evidenza, è costituzionalmente illegittima». Suona quindi troppo ottimista il tweet di Gaia Tortora, che la sera in cui è stata varata la riforma l’ha salutata come una vittoria alla memoria di suo padre (e il premier Matteo Renzi si è subito appropriato di quella generosa certificazione con un re-tweet). Anche perché intanto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si sbraccia per tranquillizzare l’Associazione nazionale magistrati. Il Guardasigilli ha già garantito alla categoria che non c’è nulla di cui preoccuparsi, che il governo «non ha alcun intento punitivo», che «resterà deluso chi si aspetta che i giudici siano condannati ogni due per tre», e addirittura che tra sei mesi sarà fatto «un tagliando» per verificare «eventuali eccessi». Nella storia d’Italia non s’era mai vista una legge con «retromarcia integrata». Beniamino Migliucci, presidente dei penalisti, è critico: «Il tagliando è un’assurdità giuridica e politica. E chi ipotizza una valanga di ricorsi fa disinformazione. Perché un imputato non può citare il suo giudice: il ricorso è improcedibile, impossibile, fino a quando non c’è una sentenza di Cassazione». Anche Giuseppe Di Federico, docente emerito di diritto penale a Bologna e tra i maggiori giuristi italiani, è scettico: «Non credo cambierà nulla. La nostra giustizia è del tutto deresponsabilizzata: la valutazione delle carriere dei magistrati fa passare tutti, al contrario di quanto accade in altri Paesi, e manca un vero sistema sanzionatorio. E poi voglio proprio vederli, gli avvocati, che si espongono a fare causa al loro giudice…». Una causa, oggi, non la farebbe nemmeno Pardo Cellini, il penalista che pure ha scoperchiato il più grave errore giudiziario italiano di tutti i tempi: quello che è costato 39 anni di processi a Giuseppe Gulotta, un muratore trapanese che nel 1976, a 18 anni, fu arrestato per l’omicidio di due carabinieri e solo dopo 22 anni di carcere, nel febbraio 2012, è stato riconosciuto innocente e liberato. Fin dalle prime udienze Gulotta dichiarò che la confessione gli era stata estorta con violenze e torture da parte dei Carabinieri. «E i suoi processi sono stati viziati da errori e lacune» dice Cellini. «Però abbiamo preferito chiedere il risarcimento come danno da errore giudiziario». Perché? Ma perché l’avvocato conosce a perfezione quali siano le tortuosità della responsabilità civile: «È un sistema che non funziona e non funzionerà» sospira. Il problema di Gulotta, che a 57 anni oggi vive della carità di un parroco, è che sono trascorsi già 36 mesi dalla sua riabilitazione ma non ha ancora visto un euro: l’avvocatura dello Stato si oppone, insiste nella tesi paradossale che il processo fu originato dalla sua confessione, per quanto estorta.«La vicenda Gulotta» conclude Cellini «mostra la resistenza dei tribunali e il disinteresse delle istituzioni. E io non vorrei proprio dirlo, ma temo che casi come il suo potrebbero accadere ancora. Per questo la responsabilità civile va rivoluzionata». Più positivo, a sorpresa, è un penalista che non ha mai simpatizzato con la magistratura: «La nuova legge è equilibrata e migliorerà la situazione» dice Maurizio Paniz, ex deputato del Pdl e avvocato di Elvo Zornitta, l’ingegnere veneto che fu ingiustamente accusato di essere «Unabomber», l’autore di una serie di 30 attentati dinamitardi dal 1994 al 2004, con sei feriti. Scagionato nel 2009, oggi Zornitta sta per chiedere il risarcimento allo Stato: non per responsabilità civile, però, ma ancora una volta come riparazione di un errore giudiziario. Per partire, Paniz aspetta le motivazioni della Cassazione che in dicembre ha condannato Ezio Zernar, il poliziotto che confezionò false prove per incastrare Zornitta. «La nuova responsabilità civile è migliore della vecchia» dice Paniz «perché specifica come cause di punibilità la manifesta violazione della legge e il travisamento delle prove. È un bene: a me sono capitati diversi processi in cui, a volte dolosamente, una prova veniva valutata in modo errato». La morale? La tira Grazia Volo, tra i più noti penalisti italiani: «Questa riforma arriva troppo tardi, 28 anni dopo il referendum. È una riforme sfilacciata, scritta da un legislatore superficiale e giustizialista, che intanto aumenta insensatamente le pene. E non cambierà nulla». Una morale ancora più severa? Dice Carlo Nordio, procuratore aggiunto di Venezia, da sempre controcorrente: «Il magistrato che manda in galera un indagato contro la legge non deve pagare. Dev’essere buttato fuori dalla magistratura». Chissà se il ministro Orlando ne terrà conto, nel suo «tagliando».
Ma ora i magistrati saranno più responsabili? La legge sulla responsabilità civile cambia poco. Con un rischio: l'eliminazione del giudizio preventivo di ammissibilità potrà ingolfare i tribunali, scrive Maurizio Tortorella su “Panorama”. Uno legge le cronache giudiziarie di oggi, perse come sono tra gli altissimi lamenti sulla fine dell'autonomia della magistratura e le infinite proteste di categoria, e pensa: caspita, che rivoluzione dev'essere questa riforma della responsabilità civile. Poi va a leggersi i 7 articoletti della legge e pensa: caspita, ma qui cambia davvero poco. Perché, in base alla legge varata ieri in via definitiva dalla Camera, da oggi in poi dovrebbe venire punito il magistrato che si macchia di una "violazione manifesta della legge", oppure di un "travisamento del fatto o delle prove". Ma questo cambia obiettivamente molto poco rispetto alla Legge Vassalli dell'aprile 1988. Questa, fino a ieri, prevedeva che ogni cittadino potesse chiedere i danni allo Stato se un magistrato adottava un atto o un provvedimento giudiziario "con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia"; e dava facoltà al cittadino "di agire contro lo Stato" anche "per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale". Differenze? Mah... Ecco, sì, la nuova legge specifica meglio che da oggi il cittadino può chiedere anche la punizione del magistrato che ha sbagliato nell'emissione di "un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge, oppure senza motivazione". Quanto al resto, poco cambia. Sì, è vero, si allungano di un anno (da due a tre) i termini per avviare l'azione legale. E oggi il governo è obbligato a esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato ritenuto colpevole. Aumenta anche la quota di stipendio che il magistrato stesso dovrà restituire allo Stato: al massimo metà del suo stipendio di un anno (prima era un terzo), senza però che si possa superare un terzo del suo stipendio mensile nel caso di pagamenti mediante trattenuta. Ma queste non sono certo modifiche sostanziali. E allora? Non cambia davvero nulla? No: una modifica sostanziale riguarda il cosiddetto "filtro". La Legge Vassalli all'art. 5 prevedeva infatti che la domanda di risarcimento presentata dal cittadino dovesse ricevere una valutazione preventiva di ammissibilità: in tre gradi di giudizio (fra tribunale, corte d'appello e Cassazione) i giudici dovevano stabilire se la domanda fosse o no "manifestamente infondata". Così, per stabilire se un magistrato dovesse effettivamente pagare per un suo errore, servivano così nove gradi di giudizio: tre per stabilire l'ammissibilità del giudizio, tre per stabilire il fatto in sé, e altri tre per la rivalsa da parte dello Stato nei confronti del magistrato che aveva agito con dolo o colpa grave. È per questo che pochissimi finora hanno pagato. Per darvi un'idea: tra 1988 e 2014 tale è stata la fiducia degli italiani nella Legge Vassalli che sono state presentate in tutto 410 domande, davvero poche. Quelle ritenute "ammissibili" sono state appena 35, nemmeno una su dieci, e di queste soltanto sette alla fine sono state accolte (per l'esattezza 2 a Perugia e una a testa a Brescia, Caltanissetta, Messina, Roma, Trento). La riforma, però, abolisce il giudizio di ammissibilità e l'art. 5. Questo riduce a sei i gradi di giudizio. Secondo alcuni c'è il rischio che questo possa esporre i tribunali italiani a una valanga di ricorsi. Tant'è vero che i magistrati sono riusciti a strappare al governo l'impegno a fare un "tagliando" della riforma tra sei mesi. Sul punto è abbastanza scettico invece Giuseppe Di Federico, uno dei primi giuristi italiani (è docente emerito di diritto penale a Bologna ed ex membro del Csm), che nel 1987 fu tra i promotori del vittorioso referendum radicale sulla responsabilità civile, poi rintuzzato dalla Legge Vassalli. "Non mi attendo uno tsunami di ricorsi" dice a Panorama.it "perché mi domando quanti avvocati saranno disposti a esporsi in casi di questo genere. E comunque prevedo un estremo rigore da parte dei tribunali".
Berlusconi, vent’anni di rapporti con la magistratura. Dalle «toghe rosse» ai ringraziamenti per i giudici della Cassazione che hanno confermato l’assoluzione nel processo Ruby. Dal 22 novembre 1994 - data in cui Berlusconi, capo del governo, riceve un invito a comparire dalla Procura di Milano che sta indagando sulle tangenti alla Guardia di finanza - fino a oggi, sono stati altalenanti e spesso conflittuali i rapporti del leader di Forza Italia con la magistratura, scrive “Il Corriere della Sera”.
1. Il pool «Mani Pulite» e l’avviso di garanzia del 1994. Il primo interessamento della giustizia nei confronti di Berlusconi risale al 1983 quando la Guardia di finanza segnalò un suo presunto coinvolgimento in un traffico di droga con la Sicilia. L’inchiesta venne archiviata. La prima condanna, invece, è del 1990: la Corte d’appello di Venezia, dichiara Berlusconi colpevole di aver giurato il falso davanti ai giudici, a proposito della sua iscrizione alla lista P2. Nel settembre 1988, infatti, in un processo per diffamazione da lui intentato contro alcuni giornalisti, Berlusconi aveva dichiarato al giudice: «Non ricordo la data esatta della mia iscrizione alla P2, ricordo che è di poco anteriore allo scandalo». Nonostante la Corte d’appello di Venezia dichiari Berlusconi colpevole (il giudice era Luigi Lanza), il reato è considerato estinto per l’amnistia del 1989. Il 22 novembre del 1994 Berlusconi, capo del governo, mentre presiede la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale, riceve un invito a comparire dalla Procura di Milano che stava indagando sulle tangenti alla Guardia di finanza. Le tangenti servivano per alleggerire le verifiche alle società Mondadori, Mediolanum, Videotime, Telepiù: in primo grado Berlusconi è stato condannato a 2 anni e 9 mesi; in appello, grazie alle attenuanti generiche, è scattata la prescrizione.
2. All Iberian, dalle accuse alla prescrizione. Il 12 luglio 1996 Silvio Berlusconi, l’ex segretario del Psi Bettino Craxi, l’amministratore delegato di Mediaset Ubaldo Livolsi vengono rinviati a giudizio con altre nove persone per l’ inchiesta sul presunto finanziamento illecito della Fininvest, attraverso la società All Iberian, al Psi nel 1991. Il processo inizia il 21 novembre 1996 davanti ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano. Il pm Francesco Greco chiede per Berlusconi 5 anni e 6 mesi di reclusione e 12 miliardi di multa poi, dopo lo stralcio del reato di falso in bilancio, riformula la richiesta in due anni e mezzo di reclusione e 12 miliardi di multa. Nel 1998 Berlusconi viene condannato in primo grado (2 anni e 4 mesi). «I giudici hanno riscritto il codice penale per allineare le norme alle esigenze repressive della procura» dichiara Berlusconi. In appello però, nel 2000, sempre per le attenuanti generiche scatta la prescrizione.
3. Colombo, il caso Lentini e la prescrizione. C’e’ anche un capitolo «sportivo»: versamento in nero di una decina di miliardi dalle casse del Milan a quelle del Torino, per l’acquisto di Gianluigi Lentini. Il dibattimento si conclude con la dichiarazione che il reato è prescritto, grazie alla legge che abolisce il falso in bilancio. È lo stesso pubblico ministero Gherardo Colombo a chiedere l’applicazione della prescrizione, dopo che il tribunale respinge la sua eccezione di incostituzionalità della normativa varata nel marzo 2002 in materia di falso in bilancio.
4. Il tribunale civile e il risarcimento a De Benedetti. Berlusconi è poi coinvolto in una lunga serie di processi per la corruzione dei giudici romani in relazione al Lodo Mondadori e al caso Sme. Sono i processi che hanno protagonista Stefania Ariosto, il teste «Omega» e Cesare Previti. Condanne per Cesare Previti e il giudice Metta. Per quanto riguarda il Lodo Mondadori, dopo una guerra durata vent’anni, si stabilisce che Berlusconi deve risarcire De Benedetti. Luigi de Ruggiero, Walter Saresella e Giovan Battista Rollero sono i tre giudici della seconda sezione civile della Corte d’Appello di Milano che emettono la sentenza nell’ambito della vicenda del Lodo Mondadori che condanna Fininvest al pagamento di circa 560 milioni di euro. La cifra diventa 494 milioni dopo la Cassazione.
5. De Pasquale e l’accusa nel caso Mills, ma è prescrizione. Le procure di Caltanissetta e Firenze che hanno indagato sui mandanti a volto coperto delle stragi del 1992 e del 1993 hanno svolto indagini sull’eventuale ruolo che Berlusconi e Dell’Utri possono avere avuto in quelle vicende. L’inchiesta è stata chiusa con l’archiviazioni nel 1998 (Firenze) e nel 2002 (Caltanissetta). La procura di Palermo, inoltre, ha indagato su Berlusconi per mafia: concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio di denaro sporco. Nel 1998 l’indagine e’ stata archiviata per scadenza dei termini massimi concessi per indagare. Definitiva la prescrizione per il caso Mills, l’avvocato inglese che avrebbe ricevuto 600 mila euro da Berlusconi per testimonianze reticenti ai processi per All Iberian e tangenti alla Gdf. A sostenere l’accusa contro Berlusconi il pm Fabio De Pasquale.
6. Caso Ruby, Boccassini è pubblica accusa. Il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini, insieme al pm Antonio Sangermano, rappresenta la pubblica accusa nel processo di primo grado sul caso Ruby. I rapporti di Berlusconi con Boccassini sono conflittuali. L’ex premier respinge le accuse e condanna l’operato dei pm di Milano.
7. Tre donne per la condanna in primo grado. Il 24 giugno 2013, nel processo Ruby, Silvio Berlusconi viene condannato in primo grado a 7 anni per entrambi i reati contestati: concussione per costrizione e prostituzione minorile. Il collegio della quarta sezione penale del Tribunale di Milano che giudica Berlusconi è composto da donne: la presidente Giulia Turri, che nel marzo del 2007 firmò l’ordinanza di arresto per il “fotografo dei vip” Fabrizio Corona; Carmen D’Elia, che già nel 2002 aveva fatto parte del collegio di giudici del processo Sme che vedeva come imputato, tra gli altri, proprio Silvio Berlusconi; Orsola De Cristofaro, la terza componente del collegio, con un passato da pm e gip, già giudice a latere nel processo che ha portato alla condanna a quindici anni e mezzo di carcere per Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario di chirurgia toracica, imputato con altri medici per il caso della clinica Santa Rita.
8. L’assoluzione in appello. Il presidente si dimette. Il processo d’appello per il caso Ruby si tiene davanti alla seconda Corte d’Appello: Enrico Tranfa è il presidente, Concetta Lo Curto e Alberto Puccinelli i giudici a latere. Berlusconi viene assolto dal reato di concussione «perché il fatto non sussiste» e dal reato di prostituzione minorile «perché il fatto non costituisce reato». L’ex Cavaliere commenta che «la maggioranza magistrati è ammirevole». Enrico Tranfa, il presidente, si dimette subito dopo aver firmato le motivazioni della sentenza, in dissenso con la sentenza presa a maggioranza con il sì degli altri due giudici. E così, dopo 39 anni di servizio, a 15 mesi dalla pensione, il magistrato lascia anzitempo la toga. Tranfa ha esercitato la professione in gran parte a Milano. Negli anni 90 è stato all’ufficio Gip. Come giudice delle indagini preliminari, nel periodo di Mani Pulite, si era occupato di uno dei filoni dell’inchiesta sugli appalti Anas e di quella sulla centrale dell’Enel a Turbigo per cui dispose l’arresto, tra gli altri, dell’ex assessore lombardo in quota alla Dc Serafino Generoso. Nel 2002 è stato nominato presidente del Tribunale del Riesame sempre di Milano. Come giudice d’appello ha confermato, tra l’altro, la condanna a tre anni di carcere per Ubaldo Livolsi per la bancarotta di Finpart. Concetta Lo Curto, entrata in magistratura nel 1990, è stata giudice al Tribunale di Milano, prima all’ottava sezione penale e poi alla terza dal 1995 al 2013 quando poi è passata in Corte d’Appello. Nel 2010 assolse l’allora deputato del Pdl Massimo Maria Berruti, imputato per la vicenda Mediaset (la sua posizione era stata stralciata da quella di Berlusconi e degli altri). Puccinelli, entrato in magistratura nell’89, è stato il giudice relatore al processo di appello che si è concluso con la prescrizione per Berlusconi, imputato per la vicenda del «nastro Unipol».
9. Processo Ruby, il pg De Petris contro l’assoluzione. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione confermato l’assoluzione, che diventa definitiva, di Silvio Berlusconi nel processo Ruby. Il sostituto procuratore della Corte d’Appello Pietro De Petris aveva fatto ricorso in Cassazione contro l’assoluzione.
10. Processo Mediaset, l’accusa di De Pasquale e Spadaro. Il 18 giugno 2012 i pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro chiedono una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione per Silvio Berlusconi, imputato di frode fiscale nel processo sulle presunte irregolarità nella compravendita dei diritti tv da parte di Mediaset. Il 26 ottobre 2012 l’ex premier viene condannato a 4 anni di reclusione, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e tre anni di interdizione dagli uffici direttivi delle imprese.
11. Pena più severa di quanto richiesto. Il presidente del collegio che condanna Berlusconi in primo grado è Edoardo D’Avossa con i giudici a latere Teresa Guadagnino e Irene Lupo). La pena è maggiore di quanto chiesto dai pm. Berlusconi commenta: «È una condanna politica, incredibile e intollerabile. È senza dubbio una sentenza politica come sono politici i tanti processi inventati a mio riguardo».
12. Il giudice Galli conferma in appello. L’8 maggio 2013, dopo quasi sei ore di camera di consiglio, i giudici della seconda Corte d’Appello di Milano, presieduti da Alessandra Galli (nella foto Brandi/Fotogramma), confermano la condanna a 4 anni di reclusione, di cui tre coperti da indulto, per Silvio Berlusconi, accusato di frode fiscale nell’ambito del processo sulla compravendita dei diritti tv Mediaset. Berlusconi parla di «persecuzione» da parte della magistratura che vuole eliminarlo dalla scena politica.
13. Esposito, la Cassazione e l’intervista contestata. Il primo agosto 2013 la Cassazione conferma la condanna a quattro anni di carcere. A leggere la sentenza sul processo Mediaset è il presidente della sezione feriale della corte di cassazione Antonio Esposito. Nei giorni successivi, il giudice Esposito finisce nella bufera per un’intervista a «Il Mattino» in cui parla della sentenza sul processo Mediaset-Berlusconi. Lo stesso magistrato farà seguire una smentita riguardo ad alcuni passaggi. In particolare, Esposito smentisce anche «di aver pronunziato, nel colloquio avuto con il cronista - rigorosamente circoscritto a temi generali e mai attinenti alla sentenza, debitamente documentato e trascritto dallo stesso cronista e da me approvato - le espressioni riportate virgolettate: “Berlusconi condannato perché sapeva non perché non poteva non sapere».
10 marzo 2015. La Corte di Cassazione assolve. Questa donna (la Boccassini) ha distrutto il Paese Ma resterà impunita. Anche un magistrato come Emiliano si indigna: "Chieda scusa". E nonostante tutto Ilda Boccassini rimarrà al suo posto come sempre, scrive Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. Per La Repubblica, Berlusconi non è un innocente perseguitato ma un «colpevole salvato», come si evince dal titolo che racconta con stizza dell'assoluzione definitiva in cassazione sul caso Ruby. Il Corriere della Sera affida invece al suo segugio Luigi Ferrarella la difesa senza se e senza ma dell'operato dei pm milanesi. Un ufficio stampa della procura non avrebbe saputo fare di meglio e, ovviamente, Ferrarella tace sul fatto che lui stesso e autorevoli colleghi del suo giornale nel corso di questi anni avevano già emesso la sentenza di colpevolezza in centinaia di articoli nei quali si spacciavano per prove certe i farneticanti teoremi dell'accusa. Non sappiamo invece il commento di Ilda Boccassini, la pm che ha fatto da redattore capo di quella grande messa in scena truffaldina ed esclusivamente mediatica che è stata l'inchiesta Ruby. Una cosa però conosciamo. E cioè che la Boccassini, grazie a questa inchiesta, è stata inclusa dalla rivista statunitense Foreign Policy al 57esimo posto nella lista delle personalità che nel corso del 2011 hanno influenzato l'andamento del mondo nella politica, nell'economia, negli esteri.Non stiamo parlando di un dettaglio. Anche dall'altra parte dell'Oceano erano giunti alla conclusione che le notizie costruite dalla procura di Milano e spacciate da Corriere e Repubblica non costituivano un mero fatto giudiziario ma avevano contribuito in modo determinante a modificare giudizi sull'Italia con ricadute decisive financo sul piano internazionale. Oggi, grazie alla sentenza di Cassazione, sappiamo che si trattò di una iniziativa scellerata, completamente falsa, paragonabile a un complotto per destabilizzare un Paese sovrano. Complotto ordito da magistrati e sostenuto da complici, o almeno utili idioti, nelle redazioni dei giornali nazionali ed esteri, nelle stanze di governi stranieri e in quelle della politica di casa. A partire da quella più prestigiosa del Quirinale, allora abitata da Giorgio Napolitano. Il quale non solo non mosse un dito per fermare il linciaggio del suo primo ministro, ma, proprio sull'onda di quella destabilizzazione, ricevette in segreto banchieri, editori e imprenditori di sinistra per organizzare un controgoverno (Monti, per intenderci) nonostante quello in carica godesse ancora della piena fiducia del Parlamento. Alla luce di tutto questo, e in attesa che la Corte europea faccia giustizia di un'altra bufala giudiziaria (la condanna di Berlusconi per evasione fiscale, avvenuta grazie al trucco di assegnare la sentenza non al giudice naturale, ma a un collegio costruito ad hoc, guarda caso su sollecitazione del Corriere della Sera ), ora si pongono problemi seri che meritano risposte veloci e all'altezza di un Paese libero e democratico. Riguardano la permanenza nelle loro delicate funzioni dei responsabili e la riabilitazione politica della vittima Berlusconi. Nessuno, su questo, può permettersi di fare il pesce in barile.
Il giallo Tranfa e quei Servizi rimasti muti, scrive Giovanni Maria Jacobazzi su “Il Garantista”. Il processo Ruby non è stato un processo come tanti. Molti aspetti, oscuri, hanno connotato questa vicenda penale che ha portato alla caduta di un governo e allo sfascio di un partito. Tralasciando lo sputtanamento internazionale e il ludibrio planetario che hanno investito Silvio Berlusconi e, di riflesso, il Paese. Due, principalmente, sono gli episodi che fanno riflettere e che ad oggi non hanno avuto risposta. Episodi che riguardano proprio l’inizio e la fine dell’inchiesta. Il primo riguarda le modalità con cui sono state condotte le indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Milano. Il secondo le dimissioni del giudice Enrico Tranfa, il presidente del collegio che in appello ha assolto Silvio Berlusconi dopo la condanna in primo grado a sette anni. Per scoprire cosa accadesse la sera nella residenza di Arcore, la Procura di Milano non ha lesinato energie. Con un dispiegamento di forze senza pari in relazione ai tipo di reato perseguito, una ipotesi di prostituzione minorile e di concussione, i pubblici ministeri milanesi hanno posto in essere un numero elevatissimo di intercettazioni telefoniche. Tranne Silvio Berlusconi che, essendo parlamentare, non poteva essere intercettato, chiunque entrasse in contatto con Villa San Martino si ritrovava il telefono sotto controllo. Decine di ragazze, ma non solo, furono intercettate per mesi. Ogni loro spostamento accuratamente monitorato. Centinaia i servizi di osservazione, controllo e pedinamento come si usa dire in gergo questurile. All’epoca dei fatti, il 2009, Silvio Berlusconi era il presidente del Consiglio. Il suo uomo più fidato, Gianni Letta, sottosegretario di Stato con delega ai Servizi. Come è stato possibile effettuare una attività investigata di queste proporzioni, migliaia le intercettazioni effettuate, senza che nessuno, in maniera ovviamente riservata, facesse arrivare il “messaggio” all’indagato eccellente di prestare attenzione alle persone frequentate ed ai comportamenti da tenere? Nessuna indicazione dai gestori telefonici? Nessun dubbio circa questa anomala concentrazione di utenze sotto controllo proprio nella residenza privata del presidente del Consiglio, sottoposta a misure di massima sicurezza secondo la legge 801 che disciplina il segreto di Stato? Ma il rapporto anomalo con gli apparati di sicurezza è anche alla base dell’accusa più grave caduta sulla testa di Berlusconi. Quella di concussione nei confronti del capo di gabinetto della Questura di Milano. Come mai il presidente del Consiglio, residente a Milano, città dove ha il centro dei suoi interessi e dove vive la sua famiglia, non si rivolge, per motivi di opportunità e riservatezza, direttamente al Questore ma passa attraverso il suo capo di gabinetto, peraltro chiamatogli al telefono dal suo capo scorta? Essendo il Consiglio dei ministri preposto alla nomina dei questori delle città, non si può proprio dire che l’allora premier non conoscesse chi fosse al vertice della pubblica sicurezza del capoluogo lombardo. E infine le dimissioni improvvise e inaspettate del giudice Enrico Tranfa, il presidente del collegio di Appello che ha assolto Silvio Berlusconi, subito dopo il deposito delle 330 pagine delle motivazioni della sentenza. Come si ricorderà, dopo aver depositato la sentenza di assoluzione, Enrico Tranfa fece domanda per essere collocato in pensione. Poteva restare in servizio altri quindici mesi. Decise di anticipare l’uscita dalla magistratura. Campano di Ceppaloni, il paese che ha dato i natali anche a Clemente Mastella, collocabile nella corrente di Unicost, Tranfa era dal 2012 a Milano in Corte d’Appello come presidente della seconda sezione penale. Equilibrato, molto preparato, mai una parola fuori posto. Un persona mite. Nulla che potesse far prevedere una reazione del genere. Le sue dichiarazioni, a chi gli chiedeva il perché di una simile decisione, furono soltanto “è una decisione molto meditata, perché in vita mia non ho fatto niente di impulso. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile”. Per poi aggiungere: “Il compito di un giudice non è quello di cavillare con i tecnicismi, ma prendere un fatto, valutarlo alla luce delle norme, e poi fare un atto di volontà, decidendo. Altrimenti è la giustizia di Ponzio Pilato”. Sul caso montò la contrapposta lettura politica: “Solidarietà” dal Pd e dure critiche da Forza Italia. Le dimissioni in polemica con l’assoluzione scatenarono anche le ire del presidente della Corte d’Appello Giovanni Canzio. “Se dettate da un personale dissenso per l’assoluzione di Silvio Berlusconi non appaiono coerenti con le regole ordinamentali e deontologiche che impongono l’assoluto riserbo sulle dinamiche della Camera di consiglio”, disse Canzio, “trattasi di un gesto clamoroso e inedito”. Se per ogni disaccordo in un collegio il magistrato dovesse dimettersi, in magistratura rimarrebbero in pochi. Ma quell’anomalia, come la prima, con ogni probabilità rimarrà senza risposta.
Processo Ruby, pool di Milano: le lettere segrete delle toghe rosse alla giudice che assolse Silvio Berlusconi, scrive “Libero Quotidiano”. Le toghe rosse di Milano si attendevano l'annullamento dell'assoluzione in secondo grado. Volevano Silvio Berlusconi di nuovo alla sbarra nel processo Ruby. Ma così non è andata. Confermata l'assoluzione. E dopo la conferma, oltre al Cav, ci sono state diverse persone che si sono levate dei sassolini dalle scarpe. Una di queste era la giudice Concetta Locurto, toga stimata e progressista, già coordinatrice milanese di Area, il cartello tra le correnti di sinistra di Magistratura Democratica. Una, insomma, che aveva il "pedegree" giusto per condannare Berlusconi in secondo grado. Già, perché la Locurto la scorsa estate era la relatrice della sentenza di assoluzione del Cav nel processo Ruby. L'assoluzione scatenò un vespaio di polemiche in magistratura, culminate con le dimissioni del suo collega e presidente del collegio, Enrico Tranfa, che con il passo indietro volle dissociarsi da un verdetto che non condivideva. La Locurto, al tempo, non volle commentare. E non ha voluto commentare neppure dopo la conferma dell'assoluzione che, nei fatti, ha confermato la bontà del suo operato. E il silenzio le deve essere costato, perché come spiega il Corriere della Sera la toga che ha assolto Berlusconi ha vissuto mesi da incubo, tra "attacchi e implicite insinuazioni di cosa di oscuro potesse essere accaduto attorno al processo" per spingere Tranfa alle dimissioni. Ha taciuto, la Tranfa. Almeno in pubblico. Già, perché secondo quanto scrive sempre il Corsera, la toga avrebbe scritto una piccola lettera ai colleghi (agli stessi colleghi che nei mesi precedenti tempestavano la sua email parlando di "torsione del diritto"). Il Corsera ha provato a chiederle del contenuto della lettera, ma la Tranfa, fedele alla sua riservatezza, ha scelto di non parlare. Eppure qualcosa è emerso. Nonostante il rifiuto della giudice, è stato ricostruito quanto abbia detto interpellando i destinatari della missiva. La Tranfa non giudicava la bontà della sentenza, ma metteva in guardia dai rischi di "una malevola dietrologia faziosa", del "pregiudizio", dei "pensieri in libertà da chiacchiera da bar" della quale è stata vittima per mesi per aver fatto il suo lavoro, che nella fattispecie prevedeva di assolvere Berlusconi. La Tranfa avrebbe scritto dei "magistrati che giudicano senza conoscere, finendo - proprio loro - per partecipare al tiro al piccione senza alcun rispetto per l'Istituzione e le persone". E il piccione, in quel momento, era proprio lei. E il "piccione", ora, si toglie le sue soddisfazioni. Nella missiva avrebbe aggiunto l'invito ai colleghi ad "andarsi a rileggere i provvedimenti redatti nel corso dell'intera carriera, piccoli o grandi che fossero, per avere certezza dell'identità di metro di valutazione utilizzato indifferentemente per extracomunitari e potenti". Quel metro di giudizio imparziale che però, i colleghi, le rimproverano: se c'è il Cav alla sbarra deve essere condannato.
Filippo Facci su “Libero Quotidiano”: logica da pm. Se Silvio Berlusconi conosce Noemi Letizia, è colpevole. La Cassazione doveva confermare o non confermare l’assoluzione di Silvio Berlusconi (caso Ruby) per concussione e prostituzione: dopodiché, lo schema era il solito. La Corte che si riunisce nel primo pomeriggio, i giornalisti italiani e stranieri che ciacolano, la consueta assicurazione che la sentenza arriverà «in serata» e che perciò potranno scriverne, hurrà. Ma forse i giudici non erano aggiornati: non sapevano che i quotidiani hanno le chiusure sempre più anticipate, mannaggia: come possono non tener conto delle sacre esigenze mediatiche? Come possono aver saltato i telegiornali della sera? I giudici (presidente Nicola Milo, consiglieri Giorgio Fidelbo, Stefano Mogini e Gaetano De Amicis) dovevano prendere esempio dal procuratore generale Eduardo Scardaccione, che nel pomeriggio aveva esposto una requisitoria mediaticamente perfetta. Niente di strano che abbia chiesto di annullare - con rinvio in Appello - l’assoluzione di Berlusconi per entrambi i reati: è ciò che ci si attendeva da lui, un’apologia di quel processo che in primo grado aveva condannato il Cav a sette anni. Mentre invece le assoluzioni di luglio scorso - pochi mesi fa: la giustizia italiana sa essere velocissima - secondo Scardaccione andavano polverizzate: altro che «il fatto non sussiste» (concussione) e «il fatto non costituisce reato» (prostituzione minorile). Sin qui tutto normale. Ma sono altri argomenti che ha adottato - poi - a farci pensare ancora una volta che taccuini e telecamere andrebbero tenuti lontani dai palazzi di giustizia. Scardaccione ha detto che le accuse sono «pienamente provate» (vabbeh) e che la Corte d’appello non doveva riaprire il processo bensì rideterminare la pena di primo grado: e ci sta anche questo. Poi lo show: «L’episodio nel quale Berlusconi racconta che Ruby è la nipote di Mubarak è degno di un film di Mel Brooks e tutto il mondo ci ha riso dietro». Uhm. Purtroppo «il mondo» non ha testimoniato a processo. E neppure Mel Brooks. A ogni modo il procuratore Scardaccione ha proseguito spiegando che la concussione c’è stata, anzi «c’è stata una violenza irresistibile» per ottenerla. Lo proverebbe il fatto che dal momento in cui ha ricevuto la telefonata di intervento da Berlusconi il capo di gabinetto della Questura di Milano «non capisce più nulla e fa ben 14 telefonate: c’è spazio per ritenere che la pressione fosse resistibile?... No... L’intervento ha avuto una potenza di fuoco tale da annullare le scelte autonome del funzionario». Par di capire che qualsiasi telefonata di Berlusconi in quel periodo - essendo lui premier ed essendo Berlusconi - avesse una potenziale valenza concussoria: chiunque ne riceveva una andava praticamente in palla e veniva annullato nella volontà, una forma di ipnosi. Il procuratore generale non ha contemplato che i dirigenti della Questura fossero banalmente eccitati all’idea di poter fare un favore al presidente del Consiglio: cosa che avrebbe avuto una valenza più che ambigua se solo avessero fatto qualcosa che non dovevano fare. Ma ciò che fecero (identificazione di Ruby, foto segnalazione e ricerca di una comunità per l’affido) corrispondeva alla prassi in vigore. Ma secondo Scardaccione no, c’è stata «una violenza grave, perdurante e irresistibile anche a margine della consegna di Ruby a Nicole Minetti». Il dettaglio è che l’idea di consegnare Ruby alla Minetti non fu un’idea di Berlusconi bensì una soluzione escogitata in questura. Ma - possiamo dirlo? - ci sta anche questo. È passando al reato di prostituzione minorile che si giunge all’incredibile: perché Scardaccione ha tirato in ballo Noemi Letizia, una ragazza che non c’entra un accidente - mai tirata in ballo in nessun processo, in nessun modo - perché la circostanza che Noemi e Ruby fossero due minorenni «non è una coincidenza» e rende «non credibile» che Berlusconi non sapesse della minore età di Ruby. Scardaccione ha ricordato quanto aveva detto Ruby in un’intercettazione: «Noemi è la sua pupilla e io il suo culo». Cioè: il fatto che due amici di Berlusconi avessero una figlia minorenne non poteva essere un caso. E chissà - aggiungiamo noi - quanti milioni di elettori di Forza Italia, negli ultimi vent’anni, hanno avuto figlie minori. Insomma: se Berlusconi sapeva che la figlia di due suoi amici era minorenne, beh, doveva sapere anche l’età di tutta la carovana di signorine che la sera gli portavano a casa con la carriola. Pagandole, certo: perché Franco Coppi, l’avvocato di Berlusconi, ieri non l’ha negato: «La sentenza d’appello ammetteva che ad Arcore avvenivano fatti di prostituzione, cosa che non contestiamo nemmeno noi difensori: ma manca, in fatto, la prova che Berlusconi prima del 27 maggio sapesse che Ruby era minorenne». Sempre che i processi si facciano ancora con le prove.
Il caso Ruby c’è costato mezzo milione. Per i pm le spese ammontano a 65mila euro, ma facendo altri calcoli si sfiorano i 600mila, scrive Simone Di Meo su “Il Tempo”. Quanto è costata l'inchiesta Ruby alle casse dello Stato? La classica domanda da un milione di dollari ha una doppia risposta. La versione minimalista, accreditata dai conti della Procura della Repubblica di Milano contenuti nel faldone 33 del procedimento, parla di appena 65mila euro così suddivisi: in sei mesi sono stati pagati 26mila euro per le intercettazioni e 39mila euro per trascrizioni di interrogatori, traduzioni dall’arabo, per il noleggio auto, la più costosa delle quali - una Golf - è stata pagata 4mila euro, e per l’acquisto di registratori digitali. Pochi spiccioli anche per le trasferte dei poliziotti in alcuni hotel di Rimini: poco meno di 200 euro per tre diversi viaggi. Insomma, per questa scuola di pensiero il procedimento penale del pm Ilda Boccassini non ha prosciugato le casse del ministero della Giustizia ma si è mantenuto addirittura al di sotto dello standard della Direzione distrettuale antimafia. Questione risolta, allora? Mica tanto perché a questa immagine light dell'inchiesta se ne contrappone una più approfondita che zavorra con almeno uno zero la cifra iniziale portandola a oltre mezzo milione di euro. Ci sono alcuni costi che, nel computo del pubblico ministero, non vengono infatti elaborati. Sarà sicuramente una distrazione, ma bisogna fare chiarezza. Stiamo parlando dei cosiddetti costi fissi che riguardano l'utilizzo della polizia giudiziaria per condurre un'indagine fatta a pezzi dalla Corte d'appello e dalla Cassazione dopo una prima condanna a sette anni nei confronti di Silvio Berlusconi. Un'indagine fondata su due capi di imputazione che tecnicamente non hanno retto al vaglio delle toghe. Perché è vero che un poliziotto o un carabiniere viene ugualmente stipendiato dallo Stato (e ci mancherebbe) ma c'è un particolare di cui non tutti si ricordano: il poliziotto o il carabiniere in questione avrebbe potuto essere impiegato su un altro versante giudiziario, magari più interessante e utile. E questo - dal punto di vista aziendalistico - è un costo che non può essere omesso se si vuole davvero fare una descrizione esatta del valore contabile del fascicolo Ruby. Dare per scontate queste voci di costo è un errore. Così come è un errore non calcolare il noleggio dell'apparecchiatura utilizzata per geolocalizzare i cellulari che hanno agganciato la cella di Arcore alla ricerca delle utenze delle partecipanti alle "cene eleganti". Un'attrezzatura che, secondo quanto risulta a Il Tempo costa in media 1000 euro al giorno: è probabile che fosse già in dotazione agli uomini del Servizio centrale operativo cui sono state delegate le attività investigative, ma il suo utilizzo, in termini economici, dev'essere adeguatamente riportato nello schema della Procura. I "target" di intercettazioni e acquisizioni di traffico telefonico e di tabulati sono stati circa trenta per oltre 115mila conversazioni monitorate. Nell'intera operazione è presumibile che siano stati impegnati oltre cento poliziotti che, per la durata delle indagini, sono stati distolti da altri fascicoli, ovviamente. Non sbirri qualunque, ma uomini dello Sco, l'organo investigativo di punta del Viminale che solitamente dà la caccia a mafiosi, narcotrafficanti e serial killer. Per dire: i due superlatitanti del clan dei Casalesi, Antonio Iovine e Michele Zagaria, sono stati presi anche con la collaborazione del Servizio centrale. Che, nel caso in esame, è stato invece sguinzagliato sulle tracce delle olgettine e del ragionieri Spinelli, lauto pagatore ufficiale del Cav. Anche i loro stipendi, anche i loro straordinari, anche i loro ticket sono dei costi a carico dello Stato (e quindi dei cittadini) che devono essere inseriti nel bilancio Ruby. Alla fine, calcoli alla mano, l'indagine di "Ilda la rossa" tra costi fissi (quelli appena descritti, che riguardano l'intera struttura) e costi variabili (i famosi 65mila euro, che dipendono appunto dalle necessità investigative del momento) ha gravato sulle casse dello Stato per circa 600mila euro. È una stima prudenziale ma che ha un suo fondamento considerato che un poliziotto viene pagato in media 100 euro lordi al giorno. Qualcuno ci aggiungerebbe anche i costi dei processi (stipendi dei giudici, dei cancellieri, del personale amministrativo, fotocopie) ma entriamo nel fantastico mondo delle ipotesi e allora tutte le ricostruzioni sono possibili.
Signori del Csm, quell’inchiesta è senza ombre? Scrive Tiziana Maiolo su “Il Garantista. Sono politici, non morali, i motivi per cui è andato in onda per cinque anni il Pornofilm del Bungabunga che ha messo nel tritacarne un presidente del Consiglio, preso a picconate il suo partito, distrutto la sua reputazione nel mondo, insieme alla sua immagine personale e i suoi affetti. Tutto nasce non tanto dal fermo, in una serata di maggio del 2010, di una giovane marocchina. Né dalla successiva telefonata di Berlusconi alla questura di Milano. Casomai dall’uso che dell’episodio venne fatto dalla Procura della Repubblica più famosa e discussa d’Italia. E’ negli uffici del quarto piano del palazzo di giustizia di Milano, già allenati dalla caccia al cinghialone ai tempi di Craxi e di Tangentopoli, che parte la crociata di stampo talebano che prende di mira il presidente del Consiglio per i suoi costumi sessuali. Ma il Pornofilm è solo l’involucro, un uovo di pasqua con sorpresa. La sorpresa è tutta politica. Se il Consiglio superiore della magistratura volesse occuparsene, potrebbe rilevare parecchie anomalie, dentro quell’uovo. Prima cosa: Ruby viene fermata e rilasciata in una notte di fine maggio. Che cosa è successo tra quella data e quella in cui Silvio Berlusconi viene iscritto nel registro degli indagati (21 dicembre 2010) e in seguito raggiunto da un invito a comparire (14 gennaio 2011)? Succede che Ruby viene ripetutamente interrogata, una serie di persone che frequentavano la casa di Arcore viene monitorata e intercettata e si tende la tela del ragno che deve catturare la preda. Che la preda sia un Arcinemico di certa magistratura e certi Pubblici ministeri non è un segreto. Che dalle parti di Milano si usino metodi disinvolti sulle competenze territoriali (un presidente del Consiglio non dovrebbe essere giudicato dal Tribunale dei ministri?) è cosa altrettanto nota. Ma quel che succede a Milano è qualcosa di ben più mostruoso: per sette-otto mesi vengono fatte indagini su un contesto che ha al centro una persona che non è indagata, vengono disposte intercettazioni a persone che parlano al telefono con un parlamentare senza che sia chiesta, come prescrive la legge, l’autorizzazione alla Camera di appartenenza. Nei fatti si indaga su una persona in violazione delle normali procedure di legge. A nulla valgono le proteste degli avvocati, le interrogazioni parlamentari del deputato di Forza Italia Giorgio Stracquadanio, la curiosità che comincia a serpeggiare nella stampa italiana e anche straniera. La Procura di Milano tira dritto. Apparentemente arrogandosi il diritto di moralizzare i costumi altrui, in realtà con obiettivi ben più ambiziosi. Ma un’altra anomalia esplode clamorosa a un certo punto, la rissa da cortile tra il procuratore capo Bruti Liberati e il suo aggiunto Robledo sulle competenze tematiche e le assegnazioni delle inchieste. Perché le indagini su Berlusconi e il “caso Ruby” vengono assegnate a Ilda Boccassini, titolare delle inchieste sulla mafia e non a Robledo che si occupa di Pubblica Amministrazione? Berlusconi non è forse accusato di aver abusato del suo potere di presidente del Consiglio, con quella famosa telefonata in questura che gli costerà la condanna in primo grado per concussione? Questo aspetto della vicenda giace nelle scartoffie (nei fatti archiviate) del Csm sulla querelle Bruti-Robledo, che nessuno pare avere la curiosità di esaminare più. Sarebbe bene, invece, che l’organo di autogoverno di Pm e giudici riaprisse gli occhi, su questo punto, e si chiedesse “perché” fosse così importante quella sostituzione di Robledo con Boccassini in un’inchiesta dal sapore squisitamente politico. Questo è il succo della vicenda: forzature e anomalie per il raggiungimento di uno scopo. Addirittura il procuratore generale di Milano, pur di fare il ricorso in Cassazione, si è appellato a questioni di merito, trascurando il fatto che il terzo grado di giudizio può riguardare solo questioni di legittimità. Un’altra delle anomalie “lombarde”, che la Cassazione avrebbe dovuto rilevare subito, rigettando il ricorso in dieci minuti. Nove ore di discussione sono un bel tributo alle tricoteuses di tutta Italia. In ogni caso,tutto il resto è contorno, il Pornofilm, il Bungabunga, sparsi a piene pani tramite un ventilatore in funzione permanente con lo scopo dello Sputtanamento. Oggi, con Berlusconi che porta a casa con una certa velocità (quattro anni per tre gradi di giudizio sono un’altra, piacevole, anomalia) l’assoluzione piena da due reati infamanti, resta il reato di Sputtanamento ancora vivo e vegeto nelle immagini del Pornofilm, tanto che gli avvocati sono stati costretti a dire (un po’ andando di fantasia) che, in fondo si, forse un po’ di prostituzione ad Arcore c’è stata, per rafforzare la realtà dei fatti sulla non conoscenza dell’età di una quasi-diciottenne che dimostrava, a detta di tutti, almeno venticinque anni. E che probabilmente era più una mantenuta che una prostituta. Anche in questo il processo Ruby è stato speciale. Ma non può finire qui. Il Csm ci deve spiegare se tutte queste violazioni sono consentite, se anche il nuovo corso “renziano” ha intenzione di chiudere gli occhi, come già si fece 20 anni fa con Tangentopoli, su questi metodi machiavellici, per cui la finalità politica può fare a pezzi le regole dello Stato di diritto e prevale sempre la filosofia del “tipo d’autore” (individuo la tipologia del colpevole, poi colpisco la persona), per cui la responsabilità penale non è più personale ma esplicitamente politica. Alla faccia dell’obbligatorietà dell’azione penale.
«Cittadini impotenti davanti ai magistrati», scrive Daniel Rustici su “Il Garantista”. «Il Csm cominci a fare sul serio il suo lavoro che fino ad oggi ha svolto, per usare un eufemismo, in modo deficitario. Sono stati puniti solo i magistrati fuori dal coro, mai quelli che hanno sbagliato nell’esercizio della professione. Il caso più emblematico è quello del processo Tortora dove i giudici di uno dei più clamorosi casi di malagiustizia hanno fatto carriera. Il Csm dovrebbe essere meno indulgente e ”perdonista” nei confronti dei magistrati che commettono gravi errori». Chi parla è uno dei giudici più intransigenti e celebri per le sue feroci polemiche contro pezzi del mondo politico, e a difesa della magistratura: Antonio Ingroia. In un’intervista al nostro giornale ha detto che bisogna difendere i cittadini che talvolta sono troppo deboli di fronte ai magistrati e ai loro eventuali errori. Ha parlato anche di carcerazione preventiva, e ha detto che «in un Paese in cui i tempi per arrivare a una sentenza definitiva sono così lunghi, è facile che si arrivi ad utilizzare la carcerazione preventiva come una sorta di anticipazione della pena prevista in caso di condanna dopo i tre gradi di giudizio».
Ingroia, stanno facendo molto rumore le sue dichiarazioni sulla responsabilità civile dei giudici. Ha parlato di cittadini «impotenti» davanti al potere della magistratura. Detto da un’ex toga…
«Voglio precisare prima di tutto che sono contrario alla responsabilità civile dei magistrati. Penso invece che per garantire i diritti dei cittadini bisognerebbe che il Csm cominci a fare sul serio il suo lavoro che fino ad oggi ha svolto, per usare un eufemismo, in modo deficitario. Sono stati puniti solo i magistrati fuori dal coro, mai quelli che hanno sbagliato nell’esercizio della professione. Il caso più emblematico è quello del processo Tortora dove i giudici di uno dei più clamorosi casi di malagiustizia hanno fatto carriera. La verità è che all’interno della magistratura troppo spesso si va avanti sulla base dell’appartenenza a questa o a quella corrente piuttosto che grazie al merito».
Cosa non la convince del disegno di legge del governo sulla punibilità dei giudici?
«La responsabilità civile non è uno strumento idoneo per difendere i cittadini. In primo luogo non lo è perché può portare il magistrato ad assumere una posizione di soggezione davanti all’imputato, specie se questo è ricco e potente. E non lo è perché moltiplicherebbe il lavoro nei tribunali e quindi, dilatando ancora di più i mostruosi tempi della nostra giustizia, paradossalmente andrebbe contro gli interessi degli imputati stessi. Lo ripeto, il vero problema è il Csm che dovrebbe essere meno indulgente e ”perdonista” nei confronti di chi commette gravi errori».
Sparare sul Consiglio nazionale della magistratura ora che ha smesso i panni di pm,non è troppo facile?
«Queste cose le ho sempre dette. Qualcuno potrebbe anche dire che parli male del Csm per come sono stato tratto io, per le parole contro le mie partecipazioni a manifestazioni pubbliche. Allora non parliamo di me, ma di un altro magistrato: Di Matteo. Perchè il Csm ostacola la sua nomina alla Procura nazionale antimafia e favorisce invece personaggi obiettivamente con meno competenze in materia?»
Perché?
«La risposta è semplice: ci si muove in base a logiche burocratiche e correntistiche invece che di sostanza».
Faceva prima riferimento alle sue contestate partecipazioni a manifestazioni politiche quando era ancora magistrato. È una scelta che rivendica?
«Sì. Mi è capitato di fare il pm nella stagione sbagliata. Trent’anni fa nessuno si scandalizzava se Terranova partecipava ai convegni del Pci e negli anni 70 nessuno si sognava di mettere in discussione la professionalità di Borsellino perché andava a parlare di giustizia nei consessi del Movimento sociale italiano. Resto convinto che un magistrato vada giudicato per quello che fa nell’orario di lavoro e che abbia tutto il diritto di esprimere le proprie opinioni. Io però sono stato subissato da attacchi, sia da parte del mondo politico sia dalla magistratura stessa…»
Nelle scorse settimane si è molto discusso delle ferie dei giudici. Ha ragione Renzi a volerle tagliare?
«Penso si tratti di un falso problema. Effettivamente 45 giorni sono tanti ma io, ad esempio, non ho mai goduto dell’intero periodo di ferie e come me la maggior parte dei giudici. Sostenere che la lentezza della giustizia italiana dipenda dalle toghe fannullone è solo un modo di trovare un capro espiatorio».
Quali sono invece le ragioni di questa lentezza e come si può intervenire per accelerare i tempi dei processi?
«Credo sia arrivata l’ora di mettere in discussione l’esistenza del processo d’appello. Con un grado secco di giudizio e un unico processo che decreti l’innocenza o la colpevolezza di un imputato si risparmierebbero un sacco di soldi e di energie. Ritengo poi necessario mettere fine alla corsa alla prescrizione, limitando l’abuso di questo strumento».
A proposito di abusi, cosa pensa dell’uso molto disinvolto della carcerazione preventiva che spesso viene fatto dai giudici?
«In un Paese in cui i tempi per arrivare a una sentenza definitiva sono così lunghi, è facile che si arrivi ad utilizzare la carcerazione preventiva come una sorta di anticipazione di quella prevista in caso di condanna dopo i tre gradi di giudizi».
Sì, ma è incostituzionale: esiste la presunzione d’innocenza.
«Certo nessuno vuole mettere in discussione la sacralità della presunzione d’innocenza ma ribadisco, finché i tempi della giustizia saranno questi credo che la carcerazione preventiva verrà ancora usata con questa frequenza».
Ora che esercita la professione di avvocato, come è cambiata la sua prospettiva sul mondo giudiziario?
«Cambiando osservatorio, sono rimasto delle mie opinioni: viviamo in un Paese profondamente ingiusto perché indulgente con i potenti e forte con i deboli».
Cosa significa per lei la parola ” garantismo”?
«Garantismo significa dare la garanzia a tutti i cittadini di un processo giusto e assicurare il diritto di difesa. Chi vede il garantismo come un modo per disarmare i pm però sbaglia. Essere garantisti significa anche fare in modo che la legge sia davvero uguale per tutti e permettere di punire chi ha sbagliato».
Ha dichiarato di essere pronto a tornare in politica e di guardare con attenzione a Landini. Pensa si aprirà davvero un nuovo spazio politico a sinistra del Pd?
«Credo che il nostro Paese abbia bisogno che emerga una nuova soggettività politica progressista, popolare e di sinistra. Mi sento politicamente vicino a Landini e Rodotà, e sono pronto a dare il mio contributo per la costruzione di una coalizione sociale per l’equità, la lotta alla criminalità organizzata e ai reati dei colletti bianchi».
Helg, Montante e gli altri: le carriere antimafia finite tra accuse e sospetti, scrive Giuseppe Pipitone su “Il Fatto Quotidiano”. L'arresto del presidente della Camera di Commercio di Palermo, che denunciava le estorsioni ed è ora accusato di praticarle, riapre in Sicilia la polemica sui "professionisti dell'antimafia". Fava: "Troppe protezioni e impunità". Don Ciotti: "Solo un'etichetta". E l'impegno autentico per la legalità rischia di essere travolto. Da anni predicava la necessità di combattere il “pizzo” imposto da Cosa Nostra agli esercenti palermitani, si faceva promotore di iniziative antimafia e ingaggiava rumorose polemiche per sottolineare il coraggio di chi denunciava le estorsioni dei boss. Attività che avevano consentito a Roberto Helg, da quasi dieci anni presidente della Camera di Commercio di Palermo, di entrare di diritto nei ranghi del movimento antimafia: peccato che nel frattempo sia finito in manette per aver chiesto e intascato una tangente da centomila euro da un commerciante che chiedeva il rinnovo dell’affitto di alcuni locali dell’aeroporto del capoluogo.Scalo intitolato a Falcone e Borsellino, simboli della lotta a Cosa Nostra, citati a più riprese nelle iniziative presenziate da Helg. Abbandonato oggi persino dal suo legale, che giudica “incompatibile” questa difesa. Il motivo? L’avvocato Fabio Lanfranca ha scelto da anni di assistere le vittime di estorsione: lo stesso reato denunciato da Helg, ma di cui ora è accusato. Solo l’ultimo emblema di un pericoloso fenomeno, un cortocircuito paradossale che rischia di polverizzare l’intero fronte della lotta a Cosa Nostra: l’antimafia utilizzata come status, un carrierismo colorato da slogan e iniziative contro la criminalità organizzata che punta solo ad occupare luoghi di potere. “Occorre chiedersi cosa sia diventato oggi il fronte antimafia in Italia e come abbia prodotto e protetto troppe carriere e troppi spazi di impunità” è il commento del vice presidente della Commissione Antimafia Claudio Fava. Gli fa eco il senatore ex M5S Francesco Campanella che sottolinea come oggi “chi gestisce sacche di potere possa farlo ergendosi a paladino e professionista di un’antimafia di facciata”. Un concetto già descritto pochi mesi fa da don Luigi Ciotti: “L’antimafia – diceva il fondatore di Libera – è ormai una carta d’identità, non un fatto di coscienza. Se la eliminassimo, forse sbugiarderemmo quelli che ci hanno costruito sopra una falsa reputazione. L’etichetta di antimafia oggi non aggiunge niente. Anzi”. E quell’ “anzi” lasciato sospeso richiama immediatamente all’allarme lanciato da Leonardo Sciascia dalle pagine del Corriere della Sera il 10 gennaio del 1987: nell’ormai celebre articolo sui professionisti dell’antimafia, lo scrittore di Racalmuto mise nel mirino gli esempi sbagliati (cioè la nomina di Borsellino a procuratore di Marsala) ma intuì prima di tutti, in tempi non ancora maturi, ciò che oggi è diventato un sistema diffuso. Parole profetiche diventate adesso più che mai attuali. Il primo caso della mafia che si fa antimafia va in scena a Villabate, nei primi anni duemila: l’associazione Addiopizzo era appena nata e Francesco Campanella, presidente del consiglio comunale della cittadina palermitana, ebbe l’idea di creare un osservatorio per la legalità, attribuendo persino un premio a Raoul Bova, interprete sul piccolo schermo del capitano Ultimo, alias Sergio De Caprio, il carabiniere che arrestò Totò Riina. Peccato che Campanella fosse un mafioso (oggi è un collaboratore di giustizia), e che l’idea dell’Osservatorio fosse solo uno stratagemma per confondere le acque: la mafia che si fa antimafia, in quel caso con l’autorizzazione diretta di Bernardo Provenzano. E più cresceva la coscienza antimafia, con le associazioni antiracket e le denunce pubbliche che si moltiplicavano, più si diffondevano i casi in cui il paravento della legalità veniva utilizzato per fare affari e carriere. Pochi anni dopo l’escamotage di Campanella, all’imprenditore Pino Migliore era arrivato un consiglio: iscriversi ad un’associazione antiracket. Peccato che quell’indicazione provenisse dagli stessi estortori mafiosi del commerciante palermitano. In questo senso il caso di Helg è solo la sintesi estrema. Prima della mazzetta in tasca, prima dell’assegno ottenuto come garanzia dell’estorsione futura, Helg era rimasto alla guida dei commercianti palermitani, nonostante lui stesso non lo fosse più dal 2012, e cioè da quando la catena di negozi di famiglia aveva dichiarato fallimento. Ciò nonostante, l’etichetta di frontman dell’antimafia gli ha garantito la permanenza al vertice di Confcommercio. È così che il concetto di lotta a Cosa Nostra è diventato passepartout per fare carriera. E poco importa se si tratti di una lotta di plastica, di cartapesta. Appena poche settimane fa era toccato ad un altro leader della lotta al racket messa in campo dagli imprenditori siciliani: Antonello Montante, presidente di Confindustria sull’Isola, delegato per la legalità dell’associazione di viale dell’Astronomia, membro (poi dimessosi) del direttivo dell’Agenzia per i Beni Confiscati. Da volto moderno dell’antimafia rampante Montante è finito trascinato addirittura in un’inchiesta per concorso esterno a Cosa Nostra: ad accusarlo non ci sono prove schiaccianti come per Helg, ma i verbali di ben cinque collaboratori di giustizia. Una storia che rimane ancora oggi a metà tra il sospetto di un complotto politico giudiziario (in Sicilia si chiama “mascariamento”) e uno dei più grandi abbagli della storia antimafia recente. A garantire l’assoluta trasparenza di Montante era stato nel settembre del 2013 il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, intervenendo ad un dibattito a Chianciano Terme, proprio al fianco del presidente degli industriali isolani. “In Sicilia – aveva tuonato il magistrato – è in corso una campagna di delegittimazione della vera antimafia da parte di centri occulti che vogliono screditare chi fa antimafia con i fatti, come Confindustria, Fai e Addiopizzo”. Poi aveva aggiunto: “Questa campagna di delegittimazione, che è anche una strategia della tensione, potrebbe tradursi in attentati e azioni eclatanti”. Oggi Montante è indagato proprio a Caltanissetta, la procura di Lari, che se è rifugiato nel no comment. E se da Castelvetrano Giuseppe Cimarosa, cugino di secondo grado di Matteo Messina Denaro, annuncia la sua battaglia contro Cosa Nostra, ( e suo padre Lorenzo è considerato soltanto al momento un dichiarante), non ha ancora dato segni effettivi la presunta Rivoluzione di Rosario Crocetta, primo presidente di Sicilia dichiaratamente antimafioso, dopo che i suoi predecessori Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo sono finiti entrambi condannati per fatti di mafia. “La storia di Helg non ci riguarda, ma non possiamo tacere di fronte al fatto che in tanti, troppi, pensano che è venuto il momento di chiudere l’impegno antimafia, la denuncia della corruzione e che sia arrivato il tempo di una riappacificazione generale” tuona il governatore, che sembra fare dei precisi riferimenti che vanno oltre all’arresto di Helg. È noto come Crocetta abbia messo la lotta a Cosa Nostra e la battaglia per la legalità tra i primi punti del suo programma di governo: fino ad oggi non è stato sfiorato da nessuna indagine penale, ma dal Tar (sul caso Muos), fino alla Corte dei Conti ha ricevuto pesantissimi richiami a livello amministrativo. Come dire che la legalità non si annida solo nel condannare l’associazione criminale denominata Cosa Nostra. È il caso di Helg, nemico degli estortori mafiosi ed estortore freelance allo stesso tempo, secondo l’accusa. “Se un soggetto del genere parla di contrasto alla corruzione e poi viene arrestato per lo stesso reato il rischio vero è che si mette in discussione anche la battaglia oltre alle sue parole” dice oggi Raffaele Cantone, il magistrato campano che guida l’Anticorruzione. All’orizzonte dunque sembra spuntare il pericolo maggiore, e cioè che l’utilizzo spregiudicato del brand antimafia distrugga alla fine l’unico, vero concetto di opposizione a Cosa Nostra: quello che passa dalle scuole, dalle iniziative culturali, dalle denunce serie, che non fa affari e non fa carriere. Ma la cui credibilità è minata oggi dai professionisti dell’anti-antimafia: ovvero gli utilizzatori di slogan contro Cosa Nostra per fini privati, che alla fine depotenziano la vera lotta contro la piovra e le sue connivenze. Una perversa evoluzione dell’allarme lanciato da Sciascia che solo sull’Isola dei paradossi poteva vedere la luce. E d’altra parte la Sicilia rimane sempre una Regione dove, parafrasando Enrico Deaglio, chi si ferma alla quarta versione dei fatti è un superficiale.
"Stigmatizzo certa antimafia. Crocetta conosce il potere", scrive Roberto Puglisi su “Live Sicilia”. Il Pd, il governo, Cosa nostra, l'Europa. Intervista a Giovanni Fiandaca: "Essere contro la mafia significa fornire un sostegno acritico ai magistrati? L'intellettuale, per dirla con Norberto Bobbio, più che un dispensatore di certezze è un seminatore di dubbi". “Rimane, peraltro, da chiedersi a questo punto quali concessioni lo Stato abbia in concreto finito col fare all'esito del tortuoso percorso trattativista, e quali effettivi vantaggi ne abbia tratto Cosa nostra. Proprio in un'ottica di risultato, è quello che rimane sfumato e che i pubblici ministeri non si sono sforzati di chiarire”. Giovanni Fiandaca, intellettuale, professore di diritto penale e docente a Palermo, candidato alle Europee per il Pd, ha sostanzialmente affermato che certa antimafia è nuda. E lo ha affermato da insospettabile uomo di centrosinistra, scrivendo tra l’altro alcuni densi saggi sulla trattativa Stato-mafia (da cui è tratto l'incipit) e su un processo dalla forte valenza simbolica. Con un tratto di penna ha demolito l'impalcatura dell'accusa, con una critica a tutto campo. Tanto è bastato per inscriverlo nella lista dei reietti. Fiandaca è andato oltre. Ha insistito. Ha tenuto conferenze sul tema. Qui spiega che cosa l'ha spinto ad affrontare anatemi e scongiuri, le usuali maledizioni destinate ai malcapitati che decidono di rompere un tabù. E' una spiegazione ragionata, più da studioso che da politico, che però contiene elementi appetibili per i titolisti di un quotidiano, perché sconfina, dall'accademia, nell'attualità. Il bersaglio è sempre quello: una certa idea dell'antimafia militante.
Professore, lei si mette a scrivere cose che riguardano il suo lavoro e viene attaccato da un settore ben delineato dell'opinione pubblica, diventando oggetto di editoriali ed esecrazioni. Perché?
“Perché taluni forse si sono sentiti traditi. Tuttavia io domando: cosa c'è di sconvolgente nel fatto che un professore di diritto critichi un processo e metta in ordine le sue osservazioni? Lo faccio per mestiere. O forse il mio mestiere dovrebbe essere quello di fornire un avallo fideistico a tutti i processi importanti? Sarebbe questa l'aspettativa?”.
Perché tanto livore contro di lei?
“Ho smontato il giocattolo. Critico il tipo di approccio di una specifica cultura antimafiosa, ne svelo gli impliciti presupposti di ordine culturale ed etico-politico, insomma decostruisco uno stile intellettuale. Essere contro la mafia significa fornire un sostegno acritico ai magistrati? L'intellettuale, per dirla con Norberto Bobbio, più che un dispensatore di certezze è un seminatore di dubbi; ciò ovviamente non gli impedisce di dare contributi costruttivi anche da un punto di vista tecnico”.
Era dai tempi del celebre articolo di Sciascia sui professionisti dell'antimafia che non si assisteva a una tale levata di scudi.
“Quello che scrivo, lo scrivo per contestare una visione dogmatica o bigotta dell’antimafia divenuta purtroppo negli ultimi anni una sorta di senso comune diffuso. C'è un ovvio riferimento a Sciascia, ai suoi avvertimenti. Mi pregio di definirmi sciasciano”.
Qual è la sua colpa massima?
“Io stigmatizzo un'antimafia irriflessiva, retorica, prevalentemente ritualistica e simbolica. Preciso subito, a scanso di equivoci: i simboli e i riti sono importanti. Testimoniano la condivisione di un insieme di valori, sono fattori di identità politica e culturale. Ma perché ciò sia vero è necessario che sussistano conseguenti comportamenti concreti. Quando si diffonde il sospetto – e questo sospetto è diffuso – che l’antimafia venga utilizzata come strumento di lotta politica o di potere, oppure diventi una scorciatoia per fare affari, allora la funzione simbolica viene di fatto contraddetta e si traduce in impostura, un tradimento di quanti hanno sacrificato la vita nella lotta alla mafia”.
Qual è il punto centrale della questione?
“Il vero problema oggi è come fare antimafia in modo intelligente ed efficace, aggiornando la cassetta degli attrezzi, affinando la tecnica di indagine, per mettere allo scoperto la forma più attuale e insidiosa del potere mafioso. Senza cercare di intentare, nello stesso tempo, processi globali alla politica e alla storia”.
Ci sono innumerevoli antimafie a disposizione sul mercato, l'una contro l'altra armata...
“Nessuno ha il diritto di stabilire una volta per tutte quale sia l'antimafia doc. Il pluralismo è una ricchezza. L'antimafia non deve costituire strumento di lotta e quindi di esclusione, perché in essa convergono valori – la liberazione dell'uomo dal potere violento, il rispetto della sua dignità e libertà – che rappresentano i prerequisiti etici dell'impegno politico. La mia concezione insiste sul fatto che tutti i possibili approcci all’antimafia dovrebbero essere non soltanto considerati legittimi in linea di principio, ma costituire la base di strategie, in concorrenza tra loro. In altri termini, i cittadini dovrebbero scegliere tra concrete politiche antimafia poste a confronto, e non in funzione del personale coefficiente di antimafiosità che il politico di turno attribuisce a se stesso più o meno arbitrariamente. Più fatti, meno annunci e meno recite mediatiche di militanza antimafia".
Qualche esempio, professore.
"Si discute molto di beni confiscati, di efficienze nella gestione delle aziende sequestrate e di Agenzia nazionale. Spesso, però, se ne discute male, e cioè a colpi di slogan, con toni scandalistici e non di rado con la coda di paglia, e cioè a difesa di interessi che con la lotta alla mafia hanno poco a che fare".
Entrando nel merito?
"Due questioni dirimenti: chi deve gestire i beni sequestrati fino a quando la confisca non passa in giudicato? Nel 2010 il Parlamento ha ritenuto di istituire l’Agenzia nazionale dei beni confiscati: a quattro anni di distanza nessuno può negare che è stato un fallimento. E io, insieme agli esperti, magistrati, prefetti e professori componenti della commissione ministeriale che ho presieduto, ritengo che bisogna correre ai ripari. L’Agenzia nazionale si occupi soltanto dei beni definitivamente confiscati per puntare a una rapidissima destinazione o vendita, ma lasci a magistrati, amministratori giudiziari e manager la gestione prima dell’acquisizione definitiva. So che il ministero dell’interno di Angelino Alfano è orientato a riaffermare la competenza dell’Agenzia anche nella gestione precedente alla confisca definitiva: significherebbe perpetuare diabolicamente nell’errore. In tali casi ha senso dividersi, discutere razionalmente la bontà delle soluzioni, senza polemiche sterili e velenose?".
La divisione è un vizio irrinunciabile.
"Le racconto un altro episodio che mi ha molto colpito, perché ha registrato un silenzio fragoroso della pur mitica Confindustria siciliana. Molti di noi ritengono, infatti, che oltre a sequestrare e confiscare le aziende irrimediabilmente compromesse da interessi mafiosi, sia necessario sviluppare una strategia nuova per intervenire con strumenti meno invasivi e più flessibili di sequestro e confisca, come il controllo giudiziario, prima che le mafie si impadroniscano delle imprese border line. Ebbene, il ministro Orlando pare che abbia accolto l’idea e stia per tradurlo in proposta di legge, da Confindustria non abbiamo ricevuto nessun segnale, nonostante più volte e pubblicamente interpellata".
Torniamo all'assunto: di concetti antimafiosi è disseminata la politica. L'antimafia, per esempio, è il biglietto da visita del governatore, Rosario Crocetta.
“Ribadisco che non condivido la tendenza perversa che è andata diffondendosi nella politica siciliana ad assumere il presunto tasso di antimafiosità personale come prevalente parametro di valutazione della capacità di governare. Per uscire dal generico, se ad esempio fosse vero che per Crocetta il numero di denunce presentate all'autorità giudiziaria rappresenti una ragione di preferenza per attribuire un incarico o una nomina d'assessore, rispetto al possesso di competenze specifiche, io non mi troverei affatto d'accordo”.
Mi pare che sia accertato. E che le scelte del presidente premino una diffusa capacità denunciante.
“E io non sono d'accordo, lo ripeto. Verosimilmente risponde a questa impostazione la nomina di Valeria Grasso alla guida della Foss. Una scelta criticabile e criticata con motivazioni che condivido pienamente”.
Qui siamo nel cuore del “crocettismo” se il termine le va bene.
“Dalla totalizzante visione antimafiocentrica del crocettismo deriva come conseguenza pressoché automatica che il massimo merito consista nell'assumere il ruolo di denunciante in servizio permanente effettivo e che la lotta alla mafia abbia come presupposto la rinuncia al primato della politica. D'altra parte, credo che, al di là di certe estremizzazioni o pose retoriche, neanche lo stesso Crocetta la pensi davvero così”.
E allora che fa? Simula?
“Crocetta conosce benissimo la logica del potere. Sa come va il mondo e in modo molto maggiore di quanto non voglia fare credere”.
Sta dicendo che l'antimafia del governatore è soltanto funzionale all'acquisizione e al mantenimento del potere?
(la risposta è un leggero sorriso)
Un suo saggio è dedicato a Loris D'Ambrosio, consigliere giuridico del presidente Napolitano, morto d'infarto dopo una martellante campagna giornalistica che lo chiamò in causa a proposito delle famose intercettazioni tra il presidente e Mancino.
“Lo conoscevo. Tra di noi era nato un rapporto di profonda stima. Era uno studioso competente, un grande uomo delle istituzioni”.
Possiamo considerarlo vittima di quella certa antimafia?
“Direi piuttosto così: tra le vittime indirette della mafia, ci sono purtroppo uomini sacrificati sull'altare di una micidiale interazione tra la macchina giudiziaria e il sistema mediatico”.
Dulcis in fundo, la belligerante dialettica tra il Pd siciliano e il presidente della Regione. Come la valuta?
“Mi preoccupa molto lo scenario di forti divisioni e contrapposizioni che si è creato. Ne risente la campagna per le Europee che viene strumentalizzata per le esigenze di due gruppi, tra chi vuole liberarsi a tutti i costi di Crocetta e chi a tutti i costi vuole stabilizzarne il potere”.
Possibile un'Antimafia del diritto? Scrive Fausto Raciti su “Live Sicilia”. L'intervento del segretario del Pd: "Il primo fatto che abbiamo sotto il naso, ma che nessuno vuole ammettere, è il fallimento del primato della società civile". Da quando è iniziato, il dibattito su cosa sia diventata l'antimafia siciliana è stato segnato da parole spesso oblique, allusive, incomprensibili. Non possono essere le indagini su Antonello Montante, né le inchieste della Commissione antimafia sull’antimafia medesima il tema della nostra discussione. I dossier, le insinuazioni, i sospetti rischiano di cancellare ciò che dovrebbe essere ovvio in uno stato di diritto: chi è indagato ha il diritto di difendersi ed essere considerato innocente fino all’ultimo grado di giudizio. Le stesse allusioni di Luigi Ciotti a nuove indagini lasciano sbigottiti. Per fare chiarezza è allora bene ripartire dalle premesse: non è dalle aule di tribunale che arriveranno le risposte su come ripensiamo l’antimafia, sui fallimenti della società civile e i compiti della politica. È molto più onesto porre il problema di cosa sia diventato questo campo di battaglia chiamato antimafia, come ha fatto Giovanni Fiandaca nel corso della difficile campagna elettorale delle elezioni europee, che non affidarsi alle parole di qualche pentito con l'obiettivo di allungare ombre senza affrontare il cuore del problema. Il primo fatto che abbiamo sotto il naso, ma che nessuno vuole ammettere, è il fallimento del primato della società civile e le storture che ci ha lasciato. L’antimafia, per come si è caratterizzata nella storia recente del nostro Paese, è il simbolo di una società civile che si è sostituita alla politica in nome di un marchio, della sua capacità di gestirlo e di una superiorità morale rivendicata nei confronti della rappresentanza democratica e finanche dello Stato. Un esempio -forse il più efficace tra i tanti possibili- è il protocollo aggiuntivo tra Confindustria nazionale e il Ministero dell’Interno di febbraio 2014 finalizzato all'accelerazione delle procedure per il rilascio della certificazione antimafia alle aziende che aderiscono all'associazione degli industriali. L’antimafia degli imprenditori che hanno scosso l’opinione pubblica e il potere siciliano si fa intermediazione, in sostituzione degli organi dello Stato. Come si può capire bene, è un problema di modello culturale, non di amicizie d’infanzia. Altro esempio è la battaglia che si sta consumando sulla gestione dei beni confiscati in cui, a modelli diversi, corrispondono distinti gruppi della grande famiglia -le liti in famiglia sono sempre le più feroci- antimafia. Nel frattempo il 90% delle aziende confiscate ha continuato a fallire regalando alla mafia uno dei migliori spot pubblicitari cui potesse ambire. A questa sostituzione della politica ha fatto sponda una parte della magistratura che ha trasformato l’antimafia in battaglia di parte, in tentativo di affermazione di una verità esclusiva e incontestabile: la candidatura di Antonio Ingroia alle elezioni politiche è stata, in ultima analisi, questo. La politica, per il suo verso, si è fatta volentieri utilizzare da un antimafia percepita come strumento di legittimazione per superare le proprie deficienze e non fare i conti con le proprie contraddizioni. Non ha, in definitiva, combattuto la propria battaglia. Esattamente come nel caso delle imprese nissene che hanno trovato in Confindustria il mediatore per ottenere i certificati antimafia, la politica si è messa in fila per ottenere indiscutibili certificati di moralità, cedendo sovranità. E’ passato il principio che migliore è la classe dirigente quanto più lontana è cresciuta dai meccanismi della rappresentanza democratica, dal consenso e dai partiti. E se fosse, allora, la politica che ha il compito di salvare l’antimafia da se stessa ritornando sulla scena? Tutto sommato, basterebbe ritornare alla finalità semplice, ma dirompente, dell'affermazione dello Stato di diritto e delle normali regole della concorrenza. L'antimafia si salva se è, e viene percepita, come strumento di liberazione, non di intermediazione né di lotta politica. Pena la perdita della propria credibilità. Il compito di chi governa è combattere l'anomalia mafiosa regalando normalità all'economia siciliana, non quello di rispondere attraverso la costruzione di un'altra anomalia. Il caso del presidente della Camera di Commercio di Palermo, colto in flagranza di reato mentre intasca una mazzetta da 100.000 euro, diventa illuminante quando scopriamo che le sue aziende erano fallite da tre anni. L'unico titolo di legittimazione per ricoprire quel ruolo gli veniva da un'esposizione pubblica come uomo dell'antiracket. Quello che in passato abbiamo chiamato "circo barnum dell’antimafia”, strumento possente ed efficace di carriere che non troverebbero altra giustificazione, e a cui non si sottrae la gestione delle camere di commercio in Sicilia, ha bisogno di essere riportato a normalità da una politica più consapevole e sicura di se. Oggi la palla passa alla nostra capacità di mettere in campo strumenti, alleanze sociali, riforme che ci consentano di recuperare l'autorevolezza e la forza necessarie ad affermare lo stato di diritto. Una delle missioni che il Partito democratico non può mancare è costruire una classe dirigente che non abbia bisogno di delegare la certificazione della propria moralità ad alcuno, che abbia la capacità di essere punto di riferimento per le forze sociali, spesso molecolari ma sane, che vogliono affermare il proprio diritto ad operare in Sicilia come farebbero in qualsiasi altra parte d'Europa. Ed è a questo che serve una nuova antimafia che non ambisca a sostituirsi allo Stato e alla politica ma, viceversa, che abbia al centro l'obiettivo dell'affermazione dello stato di diritto del principio di rappresentanza democratica. A ciascuno il proprio mestiere: chi nelle aule di tribunale, chi nelle istituzioni, chi nella società. Solo così di può rinnovare il movimento antimafia e restituirgli quell'unità e quel rispetto per il pluralismo che oggi sembrano persi dopo vent’anni di guerre interne, spesso non dichiarate, ma combattute con inusuale durezza.
Ok, basta coi professionisti dell’Antimafia. Ma adesso chi combatterà le mafie? E’ la domanda che si pone Gaetano Savatteri su “Gli Stati Generali”. L’antimafia è morta. L’antimafia dei movimenti, delle associazioni di categoria, dei bollini e dei certificati, ma anche quella dei magistrati e della politica. L’antimafia, quella che abbiamo visto e conosciuta fino ad oggi, è definitivamente sepolta. Perché le ultime vicende – l’arresto di Roberto Helg per una mazzetta conclamata o l’indagine per mafia sul presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante, per dichiarazioni di pentiti ancora tutte da chiarire e che potrebbero nascondere una manovra di delegittimazione – sanciscono in ogni caso e definitivamente la fine di un modello che per molto tempo, e fino all’altro ieri, è stato visto con favore e incoraggiato perché segno di una “rivoluzione” che metteva in prima linea la cosiddetta società civile. Attilio Bolzoni su Repubblica, lo stesso giornale che ha sparato per primo la notizia dell’indagine su Montante, ha posto un interrogativo: “Forse è arrivato il momento di una riflessione su cos’è l’Antimafia e dove sta andando”. Ma probabilmente la domanda più corretta è un’altra: potrà esserci ancora un’antimafia? Peppino Di Lello, a lungo magistrato del pool antimafia di Palermo, quello di Falcone e Borsellino, scrive sul Manifesto che “i bollini, le autocertificazioni, gli elenchi incontrollati e incontrollabili degli antimafiosi doc sono ormai ciarpame e bisogna voltare pagina riappropriandosi di una qualche serietà nella scelta di esempi di antimafia vera, scelta fondata sulla prassi, sui comportamenti che incidono realmente in questa opera di contrasto”. Di Lello, giustamente, attacca la retorica dell’antimafia, citando non a caso l’ormai storico articolo del 1987 di Leonardo Sciascia sui “professionisti dell’antimafia”. Ma le ultime vicende e un sottile veleno che percorre le vene del mondo delle associazioni e del movimento antimafia (don Luigi Ciotti ha fornito qualche anticipazione: “Mi pare di cogliere, e poi non sono in grado di dire assolutamente altro, che fra pochi giorni avremo altre belle sorprese, che sono in arrivo, che ci fanno soffrire. Perché riguardano personaggi che hanno sempre riempito la bocca di legalità, di antimafia”) percuotono chi, per entusiasmo o per mestiere o, usiamo pure questa parola, per “professionismo”, si è iscritto negli ultimi anni nel fronte antimafia. Serpeggia il disorientamento tra quanti si chiedono: e adesso, infranti alcuni simboli dell’antimafia, non si rischia di veder naufragare il lavoro fatto in tanti anni, compresi i buoni esempi concreti realizzati? L’indagine della Commissione parlamentare antimafia sull’antimafia, per individuare quando questa sia stata reale o di facciata – paradosso segnalato da Giuseppe Sottile sul Foglio – pone una questione centrale. Se molti movimenti, associazioni, progetti nelle scuole, iniziative si sono riempiti, nella migliore delle ipotesi, di un tot di vuota retorica e, nella peggiore, di piccoli o grandi interessi economici sotto forma di finanziamenti, privilegi, guadagni, chi dovrà stabilire da ora in poi la genuinità della natura antimafia? La struttura dello Stato italiano, per oltre centosessant’anni, ha costruito soggetti e ruoli incaricati di definire e individuare le mafie, arrivando a darne nel 1982 perfino una definizione normativa con l’articolo 416bis del codice penale. Ma l’Italia non ha, e forse non poteva avere, strumenti per individuare con esattezza la natura antimafiosa di soggetti, singoli o plurali, se non in termini di opposizione: in parole semplici, era antimafioso chi combatteva la mafia. Con opere o parole. Così, per lungo tempo, l’antimafia sociale – cioè quella non costituita da magistrati e poliziotti incaricati, per ragioni d’ufficio, dell’azione di contrasto e repressione – finiva per autodefinirsi. E’ bastata, per un lunghissimo periodo, la petizione di principio di dichiararsi antimafia per essere considerati tali. In un Paese che fino a una quarantina d’anni fa ancora sosteneva, spesso anche nelle sedi giudiziarie, che la mafia non esisteva, già il fatto stesso di dichiararne l’esistenza e di porsi in posizione alternativa a essa, era sufficiente per attribuirsi o vedersi attribuita la patente antimafia. Se oggi questo non basta più, quale sarà il criterio futuro per definire la nuova antimafia? I fatti, i comportamenti e la prassi, dice Di Lello. Tutto ciò è facilmente verificabile, ad esempio, nell’attività delle associazioni antiracket che convincono i loro associati a testimoniare nei processi, li sorreggono, si costituiscono accanto a loro parte civile. Ma questo principio può valere per associazioni culturali, singoli di buona volontà, gruppi di opinione, insegnanti la cui unica forza risiede solo nella dichiarazione d’intenti? E’ ovvio che laddove le parole non coincidano con i fatti (come nel caso della tangente che ha fatto finire in galera Helg), la contraddizione è talmente stridente che non ci sono dubbi. Ma anche in questo caso, è una dimostrazione al contrario: il fatto (cioè la mazzetta) mostra la non appartenenza di qualcuno al fronte autenticamente antimafioso. Ma quale può essere il fatto che, giorno dopo giorno, possa dimostrarne invece l’appartenenza? Per Confindustria Sicilia, ad esempio, sembrava già rivoluzionario e significativo che un’associazione di categoria che per molto tempo aveva ignorato la mafia o ci aveva convissuto, con molti casi di imprenditori contigui o aderenti a Cosa Nostra, avviasse una inversione di rotta pubblica, con l’annuncio di espulsioni dei propri soci che non avessero denunciato le estorsioni. Era certamente un fatto capace di attribuire identità antimafiosa a quell’associazione. Naturalmente, il movimento antimafia nel suo complesso si è nutrito di errori e di eccessi. E questi nascono probabilmente dall’evidenza che ogni movimento antimafioso, per sua natura, tende ad occupare tutti gli spazi morali a sua disposizione. La discriminante etica, ragione fondante, tende ad allargarsi e spostarsi sempre più avanti in nome della purezza antimafia, escludendo altri soggetti e movimenti. Qualsiasi movimento antimafia, poiché si costituisce e si struttura in alternativa e in opposizione a qualcosa, in primo luogo la mafia e i comportamenti che possono favorirla o sostenerla, non può tentare di includere tutto, ma deve per forza di cose escludere. Ecco perché dentro il mondo dell’antimafia non c’è pace, e ciascun gruppo di riferimento tende a vedere negli altri gruppi degli avversari, se non dei nemici insidiosi o subdoli. L’antimafia spontaneistica e aggregativa dal basso si contrappone a quella ufficiale in giacca e cravatta e viceversa, quella sociale si contrappone a quella di Stato e viceversa. La vocazione alla supremazia della leadership del mondo antimafioso, diventa allarmante quando l’antimafia non è più esclusivo appannaggio di gruppi sociali d’opposizione (i preti di frontiera contro la Chiesa ufficiale timorosa, le minoranze politiche contro le maggioranze o i governi prudenti o contigui, gli studenti contro la burocrazia scolastica troppo paludata, tanto per fare alcuni esempi), ma comincia a diventare bandiera dei gruppi dominanti. Al potere economico o politico, finisce così per sommarsi il potere di esclusione di potenziali concorrenti, che può essere esercitato anche facendo baluginare legami oscuri o poco trasparenti. L’antimafia può servire al politico di governo per demonizzare gli avversari. Siamo di fronte a quel meccanismo che viene indicato come “la mafia dell’antimafia”, definizione che non amo perché rischia di far dimenticare che nel recente passato in Sicilia, e non solo, politici, imprenditori e funzionari contigui o affiliati alla mafia facevano eliminare i loro avversari direttamente a colpi di kalashnikov. In questi giorni, in queste ore, il mondo dell’antimafia, soprattutto quello siciliano, il più antico e radicato, il più organizzato e selezionato negli anni delle stragi e delle mattanze mafiose, si trova davanti a molte domande. Chi dovrà stabilire, nel futuro prossimo, la genuinità dei comportamenti antimafia? I giornali? La tv? Il governo? Il Parlamento? Non esistono organismi o autorità morali in grado di fornire garanzie valide per tutti. La domanda principale finisce per riguardare l’esistenza stessa di un’antimafia diffusa. Se l’antimafia, per come è stata fino ad oggi, è morta, potrà esserci ancora qualcosa o qualcuno in grado di dichiararsi antimafia? Ma, soprattutto, chi potrà crederci ancora?
Imprenditori e giornalisti cantori dell’antimafia, non ci mancherete per niente. Abbiamo letto su queste colonne l’annuncio della morte dell’antimafia. Un annuncio articolato. Esteso, ragionato, scrive Salvatore Falzone su “Gli Stati Generali”. Forse però vale la pena allungare il necrologio, non foss’altro che per rispetto del de cuius e delle sue gesta. Il decesso, diciamocelo, è stato causato da colpi di toga. Ancora una volta, purtroppo. Perché se non spuntano i primi fascicoli con l’intestazione “Procura della Repubblica”, nel Belpaese tutto è lecito e tutto va bene. Prima di leggere paroline come “arresto”, “tangente”, “indagine”, “pentiti”, nessuno s’interroga, nessuno ha dubbi. Succede così che da qualche anno a questa parte un’antimafia che non è antimafia ha messo le mani sulla città, per dirla con Rosi, per fare affari e costruire carriere. Nel nome della legalità, s’intende, e con l’avallo di una torma di pensatori, magistrati, prefetti, questori e alti ufficiali che non hanno fatto altro che alimentare una colossale bugia (Giovanbattista Tona, consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta: “Come il mafioso di paese otteneva rispetto perché passeggiava col sindaco, col parroco, col maresciallo e col barbiere, l’antimafioso 2.0 può esercitare potere su tutto sol perché in confidenza con ministri, magistrati e autorità”. Giuseppe Pignatone, capo della Procura di Roma: “Bisogna fare l’esame di coscienza: non è che tra magistrati e forze dell’ordine ci sono soltanto santi, eroi e martiri. Ci sono, come in tutte le categorie, persone per bene e persone meno perbene”). C’era bisogno di scoprire Helg con la mazzetta in mano? Dovevamo leggere Bolzoni su Repubblica – che ha dato notizia di un’inchiesta per mafia a carico del presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante – per accorgerci che dalle parti di Caltanissetta l’antimafia ha i pennacchi impastati di gel? E’ mai possibile che quel “cretino” del professor Laurana continua a morire in una zolfara abbandonata, “sotto grave mora di rosticci”, senza sapere ciò che tutti sanno? Già, perché tutti sanno, e tutti sapevano. Ecco perché la meraviglia e il disorientamento del giorno dopo sono espressioni vuote, bianche come quelle di certe statue. La Sicilia è un salone da barba. E anche Roma lo è. E pure Milano. Mentre in questi anni si firmavano protocolli ai tavoli delle prefetture, mentre si stilavano codici etici, mentre procuratori generali inauguravano l’anno giudiziario magnificando le imprese dei nuovi paladini dell’antimafia, dal barbiere si sussurrava e si rideva. Si rideva (con gli occhi) e si facevano smorfie (con la bocca). Ora ci si chiede se, dopo le scosse telluriche delle ultime settimane, possa esserci ancora un’antimafia. E perché no? Un’antimafia ci sarà. Ma non questa. Non questa che ha mandato in solluchero, da nord a sud, cronisti e narratori, i “cuntastorie – come ha scritto Sergio Scandura su Gli Stati Generali – dello storytelling epopea che danno voce ai Pupi: ora con la prodezza, la tenacia e l’enfasi di battaglia, ora con l’incanto-disincanto e la passione della bella Angelica di carolingia memoria”. Sì, ci sarà un’altra antimafia. Anzi, c’è già. C’è sempre stata da quando esiste la mafia. Silenziosa, non remunerativa. E’ l’antimafia del proprio dovere quotidiano, che non fa regali, che non compra e che non paga. Un siciliano illuminato, Cataldo Naro, l’arcivescovo di Monreale scomparso nel 2006, parlava di legalità e santità nelle parrocchie tra Partinico e Corleone. A proposito di Chiesa e mafia, diceva che il cristiano non può non vivere secondo il Vangelo, e che il Vangelo è di per sé incompatibile con la mafia: il discorso vale per tutti, spiegava il presule, per il carabiniere, per il politico, per il professore, per il bidello, per il magistrato, per la guardia municipale… Ma lasciamo stare i santi e torniamo ai diavoli. Adesso che succede, adesso che l’antimafia in ghingheri traballa e che non ci sono ammortizzatori che tengono? Il tema non è “il veleno che percorre le vene del mondo delle associazioni e del movimento antimafia”, né l’esistenza o meno di una “manovra di delegittimazione” ai danni del leader degli industriali siciliani. E neppure i progetti delle scuole, le navi della legalità che attraccano a Palermo in un’esplosione di cappellini o altre simpatiche pagliacciate. Il tema è molto più – come dire? – terra terra: ed è quello del proverbio “predicare bene e razzolare male”. Il tema è la trasparenza delle azioni di chi afferma di combattere il malaffare. E’ la concretezza – oltre che la qualità – dell’impegno sul fronte della legalità (parola che Michele Costa, il figlio del procuratore di Palermo ucciso nel 1980, propone giustamente di abolire). Da questo punto di vista non c’è bisogno di attendere misure cautelari o sentenze definitive per mettere in discussione l’operato non dei “professionisti” (lasciamolo in pace il maestro di Racalmuto) ma degli “imprenditori dell’antimafia”: etichetta, quest’ultima, che ben si attacca alle giacchette dei nostri eroi. Perché debbono scriverla i giudici la storia di questa ennesima truffa? La scrivano gli artisti, se ce ne sono ancora. O gli intellettuali, ma non quelli “col senno del poi”. La raccontino le inchieste dei giornalisti e degli scrittori che non prendono soldi, i registi di cinema e di teatro… Materiale ce n’è in abbondanza. Certo per raccoglierlo bisogna superare lo Stretto, penetrare nell’entroterra incontaminato, fra colline che d’inverno sono così verdi che sembra di stare in Irlanda, e fare un salto nella “Piccola Atene”, la Caltanissetta dove la leggenda vuole che a metà degli anni duemila sia nata la rivoluzione degli imprenditori (che qualcuno, con parole misurate, ha definito copernicana). Ma va detto che nella Caltanissetta delle mitologie c’è stato pure chi in questi anni ha lavorato sul serio resistendo alle bordate sia dalla mafia che dall’antimafia. Il pm Stefano Luciani, in una requisitoria a conclusione di un processo in cui la Procura riteneva di avere scoperto estorsioni non denunciate dagli imprenditori e accordi tra imprenditori e mafiosi proprio in terra nissena, aveva evidenziato che ancora si aspettava l’effetto dell’impegno di Confindustria sul comportamento della categoria. Era il 23 gennaio 2012. Bè, dopo pochi giorni il giornalista Filippo Astone scriveva un pezzo intitolato “Le incredibili dichiarazioni del pm nisseno Stefano Luciani”: l’accusa era che il magistrato, non riconoscendo i meriti degli imprenditori antimafia, non si rendeva conto di aiutare oggettivamente la mafia. Dunque l’antimafia è morta? Macché. Se l’antimafia è quella di Helg e di Montante possiamo stracciare il necrologio e stappare champagne. Perché non è morta l’antimafia. Ma un sistema di potere che ha occupato tutti gli spazi (non morali), che controlla ogni angolo del territorio, che dai tempi di Raffaele Lombardo gestisce nell’Isola il potente assessorato alle Attività Produttive, che tiene in pugno giornali e giornalisti: l’ordine di Sicilia ha aperto un’inchiesta sui finanziamenti elargiti dalla Camera di Commercio di Caltanissetta, di cui Montante è presidente, a testate e pubblicisti. “Potrà dunque esserci un’antimafia?” Sì. “Chi dovrà stabilire nel futuro prossimo la genuinità dei comportamenti antimafia?”. Non certo questi signori. Gaetano Savatteri, sempre su Gli Stati Generali, si è chiesto chi potrà credere ancora all’antimafia… Ma la domanda va forse ribaltata: chi ci ha mai creduto a questa antimafia? E se qualcuno ci ha creduto, perché?
IL MONDO DEI TRASFORMISTI.
Trasformismo in parlamento, 235 cambi di casacca in meno di due anni. Dalle politiche del 2013 al 15 marzo 2015 - 23 mesi - tra Camera e Senato, in parlamento ci sono stati 235 cambi di casacca. Da Letta a Renzi, sono già 185 i parlamentari che hanno deciso di emigrare in un altro gruppo politico: 13 fanno come Razzi e Scilipoti e saltano lo schieramento, quasi tutti salgono sul carro del Pd. Scelta civica verso la liquefazione, emorragia nel M5s tra espulsioni e abbandoni. Non mancano gli 'affezionati' della fuga: c'è chi è riuscito ad attraversare l'intero spettro politico. Raffronto con i governi Berlusconi e Monti, scrive Michela Scacchioli su “La Repubblica”. "Metà stipendio a te che cambi gruppo" parlamentare. O peggio: non sei più d'accordo col tuo partito? "Allora ti dimetti e decadi". Se "tradisci" dopo che sei stato candidato ed eletto, devi mollare subito la poltrona e uscire dal Palazzo alla svelta. I tentativi di punire chi scavalca lo steccato fioccano. Oggi, dinanzi a un Pd attrattivo e pigliatutto, Movimento 5 Stelle e Lega Nord continuano a insistere all'unisono sulla necessità di introdurre il vincolo di mandato di cui tanto si discute. Il motivo è quel "trasformismo galoppante" nato già nel Regno d'Italia ai tempi di Depretis. In merito, la Costituzione si esprime in maniera netta nel suo articolo 67 che esclude qualsiasi tipo di ripercussione su deputati e senatori. Indipendenza e autonomia, infatti, sono sanciti nero su bianco. E chi viene democraticamente scelto è tutelato da qualsiasi ingerenza esterna - forza politica di appartenenza in primis - affinché possa agire e votare con libertà di coscienza. Una garanzia riconfermata anche nel ddl Boschi che riforma la seconda parte della Carta. Ed è proprio a questa libertà che, puntualmente, fanno appello nelle loro dichiarazioni i parlamentari protagonisti dei 235 cambi di insegna avvenuti negli ultimi 23 mesi (durante i governi a guida Enrico Letta e Matteo Renzi). Sono 119 alla Camera e 116 al Senato. Numeri altissimi che se confrontati con la legislatura precedente - la sedicesima - forniscono un'idea del fenomeno e del suo trend: 261 passaggi in 58 mesi, dal 2008 al 2013. Il raffronto, ulteriormente suddiviso, consegna una cifra pari a 10,22 cambi al mese (nella diciassettesima legislatura, quella attuale) contro i 4,50 del periodo Berlusconi-Monti. Più del doppio. Se poi si vuole scorporare il dato degli ultimi quattro governi, le differenze sono ancora più forti: secondo i dati Openpolis per Repubblica.it, vince il governo Letta, con 15,33 cambi al mese (in virtù dell'implosione del Pdl e della nascita di Ncd), seguito dal governo Renzi (8 passaggi al mese) che si piazza davanti agli esecutivi Berlusconi e Monti, rispettivamente con 5,56 e 2,94 transizioni. Un'annotazione: in cifre assolute, durante l'esecutivo guidato dall'ex Cav (3 anni e 6 mesi) i trasformismi sono stati 217 contro i 97 dell'esecutivo Renzi, i 138 dell'esecutivo Letta e i 50 dell'esecutivo Monti. Un ammontare elevato, quello che fa riferimento a Berlusconi, se si considera che l'attuale leader di Forza Italia è stato l'ultimo ad aver vinto le elezioni politiche e si è insediato in un contesto politico ben più stabile. Certo, ciascuna legislatura è una storia a sé, e ciascun parlamento rappresenta una novità rispetto a quello precedente. Ma le dinamiche che si instaurano all'interno dell'aula, fra i banchi di Camera e Senato, forniscono una chiave di lettura per capire come e quanto stia cambiando la politica italiana. La XVII legislatura, iniziata a marzo 2013, già oggi risulta caratterizzata da un alto numero di cambi di gruppo. Un fenomeno che fa parte del nostro assetto costituzionale da sempre ma che, in questi ultimi due anni, ha raggiunto nuove dimensioni, complici le spaccature interne a tutti i partiti. Di sicuro, deputati e senatori sono costituzionalmente liberi di cambiare gruppo ogni qual volta lo desiderino, senza dover render conto a nessuno. E se nel 2010 sono stati proprio improvvisi cambi di gruppo - e di schieramento - a salvare il governo guidato da Silvio Berlusconi (vedi i casi di Domenico Scilipoti e Antonio Razzi), più recentemente si è assistito al proliferare di espulsioni sommarie (come nel caso del Movimento 5 Stelle), scissioni interne (la rottura dentro al Pdl con la nascita di Forza Italia e Nuova centrodestra) e la fine di esperimenti politici, come nel caso di Mario Monti e della sua creatura post premierato tecnico: Scelta civica. Chi viene e chi va. I gruppi che compongono il parlamento - nonché le loro dimensioni - oggi sono molto diversi se confrontati con quelli eletti alle politiche del 2013. E' possibile riassumere gli spostamenti in tre grandi insiemi: gruppi in forte crescita, gruppi in perdita e quelli che hanno subìto scissioni interne. Dentro quest'ultima categoria rientrano le forze che hanno dovuto mettere a bilancio il crollo numerico maggiore: c'è il Popolo delle libertà (con la rottura tra l'ex Cavaliere e Angelino Alfano, titolare del Viminale) e c'è Scelta Civica, con la fine dell'alleanza con Udc più Popolari e la conclusione dell'esperimento montiano al Senato. A seguire, in questo valzer di cambi si pone il Movimento 5 Stelle - terzo per membri persi - che risulta essere in forte ridimensionamento sia a Montecitorio (-18) sia a Palazzo Madama (-17). Fra i tanti in perdita, l'unico in reale crescita è il Partito democratico che ha giovato sia del salto di schieramento di molti deputati Sel sia del confluire del gruppo Scelta civica al Senato. Da marzo 2013 ad oggi, dunque, ci sono stati 235 cambi di gruppo che hanno coinvolto 185 parlamentari. Non solo: molti deputati e senatori hanno cambiato più volte gruppo, ma alcuni hanno compiuto il salto da maggioranza a opposizione (si veda la migrazione di molti deputati Sel), e altri sono persino tornati nei gruppi che all'inizio avevano deciso di lasciare. L'ultima mossa, in ordine di tempo, appartiene al deputato Massimo Corsaro che soltanto qualche giorno fa ha deciso di abbandonare Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d'Italia in evidente contrasto con il feeling che si è venuto a creare tra gli ex An e la Lega di Matteo Salvini. L'approdo, come per molti altri, è stato al gruppo Misto. E' lì, ad esempio, che molti parlamentari in fuga si appoggiano in un primo momento, in attesa di spiccare il volo verso altri lidi. Negli ultimi 23 mesi il Misto ha rappresentato un porto sicuro per 11 deputati: Fucsia Nissoli, oggi parlamentare di Per l'Italia, mesi fa ha lasciato Scelta civica per il Misto salvo poi tornare a Sc e infine atterrare su Pi. Sempre alla Camera, Adriano Zaccagnini è uscito dal M5s ma è transitato dal Misto prima di arrivare a Sel. Otto deputati di Sel - da Gennaro Migliore a Titti Di Salvo - sono passati dal Misto prima di entrare nel Pd. Nel panorama, non mancano neanche i ripensamenti: alla Camera è il caso di Alberto Giorgetti (da Fi ad Ap e poi di nuovo a Fi) e di Stefano Quintarelli (da Sc a Pi e ritorno indietro). Al Senato Luigi Compagna corre dal Misto al Gal ad Ap e poi di nuovo al Gal e poi ancora ad Ap. Paolo Naccarato parte dalla Lega per andare al Gal poi ad Ap e poi di nuovo al Gal. Sempre a Palazzo Madama il salto di schieramento l'ha fatto Antonio D'Alì che da Ncd è passato a Forza Italia mentre a Montecitorio il 'ribaltone' l'hanno fatto in 12, quasi tutti a favore del Pd. Ancora al Senato, è Lorenzo Battista (passato dal M5s al Misto e poi alle Autonomie-Psi-Maie) a lanciare un appello ai colleghi che come lui sono entrati in parlamento col movimento di Beppe Grillo ma che poi ne sono usciti per dissidi con il leader: "Creiamo un gruppo con Sel ed entriamo nel governo" è l'appello che lancia mentre un altro ex pentastellato, Walter Rizzetto, scende in piazza a Venezia con la destra della Meloni. Altro dato che emerge è la tendenza a cambiare gruppo ripetutamente. Sono 11 i parlamentari che hanno cambiato maglia tanto nella XVI quanto nella XVII legislatura, con alcuni - come Dorina Bianchi - che hanno attraversato l'intero spettro politico. La parlamentare, eletta con il Partito democratico nel 2008 al Senato, è poi transitata nel Pdl, con cui è stata ricandidata e rieletta nel 2013, per poi passare nei mesi successivi nel Nuovo centrodestra.
Paola Binetti alla Camera nella XVI legislatura è passata dal Pd all'Udc mentre nella XVII è passata da Scelta civica ad Area popolare.
Linda Lanzillotta nella XVI legislatura (alla Camera) è transitata dal Pd al Misto. Poi, però, nella XVII è ritornata da Scelta civica al Pd.
Benedetto Della Vedova nella XVI legislatura è passato dal Pdl a Fli ma poi nella XVII è andato da Scelta civica al Misto.
Aldo Di Biagio nella XVI legislatura è passato, da deputato, da Pdl a Fli. Poi, nella XVII, da senatore, è passato da Scelta civica ad Area popolare (Ncd più Udc).
Vincenzo D'Anna nella XVI legislatura è passato dal Pdl a Pt (alla Camera) mentre nella XVII è passato da Fi-Pdl a Gal (al Senato).
Dorina Bianchi nella XVI legislatura (al Senato) è passata dal Pd al Pdl mentre nella XVII legislatura (alla Camera) è transitata da Fi-Pdl ad Area popolare.
Mario Ferrara, senatore, nella XVI legislatura è passato dal Pdl a Cn mentre nella XVII è passato da Misto a Gal.
Alessandro Maran nella XVI legislatura (alla Camera) è passato dal gruppo Pd a Misto mentre nella XVII (al Senato) è ritornato da Scelta civica a Pd.
Antonio Milo nella XVI legislatura (alla Camera) è passato dal gruppo Misto a Pt mentre nella XVII (al Senato) è transitato da Fi-Pdl a Gal.
Giuseppe Ruvolo nella XVI legislatura è passato (alla Camera) dall'Udc a Pt e nella XVII è transitato (al Senato) da Fi-Pdl a Gal.
Ripercussioni sulla maggioranza. Deputati e senatori possono esprimere dissenso nei confronti del proprio gruppo in vario modo. Uno di questi è proprio il voto, vale a dire la possibilità di esprimersi in maniera non conforme alla linea dettata dal capogruppo. In linea generale, prima della fuoriuscita dal gruppo di elezione, i parlamentari transfughi avevano una percentuale media di voti ribelli in linea con il resto dell'aula. Anzi: il 60% di loro alla Camera e il 77% al Senato erano sotto la media di ribellione. In pochissime situazioni in aula sono emerse le avvisaglie del cambio di gruppo e quasi mai è stata data prova tangibile di 'infedeltà' prima di scegliere la nuova 'squadra'. La situazione dei voti ribelli, però, varia molto se la si analizza subito dopo il cambio di maglia. La percentuale di voti discordanti rispetto al gruppo di elezione sale a dismisura soprattutto per deputati e senatori che hanno fatto un salto di schieramento. In una situazione analoga si trovano i numerosi fuoriusciti grillini, che dopo l'espulsione o abbandono del Movimento 5 Stelle hanno tendenzialmente iniziato a votare in maniera opposta. L'analisi sui voti ribelli permette di delineare altre due situazione ben specifiche. Da un lato il caso Pdl, con la discrepanza nei voti tra membri del Nuovo centrodestra e Forza Italia, soprattutto per il passaggio di quest'ultimo all'opposizione. Infine i tanti cambi di gruppo interni alla maggioranza (scissione Scelta Civica - Per l'Italia e spostamento di molti parlamentari nel Partito democratico), hanno reso alcuni cambi, specialmente in sede di voto, totalmente irrilevanti. A quanti una seconda chance. Se durante l'attuale legislatura il fenomeno dei cambi di gruppo è particolarmente accentuato, non si può certo dire che sia una novità rispetto alla precedente. Infatti, nella XVI legislatura (2008-2013) ben 180 parlamentari hanno cambiato gruppo. In particolare ci sono stati due eventi catalizzatori: la rottura fra il Pdl e Gianfranco Fini da un lato, e il voto di fiducia che ha salvato il governo Berlusconi grazie ai cosiddetti 'Responsabili'. Ma che fine hanno fatto questi 180 transfughi? Sono stati premiati per aver salvato il governo Berlusconi? E quelli che hanno seguito Fini nell'avventura di Fli sono stati ricandidati? I numeri parlano chiaro: il 48% dei transfughi è stato ricandidato, e il 12,75% è stato rieletto. Cifre più basse dei parlamentari 'fedeli', che sono stati ricandidati per il 52% e rieletti per il 41 per cento. La differenza principale sta nel gruppo che si è scelto di raggiungere. I 'Responsabili' che hanno lasciato i loro gruppi di appartenenza per salvare il governo Berlusconi sono stati quasi sempre ricandidati e soprattutto rieletti (Scilipoti e Razzi, appunto), mentre deputati e senatori che hanno seguito Fini nell'avventura Fli sono stati ricandidati ma non rieletti visto che il partito non ha raggiunto la soglia minima. In generale il 50% dei parlamentari che ha abbandonato Berlusconi nella scorsa legislatura è finito nel 'dimenticatoio' e non è stato neanche ricandidato.
IL MONDO DELLE CRICCHE.
Corruzione, Mose Expo e Mafia Capitale: il 2014 anno dei grandi scandali, scrive “Il Fatto Quotidiano”. Il "classico" di grandi opere e imprenditori a Venezia, il ritorno di Tangentopoli a Milano e la "quinta mafia" a Roma. Mentre l'Italia diventa primatista in tutta Europa, sorpassando anche Grecia e Bulgaria nella classifica di Transparency. La mazzette non finiscono mai. E i “tangentari” di destra e di sinistra ritornano e, in alcuni casi, diventano “mafiosi”. Il 2014 è stato un anno contraddistinto da tre grandi scandali: Mose (Venezia), Expo (Milano) e Mafia Capitale (Roma). Ed è stato anche l’anno in cui l’Italia ha raggiunto il triste primato per il reato di corruzione in Europa, sorpassando anche Grecia e Bulgaria, secondo la speciale classifica di Transparency. L’inchiesta veneziana è un classico delle bustarelle made in Italy: grande opera e imprenditori che foraggiano la politica per ottenere appalti. Quella milanese ha riportato in carcere, anche se per poco tempo, alcuni personaggi storici della Tangentopoli anni ’90 come il compagno G., Primo Greganti, o l’ex Dc, Gianstefano Frigerio. L’indagine romana invece ha rivelato l’esistenza a Roma di quella che potrebbe essere considerata la quinta mafia d’Italia. Italia prima nella classifica della corruzione di Transparency davanti a Grecia e Bulgaria. A giugno è deflagrato il caso Mose: 35 arresti, tra cui il sindaco Pd Giorgio Orsoni, e la richiesta del carcere per l’ex ministro Fi Giancarlo Galan. A sei mesi dalle misure cautelari e gli avvisi di garanzia i pm di Venezia stanno per chiudere l’indagine e nel registro degli indagati sono finiti anche i deputati democratici Mognato e Zoggia. All’ex primo cittadino, che è stato sentito nei giorni scorsi in Procura, il gup ha respinto il patteggiamento mentre per l’ex governatore del Veneto il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Quello che sarà sull’indagine sugli appalti del sistema di dighe anti-acqua alta e sul finanziamento illecito ai partiti si vedrà nei prossimi mesi. Invece la prima parte dello scandalo Expo, esplosa a maggio, si è già chiusa con patteggiamenti e poco carcere per i principali imputati. Il gup Milano ha accolto, tra le altre, le richieste dell’ex segretario della Dc milanese all’epoca di Tangentopoli Gianstefano Frigerio, dell’ex cassiere di Pci e Pds Primo Greganti e dell’ex senatore Fi Luigi Grillo. Pena massima, 3 anni e 4 mesi. E così sei dei sette imputati, già liberi o ai domiciliari, potranno accedere in tempi brevi alle misure alternative. E la grande politica è rimasta fuori dal registro degli indagati. Almeno per ora. Altre inchieste sono aperte. Da registrare, in una fase così delicata, l’esautorazione del coordinamento del dipartimento per i reati contro la pubblica amministrazione dell’aggiunto Alfredo Robledo da parte del procuratore capo Edmondo Bruti Liberati. In fase di chiusura l’indagine Mose, patteggiamenti e poco carcere per corrotti e corruttori dell’inchiesta Expo. C’è poi Mafia Capitale, l’inchiesta sul “mondo di mezzo”, che ha svelato l’esistenza di un’organizzazione, considerata mafiosa dagli inquirenti di Roma, capace di intimidire, corrompere politici di ogni schieramento e metter le mani sugli appalti del Campidoglio e della Regione Lazio. Un’indagine, quella coordinata dal ex procuratore capo di Palermo e Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, che ha portato a tre tranche di arresti e all’iscrizione nel registro degli indagati per 416bis anche l’ex sindaco della Capitale, Gianni Alemanno. Un gruppo, quello guidato da Massimo Carminati ex banda della Magliana ex terrorista Nar ora al 41bis per ordine del ministro della Giustizia, capace di infiltrarsi e fare business nella gestione dei centri accoglienza per immigrati e dei campi nomadi, di manipolare le nomine e indirizzare le scelte politiche dell’amministrazione, finanziare cene e campagne elettorali, affiliare imprenditori e usare la forza. Tanto da far scrivere al New York Times che non “c’è angolo di Itali immune dalla criminalità”. A chiudere l’anno l’inchiesta su Mafia Capitale, capace di corrompere politici di destra e di sinistra, inquinare appalti e affiliare imprenditori. Il clamore per le inchieste ha spinto il governo di Matteo Renzi ad aprire prima una discussione in estate e poi ad approvare qualche giorno fa nuove norme contro la corruzione. Ma i provvedimenti sono stati criticati con forza dall’Associazione nazionale magistrati e anche dal procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti. Era stata chiesta, anche da Pignatone e dal presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone, l’estensione degli strumenti che si utilizzano per combattere la mafia ai reati dei colletti bianchi come i “premi” per i pentiti. Richiesta allo stato rimasta inascoltata. E così Mose, Expo, Mafia Capitale, probabilmente, non resteranno un unicum nel paese che non si lascerà mai alle spalle Mani pulite. Sia per gli appalti e le gare per l’Esposizione universale (ci anche altre indagini ancora parte), sia per l’inchiesta dei pm Roma gli accertamenti non sono ancora terminati e la sensazione che il 2015 potrebbe essere un anno ancora da record in negativo per il nostro paese.
16 marzo 2015. Da oggi non solo “Mose, expo, mafia capitale”, si aggiunge TAV, scrive “News Pedia”. E’ da qualche mese che, quando si voleva descrivere l’operato della classe mala-politica, si usavano queste tre sigle, a massima espressione delle infiltrazioni malavitose nel vissuto di Stato: “Mose, Expo, Mafia capitale”. Da questa mattina, 16 Marzo 2015, si potrà aggiungere una nuova altisonante sigla, alla lista delle opere su cui è conclamata un’indagine delle procure, con qualche manetta al seguito, la TAV. L’indagine parte dalla Procura di Firenze, e ha colpito a Roma e Milano con 4 arresti ed almeno una cinquantina di indagati, grazie alla mano ferma dei carabinieri del Ros. L’accusa è gestione illecita degli appalti nelle Grandi Opere. Si tratta, secondo chi ha condotto le indagini, di un “sistema corruttivo articolato”. A finire in manette Ercole Incalza, al secolo super dirigente del ministero dei Lavori Pubblici, ed il suo collaboratore Sandro Pacella. Gli altri due ammanettati sono gli imprenditori Francesco Cavallo e Stefano Perotti. Tutti “frequentatori dei ministeri”, e in particolare Pacella, ad oggi ancora funzionario del ministero dei Lavori Pubblici, a stretto contatto con Ercole Incalza, che vanta una lunga carriera politica sotto i colori più disparati. Arrivato nel 2001 a Palazzo Chigi come capo di segreteria tecnica sotto il governo Berlusconi, Incalza avrebbe “festeggiato” l’anno venturo il quindicesimo anno di permanenza nei palazzi del potere. Sopravvissuto al governo Prodi, permane nell’ennesimo governo Berlusconi, confermato da Corrado Passera per il governo Monti, e ancora poi da Lupi (sia governo Letta che Renzi). L’accusa è incentrata principalmente su di lui, definito dagli inquirenti “potentissimo dirigente” del ministero e “priuncipale artefice del sistema corruttivo”, un autentico “dominus” della struttura tecnica del ministero. Le indagini sono partite e coordinate da Firenze per una ragione ben precisa, tutto nasce da un filone interessante gli appalti per l’Alta velocità in Firenze, e il piano di sotto-attraversamento della città toscana. In realtà la TAV di Firenze non è nuova alle procure, già nel 2013 Maria Rita Lorenzetti, dirigente Italferr di area centrosinistra, viene posta agli arresti domiciliari, con le accuse di associazione per delinquere, abuso di ufficio, corruzione e traffico di rifiuti, nell’ambito di una indagine sulla TAV fiorentina. Dalle indagini svelate oggi sembra emergere che il malaffare nella TAV Firenze non fosse affatto stato sventato.
Riecco la cricca delle Grandi Opere, scrive Domenico Camodeca su “L’Indro”. Arrestato per corruzione il boiardo di Stato Incalza. Mafia Capitale prepara la festa ai cristiani. Calma piatta in parlamento. Le irrimandabili riforme (almeno secondo Matteo Renzi) restano congelate fino a dopo le elezioni regionali del 31 maggio a causa dei soliti, squallidi, giochi di Palazzo. Ma le attenzioni mediatiche sono tutte concentrate sui nuovi clamorosi casi di corruzione. Ancora tangenti Tav e Expo, tra gli arrestati anche il manager bipartisan e Signore delle Grandi Opere Ercole Incalza: Beppe Grillo pretende una legge anticorruzione subito. Il M5S chiede le dimissioni di Maurizio Lupi: il figlio assunto da uno dei fermati (ma il ministro nega sia un favore), rolex e abiti sartoriali regalati da un altro. Intanto Mafia Capitale si prepara al Giubileo delle poltrone: voci per ora smentite su Francesco Rutelli commissario straordinario. Sul versante politico, Maurizio Landini lancia una ‘coalizione sociale’ a sinistra del Pd, ma per il momento anche Susanna Camusso si smarca. Solo il dissidente Dem Alfredo D’Attorre raccoglie in parte l’appello del leader Fiom e convoca un’assemblea per sabato prossimo. Grazie all’effetto Mose il civatiano Felice Casson trionfa nelle primarie del centrosinistra a Venezia battendo il renziano Nicola Pellicani. Dopo la defenestrazione di Flavio Tosi, Matteo Salvini prova a ricucire con Silvio Berlusconi, ma perde 3 senatori. Sergio Mattarella a via Fani per il 37° anniversario del rapimento di Aldo Moro, ma il mistero sulla vicenda resta fitto. Muore a 88 anni l’ex AN Gustavo Selva. Expo, Tav, Mose, ma anche l’intramontabile G8. L’elenco delle Grandi Opere finite nelle inchieste delle procure del Belpaese è veramente completo. Già da tempo, grazie a galantuomini come Guido Bertolaso, Angelo Balducci, Diego Anemone e agli altri protagonisti della cosiddetta cricca delle Grandi Opere, gli italiani erano al corrente dell’immenso giro di denaro sporco allestito nel 2009 in occasione del G8 dell’Aquila e dei Mondiali di Nuoto. Oggi arriva la notizia dell’arresto per corruzione ordinato dalla procura di Firenze di Ercole Incalza (insieme ad altri pesci piccoli), il potentissimo ex dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici (con 2 governi Berlusconi, ma anche Prodi, Monti, Letta e Renzi), attualmente solo consulente esterno. Tutte le principali Grandi Opere, in particolare gli appalti relativi alla Tav Firenze e alcuni riguardanti l'Expo, ma non solo, rende noto la procura fiorentina che coordina le indagini, sarebbero state oggetto dell’«articolato sistema corruttivo» architettato dalle persone arrestate e indagate. Sul cadavere della legalità italiana si getta come un rapace Beppe Grillo che, riferendosi ad Incalza, commenta sul web: «L'hanno appena arrestato. Ora ne vedremo delle belle. Tutti in galera. Ora subito legge anticorruzione». In realtà il M5S già a luglio aveva presentato un’interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi sull’ambiguo ruolo di Incalza. In quell’occasione il rappresentante di ‘Comunione e Fatturazione’ (così i detrattori chiamano CL) si era speso in una sperticata quanto improvvida difesa del supermanager. E oggi il grillino Alessandro Di Battista posta su twitter l'imbarazzante video di Lupi aggiungendo spietato: «Ministro si ricorda come difendeva Incalza di fronte a noi? Oggi l'hanno arrestato!». Il governo Renzi sarà finalmente costretto ad approvare una vera legge anticorruzione scontentando Berlusconi e Alfano? Difficile. A proposito di affari sporchi, il gioco delle ‘quattro poltrone’ (una volta si chiamavano cantoni) colpisce anche Roma Capitale, meglio nota come Mafia Capitale. L’annuncio di un Giubileo straordinario fatto a sorpresa da papa Francesco venerdì scorso, ha avuto l’effetto di un terremoto sulle istituzioni italiane e capitoline, scatenando al contempo gli appetiti affaristici della solita cricca dei Grandi Eventi. Il sindaco Ignazio Marino ha subito battuto cassa con il governo, respingendo al mittente l’ipotesi di affidare la gestione dell’evento ad un commissario straordinario. Dal Campidoglio hanno fatto sapere che «nel 2000 il commissario lo fece il sindaco di allora», proprio quel Francesco Rutelli che adesso molti indicano come possibile coordinatore del nuovo Giubileo. Ipotesi a cui Marino ha subito chiuso la porta specificando che «questo è il Giubileo della Misericordia, non della cuccagna e delle poltrone». Ma quando si parla di Roma Ladrona la lingua del solito Salvini si scioglie senza freni: «Per Marino e Renzi la città è pronta, per me no. Lo sono affaristi, trafficoni e amici di Mafia Capitale». E come dargli torto visti i precedenti? Stasera, comunque, è in programma un summit tra sindaco e assessori in Campidoglio, mentre il sottosegretario alla P.A. Angelo Rughetti (Pd) provoca il Vaticano proponendo ai taccagni porporati di mettere mano al portafoglio. Le primarie del centrosinistra svoltesi domenica scorsa a Venezia stanno lì a dimostrare che il ‘sistema Renzi’ può implodere facilmente di fronte agli scandali di corruzione di cui si rende responsabile la classe dirigente e imprenditoriale italiana. Non si spiegherebbe altrimenti, se non con l’effetto Mose (l’inchiesta su tangenti e corruzione in Laguna), la limpida vittoria ottenuta dall’ex magistrato Felice Casson. Vero che Casson è persona conosciuta e stimata per la sua probità, ma è altrettanto vero che lui stesso ha scelto di essere civatiano, ovvero seguace delle ‘idee’ di Pippo Civati, l’eterno oppositore interno del Pd. Vincere, anzi stravincere, pur essendo civatiano, con oltre il 55% delle preferenze contro il 24% del favorito del Palazzo Nicola Pellicani, significa per l’ex pm aver intercettato appieno lo scontento e il disgusto per il renzismo imperante del ‘veneziano medio’. «Il nostro popolo», così festeggia oggi Casson intervistato da ‘Repubblica’, «ha chiesto di voltare pagina con forza, nel nome della trasparenza, della legalità e dell'etica. Un segnale importante, ha vinto tutta Venezia». A sinistra del Pd, invece, qualcosa si sta muovendo. Sabato scorso il segretario della Fiom Maurizio Landini ha riunito a Roma il primo nucleo (assai sparuto per la verità) di quella coalizione sociale che, nelle intenzioni del Saldatore della sinistra, dovrebbe opporsi alla visione neoliberista brussellese di cui il governo Renzi è il fedele esecutore in Italia. Ieri, ospite della tribuna domenicale di Lucia Annunziata, Landini ha confermato di non voler trasformare il sindacato in partito, criticato le iniziative di governo e Confindustria che «hanno tolto diritti a tutti», ribadito la necessità di «una riforma del sindacato e anche della Cgil» che in passato hanno commesso l’errore di abbandonare i lavoratori non garantiti e, infine, ripetuto di voler combattere «la battaglia contro il jobs act e per un nuovo statuto dei lavoratori». Tiepide, per non dire gelide, le reazioni dei liderini degli altri partitini della galassia rossa, tutti ciecamente gelosi del loro misero orticello. Il discorso vale per Nichi Vendola di Sel, Paolo Ferrero del Prc, ma anche per Susanna Camusso della Cgil e per lo stesso Pd. Paradossalmente, però, è proprio dal partitone della nazione renziano che arrivano dei tiepidi segnali di apertura. Le famigerate minoranze Dem hanno organizzato per sabato prossimo un’assemblea, a cui parteciperanno esponenti di Cgil e Sel, dal titolo inequivoco: A sinistra del Pd. Anima dell’ennesimo rassemblement della gauche italica è il bersaniano Alfredo D’Attorre che oggi su Repubblica definisce Landini un «interlocutore importante», ma nega che sabato «nascerà un correntone antirenziano». Sarebbe stata troppa grazia per chi in Italia ha ancora il coraggio di definirsi di sinistra. Ma il cortocircuito delle alleanze si sta verificando, ormai da tempo, anche nel centrodestra. Dopo essere stato cacciato dalla Lega, il sindaco di Verona Flavio Tosi ufficializza la sua personale candidatura a governatore del Veneto. Contro il leghista ufficiale Luca Zaia e contro la ‘ladylike’ renziana Alessandra Moretti. Un Tosi riscopertosi moderato (gli ex alleati di Forza Nuova hanno inscenato il suo funerale politico nel capoluogo scaligero) che adesso fa paura a Salvini. Il leader leghista si dimostra sprezzante verso un traditore che potrebbe allearsi con il «nulla» di Angelino Alfano e con Corrado Passera, ma teme la decisione di Forza Italia. Il consigliere di Berlusconi Giovanni Toti ha già avvertito l’altro Matteo di moderare i toni se non vuole perdere l’alleanza con gli azzurri in Veneto. Per questo è già in programma un nuovo incontro tra il Cav e felpetta nera.
L'inchiesta sulle "grandi opere" e quelle preoccupazioni di Renzi. Anche per le ombre sull'Expo, l'indagine rischia di offuscare agli occhi della Ue l'immagine delle riforme del governo. Che chiede chiarezza immediata, scrive “Panorama”. "Chi sta realizzando l’Expo", ha detto Matteo Renzi nel corso dell'ultima sua visita ai cantieri milanesi, "sta costruendo una grande cattedrale laica". Ma a quanto pare con qualche peccato laico di troppo, almeno stando alle carte dell'inchiesta sulle "grandi opere" condotta dalla procura di Firenze, che ha portato all'arresto di quattro persone tra cui Ercole Incalza, dirigente ai Lavori pubblici per 7 governi incluso l'attuale esecutivo (anche se dal ministero delle Infrastrutture precisano che non ha più incarichi dallo scorso dicembre e che era un consulente esterno), e ad altri 51 indagati. Secondo i magistrati, tra le "grandi opere" macchiate da affari illeciti ci sarebbe infatti anche l'appalto per il Palazzo Italia, progetto di "architettura-paesaggio" del padiglione italiano dell'Expo, con la commessa del valore di oltre 25 milioni di euro che sarebbe stata pilotata grazie agli stretti rapporti tra Stefano Perotti, imprenditore arrestato contemporaneamente a Incalza, e l'allora manager di Expo 2015 spa Antonio Acerbo, finito ai domiciliari lo scorso ottobre in una tranche dell'inchiesta milanese sulla cosiddetta "cupola degli appalti". Stando all'imputazione, Acerbo - che ha firmato il bando per Palazzo Italia - avrebbe turbato la gara "pilotandone l'aggiudicazione in favore" dell'impresa Italiana Costruzioni, alla guida di un'associazione temporanea di imprese (composta anche dal Consorzio Veneto Cooperativo). Suoi presunti complici sarebbero stati Perotti, "quale professionista interessato alla progettazione e direzione dei lavori" dell'opera, Giacomo Beretta, ex assessore milanese al Bilancio della Giunta Moratti, Castellotti e anche i "referenti della stessa Italiana Costruzioni", Attilio Navarra (presidente del cda), Luca Navarra e Alessandro Paglia. Sempre secondo gli inquirenti, che basano le loro accuse anche su una corposa serie di intercettazioni telefoniche, Acerbo - che avrebbe redatto un bando ad hoc - e gli altri indagati si sarebbero accordati "preventivamente e clandestinamente" per quella gara, aggiudicata nel dicembre 2013. Inoltre, nel capitolo dell'ordinanza del gip di Firenze relativo a Palazzo Italia si parla anche di una richiesta da parte di Perotti di incontrare il ministro dell'Infrastrutture Maurizio Lupi. Il 3 gennaio 2014, si legge, "Perotti nel riportare che si è accordato con l'ing. Incalza per incontrarsi presso la sede di Expo 2015, chiede a Franco Cavallo (altro imprenditore arrestato nella giornata di lunedì, ndr) di fare in modo, tramite Emanuele Forlani, di incontrare in ministro Lupi prima che inizi il sopralluogo". E Cavallo "ribatte che il ministro è già informato della richiesta di incontro". Anche se si è ancora nel terreno delle indagini e dei condizionali d'obbligo, ce n'è però abbastanza per preoccupare Palazzo Chigi, che rimane in attesa di un chiarimento da parte del ministro Maurizio Lupi, finito appunto nelle intercettazioni, auspicando al contempo che si faccia luce al più presto sul tutto, non solo sull'Expo, affinché l'impegno del governo contro la corruzione, incarnato in particolare dal commissario Raffaele Cantone, non venga offuscato agli occhi tanto dei cittadini quanto dell'Europa, considerando che sul tema l'Italia è da sempre nel mirino dell'Ue e delle istituzioni internazionali per i danni che ciò comporta alla nostra economia. Concentrato nel cercare di dimostrare all'Unione Europea che il Paese è impegnato nelle riforme e sta cominciando lentamente ad uscire dal tunnel, Matteo Renzi viene raccontato come a dir poco "infastidito" dalle notizie provenienti dall'inchiesta. "Serve chiarezza, in gioco sono l'immagine e la credibilità dell'Italia", incalzano i renziani che, per voce del capogruppo in commissione Giustizia Walter Verini, chiedono di riferire "presto" in Parlamento. E in attesa che la magistratura definisca i confini dell'inchiesta, il premier vuole mandare segnali politici chiari: per questo la "riflessione" per un "tagliando" sulla legge Severino, ipotizzata ieri proprio da Cantone, viene derubricata a opinione personale del commissario. "La Severino non si tocca almeno fino alla sentenza della Consulta", spiegano fonti di maggioranza, che non vogliono alimentare l'idea di cedimenti al proposito, mentre lo stesso Renzi ha chiesto agli alleati di trovare immediatamente (e finalmente) l'accordo sul ddl anti-corruzione per arrivare in tempi brevi alla sua approvazione da parte del Senato. Proprio nella serata di lunedì, tuttavia, la seduta della Commissione Giustizia del Senato con in discussione il disegno di legge anti-corruzione è stata sospesa per mancanza del numero legale dovuta all'assenza proprio dei parlamentari del Pd. Con un presumibile aumento del "disappunto" del premier Renzi.
Grandi opere, spuntano regali al ministro Lupi. "Abito sartoriale per lui e un lavoro al figlio". Nelle carte dell'inchiesta sugli appalti anche il titolare delle infrastrutture, che non è indagato. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto doni per sé e per il figlio, incluso un rolex. La replica: "Mai chiesto favori", scrive Michele Sasso su “L’Espresso”. L’inchiesta di Firenze che ha portato all’arresto dell’uomo delle grandi opere Ercole Incalza punta dritta al ministro delle infrastrutture. Maurizio Lupi, uomo di peso nel governo Renzi in quota Nuovo Centrodestra, non è indagato ma secondo l’accusa, avrebbe goduto di incarichi di lavoro per il figlio Luca e di regali per la famiglia: un vestito sartoriale per Lupi e un Rolex da 10mila euro al figlio, in occasione della laurea. A regalare il vestito al ministro sarebbe stato Franco Cavallo, uno dei quattro arrestati che secondo gli inquirenti aveva uno “stretto legame” con Lupi tanto da dare “favori al ministro e ai suoi familiari". «Da una telefonata del 22 febbraio 2014 – si legge nell'ordinanza – emerge che Vincenzo Barbato (un sarto che avrebbe confezionato un abito per Emanuele Forlani capo segreteria del ministero e ciellino come il suo mentore ndr) sta confezionando un vestito anche per il ministro Lupi». Scambi di favori per accedere direttamente ai ricchi affari di progettazione dei lavori pubblici: dall’Alta velocità ferroviaria ai cantieri per le autostrade come Orte–Mestre e Cispadana fino al porto di Trieste. Al centro il manager pubblico Ercole Incalza che, puntualmente, affidava gli appalti all’imprenditore Stefano Perotti. Secondo il gip «effettivamente Stefano Perotti ha procurato degli incarichi di lavoro a Luca Lupi». Secondo quanto riportato, uno degli indagati, Giulio Burchi, «racconta anche al dirigente Anas, ingegner Massimo Averardi, che Stefano Perotti ha assunto il figlio del ministro». Ecco l’intercettazione che svela lo strano intreccio: «Ho visto Perotti l’altro giorno, tu sai che Perotti e il ministro sono non intimi, di più. Perché lui ha assunto anche il figlio, per star sicuro che non mancasse qualche incarico di direzione lavori, siccome ne ha soli 17, glieli hanno contati, ha assunto anche il figlio di Lupi, no?». Poi, il primo luglio 2014, sempre Burchi a Averardi: «Il nostro Perottubus (soprannome di Perotti) ha vinto anche la gara, che ha fatto un ribasso pazzesco», ha vinto «anche il nuovo palazzo dell’Eni a San Donato e c’ha quattro giovani ingegneri e sai uno come si chiama? Sai di cognome come si chiama? Un giovane ingegnere neolaureato, Lupi, ma guarda i casi della vita».Il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo spiega il meccanismo con il quale l'ex dirigente del ministero dei Lavori pubblici (ora consulente esterno) Ercole Incalza avrebbe manovrato numerosi appalti pubblici assieme all'ingegner Stefano Perotti. A Perotti sarebbe stata affidata la direzione dei lavori in cambio di consulenze retribuite allo stesso Incalza. Secondo il pm Creazzo "il meccanismo ha favorito un incremento dei costi" delle opere. «Perotti – continua il Gip – nell’ambito della commessa Eni, stipulerà un contratto con Giorgio Mor, affidandogli l’incarico di coordinatore del lavoro che, a sua volta, nominerà quale persona fissa in cantiere Luca Lupi» per 2 mila euro al mese. La replica di Lupi è secca: «Non ho mai chiesto all’ingegner Perotti né a chicchessia di far lavorare mio figlio. Non è nel mio costume e sarebbe un comportamento che riterrei profondamente sbagliato. Mio figlio si è laureato al Politecnico di Milano nel dicembre 2013 e in attesa del visto per lavorare negli Stati Uniti ha lavorato da febbraio 2014 a febbraio 2015 presso lo studio Mor di Genova con un contratto a partita Iva per 1.300 euro netti al mese»."Le spiegazioni il ministro Lupi le ha già fornite. Prematuro trarre le conclusioni di colpevolezza di un intero sistema e un intero Governo". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, ospite a "Otto e Mezzo", a proposito dell'inchiesta di Firenze su appalti di Grandi Opere e Tav. Il ministro conferma quindi l’incarico ricevuto dal figlio dallo studio Mor di Genova, uno degli snodi dell’inchiesta visto che Giorgio Mor è il cognato di Perotti. I due ne parlano a lungo al telefono: il 16 febbraio 2014 Mor sembra voler salvare almeno le forme e chiede al cognato Perotti se fosse possibile assumere il giovane Lupi “in maniera meno formale”: «Ci siamo, abbiamo fatto una riflessione che sembrava poco opportuno era la triangolazione». La “triangolazione”: secondo il gip è un’espressione che mette in relazione tre nomi, cioè Perotti, Mor e Luca Lupi. Il primo riceve l’incarico da Eni per un’attività di progettazione, stipula un contratto con il secondo affidandogli un incarico di coordinatore e il secondo nominerà come “persona fissa in cantiere” il terzo. Ovvero il neolaureato con il cognome di peso. Ecco uno scampolo dell’articolato sistema corruttivo “che coinvolgeva dirigenti pubblici, società aggiudicatarie degli appalti ed imprese esecutrici dei lavori” secondo i magistrati di Firenze. Tutto partiva dalla “struttura tecnica di missione”, un ufficio del ministero cucita su misura da Incalza e crocevia di presunti favori e mazzette per le imprese che lavorano nei ricchi appalti pubblici. Questa l’intercettazione della telefonata del 16 dicembre 2014 tra il ministro e il suo braccio destro. Secondo gli inquirenti la conversazione «ben rappresenta» l’importanza della struttura alle dirette dipendenze del ministro. «Su questa roba ci sarò io e ti garantisco che se viene abolita la struttura tecnica di missione non c’è più il governo!», urla la telefono Maurizio Lupi con Ercole Incalza di fronte alla proposta di soppressione o di passaggio della stessa sotto la direzione della presidenza del Consiglio. Una crisi di governo con il mancato appoggio del suo partito, il Nuovo Centrodestra, solo annunciata: Incalza lascia il ministero con la fine dell’anno e della ristrutturazione non c'è nessuna traccia. Ora la difesa a spada tratta dell’operato del suo factotum: «L’ingegner Incalza – spiega Lupi – era ed è una delle figure tecniche più autorevoli che il nostro Paese abbia sia da un punto di vista dell’esperienza tecnica nazionale che della competenza internazionale. Non a caso è la persona che viene definita come il padre della “legge obiettivo” ed il padre della possibilità che nel nostro Paese si siano realizzate le grandi opere».
Ercole Incalza arrestato: cinque anni dopo la cricca, la storia si ripete. Appalti truccati, affidamenti pilotati, mazzette e pressioni, scrive Claudia Fusani su L'Huffington Post. Cinque anni dopo la storia si ripete. Forse è meglio dire che non si è mai interrotta. Cinque anni fa, più o meno in questi tempi, il Ros dei carabinieri e la procura di Firenze misero le mani sulla cricca del G8, su Balducci, De Santis, Della Giovampaola, Rinaldi, Anemone e tutti gli affari del “sistema gelatinoso” che per anni, dalla cabina di regia della struttura Grandi eventi della presidenza del Consiglio dei ministri ha sottratto al Paese miliardi e miliardi in corruzione e malaffare al Paese. Ieri mattina gli stessi magistrati fiorentini, Luca Turco, Giulio Monferini e Giuseppina Mione sulla base delle indagini svolte dagli stessi uomini del Ros dei carabinieri, hanno firmato l’atto secondo della stessa storia. Cambiano i protagonisti. Salgono sulla ribalta nomi che in quell’indagine erano rimasti sullo sfondo, come il superdirigente del ministero delle Infrastrutture Ercole Incalza. Forse sono un po’ meno sfacciati i metodi. Il risultato è lo stesso: corruzione, appalti truccati, affidamenti pilotati, il mercato degli appalti pubblici falsato da mazzette, pressioni, ricatti. E il solito giro di “altre utilità”: orologi, abiti, viaggi, posti di lavoro, incarichi. Non pervenuti, al momento almeno, i benefit in forma di massaggi e cene eleganti. Presente, invece, anche oggi il prelato, il monsignore di turno con spiccato senso degli affari. Quanta politica tra gli indagati. Quattro gli arrestati: il super-dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici (ora consulente esterno) Ercole Incalza, il suo collaboratore Sandro Pacella e gli imprenditori Stefano Perotti e Francesco Cavallo. Sono tutti accusati di corruzione, induzione indebita, turbata libertà delle gare pubbliche e altri delitti contro la pubblica amministrazione. Il gip ha rifiutato un quinto arresto (l’imprenditore Massimo Fiorini). Ma sono una cinquantina gli indagati, ex sottosegretari, ex parlamentari ed ex amministratori locali. C’è Rocco Girlanda, ex sottosegretario ai trasporti ed braccio destro di Denis Verdini; Antonio Bargone, anche lui ex sottosegretario ai Trasporti ai tempi dei governi Prodi e D’Alema e poi presidente della autostrada Sat; l'ex sottosegretario allo Sviluppo economico Stefano Saglia (pdl) poi nel cda di Terna; Vito Bonsignore, ex presidente del gruppo Ppe; l’ex senatore azzurro Fedele Sanciu. Non sono indagati ma nelle intercettazioni spuntano spesso i nomi del ministro Maurizio Lupi, del figlio Luca in quanto beneficiario di un posto di lavoro, un Rolex da diecimila euro e qualche abito di sartoria. E di Riccardo Nencini, viceministro alle Infrastrutture con delega ai lavori pubblici. Sopra tutto e tutti c’è Ettore Incalza: li controlla, li contatta e ottiene il via libera per affidamenti, perizie, direzioni lavori e appalti. In cambio la sua società, la Green Field System, ottiene consulenze e direzioni lavori. Il ruolo di Incalza. Sopravvissuto a sette governi (l’unico che lo allontana è Di Pietro) e una dozzina di inchieste, Ercole Incalza, nonostante la pensione, continua a guidare, come consulente esterno, la struttura tecnica di missione della cosiddette Grandi Opere, organismo del ministero delle Infrastrutture che, ripreso il potere che gli aveva sottratto Balducci con una struttura concorrente, decide la sorte di miliardi di fondi pubblici, segue la progettazione e l'approvazione delle grandi opere. II nome di Incalza è spuntato nell’inchiesta G8, nelle intercettazioni sul Mose e sull'Expo, è indagato per la Tav di Firenze (associazione a delinquere finalizzata a corruzione e abuso). A luglio 2014 i Cinque stelle avevano fatto un’interrogazione alla Camera. Il ministro Lupi aveva difeso fino alla morte l’integrità e le capacità professionali di Incalza. Intanto il figlio lavorava già per una sua società. Il cuore dell'inchiesta. Il gip Angelo Pezzuti affronta in 268 pagine e 19 capitoli tutte le singole accuse mettendo insieme intercettazioni, testimonianze e accertamenti bancari. E individua proprio nella legge il principale alleato dell’oggetto dell’inchiesta: nel 2001, per snellire i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, il governo decise che il general contractor era anche il direttore dei lavori. L’inchiesta prende il nome “Sistema” dalla Green Field System srl, società affidataria di numerosi dietro la quale ci sarebbero lo steso Incalza e il costruttore Stefano Perotti. Il “modus operandi” è fondato, scrive il gip, sui “reciproci rapporti di interesse illecito” tra gli indagati. Le società consortili aggiudicatarie degli appalti delle Grandi Opere sarebbero state indotte da Ercole Incalza - capo della struttura di missione competente sulle Grandi Opere - a conferire all'imprenditore Stefano Perotti, o a professionisti e società a lui riconducibili, incarichi di progettazione e direzione di lavori “garantendo di fatto il superamento degli ostacoli burocratico-amministrativi”. In cambio Perotti avrebbe assicurato l'affidamento di incarichi di consulenza o tecnici a soggetti indicati dallo stesso Incalza, destinatario di incarichi “lautamente retribuiti” conferiti dalla Green Field System srl, società affidataria di direzioni lavori. A Francesco Cavallo, sempre secondo l'accusa, veniva riconosciuto da parte di Perotti, tramite società a lui riferibili, una retribuzione mensile di circa 7.000 euro “come compenso per la sua illecita mediazione”. Perotti, responsabile della società Ingegneria Spm e “figura centrale dell'indagine”, sono stati affidati da diverse società incarichi di direzione lavori per la realizzazione di numerose "Grandi Opere", ferroviarie e autostradali. Tra queste figurano l’Alta velocità Milano-Verona, il nodo Tav di Firenze per il sotto attraversamento della città; l’alta velocità Firenze Bologna, la Genova-Milano, il Terzo Valico di Giovi, l'autostrada Civitavecchia-Orte-Mestre, l'autostrada Reggiolo Rolo-Ferrara, l’autostrada Eas Ejdyer-Emssad in Libia, il nuovo terminal del porto di Olbia. Perotti avrebbe anche “influito” illecitamente sull’aggiudicazione dei lavori di realizzazione del cosiddetto Palazzo Italia Expo 2015. La commessa del valore di oltre 25 milioni di euro sarebbe stata pilotata grazie agli stretti rapporti tra Perotti e l'allora manager di Expo 2015 spa Antonio Acerbo, finito ai domiciliari in ottobre. In generale l’inchiesta documenta le relazioni instaurate da Perotti con funzionari delle stazioni appaltanti interessate alle opere in questione, “indotti – si legge nell’ordinanza - ad inserire specifiche clausole nei bandi finalizzate a determinarne l'aggiudicazione”. Il valore degli appalti affidati a Perotti si aggira sui 25 miliardi (anche la Metro C di Roma). I costi sono lievitati anche del 40 per cento. Ognuno dei 19 capitoli dell’ordinanza ricostruisce l’affidamento di un appalto e la rete di favori e pressioni. Ed è arricchito e supportato da intercettazioni telefoniche. Illuminante per capire il ruolo e il potere di Incalza sono le parole di Giovanni Gaspari, alto dirigente delle Ferrovie dello Stato e consigliere presso il ministero delle Infrastrutture. “Ercolino...è lui che decide i nomi...fa il bello e il cattivo tempo ormai là dentro...è il dominus totale” dice il 25 novembre del 2013. Dall’altra parte del telefono c’è Giulio Burchi, allora presidente di Italferr Spa e indagato nell'inchiesta di Firenze sulle Grandi Opere. “Come emerge dalle indagini - si legge nell'ordinanza - Incalza dirige con attenzione ogni grande opera, controllandone l'evoluzione in ogni passaggio formale: è lui che predispone le bozze della legge obiettivo, e' lui che, di anno in anno, individua le grandi opere da finanziare e sceglie quali bloccare e quali mandare avanti, da lui gli appaltatori non possono prescindere”. E senza il suo intervento, dice Gaspari a Burchi, “al 100% non si muove una foglia, fa sempre tutto lui”. Il bando di gara per l'incarico di collaborazione temporanea al ministero, poi vinto da Incalza, Gaspari sostiene che quel bando “naturalmente si adatta solo ad Ercolino”. Tra i requisiti c’è che l’incaricato deve aver fatto il capo della struttura tecnica di missione per 10 anni. “Cioè – osserva Gaspari - solo Incalza. Vabbè...non l'hanno capito che la gente si sta scocciando di tutte queste porcate e prima o poi farà casino”. Alla fine di una lunga trattativa per sbloccare uno dei lavori, Perotti commenta: “Finalmente la chiesa è tornata al centro del villaggio”. Il gip spiega che si tratta di un proverbio francese che sta a significare “rimettere le cose al loro posto”. Gli investigatori mettono in evidenza il legame tra Sandro Pacella ed Ercole Incalza dove il primo “funge da segretario, mediatore e consulente del secondo”. Sono indispensabili l’uno all’altro. Ed entrambi si preoccupano molto a giugno 2014 quando il decreto madia sulla Pubblica amministrazione stabilisce che non è più possibile restare nella pubblica amministrazione, neppure con incarichi di consulenza, dopo la pensione. Dice Pacella a Incalza: “ Stai lavorando, no? Che cazzo stai a fare, hai visto la norma che hanno fatto? Chi è in pensione non potrà più lavorare ottenendo incarichi dirigenziali o di consulenza per le pubbliche amministrazioni. Questi figli di mignotta stavano ad aspettare apposta perche cosi una volta approvato manco ti danno lo stipendio di quest'anno. Siamo sulla strada…”. Incalza saprà lavorare. E saprà trovare il modo per restare come consulente. Sono quelle ricevute – o capitate – a Luca Lupi, il figlio del ministro che pure, come sottolinea il padre, “è laureato con 110 e lode al Politecnico di Milano e forse non avrebbe bisogno di tante raccomandazioni”. In questo caso è meglio far parlare direttamente il gip. “Effettivamente – scrive - Stefano Perotti ha procurato degli incarichi di lavoro a Luca Lupi”. Il 21 ottobre 2014, uno degli indagati, Giulio Burchi, racconta al telefono al dirigente Anas, ing. Massimo Averardi, che Stefano Perotti ha assunto il figlio del ministro Maurizio Lupi. “Ho visto Perotti l'altro giorno - dice Burchi al telefono - tu sai che lui e il ministro sono più che intimi perché gli ha assunto anche il figlio, per star sicuro che non mancasse qualche incarico di direzione lavori, siccome ne ha soli 17, glieli hanno contati, ha assunto anche il figlio di Lupi”. Il primo luglio, sempre Burchi a Averardi: “Ha vinto anche la gara, che ha fatto un ribasso pazzesco, ha vinto anche il nuovo palazzo dell'Eni a San Donato e c'ha quattro giovani ingegneri e sai uno come si chiama? Sai di cognome come si chiama? Un giovane ingegnere neolaureato, Lupi, ma guarda i casi della vita”. Il gip spiega che “nell'ambito della commessa Eni, Perotti stipulerà un contratto con Giorgio Mor, affidandogli l'incarico di coordinatore del lavoro che, a sua volta, nominerà Luca Lupi” per 2 mila euro al mese. Il ministro Lupi corregge e dice che sono “1.300”. Luca Lupi sarebbe destinatario anche di un Rolex dal valore di circa 10mila euro come regalo di laurea della famiglia Perotti. Qualche cosina sarebbe scappata fuori anche per il babbo, ad esempio un vestito sartoriale, regalo, questa volta, di Franco Cavallo (uno dei quattro arrestati). Abiti di sartoria anche per E.F. membro della segreteria del ministro. In qualche telefonata Perotti e Mor si preoccupano circa l’opportunità di aver assunto il figlio del ministro. Il gip scrive che “la preoccupazione di Stefano Perotti e Giorgio Mor non è comprensibile al di fuori di uno scenario illecito. Nulla può impedire a costoro di assumere le persone che vogliono” salvo che la collaborazione “possa essere immaginata quale corrispettivo di qualche utilità fornita da Maurizio Lupi per il tramite di Ettore Incalza”. Incalza suggeritore di Ncd? II legame tra Ercole Incalza e Maurizio Lupi ed in generale con il Nuovo Centro Destra risulta evidente nel messaggio e nella telefonata che il primo ha con una tal Daniela che adopera un telefono intestato al Ministero delle Infrastrutture. In queste telefonate Incalza afferma di “aver trascorso la notte a redigere il programma di governo che Ncd avrebbe dovuto presentare e di essere in attesa del benestare di Angelino Alfano e di Maurizio Lupi”. Nell’ordinanza si segnala che “questa Daniela potrebbe essere la stessa persona che il 7 febbraio 2014 ha inviato un sms ad Ercole Incalza avvisandolo del ritorno di un tal Carlea “quello cattivo” che “ha detto che te la farà pagare a te e ad Aiello!!”. Daniela suggerisce ad Ercole Incalza di allearsi con Aiello. Illuminante dei rapporti tra Ercole Incalza e Maurizio Lupi è la telefonata del 17 febbraio 2014 in cui il ministro si lamenta di essere stato “abbandonato” e il super-dirigente lo contesta dicendo: “Ma se ti ho pure scritto il programma”. Il 28 febbraio 2014, sempre al telefono, Lupi ricorda ad Incalza di aver nominato Nencini solo per la “tua sponsorizzazione” e lo prega di invitarlo a “non rompere i c…..”. In altre telefonate Incalza sottolinea come al ministero siano arrivati “due suoi amici socialisti: Umberto Del Basso De Caro e Riccardo Nencini”. Nencini bolla queste parole come “millantato credito”. Anche perché il 17 febbraio il governo Letta non era neppure caduto. Nella segreteria del viceministro Riccardo Nencini lavora Massimo Romolini, ispettore della Guardia di finanza una volta in servizio presso la procura. Il 6 agosto 2014 lo chiama al telefono Sandro Pacella per avere informazioni circa “quella cosa in procura”. Romolini lo rinvia al giorno dopo. Quando lo incontrerà in ufficio.
Grandi opere, tangenti e favori. «Se ti cacciano cade il governo». Il legame tra Lupi e il manager. L’imprenditore Perotti racconta al cognato di aver trovato un lavoro al figlio del ministro. Pressione per le nomine degli emendamenti, scrive Fiorenza Sarzanini su “Il Corriere della Sera”. Il loro legame era talmente stretto che il 2 luglio scorso, quando ha dovuto rispondere alle interrogazioni parlamentari, il ministro Maurizio Lupi si è fatto scrivere il discorso dal difensore di Ercole Incalza, l’avvocato Titta Madia. E pur di difendere il ruolo di quel manager ormai in pensione, ha minacciato addirittura di far cadere il governo. Perché in realtà era proprio Incalza il vero potente, capace di guidare le scelte di politici e imprenditori, di condizionare le scelte degli uomini di governo pronti a correre in suo soccorso quando era in pericolo la riconferma come dirigente della Struttura tecnica di missione, cabina di regia di tutte le grandi opere, dalla Tav all’Expo passando per la Metro C di Roma, quella di Milano e i grandi tratti autostradali, compresa la Salerno-Reggio Calabria. Nel computer conservava una lettera spedita nel 2004 a Silvio Berlusconi per chiarirgli i motivi della nomina a Provveditore di Angelo Balducci, a riprova dell’esistenza di una «rete» clientelare che dura da oltre dieci anni. E gli avrebbe permesso di ottenere tangenti da centinaia di migliaia di euro, oltre all’assunzione di figli e parenti degli amici, primo fra tutti proprio il rampollo di Lupi, Luca, beneficiato con un incarico all’Eni da 2.000 euro al mese. Il ministro non aveva evidentemente bisogno di chiedere: arrivavano abiti di sartoria, un Rolex da 10.000 euro per la laurea del ragazzo, fine settimana nella splendida dimora fiorentina di quello Stefano Perotti diventato l’alter ego di Incalza e ora come lui finito in carcere. Sono le indagini dei carabinieri del Ros guidati dal generale Mario Parente a svelare i retroscena degli appalti assegnati negli ultimi anni. Comprese le assunzioni di altri parenti «eccellenti»: il figlio dell’ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, quello dell’ex parlamentare Angelo Sanza, il nipote di monsignor Francesco Gioia. Lupi è certamente uno dei maggiori sponsor e lo dimostra a fine dicembre quando si fa aspro lo scontro nel governo sulla gestione dei Lavori pubblici. Scrive il giudice nell’ordinanza di cattura: «La sera del 16 dicembre il ministro Lupi chiama l’ingegner Incalza e rivendica il merito di aver bloccato l’emendamento con la richiesta di trasferire la Struttura tecnica di missione alle dipendenze della presidenza del Consiglio dei ministri: “L’altra cosa che mi dispiace e ne parlerò con la Ida domani, è questa roba per cui è evidente che... cioè ancora continuare a dire che nessuno ha difeso la Struttura tecnica di missione mi fa girare molto i c... eh! scusami, perché se non l’avessi detta io, se non fossi intervenuto io, lasciate stare il Pd che la vuole trasferire, non entrava nell’emendamento governativo questa cosa qui”. Il ministro Lupi intende difendere a qualsiasi costo la Struttura fino a minacciare una crisi di governo: “Vado io guarda, siccome su questa cosa, te lo dico già. Però io non voglio, cioè vorrei che tu dicessi a chi lavora con te che sennò vanno a c...! Ho capito! Ma non possono dire altre robe! Su questa roba ci sarò io lì e ti garantisco che se viene abolita la Struttura non c’è più il governo! L’hai capito, l’hanno capito?!”». Incalza dispensa favori proprio grazie a Perotti. E così «sistema» Luca Lupi. Il 30 gennaio 2014 «Perotti informa il cognato Giorgio Mor che è riuscito a convincere i dirigenti Eni per avviare l’attività di progettazione loro affidata, gli prospetta che ha il “bisogno” di dover impiegare proprio per questa attività un “ragazzo” che verrà pagato dallo stesso Stefano Perotti: “È un ragazzo che vale molto, l’ho visto, l’ho conosciuto”. Il “ragazzo” è Luca Lupi». Annota il giudice: «Va rimarcato che il 21 febbraio 2014 Philippe Perotti, figlio di Stefano Perotti, come misura di precauzione in seguito alla pubblicazione di un articolo, invia al padre Stefano un messaggio, richiedendo di valutare l’opportunità di allontanare Luca Lupi dal cantiere Eni, e di adottare le dovute cautele nelle comunicazioni sia telefoniche che per posta elettronica: “Bisogna pensare a tirar fuori Luca da Eni. Evitiamo il problema”». Nella primavera scorsa è Franco Cavallo, collaboratore di Perotti, a saldare gli abiti ordinati dal ministro e da suo figlio, mentre il manager regala al ragazzo il prezioso orologio. Perotti e Lupi sono evidentemente amici di famiglia. Annota il giudice: «Il 14 settembre 2013, il ministro Lupi avvisa Perotti che stanno per arrivare per la cena: “Noi dovremmo essere lì verso le 8 e mezza”. Due giorni dopo Christine Mor (moglie di Perotti) racconta alla sorella che ha avuto degli ospiti a cena nel weekend: “Tutto a posto, finalmente sono andati via, anche se è stato bello però molto impegnativo. Erano in 8 con due guardie del corpo, quindi hanno mangiato da venerdì, c’era Maurizio con sua moglie, c’era Frank con la moglie, c’era Toccafondi con la moglie, i primi quattro hanno dormito in casa...». In realtà Lupi non è l’unico a difendere la struttura e soprattutto Incalza. L’inchiesta condotta dai pm di Firenze coordinati dal procuratore Giuseppe Creazzo svela i nomi degli altri. Il 19 febbraio 2014 Giovanni Gaspari, nipote del dc Remo, consigliere presso il ministero delle Infrastrutture, parla con il manager Giulio Burchi e commenta la conferma di Incalza. Gaspari :
«È veramente una cosa, una schifezza tale che non ne posso più, mi viene anche a me da vomitare. Si sono scatenati tutti alla difesa di Incalza oggi, sono passati da Alfano a Schifani, ai general contractor».
Burchi : «Beato Perotti che prende tutte le direzioni dei lavori d’Italia».
Gaspari : «Si, si, Perotti si prenderà tutto».
In realtà a parlare dei propri rapporti con il ministro dell’Interno Angelino Alfano è lo stesso Incalza al telefono con un’amica alla quale racconta «di aver trascorso la notte a redigere il programma di governo che il Nuovo centrodestra avrebbe dovuto presentare e di essere in attesa del benestare di Alfano e di Lupi».
Incalza parla con i ministri e tratta con i sottosegretari. A leggere le intercettazioni si comprende che è in grado di orientare le loro scelte politiche. «Altro esempio dell’influenza che Ercole Incalza sembra avere sulle decisioni del ministro - scrive il giudice - si trae il 28 febbraio 2014 quando Maurizio Lupi ha telefonato al primo e lo ha informato che, in seguito alla “sponsorizzazione” di quest’ultimo, avevano nominato viceministro per le Infrastrutture il senatore Riccardo Nencini: “Dopo che tu hai dato, hai coperto, hai dato la sponsorizzazione per Nencini l’abbiamo fatto viceministro alle Infrastrutture”. Lupi invita quindi Incalza a parlargli per dirgli “che non rompa i c...!”. Nel corso di successive telefonate Incalza fa presente che al ministero per le Infrastrutture sono arrivati due sue compagni socialisti facendo riferimento a Nencini e Umberto Del Basso De Caro. Il suo amico commenta le nomine: “Complimenti, sempre più coperto”. Effettivamente Del Basso De Caro si spende molto per farlo riconfermare». E ottiene vantaggi.
«Il 20 ottobre 2014 Incalza gli segnala che non è stato presentato un emendamento che riguarda la Struttura. Del Basso assicura che provvederà subito a far presentare l’emendamento dall’onorevole Enza Bruno Bossio. Un’ora dopo manda un sms e conferma l’avvenuto deposito». La norma in realtà viene bocciata ma la sua collaboratrice rassicura Incalza «perché sarà riproposto nella legge di Stabilità presentata direttamente dal governo avendo Del Basso già parlato con il ministro Lupi». Due giorni dopo Del Basso manda un sms a Incalza e «chiede aiuto perché un emendamento relativo a un’opera di suo interesse non è passato: “Mi affido, come sempre, al tuo senso di responsabilità e alla tua esperienza della quale ho assoluto bisogno per realizzare l’opera”».
Tangenti, arrestato Ercole Incalza: dirigente dei Lavori pubblici per sette governi. Inchiesta della procura di Firenze su appalti di Grandi Opere e Tav. Blitz dei Ros: in manette anche gli imprenditori Stefano Perotti e Francesco Cavallo, e il collaboratore di Incalza Sandro Pacella. 51 indagati, anche politici. Nelle carte presunti favori al figlio di Lupi e regali. Il ministro: "Mai chiesto nulla". Le intercettazioni: "Ercolino fa il bello e il cattivo tempo", scrivono Franca Selvatici e Gerardo Adinolfi su “La Repubblica”. Corruzione, induzione indebita, turbativa d'asta e altri delitti contro la pubblica amministrazione: sono alcune delle accuse che hanno portato all'arresto dell'ex super-dirigente del ministero dei Lavori pubblici Ercole Incalza, uno dei quattro arrestati nell'inchiesta condotta dal Ros e dai pm fiorentini Giuseppina Mione, Luca Turco e Giulio Monferini. In tutto gli indagati sono 51. Gli altri tre finiti in manette sono gli imprenditori Stefano Perotti e Francesco Cavallo, nonché Sandro Pacella, collaboratore di Incalza. Nel mirino dell'inchiesta la gestione illecita degli appalti delle grandi opere, in quello che i magistrati definiscono un "articolato sistema corruttivo che coinvolgeva dirigenti pubblici, società aggiudicatarie degli appalti ed imprese esecutrici dei lavori". L'inchiesta nasce dagli appalti per l'Alta velocità nel nodo fiorentino e per la costruzione del sotto-attraversamento della città. Da lì l'indagine si è allargata a tutte le più importanti tratte dell'Alta velocità del centro-nord Italia e a una lunga serie di appalti relativi ad altre Grandi Opere, compresi alcuni che riguardano l'Expo. "Il Gip non ha ritenuto che sussistessero gli elementi di gravità per contestare l'associazione per delinquere e l'ha rigettata", ha precisato poi il procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo. Il comandante del Ros, Mario Parente, ha parlato di costi di opere pubbliche che "lievitavano anche del 40 per cento". Creazzo ha inoltre reso noto che "il totale degli appalti affidati a società legate a Perotti è di 25 miliardi di euro". Nel mirino della procura i cantieri della linea ferroviaria Av Milano-Verona e Genova-Milano, l'autostrada Civitavecchia-Orte-Mestre e l'autostrada regionale Cispadana. E ancora l'hub portuale di Trieste, l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e l'autostrada in Libia Ras Ejdyer-Emssad.
CHI E' INCALZA. Il principale indagato dell'inchiesta, denominata Sistema, è proprio Ercole Incalza. "Ercolino, che fa il bello e il cattivo tempo", come lo descrive un alto dirigente delle Ferrovie dello Stato, da oltre trent'anni figura di primissimo piano nell'ambito del ministero dei Lavori Pubblici, passato per sette diversi governi, fino all'esecutivo Renzi. Ma lo stesso ministero precisa che dallo scorso dicembre non ha più alcun incarico, neppure a titolo gratuito. "Come emerge dalle indagini - si legge nell'ordinanza - Incalza dirige con attenzione ogni grande opera, controllandone l'evoluzione in ogni passaggio formale: è lui che predispone le bozze della legge obiettivo, è lui che, di anno in anno, individua le grandi opere da finanziare e sceglie quali bloccare e quali mandare avanti, da lui gli appaltatori non possono prescindere". E senza il suo intervento, dice Giovanni Paolo Gaspari, già alto dirigente del Gruppo ferrovie dello Stato e consigliere presso il ministero delle Infrastrutture, al telefono con Giulio Burchi, già presidente di Italferr spa, "al 100% non si muove una foglia... si sempre tutto lui fa... tutto tutto tutto!... ti posso garantire... ho parlato con degli amici..". Ma aggiungono anche: "Vabbè...ma non l'hanno capito che la gente si sta scocciando di tutte queste porcate e prima o poi farà casino?".
I POLITICI INDAGATI. Fra gli indagati anche politici già sottosegretari come Vito Bonsignore, ex Forza Italia e Ncd, e Antonio Bargone, Pd ed ex sottosegretario ai lavori pubblici nei governi Prodi e D'Alema, in relazione alla promessa della direzione lavori all'ingegnere Stefano Perotti da parte della sociatà consortile Ilia Orme che proponeva il project financing per la realizzazione dell'autostrada Civitavecchia-Orte-Mestre. Tra i politici coinvolti anche Stefano Saglia, ex Pdl e Ncd ed ex sottosegretario al ministero per lo Sviluppo economico, indagato per turbativa d'asta in relazione al bando di gara emessa dall'autorità portuale di Trieste per il collaudo della Hub portuale di Trieste in cui compare anche il nome di Rocco Girlanda, ex Pdl.
IL MINISTRO LUPI E IL FIGLIO LUCA. Nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Firenze compare anche Luca Lupi, figlio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi, entrambi non indagati "Effettivamente, Stefano Perotti", l'imprenditore arrestato, "ha procurato degli incarichi di lavoro a Luca Lupi", dice il magistrato. Il gip annota che il 21 ottobre 2014, uno degli indagati, Giulio Burchi, "racconta anche al dirigente Anas, ingegner Massimo Averardi, che Stefano Perotti ha assunto il figlio del ministro Maurizio Lupi". Segue l'intercettazione: "Ho visto Perotti l'altro giorno, tu sai che Perotti e il ministro sono non intimi, di più. Perché lui ha assunto anche il figlio, per star sicuro che non mancasse qualche incarico di direzione lavori, siccome ne ha soli 17, glieli hanno contati, ha assunto anche il figlio di Lupi, no?". Poi, il primo luglio 2014, sempre Burchi a Averardi: "il nostro Perottubus ha vinto anche la gara, che ha fatto un ribasso pazzesco", ha vinto "anche il nuovo palazzo dell'Eni a San Donato e c'ha quattro giovani ingegneri e sai uno come si chiama? Sai di cognome come si chiama? Un giovane ingegnere neolaureato, Lupi, ma guarda i casi della vita". "Perotti - continua il gip - nell'ambito della commessa Eni, stipulerà un contratto con Giorgio Mor, affidandogli l'incarico di coordinatore del lavoro che, a sua volta, nominerà quale 'persona fissa in cantiere' Luca Lupi" per 2 mila euro al mese. Replica però il ministro: "Non ho mai chiesto all'ingegner Perotti né a chicchessia di far lavorare mio figlio. Non è nel mio costume e sarebbe un comportamento che riterrei profondamente sbagliato".
I REGALI. Nell'ordinanza si parla anche di regali che gli arrestati avrebbero fatto al ministro e ai suoi familiari: un vestito sartoriale a Lupi e un Rolex da 10mila euro al figlio, in occasione della laurea. A regalare il vestito al ministro sarebbe stato Franco Cavallo, uno dei quattro arrestati oggi che secondo gli inquirenti aveva uno "stretto legame" con Lupi tanto da dare "favori al ministro e ai suoi familiari". "Da una telefonata del 22 febbraio 2014 - si legge nell'ordinanza - emerge che Vincenzo Barbato", un sarto che avrebbe confezionato un abito per Emanuele Forlani, della segreteria del ministero, "sta confezionando un vestito anche per il ministro Lupi". Tra le pagine dell'ordinanza spuntano anche le intercettazioni delle conversazioni di Lupi con Incalza. "Su questa roba ci sarò io lì e ti garantisco che se viene abolita la Struttura tecnica di missione non c'è più il governo!..", dice in una conversazione telefonica il ministro all'ingegnere ora in arresto. "L'importanza della Struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture - scrive il Gip - è ben rappresentata" nel colloquio: "Il ministro Lupi, infatti, a fronte della proposta di soppressione di tale struttura o di passaggio della stessa sotto la direzione della presidenza del Consiglio arriva a minacciare una crisi di governo". Tra i luoghi perquisiti - oltre ad uffici della Rete Ferroviaria Italiana Spa e dell'Anas International Enterprises - anche ambienti della Struttura di Missione presso il ministero delle Infrastrutture, delle Ferrovie del Sud Est srl, del consorzio Autostrada Civitavecchia-Orte-Mestre, dell'autostrada regionale Cispadana spa e dell'Autorità portuale Nord Sardegna. Alcune perquisizioni sono state svolte con il concorso di personale dell'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti di competenza in materia fiscale. L'esecuzione dei provvedimenti ha interessato le province di Roma, Milano, Firenze, Bologna, Genova, Torino, Padova, Brescia, Perugia, Bari, Modena, Ravenna, Crotone e Olbia. Sono passati 731 giorni da quando il presidente del Senato Grasso ha presentato il suo disegno di legge, uno strumento utile per fermare la corruzione", dice il procuratore antimafia Franco Roberti commentando gli arresti. "Bisognerebbe approvare la legge sulla corruzione nella versione, a mio avviso, proposta dal presidente del Senato Grasso, e poi probabilmente bisognerebbe intervenire anche sulla cosiddetta legge Obiettivo del 2001. Adesso - ha spiegato - è presto per definire i cordoni di questo eventuale intervento ma probabilmente qualcosa bisogna rivedere anche in quella legge". Proprio oggi, in commissione il governo ha presentato il proprio emendamento alla legge anti-corruzione che dovrebbe arrivare in aula la settimana prossima.
Caso Incalza, le intercettazioni: «Ercolino è il dominus totale». Dalle telefonate registrate la rete di rapporti intorno a Incalza e agli altri indagati. Compare anche il ministro Lupi, che minaccia la crisi di governo «se viene abolita la struttura» dello stesso Incalza, e che avrebbe ricevuto favori per il figlio Luca, scrive “Il Corriere della Sera”. «...su questa roba ci sarò io e ti garantisco che se viene abolita la Struttura Tecnica di Missione non c’è più il governo!»: con queste parole il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi si rivolge il 16 dicembre 2014 ad Ercole Incalza in una telefonata intercettata dal Ros nell’ambito dell’inchiesta di Firenze. Secondo gli inquirenti la conversazione «ben rappresenta» l’importanza della Struttura tecnica del dicastero delle Infrastrutture di cui era a capo Incalza e che opera - almeno secondo l’organigramma - alle dirette dipendenze del ministro. Maurizio Lupi è anche citato nelle intercettazioni dell’inchiesta in relazione ad alcuni favori avuti per il figlio Luca da Stefano Perrotti, uni degli arrestati. Secondo Lupi, Incalza «era ed è una delle figure tecniche più autorevoli che il nostro Paese abbia sia da un punto di vista dell’esperienza tecnica nazionale che della competenza internazionale, che gli è riconosciuta in tutti i livelli». Il viceministro alle Infrastrutture Riccardo Nencini sarebbe stato nominato grazie alla «sponsorizzazione» di Incalza. È quanto emerge da una telefonata tra Lupi e lo stesso Incalza. La telefonata è del 28 febbraio 2014 e a chiamare è Lupi: «Dopo che tu hai dato...hai coperto...hai dato la sponsorizzazione per Nencini...l’abbiamo fatto viceministro». Maurizio Lupi è chiamato in causa anche per altre telefonate. «Il ministro - si legge nell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Incalza e di altri tre indagati - a fronte della proposta di soppressione» della Struttura di Missione «o di passaggio della stessa sotto la direzione della presidenza del Consiglio arriva a minacciare una crisi di governo». Nel provvedimento viene quindi riportato un brano della conversazione intercettata. Dice Lupi: «...vado io guarda... siccome su questa cosa...te lo dico già...però io non voglio...cioè vorrei che tu dicessi a chi lavora con te che senno’ vanno a cagare!...cazzo!...ho capito!... ma non possono dire altre robe!... su questa roba ci sarò io li e ti garantisco che se viene abolita la Struttura Tecnica di Missione non c’è più il governo!...l’hai capito non l’hanno capito?!». «Effettivamente, Stefano Perotti», l’imprenditore arrestato, «ha procurato degli incarichi di lavoro a Luca Lupi»: è quanto si legge nell’ordinanza del Gip. Secondo quanto riportato, uno degli indagati, Giulio Burchi, «racconta anche al dirigente Anas, ingegner Massimo Averardi, che Stefano Perotti ha assunto il figlio del ministro Maurizio Lupi». Segue l’intercettazione: «Ho visto Perotti l’altro giorno, tu sai che Perotti e il ministro sono non intimi, di più. Perché lui ha assunto anche il figlio, per star sicuro che non mancasse qualche incarico di direzione lavori, siccome ne ha soli 17, glieli hanno contati, ha assunto anche il figlio di Lupi, no?». Poi, il primo luglio 2014, sempre Burchi a Averardi: «Il nostro Perottubus ha vinto anche la gara, che ha fatto un ribasso pazzesco», ha vinto «anche il nuovo palazzo dell’Eni a San Donato e c’ha quattro giovani ingegneri e sai uno come si chiama? Sai di cognome come si chiama? Un giovane ingegnere neolaureato, Lupi, ma guarda i casi della vita». «Perotti - continua il Gip - nell’ambito della commessa Eni, stipulerà un contratto con Giorgio Mor, affidandogli l’incarico di coordinatore del lavoro che, a sua volta, nominerà quale persona fissa in cantiere Luca Lupi» per 2 mila euro al mese. «Ercolino...è lui che decide i nomi...fa il bello e il cattivo tempo ormai là dentro...o dominus totale». Così un alto dirigente delle Ferrovie dello Stato e consigliere presso il ministero delle Infrastrutture, Giovanni Paolo Gaspari, descrive Ercole Incalza in una telefonata intercettata dal Ros il 25 novembre del 2013. Al telefono con Gaspari c’è Giulio Burchi, allora presidente di Italferr Spa e indagato nell’inchiesta di Firenze sulle Grandi Opere. «Senza l’intervento di Ercolino, dice Gaspari al telefono con Burchi, «al 100% non si muove una foglia...si sempre tutto lui fa...tutto tutto tutto!...ti posso garantire...ho parlato con degli amici..» Anche parlando del bando di gara per l’incarico di collaborazione temporanea, poi vinto da Incalza, Gaspari sostiene che quel bando «naturalmente si adatta solo ad Ercolino. Cioè deve aver fatto il capo della struttura tecnica di missione per 10 anni senno’ non può concorrere a fare il capo della struttura tecnica...hai capito?». E poi conclude: «Vabbè...non l’hanno capito che la gente si sta scocciando di tutte queste porcate e prima o poi farà casino». Nelle intercettazioni si parla anche di Expo. In una telefonata registrata e agli atti dell’inchiesta, Stefanno Perotti riferisce ad un professionista, l’architetto Marco Visconti, delle «entrature» tra i responsabili dell’iniziativa milanese: «Sappia che in quel tipo di cliente abbiamo delle relazioni molto elevate quindi... abbiamo recentemente vinto la gara per il Palazzo Italia con Italiana Costruzioni... quindi siamo un supporto di ingegneria per questa attività e abbiamo relazioni anche assolutamente trasparenti ma di grande stabilità con l’amministratore delegato, direttore generale e commissario...».
Il "Sistema" grandi opere tra vendette, favori e tangenti. Dalla Tav a Expo, blitz dei pm di Firenze: costi lievitati del 40%, giro da 25 miliardi. Le intercettazioni contro Incalza: "Ercolino è il dominus, fa il bello e cattivo tempo", scrivono Massimo Malpica Patricia Tagliaferri su “Il Giornale”. Appalti pubblici e grandi opere ancora nel mirino della magistratura. Un blitz del Ros disposto dalla procura di Firenze ieri ha fatto scattare le manette ai polsi di Ercole Incalza, grande burocrate del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha attraversato sette governi nell'arco di tre lustri, fino al dicembre 2014 capo della struttura tecnica di missione del dicastero. Oltre a Incalza, l'ordinanza del gip fiorentino Angelo Antonio Pezzuti spedisce dietro le sbarre Sandro Pacella, funzionario dello stesso ministero e stretto collaboratore di Incalza, l'imprenditore Stefano Perotti e Francesco Cavallo, presidente del cda di Centostazioni, spa del gruppo Fs. Gli indagati sono in tutto 51, tra loro anche gli ex sottosegretari alle Infrastrutture Rocco Girlanda (Pdl) e Antonio Bargone (Pds), l'ex sottosegretario allo sviluppo Economico Stefano Saglia e l'ex europarlamentare Vito Bonsignore, gli ultimi due ora nel Ncd. Ma nella bufera finisce anche il ministro Maurizio Lupi (Ncd), del quale l'ordinanza sottolinea la vicinanza con alcuni degli indagati. E il cui figlio avrebbe ricevuto un incarico di lavoro con una «triangolazione» organizzata da Perotti. Secondo la procura - che ipotizza tra i vari reati la corruzione, l'induzione indebita e la turbata libertà degli incanti - quello colpito dal blitz era «un articolato sistema corruttivo» il cui dominus era Incalza, attivo nella gestione illecita di appalti di «grandi opere», soprattutto su ferrovie, industrie e strade, facendo lievitare i costi anche del 40%. Un sistema collaudato, che «coinvolgeva dirigenti pubblici, società aggiudicatarie degli appalti e imprese esecutrici dei lavori», e che muoveva cifre importanti. Secondo il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, infatti, «si indaga su un valore di 25 miliardi di euro di appalti». «Ercole Incalza (...) - scrive il gip nell'ordinanza - è stato in grado e lo è tuttora di condizionare il settore degli appalti pubblici da moltissimi anni». È lui «che suggerisce al general contractor o all'appaltatore il nome del direttore dei lavori, cioè di soggetti sempre riferibili a Stefano Perotti (l'altro arrestato, ndr )», è ancora lui «che si mette a disposizione dell'impresa, svendendo la sua funzione ed assicurando, in violazione dei doveri di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, un trattamento di favore». L'ex alto dirigente delle Fs Giovanni Paolo Gaspari, nipote dell'ex ministro Remo, intercettato mentre parla con l'ex presidente Italferr Giulio Burchi a novembre 2013, rivela i «poteri» di Incalza. «Ercolino... è lui che decide i nomi (...) tra tutti i suoi, sì, sì ancora... fa il bello e il cattivo tempo ormai là dentro, il dominus totale, al 100 per cento, non si muove foglia, sì... sempre tutto lui fa». L'8 giugno 2014 Incalza è «particolarmente infastidito», annotano gli inquirenti, per un'intervista al Fatto quotidiano in cui Francesco Boccia caldeggia un ricambio di una «certa alta burocrazia ministeriale», riferendosi evidentemente al manager. Intercettato, Incalza sbotta con qualcuno che gli sta vicino: «Chiamiamo... avvisiamo D'Alema». E la sera, al collaboratore Pacella spiega, a proposito dell'articolo: «Mi devo vedere con Lupi assolutamente… questa cosa è molto seria». Giulio Burchi, che è indagato, viene spesso intercettato mentre manifesta la sua malsopportazione dello strapotere di Incalza e dell'asse tra questi e Perotti. In un'occasione ipotizza di fargli fare un'interpellanza parlamentare contro, «c'ho due o tre episodi circostanziati ... prendo Pippo Civati che mi rompe sempre i coglioni così gli faccio fare una cosa utile». Poi cerca di incontrare «il viceministro alle Infrastrutture Riccardo Nencini, in quanto lo vuole mettere in guardia su quello che avviene all'interno del Ministero da trent'anni sotto il controllo di Incalza». Infine accenna a un «dossier» su Incalza che avrebbe preparato «per la Serracchiani». Ma alla fine, quasi giustifica il «sistema»: «pensiamoci ... forse si sta bene solo in questo Paese qua (...) i soldi che ho guadagnato a stare in questo Paese di merda deregolarizzato ... non li avrei mai guadagnati in Inghilterra o in America». Saltano fuori anche i rapporti tra l'imprenditore Pierotti e monsignor Francesco Gioia, col prelato che secondo l'ordinanza si sarebbe anche attivato a ottobre 2013 per «dare una mano» ad alcuni imprenditori perché lavorassero all'appalto del «Palazzo Italia» dell'Expo di Milano. Inoltre Pierotti avrebbe assunto un nipote del prelato, e - scrive il gip - da una conversazione tra i due «si rileva che l'assunzione è avvenuta grazie all'interessamento del ministro Lupi ("ti volevo dire che ieri ho visto Maurizio … gli ho detto che tu lo ringrazi moltissimo") e di Luigi Fiorillo, presidente del cda della società Ferrovie del Sud Est». Il gip scrive che «il legame tra Ercole Incalza e Maurizio Lupi e in generale con il Nuovo Centro Destra» sarebbe «evidente» per lo scambio di sms e telefonate tra il manager e una certa Daniela, alla quale Incalza «afferma di aver trascorso la notte a redigere il programma di governo che l'Ncd avrebbe dovuto presentare e di essere in attesa del benestare di Angelino Alfano e di Maurizio Lupi». Per il gip la «migliore sintesi» della figura di Stefano Perotti, che avrebbe tra l'altro «influito illecitamente sulla aggiudicazione dei lavori di realizzazione del cosiddetto Palazzo Italia Expo», emerge da un'intercettazione tra la moglie Christine e il figlio Philippe, che non si sente all'altezza del padre. La donna lo consola e gli spiega che «a 25 aveva appena appena iniziato a lavorare, come te, uguale, e non aveva fatto un cazzo nella vita... (...) perché che tu ti devi paragonare con i soldi che fa papà è questo che sbagli Philo, perché papà oltretutto se guadagna bene e tanto è anche perché ci sono state delle coincidenze ... papà è bravo... però papà ha avuto delle coincidenze fortunate di entrare nel mondo della politica grazie a suo padre (...) grazie a un certo giro di politica, lavori pubblici eccetera che non è detto che in futuro sarà sempre uguale a come è stato fino adesso».
Inchiesta Grandi opere, l'accusa: "Incalza scriveva il programma di Ncd e ha sponsorizzato la nomina di Nencini nel ministero di Lupi", scrive “Libero Quotidiano”. Ercole Incalza era così influente all'interno del ministero delle Infrastrutture da aggiornare il ministro Maurizio Lupi, in procinto di farsi intervistare da un quotidiano, sullo stato dei lavori e dei finanziamenti delle Grandi Opere, da buttare giù il programma di governo che il Nuovo Centro Destra avrebbe dovuto presentare e da ottenere la nomina del senatore Riccardo Nencini a sottosegretario, dietro sua sponsorizzazione. E' quanto emerge dalle 268 pagine di ordinanza cautelare scritta dal gip di Firenze nell'inchiesta che ha portato all'arresto di quattro persone tra cui lo stesso Incalza e che avrebbe portato alla luce il rapporto stretto tra il ministro Lupi e alcuni imprenditori, con tanto di abito sartoriale regalato all'esponente di Ncd e lavoro dato al figlio Luca insieme a un Rolex da 10mila euro per la laurea. "Incalza scrive il programma di Ncd" - Il magistrato si sofferma, anzitutto, sullo strettissimo legame tra Ercole Incalza e il ministro Lupi. "Una relazione - scrive - che ha sicuramente contribuito, da ultimo, all'affermazione del potere di Incalza nei rapporti con i dirigenti delle imprese e anche con altri soggetti istituzionali". Il 28 dicembre del 2013 è significativa per gli investigatori del Ros una conversazione tra i due che esalta "l'effettiva importanza" rivestita dall'ingegnere all'interno del dicastero delle Infrastrutture. Sul Corriere della Sera del 29 dicembre 2013 viene pubblicata l'intervista concessa dal ministro Lupi proprio sui temi trattati il giorno prima con Incalza. Ma era stretto anche il legame che Incalza aveva, più in generale, con il Nuovo Centro Destra: in una telefonata tra l'ingegnere e una tal Daniela il primo "afferma di aver trascorso la notte a redigere il programma di governo che Ncd avrebbe dovuto presentare e di essere in attesa del benestare di Angelino Alfano e di Maurizio Lupi". C'è poi una telefonata del 17 febbraio 2014 indicativa dei rapporti tra il ministro e Incalza: in questa conversazione Lupi - scrive il gip - "si lamenta con l'altro per essere stato da lui abbandonato. Incalza contesta tale affermazione dicendogli di aver scritto anche il programma". La sponsorizzazione per Nencini - Altro esempio dell'influenza che Incalza "sembra avere sulle decisioni del ministro si trae - evidenzia sempre il giudice di Firenze - il 28 febbraio 2014 quando Maurizio Lupi ha telefonato al primo e lo ha informato che, in seguito alla sponsorizzazione di quest'ultimo, avevano nominato viceministro per le infrastrutture il senatore Riccardo Nencini". Lupi - si legge ancora nell'ordinanza - "invita quindi Incalza a parlargli per dirgli che non rompa i coglioni. Nel corso di alcune successive telefonate Ercole Incalza fa presente che al ministero per le Infrastrutture sono arrivati due suoi compagni socialisti facendo riferimento a Nencini e a Umberto Del Basso De Caro. Il suo amico commenta tali nomine dicendo complimenti... sempre sempre più coperto...".
Maurizio Lupi: "Soffro per mio figlio, non mi dimetto", scrive “Libero Quotidiano”. Pensa soprattutto a suo figlio il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. Il nome dell'ingegner Luca Lupi è spuntato nelle carte dell'inchiesta di Firenze su Tav e Expo. "Provo soprattutto l' amarezza di un padre nel vedere il proprio figlio sbattuto in prima pagina come un mostro senza alcuna colpa. Quando per tutta la vita ho educato i miei figli a non chiedere favori, né io ho mai cercato scorciatoie per loro", dice il ministro in un'intervista a Repubblica. Precisa che non ha mai pensato alle dimissioni anche se, confessa, che per la prima volta si è chiesto se il gioco valga la candela: "Se fare politica significhi far pagare questo sacrifico alle persone che ami. Sa la battuta che faccio sempre a Luca? Purtroppo hai fatto Ingegneria civile e ti sei ritrovato un padre ministro delle Infrastrutture". Il curriculum - E ancora: "Mio figlio si è laureato al Politecnico di Milano nel dicembre 2013 con 110 e lode. Dopo sei mesi in America presso uno studio di progettazione, nel febbraio dello scorso anno gli hanno offerto un lavoro. Ci ha messo un anno, come tutti, ad avere il permesso di lavoro e da marzo di quest'anno lavora a New York. Lo scorso anno ha lavorato presso lo studio Mor per 1.300 euro netti al mese in attesa di andare negli Usa". E continua: "Se avessi chiesto a Perotti di far lavorare mio figlio, o di sponsorizzarlo sarebbe stato un gravissimo errore e presumo anche un reato. Non l'ho fatto. Stefano Perotti conosceva mio figlio da quando, con altri studenti del Politecnico, andava a visitare i suoi cantieri. Sono amici, così come le nostre famiglie". Quando il giornalista gli chiede se per questo motivo gli ha regalato un Rolex da 10mila euro, lui risponde: "L' avesse regalato a me non l' avrei accettato". Lupi parla poi di Ercole Incalza, il supermanager ingegnere e architetto molto vicino a lui arrestato nell'inchiesta sul "sistema grandi Opere". "Incalza, che è stato al ministero per anni e ha lavorato con tutti i ministri, tranne Di Pietro, è stato il padre della Legge Obiettivo. È uno dei tecnici più stimati nel suo settore, anche in Europa ce lo invidiavano". Il ministro spiega che è sempre stato riconfermato per "le capacità tecniche riconosciute da tutti. In questi venti mesi non ho mai incontrato un presidente di Regione che non mi abbia dato un giudizio positivo su di lui. L'obiettivo era realizzare le Grandi Opere e recuperare il drammatico gap infrastrutturale dell' Italia ed Ettore Incalza poteva garantire la professionalità necessaria"..
Maurizio Lupi non è indagato, scrive Maurizio Belpietro su “Libero Quotidiano”. Né lo è il figlio, un ragazzo poco più che ventenne che fa il responsabile di cantiere di un’azienda che costruisce il nuovo palazzo dell’Eni, a San Donato milanese. Però, nonostante il ministro dei Lavori pubblici non sia stato raggiunto da alcun avviso di garanzia, né gli venga contestato alcunché, il suo nome è già finito nel tritacarne dell’inchiesta di Firenze: diciamo che gli hanno cucito addosso un vestitino su misura, che sembra fatto apposta per indurlo a gettare la spugna e lasciare l’incarico. La nostra non è una battuta: negli atti dell’indagine, il nome dell’esponente di Ncd non viene fatto per qualche cosa di illecito, ma a proposito di un abito che l’uomo politico si sarebbe fatto fare. C’è davvero il completo? Oppure è una chiacchiera telefonica? Ma se giacca e pantaloni non bastassero ecco che dai brogliacci delle intercettazioni spunta anche un orologio che un altro imprenditore avrebbe donato al figlio del responsabile dei Lavori pubblici in occasione della sua laurea. Il Rolex probabilmente vale di più dell’abito, ma basta questo per sospettare qualcosa di losco intorno agli appalti su cui il ministero dovrebbe vigilare? È sufficiente che Luca Lupi sia uno dei quattro ingegneri che si occupano di un appalto per puntare il dito?
Perotti, spunta anche Julia Roberts nell'inchiesta sugli appalti, scrive “Libero Quotidiano”. Spunta anche il nome di Julia Roberts nell'inchiesta che ha travolto Stefano Perotti, il general manager con laurea in ingegneria e una serie di collaborazioni eccellenti con ministeri e comitati nazionali. "Figlio d'arte" - suo padre Massimo è stato presidente della Cassa del Mezzogiorno e direttore generale dell'Anas, arrestato negli anni Ottanta durante Tangentopoli - è ritenuto dalla Procura il grande gestore di appalti per almeno 25 miliardi di euro. Sua moglie Christine, riporta il Corriere della Sera, parla di lui con il figlio Philippe, 27 anni, anche lui indagato, in questi termini: "Si è sposato a 23 anni, a 24 ha dato la tesi, a 25 aveva appena iniziato a lavorare..., come te, uguale, … e non aveva fatto un c… nella vita… aveva avuto tanto da suo padre… perché aveva già avuto una casa… il permesso di sposarsi, senza guadagnare però". "Ha avuto delle coincidenze fortunate… di entrare nel mondo della politica grazie a suo padre". In effetti a Stefano Perotti è andato sempre tutto bene. Per dirne una possiede una strepitosa villa con vista su Firenze in via di Forte San Giorgio 10, che è stata il set di una pubblicità di Calzedonia con protagonista la meravigliosa Julia Roberts. E ne ha una altrettanto esclusiva a Punta Ala. La sua carriera è tutta in ascesa, soprattutto a Milano non c'è grande opera che non veda la sua presenza diretta o indiretta. Si va dalla linea 5 del metrò che collega Garibaldi a San Siro alla realizzazione di CityLife con i tre grattacieli firmati Isozaki, Hadid, Libeskind, passando per la Fiera di Rho-Pero.
Da Italia 90 alle ferrovie, Incalza, 25 anni di inchieste. L’avvocato Titta Madia: «Un recordman dei proscioglimenti, ben 14 e nessuna condanna», scrive Fulvio Fiano su “Il Corriere della Sera”. Incarichi e inchieste si accumulano in due pile parallele nella carriera di Ercole Incalza, il cui nome in atti giudiziari comincia a circolare, con pesanti accuse, all’indomani dei Mondiali di calcio di Italia ‘90. Nella memoria rimangono le imprese sportive, nelle città che le hanno ospitate restano invece opere incompiute, inutilizzabili o fatte male. A Roma si muove il sostituto procuratore Giorgio Castellucci, che chiede otto rinvii a giudizio al termine dell’inchiesta sugli illeciti nella fase di costruzione e nella mancata utilizzazione di strutture realizzate nella Capitale. Tra tutte, le stazioni ferroviarie di Vigna Clara e Farneto. I reati ipotizzati sono abuso e omissione di atti d’ufficio. Ercole Incalza (che verrà prosciolto) era all’epoca direttore generale del ministero dei trasporti. Coinvolti con lui dirigenti e funzionari delle ferrovie. Sotto sequestro finiscono le due stazioni e il tratto di binari che le unisce. Costate 81,5 miliardi di lire durano giusto il tempo dei mondiali perché, come spiegò Fs, «si trattava di un collegamento provvisorio che usato a pieno regime non avrebbe offerto sufficienti garanzie di sicurezza». Passano due anni e la Corte dei conti di Cagliari chiede la condanna a un risarcimento complessivo di 11 miliardi di lire degli ex ministri dei Trasporti Giorgio Santuz e Carlo Bernini, e di altre 19 persone, tra cui Incalza, dirigente del ministero, per la costruzione e il mancato utilizzo, durato oltre quattro anni, del parcheggio realizzato nell’aeroporto di Cagliari-Elmas ancora in occasione di Italia 90: 1076 posti auto su tre piani e 25 piazzole per i bus dei tifosi che però dovettero parcheggiare altrove. I ministri vennero condannati a risarcire 2 miliardi e oltre 950 milioni di lire. Nel 1996 comincia invece il lungo capitolo legato alla Tav, di cui Incalza è amministratore delegato. La procura di La Spezia fa arrestare l’ad di Fs Lorenzo Necci, il finanziere Pierfrancesco Pacini Battaglia, l’allora ad della Oto-Melara Pier Francesco Guarguaglini (fino al 2011 presidente di Finmeccanica). Una presunta associazione a delinquere che a seconda delle pozioni degli indagati si sarebbe resa responsabile di corruzione, peculato, truffa, falso, riciclaggio. Incalza avrebbe pagato i magistrati Renato Squillante e Giorgio Castellucci per ammorbidire l’inchiesta sulla Tav. «Notizie incredibili - le definisce Incalza - se avessi ricevuto dazioni di denaro da chicchessia, come incautamente scritto da alcuni giornali, i magistrati di La Spezia non mi avrebbero consentito di proseguire nella mia attività». Poi si dimette «per evitare che mie vicende personali vengano strumentalizzate a danno del progetto Alta velocità». Il suo nome compare in alcune intercettazioni in cui Pacini Battaglia affermava di avergli dato del denaro per «far fronte ad una scommessa persa sulle partite di calcio». In un’ altra intercettazione invece lo stesso Incalza parla con l’ ex amministratore delegato delle Fs, Lorenzo Necci, di progetti e finanziamenti collegati all’alta velocità. Questo capitolo giudiziario viene aperto a Roma, dove Incalza è accusato di abuso di ufficio. La cosiddetta Tangentopoli 2 da La Spezia viene trasferita a Perugia per competenza. La posizione di Incalza si aggrava e il manager finisce agli arresti Secondo i pm «appare pienamente partecipe dei disegni criminosi dell’associazione e protetto dalla stessa, anche a livello giudiziario, in relazione alle indagini sul conto della ‘Tav spa». Tutte le accuse, escluso il riciclaggio che non coinvolge Incalza, vengono prescritte. E sempre sulla Tav la procura capitolina apre un altro filone per presunte false fatture, coinvolti ancora Necci e Incalza per i quali viene poi chiesta l’archiviazione. Arriva poi, e siamo agli anni scorsi, il coinvolgimento nell’inchiesta sui lavori per il G8 gestiti dalla «cricca degli appalti» di Balducci, Anemone e Zampolini, grazie ai quali Incalza, dal 2004 capo struttura al ministero dei trasporti su nomina del ministro Lunardi, avrebbe pagato a un prezzo stracciato un appartamento di lusso nel quartiere Flaminio: 390 mila euro per 5 stanze. «È una vicenda che mi lascia assolutamente tranquillo» precisava Incalza, mentre il suo avvocato Titta Madia lo definiva «un vero e proprio recordman dei proscioglimenti, ben 14 e nessuna condanna». Oggi il nuovo arresto.
Incalza, l'"Ercolino" delle grandi opere. Il suo nome ricorre in tutte le inchieste degli ultimi 30 anni: dalla Tav al G8 al Mose, scrive invece “la Repubblica”. Secondo Giovanni Paolo Gaspari, alto dirigente delle Ferrovie, "è lui che decide i nomi...fa il bello e il cattivo tempo ormai là dentro...o dominus totale". Dal G8, alla Tav, al Mose: il nome di Ercole Incalza ("Ercolino", come lo chiama lo stesso Gaspari in una telefonata intercettata dal Ros il 25 novembre del 2013), arrestato oggi, ricorre in tutte le grandi opere - e inchieste - degli ultimi 30 anni in Italia. L'ingegnere pugliese nato nel brindisino il 15 agosto del '44, è stato per molti anni dirigente di vertice al ministero delle Infastrutture e dei Trasporti per poi divenirne consulente esterno: ultimo incarico come capo della struttura tecnica di Missione per l'esame delle questioni giuridiche connesse alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Incalza appare nel mondo dei lavori pubblici alla fine degli anni '70 alla Cassa per il Mezzogiorno, della quale diventa dirigente nel 1978, assumendo nel marzo 1980 la responsabilità del Progetto Speciale dell'Area Metropolitana di Palermo.Giovane socialista pugliese approda al ministero dei Trasporti con Claudio Signorile. Nel 1983 è consigliere del ministro dei Trasporti, poi nel giugno 1984 assume la responsabilità di Capo della Segreteria Tecnica del Piano Generale dei Trasporti. Dal gennaio 1985 Dirigente Generale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, passa alle Ferrovie dello Stato nell'agosto 1991, per diventare Amministratore Delegato della Treno Alta Velocità TAV S.p.A. dal settembre 1991 al novembre 1996. Nel 1998 finisce ai domiciliari insieme all'ex presidente di Italferr Maraini. Dopo la bufera della Tangentopoli di Necci e Pacini Battaglia a metà degli anni Novanta, Incalza torna alla ribalta al ministero di Porta con Pietro Lunardi e diventa poi il braccio destro del ministro Altero Matteoli con l'incarico di capo della struttura tecnica di missione. Negli ultimi anni sempre più numerose le inchieste; a febbraio i pm fiorentini Giulio Monferini e Gianni Tei ne avevano chiesto il rinvio a giudizio insieme ad altre 31 persone nell'inchiesta sul sottoattraversamento fiorentino della Tav. Nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip di Firenze compare anche il nome di Luca Lupi, figlio del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Maurizio.
Arrestato l’uomo delle Grandi Opere italiane. Ercole Incalza, dirigente del ministero delle Infrastrutture per quattordici anni, ha attraversato sette governi finendo spesso nelle maglie delle Procure. Voluto a Roma dall’ex ministro azzurro Pietro Lunardi è una costante di tutti i lavori milionari degli ultimi trent’anni in Italia: dal G8, alla Tav fino alla cricca di Diego Anemone, scrive Michele Sasso su “L’Espresso”. L'amministratore delegato della Tav Ercole IncalzaGrandi opere, grandi affari e grandi inchieste. Al centro sempre lui Ercole Incalza, braccio destro del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi e potente burocrate. Oggi è arrivato l’epilogo con l’arresto per corruzione, induzione indebita, turbativa d'asta e altri delitti contro la pubblica amministrazione insieme agli imprenditori Stefano Perotti e Francesco Cavallo, e Sandro Pacella, collaboratore di Incalza. Gli indagati sono oltre cinquanta e toccano anche il mondo della politica: l’europarlamentare alfaniano Vito Bonsignore è anche il capo del gruppo privato che spinge per la costruzione della nuova autostrada Mestre-Orte, una lingua d’asfalto dal Lazio al Veneto attraversando cinque regioni, l’opera pubblica italiana più rilevante dopo il ponte sullo Stretto di Messina. Il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo spiega il meccanismo con il quale l'ex dirigente del ministero dei Lavori pubblici (ora consulente esterno) Ercole Incalza avrebbe manovrato numerosi appalti pubblici assieme all'ingegner Stefano Perotti. A Perotti sarebbe stata affidata la direzione dei lavori in cambio di consulenze retribuite allo stesso Incalza. Secondo il pm Creazzo "il meccanismo ha favorito un incremento dei costi" delle opere. Nel mirino della Procura di Firenze la gestione illecita degli appalti nostrani delle cosiddette grandi opere per quello che i magistrati definiscono un “articolato sistema corruttivo che coinvolgeva dirigenti pubblici, società aggiudicatarie degli appalti ed imprese esecutrici dei lavori”. Un sistema gelatinoso dove i ruoli si confondono ma la costante, il perno degli affari è il super manager pubblico che guida dal 2001 gli uffici del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Tra i lavori coinvolti ecco le principali nuove tratte ferroviarie, il Palazzo Italia del sito milanese di Expo 2015 e poi porti, cantieri monstre fino alla metropolitana di Parma dove emergerebbe che l'opera, non realizzata, è costata trenta milioni di euro. Soldi pubblici con l’approvazione del finanziamento arrivata grazie al ruolo dentro i palazzi del potere di Ercole Incalza. Partito come consulente del ministro parmigiano Pietro Lunardi nel 2001, Incalza è una costante in tutte le grandi opere degli ultimi trent’anni in Italia: dal G8, alla Tav, al Mose. Ingegnere pugliese, classe 1944, è stato per molti anni dirigente di vertice al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per poi divenirne consulente esterno: ultimo incarico come capo della struttura tecnica di missione per l'esame delle questioni giuridiche connesse alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Per quattordici anni all’ex ministero dei Lavori Pubblici, attraversando sette governi: da Berlusconi a Renzi, passando per Prodi e Monti. Dal 31 dicembre del 2014 non riveste nessun ruolo o funzione neanche a titolo gratuito arrivato al traguardo dei 70 anni. L’ingegnere appare nel mondo dei lavori pubblici alla fine degli anni settanta alla Cassa per il Mezzogiorno, della quale diventa dirigente nel 1978, assumendo nel marzo 1980 la responsabilità del progetto speciale dell'area metropolitana di Palermo. Giovane socialista pugliese approda al ministero dei Trasporti con Claudio Signorile. Nel 1983 è consigliere del ministro Claudio Signorile, poi nel giugno 1984 è capo della segreteria tecnica del piano generale dei Trasporti. Dal gennaio 1985 dirigente generale della direzione della motorizzazione civile per poi passare alle Ferrovie nell'agosto 1991, per diventare amministratore delegato della “Treno Alta Velocità Tav Spa” dal settembre 1991 al novembre 1996. Nel 1998 finisce ai domiciliari insieme all'ex presidente di Italferr Eugenio Maraini. Dopo la bufera della Tangentopoli di Lorenzo Necci e Pierfrancesco Pacini Battaglia a metà degli anni Novanta, Incalza torna alla ribalta dei palazzi romani con Pietro Lunardi e diventa poi il braccio destro del ministro Altero Matteoli con l'incarico di capo della struttura tecnica di missione. Negli ultimi anni sempre più numerose le inchieste: un mese fa i pm fiorentini ne avevano chiesto il rinvio a giudizio insieme ad altre trentuno persone nell'inchiesta sul sottoattraversamento fiorentino della Tav: l’accusa è traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, frode e truffa. Ecco come Incalza lodava la legge obiettivo presentata come fiore all’occhiello dal Governo Berlusconi per smuovere l’economia e rompere il tabù italiano dei cantieri infiniti:«L'accelerazione dei tempi dell'apertura dei cantieri delle grandi infrastrutture, di quelle opere cioè strategiche e di preminente interesse nazionale è uno degli scopi della legge obiettivo che come finalità di regolare organicamente e sulla base di principi innovativi la realizzazione delle opere pubbliche maggiori». Nel 2012 in una nuova tranche dell’inchiesta della cricca delle grandi opere di Guido Bertolaso, Angelo Balducci e Diego Anemone si scopre un favore per Incalza: assegni da 562mila euro, firmati dal "riciclatore" di Diego Anemone, l'architetto Angelo Zampolini, dietro l'acquisto per soli 390mila euro di un appartamento di cinque camere a Roma, a due passi da piazzale Flaminio. Il denaro, scrivono i pm nella richiesta d'arresto, era destinato ad “investimenti finanziari in immobili con intestazione a favore di terzi per la remunerazione dei pubblici ufficiali”. Denaro proveniente dai conti di Zampolini ma anche dai trenta intestati nella banca delle Marche alla segretaria dell'imprenditore, Alida Lucci. Ed ecco spuntare la compravendita di un appartamento in via Emanuele Gianturco 5 a Roma. A vendere sono Maurizio De Carolis e Daniela Alberti, ufficialmente giardinieri, mentre a comprare è tale Alberto Donati, dirigente. Ma dietro Donati ci sarebbe, secondo gli inquirenti, Ercole Incalza. Quest'ultimo è infatti il padre della moglie di Donati, e sarebbe il potente manager pubblico ad aver indicato al genero l'imprenditore Anemone per trovare una casa nella capitale. Dopo la svolta nelle indagini e gli arresti di stamane i grillini alzano il i tiro: «Più volte il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni dell’ingegnere Ercole Incalza come capo della struttura di missione sulle Grandi Opere. Ma la risposta del ministro Maurizio Lupi è stata sempre la stessa è l’uomo giusto al posto giusto. Adesso è la magistratura a spiegarci cosa volesse intendere il ministro», è il commento dei deputati del Movimento 5 Stelle delle commissioni trasporti, infrastrutture e ambiente della Camera. «Non importa che oggi, come sottolinea il ministro in un pronto comunicato stampa, Incalza non ricopra più ruoli pubblici. Lo sappiamo bene che da qualche mese è ufficialmente pensionato. Ma Lupi lo ha difeso quando era pluri-indagato. Quando solo la prescrizione lo salvava dalle indagini, quando le intercettazioni rivelavano il suo “impegno” per le Grandi Opere. Incalza in quattordici anni ha attraversato indenne sette governi. Ora il ministro dovrebbe fare un’unica scelta di dignità: dimettersi», attaccano i deputati Alessandro Di Battista, Michele Dell’Orco e Andrea Cioffi.
Incalza: chi è il grande vecchio delle opere pubbliche italiane. Da trent'anni al ministero dei Trasporti. E' sopravvissuto ai governi, alle inchieste. A settant'anni era ancora il "dominus", scrive Carmelo Caruso su “Panorama”. Da trent’anni è l’ingegnere del cemento e del ferro pubblico italiano. Ed è stato il “vigile” per quanto riguarda le strade, “ferroviere” per quanto riguarda le ferrovie e l’alta velocità, “capocantiere” per quanto riguarda le opere pubbliche, se ancora si possono chiamare tali. Trent’anni, sette governi, cinque ministri, se non è un papato cosa altro può essere quello di Ercole Incalza al ministero dei Trasporti? E se i procuratori di Firenze non lo avessero fermato per un elenco di malversazione contro la pubblica amministrazione (corruzione, induzione indebita, turbativa d’asta) chissà dove sarebbe arrivato, dicono in Europa per un incarico alla Bei (Banca europea investimenti) quasi a premiare una carriera di indefesso servizio. Di certo, al ministero dei lavori pubblici, e in particolar modo per volere di Maurizio Lupi, che lo definì pubblicamente “un patrimonio per il nostro paese”, ci sarebbe rimasto anche oltre i suoi anni, grazie a un codicillo che ne garantiva la consulenza esterna come capo della stuttura tecnica di Missione. E dato che in Italia esistono solo creatori, ma non creature che possono fare a meno di chi le ha messe in piedi, a Incalza non solo era stata offerta la guida di questa struttura, ma se ne era quasi chiesto la disponibilità per ineluttabilità, quasi come fosse l’unico chirurgo che sapesse maneggiare il bisturi, insomma il solo che potesse a "settant’anni” dirigerla. Per Incalza ci sono state solo le grandi opere mentre le piccole sono «le puttanate» perché dopo «sta gente se non ha continuità lavorativa e sono cazzi». E dunque, dite se possa essere questa la lingua di un dirigente, anche con l’attenuante di essere al telefono. Sarà che il turpiloquio è contagioso, fatto è che quello di Incalza ha colpito il ministro Lupi che nelle intercettazioni dismette il linguaggio sobrio del cattolico praticante per indossare quello del consumato uomo con il sopracciò rassicurando Incalza: «Vado io guarda, siccome su questa cosa, te lo dico già. Però io non voglio, cioè vorrei che tu dicessi a chi lavora con te che sennò vanno a c...! Su questa roba ci sarò io lì e ti garantisco che se viene abolita la Struttura non c’è più il governo!». Entrato al ministero delle Infrastrutture con il leader socialista Claudio Signorile, Incalza che nelle intercettazioni chiamano «il dominus» è passato dai progetti sull’aria metropolitana di Palermo, il suo primo incarico da dirigente della cassa del Mezzogiorno nel 1978, alla Motorizzazione civile, amministratore delegato della Alta Velocita, la Tav nel 1991, e non si contano i servizi da fedele consigliori dei ministri di destra e di sinistra, Pietro Lunardi, Antonio Di Pietro («Ma io lo cacciai senza complimenti»), Altero Matteoli, Corrado Passera e oggi lo sfortunato Lupi con un figlio che da quanto si ascolta nelle intercettazioni ha pure accettato un Rolex. Incalza ha sùbito 14 inchieste (lo si evoca anche per quanto riguarda l’Expo) uscendone indenne, ammaccato con prescrizioni, ma subito guarito dalla prodigalità della politica che lo corteggiava e dagli imprenditori che avevano cominciato a omaggiare la sua famiglia con case. L’architetto Zampolini, quello dei grandi eventi per intenderci, si premurò a pagare un milione di euro per la casa della figlia di Incalza, Antonia, che nel 2003 ne acquistò una per soli 390 mila euro, un edificio a piazzale Flaminio a Roma, senza sapere che il resto lo pagava Zampolini. Ebbene, dell’ultima appendice del libro a fascicoli “corruzione italia”, Incalza con i suoi settant’anni è nelle intercettazioni degli imprenditori «dominus totale. Maurizio crede di fare qualcosa. Ma fa quello che gli dice quest’altro», è lo sponsor dei socialisti al governo almeno secondo Lupi: «Dopo che tu hai dato, hai coperto, hai dato la sponsorizzazione per Nencini l’abbiamo fatto viceministro alle Infrastrutture». A gennaio di quest’anno Incalza ha lasciato il ministero nonostante i giovani volessero trattenerlo. Chiamatela intuizione o forse solo l’imprenscindibile prevalenza del grande vecchio. La qualità dell’ingegnere italiano che non costruisce nulla di solido, ma sa conoscere le crepe che anticipano i crolli.
La giustizia ad alta velocità, scrive Gian Marco Chiocci su “Il Tempo”. Sacra è per noi la presunzione d’innocenza. E non sarà certo un vestito su misura e un Rolex da diecimila euro, a farci cambiare idea. Strano, anzi, è che certi dettagli finiscano nelle carte di un’inchiesta, perché se qualcuno si vuol vendere, non lo fa certo per un piatto di lenticchie. È anche vero, però, che se solo un decimo delle accuse emerse rispondesse a verità (e molti indizi vanno in questo senso) allora saremmo di fronte ad un altro esempio di endemica e ormai imbattibile corruzione all’italiana. E saremmo anche all’ennesima inchiesta che tocca quell’Ncd di Angelino Alfano e Maurizio Lupi, ministri dell’Interno e delle Infrastrutture, che per inseguire sogni di governo, hanno mollato le battaglie «garantiste» di Berlusconi per schierarsi con quella sinistra storicamente vicina ai magistrati anche quando sbagliano (al netto di un premier che ha voluto la norma sulla responsabilità civile delle toghe), senza con questo riuscire a creare una classe dirigente, soprattutto locale, coerente con il nuovo percorso filo-magistrati. Vogliamo ripeterlo: un buon orologio regalato al figlio del ministro e un vestito donato al ministro stesso, non hanno nulla di penalmente rilevante. Forse è solo malcostume italico. Occorre, anzi, stare attenti alla potenza degli schizzi di fango, che in passato hanno rovinato la vita a persone innocenti, inducendone alcuni a togliersela. Così come sarebbe il caso di riflettere sulla puntualità con cui, quando in parlamento si parla dell’opportunità di inasprire le pene sulla corruzione, ecco l’inchiesta sui presunti corrotti; e quando si discute di allungare i tempi della prescrizione, ecco la sentenza su caso Eternit che assolve gli imputati proprio per l’eccessiva lunghezza del processo. Valutare tutto e rimanere vigili, ma senza condannare qualcuno prima di una sentenza. Ercole Incalza per 14 volte è stato indagato, per 14 volte prosciolto. Inorridiamo pure ma un po’ di prudenza non guasta.
I MEDIA ED I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE, CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
Per il pontefice “il clima mediatico ha le sue forme di inquinamento, i suoi veleni. La gente lo sa, se ne accorge, ma poi purtroppo si abitua a respirare dalla radio e dalla televisione un’aria sporca, che non fa bene. C’è bisogno di far circolare aria pulita. Per me i peccati dei media più grossi sono quelli che vanno sulla strada della bugia e della menzogna, e sono tre: la disinformazione, la calunnia e la diffamazione. Dare attenzione a tematiche importanti per la vita delle persone, delle famiglie, della società, e trattare questi argomenti non in maniera sensazionalistica, ma responsabile, con sincera passione per il bene comune e per la verità. Spesso nelle grandi emittenti questi temi sono affrontati senza il dovuto rispetto per le persone e per i valori in causa, in modo spettacolare. Invece è essenziale che nelle vostre trasmissioni si percepisca questo rispetto, che le storie umane non vanno mai strumentalizzate”. Infatti nessuno delle tv ed i giornali ne hanno parlato di questo intervento.
"Evitare i tre peccati dei media: la disinformazione, la calunnia e la diffamazione". E' l'esortazione che rivolge al mondo dell'informazione e della comunicazione Papa Francesco, cogliendo l'occasione dell'udienza del 15 dicembre 2014 in Aula Paolo VI dei dirigenti, dipendenti e operatori di Tv2000, la televisione della Chiesa italiana. «Di questi tre peccati, la calunnia sembra il più grave perché colpisce le persone con giudizi non veri. Ma in realtà il più grave e pericoloso è la disinformazione, perché ti porta all'errore, ti porta a credere solo a una parte della verità. La disinformazione, in particolare spinge a dire la metà delle cose e questo porta a non potersi fare un giudizio preciso sulla realtà. Una comunicazione autentica non è preoccupata di colpire: l'alternanza tra allarmismo catastrofico e disimpegno consolatorio, due estremi che continuamente vediamo riproposti nella comunicazione odierna, non è un buon servizio che i media possono offrire alle persone. Occorre parlare alle persone “intere”, alla loro mente e al loro cuore, perché sappiano vedere oltre l'immediato, oltre un presente che rischia di essere smemorato e timoroso del futuro. I media cattolici hanno una missione molto impegnativa nei confronti della comunicazione sociale cercare di preservarla da tutto ciò che la stravolge e la piega ad altri fini. Spesso la comunicazione è stata sottomessa alla propaganda, alle ideologie, a fini politici o di controllo dell'economia e della tecnica. Ciò che fa bene alla comunicazione è in primo luogo la “parresia”, cioè il coraggio di parlare con franchezza e libertà. Se siamo veramente convinti di ciò che abbiamo da dire, le parole vengono. Se invece siamo preoccupati di aspetti tattici, il nostro parlare sarà artefatto e poco comunicativo, insipido. La libertà è anche quella rispetto alle mode, ai luoghi comuni, alle formule preconfezionate, che alla fine annullano la capacità di comunicare. Risvegliare le parole: ecco il primo compito del comunicatore. La buona comunicazione in particolare evita sia di "riempire" che di "chiudere". Si riempie quando si tende a saturare la nostra percezione con un eccesso di slogan che, invece di mettere in moto il pensiero, lo annullano. Si chiude quando alla via lunga della comprensione si preferisce quella breve di presentare singole persone come se fossero in grado di risolvere tutti i problemi, o al contrario come capri espiatori, su cui scaricare ogni responsabilità. Correre subito alla soluzione, senza concedersi la fatica di rappresentare la complessità della vita reale è un errore frequente dentro una comunicazione sempre più veloce e poco riflessiva. La libertà è anche quella rispetto alle mode, ai luoghi comuni, alle formule preconfezionate, che alla fine annullano la capacità di comunicare».
Questa sub cultura artefatta dai media crea una massa indistinta ed omologata. Un gregge di pecore. A questo punto vien meno il concetto di democrazia e prende forma l’esigenza di un uomo forte alla giuda del gregge che sappia prendersi la responsabilità del necessario cambiamento nell’afasia e nell’apatia totale. Sembra necessario il concetto che è meglio far decidere al buon e capace pastore dove far andare il gregge che far decidere alle pecore il loro destino rivolto all’inevitabile dispersione.
Francesco di Sales, appena ordinato sacerdote, nel 1593, lo mandarono nel Chablais, che poi sarebbe il Chiablese, dato che sta nell’Alta Savoia, ma l’avevano invaso gli Svizzeri e tutti si erano convertiti al calvinismo, scrive Lanfranco Caminiti su “Il Garantista”. Insomma, doveva essere proprio tosto predicare il cattolicesimo lì. Però, lui aveva studiato dai Gesuiti e poi si era laureato a Padova, perciò poteva con capacità d’argomentazione affrontare qualunque disputa teologica. Era uno che lavorava di fino, Francesco di Sales. Solo che tutto quello che diceva dal pulpito non sortiva grande effetto in quei cuori e quelle menti montanare, e allora per raggiungerli e scaldarli meglio con le sue parole gli venne l’idea di far affiggere nei luoghi pubblici dei “manifesti”, composti con uno stile agile e di grande efficacia, e di far infilare dei “volantini” sotto le porte. Il risultato fu straordinario. È per questo che san Francesco di Sales è il santo patrono dei giornalisti. Per lo stile e l’efficacia, per la capacità di argomentare la verità. Almeno fino a ieri. Perché da ieri c’è un altro Francesco che ha steso le sue mani benedette sul giornalismo, ed è papa Bergoglio. «Evitare i tre peccati dei media: la disinformazione, la calunnia e la diffamazione». È l’esortazione che papa Francesco ha rivolto al mondo dell’informazione e della comunicazione, cogliendo l’occasione dell’udienza in Aula Paolo VI di dirigenti, dipendenti e operatori di Tv2000, la televisione della Cei, conferenza episcopale italiana. In realtà, ne aveva già parlato il 22 marzo, incontrando nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, i membri dell’Associazione ”Corallo”, network di emittenti locali di ispirazione cattolica presenti in tutte le regioni italiane. Ora c’è tornato sopra, ora ci batte il chiodo. Si vede che gli sta a cuore la cosa, e come dargli torto. Evidentemente non parlava solo ai giornalisti cattolici, papa Francesco, e quindi siamo tutti chiamati in causa. «Di questi tre peccati, la calunnia – ha continuato Francesco – sembra il più grave perché colpisce le persone con giudizi non veri. Ma in realtà il più grave e pericoloso è la disinformazione, perché ti porta all’errore, ti porta a credere solo a una parte della verità». Era stato anche più dettagliato nell’argomentazione il 22 marzo: «La calunnia è peccato mortale, ma si può chiarire e arrivare a conoscere che quella è una calunnia. La diffamazione è peccato mortale, ma si può arrivare a dire: questa è un’ingiustizia, perché questa persona ha fatto quella cosa in quel tempo, poi si è pentita, ha cambiato vita. Ma la disinformazione è dire la metà delle cose, quelle che sono per me più convenienti, e non dire l’altra metà. E così, quello che vede la tv o quello che sente la radio non può fare un giudizio perfetto, perché non ha gli elementi e non glieli danno».
Sono i falsari dell’informazione, i peccatori più gravi.
«E io a lui: “Chi son li due tapini
che fumman come man bagnate ’l verno,
giacendo stretti a’ tuoi destri confini?”.
L’una è la falsa ch’accusò Gioseppo;
l’altr’è ’l falso Sinon greco di Troia:
per febbre aguta gittan tanto leppo».
Così Dante descrive nel Canto XXX dell’Inferno la sorte di due “falsari”, la moglie di Putifarre e Sinone. Sinone è quello che convinse i Troiani raccontando un sacco di panzane che quelli si bevvero come acqua fresca e fecero entrare il cavallo di legno, dentro cui si erano nascosti gli Achei che così presero la città. La moglie di Putifarre, ricco signore d’Egitto – così si racconta nella Genesi –, invece, s’era incapricciata del giovane schiavo Giuseppe, cercando di sedurlo. Solo che Giuseppe non ci sentiva da quell’orecchio. Offesa dal rifiuto del giovane, la donna si vendicò accusandolo di aver tentato di farle violenza. Per questa falsa accusa Giuseppe fu gettato nelle prigioni del Faraone. Eccolo, il “leppo” dantesco, che è un fumo puzzolente. E fumo puzzolente si leva dalle pagine dei giornali di disinformacija all’italiana.
Durante la Guerra fredda i russi si erano specializzati nel diffondere informazioni false e mezze verità: raccontavano un sacco di balle sui propri progressi, o magnificavano le sorti delle nazioni che erano sotto l’orbita del comunismo, e nello stesso tempo imbrogliavano le carte su quello che succedeva nell’Occidente maledettamente capitalistico. Pure gli americani avevano la loro disinformacija. Le loro porcherie diventavano battaglie di libertà e le puttanate che compivano erano gesti necessari per difendere la democrazia dall’orso russo e dai cavalli cosacchi. Fare disinformaciija non è banale, non è che ti metti a strillare le stronzate, è un lavoro sottile. Quel cervellone di Chomsky – e ne capisce della questione, visto che è un linguista – riferendosi alle falsificazioni delle prove e delle fonti l’ha definita “ingegneria storica”. Devi orientare l’opinione pubblica, mescolando verità e menzogna; devi sminuire l’importanza e l’attenzione su un evento dandogli una scarsa visibilità e, all’opposto, ingigantire gli spazi informativi su questioni di secondaria importanza; devi negare l’evidenza inducendo al dubbio e all’incredulità. Insomma, è un lavoraccio, che presuppone una vera e propria “macchina disinformativa”. Cioè, i giornali. «Ciò che fa bene alla comunicazione è in primo luogo la parresia, cioè il coraggio di parlare con franchezza e libertà», ha aggiunto papa Francesco. Ha ragione papa Francesco, ragione da vendere. Qualunque direttore di giornale, qualunque editore, qualunque comitato di redazione, qualunque corso dell’ordine dei giornalisti, ti dirà che questi, della franchezza e della libertà, sono i cardini del lavoro dell’informazione. Ma sono chiacchiere. Francesco, invece, non fa chiacchiere. E magari succede che domani troveremo in qualche piazza dei dazebao o dei volantini sotto le nostre porte con la sua firma.
Dalla prova scientifica a quella dichiarativa, passando per il legame tra magistratura e giornalismo. Il dibattito sul processo penale organizzato il 12 dicembre 2014 a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, nell’auditorium della Casa della Cultura intitolata a Leonida Repaci dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con la collaborazione del Comune e della Camera penale, è stato molto più di un semplice dibattito, andato oltre gli aspetti prettamente giuridici, scrive Viviana Minasi su “Il Garantista”. Si è infatti parlato a lungo del legame che esiste tra la magistratura e il giornalismo, quel giornalismo che molto spesso trasforma in veri e propri eventi mediatici alcuni processi penali o fatti di cronaca nera. Se ne è parlato con il direttore de Il Garantista Piero Sansonetti, il Procuratore di Palmi Emanuele Crescenti, il presidente del Tribunale di Palmi Maria Grazia Arena, l’onorevole Armando Veneto, presidente della Camera penale di Palmi e con il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Francesco Napoli. Tanti gli ospiti presenti in questa due giorni dedicata al processo penale. Al direttore Sansonetti il compito di entrare nel vivo del dibattito, puntando quindi l’attenzione su quella sorta di “alleanza” tra magistratura e giornalismo, a volte tacita. «Mi piacerebbe apportare una correzione alla locandina di questo evento, ha detto ironicamente Sansonetti – scrivendo “Giornalismo è giustizia”, invece che “Giornalismo e giustizia”. Perché? Perché molto spesso, soprattutto negli ultimi decenni, è successo che i processi li ha fatti il giornalismo, li abbiamo fatti noi insieme ai magistrati». Fatti di cronaca quali il disastro della Concordia, Cogne, andando indietro negli anni anche Tangentopoli, fino a giungere all’evento che ha catalizzato l’attenzione dei media nazionali negli ultimi giorni, l’inchiesta su Mafia Capitale, sono stati portati alla ribalta dal giornalismo, magari a danno di altri eventi altrettanto importanti che però quasi cadono nell’oblio. «Ci sono eventi di cronaca che diventano spettacolo – ha proseguito il direttore Sansonetti – e questo accade quando alla stampa un fatto interessa, quando noi giornalisti fiutiamo “l’affare”». Sansonetti ha poi parlato di un principio importante tutelato dall’articolo 111 della Costituzione, l’articolo che parla del cosiddetto “giusto processo”, che in Italia sarebbe sempre meno applicato, soprattutto nella parte in cui si parla dell’informazione di reato a carico di un indagato. «Sempre più spesso accade che l’indagato scopre di essere indagato leggendo un giornale, o ascoltando un servizio in televisione, e non da un magistrato». Su Mafia Capitale, Sansonetti ha lanciato una frecciata al Procuratore capo di Roma Pignatone, definendo un «autointralcio alla giustizia» la comunicazione data in conferenza stampa, relativa a possibili altri blitz delle forze dell’ordine, a carico di altri soggetti che farebbero parte della “cupola”. Suggestivo anche l’intervento di Giuseppe Sartori, ordinario di neuropsicologia forense all’università di Padova, che ha relazionato su “tecniche di analisi scientifica del testimone”. Secondo quanto affermato da Sartori, le testimonianze nei processi, ma non solo, sono quasi sempre inattendibili. Il punto di partenza di questa affermazione è uno studio scientifico condotto su circa 1500 persone, che ha dimostrato come la testimonianza è deviata e deviabile, sia dal ricordo sia dalle domande che vengono poste al testimone. Un caso che si sarebbe evidenziato soprattutto nelle vicende che riguardano le molestie sessuali, nelle quali il ricordo è fortemente suggestionabile dal modo in cui vengono poste le domande. Il convegno era stato introdotto dall’ex sottosegretario del primo governo Prodi ed ex europarlamentare Armando Veneto, figura di primo piano della Camera penale di Palmi. L’associazione dei penalisti da anni è in prima linea per controbilanciare il “potere” (secondo gli avvocati) che la magistratura inquirente avrebbe nel distretto giudiziario di Reggio Calabria e il peso preponderante di cui la pubblica accusa godrebbe nelle aule di giustizia. Le posizione espresse da Veneto, anche all’interno della camera penale di Palmi, sono ormai state recepite da due generazioni di avvocati penalisti.
Purtroppo, però, in Italia non cambierà mai nulla.
Mamma l’italiani, canzone del 2010 di Après La Class
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
nei secoli dei secoli girando per il mondo
nella pizzeria con il Vesuvio come sfondo
non viene dalla Cina non è neppure americano
se vedi uno spaccone è solamente un italiano
l'italiano fuori si distingue dalla massa
sporco di farina o di sangue di carcassa
passa incontrollato lui conosce tutti
fa la bella faccia fa e poi la mette in culo a tutti
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
a suon di mandolino nascondeva illegalmente
whisky e sigarette chiaramente per la mente
oggi è un po' cambiato ma è sempre lo stesso
non smercia sigarette ma giochetti per il sesso
l'italiano è sempre stato un popolo emigrato
che guardava avanti con la mente nel passato
chi non lo capiva lui lo rispiegava
chi gli andava contro è saltato pure in a...
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
l'Italia agli italiani e alla sua gente
è lo stile che fa la differenza chiaramente
genialità questa è la regola
con le idee che hanno cambiato tutto il corso della storia
l'Italia e la sua nomina e un alta carica
un eredità scomoda
oggi la visione italica è che
viaggiamo tatuati con la firma della mafia
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
vacanze di piacere per giovani settantenni
all'anagrafe italiani ma in Brasile diciottenni
pagano pesante ragazze intraprendenti
se questa compagnia viene presa con i denti
l'italiano è sempre stato un popolo emigrato
che guardava avanti con la mente nel passato
chi non lo capiva lui lo rispiegava
chi gli andava contro è saltato pure in a...
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
spara la famiglia del pentito che ha cantato
lui che viene stipendiato il 27 dallo Stato
nominato e condannato nel suo nome hanno sparato
e ricontare le sue anime non si può più
risponde la famiglia del pentito che ha cantato
difendendosi compare tutti giorni più incazzato
sarà guerra tra famiglie
sangue e rabbia tra le griglie
con la fama come foglie che ti tradirà
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
mafia mafia mafia
non mi appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è troppo stanca è ora di cambiare aria
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
SE NASCI IN ITALIA…
Quando si nasce nel posto sbagliato e si continua a far finta di niente.
Steve Jobs è cresciuto a Mountain View, nella contea di Santa Clara, in California. Qui, con il suo amico Steve Wozniak, fonda la Apple Computer, il primo aprile del 1976. Per finanziarsi, Jobs vende il suo pulmino Volkswagen, e Wozniak la propria calcolatrice. La prima sede della nuova società fu il garage dei genitori: qui lavorarono al loro primo computer, l’Apple I. Ne vendono qualcuno, sulla carta, solo sulla base dell’idea, ai membri dell’Homebrew Computer Club. Con l’impegno d’acquisto, ottengono credito dai fornitori e assemblano i computer, che consegnano in tempo. Successivamente portano l’idea ad un industriale, Mike Markkula, che versa, senza garanzie, nelle casse della società la somma di 250.000 dollari, ottenendo in cambio un terzo di Apple. Con quei soldi Jobs e Wozniak lanciano il prodotto. Le vendite toccano il milione di dollari. Quattro anni dopo, la Apple si quota in Borsa.
Io sono Antonio Giangrande, noto autore di saggi pubblicati su Amazon, che raccontano questa Italia alla rovescia. A tal fine tra le tante opere da me scritte vi è “Italiopolitania. Italiopoli degli italioti”. Di questo, sicuramente, non gliene fregherà niente a nessuno. Fatto sta che io non faccio la cronaca, ma di essa faccio storia, perché la quotidianità la faccio raccontare ai testimoni del loro tempo. Certo che anche di questo non gliene può fregar di meno a tutti. Ma una storiella raccontata da Antonio Menna che spiega perché, tu italiano, devi darti alla fuga dall’Italia, bisogna proprio leggerla. Mettiamo che Steve Jobs sia nato in Italia. Si chiama Stefano Lavori. Non va all’università, è uno smanettone. Ha un amico che si chiama Stefano Vozzini. Sono due appassionati di tecnologia, qualcuno li chiama ricchioni perchè stanno sempre insieme. I due hanno una idea. Un computer innovativo. Ma non hanno i soldi per comprare i pezzi e assemblarlo. Si mettono nel garage e pensano a come fare. Stefano Lavori dice: proviamo a venderli senza averli ancora prodotti. Con quegli ordini compriamo i pezzi. Mettono un annuncio, attaccano i volantini, cercano acquirenti. Nessuno si fa vivo. Bussano alle imprese: “volete sperimentare un nuovo computer?”. Qualcuno è interessato: “portamelo, ti pago a novanta giorni”. “Veramente non ce l’abbiamo ancora, avremmo bisogno di un vostro ordine scritto”. Gli fanno un ordine su carta non intestata. Non si può mai sapere. Con quell’ordine, i due vanno a comprare i pezzi, voglio darli come garanzia per avere credito. I negozianti li buttano fuori. “Senza soldi non si cantano messe”. Che fare? Vendiamoci il motorino. Con quei soldi riescono ad assemblare il primo computer, fanno una sola consegna, guadagnano qualcosa. Ne fanno un altro. La cosa sembra andare. Ma per decollare ci vuole un capitale maggiore. “Chiediamo un prestito”. Vanno in banca. “Mandatemi i vostri genitori, non facciamo credito a chi non ha niente”, gli dice il direttore della filiale. I due tornano nel garage. Come fare? Mentre ci pensano bussano alla porta. Sono i vigili urbani. “Ci hanno detto che qui state facendo un’attività commerciale. Possiamo vedere i documenti?”. “Che documenti? Stiamo solo sperimentando”. “Ci risulta che avete venduto dei computer”. I vigili sono stati chiamati da un negozio che sta di fronte. I ragazzi non hanno documenti, il garage non è a norma, non c’è impianto elettrico salvavita, non ci sono bagni, l’attività non ha partita Iva. Il verbale è salato. Ma se tirano fuori qualche soldo di mazzetta, si appara tutto. Gli danno il primo guadagno e apparano. Ma il giorno dopo arriva la Finanza. Devono apparare pure la Finanza. E poi l’ispettorato del Lavoro. E l’ufficio Igiene. Il gruzzolo iniziale è volato via. Se ne sono andati i primi guadagni. Intanto l’idea sta lì. I primi acquirenti chiamano entusiasti, il computer va alla grande. Bisogna farne altri, a qualunque costo. Ma dove prendere i soldi? Ci sono i fondi europei, gli incentivi all’autoimpresa. C’è un commercialista che sa fare benissimo queste pratiche. “State a posto, avete una idea bellissima. Sicuro possiamo avere un finanziamento a fondo perduto almeno di 100mila euro”. I due ragazzi pensano che è fatta. “Ma i soldi vi arrivano a rendicontazione, dovete prima sostenere le spese. Attrezzate il laboratorio, partire con le attività, e poi avrete i rimborsi. E comunque solo per fare la domanda dobbiamo aprire la partita Iva, registrare lo statuto dal notaio, aprire le posizioni previdenziali, aprire una pratica dal fiscalista, i libri contabili da vidimare, un conto corrente bancario, che a voi non aprono, lo dovete intestare a un vostro genitore. Mettetelo in società con voi. Poi qualcosa per la pratica, il mio onorario. E poi ci vuole qualcosa di soldi per oliare il meccanismo alla regione. C’è un amico a cui dobbiamo fare un regalo sennò il finanziamento ve lo scordate”. “Ma noi questi soldi non ce li abbiamo”. “Nemmeno qualcosa per la pratica? E dove vi avviate?”. I due ragazzi decidono di chiedere aiuto ai genitori. Vendono l’altro motorino, una collezione di fumetti. Mettono insieme qualcosa. Fanno i documenti, hanno partita iva, posizione Inps, libri contabili, conto corrente bancario. Sono una società. Hanno costi fissi. Il commercialista da pagare. La sede sociale è nel garage, non è a norma, se arrivano di nuovo i vigili, o la finanza, o l’Inps, o l’ispettorato del lavoro, o l’ufficio tecnico del Comune, o i vigili sanitari, sono altri soldi. Evitano di mettere l’insegna fuori della porta per non dare nell’occhio. All’interno del garage lavorano duro: assemblano i computer con pezzi di fortuna, un po’ comprati usati un po’ a credito. Fanno dieci computer nuovi, riescono a venderli. La cosa sembra poter andare. Ma un giorno bussano al garage. E’ la camorra. Sappiamo che state guadagnando, dovete fare un regalo ai ragazzi che stanno in galera. “Come sarebbe?”. “Pagate, è meglio per voi”. Se pagano, finiscono i soldi e chiudono. Se non pagano, gli fanno saltare in aria il garage. Se vanno alla polizia e li denunciano, se ne devono solo andare perchè hanno finito di campare. Se non li denunciano e scoprono la cosa, vanno in galera pure loro. Pagano. Ma non hanno più i soldi per continuare le attività. Il finanziamento dalla Regione non arriva, i libri contabili costano, bisogna versare l’Iva, pagare le tasse su quello che hanno venduto, il commercialista preme, i pezzi sono finiti, assemblare computer in questo modo diventa impossibile, il padre di Stefano Lavori lo prende da parte e gli dice “guagliò, libera questo garage, ci fittiamo i posti auto, che è meglio”. I due ragazzi si guardano e decidono di chiudere il loro sogno nel cassetto. Diventano garagisti. La Apple in Italia non sarebbe nata, perchè saremo pure affamati e folli, ma se nasci nel posto sbagliato rimani con la fame e la pazzia, e niente più.
AVVOCATI. ABILITATI COL TRUCCO
Facile dire: sono avvocato. In Italia dove impera la corruzione e la mafiosità, quale costo intrinseco può avere un appalto truccato, un incarico pubblico taroccato, od una falsificata abilitazione ad una professione?
Ecco perché dico: italiani, popolo di corrotti! Ipocriti che si scandalizzano della corruttela altrui.
Io sono Antonio Giangrande, noto autore di saggi pubblicati su Amazon, che raccontano questa Italia alla rovescia. A tal fine tra le tante opere da me scritte vi è “Concorsopoli ed esamopoli” che tratta degli esami e dei concorsi pubblici in generale. Tutti truccati o truccabili. Nessuno si salva. Inoltre, nel particolare, nel libro “Esame di avvocato, lobby forense, abilitazione truccata”, racconto, anche per esperienza diretta, quello che succede all’esame di avvocato. Di questo, sicuramente, non gliene fregherà niente a nessuno, neanche ai silurati a quest’esame farsa: la fiera delle vanità fasulle. Fatto sta che io non faccio la cronaca, ma di essa faccio storia, perché la quotidianità la faccio raccontare ai testimoni del loro tempo. Certo che anche di questo non gliene può fregar di meno a tutti. Ma la cronistoria di questi anni la si deve proprio leggere, affinchè, tu italiano che meriti, devi darti alla fuga dall’Italia, per poter avere una possibilità di successo.
Anche perché i furbetti sanno come cavarsela. Francesco Speroni principe del foro di Bruxelles. Il leghista Francesco Speroni, collega di partito dell’ing. Roberto Castelli che da Ministro della Giustizia ha inventato la pseudo riforma dei compiti itineranti, a sfregio delle commissioni meridionali, a suo dire troppo permissive all’accesso della professione forense. È l’ultima roboante voce del curriculum dell’eurodeputato leghista, nonché suocero del capogruppo alla Camera Marco Reguzzoni, laureato nel 1999 a Milano e dopo 12 anni abilitato a Bruxelles. Speroni ha avuto un problema nel processo di Verona sulle camicie verdi, ma poi si è salvato grazie all’immunità parlamentare. Anche lui era con Borghezio a sventolare bandiere verdi e a insultare l’Italia durante il discorso di Ciampi qualche anno fa, quando gli italiani hanno bocciato, col referendum confermativo, la controriforma costituzionale della devolution. E così commentò: “Gli italiani fanno schifo, l’Italia fa schifo perché non vuole essere moderna!”. Ecco, l’onorevole padano a maggio 2011 ha ottenuto l’abilitazione alla professione forense in Belgio (non come il ministro Gelmini che da Brescia ha scelto Reggio Calabria) dopo ben 12 anni dalla laurea conseguita a Milano. Speroni dunque potrà difendere “occasionalmente in tutta Europa” spiega lo stesso neoavvocato raggiunto telefonicamente da Elisabetta Reguitti de “Il Fatto quotidiano”.
Perché Bruxelles?
Perché in Italia è molto più difficile mentre in Belgio l’esame, non dico sia all’acqua di rose, ma insomma è certamente più facile. Non conosco le statistiche, ma qui le bocciature sono molte meno rispetto a quelle dell’esame di abilitazione in Italia”.
In quei mesi di tormenti a cavallo tra il 2000 e il 2001 Mariastelalla Gelmini si trova dunque a scegliere tra fare l’esame a Brescia o scendere giù in Calabria, spiegherà a Flavia Amabile: «La mia famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri, nulla. C'era una logica di casta, per fortuna poi modificata perché il sistema è stato completamente rivisto». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la tentazione era forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo deciso di farlo anche noi». Del resto, aggiunge, lei ha «una lunga consuetudine con il Sud. Una parte della mia famiglia ha parenti in Cilento». Certo, è a quasi cinquecento chilometri da Reggio. Ma sempre Mezzogiorno è. E l'esame? Com'è stato l'esame? «Assolutamente regolare». Non severissimo, diciamo, neppure in quella sessione. Quasi 57% di ammessi agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia. Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno. Così facevan tutti, dice Mariastella Gelmini.
La Calabria è bella perchè c’è sempre il sole, scrive Antonello Caporale su “La Repubblica”. Milano invece spesso è velata dalla nebbia. E’ bella la Calabria anche, per esempio, perchè il concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato sembra più a misura d’uomo. Non c’è il caos di Milano, diciamolo. E in una delle dure prove che la vita ci pone resiste quel minimo di comprensione, quell’alito di compassione… In Calabria c’è il sole, e l’abbiamo detto. Ma vuoi mettere il mare? ”Avevo bisogno di un luogo tranquillo, dove poter concentrarmi senza le distrazioni della mia città. Studiare e affrontare con serenità l’esame”. Ecco, questo bisogno ha portato Antonino jr. Giovanni Geronimo La Russa, il figlio di Ignazio, anch’egli avvocato ma soprattutto ministro della Difesa, a trasferirsi dalla Lombardia in Calabria. Laureato a pieni voti all’università Carlo Cattaneo, Geronimo si è abilitato con soddisfazione a Catanzaro a soli ventisei anni. Due anni ha risieduto a Crotone. Dal 25 luglio 2005, in piazza De Gasperi, nella casa di Pasquale Senatore, l’ex sindaco missino. E’ rimasto nella città di Pitagora fino al 18 gennaio 2007. E si è rigenerato. Un po’ come capitò a Mariastella Gelmini, anche lei col bisogno di esercitare al meglio la professione di avvocato prima di darsi alla politica, e anche lei scesa in Calabria per affrontare con ottimismo l’esame. La scelta meridionale si è rivelata azzeccata per lei e per lui. Il piccolo La Russa è tornato in Lombardia con la forza di un leone. E dopo la pratica nello studio Libonati-Jager, nemmeno trentenne è divenuto titolare dello studio di famiglia. Quattordici avvocati a corso di porta Vittoria. Bellissimo. “Ma è tutto merito mio. Mi scoccia di passare per figlio di papà”. Geronimo è amante delle auto d’epoca, ha partecipato a due storiche millemiglia. E infatti è anche vicepresidente dell’Aci di Milano. “Sono stato eletto, e allora?”. Nutre rispetto per il mattone. Siede nel consiglio di amministrazione della Premafin, holding di Ligresti, anche della Finadin, della International Strategy. altri gioiellini del del costruttore. Geronimo è socio dell’immobiliare di famiglia, la Metropol srl. Detiene la nuda proprietà dei cespiti che per parte di mamma ha nel centro di Riccione. Studioso e s’è visto. Ricco si è anche capito. Generoso, pure. Promuove infatti insieme a Barbara Berlusconi, Paolo Ligresti, Giulia Zoppas e tanti altri nomi glamour Milano Young, onlus benefica. Per tanti cervelli che fuggono all’estero, eccone uno che resta.
Geronimo, figlio di cotanto padre tutore di lobby e caste, che sa trovare le soluzioni ai suoi problemi.
Vittoria delle lobby di avvocati e commercialisti: riforma cancellata, scrive Lucia Palmerini. “…il governo formulerà alle categorie proposte di riforma.” con questa frase è stata annullata e cancellata la proposta di abolizione degli ordini professionali. Il Consiglio Nazionale Forense ha fatto appello ai deputati-avvocati per modificare la norma del disegno di legge del Ministero dell’Economia che prevedeva non solo l’eliminazione delle restrizioni all’accesso, ma la possibilità di diventare avvocato o commercialista dopo un praticantato di 2 anni nel primo caso e 3 nel secondo, l’abolizione delle tariffe minime ed il divieto assoluto alla limitazione dello svolgimento della professione da parte degli ordini. La presa di posizione degli avvocati del PdL ha rischiato di portare alla bocciatura la manovra economica al cui interno era inserita la norma su avvocati e commercialisti. Tra questi, Raffaello Masci, deputato-avvocato che ha preso in mano le redini della protesta, ha ottenuto l’appoggio del Ministro La Russa e del Presidente del Senato Schifani, tutti accomunati dalla professione di avvocato. La norma, apparsa per la prima volta ai primi di giugno, successivamente cancellata e nuovamente inserita nei giorni scorsi è stata definitivamente cancellata; il nuovo testo quanto mai inutile recita: “Il governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche si legge nel testo, e inoltre – trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.” La situazione non cambia e l’Ordine degli avvocati può dormire sogni tranquilli. Ancora una volta gli interessi ed i privilegi di una casta non sono stati minimamente scalfiti o messi in discussione.
GLI ANNI PASSANO, NULLA CAMBIA ED E’ TUTTO TEMPO PERSO.
Devo dire, per onestà, che il mio calvario è iniziato nel momento in cui ho incominciato la mia pratica forense. A tal proposito, assistendo alle udienze durante la mia pratica assidua e veritiera, mi accorgevo che il numero dei Praticanti Avvocato presenti in aula non corrispondeva alla loro reale entità numerica, riportata presso il registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. Mi accorsi, anche, che i praticanti, per l’opera prestata a favore del dominus, non ricevevano remunerazione, o ciò avveniva in nero, né per loro si pagavano i contributi. Chiesi conto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. Mi dissero “Fatti i fatti tuoi. Intanto facci vedere il libretto di pratica, che poi vediamo se diventi avvocato”. Controllarono il libretto, contestando la veridicità delle annotazioni e delle firme di controllo. Non basta. Nonostante il regolare pagamento dei bollettini di versamento di iscrizione, a mio carico venne attivata procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, contro la quale ho presentato opposizione, poi vinta. Di fatto: con lor signori in Commissione di esame forense, non sono più diventato avvocato. A dar loro manforte, sempre nelle commissioni d’esame, vi erano e vi sono i magistrati che io ho denunciato per le loro malefatte.
Sessione d’esame d’avvocato 1998-1999. Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce mi accorgo di alcune anomalie di legalità, tra cui il fatto che 6 Avetranesi su 6 vengono bocciati, me compreso, e che molti Commissari suggerivano ai candidati incapaci quanto scrivere nell’elaborato. Chi non suggeriva non impediva che gli altri lo facessero. Strano era, che compiti simili, copiati pedissequamente, erano valutati in modo difforme.
Sessione d’esame d’avvocato 1999-2000. Presidente di Commissione, Avv. Gaetano De Mauro, Principe del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. Sul Quotidiano di Lecce il Presidente della stessa Commissione d’esame dice che: “il numero degli avvocati è elevato e questa massa di avvocati è incompatibile con la realtà socio economica del Salento. Così nasce la concorrenza esasperata”. L’Avv. Pasquale Corleto nello stesso articolo aggiunge: “non basta studiare e qualificarsi, bisogna avere la fortuna di entrare in determinati circuiti, che per molti non sono accessibili”. L’abuso del potere della Lobby forense è confermato dall’Antitrust, che con provvedimento n. 5400, il 3 ottobre 1997 afferma: “ E' indubbio che, nel controllo dell'esercizio della professione, si sia pertanto venuto a determinare uno sbilanciamento tra lo Stato e gli Ordini e che ciò abbia potuto favorire la difesa di posizioni di rendita acquisite dai professionisti già presenti sul mercato.”
Sessione d’esame d’avvocato 2000-2001. Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. La percentuale di idonei si diversifica: 1998, 60 %, 1999, 25 %, 2000, 49 %, 2001, 36 %. Mi accorgo che paga essere candidato proveniente dalla sede di esame, perché, raffrontando i dati per le province del distretto della Corte D’Appello, si denota altra anomalia: Lecce, sede d’esame, 187 idonei; Taranto 140 idonei; Brindisi 59 idonei. Non basta, le percentuali di idonei per ogni Corte D’Appello nazionale variano dal 10% del Centro-Nord al 99% di Catanzaro. L’esistenza degli abusi è nel difetto e nell’eccesso della percentuale. Il TAR Lombardia, con ordinanza n.617/00, applicabile per i compiti corretti da tutte le Commissioni d’esame, rileva che i compiti non si correggono per mancanza di tempo. Dai verbali risultano corretti in 3 minuti. Con esperimento giudiziale si accerta che occorrono 6 minuti solo per leggere l’elaborato. Il TAR di Lecce, eccezionalmente contro i suoi precedenti, ma conforme a pronunzie di altri TAR, con ordinanza 1394/00, su ricorso n. 200001275 di Stefania Maritati, decreta la sospensiva e accerta che i compiti non si correggono, perché sono mancanti di glosse o correzioni, e le valutazioni sono nulle, perché non motivate. In sede di esame si disattende la Direttiva CEE 48/89, recepita con D.Lgs.115/92, che obbliga ad accertare le conoscenze deontologiche e di valutare le attitudini e le capacità di esercizio della professione del candidato, garantendo così l'interesse pubblico con equità e giustizia. Stante questo sistema di favoritismi, la Corte Costituzionale afferma, con sentenza n. 5 del 1999: "Il legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato, quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione". In quella situazione, presento denuncia penale contro la Commissione d’esame presso la Procura di Bari e alla Procura di Lecce, che la invia a Potenza. Inaspettatamente, pur con prove mastodontiche, le Procure di Potenza e Bari archiviano, senza perseguirmi per calunnia. Addirittura la Procura di Potenza non si è degnata di sentirmi.
Sessione d’esame d’avvocato 2001-2002. Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. L’on. Luca Volontè, alla Camera, il 5 luglio 2001, presenta un progetto di legge, il n. 1202, in cui si dichiara formalmente che in Italia gli esami per diventare avvocato sono truccati. Secondo la sua relazione diventano avvocati non i capaci e i meritevoli, ma i raccomandati e i fortunati. Tutto mira alla limitazione della concorrenza a favore della Lobby. Addirittura c’è chi va in Spagna per diventare avvocato, per poi esercitare in Italia senza fare l’esame. A questo punto, presso la Procura di Taranto, presento denuncia penale contro la Commissione d’esame di Lecce con accluse varie fonti di prova. Così fanno altri candidati con decine di testimoni a dichiarare che i Commissari suggeriscono. Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2002-2003. Presidente di Commissione, Avv. Luigi Rella, Principe del Foro di Lecce. Ispettore Ministeriale, Giorgino. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. Lo stesso Ministero della Giustizia, che indice gli esami di Avvocato, mi conferma che in Italia gli esami sono truccati. Non basta, il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, propone il decreto legge di modifica degli esami, attuando pedissequamente la volontà del Consiglio Nazionale Forense che, di fatto, sfiducia le Commissioni d’esame di tutta Italia. Gli Avvocati dubitano del loro stesso grado di correttezza, probità e legalità. In data 03/05/03, ad Arezzo si riunisce il Consiglio Nazionale Forense con i rappresentanti dei Consigli dell’Ordine locali e i rappresentanti delle associazioni Forensi. Decidono di cambiare perché si accorgono che in Italia i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati abusano del loro potere per essere rieletti, chiedendo conto delle raccomandazioni elargite, e da qui la loro incompatibilità con la qualità di Commissario d’esame. In data 16/05/03, in Consiglio dei Ministri viene accolta la proposta di Castelli, che adotta la decisione del Consiglio Nazionale Forense. Ma in quella sede si decide, anche, di sbugiardare i Magistrati e i Professori Universitari, in qualità di Commissari d’esame, prevedendo l’incompatibilità della correzione del compito fatta dalla stessa Commissione d’esame. Con D.L. 112/03 si stabilisce che il compito verrà corretto da Commissione territorialmente diversa e i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati non possono essere più Commissari. In Parlamento, in sede di conversione del D.L., si attua un dibattito acceso, riscontrabile negli atti parlamentari, dal quale scaturisce l’esistenza di un sistema concorsuale marcio ed illegale di accesso all’avvocatura. Il D.L. 112/03 è convertito nella Legge 180/03. I nuovi criteri prevedono l’esclusione punitiva dei Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati dalle Commissioni d’esame e la sfiducia nei Magistrati e i Professori Universitari per la correzione dei compiti. Però, acclamata istituzionalmente l’illegalità, si omette di perseguire per abuso d’ufficio tutti i Commissari d’esame. Non solo. Ad oggi continuano ad essere Commissari d’esame gli stessi Magistrati e i Professori Universitari, ma è allucinante che, nelle nuove Commissioni d’esame, fanno parte ex Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati, già collusi in questo stato di cose quando erano in carica. Se tutto questo non basta a dichiarare truccato l’esame dell’Avvocatura, il proseguo fa scadere il tutto in una illegale “farsa”. Il Ministero, alla prova di scritto di diritto penale, alla traccia n. 1, erroneamente chiede ai candidati cosa succede al Sindaco, che prima nega e poi rilascia una concessione edilizia ad un suo amico, sotto mentite spoglie di un’ordinanza. In tale sede i Commissari penalisti impreparati suggerivano in modo sbagliato. Solo io rilevavo che la traccia era errata, in quanto riferita a sentenze della Cassazione riconducibili a violazioni di legge non più in vigore. Si palesava l’ignoranza dell’art.107, D.Lgs. 267/00, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in cui si dispongono le funzioni dei dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01, Testo Unico in materia edilizia. Da molti anni, con le varie Bassanini, sono entrate in vigore norme, in cui si prevede che è competente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune a rilasciare o a negare le concessioni edilizie. Rilevavo che il Sindaco era incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava per scontato il comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con il Sindaco e conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla Magistratura. Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15 (il minimo) al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati che hanno scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei. Durante la trasmissione “Diritto e Famiglia” di Studio 100, lo stesso Presidente dell’Ordine di Taranto, Egidio Albanese, ebbe a dire: “l’esame è blando, l’Avvocatura è un parcheggio per chi vuol far altro, diventa avvocato il fortunato, perché la fortuna aiuta gli audaci”. Si chiede copia del compito con la valutazione contestata. Si ottiene, dopo esborso di ingente denaro, per vederlo immacolato. Non contiene una correzione, né una motivazione alla valutazione data. Intanto, il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza n.2331/03, non giustifica più l’abuso, indicando l’obbligatorietà della motivazione. Su queste basi di fatto e di diritto si presenta il ricorso al TAR. Il TAR, mi dice: “ dato che si disconosce il tutto, si rigetta l’istanza di sospensiva. Su queste basi vuole che si vada nel merito, per poi decidere sulle spese di giudizio?”
Sessione d’esame d’avvocato 2003-2004. Presidente di Commissione, Avv. Francesco Galluccio Mezio, Principe del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. I candidati continuano a copiare dai testi, dai telefonini, dai palmari, dai compiti passati dai Commissari. I candidati continuano ad essere aiutati dai suggerimenti dei Commissari. I nomi degli idonei circolano mesi prima dei risultati. I candidati leccesi, divenuti idonei, come sempre, sono la stragrande maggioranza rispetto ai brindisini e ai tarantini. Alla richiesta di visionare i compiti, senza estrarre copia, in segreteria, per ostacolarmi, non gli basta l’istanza orale, ma mi impongono la tangente della richiesta formale con perdita di tempo e onerose spese accessorie. Arrivano a minacciare la chiamata dei Carabinieri se non si fa come impongono loro, o si va via. Le anomalie di regolarità del Concorso Forense, avendo carattere generale, sono state oggetto della denuncia formale presentata presso le Procure Antimafia e presso tutti i Procuratori Generali delle Corti d’Appello e tutti i Procuratori Capo della Repubblica presso i Tribunali di tutta Italia. Si presenta l’esposto al Presidente del Consiglio e al Ministro della Giustizia, al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e Giustizia del Senato. La Gazzetta del Mezzogiorno, in data 25/05/04, pubblica la notizia che altri esposti sono stati presentati contro la Commissione d’esame di Lecce (vedi Michele D’Eredità). Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2004-2005. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Marcello Marcuccio, Principe del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. Durante le prove d’esame ci sono gli stessi suggerimenti e le stesse copiature. I pareri motivati della prova scritta avvenuta presso una Commissione d’esame vengono corretti da altre Commissioni. Quelli di Lecce sono corretti dalla Commissione d’esame di Torino, che da anni attua un maggiore sbarramento d’idoneità. Ergo: i candidati sanno in anticipo che saranno bocciati in numero maggiore a causa dell’illegale limitazione della concorrenza professionale. Presento l’ennesima denuncia presso la Procura di Potenza, la Procura di Bari, la Procura di Torino e la Procura di Milano, e presso i Procuratori Generali e Procuratori Capo di Lecce, Bari, Potenza e Taranto, perché tra le altre cose, mi accorgo che tutti i candidati provenienti da paesi amministrati da una parte politica, o aventi Parlamentari dello stesso colore, sono idonei in percentuale molto maggiore. Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2005-2006. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Raffaele Dell’Anna. Principe del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. Addirittura i Commissari dettavano gli elaborati ai candidati. Gente che copiava dai testi. Gente che copiava dai palmari. Le valutazioni delle 7 Sottocommissioni veneziane non sono state omogenee, se non addirittura contrastanti nei giudizi. Il Tar di Salerno, Ordinanza n.1474/2006, conforme al Tar di Lecce, Milano e Firenze, dice che l’esame forense è truccato. I Tar stabiliscono che i compiti non sono corretti perché non vi è stato tempo sufficiente, perché non vi sono correzioni, perché mancano le motivazioni ai giudizi, perché i giudizi sono contrastanti, anche in presenza di compiti copiati e non annullati. Si è presentata l’ulteriore denuncia a Trento e a Potenza. Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2006-2007. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Giangaetano Caiaffa. Principe del Foro di Lecce. Presente l’Ispettore Ministeriale Vito Nanna. I posti a sedere, negli anni precedenti assegnati in ordine alfabetico, in tale sessione non lo sono più, tant’è che si sono predisposti illecitamente gruppi di ricerca collettiva. Nei giorni 12,13,14 dicembre, a dispetto dell’orario di convocazione delle ore 07.30, si sono letti i compiti rispettivamente alle ore 11.45, 10.45, 11.10. Molte ore dopo rispetto alle ore 09.00 delle altre Commissioni d’esame. Troppo tardi, giusto per agevolare la dettatura dei compiti tramite cellulari, in virtù della conoscenza sul web delle risposte ai quesiti posti. Commissione di correzione degli scritti è Palermo. Per ritorsione conseguente alle mie lotte contro i concorsi forensi truccati e lo sfruttamento dei praticanti, con omissione di retribuzione ed evasione fiscale e contributiva, dopo 9 anni di bocciature ritorsive all’esame forense e ottimi pareri resi, quest’anno mi danno 15, 15, 18 per i rispettivi elaborati, senza correzioni e motivazioni: è il minimo. Da dare solo a compiti nulli. La maggior parte degli idonei è leccese, in concomitanza con le elezioni amministrative, rispetto ai tarantini ed ai brindisini. Tramite le televisioni e i media nazionali si promuove un ricorso collettivo da presentare ai Tar di tutta Italia contro la oggettiva invalidità del sistema giudiziale rispetto alla totalità degli elaborati nel loro complesso: per mancanza, nelle Sottocommissioni di esame, di tutte le componenti professionali necessarie e, addirittura, del Presidente nominato dal Ministero della Giustizia; per giudizio con motivazione mancante, o illogica rispetto al quesito, o infondata per mancanza di glosse o correzioni, o incomprensibile al fine del rimedio alla reiterazione degli errori; giudizio contrastante a quello reso per elaborati simili; giudizio non conforme ai principi di correzione; giudizio eccessivamente severo; tempo di correzione insufficiente. Si presenta esposto penale contro le commissioni di Palermo, Lecce, Bari, Venezia, presso le Procure di Taranto, Lecce, Potenza, Palermo, Caltanissetta, Bari, Venezia, Trento. Il Pubblico Ministero di Palermo archivia immediatamente, iscrivendo il procedimento a carico di ignoti, pur essendoci chiaramente indicati i 5 nomi dei Commissari d’esame denunciati. I candidati di Lecce disertano in modo assoluto l’iniziativa del ricorso al Tar. Al contrario, in altre Corti di Appello vi è stata ampia adesione, che ha portato a verificare, comparando, modi e tempi del sistema di correzione. Il tutto a confermare le illegalità perpetrate, che rimangono impunite.
Sessione d’esame d’avvocato 2007-2008. Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Massimo Fasano, Principe del Foro di Lecce. Addirittura uno scandalo nazionale ha sconvolto le prove scritte: le tracce degli elaborati erano sul web giorni prima rispetto alla loro lettura in sede di esame. Le risposte erano dettate da amici e parenti sul cellulare e sui palmari dei candidati. Circostanza da sempre esistita e denunciata dal sottoscritto nell’indifferenza generale. Questa volta non sono solo. Anche il Sottosegretario del Ministero dell’Interno, On. Alfredo Mantovano, ha presentato denuncia penale e una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, chiedendo la nullità della prova, così come è successo per fatto analogo a Bari, per i test di accesso alla Facoltà di Medicina. Anche per lui stesso risultato: insabbiamento dell’inchiesta.
Sessione d’esame d’avvocato 2008-2009. Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Pietro Nicolardi, Principe del Foro di Lecce. E’ la undicesima volta che mi presento a rendere dei pareri legali. Pareri legali dettati ai candidati dagli stessi commissari o dai genitori sui palmari. Pareri resi su tracce già conosciute perché pubblicate su internet o perché le buste sono aperte ore dopo rispetto ad altre sedi, dando il tempo ai candidati di farsi passare il parere sui cellulari. Pareri di 5 o 6 pagine non letti e corretti, ma dichiarati tali in soli 3 minuti, nonostante vi fosse l’onere dell’apertura di 2 buste, della lettura, della correzione, del giudizio, della motivazione e della verbalizzazione. Il tutto fatto da commissioni illegittime, perché mancanti dei componenti necessari e da giudizi nulli, perché mancanti di glosse, correzioni e motivazioni. Il tutto fatto da commissioni che limitano l’accesso e da commissari abilitati alla professione con lo stesso sistema truccato. Da quanto emerge dal sistema concorsuale forense, vi è una certa similitudine con il sistema concorsuale notarile e quello giudiziario e quello accademico, così come le cronache del 2008 ci hanno informato. Certo è che se nulla hanno smosso le denunce del Ministro dell’Istruzione, Gelmini, lei di Brescia costretta a fare gli esami a Reggio Calabria, e del Sottosegretario al Ministero degli Interni, Mantovano, le denunce insabbiate dal sottoscritto contro i concorsi truccati, mi porteranno, per ritorsione, ad affrontare l’anno prossimo per la dodicesima volta l’esame forense, questa volta con mio figlio Mirko. Dopo essere stato bocciato allo scritto dell’esame forense per ben 11 volte, che ha causato la mia indigenza ho provato a visionare i compiti, per sapere quanto fossi inetto. Con mia meraviglia ho scoperto che il marcio non era in me. La commissione esaminatrice di Reggio Calabria era nulla, in quanto mancante di una componente necessaria. Erano 4 avvocati e un magistrato. Mancava la figura del professore universitario. Inoltre i 3 temi, perfetti in ortografia, sintassi e grammatica, risultavano visionati e corretti in soli 5 minuti, compresi i periodi di apertura di 6 buste e il tempo della consultazione, valutazione ed estensione del giudizio. Tempo ritenuto insufficiente da molti Tar. Per questi motivi, senza entrare nelle tante eccezioni da contestare nel giudizio, compresa la comparazione di compiti identici, valutati in modo difforme, si appalesava la nullità assoluta della decisione della commissione, già acclarata da precedenti giurisprudenziali. Per farmi patrocinare, ho provato a rivolgermi ad un principe del foro amministrativo di Lecce. Dal noto esponente politico non ho meritato risposta. Si è di sinistra solo se si deve avere, mai se si deve dare. L’istanza di accesso al gratuito patrocinio presentata personalmente, dopo settimane, viene rigettata. Per la Commissione di Lecce c’è indigenza, ma non c’è motivo per il ricorso!!! Nel processo amministrativo si rigettano le istanze di ammissione al gratuito patrocinio per il ricorso al Tar per mancanza di “fumus”: la commissione formata ai sensi della finanziaria 2007 (Governo Prodi) da 2 magistrati del Tar e da un avvocato, entra nel merito, adottando una sentenza preventiva senza contraddittorio, riservandosi termini che rasentano la decadenza per il ricorso al Tar.
Sessione d’esame d’avvocato 2009-2010. Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Angelo Pallara, Principe del Foro di Lecce. Nella sua sessione, nonostante i candidati fossero meno della metà degli altri anni, non ci fu notifica postale dell’ammissione agli esami. E’ la dodicesima volta che mi presento. Questa volta con mio figlio Mirko. Quantunque nelle sessioni precedenti i miei compiti non fossero stati corretti e comunque giudicate da commissioni illegittime, contro le quali mi è stato impedito il ricorso al Tar. Le mie denunce penali presentate a Lecce, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, e i miei esposti ministeriali: tutto lettera morta. Alle mie sollecitazioni il Governo mi ha risposto: hai ragione, provvederemo. Il provvedimento non è mai arrivato. Intanto il Ministro della Giustizia nomina ispettore ministeriale nazionale per questa sessione, come negli anni precedenti, l’avv. Antonio De Giorgi, già Presidente di commissione di esame di Lecce, per gli anni 1998-99, 2000-01, 2001-02, e ricoprente l’incarico di presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Insomma è tutta una presa in giro: costui con la riforma del 2003 è incompatibile a ricoprire l’incarico di presidente di sottocommissione, mentre, addirittura, viene nominato ispettore su un concorso che, quando lui era presidente, veniva considerato irregolare. Comunque è di Avetrana (TA) l’avvocato più giovane d’Italia. Il primato è stabilito sul regime dell’obbligo della doppia laurea. 25 anni. Mirko Giangrande, classe 1985. Carriera scolastica iniziata direttamente con la seconda elementare; con voto 10 a tutte le materie al quarto superiore salta il quinto ed affronta direttamente la maturità. Carriera universitaria nei tempi regolamentari: 3 anni per la laurea in scienze giuridiche; 2 anni per la laurea magistrale in giurisprudenza. Praticantato di due anni e superamento dell’esame scritto ed orale di abilitazione al primo colpo, senza l’ausilio degli inutili ed onerosi corsi pre esame organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Et Voilà, l’avvocato più giovane d’Italia. Cosa straordinaria: non tanto per la giovane età, ma per il fatto che sia avvenuta contro ogni previsione, tenuto conto che Mirko è figlio di Antonio Giangrande, noto antagonista della lobby forense e della casta giudiziaria ed accademica. Ma nulla si può contro gli abusi e le ritorsioni, nonostante che ogni anno in sede di esame tutti coloro che gli siedono vicino si abilitano con i suoi suggerimenti. Volontariato da educatore presso l’oratorio della parrocchia di Avetrana, e volontariato da assistente e consulente legale presso l’Associazione Contro Tutte le Mafie, con sede nazionale proprio ad Avetrana, fanno di Mirko Giangrande un esempio per tanti giovani, non solo avetranesi. Questo giustappunto per evidenziare una notizia positiva attinente Avetrana, in alternativa a quelle sottaciute ed alle tante negative collegate al caso di Sarah Scazzi. L’iscrizione all’Albo compiuta a novembre nonostante l’abilitazione sia avvenuta a settembre, alla cui domanda con allegati l’ufficio non rilascia mai ricevuta, è costata in tutto la bellezza di 650 euro tra versamenti e bolli. Ingenti spese ingiustificate a favore di caste-azienda, a cui non corrispondono degni ed utili servizi alle migliaia di iscritti. Oltretutto oneri non indifferenti per tutti i neo avvocati, che non hanno mai lavorato e hanno sopportato con sacrifici e privazioni ingenti spese per anni di studio. Consiglio dell’Ordine di Taranto che, come riportato dalla stampa sul caso Sarah Scazzi, apre un procedimento contro i suoi iscritti per sovraesposizione mediatica, accaparramento illecito di cliente e compravendita di atti ed interviste (Galoppa, Russo e Velletri) e nulla dice, invece, contro chi, avvocati e consulenti, si è macchiato delle stesse violazioni, ma che, venuto da lontano, pensa che Taranto e provincia sia terra di conquista professionale e tutto possa essere permesso. Figlio di famiglia indigente ed oppressa: il padre, Antonio Giangrande, perseguitato (abilitazione forense impedita da 12 anni; processi, senza condanna, di diffamazione a mezzo stampa per articoli mai scritti e di calunnia per denunce mai presentate in quanto proprio le denunce presentate sono regolarmente insabbiate; dibattimenti in cui il giudice è sempre ricusato per grave inimicizia perché denunciato). Perseguitato perché noto antagonista del sistema giudiziario e forense tarantino, in quanto combatte e rende note le ingiustizie e gli abusi in quel che viene definito “Il Foro dell’Ingiustizia”. (insabbiamenti; errori giudiziari noti: Morrone, Pedone, Sebai; magistrati inquisiti e arrestati). Perseguitato perché scrive e dice tutto quello che si tace.
Sessione d’esame d’avvocato 2010-2011. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Maurizio Villani, Principe del Foro di Lecce. Compresa la transumanza di candidati da un'aula all'altra per fare gruppo. Presente anche il Presidente della Commissione Centrale Avv. Antonio De Giorgi, contestualmente componente del Consiglio Nazionale Forense, in rappresentanza istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del distretto della Corte di Appello di Lecce. Tutto verificabile dai siti web di riferimento. Dubbi e critica sui modi inopportuni di nomina. Testo del Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le modificazioni coordinate con la legge di conversione 18 Luglio 2003, n. 180: “Art. 1-bis: ….5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine…”. Antonio De Giorgi è un simbolo del vecchio sistema ante riforma, ampiamente criticato tanto da riformarlo a causa della “Mala Gestio” dei Consiglieri dell’Ordine in ambito della loro attività come Commissari d’esame. Infatti Antonio De Giorgi è stato a fasi alterne fino al 2003 Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e contestualmente Presidente di sottocommissioni di esame di quel Distretto. Oggi ci ritroviamo ancora Antonio De Giorgi, non più come Presidente di sottocommissione, ma addirittura come presidente della Commissione centrale. La norma prevede, come membro di commissione e sottocommissione, la nomina di avvocati, ma non di consiglieri dell’Ordine. Come intendere la carica di consigliere nazionale forense indicato dal Consiglio dell’Ordine di Lecce, se non la sua estensione istituzionale e, quindi, la sua incompatibilità alla nomina di Commissario d’esame. E quantunque ciò non sia vietato dalla legge, per la ratio della norma e per il buon senso sembra inopportuno che, come presidente di Commissione centrale e/o sottocommissione periferica d’esame, sia nominato dal Ministro della Giustizia non un avvocato designato dal Consiglio Nazionale Forense su proposta dei Consigli dell'Ordine, ma addirittura un membro dello stesso Consiglio Nazionale Forense che li designa. Come è inopportuno che sia nominato chi sia l’espressione del Consiglio di appartenenza e comunque che sia l’eredità di un sistema osteggiato. Insomma, qui ci stanno prendendo in giro: si esce dalla porta e si entra dalla finestra. Cosa può pensare un candidato che si sente dire dai presidenti Villani e De Giorgi, siamo 240 mila e ci sono quest’anno 23 mila domande, quindi ci dobbiamo regolare? Cosa può pensare Antonio Giangrande, il quale ha denunciato negli anni le sottocommissioni comprese quelle presiedute da Antonio De Giorgi (sottocommissioni a cui ha partecipato come candidato per ben 13 anni e che lo hanno bocciato in modo strumentale), e poi si accorge che il De Giorgi, dopo la riforma è stato designato ispettore ministeriale, e poi, addirittura, è diventato presidente della Commissione centrale? Cosa può pensare Antonio Giangrande, quando verifica che Antonio De Giorgi, presidente anche delle sottocommissioni denunciate, successivamente ha avuto rapporti istituzionali con tutte le commissioni d’esame sorteggiate, competenti a correggere i compiti di Lecce e quindi anche del Giangrande? "A pensare male, spesso si azzecca..." disse Giulio Andreotti. Nel procedimento 1240/2011, in cui si sono presentati ben 8 motivi di nullità dei giudizi (come in allegato), il TAR rigetta il ricorso del presente istante, riferendosi alla sentenza della Corte Costituzionale, oltre ad addurre, pretestuosamente, motivazioni estranee ai punti contestati (come si riscontra nella comparazione tra le conclusioni e il dispositivo in allegato). Lo stesso TAR, invece, ha disposto la misura cautelare per un ricorso di altro candidato che contestava un solo motivo, (procedimento 746/2009). Addirittura con ordinanza 990/2010 accoglieva l’istanza cautelare entrando nel merito dell’elaborato. Ordinanza annullata dal Consiglio di Stato, sez. IV, 22 febbraio 2011, n. 595. TENUTO CONTO CHE IN ITALIA NON VI E' GIUSTIZIA SI E' PRESENTATO RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI. Qui si rileva che la Corte di Cassazione, nonostante la fondatezza della pretesa, non ha disposto per motivi di Giustizia e di opportunità la rimessione dei processi dell’istante ai sensi dell’art. 45 ss. c.p.p.. Altresì qui si rileva che la Corte di Cassazione, sistematicamente, rigetta ogni istanza di rimessione da chiunque sia presentata e qualunque ne sia la motivazione. Inoltre qui si rileva che la Corte Costituzionale legittima per tutti i concorsi pubblici la violazione del principio della trasparenza. Trasparenza, da cui dedurre l’inosservanza delle norme sulla legalità, imparzialità ed efficienza.
Sessione d’esame d’avvocato 2011-2012. Tutto come prima. Spero che sia l'ultima volta. Presidente di Commissione, Avv. Nicola Stefanizzo, Principe del Foro di Lecce. Foro competente alla correzione: Salerno. Dal sito web della Corte d’Appello di Lecce si vengono a sapere le statistiche dell'anno 2011: Totale Candidati iscritti 1277 di cui Maschi 533 Femmine 744. Invece le statistiche dell'anno 2010: Totale Candidati inscritti 1161 di cui Maschi 471 Femmine 690. Ammessi all'orale 304; non Ammessi dalla Commissione di Palermo 857 (74%). Si è presentata denuncia penale a tutte le procure presso le Corti d'Appello contro le anomalie di nomina della Commissione centrale d'esame, oltre che contro la Commissione di Palermo, in quanto questa ha dichiarato falsamente come corretti i compiti del Dr Antonio Giangrande, dando un 25 senza motivazione agli elaborati non corretti. Contestualmente si è denunciato il Tar di Lecce che ha rigettato il ricorso indicanti molteplici punti di nullità al giudizio dato ai medesimi compiti. Oltretutto motivi sostenuti da corposa giurisprudenza. Invece lo stesso Tar ha ritenuto ammissibili le istanze di altri ricorsi analoghi, per giunta valutando il merito degli stessi elaborati. Antonio Giangrande, l’alfiere contro i concorsi truccati, che per gli ipocriti è un mitomane sfigato, presenta il conto. Anzi il rendiconto di un'Italia da schifo dove tutti si ergono a benpensanti e poi sono i primi a fottere la legge ed i loro conterranei. Un giudizio sull’operato di un certo giornalismo lo debbo proprio dare, tenuto conto che è noto il mio giudizio su un sistema di potere che tutela se stesso, indifferente ai cambiamenti sociali ed insofferente nei confronti di chi si ribella. Da anni sui miei siti web fornisco le prove su come si trucca un concorso pubblico, nella fattispecie quello di avvocato, e su come si paga dazio nel dimostrarlo. Nel tempo la tecnica truffaldina, di un concorso basato su regole di un millennio fa, si è affinata trovando sponda istituzionale. La Corte Costituzionale il 7 giugno 2011, con sentenza n. 175, dice: è ammesso il giudizio non motivato, basta il voto. Alla faccia della trasparenza e del buon andamento e della legalità. Insomma dove prima era possibile contestare ora non lo è più. D'altronde la Cassazione ammette: le commissioni sbagliano ed il Tar può sindacare i loro giudizi. Ad affermare l’importante principio di diritto sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 8412, depositata il 28 maggio 2012. L’essere omertosi sulla cooptazione abilitativa di una professione od incarico, mafiosamente conforme al sistema, significa essere complici e quindi poco credibili agli occhi dei lettori e telespettatori, che, come dalla politica, si allontana sempre più da un certo modo di fare informazione. Il fatto che io non trovi solidarietà e sostegno in chi dovrebbe raccontare i fatti, mi lascia indifferente, ma non silente sul malaffare che si perpetra intorno a me ed è taciuto da chi dovrebbe raccontarlo. Premiale è il fatto che i miei scritti sono letti in tutto il mondo, così come i miei video, in centinaia di migliaia di volte al dì, a differenza di chi e censorio. Per questo è ignorato dal cittadino che ormai, in video o in testi, non trova nei suoi servizi giornalistici la verità, se non quella prona al potere. Dopo 15 anni, dal 1998 ancora una volta bocciato all’esame di avvocato ed ancora una volta a voler trovare sponda per denunciare una persecuzione. Non perché voglia solo denunciare l’esame truccato per l’abilitazione in avvocatura, di cui sono vittima, ma perché lo stesso esame sia uguale a quello della magistratura (con i codici commentati vietati, ma permessi ad alcuni), del notariato (tracce già svolte), dell’insegnamento accademico (cattedra da padre in figlio) e di tanti grandi e piccoli concorsi nazionali o locali. Tutti concorsi taroccati, così raccontati dalla cronaca divenuta storia. Per ultimo si è parlato del concorso dell’Agenzia delle Entrate (inizio dell’esame con ore di ritardo e con il compito già svolto) e del concorso dell’Avvocatura dello Stato (con i codici commentati vietati, ma permessi ad alcuni). A quest’ultimi candidati è andata anche peggio rispetto a me: violenza delle Forze dell’Ordine sui candidati che denunciavano l’imbroglio. Non che sia utile trovare una sponda che denunci quanto io sostengo con prove, tanto i miei rumors fanno boato a sè, ma si appalesa il fatto che vi è una certa disaffezione per quelle categorie che giornalmente ci offrono con la cronaca il peggio di sé: censura ed omertà. Per qualcuno forse è meglio che a me non sia permesso di diventare avvocato a cause delle mie denunce presentate a chi, magistrato, oltre che omissivo ad intervenire, è attivo nel procrastinare i concorsi truccati in qualità di commissari. Sia chiaro a tutti: essere uno dei 10mila magistrati, uno dei 200mila avvocati, uno dei mille parlamentari, uno dei tanti professori o giornalisti, non mi interessa più, per quello che è il loro valore reale, ma continuerò a partecipare al concorso forense per dimostrare dall’interno quanto sia insano. Chi mi vuol male, per ritorsione alle mie lotte, non mi fa diventare avvocato, ma vorrebbe portarmi all’insana esasperazione di Giovanni Vantaggiato, autore della bomba a Brindisi. Invece, questi mi hanno fatto diventare l’Antonio Giangrande: fiero di essere diverso! Antonio Giangrande che con le sue deflagrazioni di verità, rompe l’omertà mafiosa. L’appoggio per una denuncia pubblica non lo chiedo per me, che non ne ho bisogno, ma una certa corrente di pensiero bisogna pur attivarla, affinché l’esasperazione della gente non travolga i giornalisti, come sedicenti operatori dell’informazione, così come già avvenuto in altri campi. E gli operatori dell’informazione se non se ne sono accorti, i ragazzi di Brindisi sono stati lì a ricordarglielo. Si è visto la mafia dove non c’è e non la si indica dove è chiaro che si annida. Tutti gli altri intendono “Tutte le Mafie” come un insieme orizzontale di entità patologiche criminali territoriali (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, ecc.). Io intendo “Tutte le Mafie” come un ordinamento criminale verticale di entità fisiologiche nazionali composte, partendo dal basso: dalle mafie (la manovalanza), dalle Lobbies, dalle Caste e dalle Massonerie (le menti). La Legalità è il comportamento umano conforme al dettato della legge nel compimento di un atto o di un fatto. Se l'abito non fa il monaco, e la cronaca ce lo insegna, nè toghe, nè divise, nè poteri istituzionali o mediatici hanno la legittimazione a dare insegnamenti e/o patenti di legalità. Lor signori non si devono permettere di selezionare secondo loro discrezione la società civile in buoni e cattivi ed ovviamente si devono astenere dall'inserirsi loro stessi tra i buoni. Perchè secondo questa cernita il cattivo è sempre il povero cittadino, che oltretutto con le esose tasse li mantiene. Non dimentichiamoci che non ci sono dio in terra e fino a quando saremo in democrazia, il potere è solo prerogativa del popolo. Quindi abolizione dei concorsi truccati e liberalizzazione delle professioni. Che sia il libero mercato a decidere chi merita di esercitare la professione in base alle capacità e non in virtù della paternità o delle amicizie. Un modo per poter vincere la nostra battaglia ed abolire ogni esame truccato di abilitazione, c'è! Essere in tanti a testimoniare il proprio dissenso. Ognuno di noi, facente parte dei perdenti, inviti altri ad aderire ad un movimento di protesta, affinchè possiamo essere migliaia e contare politicamente per affermare la nostra idea. Generalmente si è depressi e poco coraggiosi nell'affrontare l'esito negativo di un concorso pubblico. Se già sappiamo che è truccato, vuol dire che la bocciatura non è a noi addebitale. Cambiamo le cose, aggreghiamoci, contiamoci attraverso facebook. Se siamo in tanti saremo appetibili e qualcuno ci rappresenterà in Parlamento. Altrimenti ci rappresenteremo da soli. Facciamo diventare questo dissenso forte di migliaia di adesioni. Poi faremo dei convegni e poi delle manifestazioni. L'importante far sapere che il candidato perdente non sarà mai solo e potremo aspirare ad avere una nuova classe dirigente capace e competente.
Sessione d’esame d’avvocato 2012-2013. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Francesco Flascassovitti, Principe del Foro di Lecce, il quale ha evitato la transumanza di candidati da un'aula all'altra per fare gruppo con una semplice soluzione: il posto assegnato. Ma ciò non ha evitato l’espulsione di chi è stato scoperto a copiare da fonti non autorizzate o da compiti stilati forse da qualche commissario, oppure smascherato perché scriveva il tema sotto dettatura da cellulare munito di auricolare. Peccato per loro che si son fatti beccare. Tutti copiavano, così come hanno fatto al loro esame gli stessi commissari che li hanno cacciati. Ed è inutile ogni tentativo di apparir puliti. Quattromila aspiranti avvocati si sono presentati alla Nuova Fiera di Roma per le prove scritte dell'esame di abilitazione forense 2012. I candidati si sono presentati all'ingresso del secondo padiglione della Fiera sin dalle prime ore del mattino, perchè a Roma c'è l'obbligo di consegnare i testi il giorno prima, per consentire alla commissione di controllare che nessuno nasconda appunti all'interno. A Lecce sono 1.341 i giovani (e non più giovani come me) laureati in Giurisprudenza. Foro competente alla correzione: Catania. Un esame di Stato che è diventato un concorso pubblico, dove chi vince, vince un bel niente. Intanto il mio ricorso, n. 1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro la valutazione insufficiente data alle prove scritte della sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda di fissazione dell’udienza di trattazione, non ha prodotto alcun giudizio, tanto da farmi partecipare, nelle more ed in pendenza dell’esito del ricorso, a ben altre due sessioni successive, il cui esito è identico ai 15 anni precedenti: compiti puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più punti. Per l’inerzia del Tar è stati costretti di presentare istanza di prelievo il 09/07/2012. Dall’udienza fissata e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Ormai l’esame lo si affronta non tanto per superarlo, in quanto dopo 15 anni non vi è più soddisfazione, dopo una vita rovinata non dai singoli commissari, avvocati o magistrati o professori universitari, che magari sono anche ignari su come funziona il sistema, ma dopo una vita rovinata da un intero sistema mafioso, che si dipinge invece, falsamente, probo e corretto, ma lo si affronta per rendere una testimonianza ai posteri ed al mondo. Per raccontare, insomma, una realtà sottaciuta ed impunita. A Lecce sarebbero solo 440 su 1258 i compiti ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania, presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame: troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale, so che alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20 minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Da 20 anni denuncio che in Italia agli esami tutti si copia ed adesso scoprono l’acqua calda. E copiano tutti. Si ricordi il “Vergogna, Vergogna” all’esame per magistrato o il “Buffoni, Buffoni” all’esame di notaio, o le intemperanze agli esami per l’avvocatura di Stato o la prova annullata per l’esame di notaio nel 2010 o di magistrato nel 1992. Sarebbe il colmo dei paradossi se tra quei 100 ci fosse il mio nome. A parlar di sé e delle proprie disgrazie in prima persona, oltre a non destare l’interesse di alcuno pur nelle tue stesse condizioni, può farti passare per mitomane o pazzo. Non sto qui a promuovermi, tanto chi mi conosce sa cosa faccio anche per l’Italia e per la sua città. Non si può, però, tacere la verità storica che ci circonda, stravolta da verità menzognere mediatiche e giudiziarie. Ad ogni elezione legislativa ci troviamo a dover scegliere tra: il partito dei condoni; il partito della CGIL; il partito dei giudici. Io da anni non vado a votare perché non mi rappresentano i nominati in Parlamento. A questo punto mi devono spiegare cosa centra, per esempio, la siciliana Anna Finocchiaro con la Puglia e con Taranto in particolare. Oltretutto mi disgustano le malefatte dei nominati. Un esempio per tutti, anche se i media lo hanno sottaciuto. La riforma forense, approvata con Legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra gli ultimi interventi legislativi consegnatici frettolosamente dal Parlamento prima di cessare di fare danni. I nonni avvocati in Parlamento (compresi i comunisti) hanno partorito, in previsione di un loro roseo futuro, una contro riforma fatta a posta contro i giovani. Ai fascisti che hanno dato vita al primo Ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36) questa contro riforma reazionaria gli fa un baffo. Trattasi di una “riforma”, scritta come al solito negligentemente, che non viene in alcun modo incontro ed anzi penalizza in modo significativo i giovani. Da venti anni inascoltato denuncio il malaffare di avvocati e magistrati ed il loro malsano accesso alla professione. Cosa ho ottenuto a denunciare i trucchi per superare l’esame? Insabbiamento delle denunce e attivazione di processi per diffamazione e calunnia, chiusi, però, con assoluzione piena. Intanto ti intimoriscono. Ed anche la giustizia amministrativa si adegua. A parlar delle loro malefatte i giudici amministrativi te la fanno pagare. Presento l’oneroso ricorso al Tar di Lecce (ma poteva essere qualsiasi altro Tribunale Amministrativo Regionale) per contestare l’esito negativo dei miei compiti all’esame di avvocato: COMMISSIONE NAZIONALE D'ESAME PRESIEDUTA DA CHI NON POTEVA RICOPRIRE L'INCARICO, COMMISSARI (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI) DENUNCIATI CHE GIUDICANO IL DENUNCIANTE E TEMI SCRITTI NON CORRETTI, MA DA 15 ANNI SONO DICHIARATI TALI. Ricorso, n. 1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro il voto numerico insufficiente (25,25,25) dato alle prove scritte di oltre 4 pagine cadaune della sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda di fissazione dell’udienza di trattazione. Tale ricorso non ha prodotto alcun giudizio nei tempi stabiliti, salvo se non il diniego immediato ad una istanza cautelare di sospensione, tanto da farmi partecipare, nelle more ed in pendenza dell’esito definitivo del ricorso, a ben altre due sessioni successive, i cui risultati sono stati identici ai temi dei 15 anni precedenti (25,25,25): compiti puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più punti. Per l’inerzia del Tar si è stati costretti a presentare istanza di prelievo il 09/07/2012. Inspiegabilmente nei mesi successivi all’udienza fissata e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Eccetto qualcuno che non poteva essere accolto, tra i quali i ricorsi dell'avv. Carlo Panzuti e dell'avv. Angelo Vantaggiato in cui si contestava il giudizio negativo reso ad un elaborato striminzito di appena una pagina e mezza. Solo in data 7 febbraio 2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a supporto del ricorso. I magistrati amministrativi potranno dire che a loro insindacabile giudizio il mio ricorso va rigettato, ma devono spiegare non a me, ma a chi in loro pone fiducia, perché un ricorso presentato il 25 luglio 2011, deciso il 7 novembre 2012, viene notificato il 7 febbraio 2013? Un'attenzione non indifferente e particolare e con un risultato certo e prevedibile, se si tiene conto che proprio il presidente del Tar era da considerare incompatibile perchè è stato denunciato dal sottoscritto e perché le sue azioni erano oggetto di inchiesta video e testuale da parte dello stesso ricorrente? Le gesta del presidente del Tar sono state riportate da Antonio Giangrande, con citazione della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la città di Lecce. Come per dire: chi la fa, l'aspetti? QUANTO SONO ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME? Ogni anno a dicembre c’è un evento che stravolge la vita di molte persone. Il Natale? No! L’esame di avvocato che si svolge presso ogni Corte di Appello ed affrontato da decine di migliaia di candidati illusi. La domanda sorge spontanea: c’è da fidarsi delle commissioni dei concorsi pubblici o degli esami di Stato? «Dai dati emersi da uno studio effettuato: per nulla!». Così opina Antonio Giangrande, lo scrittore, saggista e sociologo storico, che sul tema ha scritto un libro “CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. L’Italia dei concorsi e degli esami pubblici truccati” tratto dalla collana editoriale “L’ITALIA DEL TRUCCO, L’ITALIA CHE SIAMO”. E proprio dalle tracce delle prove di esame che si inizia. Appunto. Sbagliano anche le tracce della Maturità. “Le parole sono importanti”, urlava Nanni Moretti nel film Palombella Rossa alla giornalista che, senza successo, provava a intervistarlo. E’ proprio dalla commissione dell’esame di giornalismo partiamo e dalle tracce da queste predisposte. Giusto per saggiare la sua preparazione. La commissione è quella ad avere elaborato le tracce d’esame. In particolare due magistrati (scelti dalla corte d’appello di Roma) e cinque giornalisti professionisti. Ne dà conto il sito de l’Espresso, che pubblica sia i documenti originali consegnati ai candidati, sia la versione degli stessi per come appare sul sito dell’Ordine, cioè con le correzioni (a penna) degli errori. Ossia: “Il pubblico ministero deciderà se convalidare o meno il fermo”. Uno strafalcione: compito che spetta al giudice delle indagini preliminari. Seguono altre inesattezze come il cognome del pm (che passa da Galese a Galesi) e una citazione del regista Carlo Lizzani, in cui “stacco la chiave” diventa “stacco la spina”. Sarà per questo che Indro Montanelli decise di non affrontare l’esame e Milena Gabanelli di non riaffrontarlo? Sarà per questo che Paolo Mieli è stato bocciato? E che dire di Aldo Busi il cui compito respinto era considerato un capolavoro e ricercato a suon di moneta? È in buona compagnia la signora Gabanelli & Company. Infatti si racconta che anche Alberto Moravia fu bocciato all’esame da giornalista professionista. Poco male. Sono le eccezioni che confermano la regola. Non sono gli esami giudicate da siffatte commissioni che possono attribuire patenti di eccellenza. Se non è la meritocrazia ha fare leva in Italia, sono i mediocri allora a giudicare. Ed a un lettore poco importa sapere se chi scrive ha superato o meno l'esame di giornalismo. Peccato che per esercitare una professione bisogna abilitarsi ed anche se eccelsi non è facile che i mediocri intendano l'eccellenza. L’esperienza e il buon senso, come sempre, sono le qualità fondamentali che nessuno (pochi) può trasmettere o sa insegnare. Del resto, si dice che anche Giuseppe Verdi fu bocciato al Conservatorio e che Benedetto Croce e Gabriele D’Annunzio non si erano mai laureati. Che dire delle Commissioni di esame di avvocato. Parliamo della sessione 2012. Potremmo parlarne per le sessioni passate, ma anche per quelle future: tanto in questa Italia le cose nefaste sono destinate a durare in eterno. A Lecce sarebbero solo 440 su 1258 i compiti ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania, presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame: troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale, so che alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20 minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Oltretutto l’arbitrio non si motiva nemmeno rilasciando i compiti corretti immacolati. Prescindendo dalla caccia mirata alle streghe, c’è forse di più? Eppure c’è chi queste commissioni li sputtana. TAR Lecce: esame forense, parti estratte da un sito? Legittimo se presenti in un codice commentato. È illegittimo l’annullamento dell’elaborato dell’esame di abilitazione forense per essere alcune parti estratte da un sito, se tali parti sono presenti all’interno di un codice commentato. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima, Ordinanza 19 settembre 2013, n. 465). E’ lo stesso Tar Catania che bacchetta la Commissione d’esame di Avvocato della stessa città Esame di avvocato...Copiare non sempre fa rima con annullare - TAR CATANIA ordinanza n. 1300/2010. Esame avvocato: Qualora in sede di correzione dell'elaborato si accerta che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche manuale, per condurre all’annullamento della prova, deve essere esatto e rigoroso. Tale principio di diritto è desumibile dall’ordinanza in rassegna n. 1300/2010 del TAR Catania che ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale avanzata avverso la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di avvocato. In particolare, per il Tar etneo “il ricorso appare fondato, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che il compito di diritto penale della ricorrente conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato di penale contenuto” in altra busta recante il n. 459 senza alcuna specificazione, anche sul compito, che consenta di appurare che questa presunta “identità” vada oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la consultazione dei medesimi codici”. Per il TAR siciliano, inoltre, “l’elaborato di penale del candidato contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una diversa sottocommissione durante la seduta del 19 marzo 2010, e tale elaborato non risulta essere stato parimenti annullato”. E a sua volta è la stessa Commissione d’esame di Avvocato di Lecce ad essere sgamata. Esami di avvocato. Il Tar di Salerno accoglie i ricorsi dei bocciati. I ricorsi accolti sono già decine, più di trenta soltanto nella seduta di giovedì 24 ottobre 2013, presentati da aspiranti avvocati bocciati alle ultime prove scritte da un giudizio che il Tar ha ritenuto illegittimo in quanto non indica i criteri sui cui si è fondato. Il Tribunale amministrativo sta quindi accogliendo le domande cautelari, rinviando al maggio del 2014 il giudizio di merito ma indicando, per sanare il vizio, una nuova procedura da affidare a una commissione diversa da quella di Lecce che ha deciso le bocciature. Il numero dei bocciati, reso noto lo scorso giugno 2013, fu altissimo. Soltanto 366 candidati, su un totale di 1.125, passarono le forche caudine dello scritto e furono ammessi alle prove orali. Una percentuale del 32,53: quasi 17 punti in meno del 49,16 registrato alla sessione dell’anno precedente. Numeri, questi ultimi, in linea con una media che, poco più o poco meno, si è attestata negli ultimi anni sull’ammissione della metà dei partecipanti. Nel 2012, invece, la ghigliottina è caduta sul 64,09 per cento degli esaminandi. In numeri assoluti i bocciati furono 721, a cui vanno aggiunti i 38 compiti (3,38 per cento) annullati per irregolarità come il rinvenimento di svolgimenti uguali. Adesso una parte di quelle persone ha visto accogliere dal Tar i propri ricorsi. I criteri usati dai commissari per l’attribuzione del punteggio, hanno spiegato i giudici, «non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale». La valutazione, quindi, «deve ritenersi l'illegittima». Che ne sarà di tutti coloro che quel ricorso non lo hanno presentato. Riproveranno l’esame e, forse, saranno più fortunati. Anche perché vatti a fidare dei Tar. Ci si deve chiedere: se il sistema permette da sempre questo stato di cose con il libero arbitrio in tema di stroncature dei candidati, come mai solo il Tar di Salerno, su decine di istituzioni simili, vi ha posto rimedio? Esami di Stato: forche caudine, giochi di prestigio o giochi di azzardo? Certo non attestazione di merito. Sicuramente nell’affrontare l’esame di Stato di giornalismo sarei stato bocciato per aver, questo articolo, superato le 45 righe da 60 caratteri, ciascuna per un totale di 2.700 battute, compresi gli spazi. Così come previsto dalle norme. Certamente, però, si leggerà qualcosa che proprio i giornalisti professionisti preferiscono non dire: tutte le commissioni di esame sono inaffidabili, proprio perché sono i mediocri a giudicare, in quanto in Italia sono i mediocri a vincere ed a fare carriera!
Sessione d’esame d’avvocato 2013-2014. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Luigi Covella, Principe del Foro di Lecce. Presidente coscienzioso e preparato. Compiti come sempre uguali perché la soluzione la forniva il commissario, il compagno di banco od i testi non autorizzati. Naturalmente anche in questa sessione un altro tassello si aggiunge ad inficiare la credibilità dell’esame forense. "La S.V. ha superato le prove scritte e dovrà sostenere le prove orali dinanzi alla Sottocommissione". "Rileviamo che sono state erroneamente immesse nel sistema le comunicazioni relative all’esito delle prove scritte e le convocazioni per le prove orali". Due documenti, il secondo contraddice e annulla il primo (che è stato un errore), sono stati inviati dalla Corte di Appello di Lecce ad alcuni partecipanti alla prova d’esame per diventare avvocato della tornata 2013, sostenuta nel dicembre scorso. Agli esami di avvocato della Corte di Appello di Lecce hanno partecipato circa mille praticanti avvocati e gli elaborati sono stati inviati per la correzione alla Corte di Appello di Palermo. (commissari da me denunciati per concorsi truccati già in precedente sessione). L’errore ha provocato polemiche e critiche sul web da parte dei candidati. La vicenda sembra avere il sapore di una beffa travestita da caos burocratico, ma non solo. Che in mezzo agli idonei ci siano coloro che non debbano passare e al contrario tra gli scartati ci siano quelli da far passare? E lì vi è un dubbio che assale i malpensanti. Alle 17 del 19 giugno nella posta di alcuni candidati (nell’Intranet della Corte di Appello) è arrivata una comunicazione su carta intestata della stessa Corte di Appello, firmata dal presidente della commissione, avvocato Luigi Covella, con la quale si informava di aver superato "le prove scritte" fissando anche le date nelle quali sostenere le prove orali, con la prima e la seconda convocazione. Tre ore dopo, sul sito ufficiale corteappellolecce.it, la smentita con una breve nota. "Rileviamo – è scritto – che sono state erroneamente immesse nel sistema le comunicazioni relative all’esito delle prove scritte e le convocazioni per le prove orali. Le predette comunicazioni e convocazioni non hanno valore legale in quanto gli esiti delle prove scritte non sono stati ancora pubblicati in forma ufficiale. Gli esiti ufficiali saranno resi pubblici a conclusione delle operazioni di inserimento dei dati nel sistema, attualmente ancora in corso". Sui forum animati dai candidati sul web è scoppiata la protesta e in tanti si sono indignati. "Vergogna", scrive Rosella su mininterno.net. "Quello che sta accadendo non ha precedenti. Mi manca soltanto sapere di essere stato vittima di uno scherzo!", puntualizza Pier. Un candidato che si firma Sicomor: "un classico in Italia... divertirsi sulla sorte della povera gente! poveri noi!". Un altro utente attacca: "Si parano il c... da cosa? L’anno scorso i risultati uscirono il venerdì sera sul profilo personale e poi il sabato mattina col file pdf sul sito pubblico della Corte! La verità è che navighiamo in un mare di poca professionalità e con serietà pari a zero!". Frank aggiunge: "Ma come è possibile una cosa simile stiamo parlando di un concorso!". Il pomeriggio di lunedì 23 giugno 2014 sono stati pubblicati i nomi degli idonei all’orale. Quelli “giusti”, questa volta. E dire che trattasi della Commissione d’esame di Palermo da me denunciata e della commissione di Lecce, da me denunciata. Che consorteria tra toghe forensi e giudiziarie. Sono 465 i candidati ammessi alla prova orale presso la Corte di Appello di Lecce. E' quanto si apprende dalla comunicazione 21 giugno 2013 pubblicata sul sito della Corte di Appello di Lecce. Il totale dei partecipanti era di 1.258 unità: la percentuale degli ammessi risulta pertanto pari al 36,96%. Una percentuale da impedimento all’accesso. Percentuale propria delle commissioni d’esame di avvocato nordiste e non dell’insulare Palermo. Proprio Palermo. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Termini Imerese, in primo grado fu condannato a 10 mesi. L’accusa: truccò il concorso per avvocati. Non fu sospeso. Da “La Repubblica” di Palermo del 10/01/2001: Parla il giovane aspirante avvocato, che ha portato con sé una piccola telecamera per filmare “palesi irregolarità”. «Ho le prove nel mio video del concorso truccato. Ho un’altra cassetta con sette minuti di immagini, che parlano da sole. Oggi sarò sentito dal magistrato. A lui racconterò tutto ciò che ho visto. La giornata di un concorsista, aspirante avvocato, comincia alle quattro e mezza del mattino. Alle sei devi esser in prima fila. Ed è quello il momento in cui capisci come vanno le cose. Tutti lo sanno, ma nessuno ne parla». I.D.B., 38 anni, ha voluto rompere il silenzio. Nei giorni dell’esame scritto per l’abilitazione forense si è portato dietro una piccola telecamera e ha documentato quelle che lui chiama “palesi irregolarità”. E’ stato bloccato dai commissari e la cassetta con le immagini è stata sequestrata. Ma lui non si perde d’animo: «in fondo io cerco solo la verità». Intanto, I.D.B. rompe il silenzio con “La Repubblica” perché dice «è importante cercare un movimento d’opinione attorno a questa vicenda ». E ha già ricevuto la solidarietà dell’associazione Nazionale Praticanti ed avvocati. «Vorrei dire – racconta – delle sensazioni che ho provato tutte le volte che ho fatto questo esame. Sensazioni di impotenza per quello che senti intorno. Ed è il segreto di Pulcinella. Eccone uno: basta comunicare la prima frase del compito a chi di dovere. Io ho chiesto i temi che avevo fatto nelle sessioni precedenti: non c’era una correzione, una motivazione, solo un voto». Il primo giorno degli esami scritti il giovane si è guardato intorno. L’indomani era già dietro la telecamera: «Ho filmato circa sette minuti, in lungo ed in largo nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, dove c’erano più di novecento candidati. A casa ho rivisto più volte il filmato e ho deciso che avrei dovuto documentare ancora. Così è stato. Il secondo filmato, quello sequestrato, dura più del primo. A un certo punto una collega si è accorta di me e ha chiamato uno dei commissari. Non ho avuto alcun problema, ho consegnato la cassetta. E sin dal primo momento ho detto: Mi sono accorto di alcune irregolarità e ho documentato. Allora mi hanno fatto accomodare in una stanza. E insistevano: perché l’ha fatto?. Tornavo a parlare delle irregolarità. Poi mi chiedevano chi le avesse fatte. Lo avrei detto al presidente della commissione, in disparte. Davanti a tutti, no!» Il giovane si dice stupito per il clamore suscitato dal suo gesto: «Non dovrebbe essere questo a sorprendere, ho avuto solo un po’ più di coraggio degli altri». Ma cosa c’è in quelle videocassette? L’aspirante avvocato non vuole dire di più, fa cenno ad un commissario sorpreso in atteggiamenti confidenziali con alcuni candidati: «Francamente non capisco perché non siano stati presi provvedimenti per il concorso. Quei capannelli che ho ripreso sono davvero troppo da tollerare. Altro che piccoli suggerimenti!».
Sessione d’esame d’avvocato 2014-2015. Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Francesco De Jaco, Principe del Foro di Lecce. Presidente coscienzioso e preparato. Compiti come sempre uguali perché la soluzione la forniva il commissario, il compagno di banco od i testi non autorizzati. Sede di Corte d’appello sorteggiata per la correzione è Brescia. Mi tocca, non come il ministro Gelmini che da Brescia ha scelto Reggio Calabria, dopo ben 12 anni dalla laurea conseguita a Milano. In quei mesi di tormenti a cavallo tra il 2000 e il 2001 Mariastella Gelmini si trova dunque a scegliere tra fare l’esame a Brescia o scendere giù in Calabria, spiegherà a Flavia Amabile: «La mia famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri, nulla. C'era una logica di casta, per fortuna poi modificata perché il sistema è stato completamente rivisto». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la tentazione era forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo deciso di farlo anche noi». Del resto, aggiunge, lei ha «una lunga consuetudine con il Sud. Una parte della mia famiglia ha parenti in Cilento». Certo, è a quasi cinquecento chilometri da Reggio. Ma sempre Mezzogiorno è. E l'esame? Com'è stato l'esame? «Assolutamente regolare». Non severissimo, diciamo, neppure in quella sessione. Quasi 57% di ammessi agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia. Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno. Così facevan tutti, dice Mariastella Gelmini. Io dal 1998 ho partecipato all’esame forense annuale. Sempre bocciato. Ho rinunciato a proseguire nel 2014 con la commissione presieduta dall’avv. Francesco De Jaco. L’avvocato di Cosima Serrano condannata con la figlia Sabrina Misseri per il delitto di Sarah Scazzi. Tutte mie compaesane. La Commissione d’esame di avvocato di Lecce 2014. La più serena che io abbia trovato in tutti questi anni. Ho chiesto invano a lui di tutelare me, dagli abusi in quell’esame, come tutti quelli come me che non hanno voce. Se per lui Cosima è innocente contro il sentire comune, indotti a pensarla così dai media e dai magistrati, perché non vale per me la verità che sia vittima di un sistema che mi vuol punire per essermi ribellato? Si nega l’evidenza. 1, 2, 3 anni, passi. 17 anni son troppi anche per il più deficiente dei candidati. Ma gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Compiti non corretti, ma ritenuti tali in tempi insufficienti e senza motivazione e con quote prestabilite di abilitati. Così per me, così per tutti. Gli avvocati abilitati negano l’evidenza. Logico: chi passa, non controlla. Ma 17 anni son troppi per credere alla casualità di essere uno sfigato, specialmente perché i nemici son noti, specie se sono nelle commissioni d’esame. A Bari avrebbero tentato di agevolare la prova d'esame di cinque aspiranti avvocati ma sono stati bloccati e denunciati dai Carabinieri, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”. È accaduto nella Fiera del Levante di Bari dove è in corso da tre giorni l'esame di abilitazione professionale degli avvocati baresi. In circa 1500 hanno sostenuto le prove scritte in questi giorni ma oggi, ultimo giorno degli scritti, i Carabinieri sono intervenuti intercettando una busta contenente i compiti diretti a cinque candidati. Un dipendente della Corte di Appello, con il compito di sorvegliante nei tre giorni di prova, avrebbe consegnato ad una funzionaria dell'Università la busta con le tracce. Lei, dopo alcune ore, gli avrebbe restituito la busta con all'interno i compiti corretti e un biglietto con i cinque nomi a cui consegnare i temi. Proprio nel momento del passaggio sono intervenuti i Carabinieri, che pedinavano la donna fin dal primo giorno, dopo aver ricevuto una segnalazione. Sequestrata la busta i militari hanno condotto i due in caserma per interrogarli. Al momento sono indagati a piede libero per la violazione della legge n. 475 del 1925 sugli esami di abilitazione professionali, che prevede la condanna da tre mesi a un anno di reclusione per chi copia. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Eugenia Pontassuglia, verificheranno nei prossimi giorni la posizione dei cinque aspiranti avvocati destinatari delle tracce e quella di altre persone eventualmente coinvolte nella vicenda. Inoltre tre aspiranti avvocatesse (una è figlia di due magistrati), sono entrate nell’aula tirandosi dietro il telefono cellulare che durante la prova hanno cercato di utilizzare dopo essersi rifugiate in bagno. Quando si sono rese conto che sarebbero state scoperte, sono tornate in aula. Pochi minuti dopo il presidente della commissione d’esame ha comunicato il ritrovamento in bagno dei due apparecchi ma solo una delle due candidate si è fatta avanti, subito espulsa. L’altra è rimasta in silenzio ma è stata identifica. Esame per avvocati, la banda della truffa: coinvolti tre legali e due dirigenti pubblici. Blitz dei carabinieri nella sede della Finanza. E la potente funzionaria di Giurisprudenza sviene, scrive Gabriella De Matteis e Giuliana Foschini su “La Repubblica”. Un ponte telefonico con l'esterno. Tre avvocati pronti a scrivere i compiti. Un gancio per portare il tutto all'interno. Sei candidati pronti a consegnare. Era tutto pronto. Anzi era tutto fatto. Ma qualcosa è andato storto: quando la banda dell'"esame da avvocato" credeva che tutto fosse andato per il verso giusto, sono arrivati i carabinieri del reparto investigativo a fare saltare il banco. E a regalare l'ennesimo scandalo concorsuale a Bari. E' successo tutto mercoledì 17 dicembre 2014 pomeriggio all'esterno dei padiglioni della Guardia di finanza dove stava andando in scena la prova scritta per l'esame da avvocato. Mille e cinquecento all'incirca i partecipanti, divisi in ordine alfabetico. Commissione e steward per evitare passaggi di compiti o copiature varie. Apparentemente nulla di strano. Apparentemente appunto. Perché non appena vengono aperte le buste e lette le tracce si comincia a muovere il Sistema scoperto dai carabinieri. Qualcuno dall'interno le comunica a Tina Laquale, potente dirigente amministrativo della facoltà di Giurisprudenza di Bari. E' lei a girarle, almeno questo hanno ricostruito i Carabinieri, a tre avvocati che avevano il compito di redigere il parere di civile e di penale e di scrivere l'atto. Con i compiti in mano la Laquale si è presentata all'esterno dei padiglioni. All'interno c'era un altro componente del gruppo, Giacomo Santamaria, cancelliere della Corte d'Appello che aveva il compito di fare arrivare i compiti ai sei candidati che all'interno li aspettavano. Compiti che sarebbero poi stati consegnati alla commissione e via. Ma qui qualcosa è andato storto. Sono arrivati infatti i carabinieri che hanno bloccato tutto. Laquale è svenuta, mentre a lei e a tutte quante le altre persone venivano sequestrati documenti e soprattutto supporti informatici, telefoni in primis, che verranno analizzati in queste ore. Gli investigatori devono infatti verificare se, come sembra, il sistema fosse da tempo organizzato e rodato, se ci fosse un corrispettivo di denaro e la vastità del fenomeno. Ieri si è tenuta la convalida del sequestro davanti al sostituto procuratore, Eugenia Pontassuglia. Ma com'è chiaro l'indagine è appena cominciata. Per il momento viene contestata la truffa e la violazione di una vecchia legge del 1925 secondo la cui "chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito". È molto probabile infatti che l'esame venga invalidato per tutti. Certo è facile prendersela con i poveri cristi. Le macagne nelle segrete stanze delle commissioni di esame, in cui ci sono i magistrati, nessuno va ad indagare: perché per i concorsi truccati nessuno va in galera. Concorsi, i figli di papà vincono facile: "E noi, figli di nessuno, restiamo fuori". L’inchiesta sul dottorato vinto dal figlio del rettore della Sapienza nonostante l'uso del bianchetto ha raccolto centinaia di commenti e condivisioni. E ora siamo noi a chiedervi di raccontarci la vostra storia di candidati meritevoli ma senza parenti eccellenti. Ecco le prime due lettere arrivate, scrive Emiliano Fittipaldi su “L’Espresso”. A chi figli, e a chi figliastri: è questa la legge morale che impera in Italia, il Paese della discriminazione e delle corporazioni. Dove va avanti chi nasce privilegiato, mentre chi non vanta conoscenze e relazioni rischia, quasi sempre, di arrivare ultimo. Alla Sapienza di Roma l’assioma è spesso confermato: sono decine i parenti di professori eminenti assunti nei dipartimenti, con intere famiglie (su tutte quella dell’ex rettore Luigi Frati) salite in cattedra. A volte con merito, altre meno. La nostra inchiesta sullo strano concorso di dottorato vinto dal rampollo del nuovo magnifico Eugenio Gaudio, al tempo preside di Medicina, ha fatto scalpore: la storia del compito “sbianchettato” (qualsiasi segno di riconoscimento è vietato) e la notizia del singolare intervento dei legali dell’università (hanno chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato, che ha invitato la Sapienza a “perdonare” il candidato ) hanno fatto il giro del web. Il pezzo è stato condiviso decine di migliaia di volte, con centinaia di commenti (piuttosto severi) di ex studenti e docenti dell’ateneo romano. Tra le decine di lettere arrivate in redazione, due sono metafora perfetta di come la sorte possa essere diversa a seconda del cognome che si porta. Livia Pancotto, 28 anni, laureata in Economia con 110 e lode, spiega che la storia del pargolo di Gaudio le ha fatto «montare dentro una rabbia tale da farmi scrivere» poche, infuriate righe. «Nel 2012, dopo la laurea, decisi di partecipare al concorso per il dottorato in Management, Banking and Commodity Sciences, sempre alla Sapienza», scrive in una lettera a “l’Espresso”. «Dopo aver superato sia l’esame scritto che l’orale ricevetti la buona notizia: ero stata ammessa, sia pure senza borsa». Dopo un mese, però, la mazzata. «Vengo a sapere dal professore che il mio concorso è stato annullato, visto che durante lo scritto ho utilizzato il bianchetto. Come nel caso del figlio del rettore Gaudio, nessuno aveva specificato, prima dell’inizio del compito, che il bando prevedesse che si potesse usare solo una penna nera». Se per il rampollo dell’amico che prenderà il suo posto il rettore Frati mobiliterà i suoi uffici legali, la Pancotto viene silurata subito, senza pietà. Oggi la giovane economista vive in Galles, dove ha vinto un dottorato con borsa all’università di Bangor. Anche la vicenda di Federico Conte, ora tesoriere dell’Ordine degli psicologi del Lazio, è paradossale. Dopo aver completato in un solo anno gli esami della laurea specialistica nel 2009, la Sapienza tentò di impedire la discussione della sua tesi. «Mi arrivò un telegramma a firma di Frati, dove mi veniva comunicato l’avvio di una “procedura annullamento esami”: il magnifico non era d’accordo nel farmi laureare in anticipo, ed era intenzionato a farmi sostenere gli esami una seconda volta». Conte domandò all’ateneo di chiedere un parere all’Avvocatura, ma senza successo. Il giovane psicologo fu costretto a ricorrere al Tar, che gli diede ragione permettendogli di laurearsi. «Leggendo la vostra inchiesta ho la percezione di un’evidente diversità di trattamento rispetto al figlio del rettore. Provo un certo disgusto nel constatare come le nostre istituzioni siano così attente e garantiste con chi sbianchetta, mentre si accaniscano su chi fa il proprio dovere». Magari pure più velocemente degli altri. Ma tant’è. Nel paese dove i figli “so’ piezz’ e core”, la meritocrazia e l’uguaglianza restano una chimera. Anche nelle università, luogo dove - per antonomasia - l’eccellenza e il rigore dovrebbero essere di casa. Se poi l’Esame di Avvocato lo passi, ti obbligano a lasciare. Giovani avvocati contro la Cassa Forense. Con la campagna "'Io non pago e non mi cancello". I giuristi più giovani in rivolta sui social network per la regola dei minimi obbligatori, che impone contributi previdenziali intorno ai 4 mila euro annui alla cassa indipendentemente dal reddito. Così c'è chi paga più di quello che guadagna. E chi non paga si deve cancellare dall'Albo, venendo escluso dalla categoria, scrive Antonio Sciotto su “L’Espresso”. Chi pensa ancora che la professione di avvocato sia garantita e ben retribuita dia in questi giorni uno sguardo attento ai social network. Twitter e Facebook da qualche giorno sono inondati da 'selfie' che raccontano tutta un'altra storia. "Io non pago e io non mi cancello" è lo slogan scelto dai giovani legali per la loro rivolta contro i colleghi più anziani e in particolare contro la regola dei "minimi obbligatori", che impone di pagare i contributi previdenziali alla Cassa forense in modo del tutto slegato dal reddito. Molti spiegano che la cifra minima richiesta – intorno ai 4 mila euro annui - è pari o a volte anche superiore ai propri redditi. E visto che se non riesci a saldare, devi cancellarti non solo dalla Cassa, ma anche dall'albo professionale. Il risultato è che ad esercitare alla fine restano tendenzialmente i più ricchi, mentre chi fa fatica ad arrivare a fine mese viene di fatto espulso dalla categoria. E' vero che per i primi 8 anni è prevista una buona agevolazione per chi guadagna sotto i 10 mila euro l'anno, ma al pari le prestazioni vengono drasticamente ridotte. Per capirci: è come se l'Inps chiedesse a un operaio e a un dirigente una stessa soglia minima di contributi annui, non calcolata in percentuale ai loro redditi. Mettiamo 5 mila euro uguali per tutti: salvo poi imporre la cancellazione dall'ente a chi non riesce a saldare. "Dovrei salassarmi oggi per ricevere un'elemosina domani – protesta Antonio Maria - mentre i vecchi tromboni ottantenni si godono le loro pensioni d'oro, non pagate, conquistate avendo versato tutta la vita lavorativa (ed erano altri tempi) il 10 per cento ed imponendo a me di pagare il 14 per cento". "Il regime dei cosiddetti minimi è vergognoso – aggiunge Rosario - Pretendere che si paghi 'a prescindere' del proprio reddito è una bestemmia giuridica. Basta furti generazionali. Basta falsità". Uno dei selfie addirittura viene da un reparto di emodialisi, a testimoniare la scarsa copertura sanitaria assicurata ai giovani professionisti. La protesta si è diffusa a partire dal blog dell'Mga - Mobilitazione generale avvocati , ha un gruppo facebook pubblico dove è possibile postare i selfie, mentre su Twitter naviga sull'onda dell'hashtag #iononmicancello. La battaglia contro le casse previdenziali non è nuova, se consideriamo gli avvocati una parte del più vasto mondo delle partite Iva e degli autonomi: già da tempo Acta, associazione dei freelance, ha lanciato la campagna #dicano33, contro il progressivo aumento dei contributi Inps dal 27 per cento al 33 per cento, imposto dalla legge per portarli al livello dei lavoratori dipendenti. Il regime dei minimi obbligatori della Cassa forense non solo darebbe luogo a una vera e propria "discriminazione generazionale", ma secondo molti giovani avvocati sarebbe anche incostituzionale, come spiega efficacemente Davide Mura nel suo blog: "E' palesemente in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, che sancisce il principio della progressività contributiva. Ma si viola anche l'articolo 3, quello sull'uguaglianza davanti alla legge, perché le condizioni cambiano a seconda se stai sopra o sotto i 10 mila euro di reddito annui". La soluzione? Secondo l'Mga sarebbe quella di eliminare l'obbligo dei minimi e passare al sistema contributivo, come è per tutti gli altri lavoratori. Vietando possibilmente agli avvocati già in pensione di poter continuare a esercitare. Un modo insomma per far sì che i "tromboni" lascino spazio ai più giovani.
A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
Noi siamo animali. Siamo diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.
La Superbia-Vanità (desiderio irrefrenabile di essere superiori, fino al disprezzo di ordini, leggi, rispetto altrui);
L’Avarizia (scarsa disponibilità a spendere e a donare ciò che si possiede);
La Lussuria (desiderio irrefrenabile del piacere sessuale fine a sé stesso);
L’Invidia (tristezza per il bene altrui, percepito come male proprio);
La Gola (meglio conosciuta come ingordigia, abbandono ed esagerazione nei piaceri della tavola, e non solo);
L’Ira (irrefrenabile desiderio di vendicare violentemente un torto subito);
L’Accidia-Depressione (torpore malinconico, inerzia nel vivere e nel compiere opere di bene).
Essendo viziosi ci scanneremmo l’un l’altro per raggiungere i nostri scopi. E periodicamente lo facciamo.
Vari illuminati virtuosi, chiamati profeti, ci hanno indicato invano la retta via. La via indicata sono i precetti dettati dalle religioni nate da questi insegnamenti. Le confessioni religiose da sempre hanno cercato di porre rimedio indicando un essere superiore come castigatore dei peccati con punizioni postume ed eterne. Ecco perché i vizi sono detti Capitali.
I vizi capitali sono un elenco di inclinazioni profonde, morali e comportamentali, dell'anima umana, spesso e impropriamente chiamati peccati capitali. Questo elenco di vizi (dal latino vĭtĭum = mancanza, difetto, ma anche abitudine deviata, storta, fuori dal retto sentiero) distruggerebbero l'anima umana, contrapponendosi alle virtù, che invece ne promuovono la crescita. Sono ritenuti "capitali" poiché più gravi, principali, riguardanti la profondità della natura umana. Impropriamente chiamati "peccati", nella morale filosofica e cristiana i vizi sarebbero già causa del peccato, che ne è invece il suo relativo effetto.
Una sommaria descrizione dei vizi capitali comparve già in Aristotele, che li definì gli "abiti del male". Al pari delle virtù, i vizi deriverebbero infatti dalla ripetizione di azioni, che formano nel soggetto che le compie una sorta di "abito" che lo inclina in una certa direzione o abitudine. Ma essendo vizi, e non virtù, tali abitudini non promuovono la crescita interiore, nobile e spirituale, ma al contrario la distruggono.
In questo mondo vizioso tutto ha un prezzo e quasi tutti sono disposti a svendersi per ottenerlo e/ o a dispensare torti ai propri simili. Ciclicamente i nomi degli aguzzini cambiano, ma i peccati sono gli stessi.
In questa breve vita senza giustizia, vissuta in un periodo indefinito, vincono loro: non hanno la ragione, ma il potere. Questo, però, non impedirà di raccontare la verità contemporanea nel tempo e nello spazio, affinché ai posteri sia delegata l’ardua sentenza contro i protagonisti del tempo trattato, per gli altri ci sarà solo l’ignominia senza fama né gloria o l’anonimato eterno.
“La superficie della Terra non era ancora apparsa. V’erano solo il placido mare e la grande distesa di Cielo... tutto era buio e silenzio". Così inizia il Popol Vuh, il libro sacro dei Maya Quiché che narra degli albori dell’umanità. Il Popol Vuh descrive questi primi esseri umani come davvero speciali: "Furono dotati di intelligenza, potevano vedere lontano, riuscivano a sapere tutto quel che è nel mondo. Quando guardavano, contemplavano ora l'arco del cielo ora la rotonda faccia della Terra. Contrariamente ai loro predecessori, gli esseri umani ringraziarono sentitamente gli dei per averli creati. Ma anche stavolta i creatori si indispettirono. "Non è bene che le nostre creature sappiano tutto, e vedano e comprendano le cose piccole e le cose grandi". Gli dei tennero dunque consiglio: "Facciamo che la loro vista raggiunga solo quel che è vicino, facciamo che vedano solo una piccola parte della Terra! Non sono forse per loro natura semplici creature fatte da noi? Debbono forse anch'essi essere dei? Debbono essere uguali a noi, che possiamo vedere e sapere tutto? Ostacoliamo dunque i loro desideri... Così i creatori mutarono la natura delle loro creature. Il Cuore del Cielo soffiò nebbia nei loro occhi, e la loro vista si annebbiò, come quando si soffia su uno specchio. I loro occhi furono coperti, ed essi poterono vedere solo quello che era vicino, solo quello che ad essi appariva chiaro."
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Antonio Giangrande, perché è diverso dagli altri?
Perché lui spiega cosa è la legalità, gli altri non ne parlano, ma ne sparlano.
La legalità è un comportamento conforme alla legge ed ai regolamenti di attuazione e la sua applicazione necessaria dovrebbe avvenire secondo la comune Prassi legale di riferimento.
Legge e Prassi sono le due facce della stessa medaglia.
La Legge è votata ed emanata in nome del popolo sovrano. I Regolamenti di applicazione sono predisposti dagli alti Burocrati e già questo non va bene. La Prassi, poi, è l’applicazione della Legge negli Uffici Pubblici, nei Tribunali, ecc., da parte di un Sistema di Potere che tutela se stesso con usi e consuetudini consolidati. Sistema di Potere composto da Caste, Lobbies, Mafie e Massonerie.
Ecco perché vige il detto: La Legge si applica per i deboli e si interpreta per i forti.
La correlazione tra Legge e Prassi e come quella che c’è tra il Dire ed il Fare: c’è di mezzo il mare.
Parlare di legge, bene o male, ogni leguleio o azzeccagarbugli o burocrate o boiardo di Stato può farlo. Più difficile per loro parlar di Prassi generale, conoscendo loro signori solo la prassi particolare che loro coltivano per i propri interessi di privilegiati. Prassi che, però, stanno attenti a non svelare.
Ed è proprio la Prassi che fotte la Legge.
La giustizia che debba essere uguale per tutti parrebbe essere un principio che oggi consideriamo irrinunciabile, anche se non sempre pienamente concretizzabile nella pratica quotidiana. Spesso assistiamo a fenomeni di corruzione, all’applicazione della legge in modo diverso secondo i soggetti coinvolti. E l’la disfunzione è insita nella predisposizione umana.
Essa vien da lontano.
E’ lo stesso Alessandro Manzoni che parla di “Azzeccagarbugli” genuflessi ai mafiosi del tempo al capitolo 3 dei “Promessi Sposi”. Ma non sarebbe stato il Manzoni a coniare l’accoppiata tra il verbo “azzeccare” e il sostantivo “garbuglio” stante che quando la parola entrò nei “Promessi Sposi”, aveva un’età superiore ai tre secoli. Il primo ad usarla fu Niccolò Machiavelli che, in un passo delle "Legazioni" (1510), scrive: “Voi sapete che i mercatanti vogliono fare le cose loro chiare e non azzeccagarbugli”. Questa spiegazione si trova nel Dizionario italiano ragionato e nel Dizionario etimologico di Cortelazzo-Zolli mentre gli altri vocabolari si limitano a indicare soltanto la matrice manzoniana. È giusto dare a Niccolò quello che è di Niccolò, ricordando inoltre che il Manzoni era un conoscitore dell’opera di Machiavelli ed è probabile che sia stato ispirato dal citato passo. Non si dimentichi, infatti, che nella prima stesura dei “Promessi Sposi” il personaggio si chiamava “dotor Pe’ ttola” e non Azzeccagarbugli.
La legge non era uguale per tutti anche nel Seicento, secolo di soprusi e di prepotenze da parte dei potenti. Renzo cerca giustizia recandosi da un noto avvocato del tempo, ma, allora come oggi, la giustizia non sta dalla parte degli oppressi, bensì da quella degli oppressori.
Azzecca-garbugli è un personaggio del romanzo storico ed è il soprannome di un avvocato di Lecco, chiamato, nelle prime edizioni del romanzo, dottor Pettola e dottor Duplica (nell'edizione definitiva il nome non viene mai detto, ma solo il soprannome). Il nome costituisce un'italianizzazione del termine dialettale milanese zaccagarbùj che il Cherubini traduce "attaccabrighe". Viene chiamato così dai popolani per la sua capacità di sottrarre dai guai, non del tutto onestamente, le persone. Spesso e volentieri aiuta i Bravi, poiché, come don Abbondio, preferisce stare dalla parte del più forte, per evitare una brutta fine.
Renzo Tramaglino giunge da lui, nel capitolo III, per chiedere se ci fosse una grida che avrebbe condannato don Rodrigo, ma lui sentendo nominare il potente signore, respinge Renzo perché non avrebbe potuto contrastare la sua potente autorità. Egli rappresenta quindi un uomo la cui coscienza meschina è asservita agli interessi dei potenti. Compare anche nel capitolo quinto quando fra Cristoforo va al palazzotto di don Rodrigo e lo trova fra gli invitati al banchetto che si sta tenendo a casa appunto di don Rodrigo.
Apparentemente, è un uomo di legge molto erudito, e nel suo studio è presente una notevole quantità di libri, il cui ruolo principale, però, è quello di elementi decorativi piuttosto che di materiale di studio. Il suo tavolo invece è cosparso di fogli che impressionano gli abitanti del paese che vi si recano. In realtà non consulta libri da molti anni addietro, quando andava a Milano per qualche causa d'importanza.
Il suo nome Azzeccagarbugli è dovuto dal fatto che Azzecca significa "indovinare" e garbugli "cose non giuste", quindi: Indovinare cose non giuste.
Azzeccagarbugli è la figura centrale del Capitolo 3°, è un avvocato venduto, è un miserabile e il Manzoni pur non dicendolo apertamente ce lo fa capire descrivendocelo appunto negli aspetti più negativi. Di questo personaggio emerge una grande miseria morale: ciò che preme all'avvocato è di assicurarsi il favore di don Rodrigo anche se per ottenere questo deve calpestare quella giustizia della quale dovrebbe essere servitore. Il Dottor Azzeccagarbugli è una figurina vista di scorcio, ma pur limpida e interessante. E' un leguleio da strapazzo, ma abile la sua parte a ordire garbugli per imbrogliare le cose, come lui stesso confessa a Renzo. Ci vuole la conoscenza del codice, è necessario saper interpretare le gride, ma per lui valgono sopra tutto le arti per ingarbugliare i clienti. Tale è la morale di questo tipo di trappolone addottorato, comunissimo in ogni società. Il Manzoni lo ha ricreato di una specifica individualità esteriore, nell'eloquio profuso, a volte enfatico e sentenzioso, a volte freddo e cavilloso, grave e serio nella posa di uomo di alte cure, pieno di sussiego nella sua mimica istrionica. Don Rodrigo lo ha caro, come complice connivente nei suoi delittuosi disegni, mentre il dottore accattando protezione col servilismo e l'adulazione, scrocca lauti pranzi. Alcuni osservano, e non a torto, che in questo personaggio il Manzoni abbia voluto farsi beffe dei legulei dalla coscienza facile.
"«Non facciam niente, – rispose il dottore, scotendo il capo, con un sorriso, tra malizioso e impaziente. – Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle. Se volete ch’io v’aiuti, bisogna dirmi tutto, dall’a fino alla zeta, col cuore in mano, come al confessore. Dovete nominarmi la persona da cui avete avuto il mandato: sarà naturalmente persona di riguardo; e, in questo caso, io anderò da lui, a fare un atto di dovere. Non gli dirò, vedete, ch’io sappia da voi, che v’ha mandato lui: fidatevi. Gli dirò che vengo ad implorar la sua protezione, per un povero giovine calunniato. E con lui prenderò i concerti opportuni, per finir l’affare lodevolmente. Capite bene che, salvando sé, salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro: ho cavato altri da peggio imbrogli… Purché non abbiate offeso persona di riguardo, intendiamoci, m’impegno a togliervi d’impiccio: con un po’ di spesa, intendiamoci. Dovete dirmi chi sia l’offeso, come si dice: e, secondo la condizione, la qualità e l’umore dell’amico, si vedrà se convenga più di tenerlo a segno con le protezioni, o trovar qualche modo d’attaccarlo noi in criminale, e mettergli una pulce nell’orecchio; perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente. In quanto al curato, se è persona di giudizio, se ne starà zitto; se fosse una testolina, c’è rimedio anche per quelle. D’ogni intrigo si può uscire; ma ci vuole un uomo: e il vostro caso è serio, vi dico, serio: la grida canta chiaro; e se la cosa si deve decider tra la giustizia e voi, così a quattr’occhi, state fresco. Io vi parlo da amico: le scappate bisogna pagarle: se volete passarvela liscia, danari e sincerità, fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito.»
Mentre il dottore mandava fuori tutte queste parole, Renzo lo stava guardando con un’attenzione estatica, come un materialone sta sulla piazza guardando al giocator di bussolotti, che, dopo essersi cacciata in bocca stoppa e stoppa e stoppa, ne cava nastro e nastro e nastro, che non finisce mai. Quand’ebbe però capito bene cosa il dottore volesse dire, e quale equivoco avesse preso, gli troncò il nastro in bocca, dicendo: – oh! signor dottore, come l’ha intesa? l’è proprio tutta al rovescio. Io non ho minacciato nessuno; io non fo di queste cose, io: e domandi pure a tutto il mio comune, che sentirà che non ho mai avuto che fare con la giustizia. La bricconeria l’hanno fatta a me; e vengo da lei per sapere come ho da fare per ottener giustizia; e son ben contento d’aver visto quella grida.
- Diavolo! – esclamò il dottore, spalancando gli occhi. – Che pasticci mi fate? Tant’è; siete tutti così: possibile che non sappiate dirle chiare le cose?
- Ma mi scusi; lei non m’ha dato tempo: ora le racconterò la cosa, com’è. Sappia dunque ch’io dovevo sposare oggi, – e qui la voce di Renzo si commosse, – dovevo sposare oggi una giovine, alla quale discorrevo, fin da quest’estate; e oggi, come le dico, era il giorno stabilito col signor curato, e s’era disposto ogni cosa. Ecco che il signor curato comincia a cavar fuori certe scuse… basta, per non tediarla, io l’ho fatto parlar chiaro, com’era giusto; e lui m’ha confessato che gli era stato proibito, pena la vita, di far questo matrimonio. Quel prepotente di don Rodrigo…
- Eh via! – interruppe subito il dottore, aggrottando le ciglia, aggrinzando il naso rosso, e storcendo la bocca, – eh via! Che mi venite a rompere il capo con queste fandonie? Fate di questi discorsi tra voi altri, che non sapete misurar le parole; e non venite a farli con un galantuomo che sa quanto valgono. Andate, andate; non sapete quel che vi dite: io non m’impiccio con ragazzi; non voglio sentir discorsi di questa sorte, discorsi in aria.
- Le giuro…
- Andate, vi dico: che volete ch’io faccia de’ vostri giuramenti? Io non c’entro: me ne lavo le mani -. E se le andava stropicciando, come se le lavasse davvero. – Imparate a parlare: non si viene a sorprender così un galantuomo.
- Ma senta, ma senta, – ripeteva indarno Renzo: il dottore, sempre gridando, lo spingeva con le mani verso l’uscio; e, quando ve l’ebbe cacciato, aprì, chiamò la serva, e le disse: – restituite subito a quest’uomo quello che ha portato: io non voglio niente, non voglio niente.
Quella donna non aveva mai, in tutto il tempo ch’era stata in quella casa, eseguito un ordine simile: ma era stato proferito con una tale risoluzione, che non esitò a ubbidire. Prese le quattro povere bestie, e le diede a Renzo, con un’occhiata di compassione sprezzante, che pareva volesse dire: bisogna che tu l’abbia fatta bella. Renzo voleva far cerimonie; ma il dottore fu inespugnabile; e il giovine, più attonito e più stizzito che mai, dovette riprendersi le vittime rifiutate, e tornar al paese, a raccontar alle donne il bel costrutto della sua spedizione."
A Parlar di azzeccagarbugli non vi pare che si parli dei nostri contemporanei legulei togati, siano essi magistrati od avvocati?
Additare i difetti altrui è cosa che tutti sanno fare, più improbabile è indicare e correggere i propri.
Non abbiamo bisogno di eroi, né, tantomeno, di mistificatori con la tonaca (toga e divisa). L’abito non fa il monaco. La legalità non va promossa solo nella forma, ma va coltivata anche nella sostanza. E’ sbagliato ergersi senza meriti dalla parte dei giusti.
Se scrivi e dici la verità con il coraggio che gli altri non hanno, il risultato non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu additato come pazzo. Ti scontri sempre con la permalosità di magistrati e giornalisti e la sornionità degli avvocati avvezzi solo ai loro interessi. Categorie di saccenti che non ammettono critiche. Se scrivi e sei del centro-nord Italia, i conterranei diranno: che bel libro, bravo, è uno di noi. Se scrivi e sei del centro-sud Italia i conterranei diranno: quel libro l’avrei scritto anch’io, anzi meglio, ma sono solo cazzate.
Chi siamo noi?
Siamo i “coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare.
Da bambini i genitori ci educavano secondo i loro canoni, fino a che abbiamo scoperto che era solo il canone di poveri ignoranti.
Da studenti i maestri ci istruivano secondo il loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che era solo il pensiero di comunisti arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano “Bella Ciao”.
Da credenti i ministri di culto ci erudivano sulla confessione religiosa secondo il loro verbo, fino a che abbiamo scoperto che era solo la parola di pedofili o terroristi.
Da lettori e telespettatori l’informazione (la claque del potere) ci ammaestrava all’odio per il diverso ed a credere di vivere in un paese democratico, civile ed avanzato, fino a che abbiamo scoperto che si muore di fame o detenuti in canili umani.
Da elettori i legislatori ci imponevano le leggi secondo il loro diritto, fino a che abbiamo scoperto che erano solo corrotti, mafiosi e massoni.
Ecco, appunto: siamo i “coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare.
E se qualcuno non vuol essere “coglione” e vuol cambiare le cose, ma non ci riesce, vuol dire che è “coglione” lui e non lo sa, ovvero è circondato da amici e parenti “coglioni”.
Ho vissuto una breve vita confrontandomi con una sequela di generazioni difettate condotte in un caos organizzato. Uomini e donne senza ideali e senza valori succubi del flusso culturale e politico del momento, scevri da ogni discernimento tra il bene ed il male. L’Io è elevato all’ennesima potenza. La mia Collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo” composta da decine di saggi, riporta ai posteri una realtà attuale storica, per tema e per territorio, sconosciuta ai contemporanei perché corrotta da verità mediatiche o giudiziarie.
Per la Conte dei Conti è l’Italia delle truffe. È l'Italia degli sprechi e delle frodi fotografata in un dossier messo a punto dalla procura generale della Corte dei Conti che ha messo insieme le iniziative più rilevanti dei procuratori regionali. La Corte dei Conti ha scandagliato l'attività condotta da tutte le procure regionali e ha messo insieme «le fattispecie di particolare interesse, anche sociale, rilevanti per il singolo contenuto e per il pregiudizio economico spesso ingente».
A parlar di sé e delle proprie disgrazie in prima persona, oltre a non destare l’interesse di alcuno pur nelle tue stesse condizioni, può farti passare per mitomane o pazzo. Non sto qui a promuovermi. Non si può, però, tacere la verità storica che ci circonda, stravolta da verità menzognere mediatiche e giudiziarie. Ad ogni elezione legislativa ci troviamo a dover scegliere tra: il partito dei condoni; il partito della CGIL; il partito dei giudici. Io da anni non vado a votare perché non mi rappresentano i nominati in Parlamento. Oltretutto mi disgustano le malefatte dei nominati. Un esempio per tutti, anche se i media lo hanno sottaciuto. La riforma forense, approvata con Legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra gli ultimi interventi legislativi consegnatici frettolosamente dal Parlamento prima di cessare di fare danni. I nonni avvocati in Parlamento (compresi i comunisti) hanno partorito, in previsione di un loro roseo futuro, una contro riforma fatta a posta contro i giovani. Ai fascisti che hanno dato vita al primo Ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36) questa contro riforma reazionaria gli fa un baffo. Trattasi di una “riforma”, scritta come al solito negligentemente, che non viene in alcun modo incontro ed anzi penalizza in modo significativo i giovani. Da anni inascoltato denuncio il malaffare di avvocati e magistrati ed il loro malsano accesso alla professione. Cosa ho ottenuto a denunciare i trucchi per superare l’esame? Insabbiamento delle denunce e attivazione di processi per diffamazione e calunnia, chiusi, però, con assoluzione piena. Intanto ti intimoriscono. Ed anche la giustizia amministrativa si adegua.
La mafia cos'è? La risposta in un aneddoto di Paolo Borsellino: "Sapete che cos'è la Mafia... faccia conto che ci sia un posto libero in tribunale..... e che si presentino 3 magistrati... il primo è bravissimo, il migliore, il più preparato.. un altro ha appoggi formidabili dalla politica... e il terzo è un fesso... sapete chi vincerà??? Il fesso. Ecco, mi disse il boss, questa è la MAFIA!"
"La vera mafia è lo Stato, alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da mafiosi. Il magistrato che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo voglio in galera". Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da Pecora su Radio 2.
«Da noi - ha dichiarato Silvio Berlusconi ai cronisti di una televisione greca il 23 febbraio 2013 - la magistratura è una mafia più pericolosa della mafia siciliana, e lo dico sapendo di dire una cosa grossa». «In Italia regna una "magistocrazia". Nella magistratura c'è una vera e propria associazione a delinquere» Lo ha detto Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013 durante la riunione del gruppo Pdl a Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi all'attacco ai magistrati: «L'Anm è come la P2, non dice chi sono i loro associati». Il riferimento dell'ex premier è alle associazioni interne ai magistrati, come Magistratura Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile 2013 per un comizio.
Abbiamo una Costituzione catto-comunista predisposta e votata dagli apparati politici che rappresentavano la metà degli italiani, ossia coloro che furono i vincitori della guerra civile e che votarono per la Repubblica. Una Costituzione fondata sul lavoro (che oggi non c’è e per questo ci rende schiavi) e non sulla libertà (che ci dovrebbe sempre essere, ma oggi non c’è e per questo siamo schiavi). Un diritto all’uguaglianza inapplicato in virtù del fatto che il potere, anziché essere nelle mani del popolo che dovrebbe nominare i suoi rappresentanti politici, amministrativi e giudiziari, è in mano a mafie, caste, lobbies e massonerie.
Siamo un popolo corrotto: nella memoria, nell’analisi e nel processo mentale di discernimento. Ogni dato virulento che il potere mediatico ci ha propinato, succube al potere politico, economico e giudiziario, ha falsato il senso etico della ragione e logica del popolo. Come il personal computer, giovani e vecchi, devono essere formattati. Ossia, azzerare ogni cognizione e ripartire da zero all’acquisizione di conoscenze scevre da influenze ideologiche, religiose ed etniche. Dobbiamo essere consci del fatto che esistono diverse verità.
Ogni fatto è rappresentato da una verità storica; da una verità mediatica e da una verità giudiziaria.
La verità storica è conosciuta solo dai responsabili del fatto. La verità mediatica è quella rappresentata dai media approssimativi che sono ignoranti in giurisprudenza e poco esperti di frequentazioni di aule del tribunale, ma genuflessi e stanziali negli uffici dei pm e periti delle convinzioni dell’accusa, mai dando spazio alla difesa. La verità giudiziaria è quella che esce fuori da una corte, spesso impreparata culturalmente, tecnicamente e psicologicamente (in virtù dei concorsi pubblici truccati). Nelle aule spesso si lede il diritto di difesa, finanche negando le più elementari fonti di prova, o addirittura, in caso di imputati poveri, il diritto alla difesa. Il gratuita patrocinio è solo una balla. Gli avvocati capaci non vi consentono, quindi ti ritrovi con un avvocato d’ufficio che spesso si rimette alla volontà della corte, senza conoscere i carteggi. La sentenza è sempre frutto della libera convinzione di una persona (il giudice). Mi si chiede cosa fare. Bisogna, da privato, ripassare tutte le fasi dell’indagine e carpire eventuali errori dei magistrati trascurati dalla difesa (e sempre ve ne sono). Eventualmente svolgere un’indagine parallela. Intanto aspettare che qualche pentito, delatore, o intercettazione, produca una nuova prova che ribalti l’esito del processo. Quando poi questa emerge bisogna sperare nella fortuna di trovare un magistrato coscienzioso (spesso non accade per non rilevare l’errore dei colleghi), che possa aprire un processo di revisione.
Ognuno di noi antropologicamente ha un limite, non dovuto al sesso, od alla razza, od al credo religioso, ma bensì delimitato dall’istruzione ricevuta ed all’educazione appresa dalla famiglia e dalla società, esse stesse influenzate dall’ambiente, dalla cultura, dagli usi e dai costumi territoriali. A differenza degli animali la maggior parte degli umani non si cura del proprio limite e si avventura in atteggiamenti e giudizi non consoni al loro stato. Quando a causa dei loro limiti non arrivano ad avere ragione con il ragionamento, allora adottano la violenza (fisica o psicologica, ideologica o religiosa) e spesso con la violenza ottengono un effimero ed immeritato potere o risultato. I più intelligenti, conoscendo il proprio limite, cercano di ampliarlo per risultati più duraturi e poteri meritati. Con nuove conoscenze, con nuovi studi, con nuove esperienze arricchiscono il loro bagaglio culturale ed aprono la loro mente, affinché questa accetti nuovi concetti e nuovi orizzonti. Acquisizione impensabile in uno stato primordiale. In non omologati hanno empatia per i conformati. Mentre gli omologati sono mossi da viscerale egoismo dovuto all’istinto di sopravvivenza: voler essere ed avere più di quanto effettivamente si possa meritare di essere od avere. Loro ed i loro interessi come ombelico del mondo. Da qui la loro paura della morte e la ricerca di un dio assoluto e personale, finanche cattivo: hanno paura di perdere il niente che hanno e sono alla ricerca di un dio che dal niente che sono li elevi ad entità. L'empatia designa un atteggiamento verso gli altri caratterizzato da un impegno di comprensione dell'altro, escludendo ogni attitudine affettiva personale (simpatia, antipatia) e ogni giudizio morale, perché mettersi nei panni dell'altro per sapere cosa pensa e come reagirebbe costituisce un importante fattore di sopravvivenza in un mondo in cui l'uomo è in continua competizione con gli altri uomini. Fa niente se i dotti emancipati e non omologati saranno additati in patria loro come Gesù nella sua Nazareth: semplici figli di falegnami, perchè "non c'è nessun posto dove un profeta abbia meno valore che non nella sua patria e nella sua casa". Non c'è bisogno di essere cristiani per apprezzare Gesù Cristo: non per i suoi natali, ma per il suo insegnamento e, cosa più importante, per il suo esempio. Fa capire che alla fine è importante lasciar buona traccia di sè, allora sì che si diventa immortali nella rimembranza altrui.
Tutti vogliono avere ragione e tutti pretendono di imporre la loro verità agli altri. Chi impone ignora, millanta o manipola la verità. L'ignoranza degli altri non può discernere la verità dalla menzogna. Il saggio aspetta che la verità venga agli altri. La sapienza riconosce la verità e spesso ciò fa ricredere e cambiare opinione. Solo gli sciocchi e gli ignoranti non cambiano mai idea, per questo sono sempre sottomessi. La Verità rende liberi, per questo è importante far di tutto per conoscerla.
Tutti gli altri intendono “Tutte le Mafie” come un insieme orizzontale di entità patologiche criminali territoriali (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, ecc.).
Io intendo “Tutte le Mafie” come un ordinamento criminale verticale di entità fisiologiche nazionali composte, partendo dal basso: dalle mafie (la manovalanza), dalle Lobbies, dalle Caste e dalle Massonerie (le menti).
La Legalità è il comportamento umano conforme al dettato della legge nel compimento di un atto o di un fatto. Se l'abito non fa il monaco, e la cronaca ce lo insegna, nè toghe, nè divise, nè poteri istituzionali o mediatici hanno la legittimazione a dare insegnamenti e/o patenti di legalità. Lor signori non si devono permettere di selezionare secondo loro discrezione la società civile in buoni e cattivi ed ovviamente si devono astenere dall'inserirsi loro stessi tra i buoni. Perchè secondo questa cernita il cattivo è sempre il povero cittadino, che oltretutto con le esose tasse li mantiene. Non dimentichiamoci che non ci sono dio in terra e fino a quando saremo in democrazia, il potere è solo prerogativa del popolo.
Non sono conformato ed omologato, per questo son fiero ed orgoglioso di essere diverso.
PER UNA LETTURA UTILE E CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
Recensione di un’opera editoriale osteggiata dalla destra e dalla sinistra. Perle di saggezza destinate al porcilaio.
I giornalisti della tv e stampa, sia quotidiana, sia periodica, da sempre sono tacciati di faziosità e mediocrità. Si dice che siano prezzolati e manipolati dal potere e che esprimano solo opinioni personali, non raccontando i fatti. Lo dice Beppe Grillo e forse ha ragione. Ma tra di loro vi sono anche eccellenze di gran valore. Questo vale per le maggiori testate progressiste (Il Corriere della Sera, L’Espresso, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano), ma anche per le testate liberali (Panorama, Oggi, Il Giornale, Libero Quotidiano). In una Italia, laddove alcuni magistrati tacitano con violenza le contro voci, questi eccelsi giornalisti, attraverso le loro coraggiose inchieste, sono fonte di prova incontestabile per raccontare l’Italia vera, ma sconosciuta. L’Italia dei gattopardi e dell’ipocrisia. L’Italia dell’illegalità e dell’utopia. Tramite loro, citando gli stessi e le loro inchieste scottanti, Antonio Giangrande ha raccolto in venti anni tutto quanto era utile per dimostrare che la mafia vien dall’alto. Pochi lupi e tante pecore. Una selezione di nomi e fatti articolati per argomento e per territorio. L’intento di Giangrande è rappresentare la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Questa è sociologia storica, di cui il Giangrande è il massimo cultore. Questa è la collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo” pubblicata su www.controtuttelemafie.it ed altri canali web, su Amazon in E-Book e su Lulu in cartaceo. 40 libri scritti da Antonio Giangrande, presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie” e scrittore-editore dissidente. Saggi pertinenti questioni che nessuno osa affrontare. Opere che i media si astengono a dare loro la dovuta visibilità e le rassegne culturali ad ignorare. In occasione delle festività ed in concomitanza con le nuove elezioni legislative sarebbe cosa buona e utile presentare ai lettori una lettura alternativa che possa rendere più consapevole l’opinione dei cittadini. Un’idea regalo gratuita o con modica spesa, sicuramente gradita da chi la riceve. Non è pubblicità gratuita che si cerca per fini economici, né tanto meno è concorrenza sleale. Si chiede solo di divulgare la conoscenza di opere che già sul web sono conosciutissime e che possono anche esser lette gratuitamente. Evento editoriale esclusivo ed aggiornato periodicamente. Di sicuro interesse generale. Fa niente se dietro non ci sono grandi o piccoli gruppi editoriali. Ciò è garanzia di libertà.
Grazie per l’adesione e la partecipazione oltre che per la solidarietà.
POLITICA, GIUSTIZIA ED INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE VERGINELLE.
Politica, giustizia ed informazione. In tempo di voto si palesa l’Italietta delle verginelle.
Da scrittore navigato, il cui sacco di 50 libri scritti sull’Italiopoli degli italioti lo sta a dimostrare, mi viene un rigurgito di vomito nel seguire tutto quanto viene detto da scatenate sgualdrine (in senso politico) di ogni schieramento politico. Sgualdrine che si atteggiano a verginelle e si presentano come aspiranti salvatori della patria in stampo elettorale.
In Italia dove non c’è libertà di stampa e vige la magistratocrazia è facile apparire verginelle sol perché si indossa l’abito bianco.
I nuovi politici non si presentano come preparati a risolvere i problemi, meglio se liberi da pressioni castali, ma si propongono, a chi non li conosce bene, solo per le loro presunti virtù, come verginelle illibate.
Ci si atteggia a migliore dell’altro in una Italia dove il migliore c’ha la rogna.
L’Italietta è incurante del fatto che Nicola Vendola a Bari sia stato assolto in modo legittimo dall’amica della sorella o Luigi De Magistris sia stato assolto a Salerno in modo legale dalla cognata di Michele Santoro, suo sponsor politico.
L’Italietta che non batte ciglio quando a Bari Massimo D’Alema in modo lecito esce pulito da un’inchiesta penale. Accogliendo la richiesta d’archiviazione avanzata dal pm, il gip Concetta Russi il 22 giugno ’95 decise per il proscioglimento, ritenendo superfluo ogni approfondimento: «Uno degli episodi di illecito finanziamento riferiti – scrisse nelle motivazioni - e cioè la corresponsione di un contributo di 20 milioni in favore del Pci, ha trovato sostanziale conferma, pur nella diversità di alcuni elementi marginali, nella leale dichiarazione dell’onorevole D’Alema, all’epoca dei fatti segretario regionale del Pci (...). L’onorevole D’Alema non ha escluso che la somma versata dal Cavallari fosse stata proprio dell’importo da quest’ultimo indicato». Chi era il titolare dell’inchiesta che sollecitò l’archiviazione? Il pm Alberto Maritati, eletto coi Ds e immediatamente nominato sottosegretario all’Interno durante il primo governo D’Alema, numero due del ministro Jervolino, poi ancora sottosegretario alla giustizia nel governo Prodi, emulo di un altro pm pugliese diventato sottosegretario con D’Alema: Giannicola Sinisi. E chi svolse insieme a Maritati gli accertamenti su Cavallari? Chi altro firmò la richiesta d’archiviazione per D’Alema? Semplice: l’amico e collega Giuseppe Scelsi, magistrato di punta della corrente di Magistratura democratica a Bari, poi titolare della segretissima indagine sulle ragazze reclutate per le feste a Palazzo Grazioli, indagine «anticipata» proprio da D’Alema.
L’Italietta non si scandalizza del fatto che sui Tribunali e nella scuole si spenda il nome e l’effige di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino da parte di chi, loro colleghi, li hanno traditi in vita, causandone la morte.
L’Italietta non si sconvolge del fatto che spesso gli incriminati risultano innocenti e ciononostante il 40% dei detenuti è in attesa di giudizio. E per questo gli avvocati in Parlamento, anziché emanar norme, scioperano nei tribunali, annacquando ancor di più la lungaggine dei processi.
L’Italietta che su giornali e tv foraggiate dallo Stato viene accusata da politici corrotti di essere evasore fiscale, nonostante sia spremuta come un limone senza ricevere niente in cambio.
L’Italietta, malgrado ciò, riesce ancora a discernere le vergini dalle sgualdrine, sotto l’influenza mediatica-giudiziaria.
Fa niente se proprio tutta la stampa ignava tace le ritorsioni per non aver taciuto le nefandezze dei magistrati, che loro sì decidono chi candidare al Parlamento per mantenere e tutelare i loro privilegi.
Da ultimo è la perquisizione ricevuta in casa dall’inviato de “La Repubblica”, o quella ricevuta dalla redazione del tg di Telenorba.
Il re è nudo: c’è qualcuno che lo dice. E’ la testimonianza di Carlo Vulpio sull’integrità morale di Nicola Vendola, detto Niki. L’Editto bulgaro e l’Editto di Roma (o di Bari). Il primo è un racconto che dura da anni. Del secondo invece non si deve parlare.
I giornalisti della tv e stampa, sia quotidiana, sia periodica, da sempre sono tacciati di faziosità e mediocrità. Si dice che siano prezzolati e manipolati dal potere e che esprimano solo opinioni personali, non raccontando i fatti. La verità è che sono solo codardi.
E cosa c’è altro da pensare. In una Italia, laddove alcuni magistrati tacitano con violenza le contro voci. L’Italia dei gattopardi e dell’ipocrisia. L’Italia dell’illegalità e dell’utopia.
Tutti hanno taciuto "Le mani nel cassetto. (e talvolta anche addosso...). I giornalisti perquisiti raccontano". Il libro, introdotto dal presidente nazionale dell’Ordine Enzo Jacopino, contiene le testimonianze, delicate e a volte ironiche, di ventuno giornalisti italiani, alcuni dei quali noti al grande pubblico, che hanno subito perquisizioni personali o ambientali, in casa o in redazione, nei computer e nelle agende, nei libri e nei dischetti cd o nelle chiavette usb, nella biancheria e nel frigorifero, “con il dichiarato scopo di scoprire la fonte confidenziale di una notizia: vera, ma, secondo il magistrato, non divulgabile”. Nel 99,9% dei casi le perquisizioni non hanno portato “ad alcun rinvenimento significativo”.
Cosa pensare se si è sgualdrina o verginella a secondo dell’umore mediatico. Tutti gli ipocriti si facciano avanti nel sentirsi offesi, ma che fiducia nell’informazione possiamo avere se questa è terrorizzata dalle querele sporte dai PM e poi giudicate dai loro colleghi Giudici.
Alla luce di quanto detto, è da considerare candidabile dai puritani nostrani il buon “pregiudicato” Alessandro Sallusti che ha la sol colpa di essere uno dei pochi coraggiosi a dire la verità?
Si badi che a ricever querela basta recensire il libro dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, che racconta gli abusi ricevuti dal giornalista che scrive la verità, proprio per denunciare l'arma intimidatoria delle perquisizioni alla stampa.
Che giornalisti sono coloro che, non solo non raccontano la verità, ma tacciono anche tutto ciò che succede a loro?
E cosa ci si aspetta da questa informazione dove essa stessa è stata visitata nella loro sede istituzionale dalla polizia giudiziaria che ha voluto delle copie del volume e i dati identificativi di alcune persone, compreso il presidente che dell'Ordine è il rappresentante legale?
La Costituzione all’art. 104 afferma che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.”
Ne conviene che il dettato vuol significare non equiparare la Magistratura ad altro potere, ma differenziarne l’Ordine con il Potere che spetta al popolo. Ordine costituzionalizzato, sì, non Potere.
Magistrati. Ordine, non potere, come invece il più delle volte si scrive, probabilmente ricordando Montesquieu; il quale però aggiungeva che il potere giudiziario é “per così dire invisibile e nullo”. Solo il popolo è depositario della sovranità: per questo Togliatti alla Costituente avrebbe voluto addirittura che i magistrati fossero eletti dal popolo, per questo sostenne le giurie popolari. Ordine o potere che sia, in ogni caso è chiaro che di magistrati si parla.
Allora io ho deciso: al posto di chi si atteggia a verginella io voterei sempre un “pregiudicato” come Alessandro Sallusti, non invece chi incapace, invidioso e cattivo si mette l’abito bianco per apparir pulito.
E facile dire pregiudicato. Parliamo del comportamento degli avvocati. Il caso della condanna di Sallusti. Veniamo al primo grado: l’avvocato di Libero era piuttosto noto perché non presenziava quasi mai alle udienze, preferendo mandarci sempre un sostituto sottopagato, dice Filippo Facci. E qui, il giorno della sentenza, accadde un fatto decisamente singolare. Il giudice, una donna, lesse il dispositivo che condannava Sallusti a pagare circa 5mila euro e Andrea Monticone a pagarne 4000 (più 30mila di risarcimento, che nel caso dei magistrati è sempre altissimo) ma nelle motivazioni della sentenza, depositate tempo dopo, lo stesso giudice si dolse di essersi dimenticato di prevedere una pena detentiva. Un’esagerazione? Si può pensarlo. Tant’è, ormai era andata: sia il querelante sia la Procura sia gli avvocati proposero tuttavia appello (perché in Italia si propone sempre appello, anche quando pare illogico o esagerato) e la sentenza della prima sezione giunse il 17 giugno 2011. E qui accadeva un altro fatto singolare: l’avvocato di Libero tipicamente non si presentò in aula e però neppure il suo sostituto: il quale, nel frattempo, aveva abbandonato lo studio nell’ottobre precedente come del resto la segretaria, entrambi stufi di lavorare praticamente gratis. Fatto sta che all’Appello dovette presenziare un legale d’ufficio – uno che passava di lì, letteralmente – sicché la sentenza cambiò volto: come richiesto dall’accusa, Monticone si beccò un anno con la condizionale e Sallusti si beccò un anno e due mesi senza un accidente di condizionale, e perché? Perché aveva dei precedenti per l’omesso controllo legato alla diffamazione. Il giudice d’Appello, in pratica, recuperò la detenzione che il giudice di primo grado aveva dimenticato di scrivere nel dispositivo.
Ma anche il Tribuno Marco Travaglio è stato vittima degli avvocati. Su Wikipedia si legge che nel 2000 è stato condannato in sede civile, dopo essere stato citato in giudizio da Cesare Previti a causa di un articolo in cui Travaglio ha definito Previti «un indagato» su “L’Indipendente”. Previti era effettivamente indagato ma a causa dell'impossibilità da parte dell' avvocato del giornale di presentare le prove in difesa di Travaglio in quanto il legale non era retribuito, il giornalista fu obbligato al risarcimento del danno quantificato in 79 milioni di lire. Comunque lui stesso a “Servizio Pubblico” ha detto d’aver perso una querela con Previti, parole sue, «perché l’avvocato non è andato a presentare le mie prove». Colpa dell’avvocato.
Ma chi e quando le cose cambieranno?
Per fare politica in Italia le strade sono poche, specialmente se hai qualcosa da dire e proponi soluzioni ai problemi generali. La prima è cominciare a partecipare a movimenti studenteschi fra le aule universitarie, mettersi su le stellette di qualche occupazione e poi prendere la tessera di un partito. Se di sinistra è meglio. Poi c'è la strada della partecipazione politica con tesseramento magari sfruttando una professione che ti metta in contatto con molti probabili elettori: favoriti sono gli avvocati, i medici di base ed i giornalisti. C'è una terza via che sempre più prende piede. Fai il magistrato. Se puoi occupati di qualche inchiesta che abbia come bersaglio un soggetto politico, specie del centro destra, perché gli amici a sinistra non si toccano. Comunque non ti impegnare troppo. Va bene anche un'archiviazione. Poi togli la toga e punta al Palazzo. Quello che interessa a sinistra è registrare questo movimento arancione con attacco a tre punte: De Magistris sulla fascia, Di Pietro in regia e al centro il nuovo bomber Antonio Ingroia. Se è un partito dei magistrati e per la corporazione dei magistrati. Loro "ci stanno".
Rivoluzione Civile è una formazione improvvisata le cui figure principali di riferimento sono tre magistrati: De Magistris, Di Pietro e Ingroia. Dietro le loro spalle si rifugiano i piccoli partiti di Ferrero, Diliberto e Bonelli in cerca di presenza parlamentare. E poi, ci mancherebbe, con loro molte ottime persone di sinistra critica all’insegna della purezza. Solo che la loro severità rivolta in special modo al Partito Democratico, deve per forza accettare un’eccezione: Antonio Di Pietro. La rivelazione dei metodi disinvolti con cui venivano gestiti i fondi dell’Italia dei Valori, e dell’uso personale che l’ex giudice fece di un’eredità cospicua donata a lui non certo per godersela, lo hanno costretto a ritirarsi dalla prima fila. L’Italia dei Valori non si presenta più da sola, non per generosità ma perchè andrebbe incontro a una sconfitta certa. Il suo leader però viene ricandidato da Ingroia senza troppi interrogativi sulla sua presentabilità politica. “Il Fatto”, solitamente molto severo, non ha avuto niente da obiettare sul Di Pietro ricandidato alla chetichella. Forse perchè non era più alleato di Bersani e Vendola? Si chiede Gad Lerner.
Faceva una certa impressione nei tg ascoltare Nichi Vendola (che, secondo Marco Ventura su “Panorama”, la magistratura ha salvato dalle accuse di avere imposto un primario di sua fiducia in un concorso riaperto apposta e di essere coinvolto nel malaffare della sanità in Puglia) dire che mentre le liste del Pd-Sel hanno un certo profumo, quelle del Pdl profumano “di camorra”. E che dire di Ingroia e il suo doppiopesismo: moralmente ed eticamente intransigente con gli altri, indulgente con se stesso. Il candidato Ingroia, leader rivoluzionario, da pm faceva domande e i malcapitati dovevano rispondere. Poi a rispondere, come candidato premier, tocca a lui. E lui le domande proprio non le sopporta, come ha dimostrato nella trasmissione condotta su Raitre da Lucia Annunziata. Tanto da non dimettersi dalla magistratura, da candidarsi anche dove non può essere eletto per legge (Sicilia), da sostenere i No Tav ed avere come alleato l'inventore della Tav (Di Pietro), da criticare la legge elettorale, ma utilizzarla per piazzare candidati protetti a destra e a manca. L'elenco sarebbe lungo, spiega Alessandro Sallusti. Macchè "rivoluzione" Ingroia le sue liste le fa col manuale Cencelli. L'ex pm e i partiti alleati si spartiscono i posti sicuri a Camera e Senato, in barba alle indicazioni delle assemblee territoriali. Così, in Lombardia, il primo lombardo è al nono posto. Sono tanti i siciliani che corrono alle prossime elezioni politiche in un seggio lontano dall’isola. C’è Antonio Ingroia capolista di Rivoluzione Civile un po' dappertutto. E poi ci sono molti "paracadutati" che hanno ottenuto un posto blindato lontano dalla Sicilia. Pietro Grasso, ad esempio, è capolista del Pd nel Lazio: "Non mi candido in Sicilia per una scelta di opportunità", ha detto, in polemica con Ingroia, che infatti in Sicilia non è eleggibile. In Lombardia per Sel c'è capolista Claudio Fava, giornalista catanese, e non candidato alle ultime elezioni regionali per un pasticcio fatto sulla sua residenza in Sicilia (per fortuna per le elezioni politiche non c'è bisogno di particolare documentazione....). Fabio Giambrone, braccio destro di Orlando, corre anche in Lombardia e in Piemonte. Celeste Costantino, segretaria provinciale di Sel a Palermo è stata candidata, con qualche malumore locale, nella circoscrizione Piemonte 1. Anna Finocchiaro, catanese e con il marito sotto inchiesta è capolista del Pd, in Puglia. Sarà lei in caso di vittoria del Pd la prossima presidente del Senato. Sempre in Puglia alla Camera c'è spazio per Ignazio Messina al quarto posto della lista di Rivoluzione civile. E che dire di Don Gallo che canta la canzone partigiana "Bella Ciao" sull'altare, sventolando un drappo rosso.
"Serve una legge per regolamentare e limitare la discesa in politica dei magistrati, almeno nei distretti dove hanno esercitato le loro funzioni, per evitare che nell'opinione pubblica venga meno la considerazione per i giudici". Lo afferma il presidente della Cassazione, nel suo discorso alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario 2013. Per Ernesto Lupo devono essere "gli stessi pm a darsi delle regole nel loro Codice etico". Per la terza e ultima volta - dal momento che andrà in pensione il prossimo maggio - il Primo presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, ha illustrato - alla presenza del Presidente della Repubblica e delle alte cariche dello Stato - la «drammatica» situazione della giustizia in Italia non solo per la cronica lentezza dei processi, 128 mila dei quali si sono conclusi nel 2012 con la prescrizione, ma anche per la continua violazione dei diritti umani dei detenuti per la quale è arrivato l’ultimatum dalla Corte Ue. Sebbene abbia apprezzato le riforme del ministro Paola Severino - taglio dei “tribunalini” e riscrittura dei reati contro la pubblica amministrazione - Lupo ha tuttavia sottolineato che l’Italia continua ad essere tra i Paesi più propensi alla corruzione. Pari merito con la Bosnia, e persino dietro a nazioni del terzo mondo. Il Primo presidente ha, poi, chiamato gli stessi magistrati a darsi regole severe per chi scende in politica e a limitarsi, molto, nel ricorso alla custodia in carcere. «È auspicabile - esorta Lupo - che nella perdurante carenza della legge, sia introdotta nel codice etico quella disciplina più rigorosa sulla partecipazione dei magistrati alla vita politica e parlamentare, che in decenni il legislatore non è riuscito ad approvare». Per regole sulle toghe in politica, si sono espressi a favore anche il Procuratore generale della Suprema Corte Gianfranco Ciani, che ha criticato i pm che flirtano con certi media cavalcando le inchieste per poi candidarsi, e il presidente dell’Anm Rodolfo Sabelli. Per il Primo presidente nelle celle ci sono 18.861 detenuti di troppo e bisogna dare più permessi premio. Almeno un quarto dei reclusi è in attesa di condanna definitiva e i giudici devono usare di più le misure alternative.
"Non possiamo andare avanti così - lo aveva già detto il primo presidente della Corte di Cassazione, Vincenzo Carbone, nella relazione che ha aperto la cerimonia dell’ inaugurazione dell’ Anno Giudiziario 2009 - In più, oltre a un più rigoroso richiamo dei giudici ai propri doveri di riservatezza, occorrerebbe contestualmente evitare la realizzazione di veri e propri 'processi mediatici', simulando al di fuori degli uffici giudiziari, e magari anche con la partecipazione di magistrati, lo svolgimento di un giudizio mentre è ancora in corso il processo nelle sedi istituzionali". "La giustizia - sottolinea Carbone - deve essere trasparente ma deve svolgersi nelle sedi proprie, lasciando ai media il doveroso ed essenziale compito di informare l'opinione pubblica, ma non di sostituirsi alla funzione giudiziaria".
Questo per far capire che il problema “Giustizia” sono i magistrati. Nella magistratura sono presenti "sacche di inefficienza e di inettitudine". La denuncia arriva addirittura dal procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, sempre nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2009.
Ma è questa la denuncia più forte che viene dall'apertura dell'anno giudiziario 2013 nelle Corti d'Appello: «Non trovo nulla da eccepire sui magistrati che abbandonano la toga per candidarsi alle elezioni politiche - ha detto il presidente della Corte di Appello di Roma Giorgio Santacroce. Ma ha aggiunto una stoccata anche ad alcuni suoi colleghi - Non mi piacciono - ha affermato - i magistrati che non si accontentano di far bene il loro lavoro, ma si propongono di redimere il mondo. Quei magistrati, pochissimi per fortuna, che sono convinti che la spada della giustizia sia sempre senza fodero, pronta a colpire o a raddrizzare le schiene. Parlano molto di sè e del loro operato anche fuori dalle aule giudiziarie, esponendosi mediaticamente, senza rendersi conto che per dimostrare quell' imparzialità che è la sola nostra divisa, non bastano frasi ad effetto, intrise di una retorica all'acqua di rose. Certe debolezze non rendono affatto il magistrato più umano. I magistrati che si candidano esercitano un diritto costituzionalmente garantito a tutti i cittadini, ma Piero Calamandrei diceva che quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra».
Dove non arrivano a fare le loro leggi per tutelare prerogative e privilegi della casta, alcuni magistrati, quando non gli garba il rispetto e l’applicazione della legge, così come gli è dovuto e così come hanno giurato, disapplicano quella votata da altri. Esempio lampante è Taranto. I magistrati contestano la legge, anziché applicarla, a scapito di migliaia di lavoratori. Lo strapotere e lo straparlare dei magistrati si incarna in alcuni esempi. «Ringrazio il Presidente della Repubblica, come cittadino ma anche di giudice, per averci allontanati dal precipizio verso il quale inconsciamente marciavamo». Sono le parole con le quali il presidente della Corte d'appello, Mario Buffa, ha aperto, riferendosi alla caduta del Governo Berlusconi, la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 nell'aula magna del palazzo di giustizia di Lecce. «Per fortuna il vento sembra essere cambiato – ha proseguito Buffa: la nuova ministra non consuma le sue energie in tentativi di delegittimare la magistratura, creando intralci alla sua azione». Ma il connubio dura poco. L’anno successivo, nel 2013, ad aprire la cerimonia di inaugurazione è stata ancora la relazione del presidente della Corte d’appello di Lecce, Mario Buffa. Esprimendosi sull’Ilva di Taranto ha dichiarato che “il Governo ha fatto sull’Ilva una legge ad aziendam, che si colloca nella scia delle leggi ad personam inaugurata in Italia negli ultimi venti anni, una legge che riconsegna lo stabilimento a coloro che fingevano di rispettare le regole di giorno e continuavano a inquinare di notte”. Alla faccia dell’imparzialità. Giudizi senza appello e senza processo. Non serve ai magistrati candidarsi in Parlamento. La Politica, in virtù del loro strapotere, anche mediatico, la fanno anche dai banchi dei tribunali. Si vuole un esempio? "E' una cosa indegna". Veramente mi disgusta il fatto che io debba leggere sul giornale, momento per momento, 'stanno per chiamare la dottoressa Tizio, la stanno chiamando...l'hanno interrogato...la posizione si aggrava'". E ancora: "Perchè se no qua diamo per scontato che tutto viene raccontato dai giornali, che si fa il clamore mediatico, che si va a massacrare la gente prima ancora di trovare un elemento di colpevolezza". E poi ancora: "A me pare molto più grave il fatto che un cialtrone di magistrato dia indebitamente la notizia in violazione di legge...". Chi parla potrebbe essere Silvio Berlusconi, che tante volte si è lamentato di come le notizie escano dai tribunali prima sui giornali che ai diretti interessati. E invece, quelle che riporta il Corriere della Sera, sono parole pronunciate nel giugno 2010 nientemeno che del capo della polizia Antonio Manganelli, al telefono col prefetto Nicola Izzo, ex vicario della polizia. Ed allora “stronzi” chi li sta a sentire.
«L'unica spiegazione che posso dare è che ho detto sempre quello che pensavo anche affrontando critiche, criticando a mia volta la magistratura associata e gli alti vertici della magistratura. E' successo anche ad altri più importanti e autorevoli magistrati, a cominciare da Giovanni Falcone. Forse non è un caso - ha concluso Ingroia - che quando iniziò la sua attività di collaborazione con la politica le critiche peggiori giunsero dalla magistratura. E' un copione che si ripete». «Come ha potuto Antonio Ingroia paragonare la sua piccola figura di magistrato a quella di Giovanni Falcone? Tra loro esiste una distanza misurabile in milioni di anni luce. Si vergogni». È il commento del procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, ai microfoni del TgLa7 condotto da Enrico Mentana contro l'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, ora leader di Rivoluzione civile. Non si è fatta attendere la replica dell'ex procuratore aggiunto di Palermo che dagli schermi di Ballarò respinge le accuse della sua ex collega: «Probabilmente non ha letto le mie parole, s'informi meglio. Io non mi sono mai paragonato a Falcone, ci mancherebbe. Denunciavo soltanto una certa reazione stizzita all'ingresso dei magistrati in politica, di cui fu vittima anche Giovanni quando collaborò con il ministro Martelli. Forse basterebbe leggere il mio intervento» E poi. «Ho atteso finora una smentita, invano. Siccome non è arrivata dico che l'unica a doversi vergognare è lei che, ancora in magistratura, prende parte in modo così indecente e astioso alla competizione politica manipolando le mie dichiarazioni. La prossima volta pensi e conti fino a tre prima di aprire bocca. Quanto ai suoi personali giudizi su di me, non mi interessano e alle sue piccinerie siamo abituati da anni. Mi basta sapere cosa pensava di me Paolo Borsellino e cosa pensava di lei. Ogni parola in più sarebbe di troppo». «Sì, è vero. È stato fatto un uso politico delle intercettazioni, ma questo è stato l’effetto relativo, la causa è che non si è mai fatta pulizia nel mondo della politica». Un'ammissione in piena regola fatta negli studi di La7 dall'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. Che sostanzialmente ha ammesso l'esistenza (per non dire l'appartenenza) di toghe politicizzate. Il leader di Rivoluzione civile ha spiegato meglio il suo pensiero: «Se fosse stata pulizia, non ci sarebbero state inchieste così clamorose e non ci sarebbe state intercettazioni utilizzate per uso politico». L’ex pm ha poi affermato che «ogni magistrato ha un suo tasso di politicità nel modo in cui interpreta il suo ruolo. Si può interpretare la legge in modo più o meno estensiva, più o meno garantista altrimenti non si spiegherebbero tante oscillazione dei giudici nelle decisioni. Ogni giudice dovrebbe essere imparziale rispetto alle parti, il che non significa essere neutrale rispetto ai valori o agli ideali, c’è e c’è sempre stata una magistratura conservatrice e una progressista». Guai a utilizzare il termine toga rossa però, perché "mi offendo, per il significato deteriore che questo termine ha avuto", ha aggiunto Ingroia. Dice dunque Ingroia, neoleader dell'arancia meccanica: «Piero Grasso divenne procuratore nazionale perché scelto da Berlusconi grazie a una legge ad hoc che escludeva Gian Carlo Caselli». Come se non bastasse, Ingroia carica ancora, come in un duello nella polvere del West: «Grasso è il collega che voleva dare un premio, una medaglia al governo Berlusconi per i suoi meriti nella lotta alla mafia». Ma poi, già che c'è, Caselli regola i conti anche con Grasso: «È un fatto storico che ai tempi del concorso per nominare il successore di Vigna le regole vennero modificate in corso d'opera dall'allora maggioranza con il risultato di escludermi. Ed è un fatto che questo concorso lo vinse Grasso e che la legge che mi impedì di parteciparvi fu dichiarata incostituzionale». Dunque, la regola aurea è sempre quella. I pm dopo aver bacchettato la società tutta, ora si bacchettano fra di loro, rievocano pagine più o meno oscure, si contraddicono con metodo, si azzannano con ferocia. E così i guardiani della legalità, le lame scintillanti della legge si graffiano, si tirano i capelli e recuperano episodi sottovuoto, dissigillando giudizi rancorosi. Uno spettacolo avvilente. Ed ancora a sfatare il mito dei magistrati onnipotenti ci pensano loro stessi, ridimensionandosi a semplici uomini, quali sono, tendenti all’errore, sempre impunito però. A ciò serve la polemica tra le Procure che indagano su Mps. «In certi uffici di procura "sembra che la regola della competenza territoriale sia un optional. C'è stata una gara tra diversi uffici giudiziari, ma sembra che la new entry abbia acquisito una posizione di primato irraggiungibile». Nel suo intervento al congresso di Magistratura democratica del 2 febbraio 2013 il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati ha alluso criticamente, pur senza citarla direttamente, alla procura di Trani, l'ultima ad aprire, tra le tante inchieste aperte, un'indagine su Mps. «No al protagonismo di certi magistrati che si propongono come tutori del Vero e del Giusto magari con qualche strappo alle regole processuali e alle garanzie, si intende a fin di Bene». A censurare il fenomeno il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati nel suo intervento al congresso di Md. Il procuratore di Milano ha puntato l'indice contro il "populismo" e la "demagogia" di certi magistrati, che peraltro - ha osservato - "non sanno resistere al fascino" dell'esposizione mediatica. Di tutto quanto lungamente ed analiticamente detto bisogna tenerne conto nel momento in cui si deve dare un giudizio su indagini, processi e condanne. Perché mai nulla è come appare ed i magistrati non sono quegli infallibili personaggi venuti dallo spazio, ma solo uomini che hanno vinto un concorso pubblico, come può essere quello italiano. E tenendo conto di ciò, il legislatore ha previsto più gradi di giudizio per il sindacato del sottoposto.
LA REPUBBLICA DELLE MANETTE.
La Repubblica delle manette (e degli orrori giudiziari). Augusto Minzolini, già direttore del Tg1, è stato assolto ieri dall'accusa di avere usato in modo improprio la carta di credito aziendale. Tutto bene? Per niente, risponde scrive Alessandro Sallusti. Perché quell'accusa di avere mangiato e viaggiato a sbafo (lo zelante Pm aveva chiesto due anni di carcere) gli è costata il posto di direttore oltre che un anno e mezzo di linciaggio mediatico da parte di colleghi che, pur essendo molto esperti di rimborsi spese furbetti, avevano emesso una condanna definitiva dando per buono il teorema del Pm (suggerito da Antonio Di Pietro, guarda caso). Minzolini avrà modo di rifarsi in sede civile, ma non tutti i danni sono risarcibili in euro, quando si toccano la dignità e la credibilità di un uomo. Fa rabbia che non il Pm, non la Rai, non i colleghi infangatori e infamatori sentano il bisogno di chiedere scusa. È disarmante che questo popolo di giustizialisti non debba pagare per i propri errori. Che sono tanti e si annidano anche dentro l'ondata di manette fatte scattare nelle ultime ore: il finanziere Proto, l'imprenditore Cellino, il manager del Montepaschi Baldassarri. Storie diverse e tra i malcapitati c'è anche Angelo Rizzoli, l'erede del fondatore del gruppo editoriale, anziano e molto malato anche per avere subito un calvario giudiziario che gli ha bruciato un terzo dell'esistenza: 27 anni per vedersi riconosciuta l'innocenza da accuse su vicende finanziarie degli anni Ottanta. L'uso spregiudicato della giustizia distrugge le persone, ma anche il Paese. Uno per tutti: il caso Finmeccanica, che pare creato apposta per oscurare la vicenda Montepaschi, molto scomoda alla sinistra. Solo la magistratura italiana si permette di trattare come se fosse una tangente da furbetti del quartierino il corrispettivo di una mediazione per un affare internazionale da centinaia di milioni di euro. Cosa dovrebbe fare la più importante azienda di alta tecnologia italiana (70mila dipendenti iper qualificati, i famosi cervelli) in concorrenza con colossi mondiali, grandi quanto spregiudicati? E se fra due anni, come accaduto in piccolo a Minzolini, si scopre che non c'è stato reato, chi ripagherà i miliardi in commesse persi a favore di aziende francesi e tedesche? Non c'entra «l'elogio della tangente» che ieri il solito Bersani ha messo in bocca a Berlusconi, che si è invece limitato a dire come stanno le cose nel complicato mondo dei grandi affari internazionali. Attenzione, che l'Italia delle manette non diventi l'Italia degli errori e orrori.
Un tempo era giustizialista. Ora invece ha cambiato idea. Magari si avvicinano le elezioni e Beppe Grillo comincia ad avere paura anche lui. Magari per i suoi. Le toghe quando agiscono non guardano in faccia nessuno. E così anche Beppe se la prende con i magistrati: "La legge protegge i delinquenti e manda in galera gli innocenti", afferma dal palco di Ivrea. Un duro attacco alla magistratura da parte del comico genovese, che afferma: "Questa magistratura fa paura. Io che sono un comico ho più di ottanta processi e Berlusconi da presidente del Consiglio ne ha 22 in meno, e poi va in televisione a lamentarsi". Il leader del Movimento Cinque Stelle solo qualche tempo fa chiedeva il carcere immediato per il crack Parmalat e anche oggi per lo scandalo di Mps. Garantista part-time - Beppe ora si scopre garantista. Eppure per lui la presunzione di innocenza non è mai esistita. Dai suoi palchi ha sempre emesso condanne prima che finissero le istruttorie. Ma sull'attacco alle toghe, Grillo non sembra così lontano dal Cav. Anche se in passato, il leader Cinque Stelle non ha mai perso l'occasione per criticare Berlusconi e le sue idee su una riforma della magistratura. E sul record di processi Berlusconi, ospite di Sky Tg24, ha precisato: "Grillo non è informato. Io ho un record assoluto di 2700 udienze. I procedimenti contro di me più di cento, credo nessuno possa battere un record del genere".
"La vera mafia è lo Stato, alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da mafiosi. Il magistrato che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo voglio in galera". Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da Pecora su Radio 2.
«Da noi - ha dichiarato Silvio Berlusconi ai cronisti di una televisione greca il 23 febbraio 2013 - la magistratura è una mafia più pericolosa della mafia siciliana, e lo dico sapendo di dire una cosa grossa». «In Italia regna una "magistocrazia". Nella magistratura c'è una vera e propria associazione a delinquere» Lo ha detto Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013 durante la riunione del gruppo Pdl a Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi all'attacco ai magistrati: «L'Anm è come la P2, non dice chi sono i loro associati». Il riferimento dell'ex premier è alle associazioni interne ai magistrati, come Magistratura Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile 2013 per un comizio.
Sui media prezzolati e/o ideologicizzati si parla sempre dei privilegi, degli sprechi e dei costi della casta dei rappresentanti politici dei cittadini nelle istituzioni, siano essi Parlamentari o amministratori e consiglieri degli enti locali. Molti di loro vorrebbero i barboni in Parlamento. Nessuno che pretenda che i nostri Parlamentari siano all’altezza del mandato ricevuto, per competenza, dedizione e moralità, al di là della fedina penale o delle prebende a loro destinate. Dimenticandoci che ci sono altri boiardi di Stato: i militari, i dirigenti pubblici e, soprattutto, i magistrati. Mai nessuno che si chieda: che fine fanno i nostri soldi, estorti con balzelli di ogni tipo. Se è vero, come è vero, che ci chiudono gli ospedali, ci chiudono i tribunali, non ci sono vie di comunicazione (strade e ferrovie), la pensione non è garantita e il lavoro manca. E poi sulla giustizia, argomento dove tutti tacciono, ma c’è tanto da dire. “Delegittimano la Magistratura” senti accusare gli idolatri sinistroidi in presenza di velate critiche contro le malefatte dei giudici, che in democrazia dovrebbero essere ammesse. Pur non avendo bisogno di difesa d’ufficio c’è sempre qualche manettaro che difende la Magistratura dalle critiche che essa fomenta. Non è un Potere, ma la sinistra lo fa passare per tale, ma la Magistratura, come ordine costituzionale detiene un potere smisurato. Potere ingiustificato, tenuto conto che la sovranità è del popolo che la esercita nei modi stabiliti dalle norme. Potere delegato da un concorso pubblico come può essere quello italiano, che non garantisce meritocrazia. Criticare l’operato dei magistrati nei processi, quando la critica è fondata, significa incutere dubbi sul loro operato. E quando si sentenzia, da parte dei colleghi dei PM, adottando le tesi infondate dell’accusa, si sentenzia nonostante il ragionevole dubbio. Quindi si sentenzia in modo illegittimo che comunque è difficile vederlo affermare da una corte, quella di Cassazione, che rappresenta l’apice del potere giudiziario. Le storture del sistema dovrebbero essere sanate dallo stesso sistema. Ma quando “Il Berlusconi” di turno si sente perseguitato dal maniaco giudiziario, non vi sono rimedi. Non è prevista la ricusazione del Pubblico Ministero che palesa il suo pregiudizio. Vi si permette la ricusazione del giudice per inimicizia solo se questi ha denunciato l’imputato e non viceversa. E’ consentita la ricusazione dei giudici solo per giudizi espliciti preventivi, come se non vi potessero essere intendimenti impliciti di colleganza con il PM. La rimessione per legittimo sospetto, poi, è un istituto mai applicato. Lasciando perdere Berlusconi, è esemplare il caso ILVA a Taranto. Tutta la magistratura locale fa quadrato: dal presidente della Corte d’Appello di Lecce, Buffa, al suo Procuratore Generale, Vignola, fino a tutto il Tribunale di Taranto. E questo ancora nella fase embrionale delle indagini Preliminari. Quei magistrati contro tutti, compreso il governo centrale, regionale e locale, sostenuti solo dagli ambientalisti di maniera. Per Stefano Livadiotti, autore di un libro sui magistrati, arrivano all'apice della carriera in automatico e guadagnano 7 volte più di un dipendente”, scrive Sergio Luciano su “Il Giornale”.
Pubblichiamo ampi stralci dell'intervista di Affaritaliani.it a Stefano Livadiotti realizzata da Sergio Luciano. Livadiotti, giornalista del settimanale l'Espresso e autore di Magistrati L'ultracasta, sta aggiornando il suo libro sulla base dei dati del rapporto 2012 del Cepej (Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa). Livadiotti è anche l'autore di un libro sugli sprechi dei sindacati, dal titolo L'altra casta.
La giustizia italiana non funziona, al netto delle polemiche politiche sui processi Berlusconi. Il rapporto 2012 del Cepej (Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa) inchioda il nostro sistema alla sua clamorosa inefficienza: 492 giorni per un processo civile in primo grado, contro i 289 della Spagna, i 279 della Francia e i 184 della Germania. Milioni di procedimenti pendenti. E magistrati che fanno carriera senza alcuna selezione meritocratica. E senza alcun effettivo rischio di punizione nel caso in cui commettano errori o illeciti. «Nessun sistema può essere efficiente se non riconosce alcun criterio di merito», spiega Stefano Livadiotti, giornalista del settimanale l'Espresso e autore di Magistrati-L'ultracasta. «È evidente che Silvio Berlusconi ha un enorme conflitto d'interessi in materia, che ne delegittima le opinioni, ma ciò non toglie che la proposta di riforma avanzata all'epoca da Alfano, con la separazione delle carriere, la ridefinizione della disciplina e la responsabilità dei magistrati, fosse assolutamente giusta».
Dunque niente meritocrazia, niente efficienza in tribunale?
«L'attuale normativa prevede che dopo 27 anni dall'aver preso servizio, tutti i magistrati raggiungano la massima qualifica di carriera possibile. Tanto che nel 2009 il 24,5% dei circa 9.000 magistrati ordinari in servizio era appunto all'apice dell'inquadramento. E dello stipendio. E come se un quarto dei giornalisti italiani fosse direttore del Corriere della Sera o di Repubblica».
E come si spiega?
«Non si spiega. Io stesso quando ho studiato i meccanismi sulle prime non ci credevo. Eppure e così. Fanno carriera automaticamente, solo sulla base dell'anzianità di servizio. E di esami che di fatto sono una barzelletta. I verbali del Consiglio superiore della magistratura dimostrano che dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2012 sono state fatte, dopo l'ultima riforma delle procedure, che avrebbe dovuto renderle più severe, 2.409 valutazioni, e ce ne sono state soltanto 3 negative, una delle quali riferita a un giudice già in pensione!».
Tutto questo indipendentemente dagli incarichi?
«Dagli incarichi e dalle sedi. E questa carriera automatica si riflette, ovviamente, sulla spesa per le retribuzioni. I magistrati italiani guadagnano più di tutti i loro colleghi dell'Europa continentale, e al vertice della professione percepiscono uno stipendio parti a 7,3 volte lo stipendio medio dei lavoratori dipendenti italiani».
Quasi sempre i magistrati addebitano ritardi e inefficienze al basso budget statale per la giustizia.
«Macché, il rapporto Cepej dimostra che la macchina giudiziaria costa agli italiani, per tribunali, avvocati d'ufficio e pubblici ministeri, 73 euro per abitante all'anno (dato 2010, ndr) contro una media europea di 57,4. Quindi molto di più».
Ma almeno rischiano sanzioni disciplinari?
«Assolutamente no, di fatto. Il magistrato è soggetto solo alla disciplina domestica, ma sarebbe meglio dire addomesticata, del Csm. E cane non mangia cane. Alcuni dati nuovi ed esclusivi lo dimostrano».
Quali dati?
«Qualunque esposto venga rivolto contro un magistrato, passa al filtro preventivo della Procura generale presso la Corte di Cassazione, che stabilisce se c'è il presupposto per avviare un procedimento. Ebbene, tra il 2009 e il 2011 - un dato che fa impressione - sugli 8.909 magistrati ordinari in servizio, sono pervenute a questa Procura 5.921 notizie di illecito: il PG ha archiviato 5.498 denunce, cioè il 92,9%; quindi solo 7,1% è arrivato davanti alla sezione disciplinare del Csm».
Ma poi ci saranno state delle sanzioni, o no?
«Negli ultimi 5 anni, tra il 2007 e il 2011, questa sezione ha definito 680 procedimenti, in seguito ai quali i magistrati destituiti sono stati... nessuno. In dieci anni, tra il 2001 e il 2011, i magistrati ordinari destituiti dal Csm sono stati 4, pari allo 0,28 di quelli finiti davanti alla sezione disciplinare e allo 0,044 di quelli in servizio».
Ma c'è anche una legge sulla responsabilità civile, che permette a chi subisca un errore giudiziario di essere risarcito!
«In teoria sì, è la legge 117 dell'88, scritta dal ministro Vassalli per risponde al referendum che aveva abrogato le norme che limitavano la responsabilità dei magistrati».
E com'è andata, questa legge?
«Nell'arco 23 anni, sono state proposte in Italia 400 cause di richiesta di risarcimento danni per responsabilità dei giudici. Di queste, 253 pari al 63% sono state dichiarate inammissibili con provvedimento definitivo. Ben 49, cioè 12% sono in attesa di pronuncia sull'ammissibilità, 70, pari al 17%, sono in fase di impugnazione di decisione di inammissibilità, 34, ovvero l'8,5%, sono state dichiarate ammissibili. Di queste ultime, 16 sono ancora pendenti e 18 sono state decise: lo Stato ha perso solo 4 volte. In un quarto di secolo è alla fine è stato insomma accolto appena l'1 per cento delle pochissime domande di risarcimento».
Cioè non si sa quanto lavorano e guadagnano?
«Risulta che da un magistrato ci si possono attendere 1.560 ore di lavoro all'anno, che diviso per 365 vuol dire che lavora 4,2 ore al giorno. Sugli stipendi bisogna vedere caso per caso, perché ci sono molte variabili. Quel che è certo, un consigliere Csm, sommando stipendi base, gettoni, rimborsi e indennizzi, e lavorando 3 settimane su 4 dal lunedì al giovedì, quindi 12 giorni al mese, guadagna 2.700 euro per ogni giorno di lavoro effettivo».
TRALASCIANDO L’ABILITAZIONE UNTA DAI VIZI ITALICI, A FRONTE DI TUTTO QUESTO CI RITROVIAMO CON 5 MILIONI DI ITALIANI VITTIME DI ERRORI GIUDIZIARI.
MAGISTRATI CHE SONO MANTENUTI DAI CITTADINI E CHE SPUTANO NEL PIATTO IN CUI MANGIANO.
Chi frequenta assiduamente le aule dei tribunali, da spettatore o da attore, sa benissimo che sono luogo di spergiuro e di diffamazioni continue da parte dei magistrati e degli avvocati. Certo è che sono atteggiamenti impuniti perché i protagonisti non possono punire se stessi. Quante volte le requisitorie dei Pubblici Ministeri e le arringhe degli avvocati di parte civile hanno fatto carne da macello della dignità delle persone imputate, presunte innocenti in quella fase processuale e, per lo più, divenuti tali nel proseguo. I manettari ed i forcaioli saranno convinti che questa sia un regola aurea per affermare la legalità. Poco comprensibile e giustificabile è invece la sorte destinata alle vittime, spesso trattate peggio dei delinquenti sotto processo.
Tutti hanno sentito le parole di Ilda Boccassini: "Ruby è furba di quella furbizia orientale propria della sua origine". «E' una giovane di furbizia orientale che come molti dei giovani delle ultime generazioni ha come obbiettivo entrare nel mondo spettacolo e fare soldi, il guadagno facile, il sogno italiano di una parte della gioventù che non ha come obiettivo il lavoro, la fatica, lo studio ma accedere a meccanismi che consentano di andare nel mondo dello spettacolo, nel cinema. Questo obiettivo - ha proseguito la Boccassini - ha accomunato la minore "con le ragazze che sono qui sfilate e che frequentavano la residenza di Berlusconi: extracomunitarie, prostitute, ragazze di buona famiglia anche con lauree, persone che hanno un ruolo nelle istituzioni e che pure avevano un ruolo nelle serate di Arcore come la europarlamentare Ronzulli e la europarlamentare Rossi. In queste serate - afferma il pm - si colloca anche il sogno di Kharima. Tutte, a qualsiasi prezzo, dovevano avvicinare il presidente del Consiglio con la speranza o la certezza di ottenere favori, denaro, introduzione nel mondo dello spettacolo».
Fino a prova contraria Ruby, Karima El Mahroug, è parte offesa nel processo.
La ciliegina sulla torta, alla requisitoria, è quella delle 14.10 circa del 31 maggio 2013, quando Antonio Sangermano era sul punto d'incorrere su una clamorosa gaffe che avrebbe fatto impallidire quella della Boccassini su Ruby: "Non si può considerare la Tumini un cavallo di ....", ha detto di Melania Tumini, la principale teste dell'accusa, correggendosi un attimo prima di pronunciare la fatidica parola.
Ancora come esempio riferito ad un caso mediatico è quello riconducibile alla morte di Stefano Cucchi.
“Vi annuncio che da oggi pomeriggio (8 aprile 2013) provvederò a inserire sulla mia pagina ufficiale di Facebook quanto ci hanno riservato i pm ed avvocati e le loro poco edificanti opinioni sul nostro conto. Buon ascolto”, ha scritto sulla pagina del social network Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. E il primo audio è dedicato proprio a quei pm con i quali la famiglia Cucchi si è trovata dall’inizio in disaccordo. «Lungi dall’essere una persona sana e sportiva, Stefano Cucchi era un tossicodipendente da 20 anni,…….oltre che essere maleducato, scorbutico, arrogante, cafone». Stavolta a parlare non è il senatore del Pdl Carlo Giovanardi – anticipa Ilaria al Fatto –, ma il pubblico ministero Francesca Loy, durante la requisitoria finale. Secondo lei mio fratello aveva cominciato a drogarsi a 11 anni…”, commenta ancora sarcastica la sorella del ragazzo morto. Requisitoria che, a suo dire, sembra in contraddizione con quella dell’altro pm, Vincenzo Barba, il quale “ammette – a differenza della collega – che Stefano potrebbe essere stato pestato. Eppure neanche lui lascia fuori dalla porta l’ombra della droga e, anzi, pare voglia lasciare intendere che i miei genitori ne avrebbero nascosto la presenza ai carabinieri durante la perquisizione, la notte dell’arresto”.
A tal riguardo è uscito un articolo su “L’Espresso”. A firma di Ermanno Forte. “Ora processano Mastrogiovanni”. Requisitoria da anni '50 nel dibattimento sull'omicidio del maestro: il pm difende gli imputati e se la prende con le 'bizzarrie' della vittima. Non c'è stato sequestro di persona perché la contenzione è un atto medico e quindi chi ha lasciato un uomo legato mani e piedi a un letto, per oltre 82 ore, ha semplicemente agito nell'esercizio di un diritto medico. Al massimo ha ecceduto nella sua condotta, ma questo non basta a considerare sussistente il reato di sequestro. E' questa la considerazione centrale della requisitoria formulata da Renato Martuscelli al processo che vede imputati medici e infermieri del reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, per la morte di Francesco Mastrogiovanni. Il pm ha dunque in gran parte sconfessato l'impianto accusatorio imbastito nella fase delle indagini e di richiesta di rinvio a giudizio da Francesco Rotondo, il magistrato che sin dall'inizio ha lavorato sul caso, disponendo l'immediato sequestro del video registrato dalle telecamere di sorveglianza del reparto psichiatrico, e che poi è stato trasferito. Nella prima parte della requisitoria - durata un paio d'ore, davanti al presidente del tribunale Elisabetta Garzo –Martuscelli si è soffermato a lungo sui verbali di carabinieri e vigili urbani relativi alle ore precedenti al ricovero (quelli dove si descrivono le reazioni di Mastrogiovanni alla cattura avvenuta sulla spiaggia di San Mauro Cilento e le presunte infrazioni al codice della strada commesse dal maestro), oltre a ripercorrere la storia sanitaria di Mastrogiovanni, già sottoposto in passato a due Tso, nel 2002 e nel 2005. "Una buona metà dell'intervento del pm è stata dedicata a spiegare al tribunale quanto fosse cattivo e strano Franco Mastrogiovanni" commenta Michele Capano, rappresentante legale del Movimento per la Giustizia Robin Hood, associazione che si è costituita parte civile al processo "sembrava quasi che l'obiettivo di questa requisitoria fosse lo stesso maestro cilentano, e non i medici di quel reparto".
Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché saranno giustiziati.
“Il carcere uno stupro. Ora voglio la verità”, dice Massimo Cellino, presidente del Cagliari calcio, ad Ivan Zazzaroni. «Voglio conoscere la vera ragione di tutto questo, i miei legali l’hanno definito “uno stupro”. Cassazione e Tar hanno stabilito che non ci sono stati abusi, dandomi ragione piena. - Ricorda: riordina. - La forestale s’è presentata a casa mia alle sette del mattino. Ho le piante secche?, ho chiesto. E loro: deve venire con noi. Forza, tirate fuori le telecamere, dove sono le telecamere? Siete di Scherzi a parte. L’inizio di un incubo dal quale non esco. Sto male, non sono più lo stesso. A Buoncammino mi hanno messo in una cella minuscola, giusto lo spazio per un letto, il vetro della finestra era rotto, la notte faceva freddo. Un detenuto mi ha regalato una giacca, un altro i pantaloni della tuta, alla fine ero coperto a strati con in testa una papalina. Mi hanno salvato il carattere e gli altri detenuti. Un ragazzo che sconta otto anni e mezzo perché non ha voluto fare il nome dello spacciatore che gli aveva consegnato la roba. Otto anni e mezzo, capisci? “Se parlo non posso più tornare a casa, ho paura per i miei genitori”, ripeteva. E poi un indiano che mi assisteva in tutto, credo l’abbiano trasferito come altri a Macomer. Mi sento in colpa per loro, solo per loro. Ringrazio le guardie carcerarie, si sono dimostrate sensibili… Mi ha tradito la Sardegna delle istituzioni. Ma adesso voglio il perché, la verità. Non si può finire in carcere per arroganza». Una situazione di straordinario strazio per un uomo fin troppo diretto ma di un’intelligenza e una prontezza rare quale è il presidente del Cagliari. «Non odio nessuno (lo ripete più volte). Ma ho provato vergogna. Non ho fatto un cazzo di niente. Dopo la revoca dei domiciliari per un paio di giorni non ho avuto la forza di tornare a casa. Sono rimasto ad Assemini con gli avvocati, Altieri e Cocco – Cocco per me è un fratello. E le intercettazioni? Pubblicatele, nulla, non c’è nulla. Mi hanno accusato di aver trattato con gente che non ho mai incontrato, né sentito; addirittura mi è stato chiesto cosa fossero le emme-emme di cui parlavo durante una telefonata: solo un sardo può sapere cosa significhi emme-emme, una pesante volgarità (sa minchia su molente, il pene dell’asino). Da giorni mi raccontano di assessori che si dimettono, di magistrati che chiedono il trasferimento. Mi domando cosa sia diventata Cagliari, e dove sia finita l’informazione che non ha paura di scrivere o dire come stanno realmente le cose. Cosa penso oggi dei magistrati? Io sono dalla parte dei pm, lo sono sempre stato!»
VEDETE, E’ TUTTO INUTILE. NON C’E’ NIENTE DA FARE. SE QUANTO PROVATO SULLA PROPRIA PELLE E SE QUANTO DETTO HA UN RISCONTRO E TUTTO CIO' NON BASTA A RIBELLARSI O ALMENO A RICREDERSI SULL'OPERATO DELLA MAGISTRATURA, ALLORA MAI NULLA CAMBIERA' IN QUESTA ITALIA CON QUESTI ITALIANI.
D'altronde di italiani si tratta: dicono una cosa ed un’altra ne fanno. Per esempio, rimanendo in ambito sportivo in tema di legalità, è da rimarcare come la parola di un altoatesino vale di più di quella di un napoletano. Almeno secondo Alex Schwazer, atleta nato in quel di Vipiteno il 26 dicembre 1984, trovato positivo al test antidoping prima delle Olimpiadi di Londra 2012. Era il 28 giugno 2012. Due giorni dopo, un test a sorpresa della Wada, l'agenzia mondiale antidoping, avrebbe rivelato la sua positività all'assunzione dell'Epo. «Posso giurare che non ho fatto niente di proibito – scriveva Schwazer, il 28 giugno 2012, al medico della Fidal Pierluigi Fiorella – ti ho dato la mia parola e non ti deluderò. Sono altoatesino, non sono napoletano». Due giorni dopo, il 30 giugno, l'atleta viene trovato positivo all'Epo. Ma l'insieme della contraddizioni (a voler essere gentili) non finisce qui. Nella sua confessione pubblica dell'8 agosto 2012, Schwazer ammise di aver assunto Epo a causa di un cedimento psicologico. Era un brutto periodo, e qualcosa bisognava pur fare. Ma le indagini dei Ros di Trento e dei Nas di Firenze contraddicono la versione dell'assunzione momentanea. I carabinieri, addirittura, parlano di “profilo ematologico personale”, un'assunzione continua e costante di sostanze dopanti per la quale non è escluso che Schwazer facesse utilizzo di Epo anche durante i giochi di Pechino 2008. Competizione, lo ricordiamo, dove l'atleta di Vipiteno, vinse l'oro alla marcia di 50 chilometri. Infatti, questo si evince anche nel decreto di perquisizione della Procura di Bolzano. “La polizia giudiziaria giunge pertanto a ritenere che non possa escludersi che Schwazer Alex, già durante la preparazione per i Giochi Olimpici di Pechino 2008 (e forse ancor prima), sia stato sottoposto a trattamenti farmacologici o a manipolazioni fisiologiche capaci di innalzare considerevolmente i suoi valori ematici.” Insomma: Schwazer non solo offende i napoletani e di riporto tutti i meridionali, incluso me, ma poi, come un fesso, si fa cogliere pure con le mani nel sacco. E dire che, oltretutto, è la parola di un carabiniere, qual è Alex Schwazer.
L'Italia è un Paese fondato sulla fregatura: ecco tutti i modi in cui gli italiani raggirano gli altri (e sé stessi). In un libro, "Io ti fotto" di Carlo Tecce e Marco Morello, la pratica dell'arte della fregatura in Italia. Dai più alti livelli ai più infimi, dalle truffe moderne realizzate in Rete a quelle più antiche e consolidate. In Italia, fottere l'altro - una parola più tenue non renderebbe l'idea - è un vizio che è quasi un vanto, "lo ti fotto" è una legge: di più, un comandamento.
E fottuti siamo stati dagli albori della Repubblica. L'armistizio di Cassabile in Sicilia o armistizio corto, siglato segretamente il 3 settembre 1943, è l'atto con il quale il Regno d’Italia cessò le ostilità contro le forze anglo-americane (alleati) nell'ambito della seconda guerra mondiale. In realtà non si trattava affatto di un armistizio ma di una vera e propria resa senza condizioni da parte dell'Italia. Poiché tale atto stabiliva la sua entrata in vigore dal momento del suo annuncio pubblico, esso è comunemente detto dell'" 8 settembre", data in cui, alle 18.30, fu pubblicamente reso noto prima dai microfoni di Radio Algeri da parte del generale Dwight D. Eisenhower e, poco più di un'ora dopo, alle 19.42, confermato dal proclama del maresciallo Pietro Badoglio trasmesso dai microfoni dell' Eiar. In quei frangenti vi fu grande confusione e i gerarchi erano in fuga. L’esercito allo sbando. Metà Italia combatteva contro gli Alleati, l’altra metà a favore.
La grande ipocrisia vien da lontano. “I Vinti non dimenticano” (Rizzoli 2010), è il titolo del volume di Giampaolo Pansa. Ci si fa largo tra i morti, ogni pagina è una fossa e ci sono perfino preti che negano la benedizione ai condannati. E poi ci sono le donne, tante, tutte ridotte a carne su cui sbattere il macabro pedaggio dell’odio. È un viaggio nella memoria negata, quella della guerra civile, altrimenti celebrata nella retorica della Resistenza.. Le storie inedite di sangue e violenza che completano e concludono "Il sangue dei vinti", uscito nel 2003. Si tenga conto che da queste realtà politiche uscite vincenti dalla guerra civile è nata l'alleanza catto-comunista, che ha dato vita alla Costituzione Italiana e quantunque essa sia l'architrave delle nostre leggi, ad oggi le norme più importanti, che regolano la vita degli italiani (codice civile, codice penale, istituzione e funzionamento degli Ordini professionali, ecc.), sono ancora quelle fasciste: alla faccia dell'ipocrisia comunista, a cui quelle leggi non dispiacciono.
Esecuzioni, torture, stupri. Le crudeltà dei partigiani. La Resistenza mirava alla dittatura comunista. Le atrocità in nome di Stalin non sono diverse dalle efferatezze fasciste. Anche se qualcuno ancora lo nega scrive Giampaolo Pansa. (scrittore notoriamente comunista osteggiato dai suoi compagni di partito per essere ai loro occhi delatore di verità scomode). C’è da scommettere che il libro di Giampaolo Pansa, "La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti" (Rizzoli, pagg. 446), farà infuriare le vestali della Resistenza. Mai in maniera così netta come nell’introduzione al volume (di cui per gentile concessione “Il Giornale” pubblica un estratto) i crimini partigiani sono equiparati a quelli dei fascisti. Giampaolo Pansa imbastisce un romanzo che, sull’esempio delle sue opere più note, racconta la guerra civile in chiave revisionista, sottolineando le storie dei vinti e i soprusi dei presunti liberatori, i partigiani comunisti in realtà desiderosi di sostituire una dittatura con un’altra, la loro.
Altra storica menzogna è stata sbugiardata da "Mai più terroni. La fine della questione meridionale" di Pino Aprile. Come abbattere i pregiudizi che rendono il meridione diverso? Come mettere fine a una questione costruita ad arte sulla pelle di una parte d'Italia? La risposta sta anche negli strumenti di comunicazione odierni, capaci di abbattere i confini, veri o fittizi, rompere l'isolamento, superare le carenze infrastrutturali. E se per non essere più "meridionali" bastasse un clic? Con la sua solita vis polemica, Pino Aprile ci apre un mondo per mostrare quanto questo sia vero, potente e dilagante. "Ops... stanno finendo i terroni. Ma come, già? E così, da un momento all'altro?"
Terroni a chi? Tre libri sul pregiudizio antimeridionale. Come è nata e come si è sviluppata la diffidenza verso il Sud. Tre libri ne ricostruiscono le origini e provano a ipotizzarne gli scenari.
"Negli ormai centocinquant'anni di unità italiana il Mezzogiorno non ha mai mancato di creare problemi". D'accordo, la frase è netta e controversa. Sulla questione meridionale, nell'ultimo secolo e mezzo, si sono sprecati fiumi di inchiostro, tonnellate di pagine, migliaia di convegni. In gran parte dedicati all'indagine sociologica, al pregiudizio politico o alla rivendicazione identitaria. Ciò che colpisce allora di "La palla al piede" di Antonino De Francesco (Feltrinelli) è lo sguardo realistico e l'approccio empirico. De Francesco è ordinario di Storia moderna all'Università degli studi di Milano, ma definire il suo ultimo lavoro essenzialmente storico è quantomeno limitativo. In poco meno di duecento pagine, l'autore traccia l'identikit di un pregiudizio, quello antimeridionale appunto, nei suoi aspetti sociali, storici e politici. Lo fa rincorrendo a una considerevole pubblicistica per niente autoreferenziale, che non si ostina nel solito recinto storiografico. Il risultato si avvicina a una controstoria dell'identità italiana e, al tempo stesso, a un'anamnesi dei vizi e dei tic dell'Italia Unita. Ma per raccontare una storia ci si può ovviamente mettere sulle tracce di una tradizione e cercare, attraverso le sue strette maglie, di ricostruire una vicenda che ha il respiro più profondo di una semplice schermaglia localistica. E' quello che accade nel "Libro napoletano dei morti" di Francesco Palmieri (Mondadori). Racconta la Napoli eclettica e umbratile che dall’Unità d'Italia arriva fino alla Prima guerra mondiale. Per narrarla, si fa scudo della voce del poeta napoletano Ferdinando Russo ricostruendo con una certa perizia filologica e una sottile verve narrativa le luci e le smagliature di un'epopea in grado di condizionare la realtà dei giorni nostri. Ha il respiro del pamphlet provocatorio e spiazzante invece l'ultimo libro di Pino Aprile, "Mai più terroni" (Piemme), terzo volume di una trilogia di successo (Terroni e Giù al Sud i titoli degli altri due volumi). Aprile si domanda se oggi abbia ancora senso dividere la realtà sulla base di un fantomatico pregiudizio etnico e geografico che ha la pretesa di tagliare Nord e Sud. E si risponde che no, che in tempi di iperconnessioni reali (e virtuali), quelli stereotipo è irrimediabilmente finito. "Il Sud - scrive - è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se riferito a un altro che lo sovrasta". Nelle nuove realtà virtuali, vecchie direzioni e punti cardinali non esistono più, relegati come sono a un armamentario che sa di vecchio e obsoleto.
D'altronde siamo abituati alle stronzate dette da chi in mala fede parla e le dice a chi, per ignoranza, non può contro ribattere. Cominciamo a dire: da quale pulpito viene la predica. Vediamo in Inghilterra cosa succede. I sudditi inglesi snobbano gli italiani. Ci chiamano mafiosi, ma perché a loro celano la verità. Noi apprendiamo la notizia dal tg2 delle 13.00 del 2 gennaio 2012. Il loro lavoro è dar la caccia ai criminali, ma alcuni ladri non sembrano temerle: le forze di polizia del Regno sono state oggetto di furti per centinaia di migliaia di sterline, addirittura con volanti, manette, cani ed uniformi tutte sparite sotto il naso degli agenti. Dalla lista, emersa in seguito ad una richiesta secondo la legge sulla libertà d'informazione, emerge che la forza di polizia più colpita è stata quella di Manchester, dove il valore totale degli oggetti rubati arriva a quasi 87.000 sterline. Qui i ladri sono riusciti a fuggire con una volante da 10.000 sterline e con una vettura privata da 30.000.
E poi. Cosa sarebbe oggi la Germania se avesse sempre onorato con puntualità il proprio debito pubblico? Si chiede su “Il Giornale” Antonio Salvi, Preside della Facoltà di Economia dell’Università Lum "Jean Monnet". Forse non a tutti è noto, ma il Paese della cancelliera Merkel è stato protagonista di uno dei più grandi, secondo alcuni il più grande, default del secolo scorso, nonostante non passi mese senza che Berlino stigmatizzi il comportamento vizioso di alcuni Stati in materia di conti pubblici. E invece, anche la Germania, la grande e potente Germania, ha qualche peccatuccio che preferisce tenere nascosto. Anche se numerosi sono gli studi che ne danno conto, di seguito brevemente tratteggiati. Riapriamo i libri di storia e cerchiamo di capire la successione dei fatti. La Germania è stata protagonista «sfortunata» di due guerre mondiali nella prima metà dello scorso secolo, entrambe perse in malo modo. Come spesso accade in questi casi, i vincitori hanno presentato il conto alle nazioni sconfitte, in primis alla Germania stessa. Un conto salato, soprattutto quello successivo alla Prima guerra mondiale, talmente tanto salato che John Maynard Keynes, nel suo Conseguenze economiche della pace, fu uno dei principali oppositori a tale decisione, sostenendo che la sua applicazione avrebbe minato in via permanente la capacità della Germania di avviare un percorso di rinascita post-bellica. Così effettivamente accadde, poiché la Germania entrò in un periodo di profonda depressione alla fine degli anni '20 (in un più ampio contesto di recessione mondiale post '29), il cui esito minò la capacità del Paese di far fronte ai propri impegni debitori internazionali. Secondo Scott Nelson, del William and Mary College, la Germania negli anni '20 giunse a essere considerata come «sinonimo di default». Arrivò così il 1932, anno del grande default tedesco. L'ammontare del debito di guerra, secondo gli studiosi, equivalente nella sua parte «realistica» al 100% del Pil tedesco del 1913 (!), una percentuale ragguardevole. Poi arrivò al potere Hitler e l'esposizione debitoria non trovò adeguata volontà di onorare puntualmente il debito (per usare un eufemismo). I marchi risparmiati furono destinati ad avviare la rinascita economica e il programma di riarmo. Si sa poi come è andata: scoppio della Seconda guerra mondiale e seconda sconfitta dei tedeschi. A questo punto i debiti pre-esistenti si cumularono ai nuovi e l'esposizione complessiva aumentò. Il 1953 rappresenta il secondo default tedesco. In quell'anno, infatti, gli Stati Uniti e gli altri creditori siglarono un accordo di ridefinizione complessiva del debito tedesco, procedendo a «rinunce volontarie» di parte dei propri crediti, accordo che consentì alla Germania di poter ripartire economicamente (avviando il proprio miracolo economico, o «wirtschaftswunder»). Il lettore non sia indotto in inganno: secondo le agenzie di rating, anche le rinegoziazioni volontaristiche configurano una situazione di default, non solo il mancato rimborso del capitale e degli interessi (la Grecia nel 2012 e l'Argentina nel 2001 insegnano in tal senso). Il risultato ottenuto dai tedeschi dalla negoziazione fu davvero notevole:
1) l'esposizione debitoria fu ridotta considerevolmente: secondo alcuni calcoli, la riduzione concessa alla Germania fu nell'ordine del 50% del debito complessivo!
2) la durata del debito fu estesa sensibilmente (peraltro in notevole parte anche su debiti che erano stati non onorati e dunque giunti a maturazione già da tempo). Il rimborso del debito fu «spalmato» su un orizzonte temporale di 30 anni;
3) le somme corrisposte annualmente ai creditori furono legate al fatto che la Germania disponesse concretamente delle risorse economiche necessarie per effettuare tali trasferimenti internazionali.
Sempre secondo gli accordi del '53, il pagamento di una parte degli interessi arretrati fu subordinata alla condizione che la Germania si riunificasse, cosa che, come noto, avvenne nell'ottobre del 1990. Non solo: al verificarsi di tale condizione l'accordo del 1953 si sarebbe dovuto rinegoziare, quantomeno in parte. Un terzo default, di fatto. Secondo Albrecht Frischl, uno storico dell'economia tedesco, in una intervista concessa a Spiegel, l'allora cancelliere Kohl si oppose alla rinegoziazione dell'accordo. A eccezione delle compensazioni per il lavoro forzato e il pagamento degli interessi arretrati, nessun'altra riparazione è avvenuta da parte della Germania dopo il 1990. Una maggiore sobrietà da parte dei tedeschi nel commentare i problemi altrui sarebbe quanto meno consigliabile. Ancora Fritschl, precisa meglio il concetto: «Nel Ventesimo secolo, la Germania ha dato avvio a due guerre mondiali, la seconda delle quali fu una guerra di annientamento e sterminio, eppure i suoi nemici annullarono o ridussero pesantemente le legittime pretese di danni di guerra. Nessuno in Grecia ha dimenticato che la Germania deve la propria prosperità alla generosità delle altre nazioni (tra cui la Grecia, ndr)». È forse il caso di ricordare inoltre che fu proprio il legame debito-austerità-crisi che fornì linfa vitale ad Adolf Hitler e alla sua ascesa al potere, non molto tempo dopo il primo default tedesco. Tre default, secondo una contabilità allargata. Non male per un Paese che con una discreta periodicità continua a emettere giudizi moralistici sul comportamento degli altri governi. Il complesso da primo della classe ottunde la memoria e induce a mettere in soffitta i propri periodi di difficoltà. «Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio». Era un tempo la «bocca di rosa» di De André, è oggi, fra gli altri, la bocca del Commissario europeo Ottinger (e qualche tempo fa del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schauble). A suo avviso, Bruxelles «non si è ancora resa abbastanza conto di quanto sia brutta la situazione» e l'Europa invece di lottare contro la crisi economica e del debito, celebra «il buonismo» e si comporta nei confronti del resto del mondo come una maestrina, quasi un «istituto di rieducazione». Accidenti, da quale pulpito viene la predica.
Non solo. Un altro luogo comune viene sfatato ed abbattuto. La Germania di Angela Merkel è il paese che ha l'economia sommersa più grande d'Europa in termini assoluti. L'economia in nero teutonica vale 350 miliardi di euro. Sono circa otto milioni i cittadini tedeschi che vivono lavorando in nero. Secondo gli esperti il dato è figlio dell'ostilità dei tedeschi ai metodi di pagamento elettronici. I crucchi preferiscono i contanti. La grandezza dell'economia in nero della Germania è stata stimata e calcolata dal colosso delle carte di credito e dei circuiti di pagamento Visa in collaborazione con l'università di Linz. In relazione al Pil tedesco il nero sarebbe al 13 per cento, pari a un sesto della ricchezza nazionale. Quindi in termini relativi il peso del sommerso è minore, ma per volume e in termini assoluti resta la più grande d'Europa. Chi lavora in nero in Germania di solito opera nel commercio e soprattutto nell'edilizia, poi c'è il commercio al dettaglio e infine la gastronomia. Il livello del nero in Germania comunque si è stabilizzato. Il picco è arrivato dieci anni fa. Nel 2003 la Germania ha attraversato la peggiore stagnazione economica degli ultimi vent'anni e all'epoca il nero valeva 370 miliardi. Ora con l'economia in ripresa che fa da locomotiva per l'Europa, il nero è fermo al 13 per cento del Pil.
Tornando alla repubblica delle manette ci si chiede. Come può, chi indossa una toga, sentirsi un padreterno, specie se, come è noto a tutti, quella toga non rispecchia alcun meritocrazia? D’altronde di magistrati ve ne sono più di 10 mila a regime, cosi come gli avvocati sono intorno ai 150 mila in servizio effettivo.
Eppure nella mia vita non ho mai trovato sulla mia strada una toga degna di rispetto, mentre invece, per loro il rispetto si pretende. A me basta ed avanza essere Antonio Giangrande, senza eguali per quello che scrive e dice. Pavido nell’affrontare una ciurma togata pronta a fargli la pelle, mal riuscendoci questi, però, a tacitarlo sulle verità a loro scomode.
Si chiedeva Sant’Agostino (354-430): «Eliminata la giustizia, che cosa sono i regni se non bande di briganti? E cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?». Secondo il Vescovo di Ippona è la giustizia il principale, per non dire l’unico, argine contro la voracità dei potenti.
Da quando è nato l’uomo, la libertà e la giustizia sono gli unici due strumenti a disposizione della gente comune per contrastare la condizione di sudditanza in cui tendono a relegarla i detentori del potere. Anche un bambino comprende che il potere assoluto equivale a corruzione assoluta.
Certo. Oggi nessuno parlerebbe o straparlerebbe di assolutismo. I tempi del Re Sole sembrano più lontani di Marte. Ma, a differenza della scienza e delle tecnologie, l’arte del governo è l’unica disciplina in cui non si riscontrano progressi. Per dirla con lo storico Tacito (55-117 d. C.), la sete di potere è la più scandalosa delle passioni. E come si manifesta questa passione scandalosa? Con l’inflazione di spazi, compiti e competenze delle classi dirigenti. Detto in termini aggiornati: elevando il tasso di statalismo presente nella nostra società.
Friedrich Engels (1820-1895) tutto era tranne che un liberale, ma, da primo marxista della Storia, scrisse che quando la società viene assorbita dallo Stato, che a suo giudizio è l’insieme della classe dirigente, il suo destino è segnato: trasformarsi in «una macchina per tenere a freno la classe oppressa e sfruttata». Engels ragionava in termini di classe, ma nelle sue parole riecheggiava una palese insofferenza verso il protagonismo dello Stato, che lui identificava con il ceto dirigente borghese, che massacrava la società. Una società libera e giusta è meno corrotta di una società in cui lo Stato comanda in ogni pertugio del suo territorio. Sembra quasi un’ovvietà, visto che la scienza politica lo predica da tempo: lo Stato, per dirla con Sant’Agostino, tende a prevaricare come una banda di briganti. Bisogna placarne gli appetiti.
E così i giacobini e i giustizialisti indicano nel primato delle procure la vera terapia contro il malaffare tra politica ed economia, mentre gli antigiustizialisti accusano i magistrati di straripare con le loro indagini e i loro insabbiamenti fino al punto di trasformarsi essi stessi in elementi corruttivi, dato che spesso le toghe, secondo i critici, agirebbero per fini politici, se non, addirittura, fini devianti, fini massonici e fini mafiosi.
Insomma. Uno Stato efficiente e trasparente si fonda su buone istituzioni, non su buone intenzioni. Se le Istituzioni non cambiano si potranno varare le riforme più ambiziose, dalla giustizia al sistema elettorale; si potranno pure mandare in carcere o a casa tangentisti e chiacchierati, ma il risultato (in termini di maggiore onestà del sistema) sarà pari a zero. Altri corrotti si faranno avanti. La controprova? Gli Stati meno inquinati non sono quelli in cui l’ordinamento giudiziario è organizzato in un modo piuttosto che in un altro, ma quelli in cui le leggi sono poche e chiare, e i cui governanti non entrano pesantemente nelle decisioni e nelle attività che spettano a privati e società civile.
Oggi ci si scontra con una dura realtà. La magistratura di Milano? Un potere separatista. Procure e tribunali in Italia fanno quello che vogliono: basta una toga e arrivederci, scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”. L’equivoco prosegue da una vita: un sacco di gente pensa che esista una sinergia collaudatissima tra i comportamenti della politica e le decisioni della giustizia, come se da qualche parte ci fosse una camera di compensazione in cui tutti i poteri (politici, giudiziari, burocratici, finanziari) contrattassero l’uno con l’altro e rendessero tutto interdipendente. Molti ragionano ancora come Giorgio Straquadanio sul Fatto: «Questo clima pacifico porta a Berlusconi una marea di benefici, l’aggressione giudiziaria è destinata a finire... c’è da aspettarsi che le randellate travestite da sentenze, così come gli avvisi di garanzie e le inchieste, cessino». Ora: a parte che solo una nazione profondamente arretrata potrebbe funzionare così, questa è la stessa mentalità che ha contribuito al crollo della Prima Repubblica, protesa com’era a trovare il volante «politico» di inchieste che viceversa avevano smesso di averne uno. In troppi, in Italia, non hanno ancora capito che non esiste più niente del genere, se non, in misura fisiologica e moderata, a livello di Quirinale-Consulta-Csm. Ma per il resto procure e tribunali fanno quello che vogliono: basta un singolo magistrato e arrivederci. L’emblema ne resta Milano, dove la separatezza tra giudici e procuratori non ci si preoccupa nemmeno di fingerla: la magistratura, più che separato, è ormai un potere separatista.
Prodigio delle toghe: per lo stesso reato salvano il Pd e non il Pdl. A Bergamo "non luogo a procedere" per un democratico, a Milano invece continua il processo contro Podestà, scrive Matteo Pandini su “Libero Quotidiano”.
Stesso fatto (firme tarocche autenticate), stesso capo d’accusa (falso ideologico), stesso appuntamento elettorale (le Regionali lombarde), stesso anno (il 2010). Eppure a Bergamo un esponente di centrosinistra esce dal processo perché il giudice stabilisce il «non luogo a procedere», mentre a Milano altri politici di centrodestra - tra cui il presidente della Provincia Guido Podestà - restano alla sbarra. Ma andiamo con ordine. Nel febbraio 2010 fervono i preparativi in vista delle elezioni. È sfida tra Roberto Formigoni e Filippo Penati. Matteo Rossi, consigliere provinciale di Bergamo del Pd, è un pubblico ufficiale e quindi può vidimare le sottoscrizioni a sostegno delle varie liste. Ne autentica una novantina in quel di Seriate a sostegno del Partito pensionati, all’epoca alleato del centrosinistra. Peccato che tra gli autografi ne spuntino sette irregolari, tra cui due persone decedute, una nel 2009 e l’altra nel 1992. È il Comune a sollevare dubbi e il caso finisce in Procura. All’udienza preliminare l’avvocato Roberto Bruni, ex sindaco del capoluogo orobico e poi consigliere regionale della lista Ambrosoli, invoca la prescrizione. Lo fa appellandosi a una riforma legislativa e il giudice gli dà ragione. È successo che Bruni, tra i penalisti più stimati della città, ha scandagliato il testo unico delle leggi sulle elezioni. Testo che in sostanza indica in tre anni il tempo massimo per procedere ed emettere la sentenza. Parliamo di una faccenda da Azzeccagarbugli, anche perché un recente pronunciamento della Cassazione conferma sì il limite di tre anni per arrivarne a una, ma solo se la denuncia è partita dai cittadini. Mentre nel caso di Rossi tutto è scattato per un intervento del Comune di Seriate. Fatto sta che a Milano c’è un altro processo con lo stesso capo d’imputazione e che riguarda la lista Formigoni. Nessuno, finora, ha sollevato la questione della prescrizione ma in questi giorni la decisione del giudice orobico ha incuriosito non poco gli avvocati Gaetano Pecorella e Maria Battaglini, dello stesso studio dell’ex parlamentare del Pdl. Vogliono capire com’è andata la faccenda di Rossi, così da decidere eventuali strategie a difesa dei loro assistiti, tra cui spicca Podestà. Nel suo caso, le sottoscrizioni fasulle sarebbero 770, raccolte in tutta la Lombardia: nell’udienza il procuratore aggiunto Alfredo Robledo e il pm Antonio D’Alessio hanno indicato come testimoni 642 persone che, sentite dai carabinieri nel corso dell’inchiesta, avevano affermato che quelle firme a sostegno del listino di Formigoni, apposte con il loro nome, erano false. Tra i testi ammessi figura anche l’allora responsabile della raccolta firme del Pdl, Clotilde Strada, che ha già patteggiato 18 mesi. A processo, oltre a Podestà, ci sono quattro ex consiglieri provinciali del Popolo della Libertà milanese: Massimo Turci, Nicolò Mardegan, Barbara Calzavara e Marco Martino. Tutti per falso ideologico, come Rossi, e tutti per firme raccolte tra gennaio e febbraio del 2010. All’ombra della Madonnina il processo era scattato per una segnalazione dei Radicali, in qualità di semplici cittadini. Non è detto che il destino del democratico Rossi coinciderà con quello degli imputati azzurri di Milano. Strano ma vero.
Certo c’è da storcere il naso nel constatare che non di democrazia si parla (POTERE DEL POPOLO) ma di magistocrazia (POTERE DEI MAGISTRATI).
Detto questo parliamo del Legittimo Impedimento. Nel diritto processuale penale italiano, il legittimo impedimento è l'istituto che permette all'imputato, in alcuni casi, di giustificare la propria assenza in aula. In questo caso l’udienza si rinvia nel rispetto del giusto processo e del diritto di difesa. In caso di assenza ingiustificata bisogna distinguere se si tratta della prima udienza o di una successiva. Nel caso di assenza in luogo della prima udienza il giudice, effettuate le operazioni riguardanti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (di cui al 2° comma dell'art. 420), in caso di assenza non volontaria dell'imputato se ne dichiara la condizione di contumacia e il procedimento non subisce interruzioni. Se invece l'assenza riguarda una udienza successiva alla prima ed in quella l'imputato non è stato dichiarato contumace, questi è dichiarato semplicemente assente. E ancora, se nell'udienza successiva alla prima alla quale l'imputato non ha partecipato (per causa maggiore, caso fortuito o forza maggiore) questi può essere ora dichiarato contumace.
''L'indipendenza, l'imparzialità, l'equilibrio dell'amministrazione della giustizia sono più che mai indispensabili in un contesto di persistenti tensioni e difficili equilibri sia sul piano politico che istituzionale''. Lo afferma il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l’11 giugno 2013 al Quirinale ricevendo i neo giudici al Quirinale e, come se sentisse puzza nell’aria, invita al rispetto della Consulta. Tre ''tratti distintivi'' della magistratura, ha sottolineato il capo dello Stato, ricevendo al Quirinale i 343 magistrati ordinari in tirocinio, che rappresentano ''un costume da acquisire interiormente, quasi al pari di una seconda natura''. Napolitano ha chiesto poi rispetto verso la Consulta: serve "leale collaborazione, oltre che di riconoscimento verso il giudice delle leggi, ossia la Corte Costituzionale, chiamata ad arbitrare anche il conflitto tra poteri dello Stato''. E dopo aver fatto osservare che sarebbe ''inammissibile e scandaloso rimettere in discussione la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, per ciechi particolarismi anche politici'', Napolitano parlando del Consiglio superiore della magistratura ha detto che ''non è un organo di mera autodifesa, bensì un organo di autogoverno, che concorre alle riforme obiettivamente necessarie'' della giustizia.
D’altronde il Presidente della Repubblica in quanto capo dei giudici, non poteva dire altrimenti cosa diversa.
Eppure la corte Costituzionale non si è smentita.
Per quanto riguarda il Legittimo Impedimento attribuibile a Silvio Berlusconi, nelle funzioni di Presidente del Consiglio impegnato in una seduta dello stesso Consiglio dei Ministri, puntuale, atteso, aspettato, è piovuto il 19 giugno 2013 il "no" al legittimo impedimento. La Corte Costituzionale, nel caso Mediaset, si schiera contro Silvio Berlusconi. Per le toghe l'ex premier doveva partecipare all'udienza e non al CDM. È stato corretto l'operato dei giudici di Milano nel processo “Mediaset” quando, il primo marzo del 2010, non hanno concesso il legittimo impedimento a comparire in udienza all'allora premier e imputato di frode fiscale Silvio Berlusconi. A deciderlo, nel conflitto di attribuzioni sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in dissidio con i togati milanesi, è stata la Corte Costituzionale che ha ritenuto che l'assenza dall'udienza non sia stata supportata da alcuna giustificazione relativa alla convocazione di un Cdm fuori programma rispetto al calendario concordato in precedenza.
"Incredibile" - In una nota congiunta i ministri PDL del governo Letta, Angelino Alfano, Gaetano Quagliariello, Maurizio Lupi, Nunzia De Girolamo e Beatrice Lorenzin, commentano: "E' una decisione incredibile. Siamo allibiti, amareggiati e profondamente preoccupati. La decisione - aggiungono - travolge ogni principio di leale collaborazione e sancisce la subalternità della politica all'ordine giudiziario". Uniti anche tutti i deputati azzurri, che al termine della seduta della Camera, hanno fatto sapere in un comunicato, "si sono riuniti e hanno telefonato al presidente Berlusconi per esprimere la loro profonda indignazione e preoccupazione per la vergognosa decisione della Consulta che mina gravemente la leale collaborazione tra gli organi dello Stato e il corretto svolgimento dell’esercizio democratico". Al Cavaliere, si legge, "i deputati hanno confermato che non sarà certo una sentenza giudiziaria a decretare la sua espulsione dalla vita politica ed istituzionale del nostro Paese, e gli hanno manifestato tutta la loro vicinanza e il loro affetto". "Siamo infatti all’assurdo di una Corte costituzionale che non ritiene legittimo impedimento la partecipazione di un presidente del Consiglio al Consiglio dei ministri", prosegue il capogruppo del Pdl alla Camera, Renato Brunetta, "Dinanzi all’assurdo, che documenta la resa pressoché universale delle istituzioni davanti allo strapotere dell’ingiustizia in toga, la tentazione sarebbe quella di chiedere al popolo sovrano di esprimersi e di far giustizia con il voto". Occorre – dice – una riforma del sistema per limitare gli abusi e una nuova regolazione dei poteri dell’ordine giudiziario che non è un potere ma un ordine in quanto la magistratura non è eletta dal popolo. ''A mente fredda e senza alcuna emozione il giudizio sulla sentenza è più chiaro e netto che mai. Primo: la sentenza è un'offesa al buon senso, tanto varrebbe dichiarare l'inesistenza del legittimo impedimento a prescindere, qualora ci sia di mezzo Silvio Berlusconi. Secondo: la Consulta sancisce che la magistratura può agire in quanto potere assoluto come princeps legibus solutus. Terzo: la risposta di Berlusconi e del Pdl con lui è di netta separazione tra le proteste contro l'ingiustizia e leale sostegno al governo Letta. Quarto: non rinunceremo in nessun caso a far valere in ogni sede i diritti politici del popolo di centrodestra e del suo leader, a cui vanno da parte mia solidarietà e ammirazione. Quinto: credo che tutta la politica, di destra, di sinistra e di centro, dovrebbe manifestare preoccupazione per una sentenza che di fatto, contraddicendo la Costituzione, subordina la politica all'arbitrio di qualsiasi Tribunale''. E' quanto afferma Renato Brunetta, presidente dei deputati del Pdl. Gli fa eco il deputato Pdl Deborah Bergamini, secondo cui "è difficile accettare il fatto che viviamo in un Paese in cui c’è un cittadino, per puro caso leader di un grande partito moderato votato da milioni di italiani, che è considerato da una parte della magistratura sempre e per forza colpevole e in malafede. Purtroppo però è così".
Nessuna preoccupazione a sinistra. "Per quanto riguarda il Pd le sentenze si applicano e si rispettano quindi non ho motivo di ritenere che possa avere effetti su un governo che è di servizio per i cittadini e il Paese in una fase molto drammatica della vita nazionale e dei cittadini", ha detto Guglielmo Epifani, "È una sentenza che era attesa da tempo. Dà ragione a una parte e torto all’altra, non vedo un rapporto tra questa sentenza e il quadro politico".
Non si aveva nessun dubbio chi fossero gli idolatri delle toghe.
LE SENTENZE DEI GIUDICI SI APPLICANO, SI RISPETTANO, MA NON ESSENDO GIUDIZI DI DIO SI POSSONO BEN CRITICARE SE VI SONO FONDATE RAGIONI.
Piero Longo e Niccolò Ghedini, legali di Silvio Berlusconi, criticano duramente la decisione della Consulta sull'ex premier. «I precedenti della Corte Costituzionale in tema di legittimo impedimento sono inequivocabili e non avrebbero mai consentito soluzione diversa dall'accoglimento del conflitto proposto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri», assicurano. Per poi aggiungere: «Evidentemente la decisione assunta si è basata su logiche diverse che non possono che destare grave preoccupazione»."La preminenza della giurisdizione rispetto alla legittimazione di un governo a decidere tempi e modi della propria azione - continuano i due legali di Silvio Berlusconi - appare davvero al di fuori di ogni logica giuridica. Di contro la decisione, ampiamente annunciata da giorni da certa stampa politicamente orientata, non sorprende visti i precedenti della stessa Corte quando si è trattato del presidente Berlusconi e fa ben comprendere come la composizione della stessa non sia più adeguata per offrire ciò che sarebbe invece necessario per un organismo siffatto". Mentre per Franco Coppi, nuovo legale al posto di Longo, si tratta di «una decisione molto discutibile che crea un precedente pericoloso perché stabilisce che il giudice può decidere quando un Consiglio dei ministri è, o meno, indifferibile. Le mie idee sul legittimo impedimento non coincidono con quelle della Corte Costituzionale ma, purtroppo, questa decisione la dobbiamo tenere così come è perché è irrevocabile».
Ribatte l'Associazione Nazionale Magistrati: «È inaccettabile attribuire alla Consulta logiche politiche»; un'accusa che «va assolutamente rifiutata». A breve distanza dalla notizia che la Consulta ha negato il legittimo impedimento a Silvio Berlusconi nell'ambito del processo Mediaset, arriva anche la reazione di Rodolfo Sabelli, presidente dell'associazione nazionale magistrati, che ribadisce alle voci critiche che si sono sollevate dal Pdl la versione delle toghe."Non si può accettare, a prescindere dalla decisione presa - dice Sabelli - l’attribuzione alla Corte Costituzionale di posizioni o logiche di natura politica". Ribadendo l'imparzialità della Corte Costituzionale "a prescindere dal merito della sentenza", chiede "una posizione di rispetto" per la Consulta e una discussione che - se si sviluppa - sia però fatta "in modo informato, conoscendo le motivazioni della sentenza, e con rigore tecnico".
La Corte costituzionale ha detto no. Respinto il ricorso di Silvio Berlusconi per il legittimo impedimento (giudicato non assoluto, in questo caso) che non ha consentito all’allora premier di partecipare all’udienza del 10 marzo 2010 del processo Mediaset, per un concomitante consiglio dei ministri. Nel dare ragione ai giudici di Milano che avevano detto no alla richiesta di legittimo impedimento di Berlusconi, la Corte Costituzionale ha osservato che «dopo che per più volte il Tribunale (di Milano), aveva rideterminato il calendario delle udienze a seguito di richieste di rinvio per legittimo impedimento, la riunione del Consiglio dei ministri, già prevista in una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, è stata fissata dall'imputato Presidente del Consiglio in altra data coincidente con un giorno di udienza, senza fornire alcuna indicazione (diversamente da quanto fatto nello stesso processo in casi precedenti), nè circa la necessaria concomitanza e la non rinviabilità» dell'impegno, né circa una data alternativa per definire un nuovo calendario. "La riunione del Cdm - spiega la Consulta - non è un impedimento assoluto". Si legge nella sentenza: "Spettava all'autorità giudiziaria stabilire che non costituisce impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale del 1 marzo 2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri" Silvio Berlusconi "di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno", che invece "egli aveva in precedenza indicato come utile per la sua partecipazione all'udienza".
Ma è veramente imparziale la Corte costituzionale?
Tutta la verità sui giornali dopo la bocciatura del “Lodo Alfano”, sulla sospensione dei procedimenti penali per le più alte cariche dello Stato, avvenuta da parte della Corte Costituzionale il 7 ottobre 2009. La decisione della Consulta è arrivata con nove voti a favore e sei contrari. Quanto al Lodo Alfano, si sottolinea che il mutamento di indirizzo della Corte "oltre che una scelta politica si configura anche come violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi costituzionali che ha avuto la conseguenza di sviare l'azione legislativa del Parlamento". Berlusconi dice: "C'è un presidente della Repubblica di sinistra, Giorgio Napolitano, e c'è una Corte costituzionale con undici giudici di sinistra, che non è certamente un organo di garanzia, ma è un organo politico. Il presidente è stato eletto da una maggioranza di sinistra, ed ha le radici totali della sua storia nella sinistra. Credo che anche l'ultimo atto di nomina di un magistrato della Corte dimostri da che parte sta". La Corte ha 15 membri, con mandato di durata 9 anni: 5 nominati dal Presidente della Repubblica, Ciampi e Napolitano (di area centro-sinistra); 5 nominati dal Parlamento (maggioranza centro-sinistra); 5 nominati dagli alti organi della magistratura (che tra le sue correnti, quella più influente è di sinistra). Non solo. Dalla Lega Nord si scopre che 9 giudici su 15 sono campani. «Ci sembra alquanto strano che ben 9 dei 15 giudici della Consulta siano campani» osservano due consiglieri regionali veneti della Lega Nord, Emilio Zamboni e Luca Baggio. «È quasi incredibile - affermano Zamboni e Baggio - che un numero così elevato di giudici provenga da una sola regione, guarda caso la Campania. Siamo convinti che questo dato numerico debba far riflettere non solo l'opinione pubblica, ma anche i rappresentanti delle istituzioni». «Il Lodo Alfano è stato bocciato perché ritenuto incostituzionale. Ma cosa c'è di costituzionale - si chiedono Baggio e Zamboni - nel fatto che la maggior parte dei giudici della Consulta, che ha bocciato la contestata legge provenga da Napoli? Come mai c'è un solo rappresentante del Nord?».
Da “Il Giornale” poi, l’inchiesta verità: “Scandali e giudizi politici: ecco la vera Consulta”. Ermellini rossi, anche per l’imbarazzo. Fra i giudici della Corte costituzionale che hanno bocciato il Lodo Alfano ve n’è uno che da sempre strizza un occhio a sinistra, ma li abbassa tutti e due quando si tratta di affrontare delicate questioni che riguardano lui o i suoi più stretti congiunti. È Gaetano Silvestri, 65 anni, ex csm, ex rettore dell’ateneo di Messina, alla Consulta per nomina parlamentare («alè, hanno eletto un altro comunista!» tuonò il 22 giugno 2005 l’onorevole Carlo Taormina), cognato di quell’avvocato Giuseppe «Pucci» Fortino arrestato a maggio 2007 nell’inchiesta Oro Grigio e sotto processo a Messina per volontà del procuratore capo Luigi Croce. Che ha definito quel legale intraprendente «il Ciancimino dello Stretto», con riferimento all’ex sindaco mafioso di Palermo, tramite fra boss e istituzioni. Per i pm l’«avvocato-cognato» era infatti in grado di intrattenere indifferentemente rapporti con mafiosi, magistrati, politici e imprenditori. Di Gaetano Silvestri s’è parlato a lungo anche per la vicenda della «parentopoli» all’università di Messina. Quand’era rettore s’è scoperto che sua moglie, Marcella Fortino (sorella di Giuseppe, il «Ciancimino di Messina») era diventata docente ordinario di Scienze Giuridiche. E che costei era anche cognata dell’ex pro-rettore Mario Centorrino, il cui figlio diventerà ordinario, pure lui, nel medesimo ateneo. E sempre da Magnifico, Silvestri scrisse una lettera riservata al provveditore agli studi Gustavo Ricevuto per perorare la causa del figlio maturando, a suo dire punito ingiustamente all’esito del voto (si fermò a 97/100) poiché agli scritti - sempre secondo Silvestri - il ragazzo aveva osato criticare un certo metodo d’insegnamento. La lettera doveva rimanere riservata, il 5 agosto 2001 finì in edicola. E fu scandalo. «Come costituzionalista - scrisse Silvestri - fremo all’idea che una scuola di una Repubblica democratica possa operare siffatte censure, frutto peraltro di un non perfetto aggiornamento da parte di chi autoritariamente le pone in atto. Ho fatto migliaia di esami in vita mia, ma sentirei di aver tradito la mia missione se avessi tolto anche un solo voto a causa delle opinioni da lui professate». Andando al luglio ’94, governo Berlusconi in carica, Silvestri firma un appello per «mettere in guardia contro i rischi di uno svuotamento della carta costituzionale attraverso proposte di riforme e revisione, che non rispettino precise garanzie». Nel 2002 con una pletora di costituzionalisti spiega di «condividere le critiche delle opposizioni al Ddl sul conflitto di interessi». L’anno appresso, a proposito del Lodo sull’immunità, se ne esce così: «Siamo costretti a fare i conti con questioni che dovrebbero essere scontate, che risalgono ai classici dello stato di diritto (...). Se si va avanti così fra breve saremo capaci di metabolizzare le cose più incredibili». Altro giudice contrarissimo al Lodo è Alessandro Criscuolo. Ha preso la difesa e perorato la causa dell’ex pm di Catanzaro, Luigi De Magistris, nel procedimento disciplinare al Csm: «Non ha mai arrestato nessuno ingiustamente, De Magistris è stato molto attento alla gestione dei suoi provvedimenti». Smentito. Quand’era presidente dell’Anm, alle accuse dei radicali sulla (mala) gestione del caso Tortora, Criscuolo rispose prendendo le parti dei magistrati, difese la sentenza di primo grado, ringraziò i pentiti per il loro contributo (sic!). Nel ’97 entrò a gamba tesa in un altro processo, quello per l’omicidio del commissario Calabresi, al grido di «meglio un colpevole libero che un innocente dentro». E che dire del giudice Franco Gallo, già ministro delle Finanze con Ciampi, nemico giurato del successore visto che all’insediamento di Giulio Tremonti (scrive Il Fatto) rassegnò le dimissioni dalla scuola centrale tributaria dopo esser uscito da un’inchiesta finita al tribunale dei ministri, su presunti illeciti compiuti a favore del Coni per il pagamento di canoni irrisori per alcuni immobili. Altro ministro-giudice di Ciampi, rigorosamente no-Lodo, è il professor Sabino Cassese, gettonatissimo in commissioni di studio e d’inchiesta, ai vertici di società importanti e di banche. A proposito della sentenza del gip Clementina Forleo, che assolveva cinque islamici accusati di terrorismo definendoli «guerriglieri», chiosò dicendo che gli Stati Uniti avevano violato lo stato di diritto. Giuseppe Tesauro, terza creatura di Ciampi alla Consulta, viene ricordato al vertice dell’Antitrust per la sua battaglia contro la legge Gasparri («è una legge contro la concorrenza», oppure, «il testo non è in odor di santità, la riforma mescola coca-cola, whisky e acqua»). Di lui si parlò come candidato dell’Ulivo a fine mandato 2005 e come «persecutore» di Gilberto Benetton e della sua Edizioni Holding interessata ad acquistare la società Autogrill (l’inchiesta venne archiviata). Considerato a sinistra da sempre anche Ugo De Siervo, almeno dal ’95 quando al convegno «Con la Costituzione non si scherza» parlò di comportamenti «ispirati a dilettantismo e tatticismo, interpretazioni di stampo plebiscitario, spregio della legalità costituzionale». A maggio 2001 è a fianco dell’ex sottosegretario e senatore dei Ds Stefano Passigli, che annuncia un esposto contro Berlusconi per la violazione dei limiti di spesa per la legge elettorale.
Tanto comandano loro: le toghe! Magistrati, raddoppiati gli incarichi extragiudiziari. Le richieste per svolgere un secondo lavoro sono aumentate in 12 mesi del 100%. Sono passate da 961 a 494. Un record. Consulenze e docenze le più appetibili, scrive “Libero Quotidiano”. La doppia vita dei magistrati. Alle toghe di casa nostra non bastano mai i soldi che incassano con il loro lavoro da magistrato. Le toghe preferiscono la seconda attività. Negli ultimi sei mesi il totale degli incarichi autorizzati dal Csm alle toghe ha toccato quota 961, quasi il doppio dei 494 concessi nei sei mesi precedenti. Insomma il doppio lavoro e la doppia busta paga servono per riempire le tasche. La doppia attività è una tradizione dei nostri magistrati. E la tendenza è in crescita. Si chiamano incarichi “extragiudiziari”, in quanto relativi ad attività che non fanno riferimento alla professione giudiziaria. Gli incarichi per le toghe arrivano dalle società, dagli enti di consulenza e università private, come quella della Confindustria. I dati sull'incremento degli incarichi extragiudiziari li fornisce il Csm. Tra novembre 2012 e maggio 2013 gli incarichi sono raddoppiati. A dare l'ok alla doppia attività è proprio il Csm. Le toghe amano le cattedre e così vanno ad insegnare alla Luiss, l’ateneo confindustriale diretto da Pier Luigi Celli. Poi ci sono le consulenze legali per la Wolters Kluwer, multinazionale che si occupa di editoria e formazione professionale. Ma non finisce qua. Qualche magistrato lavora per la Altalex Consulting, altra società attiva nell’editoria e nella formazione giuridica. Le paghe sono sostanziose. Ad esempio Giovanni Fanticini, racconta Lanotiziagiornale.it, è giudice al tribunale di Reggio Emilia. Ma ha 11 incarichi extragiudiziali. Tra docenze, seminari e lezioni varie, è semplicemente impressionante: dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze (controllata al ministero di via XX Settembre) ha avuto un incarico di 7 ore con emolumento orario di 130 euro (totale 910 euro); dalla società Altalex ha avuto sei collaborazioni: 15 ore per complessivi 2.500 euro, 7 ore per 1.300, 8 ore per 1.450, 15 ore per 2.500, 5 ore per 750 e 5 ore per 700; dal Consorzio interuniversitario per l’aggiornamento professionale in campo giuridico ha ottenuto due incarichi, complessivamente 8 ore da 100 euro l’una (totale 800 euro). Insomma un buon bottino. In Confindustria poi c'è l'incarico assegnato a Domenico Carcano, consigliere della Corte di cassazione, che per 45 ore di lezioni ed esami di diritto penale ha ricevuto 6 mila euro. C’è Michela Petrini, magistrato ordinario del tribunale di Roma, che ha incassato due docenze di diritto penale dell’informatica per complessivi 4.390 euro. Ancora, Enrico Gallucci, magistrato addetto all’Ufficio amministrazione della giustizia, ha ottenuto 5.500 euro per 36 ore di lezione di diritto penale. Il doppio incarico di certo non va molto d'accordo con l'imparzialità della magistratura. Se le società dove lavorano questi magistrati dovessero avere problemi giudiziari la magistratura e i giudici quanto sarebbero equidistanti nell'amministrare giustizia? L'anomalia degli incarichi extragiudiziari va eliminata.
“VADA A BORDO, CAZZO!!”.
E’ celebre il “vada a bordo, cazzo” del comandante De Falco. L’Italia paragonata al destino ed agli eventi che hanno colpito la nave Concordia. Il naufragio della Costa Concordia, è un sinistro marittimo "tipico" avvenuto venerdì 13 gennaio 2012 alle 21:42 alla nave da crociera al comando di Francesco Schettino e di proprietà della compagnia di navigazione genovese Costa Crociere, parte del gruppo anglo-americano Carnival Corporation & plc. All'1.46 di sabato mattina 14 gennaio il comandante della Concordia Francesco Schettino riceve l'ennesima telefonata dalla Capitaneria di Porto. In linea c'è il comandante Gregorio Maria De Falco. La chiamata è concitata e i toni si scaldano rapidamente.
De Falco: «Sono De Falco da Livorno, parlo con il comandante?
Schettino: «Sì, buonasera comandante De Falco»
De Falco: «Mi dica il suo nome per favore»
Schettino: «Sono il comandante Schettino, comandante»
De Falco: «Schettino? Ascolti Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo. Adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave lato dritto. C'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo e mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione comandante Schettino...».
Schettino: «Comandante le dico una cosa...»
De Falco: «Parli a voce alta. Metta la mano davanti al microfono e parli a voce più alta, chiaro?».
Schettino: «In questo momento la nave è inclinata...».
De Falco: «Ho capito. Ascolti: c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E mi dice il numero di ciascuna di queste categorie. E' chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare ma io la porto… veramente molto male… le faccio passare un’anima di guai. Vada a bordo, cazzo!»
“TUTTI DENTRO, CAZZO!!”
Parafrasando la celebre frase di De Falco mi rivolgo a tutti gli italiani: ““TUTTI DENTRO CAZZO!!”. Il tema è “chi giudica chi?”. Chi lo fa, ha veramente una padronanza morale, culturale professionale per poterlo fare? Iniziamo con il parlare della preparazione culturale e professionale di ognuno di noi, che ci permetterebbe, in teoria, di superare ogni prova di maturità o di idoneità all’impiego frapposta dagli esami scolastici o dagli esami statali di abilitazione o di un concorso pubblico. In un paese in cui vigerebbe la meritocrazia tutto ciò ci consentirebbe di occupare un posto di responsabilità. In Italia non è così. In ogni ufficio di prestigio e di potere non vale la forza della legge, ma la legge del più forte. Piccoli ducetti seduti in poltrona che gestiscono il loro piccolo potere incuranti dei disservizi prodotti. La massa non è li ha pretendere efficienza e dedizione al dovere, ma ad elemosinare il favore. Corruttori nati. I politici non scardinano il sistema fondato da privilegi secolari. Essi tacitano la massa con provvedimenti atti a quietarla.
Panem et circenses, letteralmente: "pane e giochi del circo", è una locuzione in lingua latina molto conosciuta e spesso citata. Era usata nella Roma antica. Contrariamente a quanto generalmente ritenuto, questa frase non è frutto della fantasia popolare, ma è da attribuirsi al poeta latino Giovenale:
« ...duas tantum res anxius optat panem et circenses».
« ...[il popolo] due sole cose ansiosamente desidera pane e i giochi circensi».
Questo poeta fu un grande autore satirico: amava descrivere l'ambiente in cui viveva, in un'epoca nella quale chi governava si assicurava il consenso popolare con elargizioni economiche e con la concessione di svaghi a coloro che erano governati (in questo caso le corse dei carri tirati da cavalli che si svolgevano nei circhi come il Circo Massimo e il Circo di Massenzio).
Perché quel “TUTTI DENTRO CAZZO!!”. Perché la legge dovrebbe valere per tutti. Non applicata per i più ed interpretata per i pochi. E poi mai nessuno, in Italia, dovrebbe permettersi di alzare il dito indice ed accusare qualcun altro della sua stessa colpa. Prendiamo per esempio la cattiva abitudine di copiare per poter superare una prova, in mancanza di una adeguata preparazione. Ognuno di noi almeno un volta nella vita ha copiato. In principio era la vecchia “cartucciera” la fascia di stoffa da stringere in vita con gli involtini a base di formule trigonometriche, biografie del Manzoni e del Leopardi, storia della filosofia e traduzioni di Cicerone. Poi il vocabolario farcito d'ogni foglio e foglietto, giubbotti imbottiti di cultura bignami e addirittura scarpe con suola manoscritta. Oggi i metodi per “aiutarsi” durante gli esami sono più tecnologici: il telefonino, si sa, non si può portare, ma lo si porta lo stesso. Al massimo, se c’è la verifica, lo metti sul tavolo della commissione. Quindi non è malsana l'idea dell'iPhone sul banco, collegato a Wikipedia e pronto a rispondere ad ogni quesito nozionistico. Comunque bisogna attrezzarsi, in maniera assolutamente diversa. La rete e i negozi di cartolibreria vendono qualsiasi accrocchio garantendo si tratti della migliore soluzione possibile per copiare durante le prove scritte. C'è ad esempio la penna UV cioè a raggi ultravioletti scrive con inchiostro bianco e si legge passandoci sopra un led viola incluso nel corpo della penna. Inconveniente: difficile non far notare in classe una luce da discoteca. Poi c'è la cosiddetta penna-foglietto: nel corpo della stilo c'è un foglietto avvolto sul quale si è scritto precedentemente formule, appunti eccetera. Foglietto che in men che non si dica si srotola e arrotola. Anche in questo caso l'inconveniente è che se ti sorprendono sono guai. E infine, c'è l'ormai celebre orologio-biglietto col display elettronico e una porta Usb sulla quale caricare testi d'ogni tipo. Pure quello difficile da gestire: solo gli artisti della copia copiarella possono.
Il consiglio è quello di studiare e non affidarsi a trucchi e trucchetti. Si rischia grosso e non tutti lo sanno. Anche perché il copiare lo si fa passare per peccato veniale. Copiare ad esami e concorsi, invece, potrebbe far andare in galera. E' quanto stabilito dalla legge n. 475/1925 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 32368/10. La legge recita all'art.1 :“Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito”. A conferma della legge è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n.32368/10, che ha condannato una candidata per aver copiato interamente una sentenza del TAR in un elaborato a sua firma presentato durante un concorso pubblico. La sentenza della sezione VI penale n. 32368/10 afferma: “Risulta pertanto ineccepibile la valutazione dei giudici di merito secondo cui la (…) nel corso della prova scritta effettuò, pur senza essere in quel frangente scoperta, una pedissequa copiatura del testo della sentenza trasmessole (…). Consegue che il reato è integrato anche qualora il candidato faccia riferimento a opere intellettuali, tra cui la produzione giurisprudenziale, di cui citi la fonte, ove la rappresentazione del suo contenuto sia non il prodotto di uno sforzo mnemonico e di autonoma elaborazione logica ma il risultato di una materiale riproduzione operata mediante l’utilizzazione di un qualsiasi supporto abusivamente impiegato nel corso della prova”.
In particolare per gli avvocati la Riforma Forense, legge 247/2012, al CAPO II (ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO) Art. 46. (Esame di Stato) stabilisce che “….10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.”
Ma, di fatto, quello previsto come reato è quello che succede da quando esiste questo tipo di esame e vale anche per i notai ed i magistrati. Eppure, come ogni altra cosa italiana c’è sempre l’escamotage tutto italiano. Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che copiare non è reato: niente più punizione. Dichiarando tuttavia “legale” copiare a scuola, si dichiara pure legale copiare nella vita. Non viene sanzionato un comportamento che è senza dubbio scorretto. Secondo il Consiglio di Stato, il superamento dell’esame costituisce di per sè attestazione delle “competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite” dall'alunna e la norma che regola l'espulsione dei candidati dai pubblici concorsi per condotta fraudolenta, non può prescindere "dal contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente, secondo i principi che regolano il cosiddetto esame di maturità": le competenze e le conoscenze acquisite….in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato. A ciò il Cds ha anche aggiunto un'attenuante, cioè "uno stato d’ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute" della studentessa stessa, che sarebbe stato alla base del gesto. Il 12 settembre 2012 una sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar della Campania che aveva escluso dagli esami di maturità una ragazza sorpresa a copiare da un telefono palmare. Per il Consiglio di Stato la decisione del Tar non avrebbe adeguatamente tenuto conto né del “brillante curriculum scolastico” della ragazza in questione, né di un suo “stato di ansia”. Gli esami, nel frattempo, la giovane li aveva sostenuti seppur con riserva. L’esclusione della ragazza dagli esami sarà forse stata una sanzione eccessiva. Probabilmente la giovane in questione, sulla base del suo curriculum poteva esser perdonata. Gli insegnanti, conoscendola e comprendendo il suo stato d’ansia pre-esame, avrebbero potuto chiudere un occhio. Tutto vero. Ma sono valutazioni che spettavano agli insegnanti che la studente conoscono. Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce invece, di fatto, un principio. E in questo caso il principio è che copiare vale. Non è probabilmente elegante, ma comunque va bene. Questo principio applicato alla scuola, luogo in cui le generazioni future si forgiano ed educano, avrà ripercussioni sulla società del futuro. Se ci viene insegnato che a non rispettar le regole, in fondo, non si rischia nulla più che una lavata di capo, come ci porremo di fronte alle regole della società una volta adulti? Ovviamente male. La scuola non è solo il luogo dove si insegnano matematica e italiano, storia e geografia. Ma è anche il luogo dove dovrebbe essere impartito insegnamento di civica educazione, dove si impara a vivere insieme, dove si impara il rispetto reciproco e quello delle regole. Dove si impara a “vivere”. Se dalla scuola, dalla base, insegniamo che la “furbizia” va bene, non stupiamoci poi se chi ci amministra si compra il Suv con i soldi delle nostre tasse. In fondo anche lui avrà avuto il suo “stato d’ansia”. Ma il punto più importante non è tanto la vicenda della ragazza sorpresa a copiare e di come sia andata la sua maturità. Il punto è la sanzionabilità o meno di un comportamento che è senza dubbio scorretto. In un paese già devastato dalla carenza di etica pubblica, dalla corruzione e dall’indulgenza programmatica di molte vulgate pedagogiche ammantate di moderno approccio relazionale, ci mancava anche la corrività del Consiglio di Stato verso chi imbroglia agli esami.
E, comunque, vallo a dire ai Consiglieri di Stato, che dovrebbero già saperlo, che nell’ordinamento giuridico nazionale esiste la gerarchia della legge. Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione; queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia delle fonti). nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida". Al primo livello della gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione e le leggi costituzionali (fonti superprimarie). La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli: essa detta i principi fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita lunga e rigida, lunga perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi" riguardando anche altre materie, rigida in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto aggravato (vedi art. 138 cost.). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale. Al di sotto delle leggi costituzionali si pongono i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. I primi hanno efficacia immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Seguono le fonti primarie, ovvero le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura di cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate: l'iniziativa di legge; l'approvazione del testo di legge è affidata alle due Camere del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica); la promulgazione del Presidente della Repubblica; la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici e all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la consuetudine, prodotta dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta. Sono ammesse ovviamente solo consuetudini secundum legem e praeter legem non dunque quelle contra legem.
Pare che molte consuetudini sono contra legem e pervengono proprio da coloro che dovrebbero dettare i giusti principi.
Tutti in pensione da "presidente emerito". I giudici della Corte Costituzionale si danno una mano tra loro per dare una spinta in più alla remunerazione pensionistica a fine carriera. Gli ermellini in pratica a rotazione, anche breve, cambiano il presidente della Corte per regalargli il titolo più prestigioso prima che giunga il tramonto professionale. Nulla di strano se non fosse che il quinto comma dell'articolo 135 della Costituzione recita: "La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice". Dunque secondo Costituzione il presidente dovrebbe cambiare ogni 3 anni, o quanto meno rieletto anche per un secondo mandato dopo 36 mesi. Le cose invece vanno in maniera completamente diversa. La poltrona da presidente con relativa pensione fa gola a tanti e allora bisogna accontentare tutti. Così dagli Anni Ottanta la norma è stata aggirata per un tornaconto personale, scrive “Libero Quotidiano”. Per consentire al maggior numero di membri di andare in pensione col titolo da presidente emerito, e fino al 2011 con tanto di auto blu a vita, si è deciso che il prescelto debba essere quello con il maggior numero di anni di servizio. Il principio di anzianità. Questo passaggio di consegne oltre a garantire una pensione più sostanziosa rispetto a quella di un semplice giudice costituzionale, offre anche un’indennità aggiuntiva in busta paga: "I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione", recita la legge 87/1953. Successivamente, il legislatore è intervenuto con legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituendo il primo periodo dell'originario art. 12, comma 1, della legge 87/1953 nei seguenti termini: "I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà". Resta ferma l'attribuzione dell'indennità di rappresentanza per il Presidente. Quella era intoccabile. Così ad esempio accade che Giovanni Maria Flick è stato presidente per soli 3 mesi, dal 14 novembre 2008 al 18 febbraio 2009. Flick si difese dicendo che quella "era ormai una prassi consolidata". Già, consolidata in barba alla Carta Costituzionale che loro per primi dovrebbero rispettare. Gustavo Zagerblesky ad esempio è stato presidente per soli 7 mesi. Poi è stato il turno di Valerio Onida, presidente per 4 mesi dal 22 settembre 2004 al 30 maggio 2005. Ugo De Servio invece ha tenuto la poltrona dal 10 dicembre 2010 al 29 aprile 2011, 4 mesi anche per lui. Recordman invece Alfonso Quaranta che è stato in carica per un anno e sette mesi, dal 6 giugno 2011 al 27 gennaio 2012. Ora la corsa alla poltrona è per l'attuale presidente Franco Gallo, in carica dal gennaio 2013. Durerà fin dopo l'estate? Probabilmente no.
“TUTTI DENTRO, CAZZO!!”
Per esempio nei processi, anche i testimoni della difesa.
Tornando alla parafrasi del “TUTTI DENTRO, CAZZO!!” si deve rimarcare una cosa. Gli italiani sono: “Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigatori”. Così è scritto sul Palazzo della Civiltà Italiana dell’EUR a Roma. Manca: “d’ingenui”. Ingenui al tempo di Mussolini, gli italiani, ingenui ancora oggi. Ma no, un popolo d’ingenui non va bene. Sul Palazzo della Civiltà aggiungerei: “Un popolo d’allocchi”, anzi “Un popolo di Coglioni”. Perché siamo anche un popolo che quando non sa un “cazzo” di quello che dice, parla. E parla sempre. Parla..…parla. Specialmente sulle cose di Giustizia: siamo tutti legulei.
Chi frequenta bene le aule dei Tribunali, non essendo né coglione, né in mala fede, sa molto bene che le sentenze sono già scritte prima che inizi il dibattimento. Le pronunce sono pedisseque alle richieste dell’accusa, se non di più. Anche perché se il soggetto è intoccabile l’archiviazione delle accuse è già avvenuta nelle fasi successive alla denuncia o alla querela: “non vi sono prove per sostenere l’accusa” o “il responsabile è ignoto”. Queste le motivazioni in calce alla richiesta accolta dal GIP, nonostante si conosca il responsabile o vi siano un mare di prove, ovvero le indagini non siano mai state effettuate. La difesa: un soprammobile ben pagato succube dei magistrati. Il meglio che possono fare è usare la furbizia per incidere sulla prescrizione. Le prove a discarico: un perditempo, spesso dannoso. Non è improbabile che i testimoni della difesa siano tacciati di falso.
Nel formulare la richiesta la Boccassini nel processo Ruby ha fatto una gaffe dicendo: "Lo condanno", per poi correggersi: "Chiedo la condanna" riferita a Berlusconi.
Esemplare anche è il caso di Napoli. Il gip copia o si limita a riassumere le tesi accusatorie della Procura di Napoli e per questo il tribunale del riesame del capoluogo campano annulla l'arresto di Gaetano Riina, fratello del boss di Cosa nostra, Totò, avvenuto il 14 novembre 2011. L'accusa era di concorso esterno in associazione camorristica. Il gip, scrive il Giornale di Sicilia, si sarebbe limitato a riassumere la richiesta di arresto della Procura di Napoli, incappando peraltro in una serie di errori e non sostituendo nella sua ordinanza neanche le parole «questo pm» con «questo gip».
Il paradosso, però, sono le profezie cinematografiche adattate ai processi: «... e lo condanna ad anni sette di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e all'interdizione legale per la durata della pena». Non è una frase registrata Lunedì 24 giugno 2013 al Tribunale di Milano, ma una battuta presa dagli ultimi minuti del film «Il caimano» di Nanni Moretti. La condanna inflitta al protagonista (interpretato dallo stesso regista) è incredibilmente identica a quella decisa dai giudici milanesi per Silvio Berlusconi. Il Caimano Moretti, dopo la sentenza, parla di «casta dei magistrati» che «vuole avere il potere di decidere al posto degli elettori».
Sul degrado morale dell’Italia berlusconiana (e in generale di tutti quelli che hanno votato Berlusconi nonostante sia, per dirla con Gad Lerner, un “puttaniere”) è stato detto di tutto, di più. Ma poco, anzi meno, è stato detto a mio parere sul degrado moralista della sinistra anti-berlusconiana (e in generale di molti che hanno votato “contro” il Cavaliere e che hanno brindato a champagne, festeggiato a casa o in ufficio, tirato un sospiro di sollievo come al risveglio da un incubo di vent’anni). Quella sinistra che, zerbino dei magistrati, ha messo il potere del popolo nelle mani di un ordine professionale, il cui profilo psico-fisico-attitudinale dei suoi membri non è mai valutato e la loro idoneità professionale incute dei dubbi.
Condanna a sette anni di carcere per concussione per costrizione (e non semplice induzione indebita) e prostituzione minorile, con interdizione perpetua dai pubblici uffici per Silvio Berlusconi: il processo Ruby a Milano finisce come tutti, Cavaliere in testa, avevano pronosticato. Dopo una camera di consiglio-fiume iniziata alle 10 di mattina e conclusa sette ore abbondanti dopo, le tre giudici della quarta sezione penale Giulia Turri, Orsola De Cristofaro e Carmen D'Elia hanno accolto in pieno, e anzi aumentato, le richieste di 6 anni dell'accusa, rappresentata dai pm Ilda Boccassini (in ferie e quindi non in aula, sostituita dal procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati, fatto mai avvenuto quello che il procuratore capo presenzi in dibattimento) e Antonio Sangermano. I giudici hanno anche trasmesso alla Procura, per le opportune valutazioni, gli atti relativi alla testimonianza, tra gli altri, di Giorgia Iafrate, la poliziotta che affidò Ruby a Nicole Minetti. Inoltre, sono stati trasmessi anche i verbali relativi alle deposizioni di diverse olgettine, di Mariano Apicella e di Valentino Valentini. Il tribunale di Milano ha disposto anche la confisca dei beni sequestrati a Ruby, Karima El Mahroug e al compagno Luca Risso, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, secondo cui il giudice "può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto".
I paradossi irrisolti della sentenza sono che colpiscono anche la “vittima” Ruby e non solo il “carnefice” Berlusconi. L’ex minorenne, Karima El Mahroug, «per un astratta tutela della condizione di minorenne», viene dichiarata prima “prostituta” e poi i suoi beni le vengono confiscati: «Come nel caso del concusso, la parte lesa non si dichiara tale anzi si manifesta lesa per l’azione dei magistrati». Ruby «è doppiamente lesa dai magistrati», spiega Sgarbi, «nella reputazione e nel vedersi sottrarre, in via cautelativa, i denari che Berlusconi le ha dato».
«Non chiamiamola sentenza. Non chiamiamolo processo. Soprattutto, non chiamiamola giustizia». Comincia così, con queste amarissime parole, la nota di Marina Berlusconi in difesa di suo padre. «Quello cui abbiamo dovuto assistere è uno spettacolo assurdo che con la giustizia nulla ha a che vedere, uno spettacolo che la giustizia non si merita. La condanna - scrive Marina - era scritta fin dall'inizio, nel copione messo in scena dalla Procura di Milano. Mio padre non poteva non essere condannato. Ma se possibile il Tribunale è andato ancora più in là, superando le richieste dell'accusa e additando come spergiuri tutti i testi in contrasto con il suo teorema». Nonostante la "paccata" di testimoni portati in tribunale dalla difesa di Silvio Berlusconi, il presidente della Corte Giulia Turri e i giudici Orsolina De Cristofano e Carmen D'Elia hanno preferito inseguire il teorema costruito ad arte dal pm Ilda Boccassini e tacciare di falsa testimonianza tutte le persone che, con le proprie parole, hanno scagionato il Cavaliere. Insomma, se la "verità" non coincide con quella professata dalla magistratura milanese, allora diventa automaticamente bugia. Non importa che non ci sia alcuna prova a dimostrarlo.
L'accusa dei giudici milanesi è sin troppo chiara, spiega Andrea Indini su "Il Giornale": le trentadue persone che si sono alternate sul banco dei testimoni per rendere dichiarazioni favorevoli a Berlusconi hanno detto il falso. Solo le motivazioni, previste tra novanta giorni, potranno chiarire le ragioni per cui il collegio abbia deciso di trasmettere alla procura i verbali di testimoni che vanno dall’amico storico dell’ex premier Mariano Apicella all’ex massaggiatore del Milan Giorgio Puricelli, dall’europarlamentare Licia Ronzulli alla deputata Maria Rosaria Rossi. Da questo invio di atti potrebbe nascere, a breve, un maxi procedimento per falsa testimonianza. A finir nei guai per essersi opposta al teorema della Boccassini c'è anche il commissario Giorgia Iafrate che era in servizio in Questura la notte del rilascio di Ruby. La funzionaria aveva, infatti, assicurato di aver agito "nell’ambito dei miei poteri di pubblico ufficiale". "Di fronte alla scelta se lasciare la ragazza in Questura in condizioni non sicure o affidarla ad un consigliere regionale - aveva spiegato - ho ritenuto di seguire quest’ultima possibilità". Proprio la Boccassini, però, nella requisitoria aveva definito "avvilenti le dichiarazioni della Iafrate che afferma che il pm minorile Fiorillo le aveva dato il suo consenso". Alla procura finiscono poi i verbali di una ventina di ragazze. Si va da Barbara Faggioli a Ioana Visan, da Lisa Barizonte alle gemelle De Vivo, fino a Roberta Bonasia. Davanti ai giudici avevano descritto le serate di Arcore come "cene eleganti", con qualche travestimento sexy al massimo, e avevano sostenuto che Ruby si era presentata come una 24enne. "I giudici hanno dato per scontato che siamo sul libro paga di Berlusconi - ha tuonato Giovanna Rigato, ex del Grande Fratello - io tra l’altro al residence non ho mai abitato, sono una che ha sempre lavorato, l’ho detto in mille modi che in quelle serata ad Arcore non ho mai visto nulla di scabroso ma tanto...". Anche Marysthelle Polanco è scioccata dalla sentenza: "Non mi hanno creduto, non ci hanno creduto, io ho detto la verità e se mi chiamano di nuovo ripeterò quello che ho sempre raccontato". Sebbene si siano lasciate scivolare addosso insulti ben più pesanti, le ragazze che hanno partecipato alle feste di Arcore non sono disposte ad accettare l’idea di passare per false e bugiarde. Da Puricelli a Rossella, fino al pianista Mariani e ad Apicella, è stato tratteggiato in Aula un quadro di feste fatto di chiacchiere, balli e nessun toccamento.
Nel tritacarne giudiziario finisce anche la Ronzulli, "rea" di aver fornito una versione diversa da quella resa da Ambra e Chiara nel processo "gemello" e di aver negato di aver visto una simulazione di sesso orale con l’ormai famosa statuetta di Priapo. Stesso destino anche per l’ex consigliere per le relazioni internazionali Valentino Valentini che aveva svelato di esser stato lui a far contattare la Questura di Milano per "capire cosa stesse accadendo". Ed era stato sempre lui a parlare di una conversazione tra Berlusconi e l'ex raìs Hosni Mubarak sulla parentela con Ruby. Anche il viceministro Bruno Archi, all’epoca diplomatico, ai giudici aveva descritto quel pranzo istituzionale nel quale si sarebbe parlato di Karima. E ancora: sono stati trasmessi ai pm anche i verbali di Giuseppe Estorelli, il capo scorta di Berlusconi, e del cameriere di Arcore Lorenzo Brunamonti, "reo" di aver regalato al Cavaliere, di ritorno da un viaggio, la statuetta di Priapo. Tutti bugiardi, tutti nella tritarcarne del tribunale milanese. La loro colpa? Aver detto la verità. Una verità che non piace ai giudici che volevano far fuori a tutti i costi Berlusconi.
C'era un solo modo per condannare Silvio Berlusconi nel processo cosiddetto Ruby, spiega Alessandro Sallusti su "Il Giornale": fare valere il teorema della Boccassini senza tenere conto delle risultanze processuali, in pratica cancellare le decine e decine di testimonianze che hanno affermato, in due anni di udienze, una verità assolutamente incompatibile con le accuse. E cioè che nelle notti di Arcore non ci furono né vittime né carnefici, così come in Questura non ci furono concussi. Questo trucco era l'unica possibilità e questo è accaduto. Trenta testimoni e protagonisti della vicenda, tra i quali rispettabili parlamentari, dirigenti di questura e amici di famiglia sono stati incolpati in sentenza, cosa senza precedenti, di falsa testimonianza e dovranno risponderne in nuovi processi. Spazzate via in questo modo le prove non solo a difesa di Berlusconi ma soprattutto contrarie al teorema Boccassini, ecco spianata la strada alla condanna esemplare per il capo: sette anni più l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, esattamente la stessa pronunciata nella scena finale del film Il Caimano di Nanni Moretti, in cui si immagina l'uscita di scena di Berlusconi. Tra questa giustizia e la finzione non c'è confine. Siamo oltre l'accanimento, la sentenza è macelleria giudiziaria, sia per il metodo sia per l'entità. Ricorda molto, ma davvero molto, quelle che i tribunali stalinisti e nazisti usavano per fare fuori gli oppositori: i testimoni che osavano alzare un dito in difesa del disgraziato imputato di turno venivano spazzati via come vermi, bollati come complici e mentitori, andavano puniti e rieducati. Come osi, traditore - sostenevano i giudici gerarchi - mettere in dubbio la parola dello Stato padrone? Occhio, che in galera sbatto pure te. Così, dopo Berlusconi, tocca ai berlusconiani passare sotto il giogo di questi pazzi scatenati travestiti da giudici. I quali vogliono che tutti pieghino la testa di fronte alla loro arroganza e impunità. In trenta andranno a processo per aver testimoniato la verità, raccontato ciò che hanno visto e sentito. Addio Stato di diritto, addio a una nobile tradizione giuridica, la nostra, in base alla quale il giudizio della corte si formava esclusivamente sulle verità processuali, che se acquisite sotto giuramento e salvo prova contraria erano considerate sacre.
Omicidi, tentati omicidi, sequestro di persona, occultamenti di cadavere. Per la giustizia italiana questi reati non sono poi così diversi da quello di concussione, scrive Nadia Francalacci su "Panorama". La condanna inflitta a Silvio Berlusconi a 7 anni di carcere, uno in più rispetto alla pena chiesta dai pubblici ministeri, e interdizione perpetua dai pubblici uffici per i reati di prostituzione minorile e concussione, non differisce che di poche settimane da quella inflitta a Michele Misseri il contadino di Avetrana che ha occultato il cadavere della nipotina Sara Scazzi in un pozzo delle campagne pugliesi. Non solo. La condanna all’ex premier è addirittura ancor più pesante rispetto a quella inflitta a due studenti di Giurisprudenza, Scattone e Ferraro, che “ quasi per gioco” hanno mirato alla testa di una studentessa, Marta Russo, uccidendola nel cortile interno della facoltà. Quasi per gioco. Così in pochi istanti hanno ucciso, tolto la vita, ad una ragazza che aveva tanti sogni da realizzare. Marta Russo così come Sara Scazzi oppure un Gabriele Sandri, il tifoso laziale ucciso nell’area di servizio dopo dei tafferugli con i tifosi juventini. Il poliziotto che ha premuto il grilletto colpendolo alla nuca, è stato condannato a 9 anni e 4 mesi. A soli 28 mesi in più di carcere rispetto a Silvio Berlusconi.
Analizzando casi noti e quelli meno conosciuti dall’opinione pubblica, non è possibile non notare una “sproporzione” di condanna tra il caso Ruby e una vicenda quale il caso Scazzi o Russo. Ecco alcuni dei casi e delle sentenze di condanna.
Caso Sandri: 9 anni e 4 mesi. Per la Cassazione è omicidio volontario. Per l'agente della Polstrada Luigi Spaccarotella, la sentenza è diventata definitiva con la pronuncia della Cassazione. La condanna è di nove anni e quattro mesi di reclusione per aver ucciso il tifoso della Lazio Gabriele Sandri dopo un tafferuglio con tifosi juventini nell'area di servizio aretina di Badia al Pino sulla A1. Sandri era sulla Renault che doveva portarlo a Milano, la mattina dell'11 novembre 2007, per vedere Inter-Lazio insieme ad altri quattro amici. Spaccarotella era stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per omicidio colposo, determinato da colpa cosciente. In secondo grado i fatti erano stati qualificati come omicidio volontario per dolo eventuale e la pena era stata elevata a nove anni e quattro mesi di reclusione.
Caso Scazzi: per Michele Misseri, 8 anni. Ergastolo per Sabrina. Ergastolo per sua madre Cosima Serrano. Otto anni per Michele Misseri, che ora rischia anche un procedimento per autocalunnia. Questo è il verdetto di primo grado sulla tragedia di Avetrana. il contadino è accusato di soppressione di cadavere insieme al fratello e al nipote.
Caso Marta Russo. L’omicidio quasi per gioco di Marta Russo è stato punito con la condanna di Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, rispettivamente puniti con 5 anni e quattro mesi il primo e 4 anni e due mesi il secondo; Marta Russo, 22 anni, studentessa di giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, fu uccisa all'interno della Città universitaria il 9 maggio 1997, da un colpo di pistola alla testa.
Caso Jucker. Ruggero Jucker, reo di aver assassinato la propria fidanzata sotto l’effetto di stupefacenti, è stato condannato, con un patteggiamento in appello a 16 anni di reclusione salvo poi essere stato liberato dopo 10 anni.
Casi minori e meno conosciuti dall’opinione pubblica.
Bari. 8 anni di carcere ad un politico che uccise un rapinatore. 5 giugno 2013. La Corte d’appello di Bari, ha chiesto la condanna a otto anni di reclusione per Enrico Balducci, l’ex consigliere regionale pugliese, gestore del distributore di carburante di Palo del Colle, accusato di omicidio volontario e lesioni personali, per aver ucciso il 23enne Giacomo Buonamico e ferito il 25enne Donato Cassano durante un tentativo di rapina subito il 5 giugno 2010. In primo grado, Balducci era stato condannato con rito abbreviato alla pena di 10 anni di reclusione. Dinanzi ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Bari l’accusa ha chiesto una riduzione di pena ritenendo sussistente l’attenuante della provocazione, così come era stato chiesto anche dal pm in primo grado ma non era stato riconosciuto dal gup. Chiesta una condanna a quattro anni di reclusione per Cassano (condannato in primo grado a 5 anni) per i reati di rapina e tentativo di rapina. Prima di recarsi in moto al distributore di carburante gestito da Balducci, infatti, i due avrebbero compiuto un’altra rapina al vicino supermercato. Balducci, questa la ricostruzione dell’accusa, vedendosi minacciato, non sarebbe riuscito a controllare la sua ira, e consapevole di poter uccidere, avrebbe fatto fuoco ferendo Cassano e uccidendo Buonamico.
Sequestro Spinelli (ragioniere di Berlusconi): 8 anni e 8 mesi di carcere al capobanda Leone. Condannati anche i tre complici albanesi. Ma le pene sono state dimezzate rispetto alle richieste dell'accusa. Il pm Paolo Storari ha chiesto la condanna a 16 anni di carcere per Francesco Leone, ritenuto il capo banda, e pene tra gli 8 e i 10 anni per gli altri tre imputati. I quattro furono arrestati nel novembre dell'anno scorso assieme ad altri due italiani, Pier Luigi Tranquilli e Alessandro Maier, per i quali invece è stata chiesta l'archiviazione. Il gup di Milano Chiara Valori ha condannato con il rito abbreviato a 8 anni e 8 mesi Francesco Leone, riqualificando il reato in sequestro semplice. Sono arrivate due condanne a 4 anni e 8 mesi, e una a 6 anni e 8 mesi, per gli altri tre imputati. La vicenda è quella del sequestro lampo di Giuseppe Spinelli e della moglie.
Pesaro. Picchiò e gettò la ex dal cavalcavia: condannato a 10 anni di carcere. Il 22 giugno scorso, Saimo Luchetti è stato condannato ieri a 10 anni di reclusione per sequestro di persona, stalking, violenza privata e tentato omicidio. Dovrà versare anche una provvisionale immediata di 60mila euro per la ragazza, 40mila per la madre e 15 per la sorella. Luchetti, 23 anni, calciatore dilettante, la notte del 18 marzo 2012 aveva malmenato e rapito sotto casa l’ex fidanzata Andrea Toccaceli di 18 anni, gettandola poi da un viadotto di Fossombrone alto 15 metri. Lui si gettò giù subito dopo. Sono sopravvissuti entrambi, ristabilendosi completamente. Luchetti è in carcere ad Ancona e dove dovrà rimanerci altri nove anni.
Caso Mancuso: condannato per tentato omicidio a 5 anni di carcere. Il diciannovenne Luigi Mancuso è stato condannato a 5 anni di reclusione per il tentato omicidio di Ion Sorin Sheau, un cittadino romeno aggredito e abbandonato in strada a San Gregorio d'Ippona. Assieme a Mancuso, figlio di Giuseppe Manuso, boss della 'ndrangheta, è stato condannato anche Danilo Pannace, 18 anni, che dovrà scontare la pena di 4 anni e 8 mesi sempre per tentato omicidio. I due imputati, giudicati col rito abbreviato, sono stati ritenuti responsabili del tentato omicidio del romeno Ion Sorin Sheau, aggredito e lasciato in strada con il cranio sfondato ed in un lago di sangue il 10 agosto del 2011 a San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo. Mancuso è stato ritenuto responsabile anche del reato di atti persecutori nei confronti della comunità romena di San Gregorio.
All’estero. In Argentina l’ex-presidente Carlos Menem è stato condannato a 8 anni di carcere per traffico d'armi internazionale. Sono otto gli anni di carcere che l’ex presidente, ora senatore al parlamento di Buenos Aires, dovrà scontare insieme a Óscar Camilión, ministro della difesa durante il suo governo, con l’accusa di contrabbando aggravato d’armi a Croazia ed Ecuador. Tra il 1991 e il 1995, l’Argentina esportò 6.500 tonnellate di armamenti destinati ufficialmente a Panama e Venezuela. Questi raggiunsero però la Croazia nel pieno del conflitto jugoslavo, e l’Ecuador che nel ‘95, combatteva con il Perú.
Parlare, però, di Berlusconi è come sminuire il problema. I Pasdaran della forca a buon mercato storcerebbero il naso: Bene, parliamo d’altro.
«In questo processo chiunque ha detto cose in contrasto con la tesi accusatoria è stato tacciato di falso, mentre ben altri testi non hanno detto la verità e sono passati per super testimoni» ha detto Franco De Jaco difensore di Cosima Serrano. E’ così è stato, perché sotto processo non c’è solo Sabrina Misseri, Michele Misseri, Cosima Serrano Misseri, Carmine Misseri, Cosimo Cosma, Giuseppe Nigro, Cosima Prudenzano Antonio Colazzo, Vito Junior Russo, ma c’è tutta Avetrana e tutti coloro che non si conformano alla verità mediatica-giudiziaria. Ed ancora Morrone fu arrestato mezz’ora dopo la mattanza, il 30 gennaio ’91. Sul terreno c’erano i corpi di due giovani e le forze dell’ordine di Taranto cercavano un colpevole a tutti i costi. La madre di una delle vittime indirizzò i sospetti su di lui. Lo presero e lo condannarono. Le persone che lo scagionavano furono anche loro condannate per falsa testimonianza. Così funziona a Taranto. Vai contro la tesi accusatoria; tutti condannati per falsa testimonianza. Nel ’96 alcuni pentiti svelarono la vera trama del massacro: i due ragazzi erano stati eliminati perché avevano osato scippare la madre di un boss. Morrone non c’entrava, ma ci sono voluti altri dieci anni per ottenere giustizia. E ora arriva anche l’indennizzo per le sofferenze subite: «Avevo 26 anni quando mi ammanettarono - racconta lui - adesso è difficile ricominciare. Ma sono soddisfatto perché lo Stato ha capito le mie sofferenze, le umiliazioni subite, tutto quello che ho passato». Un procedimento controverso: due volte la Cassazione annullò la sentenza di condanna della corte d’Assise d’Appello, ma alla fine Morrone fu schiacciato da una pena definitiva a 21 anni. Non solo: beffa nella beffa, fu anche processato e condannato a 1 anno e 8 mesi per calunnia. La sua colpa? Se l’era presa con i magistrati che avevano trascurato i verbali dei pentiti.
Taranto, Milano, l’Italia.
“Egregi signori, forse qualcuno di voi, componente delle più disparate commissioni di esame di avvocato di tutta Italia, da Lecce a Bari, da Venezia a Torino, da Palermo a Messina o Catania, pensa di intimorirmi con la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Sicuramente il più influente tra di voi, bocciandomi o (per costrizione e non per induzione) facendomi bocciare annualmente senza scrupoli all’esame di avvocato dal lontano 1998, (da quando ho promosso interrogazioni parlamentari e inoltrato denunce penali, che hanno ottenuto dei risultati eclatanti, come l’esclusione dei consiglieri dell’ordine degli avvocati dalle commissioni d’esame e ciononostante uno di loro è diventato presidente nazionale), pensa che possa rompermi le reni ed impedirmi di proseguire la mia lotta contro questo concorso forense e tutti i concorsi pubblici che provo nei miei libri essere truccati. E sempre su quei libri provo il vostro sistema giudiziario essere, per gli effetti, fondato sull’ingiustizia. Mi conoscete tutti bene da vent’anni, come mi conoscono bene, prima di giudicarmi, i magistrati che critico. Per chi non fa parte del sistema e non MI conosce e non VI conosce bene, al di là dell’immagine patinata che vi rendono i media genuflessi, pensa che in Italia vige la meritocrazia e quindi chi esamina e giudica e chi supera gli esami, vale. Non è così e non mi impedirete mai di gridarlo al mondo. Avete la forza del potere, non la ragione della legge. Forse qualcuno di voi, sicuramente il più influente, perseguendomi artatamente anche per diffamazione a mezzo stampa, senza mai riuscire a condannarmi, pur con le sentenze già scritte prima del dibattimento, pensa di tagliarmi la lingua affinchè non possa denunciare le vostre malefatte. Non è così e non mi impedirete mai di gridarlo al mondo. E non per me, ma per tutti coloro che, codardi, non hanno il coraggio di ribellarsi. Anche perché se lo fate a me, lo fate anche agli altri. Fino a che ci saranno centinaia di migliaia di giovani vittime che mi daranno ragione, voi sarete sempre dalla parte del torto. Avete un potere immeritato, non la ragione. Un ordine che dileggia il Potere del popolo sovrano. In Italia succede anche questo. Potete farmi passare per mitomane o pazzo. E’ nell’ordine delle cose: potrebbe andarmi peggio, come marcire in galera o peggio ancora. Potete, finché morte non ci separi, impedirmi di diventare avvocato. Farò vita eremitica e grama. Comunque, cari miei, vi piaccia o no, di magistrati ce ne sono più di dieci mila, criticati e non sono certo apprezzati; di avvocati più di 250 mila e questi, sì, disprezzati. Alla fine per tutti voi arriva comunque la Livella e l’oblio. Di Antonio Giangrande c’è uno solo. Si ama o si odia, ma fatevene un ragione: sarò per sempre una spina nel vostro fianco e sopravviverò a voi. Più mi colpite, più mi rendete altrettanto forte. Eliminarmi ora? E’ troppo tardi. Il virus della verità si diffonde. E ringraziate Dio che non ci sia io tra quei 945 parlamentari che vi vogliono molto, ma molto bene, che a parlar di voi si cagano addosso. Solo in Italia chi subisce un’ingiustizia non ha nessuno a cui rivolgersi, siano essi validi bocciati ai concorsi pubblici o innocenti in galera, che si chiamino Berlusconi o Sallusti o Mulè o Riva (e tutti questi li chiamano “persone influenti e potenti”). I nostri parlamentari non sanno nemmeno di cosa tu stia parlando, quando ti prestano attenzione. Ed è raro che ciò succeda. In fede Antonio Giangrande”.
Una denuncia per calunnia, abuso d’ufficio e diffamazione contro la Commissione d’esame di avvocato di Catania per tutelare l’immagine dei professionisti e di tutti i cittadini leccesi, tarantini e brindisini è quanto propone il dr Antonio Giangrande, presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie” (www.controtuttelemafie.it) e profondo conoscitore del fenomeno degli esami e dei concorsi pubblici truccati. Proposta presentata a tutti coloro che sono stati esclusi ed a tutti gli altri, anche non candidati all’esame di avvocato, che si sentono vittime di questo fenomeno di caccia alle streghe o che si sentano diffamati come rappresentanti e come cittadini del territorio, ormai sputtanato in tutta Italia. E proposta di presentazione del ricorso al Tar che sarebbe probabilmente accolto, tenuto conto dei precedenti al Consiglio di Stato.
«A Lecce sarebbero solo 440 su 1258 i compiti ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania, presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame: troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale, so che alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20 minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Da 20 anni denuncio che in Italia agli esami tutti si copia ed adesso scoprono l’acqua calda. E copiano tutti. Si ricordi il “Vergogna, Vergogna” all’esame per magistrato o il “Buffoni, Buffoni” all’esame di notaio, o le intemperanze agli esami per l’avvocatura di Stato o la prova annullata per l’esame di notaio nel 2010 o di magistrato nel 1992.
Le mie denunce sono state sempre archiviate ed io fatto passare per pazzo o mitomane.
Quindi chi si è abilitato barando, ha scoperto l’acqua calda. Questa caccia alle streghe, perché? Vagito di legalità? Manco per idea. In tempo di magra per i professionisti sul mercato, si fa passare per plagio, non solo la dettatura uniforme dell’intero elaborato (ripeto, che c’è sempre stata), ma anche l’indicazione della massima giurisprudenziale senza virgolette. Ergo: dov’è il dolo? Per chi opera in ambito giuridico le massime della Cassazione sono l’appiglio per tutte le tesi difensive di parte o accusatorie. Senza di queste sarebbero solo opinioni personali senza valore. Altra cosa è riportare pari pari, più che le massime, le motivazioni delle sentenze.
Prescindendo dalla caccia mirata alle streghe, c’è forse di più?
Ed allora i candidati esclusi alla prova scritta dell’esame di avvocato tenuta presso la Corte d’Appello di Lecce si rivolgano a noi per coordinare tutte le azioni di tutela: una denuncia per calunnia, abuso d’ufficio e per diffamazione contro tutti coloro che si son resi responsabili di una campagna diffamatoria ed un accanimento senza precedenti. Premo ricordare che l’esame è truccato insitamente e non bisogna scaricare sulla dignità e l’onore dei candidati gli interessi di una categoria corporativistica. Nessuno li difende i ragazzi, esclusi e denunciati (cornuti e mazziati) ma, dato che io c’ero e ci sono dal 1998, posso testimoniare che se plagio vi è stato, vi è sempre stato, e qualcuno ha omesso il suo intervento facendola diventare una consuetudine e quindi una norma da rispettare, e sono concorsi nel reato anche la commissione di Lecce ed il Presidente della Corte d’Appello, Mario Buffa, in quanto hanno agevolato le copiature. L’esame di avvocato in tutta Italia si apre alle 9 con la lettura delle tracce, che così finiscono in rete sul web. A Lecce l’esame non inizia mai prima delle undici. I ragazzi più furbi hanno tutto il tempo di copiare legalmente, in quanto l’esame non è ancora iniziato e quindi, se hanno copiato, non lo hanno fatto in quel frangente, perché non ci si può spostare dal banco. Anche se, devo dire, si è sempre permessa la migrazione per occupare posti non propri.
Su questi punti chiamerei a testimoniare, a rischio di spergiuro, tutti gli avvocati d’Italia.
Ai malfidati, poi, spiegherei per filo e per segno come si trucca l’esame, verbalmente, in testi ed in video.
Mi chiedo, altresì, perché tanto accanimento su Lecce se sempre si è copiato ed in tutta Italia? E perché non ci si impegna ha perseguire le commissioni che i compiti non li correggono e li dichiarano tali?
Ma la correzione era mirata al dare retti giudizi o si sono solo impegnati a fare opera inquisitoria e persecutoria?
Inoltre ci sono buone possibilità che il ricorso al Tar avverso all’esclusione possa essere accolto in base ai precedenti del Consiglio di Stato».
Sarebbe il colmo dei paradossi se tra quei 100 ci fosse il mio nome.
I commissari dovrebbero dimostrare che, in quei pochi minuti, la loro attenzione era rivolta, non a correggere ed a valutare i compiti, ma esclusivamente a cercare l’opera primaria, fonte del plagio, presentata come propria dal candidato, per verificarne l’esatta ed integrale corrispondenza.
Essi, al di là della foga persecutoria, dovrebbero dimostrare che la Premessa, la Tesi e l’Antitesi, le Conclusioni sono frutto di imitazione totale dell’altrui pensiero. Dovrebbero, altresì, dimostrare che il richiamo essenziale alle massime giurisprudenziali (spesso contrastanti tra loro) per suffragare la propria tesi e renderla convincente, siano anch’esse plagio, pur essendo ammessi i codici commentati dalla giurisprudenza, così come non lo sono per i magistrati e per i prossimi esami di avvocato (tempi di applicazione della riforma permettendo).
Dovrebbero, i commissari, dimostrare che quei pochi minuti sono bastati a loro per correggere, accusare e giudicare, rischiando si dichiarare il falso.
Sarebbe il colmo dei paradossi se tra quei 100 ci fosse il mio nome.
Io che ho denunciato e dimostrato che gli esami ed i concorsi pubblici sono truccati. Forse per questo per le mie denunce sono stato fatto passare per mitomane o pazzo ed ora anche per falsario.
Denigrare la credibilità delle vittime e farle passare per carnefici. Vergogna, gentaglia.
INDIZIONE DEL CONCORSO: spesso si indice un concorso quando i tempi sono maturi per soddisfare da parte dei prescelti i requisiti stabiliti (acquisizione di anzianità, titoli di studio, ecc.). A volte chi indice il concorso lo fa a sua immagine e somiglianza (perché vi partecipa personalmente come candidato). Spesso si indice il concorso quando non vi sono candidati (per volontà o per induzione), salvo il prescelto. Queste anomalie sono state riscontrate nei concorsi pubblici tenuti presso le Università e gli enti pubblici locali. Spesso, come è successo per la polizia ed i carabinieri, i vincitori rimangono casa.
COMMISSIONE D’ESAME: spesso a presiedere la commissione d’esame di avvocato sono personalità che hanno una palese incompatibilità. Per esempio nella Commissione d’esame centrale presso il Ministero della Giustizia del concorso di avvocato 2010 è stato nominato presidente colui il quale non poteva, addirittura, presiedere la commissione locale di Corte d’Appello di Lecce. Cacciato in virtù della riforma (decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180). La legge prevede che i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati non possono essere Commissari d’esame (e per conseguenza i nominati dal Consiglio locale per il Consiglio Nazionale Forense, che tra i suoi membri nomina il presidente di Commissione centrale). La riforma ha cacciato gli avvocati e sbugiardato i magistrati e professori universitari (in qualità anch’essi di commissari d’esame) perché i compiti vengono letti presso altre sedi: tutto questo perché prima tutti hanno raccomandato a iosa ed abusato del proprio potere dichiarando altresì il falso nei loro giudizi abilitativi od osteggiativi. Spesso le commissioni d’esame di avvocato sono mancanti delle componenti necessarie per la valutazione tecnica della materia d’esame. Essenziale nelle commissioni a cinque è la figura del magistrato, dell’avvocato, del professore universitario: se una manca, la commissione è nulla. Le Commissioni d’esame hanno sempre e comunque interessi amicali, familistiche e clientelari.
I CONCORSI FARSA: spesso i concorsi vengono indetti per sanare delle mansioni già in essere, come il concorso truffa a 1.940 posti presso l’INPS, bandito per sistemare i lavoratori socialmente utili già operanti presso l’Ente.
LE TRACCE: le tracce sono composte da personalità ministeriali scollegate alla realtà dei fatti. Ultimamente le tracce si riferiscono a massime giurisprudenziali espresse nell’imminenza della stilazione della traccia, quindi, in prossimità dell’esame. Quasi nessun testo recente, portato legalmente dai candidati, è talmente aggiornato da riportare quella massima. Altre volte si son riportate tracce con massime vecchissime e non corrispondenti con le riforme legislative successive. Sessione d’esame d’avvocato 2002-2003. Presidente di Commissione, Avv. Luigi Rella, Principe del Foro di Lecce. Ispettore Ministeriale, Giorgino. Sono stato bocciato. Il Ministero, alla prova di scritto di diritto penale, alla traccia n. 1, erroneamente chiede ai candidati cosa succede al Sindaco, che prima nega e poi rilascia una concessione edilizia ad un suo amico, sotto mentite spoglie di un’ordinanza. In tale sede i Commissari penalisti impreparati suggerivano in modo sbagliato. Solo io rilevavo che la traccia era errata, in quanto riferita a sentenze della Cassazione riconducibili a violazioni di legge non più in vigore. Si palesava l’ignoranza dell’art.107, D.Lgs. 267/00, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in cui si dispongono le funzioni dei dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01, Testo Unico in materia edilizia. Da molti anni, con le varie Bassanini, sono entrate in vigore norme, in cui si prevede che è competente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune a rilasciare o a negare le concessioni edilizie. Rilevavo che il Sindaco era incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava per scontato il comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con il Sindaco e conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla Magistratura. Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15 (il minimo) al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati che hanno scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei.
LE PROVE D’ESAME: spesso sono conosciute in anticipo. A volte sono pubblicate su internet giorni prima, come è successo per il concorso degli avvocati (con denuncia del sottosegretario Alfredo Mantovano di Lecce), dei dirigenti scolastici, o per l’accesso alle Università a numero chiuso (medicina), ovvero, come succede all’esame con più sedi (per esempio all’esame forense o per l’Agenzia delle Entrate, le tracce sono conosciute tramite cellulari o palmari in virtù del tardivo inizio delle prove in una sede rispetto ad altre. Si parla di ore di ritardo tra una sede ed un’altra). A volte le tracce sono già state elaborate in precedenza in appositi corsi, così come è successo all’esame di notaio. A volte le prove sono impossibili, come è successo al concorsone pubblico per insegnanti all’estero: 40 quesiti a risposta multipla dopo averli cercati, uno ad uno, in un volume di oltre 4mila che i partecipanti alla selezione hanno visto per la prima volta, leggere quattro testi in lingua straniera e rispondere alle relative domande. Il tutto nel tempo record di 45 minuti, comprese parti di testo da tradurre. Quasi 1 minuto a quesito.
MATERIALE CONSULTABILE: c’è da dire che intorno al materiale d’esame c’è grande speculazione e un grande salasso per le famiglie dei candidati, che sono rinnovati anno per anno in caso di reiterazione dell’esame a causa di bocciatura. Centinaia di euro per codici e materiale vario. Spesso, come al concorso di magistrato o di avvocato dello Stato ed in tutti gli altri concorsi, ad alcuni è permessa la consultazione di materiale vietato (codici commentati, fogliettini, fin anche compiti elaborati dagli stessi commissari) fino a che non scoppia la bagarre. Si ricordi il “Vergogna, Vergogna” all’esame per magistrato o il “Buffoni, Buffoni” all’esame di notaio, o le intemperanze agli esami per l’avvocatura di Stato o la prova annullata per l’esame di notaio nel 2010. Al concorso di avvocato, invece, è permesso consultare codici commentati con la giurisprudenza. Spesso, come succede al concorso di avvocato, sono proprio i commissari a dettare il parere da scrivere sull’elaborato, tale da rendere le prove dei candidati uniformi e nonostante ciò discriminati in sede di correzione. Il caso esemplare è lo scandalo di Catanzaro: oltre duemila compiti-fotocopia. Su 2301 prove scritte per l’accesso all’albo degli avvocati consegnate a metà dicembre del 1997 alla commissione d’esame di Catanzaro, ben 2295 risultano identiche. Soltanto sei elaborati, cioè lo 0,13 per cento del totale, appare non copiato. Compiti identici, riga per riga, parola per parola. Le tre prove di diritto civile, diritto penale e atti giudiziari non mettono in risalto differenze. Sono uguali anche negli errori: tutti correggono l’avverbio «recisamente» in «precisamente». Una concorrente rivela che un commissario avrebbe letteralmente dettato lo svolgimento dei temi ai candidati. Racconta: «Entra un commissario e fa: “scrivete”. E comincia a dettare il tema, piano piano, per dar modo a tutti di non perdere il filo». «Che imbecilli quelli che hanno parlato, sono stati loro a incasinare tutto. Se non avessero piantato un casino sarebbe andato tutto liscio», dice una candidata, che poi diventerà avvocato e probabilmente commissario d’esame, che rinnegherà il suo passato e che accuserà di plagio i nuovi candidati. L’indagine è affidata ai pm Luigi de Magistris e Federica Baccaglini, che ipotizzano il reato di falso specifico e inviano ben 2295 avvisi di garanzia. Catanzaro non è l’unica mecca delle toghe: le fa concorrenza anche Reggio Calabria che, tra l’altro, nel 2001 promuove il futuro ministro dell’Istruzione per il Pdl Mariastella Gelmini in trasferta da Brescia. Ma Catanzaro è da Guinness dei primati. I candidati arrivano da tutta Italia, e i veri intoccabili soprattutto dalle sedi del Nord dove gli esami sono molto selettivi per impedire l’accesso di nuovi avvocati nel mercato saturo. Gli aspiranti avvocati milanesi o torinesi risultano residenti a Catanzaro per i sei mesi necessari per il tirocinio, svolto in studi legali del luogo, i quali certificano il praticantato dei futuri colleghi. Frotte di giovani si fanno consigliare dove e come chiedere ospitalità. In città esistono numerose pensioni e alloggi, oltre a cinque alberghi, che periodicamente accolgono con pacchetti scontati i pellegrini forensi. Tutti sanno come funziona e nessuno se ne lamenta. L’omertà è totale. I magistrati interrogano gruppi di candidati dell’esame del dicembre 1997, che rispondono all’unisono: «Mi portai sovente in bagno per bisogni fisiologici […]. Non so spiegare la coincidenza tra gli elaborati da me compilati e quelli esibiti. Mi preme tuttavia evidenziare che qualcuno potrebbe avermi copiato durante la mia assenza». Mentre il procedimento giudiziario avanza a fatica per la difficoltà di gestire un numero così grande di indagati, tutti gli aspiranti avvocati dell’esame del 1997 rifanno le prove nel 1998 nel medesimo posto e sono promossi. Dopo otto anni di indagini e rinvii, nell’estate 2005 il pm Federico Sergi, nuovo titolare dell’indagine, chiede e ottiene per ciascuno il «non luogo a procedere per avvenuta prescrizione». Tutto finito. Ultimamente le tracce si riferiscono a massime giurisprudenziali espresse nell’imminenza della stilazione della traccia, quindi, in prossimità dell’esame. Quasi nessun testo recente, portato legalmente dai candidati, è talmente aggiornato da riportare quella massima. Ecco perché i commissari d’esame, con coscienza e magnanimità, aiutano i candidati. Altrimenti nessuno passerebbe l’esame. I commissari dovrebbero sapere quali sono le fonti di consultazioni permesse e quali no. Per esempio all’esame di avvocato può capitare che il magistrato commissario d’esame, avendo fatto il suo esame senza codici commentati, non sappia che per gli avvocati ciò è permesso. I commissari d’esame dovrebbero dimostrare che, in quei pochi minuti, la loro attenzione era rivolta, non a correggere ed a valutare i compiti, ma esclusivamente a cercare l’opera primaria, fonte del plagio, presentata come propria dal candidato, per verificarne l’esatta ed integrale corrispondenza. Essi, al di là della foga persecutoria, dovrebbero dimostrare che la Premessa, la Tesi e l’Antitesi, le Conclusioni sono frutto di imitazione totale dell’altrui pensiero. Dovrebbero, altresì, dimostrare che il richiamo essenziale alle massime giurisprudenziali (spesso contrastanti tra loro) per suffragare la propria tesi e renderla convincente, siano anch’esse plagio, pur essendo ammessi i codici commentati dalla giurisprudenza, così come non lo sono per i magistrati e per i prossimi esami di avvocato (tempi di applicazione della riforma permettendo). Dovrebbero, i commissari, dimostrare che quei pochi minuti sono bastati a loro per correggere, accusare e giudicare, rischiando si dichiarare il falso. Impuniti, invece sono coloro che veramente copiano integralmente i compiti. In principio era la vecchia “cartucciera” la fascia di stoffa da stringere in vita con gli involtini. Poi il vocabolario farcito d'ogni foglio e foglietto, giubbotti imbottiti di cultura bignami e addirittura scarpe con suola manoscritta. Oggi i metodi per “aiutarsi” durante gli esami sono più tecnologici: il telefonino, si sa, non si può portare, ma lo si porta lo stesso. Al massimo, se c’è la verifica, lo metti sul tavolo della commissione. Quindi non è malsana l'idea dell'iPhone sul banco, collegato a Wikipedia e pronto a rispondere ad ogni quesito nozionistico. Comunque bisogna attrezzarsi, in maniera assolutamente diversa. La rete e i negozi di cartolibreria vendono qualsiasi accrocchio garantendo si tratti della migliore soluzione possibile per copiare durante le prove scritte. C'è ad esempio la penna UV cioè a raggi ultravioletti scrive con inchiostro bianco e si legge passandoci sopra un led viola incluso nel corpo della penna. Inconveniente: difficile non far notare in classe una luce da discoteca. Poi c'è la cosiddetta penna-foglietto: nel corpo della stilo c'è un foglietto avvolto sul quale si è scritto precedentemente formule, appunti eccetera. Foglietto che in men che non si dica si srotola e arrotola. E infine, c'è l'ormai celebre orologio-biglietto col display elettronico e una porta Usb sulla quale caricare testi d'ogni tipo.
IL MATERIALE CONSEGNATO: il compito dovrebbe essere inserito in una busta da sigillare contenente un’altra busta chiusa con inserito il nome del candidato. Non ci dovrebbero essere segni di riconoscimento. Non è così come insegna il concorso di notaio. Oltre ai segni di riconoscimento posti all’interno (nastri), i commissari firmano in modo diverso i lembi di chiusura della busta grande consegnata.
LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI. Quanto già indicato sono i trucchi che i candidati possono vedere ed eventualmente denunciare. Quanto avviene in sede di correzione è lì la madre di tutte le manomissioni. Proprio perchè nessuno vede. La norma prevede che la commissione d’esame (tutti i componenti) partecipi alle fasi di:
• apertura della busta grande contenente gli elaborati;
• lettura del tema da parte del relatore ed audizione degli altri membri;
• correzione degli errori di ortografia, sintassi e grammatica;
• richiesta di chiarimenti, valutazione dell’elaborato affinchè le prove d’esame del ricorrente evidenzino un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico, anche sotto il profilo più strettamente tecnico-giuridico, e che anche la soluzione delle problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzino un corretto approccio a problematiche complesse;
• consultazione collettiva, interpello e giudizio dei singoli commissari, giudizio numerico complessivo, motivazione, sottoscrizione;
• apertura della busta piccola contenete il nome del candidato da abbinare agli elaborati corretti;
• redazione del verbale.
Queste sono solo fandonie normative. Di fatto si apre prima la busta piccola, si legge il nome, se è un prescelto si dà agli elaborati un giudizio positivo, senza nemmeno leggerli. Quando i prescelti sono pochi rispetto al numero limite di idonei stabilito illegalmente, nonostante il numero aperto, si aggiungono altri idonei diventati tali “a fortuna”.
La riforma del 2003 ha cacciato gli avvocati e sbugiardato i magistrati e professori universitari (in qualità anch’essi di commissari d’esame) perché i compiti vengono letti presso altre sedi: tutto questo perché prima tutti hanno raccomandato a iosa ed abusato del proprio potere dichiarando altresì il falso nei loro giudizi abilitativi od osteggiativi. Spesso le commissioni d’esame sono mancanti delle componenti necessarie per la valutazione tecnica della materia d’esame. Le Commissioni d’esame hanno sempre e comunque interessi amicali, familistiche e clientelari. Seguendo una crescente letteratura negli ultimi anni abbiamo messo in relazione l’età di iscrizione all’albo degli avvocati con un indice di frequenza del cognome nello stesso albo. In particolare, per ogni avvocato abbiamo calcolato la frequenza del cognome nell’albo, ovvero il rapporto tra quante volte quel cognome vi appare sul totale degli iscritti, in relazione alla frequenza dello stesso cognome nella popolazione. In media, il cognome di un avvocato appare nell’albo 50 volte di più che nella popolazione. Chi ha un cognome sovra-rappresentato nell’albo della sua provincia diventa avvocato prima. Infine vi sono commissioni che, quando il concorso è a numero aperto, hanno tutto l’interesse a limitare il numero di idonei per limitare la concorrenza: a detta dell’economista Tito Boeri: «Nelle commissioni ci sono persone che hanno tutto da perderci dall’entrata di professionisti più bravi e più competenti».
Paola Severino incoraggia gli studenti e racconta: “Anch’io la prima volta fui bocciata all’esame per diventare avvocato”. Raccontare una propria disavventura per infondere coraggio alle nuove generazioni. Questa è la tecnica adottata dal Ministro della Giustizia Paola Severino con i ragazzi della «Summer School» promossa dalla Fondazione Magna Charta di Gaetano Quagliariello e Maurizio Gasparri. “Cari ragazzi, non dovete scoraggiarvi perché anch’io la prima volta fui bocciata all’esame per diventare avvocato… Quella volta ero con il mio futuro marito: lui fu promosso e io non ce la feci… Ma eccoci ancora qua. Siamo sposati da tanti anni” ha raccontato di fronte ai futuri avvocati puntando tutto sulla love story e omettendo che, nonostante quella bocciatura, sarà titolare fino a novembre di uno degli studi legali più importanti d’Italia (con cifre che si aggirano intorno ai 7 milioni di euro). Una piccola consolazione non solo per i laureati in legge, ma anche per tutte le future matricole che sosterranno i test di ammissione. In fondo anche Albert Einstein venne bocciato. E a quanto pare anche la Severino. Bisognerebbe, però, chiedere al ministro: gli amorosi l’aiuto se lo son dato vicendevolmente ed i compiti sicuramente erano simili, quindi perché un diverso giudizio?
In quei mesi di tormenti a cavallo tra il 2000 e il 2001 la Mariastella Gelmini si trova dunque a scegliere, spiegherà essa stessa a Flavia Amabile de “La Stampa.it”: «La mia famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri, nulla. C'era una logica di casta». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la tentazione era forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo deciso di farlo anche noi». E l'esame? Com'è stato l'esame? Quasi 57% di ammessi agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia. Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno.
Quello per giudici e pm resta uno dei concorsi più duri. Dopo la laurea occorrono oltre due anni di preparazione negli studi forensi. Oppure nelle scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali. Sui 3.193 candidati che nel novembre 2008 hanno consegnato i tre scritti di diritto amministrativo, penale e civile, la commissione ha mandato agli orali soltanto 309 aspiranti magistrati. Per poi promuoverne 253. Nonostante i quasi due anni di prove e correzioni e i soldi spesi, il ministero non è nemmeno riuscito a selezionare i 500 magistrati previsti dal concorso. E tanto attesi negli uffici giudiziari di tutta Italia. Se questi sono i risultati dei corsi di formazione post-laurea, il fallimento degli obiettivi è totale. Eppure almeno cinque tra i 28 commissari sono stati scelti dal ministro Alfano proprio tra quanti hanno insegnato nelle scuole di specializzazione per le professioni legali. "I componenti della commissione rispondono che il livello degli elaborati non ammessi era basso", dice l'avvocato Anna Sammassimo, dell'Unione giuristi cattolici: "Ma alla lettura degli elaborati dichiarati idonei si resta perplessi e molto. Tanto più che i curricula dei candidati esclusi destano ammirazione. Dal verbale da me visionato, il 227, risulta che la correzione dei tre elaborati di ciascun candidato ha impegnato la sottocommissione per circa 30 minuti: per leggere tre temi di tre materie, discuterne e deciderne il voto o la non idoneità sembra obiettivamente un po' poco". Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati.
Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio.
Di scandali per i compiti non corretti, ma ritenuti idonei, se ne è parlato.
Nel 2008 un consigliere del Tar trombato al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si è preso la briga di controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette le sue prove, scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza di 690 pagine. "Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette, significa che hanno letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record da guinness, visto che la materia è complessa", ironizza Alessio Liberati. Che ha impugnato anche i concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori hanno proposto stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa identica sentenza. Il magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori, Roberto Giovagnoli, non aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso. L'esposto viene palleggiato da mesi tra lo stesso Consiglio di Stato e la presidenza del Consiglio dei ministri, ma i dubbi e "qualche perplessità" serpeggiano anche tra alcuni consiglieri. "Il bando sembra introdurre l'ulteriore requisito dell'anzianità quinquennale" ha messo a verbale uno di loro durante una sessione dell'organo di presidenza: "Giovagnoli era stato dirigente presso la Corte dei conti per circa 6 mesi (...) Il bando non sembra rispettato su questo punto". Per legge, a decidere se i concorsi siano stati o meno taroccati, saranno gli stessi membri del Consiglio. Vedremo.
In effetti, con migliaia di ricorsi al TAR si è dimostrato che i giudizi resi sono inaffidabili. La carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del giudizio negativo reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti, ecc., o comunque la infondatezza dei giudizi assunti, tale da suffragare e giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò denota l’assoluta discrasia tra giudizio e contenuto degli elaborati, specie se la correzione degli elaborati è avvenuta in tempi insufficienti, tali da rendere un giudizio composito. Tempi risibili, tanto da offendere l’umana intelligenza. Dai Verbali si contano 1 o 2 minuti per effettuare tutte le fasi di correzione, quando il Tar di Milano ha dichiarato che ci vogliono almeno 6 minuti solo per leggere l’elaborato. La mancanza di correzione degli elaborati ha reso invalido il concorso in magistratura. Per altri concorsi, anche nella stessa magistratura, il ministero della Giustizia ha fatto lo gnorri e si è sanato tutto, alla faccia degli esclusi. Già nel 2005 candidati notai ammessi agli orali nonostante errori da somari, atti nulli che vengono premiati con buoni voti, mancata verbalizzazione delle domande, elaborati di figli di professionisti ed europarlamentari prima considerati “non idonei” e poi promossi agli orali. Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio. Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati. O ancora l’esame di ammissione all’albo dei giornalisti professionisti del 1991, audizione riscontrabile negli archivi di radio radicale, quando la presenza di un folto gruppo di raccomandati venne scoperta per caso da un computer lasciato acceso nella sala stampa del Senato proprio sul file nel quale il caposervizio di un’agenzia, commissario esaminatore, aveva preso nota delle prime righe dei temi di tutti quelli da promuovere. E ancora lo scandalo denunciato da un’inchiesta del 14 maggio 2009 apparsa su “La Stampa”. A finire sotto la lente d’ingrandimento del quotidiano torinese l’esito del concorso per allievi per il Corpo Forestale. Tra i 500 vincitori figli di comandanti, dirigenti, uomini di vertice. La casualità ha voluto, inoltre, che molti dei vincitori siano stati assegnati nelle stazioni dove comandano i loro genitori. Una singolare coincidenza che diventa ancor più strana nel momento in cui si butta un occhio ad alcuni “promemoria”, sotto forma di pizzini, ritrovati nei corridoi del Corpo forestale e in cui sono annotati nomi, cognomi, date di nascita e discendenze di alcuni candidati. «Per Alfonso, figlio di Rosetta», «Per Emidio, figlio di Cesarina di zio Antonio», «Per Maria, figlia di Raffaele di zia Maria». Piccole annotazioni, certo. Il destino, però, ha voluto che le tutte persone segnalate nei pizzini risultassero vincitrici al concorso.
GLI ESCLUSI, RIAMMESSI. Candidati che sono stati esclusi dalla prova per irregolarità, come è successo al concorso per Dirigenti scolastici, o giudicati non idonei, che poi si presentano regolarmente agli orali. L’incipit della confidenza di Elio Belcastro, parlamentare dell’Mpa di Raffaele Lombardo, pubblicata su “Il Giornale”. Belcastro ci fa subito capire, scandendo bene le parole, che Tonino non era nemmeno riuscito a prenderlo quel voto, minimo. «Tempo fa l’ex procuratore capo di Roma, Felice Filocamo, che di quella commissione d’esami era il segretario, mi ha raccontato che quando Carnevale si accorse che i vari componenti avevano bocciato Di Pietro, lo chiamò e si arrabbiò molto. Filocamo fu costretto a tornare in ufficio, a strappare il compito del futuro paladino di Mani pulite e a far sì che, non saprei dire come, ottenesse il passaggio agli orali, seppur con il minimo dei voti». Bocciato e ripescato? Magistrato per un falso? Possibile? Non è l’unico caso. Era già stato giudicato non idoneo, ma in una seconda fase sarebbero saltati fuori degli strani fogli aggiuntivi che prima non c’erano. Ecco come sarebbe sorto il sospetto che qualcuno li avesse inseriti per “salvare” il candidato già bocciato, in modo da giustificare una valutazione diversa oppure da consentire un successivo ricorso al TAR. I maggiori quotidiani nazionali e molti locali, ed anche tanti periodici, si sono occupati di tale gravissimo fatto, e che è stato individuato con nome e cognome il magistrato (una donna) in servizio a Napoli quale autore del broglio accertato. Per tale episodio il CSM ha deciso di sospendere tale magistrato dalle funzioni e dallo stipendio. In quella sessione a fronte di 350 candidati ammessi alle prove orali pare che oltre 120 siano napoletani, i quali sembrano avere particolari attitudini naturali verso le scienze giuridiche e che sembrano essere particolarmente facilitati nel loro cammino anche dalla numerosa presenza nella commissione di esami di magistrati e professori napoletani.
TUTELA AMMINISTRATIVA: non è ammesso ricorso amministrativo gerarchico. Sessione d’esame d’avvocato 2002-2003. Presidente di Commissione, Avv. Luigi Rella, Principe del Foro di Lecce. Ispettore Ministeriale, Giorgino. Sono stato bocciato. Il Ministero, alla prova di scritto di diritto penale, alla traccia n. 1, erroneamente chiede ai candidati cosa succede al Sindaco, che prima nega e poi rilascia una concessione edilizia ad un suo amico, sotto mentite spoglie di un’ordinanza. In tale sede i Commissari penalisti impreparati suggerivano in modo sbagliato. Solo io rilevavo che la traccia era errata, in quanto riferita a sentenze della Cassazione riconducibili a violazioni di legge non più in vigore. Si palesava l’ignoranza dell’art.107, D.Lgs. 267/00, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in cui si dispongono le funzioni dei dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01, Testo Unico in materia edilizia. Da molti anni, con le varie Bassanini, sono entrate in vigore norme, in cui si prevede che è competente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune a rilasciare o a negare le concessioni edilizie. Rilevavo che il Sindaco era incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava per scontato il comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con il Sindaco e conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla Magistratura. Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15 (il minimo) al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati che hanno scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei. Il presidente di Commissione d’esame di Lecce, ricevendo il ricorso amministrativo gerarchico contro l’esito della valutazione della sottocommissione, non ha risposto entro i trenta giorni (nemmeno per il diniego) impedendomi di presentare ricorso al Tar.
TUTELA GIUDIZIARIA. Un ricorso al TAR non si nega a nessuno: basta pagare la tangente delle spese di giudizio. Per veder accolto il ricorso basta avere il principe del Foro amministrativo del posto; per gli altri non c’è trippa per gatti. Cavallo di battaglia: mancanza della motivazione ed illogicità dei giudizi. Nel primo caso, dovendo accertare un’ecatombe dei giudizi, la Corte Costituzionale, con sentenza 175 del 2011, ha legittimato l’abuso delle commissioni: “buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni sottese ad un giudizio di non idoneità, sia per i tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia per il numero dei partecipanti alle prove”. Così la Corte Costituzionale ha sancito, il 7 giugno 2011, la legittimità costituzionale del cd. “diritto vivente”, secondo cui sarebbe sufficiente motivare il giudizio negativo, negli esami di abilitazione, con il semplice voto numerico. La Corte Costituzionale per ragion di Stato (tempi ristretti ed elevato numero) afferma piena fiducia nelle commissioni di esame (nonostante la riforma e varie inchieste mediatiche e giudiziarie ne minano la credibilità), stabilendo una sorta d’infallibilità del loro operato e di insindacabilità dei giudizi resi, salvo che il sindacato non promani in sede giurisdizionale. I candidati, quindi, devono sperare nel Foro presso cui vi sia tutela della meritocrazia ed un certo orientamento giurisprudenziale a favore dei diritti inviolabili del candidato, che nella massa è ridimensionato ad un semplice numero, sia di elaborato, sia di giudizio. Giudizi rapidi e sommari, che spesso non valorizzano le capacità tecniche e umane che da un’attenta lettura dell’elaborato possono trasparire. Fatto assodato ed incontestabile il voto numerico, quale giudizio e motivazione sottesa. Esso deve, però, riferire ad elementi di fatto corrispondenti che supportino quel voto. Elementi di fatto che spesso mancano o sono insussistenti. All’improvvida sentenza della Corte Costituzionale viene in soccorso la Corte di Cassazione. Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione. In sostanza il TAR può scendere sul terreno delle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici per l’accesso a una professione o in un concorso pubblico, quando il giudizio è viziato da evidente illogicità e da travisamento del fatto. Ad affermare l’importante principio di diritto sono le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 8412, depositata il 28 maggio 2012. Insomma, la Cassazione afferma che le commissioni deviano il senso della norma concorsuale.
Sì, il Tar può salvare tutti, meno che Antonio Giangrande. Da venti anni inascoltato Antonio Giangrande denuncia il malaffare di avvocati e magistrati ed il loro malsano accesso alla professione. Cosa ha ottenuto a denunciare i trucchi per superare l’esame? Prima di tutto l’ostracismo all’abilitazione. Poi, insabbiamento delle denunce contro i concorsi truccati ed attivazione di processi per diffamazione e calunnia, chiusi, però, con assoluzione piena. Intanto ti intimoriscono. Ed anche la giustizia amministrativa si adegua. A parlar delle loro malefatte i giudici amministrativi te la fanno pagare. Presenta l’oneroso ricorso al Tar di Lecce (ma poteva essere qualsiasi altro Tribunale Amministrativo Regionale) per contestare l’esito negativo dei suoi compiti all’esame di avvocato: COMMISSIONE NAZIONALE D'ESAME PRESIEDUTA DA CHI NON POTEVA RICOPRIRE L'INCARICO, COMMISSARI (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI) DENUNCIATI CHE GIUDICANO IL DENUNCIANTE E TEMI SCRITTI NON CORRETTI, MA DA 15 ANNI SONO DICHIARATI TALI. Ricorso, n. 1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro il voto numerico insufficiente (25,25,25) dato alle prove scritte di oltre 4 pagine cadaune della sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda di fissazione dell’udienza di trattazione. Tale ricorso non ha prodotto alcun giudizio nei tempi stabiliti, salvo se non il diniego immediato ad una istanza cautelare di sospensione, tanto da farlo partecipare, nelle more ed in pendenza dell’esito definitivo del ricorso, a ben altre due sessioni successive, i cui risultati sono stati identici ai temi dei 15 anni precedenti (25,25,25): compiti puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più punti. Per l’inerzia del Tar si è stati costretti a presentare istanza di prelievo il 09/07/2012. Inspiegabilmente nei mesi successivi all’udienza fissata e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Eccetto qualcuno che non poteva essere accolto, tra i quali i ricorsi dell'avv. Carlo Panzuti e dell'avv. Angelo Vantaggiato in cui si contestava il giudizio negativo reso ad un elaborato striminzito di appena una pagina e mezza. Solo in data 7 febbraio 2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a supporto del ricorso. I magistrati amministrativi potranno dire che a loro insindacabile giudizio il ricorso di Antonio Giangrande va rigettato, ma devono spiegare a chi in loro pone fiducia, perché un ricorso presentato il 25 luglio 2011, deciso il 7 novembre 2012, viene notificato il 7 febbraio 2013? Un'attenzione non indifferente e particolare e con un risultato certo e prevedibile, se si tiene conto che proprio il presidente del Tar era da considerare incompatibile perchè è stato denunciato dal Giangrande e perché le sue azioni erano oggetto di inchiesta video e testuale da parte dello stesso ricorrente? Le gesta del presidente del Tar sono state riportate da Antonio Giangrande, con citazione della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la città di Lecce. Come per dire: chi la fa, l'aspetti?
In Italia tutti sanno che i concorsi pubblici sono truccati e nessuno fa niente, tantomeno i magistrati. Gli effetti sono che non è la meritocrazia a condurre le sorti del sistema Italia, ma l’incompetenza e l’imperizia. Non ci credete o vi pare un’eresia? Basta dire che proprio il Consiglio Superiore della Magistratura, dopo anni di giudizi amministrativi, è stato costretto ad annullare un concorso già effettuato per l’accesso alla magistratura. Ed i candidati ritenuti idonei? Sono lì a giudicare indefessi ed ad archiviare le denunce contro i concorsi truccati. E badate, tra i beneficiari del sistema, vi sono nomi illustri.
Certo che a qualcuno può venire in mente che comunque una certa tutela giuridica esiste. Sì, ma dove? Ma se già il concorso al TAR è truccato. Nel 2008 un consigliere del Tar trombato al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si è preso la briga di controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette le sue prove, scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza di 690 pagine. “Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette, significa che hanno letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record da guinness, visto che la materia è complessa”, ironizza Alessio Liberati. Che ha impugnato anche i concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori hanno proposto stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa identica sentenza. Il magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori, Roberto Giovagnoli, non aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso. Mentre il Governo rifiuta da mesi di rispondere alle varie interrogazioni parlamentari sul concorso delle mogli (il concorso per magistrati Tar vinto da Anna Corrado e Paola Palmarini, mogli di due membri dell’organo di autogoverno che ne nominò la commissione) si è svolto un altro – già discusso – concorso per l’accesso al Tar. Nonostante l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi (Consiglio di Presidenza – Cpga) si sia stretto in un imbarazzante riserbo, che davvero stride con il principio di trasparenza che i magistrati del Tar e del Consiglio di Stato sono preposti ad assicurare controllando l’operato delle altre amministrazioni, tra i magistrati amministrativi si vocifera che gli elaborati scritti del concorso sarebbero stati sequestrati per mesi dalla magistratura penale, dopo aver sorpreso un candidato entrato in aula con i compiti già svolti, il quale avrebbe già patteggiato la pena. Dopo il patteggiamento la commissione di concorso è stata sostituita completamente ed è ricominciata la correzione dei compiti. Si è già scritto della incredibile vicenda processuale del dott. Enrico Mattei, fratello di Fabio Mattei (oggi membro dell’organo di autogoverno), rimesso “in pista” nel precedente concorso c.d. delle mogli grazie ad una sentenza del presidente del Tar Lombardia, assolutamente incompetente per territorio, che, prima di andare in pensione coinvolto dallo scandalo della c.d. cricca, si era autoassegnato il ricorso ed aveva ammesso a partecipare al concorso il Mattei, redigendo addirittura una sentenza breve (utilizzabile solo in caso di manifesta fondatezza), poco dopo stroncata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6190/2008), che ha rilevato perfino l’appiattimento lessicale della motivazione della decisione rispetto alle memorie difensive presentate dal Mattei. Dopo il concorso delle mogli e il caso Mattei, un altro concorso presieduto da Pasquale De Lise è destinato a far parlare di sé. Si sono infatti concluse le prove scritte del concorso per 4 posti a consigliere di Stato, presieduto da una altisonante commissione di concorso: il presidente del Consiglio di Stato (Pasquale De Lise), il presidente aggiunto del Consiglio di Stato (Giancarlo Coraggio), il presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia (Riccardo Virgilio), il preside della facoltà di giurisprudenza (Carlo Angelici) ed un presidente di sezione della Corte di Cassazione (Luigi Antonio Rovelli). Ma anche il concorso al Consiglio di Stato non è immune da irregolarità. Tantissime le violazioni di legge già denunciate all’organo di autogoverno: area toilettes non sigillata e accessibile anche da avvocati e magistrati durante le prove di concorso, ingresso a prove iniziate di pacchi non ispezionati e asseritamente contenenti cibi e bevande, ingresso di estranei nella sala durante le prove di concorso, uscita dei candidati dalla sala prima delle due ore prescritte dalla legge, mancanza di firma estesa dei commissari di concorso sui fogli destinati alle prove, presenza di un solo commissario in aula. Tutti vizi, questi, in grado di mettere a rischio la validità delle prove. Qual è l’organo deputato a giudicare, in caso di ricorso, sulla regolarità del concorso per consigliere di Stato? Il Consiglio di Stato… naturalmente! Ecco perché urge una riforma dei concorsi pubblici. Riforma dove le lobbies e le caste non ci devono mettere naso. E c’è anche il rimedio. Niente esame di abilitazione. Esame di Stato contestuale con la laurea specialistica. Attività professionale libera con giudizio del mercato e assunzione pubblica per nomina del responsabile politico o amministrativo che ne risponde per lui (nomina arbitraria così come di fatto è già oggi). E’ da vent’anni che Antonio Giangrande studia il fenomeno dei concorsi truccati. Anche la fortuna fa parte del trucco, in quanto non è tra i requisiti di idoneità. Qualcuno si scandalizzerà. Purtroppo non sono generalizzazioni, ma un dato di fatto. E da buon giurista, consapevole del fatto che le accuse vanno provate, pur in una imperante omertà e censura, l’ha fatto. In video ed in testo. Se non basta ha scritto un libro, tra i 50, da leggere gratuitamente su www.controtuttelemafie.it o su Google libri o in ebook su Amazon.it o cartaceo su Lulu.com. Invitando ad informarsi tutti coloro che, ignoranti o in mala fede, contestano una verità incontrovertibile, non rimane altro che attendere: prima o poi anche loro si ricrederanno e ringrazieranno iddio che esiste qualcuno con le palle che non ha paura di mettersi contro Magistrati ed avvocati. E sappiate, in tanti modi questi cercano di tacitare Antonio Giangrande, con l’assistenza dei media corrotti dalla politica e dall’economia e genuflessi al potere. Ha perso le speranze. I praticanti professionali sono una categoria incorreggibile: “so tutto mi”, e poi non sanno un cazzo, pensano che essere nel gota, ciò garantisca rispetto e benessere. Che provino a prendere in giro chi non li conosce. La quasi totalità è con le pezze al culo e genuflessi ai Magistrati. Come avvoltoi a buttarsi sulle carogne dei cittadini nei guai e pronti a vendersi al miglior offerente. Non è vero? Beh! Chi esercita veramente sa che nei Tribunali, per esempio, vince chi ha più forza dirompente, non chi è preparato ed ha ragione. Amicizie e corruttele sono la regola. Naturalmente per parlare di ciò, bisogna farlo con chi lavora veramente, non chi attraverso l’abito, cerca di fare il monaco.
Un esempio per tutti di come si legifera in Parlamento, anche se i media lo hanno sottaciuto. La riforma forense, approvata con Legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra gli ultimi interventi legislativi consegnatici frettolosamente dal Parlamento prima di cessare di fare danni. I nonni avvocati in Parlamento (compresi i comunisti) hanno partorito, in previsione di un loro roseo futuro, una contro riforma fatta a posta contro i giovani. Ai fascisti che hanno dato vita al primo Ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36) questa contro riforma reazionaria gli fa un baffo. Trattasi di una “riforma”, scritta come al solito negligentemente, che non viene in alcun modo incontro ed anzi penalizza in modo significativo i giovani.
In tema di persecuzione giudiziaria, vi si racconta una favola e per tale prendetela.
C‘era una volta in un paese ridente e conosciuto ai più come il borgo dei sognatori, un vecchietto che andava in bicicletta per la via centrale del paese. Il vecchietto non era quello che in televisione indicano come colui che buttava le bambine nei pozzi. In quel frangente di tempo una sua coetanea, avendo parcheggiato l’auto in un tratto di strada ben visibile, era in procinto di scendere, avendo aperto la portiera. Ella era sua abitudine, data la sua tarda età, non avere una sua auto, ma usare l’auto della nipote o quella simile del fratello. Auto identiche in colore e marca. Il vecchietto, assorto nei suoi pensieri, investe lo sportello aperto dell’auto e cade. Per sua fortuna, a causa della bassa velocità tenuta, la caduta è indolore. Assicurato alla signora che nulla era accaduto, il vecchietto inforca la bicicletta e va con le sue gambe. Dopo poco tempo arriva alla signora da parte del vecchietto una richiesta di risarcimento danni, su mandato dato allo studio legale di sua figlia. L’assicurazione considera che sia inverosimile la dinamica indicata ed il danno subito e ritiene di non pagare.
Dopo due anni arriva una citazione da parte di un’altro avvocato donna. Una richiesta per danni tanto da farsi ricchi. Ma non arriva alla vecchietta, ma a sua nipote. Essa indica esattamente l’auto, la zona del sinistro e la conducente, accusando la nipote di essere la responsabile esclusiva del sinistro.
E peccato, però, che nessun testimone in giudizio ha riconosciuto la targa, pur posti a pochi metri del fatto; che nessun testimone in giudizio ha riconosciuto l’auto distinguendola da quella simile; che nessun testimone in giudizio ha disconosciuto la vecchietta come protagonista; che nessun testimone in giudizio ha ammesso che vi siano stati conseguenze per la caduta.
E peccato, però, che l’auto non era in curva, come da essa indicato.
Peccato, però, che la responsabile del sinistro non fosse quella chiamata in giudizio, ma la vecchietta di cui sopra.
Una prima volta sbaglia il giudice competente ed allora cambia l’importo, riproponendo la domanda.
Tutti i giudici di pace ed onorari (avvocati) fanno vincere la causa del sinistro fantasma alla collega.
La tapina chiamata in causa afferma la sua innocenza e presenta una denuncia contro l’avvocato. La poveretta, che poteva essere querelata per lesioni gravissime, si è cautelata. La sua denuncia è stata archiviata, mentre contestualmente, alla stessa ora, i testimoni venivano sentiti alla caserma dei carabinieri.
La poveretta non sapeva che l’avvocato denunciato era la donna del pubblico ministero, il cui ufficio era competente sulla denuncia contro proprio l’avvocato.
Gli amorosi cosa hanno pensato per tacitare chi ha osato ribellarsi? L’avvocato denuncia per calunnia la poveretta, ingiustamente accusata del sinistro, la procura la persegue e gli amici giudici la condannano.
L’appello sacrosanto non viene presentato dagli avvocati, perché artatamente ed in collusione con la contro parte sono fatti scadere i termini. L’avvocato amante del magistrato altresì chiede ed ottiene una barca di soldi di danni morali.
La poveretta ha due fratelli: uno cattivo, amico e succube di magistrati ed avvocati, che le segue le sue cause e le perde tutte: uno buono che è conosciuto come il difensore dei deboli contro i magistrati e gli avvocati. I magistrati le tentano tutte per condannarlo: processi su processi. Ma non ci riescono, perché è innocente e le accuse sono inventate. L’unica sua colpa è ribellarsi alle ingiustizie su di sé o su altri. Guarda caso il fratello buono aveva denunciato il magistrato amante dell’avvocato donna di cui si parla. Magistrato che ha archiviato la denuncia contro se stesso.
La procura ed i giudici accusano anche il fratello buono di aver presentato una denuncia contro l’avvocato e di aver fatto conoscere la malsana storia a tutta l’Italia. Per anni si cerca la denuncia: non si trova. Per anni si riconduce l’articolo a lui: non è suo.
Il paradosso è che si vuol condannare per un denuncia, che tra tante, è l’unica non sua.
Il paradosso è che si vuol condannare per un articolo, che tra tanti (è uno scrittore), è l’unico non suo e su spazio web, che tra tanti, non è suo.
Se non si può condannare, come infangare la sua credibilità? Dopo tanti e tanti anni si fa arrivare il conto con la prescrizione e far pagare ancora una volta la tangente per danni morali all’avvocato donna, amante di magistrati.
Questa è il finale triste di un favola, perché di favola si tratta, e la morale cercatevela voi.
Ed in fatto di mafia c’è qualcuno che la sa lunga. «Io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano me….Mi hanno fatto arrestare Provenzano e Ciancimino, non come dicono, i carabinieri……Di questo papello non ne sono niente….Il pentito Giovanni Brusca non ha fatto tutto da solo, c'è la mano dei servizi segreti. La stessa cosa vale anche per l'agenda rossa. Ha visto cosa hanno fatto? Perchè non vanno da quello che aveva in mano la borsa e si fanno consegnare l'agenda. In via D'Amelio c'erano i servizi……. Io sono stato 25 anni latitante in campagna senza che nessuno mi cercasse. Com'è possibile che sono responsabile di tutte queste cose? La vera mafia sono i magistrati e i politici che si sono coperti tra di loro. Loro scaricano ogni responsabilità sui mafiosi. La mafia quando inizia una cosa la porta a termine. Io sto bene. Mi sento carico e riesco a vedere oltre queste mura……Appuntato, lei mi vede che possa baciare Andreotti? Le posso dire che era un galantuomo e che io sono stato dell'area andreottiana da sempre». Le confidenze fatte da Toto Riina, il capo dei capi, sono state fatte in due diverse occasioni, a due guardie penitenziarie del Gom del carcere Opera di Milano. Il dialogo tra polizia penitenziaria e l'ex numero uno della mafia, è avvenuto lo scorso 31 maggio 2013, durante la pausa di un'udienza alla quale il boss partecipava in teleconferenza. Queste frasi sono contenute in una relazione di servizio stilata dagli agenti del Gom, il gruppo speciale della polizia penitenziaria che si occupa della gestione dei detenuti eccellenti. La relazione è stata inviata ai magistrati della Procura di Palermo che si occupano della trattativa Stato-mafia, Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia.
La legge forse è uguale per tutti, le toghe certamente no. Ci sono quelle buone e quelle cattive. Ci sono i giudici e i pm da una parte e gli avvocati dall'altra. Il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri al convegno di Confindustria del 2 luglio 2013 risponde senza peli sulla lingua alla domanda del direttore del Tg de La7 Enrico Mentana , su chi sia al lavoro per frenare le riforme: «gli avvocati... le grandi lobby che impediscono che il Paese diventi normale». Così come è altrettanto diretta quando Mentana le chiede se nel governo c’è una unità di intenti sulla giustizia: «non c’è un sentimento comune, o meglio c’è solo a parole», dice, spiegando che «quando affrontiamo il singolo caso, scattano i campanilismi e le lobby». Magari ha ragione lei. Forse esiste davvero la lobby degli azzeccagarbugli, scrive Salvatore Tramontano su “Il Giornale”. Ogni categoria fa nel grande gioco del potere la sua partita. Non ci sono, però, solo loro. Il Guardasigilli, ex Ministro dell’Interno ed ex alto burocrate come ex Prefetto non si è accorto che in giro c'è una lobby molto più forte, un Palazzo, un potere che da anni sogna di sconfinare e che fa dell'immobilismo la sua legge, tanto da considerare qualsiasi riforma della giustizia un attentato alla Costituzione. No, evidentemente no.
Oppure il ministro fa la voce grossa con le toghe piccole, ma sta bene attenta a non infastidire i mastini di taglia grossa. La lobby anti riforme più ostinata e pericolosa è infatti quella dei dottor Balanzone, quella con personaggi grassi e potenti. È la Lobby ed anche Casta dei magistrati. Quella che se la tocchi passi guai, e guai seri. Quella che non fa sconti. Quella che ti dice: subisci e taci. Quella che non si sottopone alla verifica pisco-fisica-attitudinale. Quella vendicativa. Quella che appena la sfiori ti inquisisce per lesa maestà. È una lobby così minacciosa che perfino il ministro della Giustizia non se la sente neppure di nominarla. Come se al solo pronunciarla si evocassero anatemi e disgrazie. È un'ombra che mette paura, tanto che la sua influenza agisce perfino nell'inconscio. Neanche in un fuori onda la Cancellieri si lascia scappare il nome della gran casta. È una censura preventiva per vivere tranquilli. Maledetti avvocati, loro portano la scusa. Ma chi soprattutto non vuole riformare la giustizia in Italia ha un nome e un cognome: magistratura democratica. Quella delle toghe rosse. Dei comunisti che dovrebbero tutelare i deboli contro i potenti.
Ma si sa in Italia tutti dicono: “tengo famiglia e nudda sacciu, nudda vidi, nudda sentu”.
I magistrati, diceva Calamandrei, sono come i maiali. Se ne tocchi uno gridano tutti. Non puoi metterti contro la magistratura, è sempre stato così, è una corporazione.
In tema di Giustizia l'Italia è maglia nera in Europa. In un anno si sono impiegati 564 giorni per il primo grado in sede civile, contro una media di 240 giorni nei Paesi Ocse. Il tempo medio per la conclusione di un procedimento civile nei tre gradi di giudizio si attesta sui 788 giorni. Non se la passa meglio la giustizia penale: la sua lentezza è la causa principale di sfiducia nella giustizia (insieme alla percezione della mancata indipendenza dei magistrati e della loro impunità, World Economic Forum). La durata media di un processo penale, infatti, tocca gli otto anni e tre mesi, con punte di oltre 15 anni nel 17% dei casi. Ora, tale premessa ci sbatte in faccia una cruda realtà. Per Silvio Berlusconi la giustizia italiana ha tempi record, corsie preferenziali e premure impareggiabili. Si prenda ad esempio il processo per i diritti televisivi: tre gradi di giudizio in nove mesi, una cosa del genere non si è mai vista in Italia. Il 26 ottobre 2012 i giudici del Tribunale di Milano hanno condannato Silvio Berlusconi a quattro anni di reclusione, una pena più dura di quella chiesta dalla pubblica accusa (il 18 giugno 2012 i PM Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro chiedono al giudice una condanna di 3 anni e 8 mesi per frode fiscale di 7,3 milioni di euro). Il 9 novembre 2012 Silvio Berlusconi, tramite i suoi legali, ha depositato il ricorso in appello. L'8 maggio 2013 la Corte d'Appello di Milano conferma la condanna di 4 anni di reclusione, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 3 anni dagli uffici direttivi. Il 9 luglio 2013 la Corte di Cassazione ha fissato al 30 luglio 2013 l'udienza del processo per frode fiscale sui diritti Mediaset. Processo pervenuto in Cassazione da Milano il 9 luglio con i ricorsi difensivi depositati il 19 giugno. Per chi se ne fosse scordato - è facile perdere il conto tra i 113 procedimenti (quasi 2700 udienze) abbattutisi sull'ex premier dalla sua discesa in campo, marzo 1994 - Berlusconi è stato condannato in primo grado e in appello a quattro anni di reclusione e alla pena accessoria di cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Secondo i giudici, l'ex premier sarebbe intervenuto per far risparmiare a Mediaset tre milioni di imposte nel 2002-2003. Anni in cui, per quanto vale, il gruppo versò all'erario 567 milioni di tasse. I legali di Berlusconi avranno adesso appena venti giorni di tempo per articolare la difesa. «Sono esterrefatto, sorpreso, amareggiato» dichiara Franco Coppi. Considerato il migliore avvocato cassazionista d'Italia, esprime la sua considerazione con la sua autorevolezza e il suo profilo non politicizzato: «Non si è mai vista un'udienza fissata con questa velocità», che «cade tra capo e collo» e «comprime i diritti della difesa». Spiega: «Noi difensori dovremo fare in 20 giorni quello che pensavamo di fare con maggior respiro». Tutto perché? «Evidentemente - ragiona Coppi -, la Cassazione ha voluto rispondere a chi paventava i rischi della prescrizione intermedia. Ma di casi come questo se ne vedono molti altri e la Suprema Corte si limita a rideterminare la pena, senza andare ad altro giudice. Al di là degli aspetti formali, sul piano sostanziale, dover preparare una causa così rinunciando a redigere motivi nuovi, perché i tempi non ci sono, significa un'effettiva diminuzione delle possibilità di difesa». Il professore risponde così anche all'Anm che definisce «infondate» le polemiche e nega che ci sia accanimento contro il Cavaliere.
113 procedimenti. Tutto iniziò nel 1994 con un avviso di garanzia (poi dimostratosi infondato) consegnato a mezzo stampa dal Corriere della Sera durante il G8 che si teneva a Napoli. Alla faccia del segreto istruttorio. E’ evidentemente che non una delle centinaia di accuse rivoltegli contro era fondata. Nessun criminale può farla sempre franca se beccato in castagna. E non c’è bisogno di essere berlusconiano per affermare questo.
E su come ci sia commistione criminale tra giornali e Procure è lo stesso Alessandro Sallusti che si confessa. In un'intervista al Foglio di Giuliano Ferrara, il direttore de Il Giornale racconta i suoi anni al Corriere della Sera, e il suo rapporto con Paolo Mieli: «Quando pubblicammo l'avviso di garanzia che poi avrebbe fatto cadere il primo governo di Silvio Berlusconi, ero felicissimo. Era uno scoop pazzesco. E lo rifarei. Ma si tratta di capire perché certe notizie te le passano. Sin dai tempi di Mani pulite il Corriere aveva due direttori, Mieli e Francesco Saverio Borrelli, il procuratore capo di Milano. I magistrati ci passavano le notizie, con una tempistica che serviva a favorire le loro manovre. Mi ricordo bene la notte in cui pubblicammo l'avviso di garanzia a Berlusconi. Fu una giornata bestiale, Mieli a un certo punto, nel pomeriggio, sparì. Poi piombò all'improvviso nella mia stanza, fece chiamare Goffredo Buccini e Gianluca Di Feo, che firmavano il pezzo, e ci disse, pur con una certa dose di insicurezza, di scrivere tutto, che lo avremmo pubblicato. Parlava con un tono grave, teso. Quella notte, poi, ci portò in pizzeria, ci disse che aveva già scritto la lettera di dimissioni, se quello che avevamo non era vero sarebbero stati guai seri. Diceva di aver parlato con Agnelli e poi anche con il presidente Scalfaro. Ma poi ho ricostruito che non era così, non li aveva nemmeno cercati, secondo me lui pendeva direttamente dalla procura di Milano».
Si potrebbe sorridere al fatto che i processi a Silvio Berlusconi, nonostante cotanto di principi del foro al seguito, innalzino sensibilmente la media nazionale dello sfascio della nostra giustizia. Ma invece la domanda, che fa capolino e che sorge spontanea, è sempre la stessa: come possiamo fidarci di "questa" giustizia, che se si permette di oltraggiare se stessa con l’uomo più potente d’Italia, cosa potrà fare ai poveri cristi? La memoria corre a quel film di Dino Risi, "In nome del popolo italiano", 1971. C'è il buono, il magistrato impersonato da Tognazzi. E poi c'è il cialtrone, o presunto tale, che è uno strepitoso Gassman. Alla fine il buono fa arrestare il cialtrone, ma per una cosa che non ha fatto, per un reato che non ha commesso. Il cialtrone è innocente, ma finalmente è dentro.
Ciononostante viviamo in un’Italia fatta così, con italiani fatti così, bisogna subire e tacere. Questo ti impone il “potere”. Ebbene, si faccia attenzione alle parole usate per prendersela con le ingiustizie, i soprusi e le sopraffazioni, le incapacità dei governati e l’oppressione della burocrazia,i disservizi, i vincoli, le tasse, le code e la scarsezza di opportunità del Belpaese. Perché sfogarsi con il classico "Italia paese di merda", per quanto liberatorio, non può essere tollerato dai boiardi di Stato. E' reato, in quanto vilipendio alla nazione. Lo ha certificato la Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 4 luglio 2013 n. 28730. Accadde che un vigile, a Montagnano, provincia di Campobasso, nel lontano 2 novembre 2005 fermò un uomo di 70 anni: la sua auto viaggiava con un solo faro acceso. Ne seguì una vivace discussione tra il prossimo multato e l'agente. Quando contravvenzione fu, il guidatore si lasciò andare al seguente sfogo: "Invece di andare ad arrestare i tossici a Campobasso, pensate a fare queste stronzate e poi si vedono i risultati. In questo schifo di Italia di merda...". Il vigile zelante prese nota di quella frase e lo denunciò. Mille euro di multa - In appello, il 26 aprile del 2012, per il viaggiatore senza faro che protestò aspramente contro la contravvenzione arrivò la condanna, pena interamente coperta da indulto. L'uomo decise così di rivolgersi alla Cassazione. La sentenza poi confermata dai giudici della prima sezione penale del Palazzaccio. Il verdetto: colpevole di "vilipendio alla nazione". Alla multa di ormai otto anni fa per il faro spento, si aggiunge quella - salata - di mille euro per l'offesa al tricolore. L'uomo si era difeso sostenendo che non fosse sua intenzione offendere lo Stato e appellandosi al "diritto alla libera manifestazione di pensiero". «Il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo - si legge nella sentenza depositata - non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva»: per integrare il reato, previsto dall'articolo 291 del codice penale, «è sufficiente una manifestazione generica di vilipendio alla nazione, da intendersi come comunità avente la stessa origine territoriale, storia, lingua e cultura, effettuata pubblicamente». Il reato in esame, spiega la Suprema Corte, «non consiste in atti di ostilità o di violenza o in manifestazioni di odio: basta l'offesa alla nazione, cioè un'espressione di ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o l'onore della collettività nazionale, a prescindere dai vari sentimenti nutriti dall'autore». Il comportamento dell'imputato, dunque, che «in luogo pubblico, ha inveito contro la nazione», gridando la frase “incriminata”, «sia pure nel contesto di un'accesa contestazione elevatagli dai carabinieri per aver condotto un'autovettura con un solo faro funzionante, integra - osservano gli “ermellini” - il delitto di vilipendio previsto dall'articolo 291 cp, sia nel profilo materiale, per la grossolana brutalità delle parole pronunciate pubblicamente, tali da ledere oggettivamente il prestigio o l'onore della collettività nazionale, sia nel profilo psicologico, integrato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di proferire, al cospetto dei verbalizzanti e dei numerosi cittadini presenti sulla pubblica via nel medesimo frangente, le menzionate espressioni di disprezzo, a prescindere dai veri sentimenti nutriti dall'autore e dal movente, nella specie di irata contrarietà per la contravvenzione subita, che abbia spinto l'agente a compiere l'atto di vilipendio».
A questo punto ognuno di noi ammetta e confessi che, almeno per un volta nella sua vita, ha proferito la fatidica frase “che schifo questa Italia di merda” oppure “che schifo questi italiani di merda”.
Bene, allora cari italiani: TUTTI DENTRO, CAZZO!!
Non sarà la mafia a uccidermi ma alcuni miei colleghi magistrati (Borsellino). La verità sulle stragi non la possiamo dire noi Magistrati ma la deve dire la politica se non proprio la storia (Ingroia). Non possiamo dire la verità sulle stragi altrimenti la classe politica potrebbe non reggere (Gozzo). Non sono stato io a cercare loro ma loro a cercare me (Riina). In Italia mai nulla è come appare. Ipocriti e voltagabbana. Le stragi come eccidi di Stato a cui non è estranea la Magistratura e e gran parte della classe politica del tempo tranne quei pochi che ne erano i veri destinatari (Craxi e Forlani) e quei pochissimi che si rifiutarono di partecipare al piano stragista (Andreotti Lima e Mannino) e che per questo motivo furono assassinati o lungamente processati. La Sinistra non di governo sapeva. La Sinistra Democristiana ha partecipato al piano stragista fino all'elezione di Scalfaro poi ha cambiato rotta. I traditori di Craxi e la destra neofascista sono gli artefici delle stragi. Quelli che pensavamo essere i peggio erano i meglio. E quelli che pensavamo essere i meglio erano i peggio. In questo contesto non si può cercare dai carabinieri Mario Mori e Mario Obinu che comunque dipendevano dal Ministero degli Interni e quindi dal Potere Politico, un comportamento lineare e cristallino.
Ed a proposito del “TUTTI DENTRO”, alle toghe milanesi Ruby non basta mai. Un gigantesco terzo processo per il caso Ruby, dove sul banco degli imputati siedano tutti quelli che, secondo loro, hanno cercato di aiutare Berlusconi a farla franca: poliziotti, agenti dei servizi segreti, manager, musicisti, insomma quasi tutti i testimoni a difesa sfilati davanti ai giudici. Anche Ruby, colpevole di avere negato di avere fatto sesso con il Cavaliere. Ma anche i suoi difensori storici, Niccolò Ghedini e Piero Longo. E poi lui medesimo, Berlusconi. Che della opera di depistaggio sarebbe stato il regista e il finanziatore. I giudici con questa decisione mandano a dire (e lo renderanno esplicito nelle motivazioni) che secondo loro in aula non si è assistito semplicemente ad una lunga serie di false testimonianze, rese per convenienza o sudditanza, ma all'ultima puntata di un piano criminale architettato ben prima che lo scandalo esplodesse, per mettere Berlusconi al riparo dalle sue conseguenze. Corruzione in atti giudiziari e favoreggiamento, questi sono i reati che i giudici intravedono dietro quanto è accaduto. Per l'operazione di inquinamento e depistaggio la sentenza indica una data di inizio precisa: il 6 ottobre 2010, quando Ruby viene a Milano insieme al fidanzato Luca Risso e incontra l'avvocato Luca Giuliante, ex tesoriere del Pdl, al quale riferisce il contenuto degli interrogatori che ha già iniziato a rendere ai pm milanesi. I giudici del processo a Berlusconi avevano trasmesso gli atti su quell'incontro all'Ordine degli avvocati, ritenendo di trovarsi davanti a una semplice violazione deontologica. Invece la sentenza afferma che fu commesso un reato, e che insieme a Giuliante ne devono rispondere anche Ghedini e Longo. E l'operazione sarebbe proseguita a gennaio, quando all'indomani delle perquisizioni e degli avvisi di garanzia, si tenne una riunione ad Arcore tra Berlusconi e alcune delle «Olgettine» che erano state perquisite. Berlusconi come entra in questa ricostruzione? Essendo imputato nel processo, il Cavaliere non può essere accusato né di falsa testimonianza né di favoreggiamento. La sua presenza nell'elenco vuol dire che per i giudici le grandi manovre compiute tra ottobre e gennaio si perfezionarono quando Berlusconi iniziò a stipendiare regolarmente le fanciulle coinvolte nell'inchiesta. Corruzione di testimoni, dunque. Ghedini e Longo ieri reagiscono con durezza, definendo surreale la mossa dei giudici e spiegando che gli incontri con le ragazze erano indagini difensive consentite dalla legge. Ma la nuova battaglia tra Berlusconi e la Procura di Milano è solo agli inizi. D’altra parte anche Bari vuol dire la sua sulle voglie sessuali di Berlusconi. Silvio Berlusconi avrebbe pagato l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini tramite il faccendiere Walter Lavitola, perchè nascondesse dinanzi ai magistrati la verità sulle escort portate alle feste dell’ex premier. Ne è convinta la procura di Bari che ha notificato avvisi di conclusioni delle indagini sulle presunte pressioni che Berlusconi avrebbe esercitato su Tarantini perchè lo coprisse nella vicenda escort. Nell’inchiesta Berlusconi e Lavitola sono indagati per induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Secondo quanto scrivono alcuni quotidiani, l’ex premier avrebbe indotto Tarantini a tacere parte delle informazioni di cui era a conoscenza e a mentire nel corso degli interrogatori cui è stato sottoposto dai magistrati baresi (tra luglio e novembre 2009) che stavano indagando sulla vicenda escort. In cambio avrebbe ottenuto complessivamente mezzo milione di euro, la promessa di un lavoro e la copertura delle spese legali per i processi. Secondo l’accusa, Tarantini avrebbe mentito, tra l'altro, negando che Berlusconi fosse a conoscenza che le donne che Gianpy reclutava per le sue feste erano escort. Sono indagati Berlusconi e Lavitola, per induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.
Comunque torniamo alle condanne milanesi. Dopo il processo Ruby 1, concluso con la condanna in primo grado di Silvio Berlusconi a 7 anni, ecco il processo Ruby 2, con altri 7 anni di carcere per Emilio Fede e Lele Mora e 5 per Nicole Minetti. Ma attenzione, perché si parlerà anche del processo Ruby 3, perché come accaduto con la Corte che ha giudicato il Cav anche quella che ha condannato Fede, Mora e Minetti per induzione e favoreggiamento della prostituzione ha stabilito la trasmissione degli atti al pm per valutare eventuali ipotesi di reato in relazione alle indagini difensive. Nel mirino ci sono, naturalmente, Silvio Berlusconi, i suoi legali Niccolò Ghedini e Piero Longo e la stessa Karima el Mahroug, in arte Ruby. Come accaduto per il Ruby 1 anche per il Ruby 2 il profilo penale potrebbe essere quello della falsa testimonianza. La procura, rappresentata dal pm Antonio Sangermano e dall’aggiunto Piero Forno, per gli imputati aveva chiesto sette anni di carcere per induzione e favoreggiamento della prostituzione anche minorile. Il processo principale si era concluso con la condanna a sette anni di reclusione per Silvio Berlusconi, accusato di concussione e prostituzione minorile. Durante la requisitoria l’accusa aveva definito le serate di Arcore “orge bacchiche”. Secondo gli inquirenti sono in tutto 34 le ragazze che sono state indotte a prostituirsi durante le serate ad Arcore per soddisfare, come è stato chiarito in requisitoria, il “piacere sessuale” del Cavaliere. Serate che erano “articolate” in tre fasi: la prima “prevedeva una cena”, mentre la seconda “definita ‘bunga bunga’” si svolgeva “all’interno di un locale adibito a discoteca, dove le partecipanti si esibivano in mascheramenti, spogliarelli e balletti erotici, toccandosi reciprocamente ovvero toccando e facendosi toccare nelle parti intime da Silvio Berlusconi”. La terza fase riguardava infine la conclusione della serata e il suo proseguimento fino alla mattina dopo: consisteva, scrivono i pm, “nella scelta, da parte di Silvio Berlusconi, di una o più ragazze con cui intrattenersi per la notte in rapporti intimi, persone alle quali venivano erogate somme di denaro ed altre utilità ulteriori rispetto a quelle consegnate alle altre partecipanti”. A queste feste, per 13 volte (il 14, il 20, il 21, il 27 e il 28 febbraio, il 9 marzo, il 4, il 5, il 24, il 25 e il 26 aprile, e l’1 e il 2 maggio del 2010) c’era anche Karima El Mahroug, in arte Ruby Rubacuori, non ancora 18enne. La ragazza marocchina, in base all’ipotesi accusatoria, sarebbe stata scelta da Fede nel settembre del 2009 dopo un concorso di bellezza in Sicilia, a Taormina, dove lei era tra le partecipanti e l’ex direttore del Tg4 uno dei componenti della giuria. Secondo le indagini, andò ad Arcore la prima volta accompagnata da Fede con una macchina messa a disposizione da Mora. Per i pm, però, ciascuno dei tre imputati, in quello che è stato chiamato “sistema prostitutivo”, aveva un ruolo ben preciso. Lele Mora “individuava e selezionava”, anche insieme a Emilio Fede, “giovani donne disposte a prostituirsi” nella residenza dell’ex capo del Governo scegliendole in alcuni casi “tra le ragazze legate per motivi professionali all’agenzia operante nel mondo dello spettacolo” gestita dall’ex agente dei vip. Inoltre Mora, come Fede, “organizzava” in alcune occasioni “l’accompagnamento da Milano ad Arcore” di alcune delle invitate alla serate “mettendo a disposizione le proprie autovetture”, con tanto di autista. I pm in requisitoria hanno paragonato Mora e Fede ad “assaggiatori di vini pregiati”, perché valutavano la gradevolezza estetica delle ragazze e le sottoponevano a “un minimo esame di presentabilità socio-relazionale”, prima di immetterle nel “circuito” delle cene. Nicole Minetti, invece, avrebbe fatto da intermediaria per i compensi alle ragazze – in genere girati dal ragionier Giuseppe Spinelli, allora fiduciario e “ufficiale pagatore” per conto del leader del Pdl – che consistevano “nella concessione in comodato d’uso” degli appartamenti nel residence di via Olgettina e “in contributi economici” per il loro mantenimento o addirittura per il pagamento delle utenze di casa o delle spese mediche fino agli interventi di chirurgia estetica.
Il rischio di una sentenza che smentisse quella inflitta a Berlusconi è stato dunque scongiurato: e di fatto la sentenza del 19 luglio 2013 e quella che del 24 giugno 2013 rifilò sette anni di carcere anche al Cavaliere si sorreggono a vicenda. Chiamati a valutare sostanzialmente il medesimo quadro di prove, di testimonianze, di intercettazioni, due tribunali composti da giudici diversi approdano alle stesse conclusioni. Vengono credute le ragazze che hanno parlato di festini hard. E non vengono credute le altre, Ruby in testa, che proprio nell’aula di questo processo venne a negare di avere mai subito avances sessuali da parte di Berlusconi. La testimonianza di Ruby viene trasmessa insieme a quella di altri testimoni alla procura perché proceda per falso, insieme a quella di molti altri testimoni. I giudici, come già successo nel processo principale, hanno trasmesso gli atti alla Procura perché valutino le dichiarazioni di 33 testimoni della difesa compresa la stessa Ruby; disposta la trasmissione degli atti anche per lo stesso Silvio Berlusconi e dei suoi avvocati: Niccolò Ghedini e Piero Longo per violazione delle indagini difensive. Il 6-7 ottobre 2010 (prima che scoppiasse lo scandalo) e il 15 gennaio 2011 (il giorno dopo l’avviso di garanzia al Cavaliere) alcune ragazze furono convocate ad Arcore, senza dimenticare l’interrogatorio fantasma fatto a Karima. Durante le perquisizioni in casa di alcune Olgettine erano stati trovati verbali difensivi già compilati. Vengono trasmessi gli atti alla procura anche perché proceda nei confronti di Silvio Berlusconi e dei suoi difensori Niccolò Ghedini e Piero Longo, verificando se attraverso l'avvocato Luca Giuliante abbiano tentato di addomesticare la testimonianza di Ruby. In particolare la Procura dovrà valutare la posizione, al termine del processo di primo grado «Ruby bis» non solo per Silvio Berlusconi, i suoi legali e Ruby, ma anche per altre ventinove persone. Tra queste, ci sono numerose ragazze ospiti ad Arcore che hanno testimoniato, tra le quali: Iris Berardi e Barbara Guerra (che all'ultimo momento avevano ritirato la costituzione di parte civile) e Alessandra Sorcinelli. Il tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica anche per il primo avvocato di Ruby, Luca Giuliante. «Inviare gli atti a fini di indagini anche per il presidente Berlusconi e i suoi difensori è davvero surreale». Lo affermano i legali di Berlusconi, Niccolò Ghedini e Piero Longo, in merito alla decisione dei giudici di Milano di trasmettere gli atti alla procura in relazione alla violazione delle indagini difensive. «Quando si cerca di esplicare il proprio mandato defensionale in modo completo, e opponendosi ad eventuali prevaricazioni, a Milano possono verificarsi le situazioni più straordinarie» proseguono i due avvocati. E ancora: «La decisione del Tribunale di Milano nel processo cosiddetto Ruby bis di inviare gli atti per tutti i testimoni che contrastavano la tesi accusatoria già fa ben comprendere l'atteggiamento del giudicante. Ma inviare gli atti ai fini di indagini anche per il presidente Berlusconi e per i suoi difensori è davvero surreale. Come è noto nè il presidente Berlusconi nè i suoi difensori hanno reso testimonianza in quel processo. Evidentemente si è ipotizzato che vi sarebbe stata attività penalmente rilevante in ordine alle esperite indagini difensive. Ciò è davvero assurdo».
La sentenza è stata pronunciata dal giudice Annamaria Gatto. Ad assistere all'udienza anche per il Ruby 2, in giacca e cravatta questa volta e non in toga, anche il procuratore Edmondo Bruti Liberati, che anche in questo caso, come nel processo a Berlusconi, ha voluto rivendicare in questo modo all'intera Procura la paternità dell'inchiesta Ruby. Il collegio presieduto da Anna Maria Gatto e composto da Paola Pendino e Manuela Cannavale è formato da sole donne. Giudici donne come quelle del collegio del processo principale formato dai giudici Orsola De Cristofaro, Carmela D'Elia e dal presidente Giulia Turri. Anche la Turri, come la Gatto, ha deciso anche di rinviare al pm le carte per valutare l'eventuale falsa testimonianza per le dichiarazioni rese in aula da 33 testi: una lunga serie di testimoni che hanno sfilato davanti alla corte.
TOGHE ROSA
Dici donna e dici danno, anzi, "condanno".
È il sistema automatico che porta il nome di una donna, Giada (Gestione informatica assegnazioni dibattimentali) che ha affidato il caso della minorenne Karima el Mahroug, detta Ruby Rubacuori, proprio a quelle tre toghe. Che un processo possa finire a un collegio tutto femminile non è una stranezza, come gridano i falchi del Pdl che dopo troppi fantomatici complotti rossi ora accusano la trama rosa: è solo il segno dell'evoluzione storica di una professione che fino a 50 anni fa era solo maschile. Tra i giudici del tribunale di Milano oggi si contano 144 donne e 78 uomini: quasi il doppio.
Donna è anche Ilda Boccassini, che rappresentava l’accusa contro Berlusconi. Tutti hanno sentito le parole di Ilda Boccassini: "Ruby è furba di quella furbizia orientale propria della sua origine". «E' una giovane di furbizia orientale che come molti dei giovani delle ultime generazioni ha come obbiettivo entrare nel mondo spettacolo e fare soldi, il guadagno facile, il sogno italiano di una parte della gioventù che non ha come obiettivo il lavoro, la fatica, lo studio ma accedere a meccanismi che consentano di andare nel mondo dello spettacolo, nel cinema. Questo obiettivo - ha proseguito la Boccassini - ha accomunato la minore "con le ragazze che sono qui sfilate e che frequentavano la residenza di Berlusconi: extracomunitarie, prostitute, ragazze di buona famiglia anche con lauree, persone che hanno un ruolo nelle istituzioni e che pure avevano un ruolo nelle serate di Arcore come la europarlamentare Ronzulli e la europarlamentare Rossi. In queste serate - afferma il pm - si colloca anche il sogno di Kharima. Tutte, a qualsiasi prezzo, dovevano avvicinare il presidente del Consiglio con la speranza o la certezza di ottenere favori, denaro, introduzione nel mondo dello spettacolo».
Dovesse mai essere fermata un'altra Ruby, se ne occuperebbe lei. Il quadro in rosa a tinta forte si completa con il gip Cristina Di Censo, a cui il computer giudiziario ha affidato l'incarico di rinviare a "giudizio immediato" Berlusconi, dopo averle fatto convalidare l'arresto di Massimo Tartaglia, il folle che nel 2010 lo ferì al volto con una statuetta del Duomo. Per capirne la filosofia forse basta la risposta di una importante giudice di Milano a una domanda sulla personalità di queste colleghe: «La persona del magistrato non ha alcuna importanza: contano solo le sentenze. È per questo che indossiamo la toga».
Donna di carattere anche Annamaria Fiorillo, il magistrato dei minori che, convocata dal tribunale, ha giurato di non aver mai autorizzato l'affidamento della minorenne Ruby alla consigliera regionale del Pdl Nicole Minetti e tantomeno alla prostituta brasiliana Michelle Conceicao. Per aver smentito l'opposta versione accreditata dall'allora ministro Roberto Maroni, la pm si è vista censurare dal Csm per "violazione del riserbo".
Ruby 2, chi sono le tre giudicesse che hanno condannato Mora, Fede e la Minetti, e trasmesso gli atti per far condannare Berlusconi, i suoi avvocati e tutti i suoi testimoni? Anna Maria Gatto, Paola Pendino e Manuela Cannavale. Si assomigliano molto anche nel look alle loro colleghe del Ruby 1.
Anna Maria Gatto si ricorda per una battuta. La testimone Lisa Barizonte, sentita in aula, rievoca le confidenze tra lei e Karima El Mahrough, alias Ruby. In particolare il giudice le chiede di un incidente con l’olio bollente. La teste conferma: “Mi disse che lo zio le fece cadere addosso una pentola di olio bollente”. “Chi era lo zio? Mubarak?”, chiede Anna Maria Gatto strappando un sorriso ai presenti in aula. Ironia che punta dritta al centro dello scandalo. La teste, sottovoce, risponde: “No, non l’ha detto”. Annamaria Gatto, presidente della quinta sezione penale, è il giudice che, tra le altre cose, condannò in primo grado a 2 anni l'ex ministro Aldo Brancher per ricettazione e appropriazione indebita, nell'ambito di uno stralcio dell'inchiesta sulla tentata scalata ad Antonveneta da parte di Bpi.
Manuela Cannavale, invece, ha fatto parte del collegio che nel 2008 ha condannato in primo grado a tre anni di reclusione l'ex ministro della Sanità Girolamo Sirchia.
Paola Pendino è stata invece in passato membro della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione di Milano, e si è occupata anche di Mohammed Daki, il marocchino che era stato assolto dall'accusa di terrorismo internazionale dal giudice Clementina Forleo.
Ruby 1, chi sono le tre giudichesse che hanno condannato Berlusconi?
Giulia Turri, Carmen D’Elia e Orsola De Cristofaro: sono i nomi dei tre giudici che hanno firmato la sentenza di condanna di Berlusconi a sette anni. La loro foto sta facendo il giro del web e tra numerosi commenti di stima e complimenti, spunta anche qualche offesa (perfino dal carattere piuttosto personale). L’aggettivo più ricorrente, inteso chiaramente in senso dispregiativo, è quello di “comuniste”. Federica De Pasquale le ha definite “il peggior esempio di femminismo” arrivando ad ipotizzare per loro il reato di stalking. Ma su twitter qualche elettore del Pdl non ha esitato a definirle come “represse” soppesandone il valore professionale con l’aspetto fisico e definendole “quasi più brutte della Bindi”. Ma cosa conta se il giudice è uomo/donna, bello/brutto?
Condanna a Berlusconi: giudici uomini sarebbero stati più clementi? Ma per qualcuno il problema non è tanto che si trattasse di “toghe rosse” quanto piuttosto di “giudici rosa”. Libero intitola l’articolo sulla sentenza di condanna alle “giudichesse”, sottolineando con un femminile forzato di questo sostantivo la natura di genere della condanna e quasi a suggerire che se i giudici fossero stati uomini la sentenza sarebbe stata diversa da quella che il giornale definisce “castrazione” e “ergastolo politico” del Cav. La natura rosa del collegio quindi avrebbe influenzato l’esito del giudizio a causa di un “dente avvelenato in un caso così discusso e pruriginoso. Un dente avvelenato che ha puntualmente azzannato Berlusconi”. Eppure è lo stesso curriculum dei giudici interessati, sintetizzato sempre da Libero, a confermare la preparazione e la competenza delle tre toghe a giudicare con lucidità in casi di grande impatto mediatico.
Giulia Turri è nota come il giudice che nel marzo del 2007 firmò l’ordinanza di arresto per Fabrizio Corona ma è anche la stessa che ha giudicato in qualità di gup due degli assassini del finanziere Gian Mario Roveraro e che, nel 2010, ha disposto l’arresto di cinque persone nell’ambito dell’inchiesta su un giro di tangenti e droga che ha coinvolto la movida milanese, e in particolare le note discoteche Hollywood e The Club.
Orsola De Cristofaro è stata giudice a latere nel processo che si è concluso con la condanna a quindici anni e mezzo di carcere per Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario di chirurgia toracica, nell’ambito dell’inchiesta sulla clinica Santa Rita.
Carmen D’Elia si è già trovata faccia a faccia con Berlusconi in tribunale: ha fatto infatti parte del collegio di giudici del processo Sme in cui era imputato.
A condannare Berlusconi sono state tre donne: la Turri, la De Cristofaro e la D'Elia che già lo aveva processato per la Sme. La presentazione è fatta da “Libero Quotidiano” con un articolo del 24 giugno 2013. A condannare Silvio Berlusconi a 7 anni di reclusione e all'interdizione a vita dai pubblici uffici nel primo grado del processo Ruby sono state tre toghe rosa. Tre giudichesse che hanno propeso per una sentenza pesantissima, ancor peggiore delle richieste di Ilda Boccassini. Una sentenza con cui si cerca la "castrazione" e l'"ergastolo politico" del Cav. Il collegio giudicante della quarta sezione penale del Tribunale di Milano che è entrato a gamba tesa contro il governo Letta e contro la vita democratica italiana era interamente composto da donne, tanto che alcuni avevano storto il naso pensando che la matrice "rosa" del collegio avrebbe potuto avere il dente avvelenato in un caso così discusso e pruriginoso. Un dente avvelenato che ha puntualmente azzannato Berlusconi.
A presiedere il collegio è stata Giulia Turri, arrivata in Tribunale dall'ufficio gip qualche mese prima del 6 aprile 2011, giorno dell'apertura del dibattimento. Come gup ha giudicato due degli assassini del finanziere Gian Mario Roveraro, sequestrato e ucciso nel 2006, pronunciando due condanne, una all'ergastolo e una a 30 anni. Nel marzo del 2007 firmò l'ordinanza di arresto per il "fotografo dei vip" Fabrizio Corona, e nel novembre del 2008 ha rinviato a giudizio l'ex consulente Fininvest e deputato del Pdl Massimo Maria Berruti. Uno degli ultimi suoi provvedimenti come gip, e che è salito alla ribalta della cronaca, risale al luglio 2010: l'arresto di cinque persone coinvolte nell'inchiesta su un presunto giro di tangenti e droga nel mondo della movida milanese, e in particolare nelle discoteche Hollywood e The Club, gli stessi locali frequentati da alcune delle ragazze ospiti delle serate ad Arcore e che sono sfilate in aula.
La seconda giudichessa è stata Orsola De Cristofaro, con un passato da pm e gip, che è stata giudice a latere nel processo che ha portato alla condanna a quindici anni e mezzo di carcere per Pier Paolo Brega Massone, l'ex primario di chirurgia toracica, imputato con altri medici per il caso della clinica Santa Rita e che proprio sabato scorso si è visto in pratica confermare la condanna sebbene con una lieve diminuzione per via della prescrizioni di alcuni casi di lesioni su pazienti.
Carmen D'Elia invece è un volto noto nei procedimenti contro il Cavaliere: nel 2002, ha fatto parte parte del collegio di giudici del processo Sme che vedeva come imputato, tra gli altri, proprio Silvio Berlusconi. Dopo che la posizione del premier venne stralciata - per lui ci fu un procedimento autonomo - insieme a Guido Brambilla e a Luisa Ponti, il 22 novembre 2003 pronunciò la sentenza di condanna in primo grado a 5 anni per Cesare Previti e per gli altri imputati, tra cui Renato Squillante e Attilio Pacifico. Inoltre è stata giudice nel processo sulla truffa dei derivati al Comune di Milano.
Donna è anche Patrizia Todisco del caso Taranto. Ed è lo stesso “Libero Quotidiano” che la presenta con un articolo del 13 agosto 2012. Patrizia Todisco, gip: la zitella rossa che licenzia 11mila operai Ilva.
Patrizia Todisco, il giudice per le indagini preliminari che sabato 11 agosto ha corretto il tiro rispetto alla decisione del Tribunale di Riesame decidendo di fermare la produzione dell'area a caldo dell'Ilva si Taranto lasciando quindi a casa 11mila operai, è molto conosciuta a Palazzo di giustizia per la sua durezza. Una rigorosa, i suoi nemici dicono "rigida", una a cui gli avvocati che la conoscono bene non osano avvicinarsi neanche per annunciare la presentazione di un'istanza. Il gip è nata a Taranto, ha 49 anni, i capelli rossi, gli occhiali da intellettuale, non è sposata, non ha figli e ha una fama di "durissima". Come scrive il Corriere della Sera, è una donna che non si fermerà davanti alle reazioni alla sua decisione che non si aspetta né la difesa della procura tarantina né di quella generale che sulle ultime ordinanze non ha aperto bocca. Patrizia Todisco è entrata in magistratura 19 anni fa, e non si è mai spostata dal Palazzo di giustizia di Taranto, non si è mai occupata dell'Ilva dove sua sorella ha lavorato come segretaria della direzione fino al 2009. Non si è mai occupata del disastro ambientale dell'Ilva ma, vivendo da sempre a Taranto, ha osservato da lontano il profilo delle ciminiere che hanno dato lavoro e morte ai cittadini. La sua carriera è cominciata al Tribunale per i minorenni, poi si si è occupata di violenze sessuali, criminalità organizzata e corruzione. Rigorosissima nell'applicazione del diritto, intollerante verso gli avvocati che arrivano in ritardo, mai tenera con nessuno. Sempre il Corriere ricorda quella volta che, davanti a un ragazzino che aveva rubato un pezzo di formaggio dal frigorifero di una comunità. Fu assolto, come come dice un avvocato "lo fece così nero da farlo sentire il peggiore dei criminali".
Ma anche Giusi Fasano per "Il Corriere della Sera" ne dà una definizione. Patrizia va alla guerra. Sola. Gli articoli del codice penale sono i suoi soldati e il rumore dell'esercito «avversario» finora non l'ha minimamente spaventata. «Io faccio il giudice, mi occupo di reati...» è la sua filosofia. Il presidente della Repubblica, il Papa, il ministro dell'Ambiente, il presidente della Regione, i sindacati, il Pd, il Pdl... L'Ilva è argomento di tutti. Da ieri anche del ministro Severino, che ha chiesto l'acquisizione degli atti, e del premier Mario Monti che vuole i ministri di Giustizia, Ambiente e Sviluppo a Taranto il 17 agosto, per incontrare il procuratore della Repubblica. Anna Patrizia Todisco «ha le spalle grosse per sopportare anche questa» giura chi la conosce. Ha deciso che l'Ilva non deve produrre e che Ferrante va rimosso? Andrà fino in fondo. Non è donna da farsi scoraggiare da niente e da nessuno: così dicono di lei. E nemmeno si aspetta la difesa a spada tratta della procura tarantina o di quella generale che sulle ultime ordinanze, comunque, non hanno aperto bocca. Ieri sera alle otto il procuratore generale Giuseppe Vignola, in Grecia in vacanza, ha preferito non commentare gli interventi del ministro Severino e del premier Monti «perché non ho alcuna notizia di prima mano e non me la sento di prendere posizione». È stato un prudente «no comment» anche per il procuratore capo di Taranto Franco Sebastio. Nessuna affermazione. Che vuol dire allo stesso tempo nessuna presa di posizione contro o a favore della collega Todisco. Quasi un modo per studiare se prenderne o no le distanze. Lei, classe 1963, né sposata né figli, lavora e segue tutto in silenzio. La rossa Todisco (e parliamo del colore dei capelli) è cresciuta a pane e codici da quando diciannove anni fa entrò nella magistratura scegliendo e rimanendo sempre nel Palazzo di giustizia di Taranto. Dei tanti procedimenti aperti sull'Ilva finora non ne aveva seguito nessuno. Il mostro d'acciaio dove sua sorella ha lavorato fino al 2009 come segretaria della direzione, lo ha sempre osservato da lontano. Non troppo lontano, visto che è nata e vive a pochi chilometri dal profilo delle ciminiere che dev'esserle quantomeno familiare. Il giudice Todisco non è una persona riservata. Di più. E ovviamente è allergica ai giornalisti. «Non si dispiaccia, proprio non ho niente da dire» è stata la sola cosa uscita dalle sue labbra all'incrocio delle scale che collegano il suo piano terra con il terzo, dov'è la procura. Lei non parla, ma i suoi provvedimenti dicono di lei. Di quel «rigore giuridico perfetto» descritto con ammirazione dai colleghi magistrati, o dell'interpretazione meno benevola di tanti avvocati: «Una dura oltremisura, rigida che più non si può». Soltanto un legale che non la conosce bene potrebbe avvicinarla al bar del tribunale per dirle cose tipo «volevo parlarle di quell'istanza che vorrei presentare...». Nemmeno il tempo di finire la frase. «Non c'è da parlare, avvocato. Lei la presenti e poi la valuterò». E che dire dei ritardi in aula? La sua pazienza dura qualche minuto, poi si comincia, e poco importa se l'avvocatone sta per arrivare, come spiega inutilmente il tirocinante. Istanza motivata o niente da fare: si parte senza il principe del foro. La carriera di Patrizia Todisco è cominciata nel più delicato dei settori: i minorenni, poi fra i giudici del tribunale e infine all'ufficio gip dove si è occupata di violenze sessuali, criminalità organizzata, corruzione. Qualcuno ricorda che la giovane dottoressa Todisco una volta fece marcia indietro su un suo provvedimento, un bimbetto di cinque anni che aveva tolto alla famiglia per presunti maltrattamenti. Una perizia medica dimostrò che i maltrattamenti non c'entravano e lei si rimangiò l'ordinanza. Mai tenera con nessuno. Nemmeno con il ragazzino che aveva rubato un pezzo di formaggio dal frigorifero di una comunità: «alla fine fu assolto» racconta l'avvocato «ma lo fece così nero da farlo sentire il peggiore dei criminali».
Donne sono anche le giudici del caso Scazzi. Quelle del tutti dentro anche i testimoni della difesa e del fuori onda. «Bisogna un po' vedere, no, come imposteranno...potrebbe essere mors tua vita mea». È lo scambio di opinioni tra il presidente della Corte d'assise di Taranto, Rina Trunfio, e il giudice a latere Fulvia Misserini. La conversazione risale al 19 marzo ed è stata registrata dai microfoni delle telecamere «autorizzate a filmare l'udienza». Il presidente della corte, tra l'altro, afferma: «Certo vorrei sapere se le due posizioni sono collegate. Quindi bisogna vedere se si sono coordinati tra loro e se si daranno l'uno addosso all'altro»; il giudice a latere risponde: «Ah, sicuramente». Infine il presidente conclude: «(Non è che) negheranno in radice».
Donne sono anche le giudici coinvolte nel caso Vendola. Susanna De Felice, il magistrato fu al centro delle polemiche dopo che i due magistrati che rappresentavano l'accusa nel processo a Vendola, Desirée Digeronimo (trasferita alla procura di Roma) e Francesco Bretone, dopo l'assoluzione del politico (per il quale avevano chiesto la condanna a 20 mesi di reclusione) inviarono un esposto al procuratore generale di Bari e al capo del loro ufficio segnalando l'amicizia che legava il giudice De Felice alla sorella del governatore, Patrizia.
Donna è anche il giudice che ha condannato Raffaele Fitto. Condannarono Fitto: giudici sotto inchiesta. Sentenza in tempi ristretti e durante le elezioni: Lecce apre un fascicolo. L'ira di Savino: procedura irrituale, non ci sono ancora le motivazioni del verdetto, scrive Giuliano Foschini su “La Repubblica”. La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta sul collegio di giudici che, nel dicembre scorso, ha condannato l'ex ministro del Pdl, Raffaele Fitto a quattro anno di reclusione per corruzione e abuso di ufficio. Nelle scorse settimane il procuratore Cataldo Motta ha chiesto al presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, alcune carte che documentano lo svolgimento del processo. Una richiesta che ha colto di sorpresa il presidente che ha inviato tutti gli atti alla procura. Ma contestualmente ha segnalato la vicenda al presidente della Corte d'Appello, Vito Marino Caferra, indicandone l'originalità non fosse altro perché si sta indagando su una sentenza della quella non si conoscono ancora le motivazioni. L'indagine della procura di Lecce nasce dopo le durissime accuse di Fitto, 24 ore dopo la sentenza nei confronti della corte che lo aveva condannato. Secondo l'ex ministro il presidente di sezione Luigi Forleo, e gli altri due giudici Clara Goffredo e Marco Galesi avrebbero imposto un ritmo serrato al suo processo in modo da condannarlo proprio nel mezzo della campagna elettorale. "Si è aperta in maniera ufficiale un'azione da parte della magistratura barese - aveva detto Fitto - che è entrata a piedi uniti in questa campagna elettorale. Non c'era bisogno di fare questa sentenza in questi tempi. Attendo di sapere dal presidente Forleo, dalla consigliera Goffredo e dal presidente del tribunale Savino - aveva attaccato Fitto - perché vengono utilizzi due pesi e due misure in modo così clamoroso. Ci sono dei processi - aveva spiegato per i quali gli stessi componenti del collegio che mi ha condannato hanno fatto valutazioni differenti con tre udienze all'anno, salvo dichiarare la prescrizione di quei procedimenti a differenza del caso mio nel quale ho avuto il privilegio di avere tre udienze a settimana". Il riferimento era al processo sulla missione Arcobaleno che era appunto seguito dagli stessi giudici e che invece aveva avuto tempi molto più lunghi. "Questa è la volontà precisa di un collegio che ha compiuto una scelta politica precisa, che è quella di dare un'indicazione a questa campagna elettorale". Alle domande di Fitto vuole rispondere evidentemente ora la procura di Lecce che ha aperto prontamente l'indagine e altrettanto prontamente si è mossa con il tribunale. Tra gli atti che verranno analizzati ci sono appunti i calendari delle udienze: l'obiettivo è capire se sono stati commessi degli abusi, come dice Fitto, o se tutto è stato svolto secondo le regole.
Donna è anche Rita Romano, giudice di Taranto che è stata denunciata da Antonio Giangrande, lo scrittore autore di decine di libri/inchieste, e da questa denunciato perchè lo scrittore ha chiesto la ricusazione del giudice criticato per quei processi in cui questa giudice doveva giudicarlo. La Romano ha condannato la sorella del Giangrande che si proclamava estranea ad un sinistro di cui era accusata di essere responsabile esclusiva, così come nei fatti è emerso, e per questo la sorella del Giangrande aveva denunciato l'avvocato, che aveva promosso i giudizi di risarcimento danni. Avvocato, molto amica di un pubblico ministero del Foro. La Romano ha condannato chi si professava innocente e rinviato gli atti per falsa testimonianza per la sua testimone.
E poi giudice donna è per il processo………
E dire che la Nicole Minetti ebbe a dire «Ovvio che avrei preferito evitarlo, ma visto che ci sarà sono certa che riuscirò a chiarire la mia posizione e a dimostrare la mia innocenza. Da donna mi auguro che a giudicarmi sia un collegio di donne o per lo meno a maggioranza femminile». Perché, non si fida degli uomini? «Le donne riuscirebbero a capire di più la mia estraneità ai fatti. Le donne hanno una sensibilità diversa».
Quello che appare accomunare tutte queste donne giudice è, senza fini diffamatori, che non sono donne normali, ma sono donne in carriera. Il lavoro, innanzi tutto, la famiglia è un bisogno eventuale. E senza famiglia esse sono. Solo la carriera per esse vale e le condanne sono una funzione ausiliare e necessaria, altrimenti che ci stanno a fare: per assolvere?!?
Ma quanti sono le giudici donna? A questa domanda risponde Gabriella Luccioli dal sito Donne Magistrato. La presenza delle donne nella Magistratura Italiana.
L'ammissione delle donne all'esercizio delle funzioni giurisdizionali in Italia ha segnato il traguardo di un cammino lungo e pieno di ostacoli. Come è noto, l'art. 7 della legge 17 luglio 1919 n. 1176 ammetteva le donne all'esercizio delle professioni ed agli impieghi pubblici, ma le escludeva espressamente dall'esercizio della giurisdizione. L'art. 8 dell'ordinamento giudiziario del 1941 poneva quali requisiti per accedere alle funzioni giudiziarie “essere cittadino italiano, di razza ariana, di sesso maschile ed iscritto al P.N.F.". Pochi anni dopo, il dibattito in seno all’Assemblea Costituente circa l’accesso delle donne alla magistratura fu ampio e vivace ed in numerosi interventi chiaramente rivelatore delle antiche paure che la figura della donna magistrato continuava a suscitare: da voci autorevoli si sostenne che “nella donna prevale il sentimento sul raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio sul sentimento” (on. Cappi); che “ soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomo-fisiologico la donna non può giudicare” (on. Codacci); si ebbe inoltre cura di precisare che “non si intende affermare una inferiorità nella donna; però da studi specifici sulla funzione intellettuale in rapporto alle necessità fisiologiche dell’uomo e della donna risultano certe diversità, specialmente in determinati periodi della vita femminile” (on. Molè). Più articolate furono le dichiarazioni dell’onorevole Leone, il quale affermò: “Si ritiene che la partecipazione illimitata delle donne alla funzione giurisdizionale non sia per ora da ammettersi. Che la donna possa partecipare con profitto là dove può far sentire le qualità che le derivano dalla sua sensibilità e dalla sua femminilità, non può essere negato. Ma negli alti gradi della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possono mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni”; e che pertanto alle donne poteva essere consentito giudicare soltanto in quei procedimenti per i quali era maggiormente avvertita la necessità di una presenza femminile, in quanto richiedevano un giudizio il più possibile conforme alla coscienza popolare. Si scelse infine di mantenere il silenzio sulla specifica questione della partecipazione delle donne alle funzioni giurisdizionali, stabilendo all’art. 51 che “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Si intendeva in tal modo consentire al legislatore ordinario di prevedere il genere maschile tra i requisiti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, in deroga al principio dell’eguaglianza tra i sessi, e ciò ritardò fortemente l’ingresso delle donne in magistratura. Solo con la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 fu permesso alle donne di far parte nei collegi di corte di assise, con la precisazione che almeno tre giudici dovessero essere uomini. La legittimità costituzionale di tale disposizione fu riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 56 del 1958, nella quale si affermò che ben poteva la legge “ tener conto, nell’interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purchè non fosse infranto il canone fondamentale dell’eguaglianza giuridica”. Fu necessario aspettare quindici anni dall’entrata in vigore della Carta fondamentale perchè il Parlamento - peraltro direttamente sollecitato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 33 del 1960, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo il richiamato art. 7 della legge n. 1176 del 1919, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l’esercizio di diritti e di potestà politiche - approvasse una normativa specifica, la legge n. 66 del 9 febbraio 1963, che consentì l' accesso delle donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura. Dall'entrata in vigore della Costituzione si erano svolti ben sedici concorsi per uditore giudiziario, con un totale di 3127 vincitori, dai quali le donne erano state indebitamente escluse. Con decreto ministeriale del 3 maggio 1963 fu bandito il primo concorso aperto alla partecipazione delle donne: otto di loro risultarono vincitrici e con d.m. 5 aprile del 1965 entrarono nel ruolo della magistratura. Da quel primo concorso l’accesso delle donne nell’ordine giudiziario ha registrato nel primo periodo dimensioni modeste, pari ad una media del 4% -5% per ogni concorso, per aumentare progressivamente intorno al 10% -20%“ dopo gli anni ’70, al 30% - 40% negli anni ’80 e registrare un’impennata negli anni successivi, sino a superare ormai da tempo ampiamente la metà. Attualmente le donne presenti in magistratura sono 3788, per una percentuale superiore al 40% del totale, e ben presto costituiranno maggioranza, se continuerà il trend che vede le donne vincitrici di concorso in numero di gran lunga superiore a quello degli uomini. Come è evidente, tale fenomeno è reso possibile dal regime di assunzione per concorso pubblico, tale da escludere qualsiasi forma di discriminazione di genere; esso è inoltre alimentato dalla presenza sempre più marcata delle studentesse nelle facoltà di giurisprudenza, superiore a quello degli uomini. Dal primo concorso ad oggi il profilo professionale delle donne magistrato è certamente cambiato. Alle prime generazioni fu inevitabile, almeno inizialmente, omologare totalmente il proprio ideale di giudice all’unico modello professionale di riferimento ed integrarsi in quel sistema declinato unicamente al maschile attraverso un processo di completa imitazione ed introiezione di tale modello, quale passaggio necessario per ottenere una piena legittimazione. Ma ben presto, una volta pagato per intero il prezzo della loro ammissione, superando la prova che si richiedeva loro di essere brave quanto gli uomini, efficienti quanto gli uomini, simili il più possibile agli uomini, e spesso vivendo in modo colpevolizzante i tempi della gravidanza e della maternità come tempi sottratti all’attività professionale, si pose alle donne magistrato il dilemma se continuare in una assunzione totale del modello dato, di per sé immune da rischi e collaudata da anni di conquistate gratificazioni, o tentare il recupero di una identità complessa, tracciando un approccio al lavoro, uno stile, un linguaggio, delle regole comportamentali sulle quali costruire una figura professionale di magistrato al femminile.
Certo che a parlar male di loro si rischia grosso. Ma i giornalisti questo coraggio ce l’hanno?
Certo che no! Per fare vero giornalismo forse è meglio non essere giornalisti.
PARLIAMO DEI BRAVI CHE NON POSSONO ESERCITARE, EPPURE ESERCITANO.
Questa è “Mi-Jena Gabanelli” (secondo Dagospia), la Giovanna D’Arco di Rai3, che i grillini volevano al Quirinale. Milena Gabanelli intervistata da Gian Antonio Stella per "Sette - Corriere della Sera".
Sei impegnata da anni nella denuncia delle storture degli ordini professionali: cosa pensi dell'idea di Grillo di abolire solo quello dei giornalisti?
«Mi fa un po' sorridere. Credo che impareranno che esistono altri ordini non meno assurdi. Detto questo, fatico a vedere l'utilità dell'Ordine dei giornalisti. Credo sarebbe più utile, come da altre parti, un'associazione seria e rigorosa nella quale si entra per quello che fai e non tanto per aver dato un esame...».
Ti pesa ancora la bocciatura?
«Vedi un po' tu. L'ho fatto assieme ai miei allievi della scuola di giornalismo. Loro sono passati, io no».
Bocciata agli orali per una domanda su Pannunzio.
«Non solo. Avrò risposto a tre domande su dieci. Un disastro. Mi chiesero cos'era il Coreco. Scena muta».
Come certi parlamentari beccati dalle Iene fuori da Montecitorio...
«Le Iene fanno domande più serie. Tipo qual è la capitale della Libia. Il Coreco!».
Essere bocciata come Alberto Moravia dovrebbe consolarti.
«C'era una giovane praticante che faceva lo stage da noi. Le avevo corretto la tesina... Lei passò, io no. Passarono tutti, io no».
Mai più rifatto?
«No. Mi vergognavo. Per fare gli orali dovevi mandare a memoria l'Abruzzo e io lavorando il tempo non l'avevo».
Nel senso del libro di Franco Abruzzo, giusto?
«Non so se c'è ancora quello. So che era un tomo che dovevi mandare a memoria per sapere tutto di cose che quando ti servono le vai a vedere volta per volta. Non ha senso. Ho pensato che si può sopravvivere lo stesso, anche senza essere professionista».
Tornando al caso Ruby, logica vorrebbe che chi ha avuto la fortuna nella vita di fare tanti soldi dovrebbe sistemare innanzi tutto i propri figli. Fatto ciò, dovrebbe divertirsi e godersi la vita e se, altruista, fare beneficenza.
Bene. L’assurdità di un modo di ragionare sinistroide ed invidioso, perverso e squilibrato, pretenderebbe (e di fatto fa di tutto per attuarlo) che per i ricchi dovrebbe valere la redistribuzione forzosa della loro ricchezza agli altri (meglio se sinistri) e se a questo vi si accomuna un certo tipo di divertimento, allora vi è meretricio. In questo caso non opera più la beneficenza volontaria, ma scatta l’espropriazione proletaria.
Una cosa è certa. In questa Italia di m….. le tasse aumentano, cosi come le sanguisughe. I disservizi e le ingiustizie furoreggiano. Ma allora dove cazzo vanno a finire i nostri soldi se è vero, come è vero, che sono ancora di più gli italiani che oltre essere vilipesi, muoiono di fame? Aumenta in un anno l’incidenza della povertà assoluta in Italia. Come certifica l’Istat, le persone in povertà assoluta passano dal 5,7% della popolazione del 2011 all’8% del 2012, un record dal 2005. È quanto rileva il report «La povertà in Italia», secondo cui nel nostro Paese sono 9 milioni 563 mila le persone in povertà relativa, pari al 15,8% della popolazione. Di questi, 4 milioni e 814 mila (8%) sono i poveri assoluti, cioè che non riescono ad acquistare beni e servizi essenziali per una vita dignitosa. Una situazione accentuata soprattutto al Sud. Nel 2012 infatti quasi la metà dei poveri assoluti (2 milioni 347 mila persone) risiede nel Mezzogiorno. Erano 1 milione 828 mila nel 2011.
Ed è con questo stato di cose che ci troviamo a confrontarci quotidianamente. Ed a tutto questo certo non corrisponde un Stato efficace ed efficiente, così come ampiamente dimostrato. Anzi nonostante il costo del suo mantenimento questo Stato si dimostra incapace ed inadeguato.
Eppure ad una mancanza di servizi corrisponde una Spesa pubblica raddoppiata. E tasse locali che schizzano all'insù. Negli ultimi venti anni le imposte riconducibili alle amministrazioni locali sono aumentate da 18 a 108 miliardi di euro, «con un eccezionale incremento di oltre il 500% ». È quanto emerge da uno studio della Confcommercio in collaborazione con il Cer (Centro Europa Ricerche) che analizza le dinamiche legate al federalismo fiscale a partire dal 1992. È uno studio del Corriere della Sera a riportare al centro del dibattito la questione delle tasse locali e della pressione fiscale sugli italiani. Con una interessante intervista a Luca Antonini, presidente della Commissione sul federalismo fiscale e poi alla guida del Dipartimento delle Riforme di Palazzo Chigi, si mettono in luce le contraddizioni e il peso di “un sistema ingestibile”: “Cresce la spesa statale e cresce la spesa locale, crescono le tasse nazionali (+95% in 20 anni secondo Confcommercio) e crescono quelle locali (+500%). Così non può funzionare. Non c'è una regia, manca completamente il ruolo di coordinamento dello Stato”. Sempre dal 1992 la spesa corrente delle amministrazioni centrali (Stato e altri enti) è cresciuta del 53%. La spesa di regioni, province e comuni del 126% e quella degli enti previdenziali del 127%: il risultato è che la spesa pubblica complessiva è raddoppiata. «Per fronteggiare questa dinamica - sottolinea il dossier - si è assistito ad una esplosione del gettito derivante dalle imposte (dirette e indirette) a livello locale con un aumento del 500% a cui si è associato il sostanziale raddoppio a livello centrale. I cittadini si aspettavano uno Stato più efficiente, una riduzione degli sprechi, maggior responsabilità politica dagli amministratori locali. Non certo di veder aumentare le tasse pagate allo Stato e pure quelle versate al Comune, alla Provincia e alla Regione. E invece è successo proprio così: negli ultimi vent'anni le imposte nazionali sono raddoppiate, e i tributi locali sono aumentati addirittura cinque volte. Letteralmente esplosi. Tanto che negli ultimi dodici anni le addizionali Irpef regionali e comunali sono cresciute del 573%, ed il loro peso sui redditi è triplicato, arrivando in alcuni casi oltre il 17%.
Nonostante che i Papponi di Stato, centrali e periferici, siano mantenuti dai tartassati ecco che è clamorosa l'ennesima uscita dell'assessore Franco D'Alfonso, lo stesso che voleva proibire i gelati dopo mezzanotte ricoprendo Milano di ridicolo e che si è ripetuto in versione giacobina accusando Dolce e Gabbana di evasione fiscale a iter giudiziario non ancora concluso. Provocando i tre giorni di serrata dei nove negozi D&G di Milano. E a chi avesse solo immaginato la possibilità di rinnegarlo, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia fa subito capire che il suo vero bersaglio non è D'Alfonso e il suo calpestare il più elementare stato di diritto, ma gli stilisti offesi. «Che c'entra “Milano fai schifo”? Sono molte - va all'attacco un durissimo Pisapia - le cose che fanno schifo, ma non ho mai visto chiudere i loro negozi per le stragi, le guerre, le ingiustizie». Ricordando che il fisco, le sue regole e le sanzioni contro le infrazioni, non sono materia di competenza del Comune. Giusto. Perché in quella Babilonia che è diventata il Comune tra registri per le coppie omosessuali, no-global che occupano e rom a cui rimborsare le case costruite abusivamente, nulla succede per caso. Intanto, però, i negozi, i ristoranti, i bar e l'edicola di Dolce e Gabbana sono rimasti chiusi per giorni. In protesta contro le indagini della Gdf e le sentenze di condanna in primo grado del Tribunale, dopo le dichiarazioni dell'assessore al Commercio, Franco D'Alfonso, sul non «concedere spazi pubblici a marchi condannati per evasione». «Spazi mai richiesti», secondo i due stilisti, che con l'ennesimo tweet hanno rilanciato la campagna contro il Comune.
Uomini trattati da animali dai perbenisti di maniera. Politici inetti, incapaci ed ipocriti che si danno alla zoologia.
Anatra – Alla politica interessa solo se è zoppa. Una maggioranza senza maggioranza.
Asino – Simbolo dei democrat Usa. In Italia ci provò Prodi con risultati scarsi.
Balena – La b. bianca fu la Dc. La sua estremità posteriore è rimasta destinazione da augurio.
Caimano – Tra le definizioni correnti di Berlusconi. Dovuto a un profetico film di Nanni Moretti.
Cignalum – Sistema elettorale toscano da cui, per involuzione, nacque il porcellum (v.).
Cimice – Di provenienza statunitense, di recente pare abbia invaso l’Europa.
Colomba – Le componenti più disponibili al dialogo con gli avversari. Volatili.
Coccodrillo – Chi piange sul latte versato. Anche articolo di commemorazione redatto pre-mortem.
Delfino – Destinato alla successione. Spesso è un mistero: a oggi non si sa chi sia il d. del caimano (v.).
Elefante – Simbolo dei republican Usa. L’e. rosso fu il Pci. La politica si muove “Come un e. in una cristalleria”.
Falco – Le componenti meno disponibili al dialogo con gli avversari. Amano le picchiate.
Gambero – Il suo passo viene evocato quando si parla della nostra economia.
Gattopardo – Da Tomasi di Lampedusa in poi segno dell’immutabilità della politica. Sempre attuale.
Giaguaro – Ci fu un tentativo di smacchiarlo. Con esiti assai deludenti.
Grillo – Il primo fu quello di Pinocchio. L’attuale, però, dice molte più parolacce.
Gufo – Uno che spera che non vincano né i falchi né le colombe.
Orango – L’inventore del Porcellum (vedi Roberto Calderoli Cecile Kyenge) ne ha fatto un uso ributtante confermandosi uomo bestiale.
Piccione – Di recente evocato per sé, come obiettivo di tiro libero, da chi disprezzò il tacchino (v.).
Porcellum – Una porcata di sistema elettorale che tutti vogliono abolire, ma è sempre lì.
Pitonessa – Coniato specificatamente per Daniela Santanchè. Sinuosa e infida, direi.
Struzzo - Chi non vuol vedere e mette la testa nella sabbia. Un esercito.
Tacchino – Immaginato su un tetto da Bersani, rischiò di eclissare il giaguaro.
Tartaruga – La t. un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Ora dà il passo alla ripresa.
Ed a proposito di ingiustizia e “canili umani”. La presidente della Camera, Laura Boldrini, il 22 luglio 2013 durante la visita ai detenuti del carcere di Regina Coeli, ha detto: «Il sovraffollamento delle carceri non è più tollerabile, spero che Governo e Parlamento possano dare una risposta di dignità ai detenuti e a chi lavora. Ritengo che sia importante tenere alta l’attenzione sull’emergenza carceri e sono qui proprio per dare attenzione a questo tema, la situazione delle carceri è la cartina di tornasole del livello di civiltà di un Paese. La certezza del diritto è fondamentale: chi ha sbagliato deve pagare, non chiediamo sconti, ma è giusto che chi entra in carcere possa uscire migliore, è giusto che ci sia la rieducazione e in una situazione di sovraffollamento è difficile rieducare perché non si fa altro che tirare fuori il peggio dell’essere umano e non il meglio. Nel codice non c’è scritto che un’ulteriore pena debba essere quella del sovraffollamento. Costruire nuove strutture è complicato perché non ci sono risorse ma in alcuni carceri ci sono padiglioni non utilizzati e con un po’ di fondi sarebbe possibile renderli agibili. In più bisogna mettere in atto misure alternative e considerare le misure di custodia cautelare perché il 40% dei detenuti non ha una condanna definitiva. Bisogna ripensare, rivedere il sistema di custodia cautelare. Perché se quelle persone sono innocenti, il danno è irreparabile». «Dignità, dignità». Applaudono e urlano, i detenuti della terza sezione del carcere di Regina Coeli quando vedono arrivare il presidente della Camera Laura Boldrini, in visita ufficiale al carcere romano che ha una capienza di 725 unità e ospita, invece, più di mille persone. Urlano i detenuti per invocare «giustizia e libertà» che il sovraffollamento preclude non solo a loro, ma anche agli agenti di polizia penitenziaria costretti a turni insostenibili (a volte «c'è un solo agente per tre piani, per circa 250 detenuti» confessa un dipendente). “Vogliamo giustizia, libertà e dignità”, sono queste invece le parole che hanno intonato i detenuti durante la visita della Boldrini. I detenuti nell'incontro con il presidente della Camera hanno voluto sottolineare che cosa significa in concreto sovraffollamento: "Secondo la Corte europea di Giustizia ", ha detto uno di loro "ogni detenuto ha diritto a otto metri quadri di spazio, esclusi bagno e cucina. Noi abbiamo 17 metri quadri per tre detenuti, in letti a castello con materassi di gomma piuma che si sbriciolano e portano l'orma di migliaia di detenuti. Anche le strutture ricreative sono state ridotte a luoghi di detenzione. Questo non è un carcere ma un magazzino di carne umana". E' stata la seconda visita a un istituto carcerario italiano per Laura Boldrini da quando è diventata presidente della Camera dei deputati. A Regina Coeli, dove la capienza sarebbe di 725 detenuti, ve ne sono attualmente circa 1.050; le guardie carcerarie sono 460 ma ne sarebbero previste 614. «Ho voluto fortemente questo incontro, non avrebbe avuto senso la mia visita, sarebbe stata una farsa. Ora mi sono resa conto di persona della situazione nelle celle e condivido la vostra indignazione» ha replicato la Boldrini ai detenuti. Dici Roma, dici Italia.
Già!! La giustizia e le nostre vite in mano a chi?
«Antonio Di Pietro è il primo a lasciare l'ufficio di Borrelli. È irriconoscibile. Cammina come un ubriaco, quasi appoggiandosi ai muri». Così scrive Goffredo Buccini sul Corriere della Sera del 24 luglio 1993, il giorno dopo il suicidio di Raul Gardini.
«Per me fu una sconfitta terribile - racconta oggi Antonio Di Pietro ad Aldo Cazzullo su “Il Corriere della Sera” -. La morte di Gardini è il vero, grande rammarico che conservo della stagione di Mani pulite. Per due ragioni. La prima: quel 23 luglio Gardini avrebbe dovuto raccontarmi tutto: a chi aveva consegnato il miliardo di lire che aveva portato a Botteghe Oscure, sede del Pci; chi erano i giornalisti economici corrotti, oltre a quelli già rivelati da Sama; e chi erano i beneficiari del grosso della tangente Enimont, messo al sicuro nello Ior. La seconda ragione: io Gardini lo potevo salvare. La sera del 22, poco prima di mezzanotte, i carabinieri mi chiamarono a casa a Curno, per avvertirmi che Gardini era arrivato nella sua casa di piazza Belgioioso a Milano e mi dissero: "Dottore che facciamo, lo prendiamo?". Ma io avevo dato la mia parola agli avvocati che lui sarebbe arrivato in Procura con le sue gambe, il mattino dopo. E dissi di lasciar perdere. Se l'avessi fatto arrestare subito, sarebbe ancora qui con noi».
Ma proprio questo è il punto. Il «Moro di Venezia», il condottiero dell'Italia anni 80, il padrone della chimica non avrebbe retto l'umiliazione del carcere. E molte cose lasciano credere che non se la sarebbe cavata con un interrogatorio. Lei, Di Pietro, Gardini l'avrebbe mandato a San Vittore?
«Le rispondo con il cuore in mano: non lo so. Tutto sarebbe dipeso dalle sue parole: se mi raccontava frottole, o se diceva la verità. Altre volte mi era successo di arrestare un imprenditore e liberarlo in giornata, ad esempio Fabrizio Garampelli: mi sentii male mentre lo interrogavo - un attacco di angina -, e fu lui a portarmi in ospedale con il suo autista... Io comunque il 23 luglio 1993 ero preparato. Avevo predisposto tutto e allertato la mia squadretta, a Milano e a Roma. Lavoravo sia con i carabinieri, sia con i poliziotti, sia con la Guardia di Finanza, pronti a verificare quel che diceva l'interrogato. Se faceva il nome di qualcuno, prima che il suo avvocato potesse avvertirlo io gli mandavo le forze dell'ordine a casa. Sarebbe stata una giornata decisiva per Mani pulite. Purtroppo non è mai cominciata».
Partiamo dall'inizio. Il 20 luglio di vent'anni fa si suicida in carcere, con la testa in un sacchetto di plastica, Gabriele Cagliari, presidente dell'Eni.
«L'Eni aveva costituito con la Montedison di Gardini l'Enimont. Ma Gardini voleva comandare - è la ricostruzione di Di Pietro -. Quando diceva "la chimica sono io", ne era davvero convinto. E quando vide che i partiti non intendevano rinunciare alla mangiatoia della petrolchimica pubblica, mamma del sistema tangentizio, lui si impuntò: "Io vendo, ma il prezzo lo stabilisco io". Così Gardini chiese tremila miliardi, e ne mise sul piatto 150 per la maxitangente. Cagliari però non era in carcere per la nostra inchiesta, ma per l'inchiesta di De Pasquale su Eni-Sai. Non si possono paragonare i due suicidi, perché non si possono paragonare i due personaggi. Cagliari era un uomo che sputava nel piatto in cui aveva mangiato. Gardini era un uomo che disprezzava e comprava, e disprezzava quel che comprava. Il miliardo a Botteghe Oscure lo portò lui. Il suo autista Leo Porcari mi aveva raccontato di averlo lasciato all'ingresso del quartier generale comunista, ma non aveva saputo dirmi in quale ufficio era salito, se al secondo o al quarto piano: me lo sarei fatto dire da Gardini. Ma era ancora più importante stabilire chi avesse imboscato la maxitangente, probabilmente portando i soldi al sicuro nello Ior. Avevamo ricostruito la destinazione di circa metà del bottino; restavano da rintracciare 75 miliardi».
Chi li aveva presi?
«Qualcuno l'abbiamo trovato. Ad esempio Arnaldo Forlani: non era certo Severino Citaristi a gestire simili cifre. Non è vero che il segretario dc fu condannato perché non poteva non sapere, e lo stesso vale per Bettino Craxi, che fu condannato per i conti in Svizzera. Ma il grosso era finito allo Ior. Allora c'era il Caf».
Craxi. Forlani. E Giulio Andreotti.
«Il vero capo la fa girare, ma non la tocca. Noi eravamo arrivati a Vito Ciancimino, che era in carcere, e a Salvo Lima, che era morto. A Palermo c'era già Giancarlo Caselli, tra le due Procure nacque una stretta collaborazione, ci vedevamo regolarmente e per non farci beccare l'appuntamento era a casa di Borrelli. Ingroia l'ho conosciuto là».
Torniamo a Gardini. E al 23 luglio 1993.
«Con Francesco Greco avevamo ottenuto l'arresto. Un gran lavoro di squadra. Io ero l'investigatore. Piercamillo Davigo era il tecnico che dava una veste giuridica alle malefatte che avevo scoperto: arrivavo nel suo ufficio, posavo i fascicoli sulla scrivania, e gli dicevo in dipietrese: "Ho trovato quindici reati di porcata. Ora tocca a te trovargli un nome". Gherardo Colombo, con la Guardia di Finanza, si occupava dei riscontri al mio lavoro di sfondamento, rintracciava i conti correnti, trovava il capello (sic) nell'uovo. Gli avvocati Giovanni Maria Flick e Marco De Luca vennero a trattare il rientro di Gardini, che non era ancora stato dichiarato latitante. Fissammo l'appuntamento per il 23, il mattino presto». «Avevamo stabilito presidi a Ravenna, Roma, a Milano e allertato le frontiere. E proprio da Milano, da piazza Belgioioso dove Gardini aveva casa, mi arriva la telefonata: ci siamo, lui è lì. In teoria avrei dovuto ordinare ai carabinieri di eseguire l'arresto. Gli avrei salvato la vita. Ma non volevo venir meno alla parola data. Così rispondo di limitarsi a sorvegliare con discrezione la casa. Il mattino del 23 prima delle 7 sono già a Palazzo di Giustizia. Alle 8 e un quarto mi telefona uno degli avvocati, credo De Luca, per avvertirmi che Gardini sta venendo da me, si sono appena sentiti. Ma poco dopo arriva la chiamata del 113: "Gardini si è sparato in testa". Credo di essere stato tra i primi a saperlo, prima anche dei suoi avvocati». «Mi precipito in piazza Belgioioso, in cinque minuti sono già lì. Entro di corsa. Io ho fatto il poliziotto, ne ho visti di cadaveri, ma quel mattino ero davvero sconvolto. Gardini era sul letto, l'accappatoio insanguinato, il buco nella tempia».
E la pistola?
«Sul comodino. Ma solo perché l'aveva raccolta il maggiordomo, dopo che era caduta per terra. Capii subito che sarebbe partito il giallo dell'omicidio, già se ne sentiva mormorare nei conciliaboli tra giornalisti e pure tra forze dell'ordine, e lo dissi fin dall'inizio: nessun film, è tutto fin troppo chiaro. Ovviamente in quella casa mi guardai attorno, cercai una lettera, un dettaglio rivelatore, qualcosa: nulla».
Scusi Di Pietro, ma spettava a lei indagare sulla morte di Gardini?
«Per carità, Borrelli affidò correttamente l'inchiesta al sostituto di turno, non ricordo neppure chi fosse, ma insomma un'idea me la sono fatta...».
Quale?
«Fu un suicidio d'istinto. Un moto d'impeto, non preordinato. Coerente con il personaggio, che era lucido, razionale, coraggioso. Con il pelo sullo stomaco; ma uomo vero. Si serviva di Tangentopoli, che in fondo però gli faceva schifo. La sua morte per me fu un colpo duro e anche un coitus interruptus».
Di Pietro, c'è di mezzo la vita di un uomo.
«Capisco, non volevo essere inopportuno. È che l'interrogatorio di Gardini sarebbe stato una svolta, per l'inchiesta e per la storia d'Italia. Tutte le altre volte che nei mesi successivi sono arrivato vicino alla verità, è sempre successo qualcosa, sono sempre riusciti a fermarmi. L'anno dopo, era il 4 ottobre, aspettavo le carte decisive dalla Svizzera, dal giudice Crochet di Ginevra: non sono mai arrivate. Poi mi bloccarono con i dossier, quando ero arrivato sulla soglia dell'istituto pontificio...».
Ancora i dossier?
«Vada a leggersi la relazione del Copasir relativa al 1995: contro di me lavoravano in tanti, dal capo della polizia Parisi a Craxi».
Lei in morte di Gardini disse: «Nessuno potrà più aprire bocca, non si potrà più dire che gli imputati si ammazzano perché li teniamo in carcere sperando che parlino».
«Può darsi che abbia detto davvero così. Erano giornate calde. Ma il punto lo riconfermo: non è vero, come si diceva già allora, che arrestavamo gli inquisiti per farli parlare. Quando arrestavamo qualcuno sapevamo già tutto, avevamo già trovato i soldi. E avevamo la fila di imprenditori disposti a parlare».
Altri capitani d'industria hanno avuto un trattamento diverso.
«Carlo De Benedetti e Cesare Romiti si assunsero le loro responsabilità. Di loro si occuparono la Procura di Roma e quella di Torino. Non ci furono favoritismi né persecuzioni. Purtroppo, nella vicenda di Gardini non ci furono neanche vincitori; quel giorno abbiamo perso tutti».
Dopo 20 anni Di Pietro è senza: pudore: «Avrei potuto salvarlo». Mani Pulite riscritta per autoassolversi. L'ex pm: "Avrei dovuto arrestarlo e lui avrebbe parlato delle mazzette al Pci". La ferita brucia ancora. Vent'anni fa Antonio Di Pietro, allora l'invincibile Napoleone di Mani pulite, si fermò sulla porta di Botteghe Oscure e il filo delle tangenti rosse si spezzò con i suoi misteri, scrive Stefano Zurlo su “Il Giornale”. Per questo, forse per trovare una spiegazione che in realtà spiega solo in parte, l'ex pm racconta che il suicidio di Raul Gardini, avvenuto il 23 luglio '93 a Milano, fu un colpo mortale per quell'indagine. «La sua morte - racconta Di Pietro ad Aldo Cazzullo in un colloquio pubblicato ieri dal Corriere della Sera - fu per me un coitus interruptus». Il dipietrese s'imbarbarisce ancora di più al cospetto di chi non c'è più, ma non è questo il punto. È che l'ormai ex leader dell'Italia dei Valori si autoassolve a buon mercato e non analizza con la dovuta brutalità il fallimento di un'inchiesta che andò a sbattere contro tanti ostacoli. Compresa l'emarginazione del pm Tiziana Parenti, titolare di quel filone. E non s'infranse solo sulla tragedia di piazza Belgioioso. Di Pietro, come è nel suo stile, semplifica e fornisce un quadro in cui lui e il Pool non hanno alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per quel fiasco. Tutto finì invece con quei colpi di pistola: «Quel 23 luglio Gardini avrebbe dovuto raccontarmi tutto: a chi aveva consegnato il miliardo di lire che aveva portato a Botteghe Oscure, sede del Pci; chi erano i giornalisti economici corrotti, oltre a quelli già rivelati da Sama; e chi erano i beneficiari del grosso della tangente Enimont, messo al sicuro nello Ior». E ancora, a proposito di quel miliardo su cui tanto si è polemizzato in questi anni, specifica: «Il suo autista Leo Porcari mi aveva raccontato di averlo lasciato all'ingresso del quartier generale comunista, ma non aveva saputo dirmi in quale ufficio era salito, se al secondo o al quarto piano: me lo sarei fatto dire da Gardini». Il messaggio che arriva è chiaro: lui ha fatto tutto quel che poteva per scoprire i destinatari di quel contributo illegale, sulla cui esistenza non c'è il minimo dubbio, ma quel 23 luglio cambiò la storia di Mani pulite e in qualche modo quella d'Italia e diventa una data spartiacque, come il 25 luglio 43. Vengono i brividi, ma questa ricostruzione non può essere accettata acriticamente e dovrebbero essere rivisti gli errori, e le incertezze dell'altrove insuperabile Pool sulla strada del vecchio Pci. Non si può scaricare su chi non c'è più la responsabilità di non aver scoperchiato quella Tangentopoli. Di Pietro invece se la cava così, rammaricandosi solo di non aver fatto ammanettare il signore della chimica italiana la sera prima, quando i carabinieri lo avvisarono che Gardini era a casa, in piazza Belgioioso. «M avevo dato la mia parola agli avvocati che lui sarebbe arrivato in procura con le sue gambe, il mattino dopo». Quello fatale. «E dissi di lasciar perdere. Se l'avessi fatto arrestare subito sarebbe ancora qui con noi. Io Gardini lo potevo salvare». La storia non si fa con i se. E quella delle tangenti rosse è finita prima ancora di cominciare.
Pomicino: il pm Di Pietro tentò di farmi incastrare Napolitano. L'ex ministro Cirino Pomicino: "Inventando una confessione, cercò di spingermi a denunciare una tangente all'attuale capo dello Stato, poi spiegò il trucco", scrive Paolo BracaliniIl Giornale E mentre la truccatrice gli passa la spazzola sulla giacca, prima di entrare nello studio tv di Agorà, 'o ministro ti sgancia la bomba: «Di Pietro mi chiese: "È vero che Giorgio Napolitano ha ricevuto soldi da lei?". Io risposi che non era vero, ma lui insisteva. "Guardi che c'è un testimone, un suo amico, che lo ha confessato". "Se l'ha detto, ha detto una sciocchezza, perché non è vero" risposi io. E infatti la confessione era finta, me lo rivelò lo stesso Di Pietro poco dopo, un tranello per farmi dire che Napolitano aveva preso una tangente. Ma si può gestire la giustizia con questi metodi? E badi bene che lì aveva trovato uno come me, ma normalmente la gente ci metteva due minuti a dire quel che volevano fargli dire". "In quegli anni le persone venivano arrestate, dicevano delle sciocchezze, ammettevano qualsiasi cosa e il pm li faceva subito uscire e procedeva col patteggiamento. Quando poi queste persone venivano chiamate a testimoniare nel processo, contro il politico che avevano accusato, potevano avvalersi della facoltà di non rispondere. E quindi restavano agli atti le confessioni false fatte a tu per tu col pubblico ministero», aveva già raccontato Pomicino in una lunga intervista video pubblicata sul suo blog paolocirinopomicino.it. La stessa tesi falsa, cioè che Napolitano, allora presidente della Camera, esponente Pds dell'ex area migliorista Pci, avesse ricevuto dei fondi, per sé e per la sua corrente, col tramite dell'ex ministro democristiano, Pomicino se la ritrovò davanti in un altro interrogatorio, stavolta a Napoli. «Il pm era il dottor Quatrano (nel 2001 partecipò ad un corteo no global e l'allora Guardasigilli Roberto Castelli promosse un'azione disciplinare). Mi fece incontrare una persona amica, agli arresti, anche lì per farmi dire che avevo dato a Napolitano e alla sua corrente delle risorse finanziaria». La ragione di quel passaggio di soldi a Napolitano, mai verificatosi ma da confermare a tutti i costi anche col tranello della finta confessione di un amico (uno dei trucchi dell'ex poliziotto Di Pietro, "altre volte dicevano che se parlavamo avremmo avuto un trattamento più mite"), per Cirino Pomicino è tutta politica: «Obiettivo del disegno complessivo era far fuori, dopo la Dc e il Psi, anche la componente amendoliana del Pci, quella più filo-occidentale, più aperta al centrosinistra. Tenga presente che a Milano fu arrestato Cervetti, anch'egli della componente migliorista di Giorgio Napolitano, e fu accusata anche Barbara Pollastrini. Entrambi poi scagionati da ogni accusa». I ricordi sono riemersi di colpo, richiamati dalle «corbellerie» dette da Di Pietro al Corriere a proposito del suicidio di Raul Gardini, vent'anni esatti fa (23 luglio 1993). «Sono allibito che il Corriere della Sera dia spazio alle ricostruzioni false raccontate da Di Pietro. Ho anche mandato un sms a De Bortoli, ma quel che gli ho scritto sono cose private. Di Pietro dice che Gardini si uccise con un moto d'impeto, e che lui avrebbe potuto salvarlo arrestandolo il giorno prima. Io credo che Gardini si sia ucciso per il motivo opposto», forse perché era chiaro che di lì a poche ore sarebbe stato arrestato. Anche Luigi Bisignani, l'«Uomo che sussurra ai potenti» (bestseller Chiarelettere con Paolo Madron), braccio destro di Gardini alla Ferruzzi, conferma questa lettura: «Raul Gardini si suicidò perché la procura aveva promesso che la sua confessione serviva per non andare in carcere, ma invece scoprì che l'avrebbero arrestato». Processo Enimont, la «madre di tutte le tangenti», l'epicentro del terremoto Tangentopoli. «La storia di quella cosiddetta maxitangente, che poi invece, come diceva Craxi, era una maxiballa, è ancora tutta da scrivere. - Pomicino lo spiega meglio - Alla politica andarono 15 o 20 miliardi, ma c'erano 500 miliardi in fondi neri. Dove sono finiti? A chi sono andati? E chi ha coperto queste persone in questi anni? In parte l'ho ricostruito, con documenti che ho, sui fondi Eni finiti a personaggi all'interno dell'Eni. Ma di questo non si parla mai, e invece si pubblicano false ricostruzioni della morte tragica di Gardini».
Ieri come oggi la farsa continua.
Dopo 5 anni arriva la sentenza di primo grado: l'ex-governatore dell'Abruzzo Ottaviano del Turco è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione dal Tribunale collegiale di Pescara nell'inchiesta riguardo le presunti tangenti nella sanità abruzzese. L’ex ministro delle finanze ed ex segretario generale aggiunto della Cgil all’epoca di Luciano Lama è accusato di associazione per delinquere, corruzione, abuso, concussione, falso. Il pm aveva chiesto 12 anni. Secondo la Procura di Pescara l’allora governatore avrebbe intascato 5 milioni di euro da Vincenzo Maria Angelini, noto imprenditore della sanità privata, all’epoca titolare della casa di cura Villa Pini.
«E' un processo che è nato da una vicenda costruita dopo gli arresti, cioè senza prove - attacca l'ex governatore dell'Abruzzo intervistato al Giornale Radio Rai -. Hanno cercato disperatamente le prove per 4 anni e non le hanno trovate e hanno dovuto ricorrere a una specie di teorema e con il teorema hanno comminato condanne che non si usano più nemmeno per gli assassini, in questo periodo. Io sono stato condannato esattamente a 20 anni di carcere come Enzo Tortora». E a Repubblica ha poi affidato un messaggio-shock: «Ho un tumore, ma voglio vivere per dimostrare la mia innocenza».
Lunedì 22 luglio 2013, giorno della sentenza, non si era fatto attendere il commento del legale di Del Turco, Giandomenico Caiazza, che ha dichiarato: «Lasciamo perdere se me lo aspettassi o no perchè questo richiederebbe ragionamenti un pò troppo impegnativi. Diciamo che è una sentenza che condanna un protagonista morale della vita politica istituzionale sindacale del nostro paese accusato di aver incassato sei milioni e 250 mila euro a titolo di corruzione dei quali non si è visto un solo euro. Quindi penso che sia un precedente assoluto nella storia giudiziaria perchè si possono non trovare i soldi ma si trovano le tracce dei soldi».
Nello specifico, Del Turco è accusato insieme all’ex capogruppo del Pd alla Regione Camillo Cesarone e a Lamberto Quarta, ex segretario generale dell’ufficio di presidenza della Regione, di aver intascato mazzette per 5 milioni e 800mila euro. Per questa vicenda fu arrestato il 14 luglio 2008 insieme ad altre nove persone, tra le quali assessori e consiglieri regionali. L’ex presidente finì in carcere a Sulmona (L'Aquila) per 28 giorni e trascorse altri due mesi agli arresti domiciliari. A seguito dell’arresto, Del Turco il 17 luglio 2008 si dimise dalla carica di presidente della Regione e con una lettera indirizzata all’allora segretario nazionale Walter Veltroni si autosospese dal Pd, di cui era uno dei 45 saggi fondatori nonchè membro della Direzione nazionale. Le dimissioni comportarono lo scioglimento del consiglio regionale e il ritorno anticipato alle urne per i cittadini abruzzesi.
Del Turco condannato senza prove. All'ex presidente dell'Abruzzo 9 anni e sei mesi per presunte tangenti nella sanità. Ma le accuse non hanno riscontri: nessuna traccia delle mazzette né dei passaggi di denaro, scrive Gian Marco Chiocci su “Il Giornale”. In dubio pro reo. Nel dubbio - dicevano i latini - decidi a favore dell'imputato. Duole dirlo, e non ce ne voglia il collegio giudicante del tribunale di Pescara, ma la locuzione dei padri del diritto sembra sfilacciarsi nel processo all'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco. Processo che in assenza di prove certe s'è concluso come gli antichi si sarebbero ben guardati dal concluderlo: con la condanna del principale imputato e dei suoi presunti sodali. Qui non interessa riaprire il dibattito sulle sentenze da rispettare o sull'assenza o meno di un giudice a Berlino. Si tratta più semplicemente di capire se una persona - che su meri indizi è finita prima in cella e poi con la vita politica e personale distrutta - di fronte a un processo per certi versi surreale, contraddistintosi per la mancanza di riscontri documentali, possa beccarsi, o no, una condanna pesantissima a nove anni e sei mesi (non nove mesi, come ha detto erroneamente in aula il giudice). Noi crediamo di no. E vi spieghiamo perché. In cinque anni nessuno ha avuto il piacere di toccare con mano le «prove schiaccianti» a carico dell'ex governatore Pd di cui parlò, a poche ore dalle manette, l'allora procuratore capo Trifuoggi. Un solo euro fuori posto non è saltato fuori dai conti correnti dell'indagato eccellente, dei suoi familiari o degli amici più stretti, nemmeno dopo centinaia di rogatorie internazionali e proroghe d'indagini. E se non si sono trovati i soldi, nemmeno s'è trovata una traccia piccola piccola di quei soldi. Quanto alle famose case che Del Turco avrebbe acquistate coi denari delle tangenti (sei milioni di euro) si è dimostrato al centesimo esser state in realtà acquistate con mutui, oppure prima dei fatti contestati o ancora coi soldi delle liquidazioni o le vendite di pezzi di famiglia. Non c'è un'intercettazione sospetta. Non un accertamento schiacciante. Non è emerso niente di clamoroso al processo. Ma ciò non vuol dire che per i pm non ci sia «niente» posto che nella requisitoria finale i rappresentanti dell'accusa hanno spiegato come l'ex segretario della Cgil in passato avesse ricoperto i ruoli di presidente della commissione parlamentare Antimafia e di ministro dell'Economia, e dunque fosse a conoscenza dei «sistemi» criminali utilizzati per occultare i quattrini oltre confine. Come dire: ecco perché i soldi non si trovano (sic !). Per arrivare a un verdetto del genere i giudici, e in origine i magistrati di Pescara (ieri assolutamente sereni prima della sentenza, rinfrancati dalla presenza a sorpresa in aula del loro ex procuratore capo) hanno creduto alle parole del re delle cliniche abruzzesi, Vincenzo Maria Angelini, colpito dalla scure della giunta di centrosinistra che tagliava fondi alla sanità privata, per il quale i carabinieri sollecitarono (invano) l'arresto per tutta una serie di ragioni che sono poi emerse, e deflagrate, in un procedimento parallelo: quello aperto non a Pescara bensì a Chieti dove tal signore è sotto processo per bancarotta per aver distratto oltre 180 milioni di euro con operazioni spericolate, transazioni sospette, spese compulsive per milioni e milioni in opere d'arte e beni di lusso. Distrazioni, queste sì, riscontrate nel dettaglio dagli inquirenti teatini. Da qui il sospetto, rimasto tale, che il super teste possa avere utilizzato per sé (vedi Chieti) ciò che ha giurato (a Pescara) di avere passato ai politici. Nel «caso Del Turco» alla mancanza di riscontri si è supplito con le sole dichiarazioni dell'imprenditore, rivelatesi raramente precise e puntuali come dal dichiarante di turno pretendeva un certo Giovanni Falcone. Angelini sostiene che prelevava contanti solo per pagare i politici corrotti? Non è vero, prelevava di continuo ingenti somme anche prima, e pure dopo le manette (vedi inchiesta di Chieti). Angelini giura che andava a trovare Del Turco nella sua casa di Collelongo, uscendo al casello autostradale di Aiello Celano? Non è vero, come dimostrano i telepass, le testimonianze e le relazioni degli autisti, a quel casello l'auto della sua azienda usciva prima e dopo evidentemente anche per altri motivi. Angelini dice che ha incontrato Del Turco a casa il giorno x? Impossibile, quel giorno si festeggiava il santo patrono e in casa i numerosi vertici istituzionali non hanno memoria della gola profonda. Angelini porta la prova della tangente mostrando una fotografia sfocata dove non si riconosce la persona ritratta? In dibattimento la difesa ha fornito la prova che quella foto risalirebbe ad almeno un anno prima, e così cresce il giallo del taroccamento. Angelini corre a giustificarsi consegnando ai giudici il giaccone che indossava quando passò la mazzetta nel 2007, e di lì a poco la casa produttrice della giubba certifica che quel modello nel 2007 non esisteva proprio essendo stato prodotto a far data 2011. Questo per sintetizzare, e per dire che le prove portate da Angelini, che la difesa ribattezza «calunnie per vendetta», sono tutt'altro che granitiche come una sana certezza del diritto imporrebbe. Se per fatti di mafia si è arrivati a condannare senza prove ricorrendo alla convergenza del molteplice (il fatto diventa provato se lo dicono più pentiti) qui siamo decisamente oltre: basta uno, uno soltanto, e sei fregato. «Basta la parola», recitava lo spot di un celebre lassativo. Nel dubbio, d'ora in poi, il reo presunto è autorizzato a farsela sotto. Del Turco: "Ho un cancro, voglio vivere per provare la mia innocenza". «Da tre mesi so di avere un tumore, da due sono in chemioterapia. Domani andrò a Roma a chiedere al professor Mandelli di darmi cinque anni di vita, cinque anni per dimostrare la mia innocenza e riabilitare la giunta della Regione Abruzzo che ho guidato». A dichiararlo in una intervista a Repubblica è Ottaviano Del Turco, condannato a nove anni e sei mesi per presunte tangenti nella sanità privata abruzzese. «Mi hanno condannato senza una prova applicando in maniera feroce il teorema Angelini, oggi in Italia molti presidenti di corte sono ex pm che si portano dietro la cultura accusatoria. Il risultato, spaventoso, sono nove anni e sei mesi basati sulle parole di un bandito. Ho preso la stessa condanna di Tortora, e questo mi dà sgomento». Il Pd? «Ha così paura dei giudici che non è neppure capace di difendere un suo dirigente innocente», ha aggiunto Del Turco.
MA CHE CAZZO DI GIUSTIZIA E’!?!?
Funziona alla grande, la giustizia in Italia, scrive Marco Ventura su Panorama. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a punizioni esemplari, sentenze durissime nei confronti di fior di criminali. Castighi detentivi inflitti da giudici inflessibili. Due esempi per tutti. Il primo: Lele Mora e Emilio Fede condannati a 7 anni di carcere e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per aver “presentato” Ruby a Silvio Berlusconi. Il secondo: Ottaviano Del Turco condannato a 9 anni e 6 mesi per le tangenti sulla sanità in Abruzzo, anche se i 6 milioni di mazzette non sono mai stati trovati sui conti suoi o riconducibili a lui, e anche se il suo grande accusatore ha dimostrato in diverse occasioni di non essere attendibile nell’esibire “prove” contro l’ex governatore. In compenso, per cinque imputati del processo sul naufragio della Costa Concordia (32 i morti, più incalcolabili effetti economici, d’inquinamento ambientale e d’immagine internazionale dell’Italia), sono state accettate le richieste di patteggiamento. Risultato: a fronte di accuse come omicidio plurimo colposo e lesioni colpose, ma anche procurato naufragio, i cinque ottengono condanne che variano, a seconda delle responsabilità e dei reati contestati, da 1 anno e 8 mesi a 2 anni e 10 mesi. Tutto previsto dal codice. Tutto legale. Tutto giuridicamente ineccepibile. Ma avverto un certo disagio se poi faccio confronti. Se navigo nel web e scopro che mentre l’ex direttore del Tg4, Fede, subisce la condanna a 7 anni di carcere per il caso Ruby, la stessa pena viene inflitta a un tale che abusa della figlia di 8 anni e a un altro che, imbottito di cocaina, travolge e uccide una diciottenne sulle strisce pedonali. E non trovo altri colpevoli per crimini analoghi a quelli contestati a Fede a Milano, né personaggi che abbiano pagato (o per i quali sia valsa la fatica di provare a identificarli) per complicità nella pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto come qualcuno ben noto agli italiani, che di intercettazioni pubblicate è vittima quasi ogni giorno. E temo pure che la percezione della pubblica opinione sia molto distante dalla scala di gravità dei tribunali, almeno stando a questi casi. Un anno e 8 mesi è un quarto della pena comminata a Fede. Ho ancora nella mente, negli occhi, la scena della “Costa Concordia” coricata col suo carico di morte per l’incosciente inchino al Giglio. E ricordo il massacro dei media di tutto il mondo sull’Italietta di Schettino (l’unico per il quale non ci sarà patteggiamento e che presumibilmente pagherà per intero le sue colpe). Nei paesi anglosassoni con una tradizione marinara, colpe come quelle emerse nella vicenda “Costa Concordia” sono trattate con la gravità che meritano: la sicurezza è una priorità assoluta. Ciascuno di noi ha esperienza diretta o indiretta di come funzioni la giustizia in Italia: della sua rapidità o lentezza, della sua spietatezza o clemenza, dei suoi pesi e delle sue misure. Une, doppie, trine. La lettera della legge e delle sentenze non combacia col (buon) senso comune. Sarà un caso che la fiducia nelle toghe, in Italia, risulti ai livelli più bassi delle classifiche mondiali?
Sul Foglio del del 24 luglio 2013 Massimo Bordin spiega bene che nel processo Del Turco la difesa ha dimostrato che in determinati giorni citati dai pm nel capo d'accusa, l'ex governatore abruzzese sicuramente non aveva potuto commettere il reato che gli era imputato. "E' vero" risponde l'accusa. Vorrà dire che cambieremo la data" Capito? Le date non corrispondono così le cambieranno, elementare. Perché Del Turco è, nella loro formazione barbarica, colpevole a prescindere. E quindi quel corpo lo vogliono, anche senza prove. Tutto per loro. Dunque, ecco a voi servita "l'indipendenza della magistratura". A me avevano insegnato che per essere indipendenti, bisogna prima esseri liberi. E per essere liberi, bisogna essere soprattutto Responsabili. A questi giudici gli si potrebbe sicuramente attribuire una certa inclinazione alla libertà, ma intesa come legittimazione a delinquere. E' vero, Del Turco non sarà Tortora. Ma il comportamento da canaglie di alcuni magistrati italiani - salvaguardato da sessant'anni da giornali e apparati - continua e continuerà ad avere, nel tempo, lo stesso tanfo di sempre. E che dire del Processo Mediaset. Un processo "assurdo e risibile", per di più costato ai contribuenti "una ventina di milioni di euro". I conti, e le valutazioni politiche, sono del Pdl che mette nero su bianco i motivi per cui "in qualunque altra sede giudiziaria, a fronte di decisioni consimili si sarebbe doverosamente ed immediatamente pervenuti ad una sentenza più che assolutoria. Ma non a Milano". "Il 'processo diritti Mediaset', così convenzionalmente denominato, è basato su una ipotesi accusatoria così assurda e risibile che in presenza di giudici non totalmente appiattiti sull'accusa e "super partes", sarebbe finito ancor prima di iniziare, con grande risparmio di tempo per i magistrati e di denaro per i contribuenti", si legge nel documento politico elaborato dal Pdl a proposito del processo "diritti Mediaset", "dopo una approfondita analisi delle carte processuali". "Basti pensare - scrive ancora il Pdl - che una sola delle molte inutili consulenze contabili ordinate dalla Procura è costata ai cittadini quasi tre milioni di euro. Non è azzardato ipotizzare che tra consulenze, rogatorie ed atti processuali questa vicenda sia già costata allo Stato una ventina di milioni di euro".
Del Turco come Tortora. Un punto di vista (di sinistra) contro la condanna dell'ex governatore Del Turco. Il caso Del Turco come il caso Tortora: Una condanna senza indizi né prove, scrive Piero Sansonetti il 23 luglio 2013 su “Gli Altri. Il problema non è quello della persecuzione politica o dell’accanimento. La persecuzione è lo spunto, ma il problema è molto più grave: se la cosiddetta “Costituzione materiale” si adatterà al metodo (chiamiamolo così) Del Turco-Minetti, la giustizia in Italia cambierà tutte le sue caratteristiche, sostituendosi allo stato di diritto. E ci rimetteranno decine di migliaia di persone. E saranno riempite le carceri di persone innocenti. Non più per persecuzione ma per “burocrazia” ed eccesso di potere. Il rischio è grandissimo perché, in qualche modo, prelude ad un salto di civiltà. Con le sentenze contro Minetti e, neppure sette giorni dopo, contro Del Turco, la magistratura ha maturato una svolta fondata su due pilastri: il primo è la totale identificazione della magistratura giudicante con la magistratura inquirente: tra le due magistrature si realizza una perfetta integrazione e collaborazione (non solo non c’è separazione delle carriere ma viene stabilita la unità e l’obbligo di lealtà e di collaborazione attiva); il secondo pilastro è la cancellazione, anzi proprio lo sradicamento del principio di presunzione di innocenza. Nel caso della Minetti (accusata di avere organizzato una festa e per questo condannata a cinque anni di carcere) al processo mancavano, più che le prove, il reato. E infatti i giudici, in assenza di delitti definibili giuridicamente, sono ricorsi al “favoreggiamento”. L’hanno condannata per aver “favorito” un festino. Nel caso di Del Turco il reato c’era, ma erano del tutto assenti le prove, e anzi – cosa più grave – i pochi indizi racimolati si sono rivelati falsi durante il processo. Non solo mancavano le prove, e persino gli indizi, ma mancava il corpo del reato. In questi casi è difficile la condanna anche in situazioni di dittatura. I giudici hanno deciso allora di usare questo nuovo principio: è vero che non ci sono né prove né indizi a carico dell’imputato, però la sua difesa ha mostrato solo indizi di innocenza e non una prova regina. E hanno stabilito che non sono consentite “assoluzioni indiziarie”, decidendo di conseguenza la condanna con una nuova formula: insufficienza di prove a discolpa. Avete presenti quei processi americani nei quali il giudice a un certo punto chiede ai giurati: “siete sicuri, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell’imputato?”. In America basta che un solo giurato dica: “no, io un piccolo dubbio ce l’ho ancora…” e l’imputato è assolto. Può essere condannato solo all’unanimità e senza il più piccolo dubbio. Con Del Turco si è fatto al contrario: i giurati hanno stabilito che a qualcuno (per esempio a Travaglio) poteva essere rimasto qualche ragionevole dubbio sulla sua innocenza. E gli hanno rifilato 10 anni di carcere, come fecero una trentina d’anni fa con Enzo Tortora. Con Tortora i Pm avevano lavorato sulla base di indizi falsi o del tutto inventati. In appello Tortora fu assolto, il mondo intero si indignò, ma i pubblici ministeri non ricevettero neppur una noticina di censura e fecero delle grandi carrierone. Sarà così anche con Del Turco. Per oggi dobbiamo però assistere allo spettacolo di uno dei protagonisti della storia del movimento operaio e sindacale italiano condannato sulla base esclusivamente dell’accusa di un imprenditore che probabilmente non aveva ottenuto dalla Regione quello che voleva.
Toghe impunite e fannullone: loro il problema della giustizia. Le condanne abnormi sono ormai quotidiane: da Tortora a Del Turco, è colpa dei magistrati. Ma non si può dire. Su Libero di mercoledì 24 luglio il commento di Filippo Facci: "Toghe impunite e fannullone. Così c'è un Del Turco al giorno". Secondo Facci le condanne abnormi sono ormai quotidiane: dal caso Tortora a oggi il problema giustizia, spiega, è colpa dei magistrati. Ma è vietato dirlo. I casi Del Turco durano un giorno, ormai: scivolano subito in una noia mediatica che è generazionale. La verità è che l’emergenza giustizia e l’emergenza magistrati (ripetiamo: magistrati) non è mai stata così devastante: solo che a forza di ripeterlo ci siamo sfibrati, e l’accecante faro del caso Berlusconi ha finito per vanificare ogni battaglia. E’ inutile girarci attorno: in nessun paese civile esiste una magistratura così, una casta così, una sacralità e un’intangibilità così.
Accade, nelle carceri italiani, che persone indagate per i reati più disparati vengano sbattute in cella per obbligarle a vuotare il sacco. Accade anche che le chiavi che danno la libertà vengano dimenticate in un cassetto per settimane, se non mesi. In barba al principio di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio. Tanto che il carcere preventivo diventa una vera e propria tortura ad uso e consumo delle toghe politicizzate. Toghe che con tipi loschi come gli stupratori si trasformano in specchiati esempi di garantismo. No alla custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo qualora il caso concreto consenta di applicare misure alternative. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, terzo periodo, del Codice di procedura penale. I «gravi indizi di colpevolezza». si legge nella motivazione, non rendono automatica la custodia in carcere. La decisione segue quanto già stabilito in relazione ad altri reati, tra cui il traffico di stupefacenti, l'omicidio, e delitti a sfondo sessuale e in materia di immigrazione. La norma “bocciata” dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.232 depositata il 23 luglio 2013, relatore il giudice Giorgio Lattanzi, prevede che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per il delitto di violenza sessuale di gruppo si applica unicamente la custodia cautelare in carcere. Ora la Consulta ha stabilito che, se in relazione al caso concreto, emerga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, il giudice può applicarle. Nella sentenza, peraltro, la Corte conferma la gravità del reato, da considerare tra quelli più «odiosi e riprovevoli». Ma la «più intensa lesione del bene della libertà sessuale», «non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente valido al regime cautelare speciale previsto dalla norma censurata», scrive la Corte. Alla base del pronunciamento una questione di legittimità sollevata dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno. Richiamando anche precedenti decisioni la Consulta ricorda in sentenza come «la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del “minore sacrificio necessario”: la compressione della libertà personale deve essere, pertanto, contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità graduata”, predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale, e, dall’altra, a prefigurare criteri per scelte “individualizzanti” del trattamento cautelare, parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete». Sul punto si era pronunciata analogamente la Corte di Cassazione nel 2012, accogliendo il ricorso di due imputati per lo stupro subìto da una minorenne a Cassino. Il Tribunale di Roma aveva confermato il carcere nell'agosto 2011, ma la Cassazione motivò così la sua decisione: «L'unica interpretazione compatibile con i principi fissati dalla sentenza 265 del 2010 della Corte Costituzionale è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia in carcere anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all'art. 609 octies c.p.». In pratica recependo il dettato della Consulta del 2010 e l'indicazione della Corte di Strasburgo.
Da questo si evince che la Corte Costituzionale se ne infischia della violenza sessuale di gruppo. Oggi le toghe hanno, infatti, deciso che gli stupratori non dovranno scontare la custodia cautelare in carcere qualora il caso concreto consenta di applicare misure alternative. Nessuna preoccupazione, da parte dei giudici costituzionalisti, che le violenze possano essere reiterate. La beffa maggiore? Nella sentenza, della Corte costituzionale le toghe si premurano di confermare la gravità del reato invitando i giudici a considerarlo tra quelli più "odiosi e riprovevoli". Non abbastanza - a quanto pare - per assicurarsi che lo stupratore non commetta più la brutale violenza di cui si macchia. "La più intensa lesione del bene della libertà sessuale - si legge nella sentenza shock redatta dalla Corte - non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente valido al regime cautelare speciale previsto dalla norma censurata". Alla base del pronunciamento della Consulta c'è una questione di legittimità sollevata dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno. Richiamando anche precedenti decisioni, la Consulta ricorda come la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del "minore sacrificio necessario". Già nel 2010 la Corte aveva bocciato le norme in materia di misure cautelari nelle parti in cui escludevano la facoltà del giudice di decidere se applicare la custodia cautelare in carcere o un altro tipo di misura cautelare per chi ha abusato di un minore. Insomma, adesso appare chiaro che il carcere preventivo sia una misura "cautelare" pensata ad hoc per far fuori gli avversari politici. Nemmeno per gli stupratori è più prevista.
Stupro, dalla parte dei carnefici: niente carcere (per un po’) per il branco. Firmato: Corte Costituzionale, scrive Deborah Dirani su Vanity Fair. C’era una volta, 3 anni fa, a Cassino, comune ciociaro di 33 mila anime (per la maggior parte buone), una ragazzina che non aveva ancora compiuto 18 anni ed era molto graziosa. Sgambettava tra libri e primi “ti amo” sussurrati all’orecchio del grande amore, e pensava che la vita fosse bella. Pensava che il sole l’avrebbe sempre scaldata, che le avrebbe illuminato la vita ogni giorno. Non pensava che il sole potesse scomparire, che potesse tramontare e non tornare più a riscaldarle la pelle, a illuminarle la vita. Ma un giorno, un giorno di 3 anni fa, il suo sole tramontò oscurato dal buio di due ragazzi del suo paese, due che la volevano e, dato che con le buone non erano riusciti a prenderla, quel giorno scuro decisero di ricordarle che la donna è debole e l’uomo è forte. Così, quei due maschi del suo paese, la stuprarono, assieme, dandosi il cambio, a turno. Lei non voleva, lei piangeva, lottava, mordeva e graffiava con le sue unghie dipinte di smalto. Lei urlava, ci provava, perché poi quelli erano in due e si ritrovava sempre con una mano sulla bocca che la faceva tacere, che non la faceva respirare. Ma gli occhi quella ragazzina li aveva aperti a cercare quelli di quei due, a chiedere pietà, a scongiurarli di ritirarsi su i pantaloni, di uscire da lei, che le facevano male, nel cuore, più ancora che tra le gambe. Raccontano che quella ragazzina oggi non viva più nel suo paese, che quella notte sia scesa sulla sua vita e ancora non l’abbia lasciata. Raccontano che non esca di casa, che soffra di depressione e attacchi di panico. Raccontano che il suo buio sia denso come il petrolio. Raccontano che sia come un cormorano con le ali zuppe di olio nero che non può più volare. Raccontano anche che quando, a pochi mesi dal giorno più brutto della sua vita, la Corte di Cassazione ha stabilito che i suoi due stupratori non dovessero stare in custodia cautelare in carcere, ma potessero (in attesa della sentenza definitiva) essere trattenuti ai domiciliari, lei abbia pensato che Rino Gaetano non avesse mica ragione a cantare che il cielo è sempre più blu. Secondo la Cassazione, la galera (prevista da una legge approvata dal Parlamento nel 2009 che stabiliva che dovesse stare in carcere chiunque avesse abusato di una minorenne) non era giusta per quei due bravi figlioli perché quella stessa legge del 2009 violava gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione rieducativa della pena) della Costituzione. Secondo i giudici, insomma, ci sono misure alternative al carcere (nella fattispecie gli arresti domiciliari) alle quali ricorrere in casi come questo. Questo che, per la cronaca, è uno stupro di gruppo. I giorni passano, la vita continua, le sentenze si susseguono e quella della Cassazione apre un’autostrada a 4 corsie per chi, in compagnia di un paio di amici, prende una donna le apre le gambe e la spacca a metà. Così la Corte Costituzionale, la Suprema Corte, con una decisione barbara, incivile, retrograda, vigliacca, pilatesca, giusto poche ore fa, ha dichiarato illegittimo l’articolo 275, comma 3, periodo terzo del Codice di Procedura Penale che prevede che gravi indizi di colpevolezza rendano automatica la custodia cautelare in carcere per chi commette il reato previsto all’articolo 609 octies del Codice Penale: lo stupro di gruppo (niente carcere subito per chi violenta in gruppo, non importa, dice la Corte Costituzionale). Fortuna che quella ragazzina, che lo stupro di gruppo lo ha provato sulla sua luminosa pelle di adolescente, non può guardare in faccia i giudici di quella che si chiama Suprema Corte che hanno sentenziato che i suoi stupratori in galera non ci debbano andare (almeno fino al terzo grado di giudizio), ma che possano beatamente starsene ai domiciliari. Che possano evadere dai domiciliari (fossero i primi), possano prendere un’altra ragazzina, un’altra donna, un’altra mamma, una vedova, una che comunque in mezzo alle gambe ha un taglio e abusarne a turno, per ore, per giorni. Fino a quando ne hanno voglia. E poi, ritirati su i pantaloni, possano tonarsene a casa, ai domiciliari, che il carcere chissà se e quando lo vedranno. Bastardi, loro, e chi non fa giustizia. Che una donna non è un pezzo di carne con un taglio tra le gambe. Questa ragazzina non era quello che quei due maschi avevano visto in lei: un pezzo di carne, giovane, con un taglio in cui entrare a forza. No, non era un pezzo di carne, era un essere umano, e la Corte Costituzionale, la CORTE COSTITUZIONALE, non un giudice qualunque oberato e distratto di carte e senza un cancelliere solerte, ha certificato che il suo dolore non meritava nemmeno la consolazione che si dovrebbe alle vittime, agli esseri umani umiliati e offesi. Chi ha negato a questa giovane donna il diritto a credere nel sole della giustizia non è in galera, oggi. Chi da oggi lo negherà a qualunque donna: a voi che mi leggete, alle vostre figlie, mamme, nonne, sorelle, non andrà in galera. Non ci andrà fino a quando l’ultimo grado di giudizio non avrà stabilito che sì, in effetti, un po’ di maschi che tengono ferma una donna e che a turno le entrano dentro al corpo e all’anima, sono responsabili del suo dolore, del buio in cui l’hanno sepolta. E allora, voglio le parole della presidente della Camera, del ministro per le Pari opportunità, voglio le parole di ogni donna: le voglio sentire perché non serve essere femministe e professioniste delle dichiarazioni per scendere in piazza, in tutte le piazze, e incazzarsi. Non ci vuole sempre un capo del Governo antipatico e discutibile per fare scendere in piazza noi donne. Perché: SE NON OGGI, QUANDO?
Bene, allora cari italiani: TUTTI DENTRO, CAZZO!!
LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI.
Tutti dentro se la legge fosse uguale per tutti. Ma la legge non è uguale per tutti. Così la Cassazione si è tradita. Sconcertante linea delle Sezioni unite civili sul caso di un magistrato sanzionato. La Suprema Corte: vale il principio della discrezionalità. E le toghe di Md si salvano, scrive Stefano Zurlo su “Il Giornale”. La legge è uguale per tutti. Ma non al tribunale dei giudici. Vincenzo Barbieri, toga disinvolta, viene inchiodato dalle intercettazioni telefoniche, ma le stesse intercettazioni vengono cestinate nel caso di Paolo Mancuso, nome storico di Magistratura democratica. Eduardo Scardaccione, altro attivista di Md, la corrente di sinistra delle toghe italiane, se la cava anche se ha avuto la faccia tosta di inviare un pizzino al collega, prima dell'udienza, per sponsorizzare il titolare di una clinica. Assolto pure lui, mentre Domenico Iannelli, avvocato generale della Suprema corte, si vede condannare per aver semplicemente sollecitato una sentenza attesa da quasi sette anni. Sarà un caso ma il tribunale disciplinare funziona così: spesso i giudici al di fuori delle logiche correntizie vengono incastrati senza pietà. Quelli che invece hanno un curriculum sfavillante, magari a sinistra, magari dentro Md, trovano una via d'uscita. Non solo. Quel che viene stabilito dalla Sezione disciplinare del Csm trova facilmente sponda nel grado superiore, alle Sezioni unite civili della Cassazione, scioglilingua chilometrico, come i titoli dei film di Lina Wertmüller, per indicare la più prestigiosa delle corti. E proprio le Sezioni unite civili della Cassazione, nei mesi scorsi, hanno teorizzato il principio che sancisce la discrezionalità assoluta per i procedimenti disciplinari: se un magistrato viene punito e l'altro no, si salva anche se la mancanza è la stessa, pazienza. Il primo se ne dovrà fare una ragione. Testuale. Così scrive l'autorevolissimo collegio guidato da Roberto Preden, dei Verdi, l'altra corrente di sinistra della magistratura italiana, e composto da eminenti giuristi come Renato Rordorf e Luigi Antonio Rovelli, di Md, e Antonio Segreto di Unicost, la corrente di maggioranza, teoricamente centrista ma spesso orientata a sua volta a sinistra. A lamentarsi è Vincenzo Brancato, giudice di Lecce, incolpato per gravi ritardi nella stesura delle sentenze e di altri provvedimenti. La Cassazione l'ha condannato e le sezioni unite civili confermano ribadendo un principio choc: la legge non è uguale per tutti. O meglio, va bene per gli altri, ma non per i giudici. Un collega di Lecce, fa notare Brancato, ha avuto gli stessi addebiti ma alla fine è uscito indenne dal processo disciplinare. Come mai? È tutto in regola, replica il tribunale di secondo grado. «La contraddittorietà di motivazione - si legge nel verdetto del 25 gennaio 2013 - va colta solo all'interno della stessa sentenza e non dal raffronto fra vari provvedimenti, per quanto dello stesso giudice». Chiaro? Si può contestare il diverso trattamento solo se i due pesi e le due misure convivono dentro lo stesso verdetto. Altrimenti ci si deve rassegnare. E poiché Brancato e il collega più fortunato, valutato con mano leggera, sono protagonisti di due sentenze diverse, il caso è chiuso. Senza se e senza ma: «Va ribadito il principio già espresso da queste sezioni unite secondo cui il ricorso avverso le pronunce della sezione disciplinare del Csm non può essere rivolto a conseguire un sindacato sui poteri discrezionali di detta sezione mediante la denuncia del vizio di eccesso di potere, attesa la natura giurisdizionale e non amministrativa di tali pronunce». Tante teste, tante sentenze. «Pertanto non può censurarsi il diverso metro di giudizio adottato dalla sezione disciplinare del Csm nel proprio procedimento rispetto ad altro, apparentemente identico, a carico di magistrato del medesimo ufficio giudiziario, assolto dalla stessa incolpazione». Tradotto: i magistrati, nelle loro pronunce, possono far pendere la bilancia dalla parte che vogliono. Il principio è srotolato insieme a tutte le sue conseguenze e porta il timbro di giuristi autorevolissimi, fra i più titolati d'Italia. È evidente che si tratta di una massima sconcertante che rischia di creare figli e figliastri. È, anche, sulla base di questo ragionamento che magistrati appartenenti alle correnti di sinistra, in particolare Md, così come le toghe legate alle corporazioni più strutturate, sono stati assolti mentre i loro colleghi senza reti di rapporti o di amicizie sono stati colpiti in modo inflessibile. Peccato che questo meccanismo vada contro la Convenzione dei diritti dell'uomo: «L'articolo 14 vieta di trattare in modo differente, salvo giustificazione ragionevole e obiettiva, persone che si trovino in situazioni analoghe». Per i giudici italiani, a quanto pare, questo criterio non è valido. Non solo. La stessa Cassazione, sezione Lavoro, afferma che la bilancia dev'essere perfettamente in equilibrio. Il caso è quello di due dipendenti Telecom che avevano usato il cellulare aziendale per conversazioni private. Il primo viene licenziato, il secondo no. E dunque quello che è stato spedito a casa si sente discriminato e fa causa. La Cassazione gli dà ragione: «In presenza del medesimo illecito disciplinare commesso da più dipendenti, la discrezionalità del datore di lavoro non può trasformarsi in arbitrio, con la conseguenza che è fatto obbligo al datore di lavoro di indicare le ragioni che lo inducono a ritenere grave il comportamento illecito di un dipendente, tanto da giustificare il licenziamento, mentre per altri dipendenti è applicata una sanzione diversa». Il metro dev'essere sempre lo stesso. Ma non per i magistrati, sudditi di un potere discrezionale che non è tenuto a spiegare le proprie scelte. La regola funziona per i dipendenti Telecom, insomma, per i privati. Non per i magistrati e il loro apparato di potere. La legge è uguale per tutti ma non tutti i magistrati sono uguali davanti alla legge. La Legge che non sia uguale per tutti è pacifico. Invece è poco palese la sua conoscenza, specie se in Italia è tutto questione di famiglia. Famiglia presso cui si devono lavare i panni sporchi.
Quando anche per i comunisti è tutto questione di famiglia.
Luigi Berlinguer (ex ministro PD) è il cugino di Bianca Berlinguer (direttrice del Tg3 e figlia di Enrico) che è sposata con Luigi Manconi (senatore PD, fondatore e presidente dell’Associazione “A Buon Diritto”) che è cognato di Luca Telese (giornalista La7 e Canale 5) che è marito di Laura Berlinguer (giornalista MEDIASET) che è cugina di Sergio Berlinguer (consigliere di Stato), fratello di Luigi e cugino di Enrico.
Bene, allora cari italiani: TUTTI DENTRO, CAZZO??? QUASI TUTTI!!!!
ITALIA PAESE DELL’IMMUNITA’ E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
La Commissione europea, la Corte Europea dei diritti dell’uomo e “Le Iene”, sputtanano. Anzi, “Le Iene” no!!
E la stampa censura pure…..
Pensavo di averle viste tutte.
La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia perchè non adegua la sua normativa sulla responsabilità civile dei giudici al diritto comunitario. Bruxelles si aspetta che il governo nostrano estenda la casistica per i risarcimenti "cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie". Casistica regolata da una legge del 1988 e assai stretta: il legislatore prevede che le toghe rispondano in prima persona solo in caso di dolo o colpa grave nel compimento dell'errore giudiziario. Qual è il problema per l'Ue? Si chiede “Libero Quotidiano”. Che i giudici italiani sono chiamati a pagare per i propri errori in casi troppo ristretti, godendo di una normativa che non solo li avvantaggia rispetto ad altri lavoratori e professionisti italiani, ma anche rispetto ai propri colleghi europei. La legge italiana 117/88 restringe la responsabilità dei giudici ai soli casi di errore viziato da "dolo e colpa grave". E, come se non fosse abbastanza, il legislatore assegna l'onere della prova (ovvero la dimostrazione del dolo e della colpa del giudice) al querelante che chiede risarcimento per il danno subito. Per l'Ue troppo poco. La Commissione Ue chiede all'Italia di conformarsi al diritto comunitario. Innanzitutto via l'onere della dimostrazione del dolo e della colpa. E poi estensione della responsabilità del giudice di ultima istanza anche ai casi di sbagliata interpretazione delle leggi e di errata valutazione delle prove, anche senza il presupposto della malevolezza della toga verso l'imputato. Anche per colpa semplice, insomma. E, comunque, non pagano i giudici, paghiamo noi.
Inoltre su un altro punto è intervenuta l’Europa. Condannare un giornalista alla prigione è una violazione della libertà d’espressione, salvo casi eccezionali come incitamento alla violenza o diffusione di discorsi razzisti. A stabilirlo, ancora una volta. è la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in cui dà ragione a Maurizio Belpietro, direttore di Libero, condannato a quattro anni dalla Corte d’Appello di Milano.
La Convenzione e la Corte europea dei diritti dell’uomo ampliano il diritto di cronaca (“dare e ricevere notizie”) e proteggono il segreto professionale dei giornalisti. No alle perquisizioni in redazione! Il giudice nazionale deve tener conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della decisione, anche in corso di causa, con effetti immediati e assimilabili al giudicato: è quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19985 del 30/9/2011.
Cedu. Decisione di Strasburgo. Il diritto di cronaca va sempre salvato. Per i giudici l'interesse della collettività all'informazione prevale anche quando la fonte siano carte segretate, scrive Marina Castellaneta per Il Sole 24 Ore il 17/4/2012. La Corte europea dei diritti dell'uomo pone un freno alle perquisizioni nei giornali e al sequestro da parte delle autorità inquirenti dei supporti informatici dei giornalisti. Con un preciso obiettivo. Salvaguardare il valore essenziale della libertà di stampa anche quando sono pubblicate notizie attinte da documenti coperti da segreto. Lo ha chiarito la Corte dei diritti dell'uomo nella sentenza depositata il 12 aprile 2012 (Martin contro Francia) che indica i criteri ai quali anche i giudici nazionali devono attenersi nella tutela del segreto professionale dei giornalisti per non incorrere in una violazione della Convenzione e in una condanna dello Stato. A Strasburgo si erano rivolti quattro giornalisti di un quotidiano francese che avevano pubblicato un resoconto di documenti della Corte dei conti che riportavano anomalie nell'amministrazione di fondi pubblici compiute da un ex governatore regionale. Quest'ultimo aveva agito contro i giornalisti sostenendo che era stato leso il suo diritto alla presunzione d'innocenza anche perché erano stati pubblicati brani di documenti secretati. Il giudice istruttore aveva ordinato una perquisizione nel giornale con il sequestro di supporti informatici, agende e documenti annotati. Per i giornalisti non vi era stato nulla da fare. Di qui il ricorso a Strasburgo che invece ha dato ragione ai cronisti condannando la Francia per violazione del diritto alla libertà di espressione (articolo 10 della Convenzione). Per la Corte la protezione delle fonti dei giornalisti è una pietra angolare della libertà di stampa. Le perquisizioni nel domicilio e nei giornali e il sequestro di supporti informatici con l'obiettivo di provare a identificare la fonte che viola il segreto professionale trasmettendo un documento ai giornalisti compromettono la libertà di stampa. Anche perché il giornalista potrebbe essere dissuaso dal fornire notizie scottanti di interesse della collettività per non incorrere in indagini. È vero - osserva la Corte - che deve essere tutelata la presunzione d'innocenza, ma i giornalisti devono informare la collettività. Poco contano - dice la Corte - i mezzi con i quali i giornalisti si procurano le notizie perché questo rientra nella libertà di indagine che è inerente allo svolgimento della professione. D'altra parte, i giornalisti avevano rispettato le regole deontologiche precisando che i fatti riportati erano ricavati da un rapporto non definitivo. Giusto, quindi, far conoscere al pubblico le informazioni in proprio possesso sulla gestione di fondi pubblici.
Ed ancora. La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso presentato dall’autore di “Striscia la notizia”, Antonio Ricci, per violazione dell’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Il ricorso era stato presentato in seguito alla sentenza con la quale, nel 2005, la Corte di cassazione – pur dichiarando la prescrizione del reato – aveva ritenuto integrato il reato previsto dall’art. 617 quater e 623 bis c.p., per avere “Striscia la notizia” divulgato nell’ottobre del 1996 un fuori onda della trasmissione di Rai3 “L’altra edicola”, con protagonisti il filosofo Gianni Vattimo e lo scrittore Aldo Busi che se ne dicevano di tutti i colori.
I fatti risalgono al 1996 e c'erano voluti 10 anni perchè la Cassazione ritenesse Ricci colpevole per la divulgazione del fuori onda di Rai Tre.
«Superando le eccezioni procedurali interposte dal Governo Italiano, che - dicono i legali di Ricci, Salvatore Pino e Ivan Frioni - ha provato a scongiurare una pronuncia che entrasse nel merito della vicenda, ha ottenuto l’auspicato risarcimento morale, sancito dalla Corte che – al termine di una densa motivazione – ha riconosciuto la violazione dell’art. 10 della Convenzione, posto a tutela della libertà d’espressione».
«La Corte – dopo aver riconosciuto che “il rispetto della vita privata e il diritto alla libertà d’espressione meritano a priori un uguale rispetto” – diversamente da quanto sostenuto dai giudici italiani, “che -spiega l’avvocato Salvatore Pino- avevano escluso la possibilità stessa di un bilanciamento – ha ritenuto che la condanna di Antonio Ricci abbia costituito un’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 10 § 1 della Convenzione ed ha altresì stigmatizzato la sproporzione della pena applicata rispetto ai beni giuridici coinvolti e dei quali era stata lamentata la lesione».
«Sono felice per la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - ha commentato Antonio Ricci, creatore di Striscia la notizia.- La condanna aveva veramente dell’incredibile, tra l’altro sia in primo che in secondo grado la Pubblica Accusa aveva chiesto la mia assoluzione. E' una vittoria di Antonio Ricci contro lo Stato italiano, per questo la sentenza di Strasburgo è molto importante». E' soddisfatto il patron di Striscia la notizia per quella che ritiene essere stata una vittoria di principio. «Il fatto che l'Europa si sia pronunciata a mio favore - ha dichiarato Ricci - implica che esiste una preoccupazione in merito alla libertà d'espressione nel nostro Paese». Una vittoria importante nella battaglia per la libertà d'espressione che segna un punto a favore di Ricci e che pone ancora una volta l'accento sui lacci e lacciuoli con i quali bisogna fare i conti in Italia quando si cerca di fare informazione, come spiega lo stesso Ricci nella video intervista. «Quante volte sono andati in onda dei fuori onda - si è chiesto Ricci - E nessuno è mai stato punito? Per questo sono voluto andare fino in fondo, la mia è stata una battaglia di principio».
Trattativa stato-mafia, Ingroia rientra nel processo come avvocato parte civile. Rappresenta l'associazione vittime della strage di via Georgofili. Si presenta con la sua vecchia toga, abbracciato dagli amici pm. Antonio Ingroia, nelle vesti di avvocato di parte civile. Il leader di Azione civile rappresenta l'associazione dei familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, presieduta da Giovanna Maggiani Chelli. Ingroia sarà il sostituto processuale dell'avvocato Danilo Ammannato. Antonio Ingroia denunciato per esercizio abusivo della professione? Il rischio c'è. Il segretario dell’Ordine di Roma, dove Ingroia è iscritto, e il presidente del Consiglio di Palermo, dove sarebbe avvenuto l’esercizio abusivo della professione, ritengono "che prima di potere esercitare la professione l’avvocato debba giurare davanti al Consiglio".
Ed Ancora. Bruxelles avvia un'azione contro l'Italia per l'Ilva di Taranto. La Commissione "ha accertato" che Roma non garantisce che l'Ilva rispetti le prescrizioni Ue sulle emissioni industriali, con gravi conseguenze per salute e ambiente. Roma è ritenuta "inadempiente" anche sulla norma per la responsabilità ambientale. La Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione sull’Ilva per violazione delle direttive sulla responsabilità ambientale e un’altra sul mancato adeguamento della legislazione italiana alle direttive europee in materia di emissioni industriali. Le prove di laboratorio «evidenziano un forte inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, sia sul sito dell'Ilva, sia nelle zone abitate adiacenti della città di Taranto. In particolare, l'inquinamento del quartiere cittadino di Tamburi è riconducibile alle attività dell'acciaieria». Oltre a queste violazioni della direttiva IPPC e al conseguente inquinamento, risulta che «le autorità italiane non hanno garantito che l'operatore dello stabilimento dell'Ilva di Taranto adottasse le misure correttive necessarie e sostenesse i costi di tali misure per rimediare ai danni già causati».
Bene. Di tutto questo la stampa si guarda bene di indicare tutti i responsabili, non fosse altro che sono i loro referenti politici. Ma sì, tanto ci sono “Le Iene” di Italia 1 che ci pensano a sputtanare il potere.
Cosa????
Invece “Le Iene” ci ricascano. Tralasciamo il fatto che è da anni che cerco un loro intervento a pubblicizzare l’ignominia dell’esame forense truccato, ma tant’è. Ma parliamo di altro. La pubblicazione del video di Alessandro Carluccio denuncia la censura de “Le Iene” su Francesco Amodeo, quando Francesco ha parlato è stato censurato...non serve parlare !! il Mes, il gruppo Bilderberg, Mario Monti, Enrico Letta, Giorgio Napolitano, il Signoraggio Bancario, la Guerra Invisibile,...e tanta truffa ancora!!! Alessandro Carluccio, il bastardo di professione .. "figlio di iene"….indaga,..spiegando che non è crisi.. è truffa..se accarezzi la iena rischi di esser azzannato...in quanto la iena approfitta delle prede facili...ma se poi dopo diventi il leone sono costrette a scappare...un faccia a faccia con Matteo Viviani e Pablo Trincia in arte LE IENE....con Francesco Amodeo.
Dopo questo, ci si imbatte nel caso di Andrea Mavilla, vittima di violenza e di censura. C’è il servizio shock delle Iene sui carabinieri, ma il video scompare scatenando le ire del web. Una storia davvero incredibile che ha lasciato tutto il pubblico de Le Iene Show senza parole. Peccato che le stesse Iene abbiano censurato, o siano state costrette a farlo, il loro stesso lavoro. “Ma il servizio di Viviani?”, “dove si può vedere il video riguardo Andrea Mavilla e il vergognoso abuso di potere che ha subito?”, “TIRATE FUORI IL VIDEO!”. Sono solo alcuni dei commenti che hanno inondato il 25 settembre 2013 la pagina Facebook di Le Iene, noto programma di Italia Uno la cui fama è legata ai provocatori, ma anche il più delle volte illuminanti, servizi di inchiesta, scrive Francesca su “Che Donna”. Proprio oggi però l’intrepido coraggio dei ragazzi in giacca e cravatta è stato messo in dubbio proprio dai loro stessi fan. Tempo fa Andrea Mavilla, blogger, filmò un’auto dei carabinieri mentre sostava contromano sulle strisce pedonali: l’uomo dimostrò che i tre militari rimasero diversi minuti nella pasticceria lì vicino, uscendo poi con un pacchetto della stessa. I carabinieri dovettero poi ricorrere alle vie legali, dimostrando con tanto di verbale che il pasticcere li aveva chiamati e loro, seguendo il regolamento, erano intervenuti parcheggiando la volante quanto più vicino possibile al locale. Il pacchetto? Un semplice regalo del negoziante riconoscente per la celerità dell’arma. Storia finita dunque? A quanto pare no. Il blogger infatti sostiene di aver subito una ritorsione da parte dell’arma: i carabinieri sarebbero entrati senza mandato in casa sua svolgendo una perquisizione dunque non autorizzata. Proprio qui sono intervenute Le Iene: Viviani, inviato del programma, ha infatti realizzato sull’accaduto un servizio andato in onda la sera del 24 settembre 2013, alla ripresa del programma dopo la pausa estiva. Inutile dire che la cosa ha subito calamitato l’attenzione del pubblico che così, la mattina dopo, si è catapultato sul web per rivedere il servizio. Peccato che questo risulta ad oggi irreperibile e la cosa non è proprio piaciuta al pubblico che ora alza la voce su Facebook per richiedere il filmato in questione. Come mai manca proprio quel filmato? Che i temerari di Italia Uno non siano poi così impavidi? Le provocazioni e le domande fioccano sul social network e la storia sembra dunque non finire qui.
Quando la tv criminalizza un territorio.
7 ottobre 2013. Dal sito di Striscia la Notizia si legge “Stasera a Striscia la notizia Fabio e Mingo documentano la situazione di drammatico degrado in cui vivono migliaia di persone nelle campagne di Foggia. Si tratta di lavoratori stranieri che vengono in Italia per raccogliere i pomodori e lavorano dalle 5 del mattino fino a notte per pochi euro. Il caso documentato da Striscia riguarda un gruppo di lavoratori bulgari che per otto mesi l'anno vivono con le loro famiglie in case improvvisate, senza acqua, gas e elettricità, in condizioni igieniche insostenibili, tra fango e rifiuti di ogni genere, tra cui anche lastre di amianto.”
In effetti il filmato documenta una situazione insostenibile. Certo, però, ben lontana dalla situazione descritta. Prima cosa è che non siamo in periodo di raccolta del pomodoro, né dell’uva. Nel filmato si vede un accampamento di poche famiglie bulgare, ben lontane dal numero delle migliaia di persone richiamate nel servizio. Famiglie senza acqua, luce e servizi igienici. Un accampamento immerso nell’immondizia e con auto di grossa cilindrata parcheggiate vicino alle baracche. «Scusate ma a me sembra un "normale" accampamento di Zingari, come ci sono ahimè in tutte le città italiane - scrive Antonio sul sito di Foggia Today - Purtroppo oggi la televisione per fare audience, deve proporre continuamente lo scoop, specialmente quando si tratta di televisione cosiddetta commerciale. Ma anche la televisione pubblica a volte non è esente da criticare a riguardo. Fare televisione oggi significa soprattutto speculare sulla notizia, e molte volte non ci si fa scrupoli di speculare anche sulle tragedie, pur di raggiungere gli agognati indici di ascolto. E tutto questo senza preoccuparsi minimamente, di quanto viene proposto agli spettatori, a volte paganti (vedi il canone Rai). Tanto a nessuno importa, perchè vige la regola: "Il popolo è ignorante".» Giovanni scrive: «quello è un campo nomadi e non il campo dei lavoratori agricoli stagionali».
Questo non per negare la terribile situazione in cui versano i lavoratori stagionali, a nero e spesso clandestini, che coinvolge tutta l’Italia e non solo il Foggiano, ma per dare a Cesare quel che è di Cesare.
In effetti di ghetto ne parla “Foggia Città Aperta”. Ma è un’altra cosa rispetto a quel campo documentato da Striscia. Una fetta di Africa a dodici chilometri da Foggia. Benvenuti nel cosiddetto Ghetto di Rignano, un villaggio di cartone sperduto fra le campagne del Tavoliere Dauno che ogni estate ospita circa 700 migranti. Tutti, o quasi, impegnati nella raccolta dei campi, in modo particolare dei pomodori. Dodici ore di lavoro sotto al sole e al ritorno neanche la possibilità di farsi la doccia. Attenzione si parla di Africani, non di Bulgari.
Sicuramente qualcuno mi farà passare per razzista, ma degrado e sudiciume illustrato da Striscia, però, sono causati da quelle persone che ivi abitano e non sono certo da addebitarsi all’amministrazione pubblica Foggiana, che eventualmente, per competenza, non ha ottemperato allo sgombero ed alla bonifica dei luoghi.
Ai buonisti di maniera si prospettano due soluzioni:
L’Amministrazione pubblica assicura ai baraccati vitto, alloggio e lavoro, distogliendo tale diritto ai cittadini italiani, ove esistesse;
L’Amministrazione pubblica assicura la prole ad un centro per minori, togliendoli alle famiglie; libera con forza l’accampamento abusivo e persegue penalmente i datori di lavori, ove vi sia sfruttamento della manodopera; chiede ai baraccati ragione del loro tenore di vita in assenza di lavoro, per verificare che non vi siano da parte loro atteggiamenti e comportamenti criminogeni, in tal caso provvede al rimpatrio coatto.
Colui il quale dalla lingua biforcuta sputerà anatemi per aver ristabilito una certa verità, sicuramente non avrà letto il mio libro “UGUAGLIANZIOPOLI L’ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE. L'ITALIA DELL'INDISPONENZA, DELL'INDIFFERENZA, DELL'INSOFFERENZA”, tratto dalla collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo”. Opere reperibili su Amazon.it.
Alla fine della fiera, si può dire che stavolta Fabio e Mingo e tutta Striscia la Notizia per fare sensazionalismo abbiano toppato?
Che anche le toghe paghino per i loro errori: adesso lo pretende la Ue, chiede “Libero Quotidiano”. La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia perchè non adegua la sua normativa sulla responsabilità civile dei giudici al diritto comunitario. Bruxelles si aspetta che il governo nostrano estenda la casistica per i risarcimenti "cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie". Casistica regolata da una legge del 1988 e assai stretta: il legislatore prevede che le toghe rispondano in prima persona solo in caso di dolo o colpa grave nel compimento dell'errore giudiziario. All'Ue non sta bene, e il procedimento di infrazione non è un fulmine a ciel sereno. E' del novembre 2011 la condanna all'Italia da parte della Corte di Giustizia Ue per l'inadeguatezza della nostra normativa in materia di responsabilità civile dei giudici, mentre già nel settembre 2012 la Commissione aveva chiesto al governo aggiornamenti sull'applicazione del decreto di condanna. Ma non è bastato. In due anni i governi di Mario Monti e Enrico Letta non hanno adeguato la legge italiana a quella europea, e ora l'Ue passa ai provvedimenti sanzionatori. L'Italia è responsabile della violazione del diritto dell'Unione da parte di un suo organo (in questo caso giudiziario), e per questo sarà chiamata a pagare. Qual è il problema per l'Ue? Che i giudici italiani sono chiamati a pagare per i propri errori in casi troppo ristretti, godendo di una normativa che non solo li avvantaggia rispetto ad altri lavoratori e professionisti italiani, ma anche rispetto ai propri colleghi europei. La legge italiana 117/88 restringe la responsabilità dei giudici ai soli casi di errore viziato da "dolo e colpa grave". E, come se non fosse abbastanza, il legislatore assegna l'onere della prova (ovvero la dimostrazione del dolo e della colpa del giudice) al querelante che chiede risarcimento per il danno subito. Per l'Ue troppo poco. La Commissione Ue chiede all'Italia di conformarsi al diritto comunitario. Innanzitutto via l'onere della dimostrazione del dolo e della colpa. E poi estensione della responsabilità del giudice di ultima istanza anche ai casi di sbagliata interpretazione delle leggi e di errata valutazione delle prove, anche senza il presupposto della malevolezza della toga verso l'imputato. Anche per colpa semplice, insomma. Interpellate da Bruxelles nel settembre 2012, le autorità italiane avevano risposto in maniera rassicurante: cambieremo la legge. In dodici mesi non si è mossa una foglia, e ora il Belpaese va incontro a un procedimento di infrazione, cioè a una cospicua multa. Insomma, non pagano i giudici, paghiamo noi.
La proposta di aprire una nuova procedura d'infrazione è stata preparata dal servizio giuridico della Commissione che fa capo direttamente al gabinetto del presidente Josè Manuel Barroso, scrive “La Repubblica”. Bruxelles si è in pratica limitata a constatare che a quasi due anni dalla prima condanna, l'Italia non ha fatto quanto necessario per eliminare la violazione del diritto europeo verificata nel 2011. La prima sentenza emessa dai giudici europei ha decretato che la legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati li protegge in modo eccessivo dalle conseguenze del loro operato, ovvero rispetto agli eventuali errori commessi nell'applicazione del diritto europeo (oggi circa l'80% delle norme nazionali deriva da provvedimenti Ue). Due in particolare le ragioni che hanno portato Commissione e Corte a censurare la normativa italiana giudicandola incompatibile con il diritto comunitario. In primo luogo, osservano fonti europee, la legge nazionale esclude in linea generale la responsabilità dei magistrati per i loro errori di interpretazione e valutazione. Inoltre, la responsabilità dello Stato scatta solo quando sia dimostrato il dolo o la colpa grave. Un concetto, quest'ultimo, che secondo gli esperti Ue la Cassazione ha interpretato in maniera troppo restrittiva, circoscrivendola a sbagli che abbiano un carattere “manifestamente aberrante”.
Ciò che l'Unione Europea contestava, e ancora contesta, è l'eccessiva protezione garantita alla magistratura italiana, scrive “Il Giornale”. Per eventuali errori commessi nell'applicare il diritto europeo, non è infatti prevista responsabilità civile, che entra in gioco per dolo o colpa grave, ma non per errori di valutazione o interpretazione. Una differenzia importante, se si considera che circa l'80% delle norme italiana deriva ormai da provvedimenti comunitari.
Pronta la replica delle toghe: guai a toccare i magistrati.
Nessun "obbligo per l'Italia di introdurre una responsabilità diretta e personale del singolo giudice": l'Europa "conferma che nei confronti del cittadino l'unico responsabile è lo Stato". Il vice presidente del Csm Michele Vietti commenta così la notizia dell'avvio di una procedura da parte dell'Ue. "L'Europa ha parlato di responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario; non entra invece nella questione della responsabilità personale dei giudici perché é un problema di diritto interno, regolato diversamente nei vari Stati membri", ha puntualizzato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Rodolfo Sabelli, che sin da ora avverte: "Denunceremo ogni tentativo di condizionamento dei magistrati attraverso una disciplina della responsabilità civile che violi i principi di autonomia e indipendenza".
Tutti uguali davanti alla legge. Tutti uguali? Anche i magistrati? E invece no. I magistrati sono al di sopra della legge, ci si tengono - al di sopra - con pervicacia, si rifugiano sotto l’ombrello dell’autonomia, indipendenza dalla politica, in realtà tenendosi stretto il privilegio più anacronistico che si possa immaginare: l’irresponsabilità civile. O irresponsabilità incivile, scrive Marvo Ventura su “Panorama”. La Commissione Europea ha deciso di avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per l’eccessiva protezione offerta dalle norme ai magistrati, per i limiti all’azione di risarcimento delle vittime di palesi e magari volute ingiustizie. Per l’irresponsabilità del magistrato che per dolo o colpa grave rovini la vita delle persone con sentenze chiaramente errate, se non persecutorie. Succede che in capo direttamente al presidente della Commissione UE, Barroso, è partita la proposta di agire contro l’Italia per aver totalmente ignorato la condanna del 2011 della Corte di Giustizia che fotografava l’inadeguatezza del sistema italiano agli standard del diritto europeo rispetto alla responsabilità civile delle toghe. Dov’è finita allora l’urgenza, la fretta, quel rimbocchiamoci le maniche e facciamo rispettare la legge e le sentenze, che abbiamo visto negli ultimi giorni, settimane, mesi, come una battaglia di principio che aveva e ha come bersaglio l’avversario politico Silvio Berlusconi. Perché dal 1987, anno del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, c’è stata solo una legge, la Vassalli dell’anno successivo, che serviva purtroppo per introdurre una qualche responsabilità ma non troppa, per non pestare i piedi alla magistratura, forte già allora di uno strapotere discrezionale nella sua funzione inquirente e nella sua vocazione sovente inquisitoria. Adesso che l’Europa ci bacchetta (e la minaccia è anche quella di farci pagare per l’irresponsabilità dei nostri magistrati, dico far pagare a noi contribuenti che sperimentiamo ogni giorno le inefficienze e i ritardi della giustizia civile e penale), l’Europa non è più quel mostro sacro che ha sempre ragione. Non è più neanche il depositario del bene e del giusto. È invece la fonte di una raccomandazione che merita a stento dichiarazioni di seconda fila. E l’Associazione nazionale magistrati stavolta non tuona, non s’indigna, non incalza. Si limita a scaricare il barile al governo, dice per bocca dei suoi vertici che la Commissione non ha infilzato i singoli magistrati ma lo Stato italiano per la sua inadempienza al diritto UE, comunitario. Come se i magistrati e la loro associazione corporativa non avessero avuto alcuna voce in capitolo nel tornire una legislazione che non è in linea con lo stato di diritto di un avanzato paese europeo. Come se in questo caso le toghe potessero distinguere le loro (ir)responsabilità da quelle di una parte della politica che ha fatto sponda alle correnti politiche giudiziarie e alla loro campagna ventennale. Come se i magistrati più in vista, più esposti, non avessero facilmente e disinvoltamente travalicato i confini e non si fossero gettati in politica facendo tesoro della popolarità che avevano conquistato appena il giorno prima con le loro inchieste di sapore “politico”. Ma quel che è peggio è l’odissea di tanti cittadini vittime di ingiustizia che si sono dovuti appellare all’Europa, avendo i soldi per farlo e il tempo di aspettare senza morire (a differenza di tanti altri). A volte ho proprio l’impressione di non trovarmi in Europa ma in altri paesi che non saprei citare senza peccare di presunzione. L’Italia, di certo, non appartiene più al novero dei paesi nei quali vi è certezza del diritto. Per quanto ancora?
Di altro parere rispetto a quello espresso dalle toghe, invece è il Presidente della Repubblica e capo del CSM. L’opposizione dei giudici alla riforma della giustizia è eccessiva, spiega “Libero Quotidiano”. Se ne è accorto anche Giorgio Napolitano che, il 20 settembre 2013 intervenendo alla Luiss per ricordare Loris D'Ambrosio, riflette sul rapporto tra magistratura e politica: entrambi i poteri sbagliano, ma la magistratura è troppo piegata sulle sue posizioni ed una rinfrescata ai codici sarebbe cosa buona. Secondo Napolitano, le critiche che le piovono addosso, vero, sono eccessive; ma ai punti a perdere sono i magistrati, sempre più convinti di essere intoccabili. La politica e la giustizia devono smettere di "concepirsi come mondi ostili, guidati dal sospetto reciproco", dice Napolitano che sogna, invece, l’esaltazione di quella "comune responsabilità istituzionale" propria dei due poteri. "Ci tocca operare in questo senso - precisa Napolitano - senza arrenderci a resistenze ormai radicate e a nuove recrudescenze del conflitto da spegnere nell'interesse del Paese". Per superare quelle criticità emerse con foga negli ultimi vent’anni (prendendo Tangentopoli come primo e vero momento di scontro tra politica e magistratura), secondo Napolitano, la soluzione si può trovare "attraverso un ridistanziamento tra politica e diritto" ma soprattutto non senza la cieca opposizione ad una riforma completa della magistratura. Il presidente della Repubblica sembra non sapersi spiegare perché proprio i magistrati siano sulle barricate per difendere il loro status. Tra i giudici, dice Napolitano, dovrebbe "scaturire un'attitudine meno difensiva e più propositiva rispetto al discorso sulle riforme di cui la giustizia ha indubbio bisogno da tempo e che sono pienamente collocabili nel quadro dei principi della Costituzione repubblicana". Sul Quirinale non sventola mica la bandiera di Forza Italia, ma bastano le lampanti criticità ad illuminare il discorso di Re Giorgio. "L'equilibrio, la sobrietà ed il riserbo, l'assoluta imparzialità e il senso della misura e del limite, sono il miglior presidio dell'autorità e dell'indipendenza del magistrato". Così Napolitano non si lascia sfuggire l’occasione di parlare indirettamente a quei magistrati che fanno del protagonismo la loro caratteristica principale. Pm, come Henry John Woodcock, o giudicanti, come il cassazionista Antonio Esposito, che si sono lasciarti sedurre da taccuini e telecamere quando, invece, avrebbero dovuto seguire quei dettami di "sobrietà e riserbo". Il presidente, poi, ricorda che nessun lavoro è delicato quanto quello del giudice perché sa che dalla magistratura dipende la vita (o la non-vita) degli indagati.
Inoltre su un altro punto è intervenuta l’Europa. Condannare un giornalista alla prigione è una violazione della libertà d’espressione, salvo casi eccezionali come incitamento alla violenza o diffusione di discorsi razzisti. A stabilirlo, ancora una volta. è la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in cui dà ragione a Maurizio Belpietro, direttore di Libero, condannato a quattro anni dalla Corte d’Appello di Milano. In sostanza, scrive Vittorio Feltri, i giudici continentali si sono limitati a dire ai tribunali italiani che i giornalisti non devono andare in galera per gli sbagli commessi nello svolgimento del loro lavoro, a meno che inneggino alla violenza o incitino all'odio razziale. Tutti gli altri eventuali reati commessi dai colleghi redattori vanno puniti, a seconda della gravità dei medesimi, con sanzioni pecuniarie. Perché la libertà di espressione non può essere compressa dal terrore dei giornalisti di finire dietro le sbarre. La Corte, per essere ancora più chiara, ha detto che il carcere collide con la Carta dei diritti dell'uomo. Inoltre, scrive “Panorama”, ha condannato lo Stato italiano a risarcire Belpietro - per il torto patito - con 10mila euro, più 5mila per le spese legali. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano a pagare a Maurizio Belpietro 10 mila euro per danni morali e 5 mila per le spese processuali a causa della condanna a 4 anni di carcere, inflittagli dai giudici d'appello di Milano, per aver ospitato sul suo giornale un articolo del 2004 ritenuto gravemente diffamatorio a firma Lino Jannuzzi, allora senatore PdL. Senza entrare nel merito della questione giudiziaria, la Corte ha cioè ribadito un principio assimilato da tutti i Paesi europei: il carcere per i giornalisti per il reato di diffamazione - previsto dal nostro codice penale - è un abominio giuridico incompatibile con i principi della libertà d'informazione. A questo tema, di cui si è occupato anche Panorama , è dedicato il fondo di Vittorio Feltri su Il Giornale intitolato E l'Europa ci bastona. Un orrore il carcere per i giornalisti . “La vicenda dell'attuale direttore di Libero è addirittura paradossale. Udite. Lino Jannuzzi scrive un articolo scorticante sui misteri della mafia, citando qualche magistrato, e lo invia al Giornale. La redazione lo mette in pagina. E il dì appresso partono le querele delle suddette toghe. Si attende il processo di primo grado. Fra la sorpresa generale, il tribunale dopo avere udito testimoni ed esaminato approfonditamente le carte, assolve sia Jannuzzi sia Belpietro. Jannuzzi perché era senatore ed era suo diritto manifestare le proprie opinioni, senza limitazioni. Belpietro perché pubblicare il pezzo di un parlamentare non costituisce reato. Ovviamente, i soccombenti, cioè i querelanti, ricorrono in appello. E qui si ribalta tutto. Il direttore si becca quattro mesi di detenzione, per non parlare della sanzione economica: 100mila e passa euro. Trascorrono mesi e anni, e si arriva in Cassazione - suprema corte - che, lasciando tutti di stucco, conferma la sentenza di secondo grado, a dimostrazione che la giustizia è un casino, dove la certezza del diritto è un sogno degli ingenui o dei fessi. Belpietro, allora, zitto zitto, inoltra ricorso alla Corte di Strasburgo che, essendo più civile rispetto al nostro sistema marcio, riconosce al ricorrente di avere ragione. Attenzione. Le toghe europee non se la prendono con i colleghi italiani che, comunque , hanno esagerato con le pene, bensì con lo Stato e chi lo guida (governo e Parlamento) che consentono ancora - non avendo mai modificato i codici - di infliggere ai giornalisti la punizione del carcere, prediletta dalle dittature più infami.”
Anche il fondo di Belpietro è dedicato alla storica decisione della Corte di Strasburgo che ha dato ragione a quanti, tra cui Panorama, sostengono che il carcere per i giornalisti sia una stortura liberticida del nostro sistema penale che un Parlamento degno di questo nome dovrebbe subito cancellare con una nuova legge che preveda la pena pecuniaria, anziché il carcere. Così ricostruisce la vicenda il direttore di Libero.
La questione è che per aver dato conto delle opinioni di un senatore su un fatto di rilevante interesse nazionale un giornalista è stato condannato al carcere. Ho sbagliato a dar voce a Iannuzzi? Io non credo, perché anche le opinioni sbagliate se corrette da un contraddittorio o da una rettifica contribuiscono a far emergere la verità. Tuttavia, ammettiamo pure che io sia incorso in un errore, pubblicando opinioni non corrette: ma un errore va punito con il carcere? Allora cosa dovrebbe succedere ai magistrati che commettono errori giudiziari e privano della libertà una persona? Li mettiamo in cella e buttiamo via la chiave? Ovvio che no, ma nemmeno li sanzioniamo nella carriera o nel portafoglio, a meno che non commettano intenzionalmente lo sbaglio. Naturalmente non voglio mettere noi infimi cronisti sullo stesso piano di superiori uomini di legge, ma è evidente che c’è qualcosa che non va. Non dico che i giornalisti debbano avere licenza di scrivere, di diffamare e di insultare, ma nemmeno devono essere puniti con la galera perché sbagliano. Altrimenti la libertà di stampa e di informare va a quel paese, perché nel timore di incorrere nei rigori della legge nessuno scrive più nulla. Tradotto in giuridichese, questo è quel che i miei avvocati hanno scritto nel ricorso contro la condanna presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale proprio ieri ci ha dato ragione, condannando l’Italia a risarcirmi per i danni morali subiti e sentenziando che un omesso controllo in un caso di diffamazione non giustifica una sanzione tanto severa quale il carcere. Qualcuno penserà a questo punto che io mi sia preso una rivincita contro i giudici, ma non è così.
Siamo una masnada di fighetti neppure capaci di essere una corporazione, anzi peggio, siamo dei professionisti terminali e già «morti» come direbbe un qualsiasi Grillo, scrive Filippo Facci. La Corte di Strasburgo ha sancito che il carcere per un giornalista - Maurizio Belpietro, nel caso - costituisce una sproporzione e una violazione della libertà di espressione. È una sentenza che farà giurisprudenza più di cento altri casi, più della nostra Cassazione, più degli estenuanti dibattiti parlamentari che da 25 anni non hanno mai partorito una legge decente sulla diffamazione. Il sindacato dei giornalisti si è detto soddisfatto e anche molti quotidiani cartacei (quasi tutti) hanno almeno dato la notizia, che resta essenzialmente una notizia: ora spiegatelo ai censori del Fatto Quotidiano (il giornale di Marco Travaglio), a questi faziosi impregnati di malanimo che passano la vita a dare dei servi e chi non è affiliato al loro clan. Non una riga. Niente.
Tutt’altro trattamento, però, è riservato a Roberto Saviano. Ci dev'essere evidentemente un delirio nella mente di Saviano dopo la condanna per plagio, scrive Vittorio Sgarbi. Lo hanno chiamato per una occasione simbolico-folkloristica: guidare la Citroen Mehari che fu di Giancarlo Siani, un'automobile che rappresenta il gusto per la libertà di una generazione. All'occasione Saviano dedica un'intera pagina della Repubblica. Possiamo essere certi che non l'ha copiata, perché senza paura del ridicolo, di fronte alla tragedia della morte del giornalista, per il suo coraggio e le sue idee, che si potrebbero semplicemente celebrare ripubblicando i suoi articoli in un libro da distribuire nelle scuole (pensiero troppo facile) scrive: «Riaccendere la Mehari, ripartire, è il più bel dono che Paolo Siani (il fratello) possa fare non solo alla città di Napoli ma al Paese intero... la Mehari che riparte è il contrario del rancore, è il contrario di un legittimo sentimento di vendetta che Paolo Siani potrebbe provare». Eppure Roberto Saviano e la Mondadori sono stati condannati per un presunto plagio ai danni del quotidiano Cronache di Napoli, scrive “Il Corriere del Mezzogiorno”. Editore e scrittore sono stati ritenuti responsabili di «illecita riproduzione» nel bestseller Gomorra di tre articoli (pubblicati dai quotidiani locali «Cronache di Napoli» e «Corriere di Caserta»). In particolare, Saviano e Mondadori , suo editore prima del passaggio con Feltrinelli, sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per 60mila euro. Questa la decisione del secondo grado di giudizio. Spetterà adesso ai giudici di Cassazione dire l'ultima parola su una querelle che si trascina da almeno cinque anni, da quando cioè la società Libra, editrice dei due quotidiani campani, imputò allo scrittore anticamorra di essersi appropriato di diversi articoli senza citare la fonte per redigere alcune parti di Gomorra (corrispondenti, sostiene Saviano, a due pagine).
Detto questo si presume che le ritorsioni su chi testimonia una realtà agghiacciante abbiano uno stop ed invece c’è il servizio shock delle Iene sui carabinieri, ma il video scompare scatenando le ire del web.
“Ma il servizio di Viviani?”, “dove si può vedere il video riguardo Andrea Mavilla e il vergognoso abuso di potere che ha subito?”, “TIRATE FUORI IL VIDEO!”. Sono solo alcuni dei commenti che hanno inondato il 25 settembre 2013 la pagina Facebook di Le Iene, noto programma di Italia Uno la cui fama è legata ai provocatori, ma anche il più delle volte illuminanti, servizi di inchiesta, scrive “Che Donna”. Proprio oggi però l’intrepido coraggio dei ragazzi in giacca e cravatta è stato messo in dubbio proprio dai loro stessi fan. Ma andiamo con ordine.
Tempo fa Andrea Mavilla, blogger, filmò un’auto dei carabinieri mentre sostava contromano sulle strisce pedonali: l’uomo dimostrò che i tre militari rimasero diversi minuti nella pasticceria lì vicino, uscendo poi con un pacchetto della stessa. I carabinieri dovettero poi ricorrere alle vie legali, dimostrando con tanto di verbale che il pasticcere li aveva chiamati e loro, seguendo il regolamento, erano intervenuti parcheggiando la volante quanto più vicino possibile al locale. Il pacchetto? Un semplice regalo del negoziante riconoscente per la celerità dell’arma. Storia finita dunque? A quanto pare no. Il blogger infatti sostiene di aver subito una ritorsione da parte dell’arma: i carabinieri sarebbero entrati senza mandato in casa sua svolgendo una perquisizione dunque non autorizzata. Proprio qui sono intervenute Le Iene: Viviani, inviato del programma, ha infatti realizzato sull’accaduto un servizio andato in onda la sera del 25 settembre 2013, alla ripresa del programma dopo la pausa estiva. Inutile dire che la cosa ha subito calamitato l’attenzione del pubblico che così, la mattina dopo, si è catapultato sul web per rivedere il servizio. Peccato che questo risulta ad oggi irreperibile e la cosa non è proprio piaciuta al pubblico che ora alza la voce su Facebook per richiedere il filmato in questione. Come mai manca proprio quel filmato? Che i temerari di Italia Uno non siano poi così impavidi? Le provocazioni e le domande fioccano da questa mattina sul social network e la storia sembra dunque non finire qui.
Andrea Mavilla, blogger dallo spiccato senso civico, ha pubblicato su YouTube un filmato in cui pizzicava un’auto dei carabinieri in divieto di sosta, sulle strisce pedonali, in prossimità di un semaforo e controsenso, scrive “Blitz Quotidiano”. Oltre trecentomila contatti in poche ore e poco dopo un plotone di 30 carabinieri si precipita a casa sua, a Cavenago di Brianza, comune alle porte di Milano. Il video è stato girato domenica mattina, nel filmato intitolato “operazione pasticcini” il blogger insinua che i militari stessero comprando pasticcini all’interno della pasticceria accanto. Per svariati minuti il videoamatore resta in attesa dei carabinieri: ferma i passanti “signora guardi sono sulle strisce, in prossimità di un semaforo, saranno entrati a prendere i pasticcini in servizio”, commenta ironico “è scioccante”, “normale parcheggiare sulle strisce vero?”. Quando infine i carabinieri escono dalla pasticceria, con in mano un pacchetto, notano l’uomo con la telecamera in mano. Il blogger li bracca e chiede loro spiegazioni e i militari lo fermano per identificarlo. Il legale dei tre carabinieri, Luigi Peronetti, spiega che: “La realtà è un’altra. E lo dicono i documenti, non solo i miei assistiti. Il caso è agghiacciante e mostra come immagini neutre con un commentatore che insinua a e fa deduzioni malevole possano distorcere la realtà”. Sulla carta, in effetti, risulta che i carabinieri erano in quella pasticceria perché il proprietario aveva chiesto il loro intervento, hanno lasciato l’auto nel posto più vicino, come prevedono le disposizioni interne all’Arma in materia di sicurezza, hanno verificato richieste e problemi del pasticcere, hanno redatto un verbale, poi sono usciti. In mano avevano un pacchetto, è vero: “Ma certo. Solo che non l’avevano acquistato – continua l’avvocato Peronetti – in realtà i negozianti, per ringraziare i militari della gentilezza e della professionalità, hanno regalato loro alcune brioches avanzate a fine mattinata, da portare anche ai colleghi in caserma. I militari hanno rifiutato, e solo dopo alcune insistenze, hanno accettato il pacchetto. Al blogger bastava chiedere, informarsi prima di screditare così i miei assistiti!. Ora il blogger rischia guai grossi, perché i militari stanno valutando se procedere contro di lui legalmente per aver screditato la loro professionalità. Ma Andrea Mavilla non si arrende e controbatte: “Ho le prove che dimostrano i soprusi di cui sono stato vittima – annuncia – ho solo cercato di documentare un fatto che ho visto e ho ripreso per il mio blog, la mia passione. Ho visto quella che secondo me è una violazione al codice della strada, che in realtà è concessa ai carabinieri solo in caso di pericolo o emergenze. Poi hanno effettuato una perquisizione, ma i carabinieri non dovevano entrare in casa mia e la vicenda è in mano agli avvocati. Per questo motivo sono sotto choc, sconvolto e mi sento sotto attacco”.
Nel servizio de Le Iene, in onda martedì 25 settembre 2013, Andrea Mavilla è protagonista di un sequestro di beni non dovuto, a seguito di un video che documentava una macchina dei carabinieri parcheggiata sulle strisce pedonali e in controsenso, davanti ad una pasticceria. Mavilla, già ospite a Pomeriggio 5 per via di un’altra vicenda, è stato poi convocato in questura dove, racconta a Matteo Viviani de Le Iene, sarebbe stato costretto a denudarsi mentre veniva insultato: dichiarazioni che tuttavia non sono supportate da registrazioni audio o video, e che quindi non possono essere provate. Un esperto di informatica, però, ha fatto notare che, in seguito al sequestro dei computer di Mavilla, i carabinieri avrebbero cancellato ogni cosa presente sul pc dell’autore del filmato incriminato.
Uno dei servizi più interessanti (e, a tratti, agghiaccianti) andati in onda nella prima puntata de Le Iene Show, è stato quello curato da Matteo Viviani che ha documentato un presunto caso di abuso di potere perpetrato dai Carabinieri nei confronti di Andrea Mavilla. L’uomo è molto famoso su internet e, ultimamente, è apparso anche in televisione ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Ecco cos’è accaduto nel servizio de Le Iene.
Andrea accoglie la Iena Matteo Viviani in lacrime: ha la casa a soqquadro, come se fosse stata appena svaligiata dai ladri. Ma la verità è ben diversa. Purtroppo. L’incubo comincia quando Andrea Mavilla filma, con il proprio cellulare, una volante dei Carabinieri parcheggiata sulle strisce pedonali e davanti ad uno scivolo per disabili. L’auto rimane parcheggiata sulle strisce per circa venti minuti mentre i Carabinieri, presumibilmente, sono in pasticceria. Non appena gli agenti si accorgono di essere filmati, intimano ad Andrea di spegnere il cellulare e di mostrare loro i documenti. Poi inizia l’incubo. Il Comandante dei Carabinieri si sarebbe recato a casa di Andrea per intimargli di consegnargli tutto il materiale video e fotografico in suo possesso. Al rifiuto del ragazzo, gli agenti avrebbero iniziato a perquisire la sua casa alla ricerca di materiale compromettente. Matteo Viviani, nel suo servizio, ha riportato l’audio della la conversazione tra Andrea ed i carabinieri registrato tramite Skype da una collaboratrice di Andrea. Nel servizio andato in onda a Le Iene Show, poi, Andrea racconta quel che è accaduto dopo la presunta perquisizione: secondo Mavilla i Carabinieri lo avrebbero condotto in Caserma ed insultato pesantemente. Il giovane si sarebbe sentito poi male tanto da rendere necessario il suo ricovero in Ospedale. Una storia davvero incredibile che ha lasciato tutto il pubblico de Le Iene Show senza parole. Peccato che le stesse Iene abbiano censurato, o siano state costrette a farlo, il loro stesso lavoro.
MALAGIUSTIZIA. PUGLIA: BOOM DI CASI.
C’è l’elettricista incensurato scambiato per un pericoloso narcotrafficante per un errore nella trascrizione delle intercettazioni; e ci sono i due poliziotti accusati di rapina ai danni di un imprenditore, sottoposti nel 2005 a misura cautelare per 13 mesi, spogliati della divisa e poi assolti con formula piena. Ma nel frattempo hanno perso il lavoro, scrive Vincenzo Damiani su “Il Corriere del Mezzogiorno”. Sino alla drammatica storia di Filippo Pappalardi, ammanettato e rinchiuso in una cella con l’accusa - rivelatasi poi completamente sbagliata - di aver ucciso i suoi due figli, Francesco e Salvatore. E’ lungo l’elenco delle persone incastrate nelle maglie della malagiustizia, che hanno - loro malgrado - vissuto per mesi o per anni un incubo chiamato carcere. A Bari, secondo i dati ufficiali raccolti dal sito errori giudiziari.com, le richieste di risarcimento presentate per ingiusta detenzione, nell’ultimo anno, si sono più che raddoppiate: nel 2012 i giudici della Corte di appello hanno riconosciuto 29 errori da parte dei loro colleghi, condannando lo Stato a pagare complessivamente 911mila euro. A metà dell’ultimo anno i casi sono già passati a 64, valore totale degli indennizzi oltre 1,7 milioni. In aumento gli errori anche a Taranto, dove si è passati dai due risarcimenti riconosciuti nel 2012 ai sette del 2013. In controtendenza, invece, l’andamento nel distretto di Lecce: nel 2012 gli errori riconosciuti sono stati ben 97, quest’anno la statistica è ferma a 37. Spesso i mesi o addirittura gli anni trascorsi da innocente dietro le sbarre vengono "liquidati" con poche migliaia di euro, al danno così si unisce la beffa. Secondo quanto disposto dagli articoli 314 e 315 del codice penale e dalla Convenzione dei diritti dell’uomo, la persona diventata suo malgrado imputato ha diritto ad un’equa riparazione. La legge "Carotti" ha aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito un'ingiusta permanenza in carcere, passando da cento milioni di lire a 516mila euro, ma raramente viene riconosciuto il massimo. Per non parlare dei tempi per ottenere la riparazione: le cause durano anni, basti pensare che Filippo Pappalardi, giusto per fare un esempio, è ancora in attesa che venga discussa la sua richiesta. Ma il papà dei due fratellini di Gravina, i ragazzini morti dopo essere caduti accidentalmente in una cisterna, non è l’unico arrestato ingiustamente. Attenzione ingiusta detenzione da non confondere il risarcimento del danno per l’errore giudiziario causato da colpa grave o dolo. Eventi, questi, quasi mai rilevati dai colleghi magistrati contro i loro colleghi magistrati. Gianfranco Callisti conduceva una vita normale e portava avanti serenamente la sua attività di elettricista. Sino al giorno in cui, nel 2002, viene prelevato dai carabinieri e trasferito in carcere all’improvviso. La Procura e il Tribunale di Bari erano convinti che fosse coinvolto in un vasto traffico di droga, la storia poi stabilirà che si trattò di un tragico errore provocato da uno sbaglio nella trascrizione delle intercettazioni. Callisti da innocente fu coinvolto nella maxi inchiesta denominata "Operazione Fiume", come ci finì? Il suo soprannome, "Callo", fu confuso con il nome "Carlo", che era quello di una persona effettivamente indagato. Il telefono dell’elettricista non era sotto controllo, ma quello di un suo conoscente si, una casualità sfortunata che lo fece entrare nell’ordinanza di custodia cautelare. Si fece sei mesi in carcere, tre mesi ai domiciliari e tre mesi di libertà vigilata, prima che i giudici riconobbero il clamoroso abbaglio. Dopo 10 anni lo Stato gli ha riconosciuto un indennizzo di 50mila euro, nulla in confronto all’inferno vissuto.
Correva l'anno 1985 e Indro Montanelli, che a quel tempo direttore del Giornale, era ospite di Giovanni Minoli a Mixer, scrive Francesco Maria Del Vigo su “Il Giornale”. In un'intervista del 1985 il giornalista attacca le toghe. Dopo ventotto anni è ancora attuale: "C'è pieno di giudici malati di protagonismo. Chiedo ed esigo che la magistratura risponda dei suoi gesti e dei suoi errori spesso catastrofici"Un pezzo di modernariato, direte voi. Invece è una perfetta, precisa, lucida ma soprattutto attuale, fotografia della giustizia italiana. Sono passati ventotto anni. Si vede dai colori delle riprese, dagli abiti e anche dal format stesso della trasmissione. Ma solo da questo. In tutto il resto, il breve spezzone che vi riproponiamo, sembra una registrazione di poche ore fa. Attuale. Più che mai. Una prova della lungimiranza di Montanelli, ma anche la testimonianza dell'immobilità di un Paese che sembra correre su un tapis roulant: sempre in movimento, ma sempre nello stesso posto, allo stesso punto di partenza. Montanelli parla di giustizia e ci va giù pesante. Minoli lo interpella sul un articolo in cui aveva attaccato i giudici che avevano condannato Vincenzo Muccioli, fondatore ed allora patron di San Patrignano. Una presa di posizione che gli costò una querela. "Quello di Muccioli è uno dei più clamorosi casi in cui la giustizia si è messa contro la coscienza popolare", spiega Montanelli. Poi torna sulla sua querela: "Ne avrò delle altre. Non sono affatto disposto a tollerare una magistratura come quella che abbiamo in Italia". Montanelli continua attaccando il protagonismo delle toghe, puntando il dito in particolare contro il magistrato Carlo Palermo, e denunciando le degenerazioni di una stampa sempre più sensazionalistica e di una magistratura sempre più arrogante. Ma non solo. Il giornalista mette alla berlina i giudici che cavalcano le indagini per farsi vedere e poi, dopo aver rovinato uomini e aziende, non pagano per i loro errori. Parole profetiche. Sembra storia di oggi, invece è storia e basta. Insomma, una lezione attualissima. Una pagina sempreverde dell'infinita cronaca del Paese Italia. Purtroppo.
Libri. "Discorsi potenti. Tecniche di persuasione per lasciare il segno" di Trupia Flavia. Giusto per dire: con le parole fotti il popolo…che i fatti possono aspettare. Alcuni discorsi colpiscono; altri, invece, generano solo un tiepido applauso di cortesia. Dov'è la differenza? Cosa rende un discorso potente? Certamente l'argomento, l'oratore, il luogo e il momento storico sono fattori rilevanti. Ma non basta, occorre altro per dare forza a un discorso. Occorre la retorica. L'arte del dire non può essere liquidata come artificio ampolloso e manieristico. È, invece, una tecnica che permette di dare gambe e respiro a un'idea. È la persuasione la sfida affascinante della retorica. Quell'istante magico in cui le parole diventano condivisione, emozione, voglia di agire, senso di appartenenza, comune sentire dell'uditorio. Non è magia nera, ma bianca, perché la parola è lo strumento della democrazia. La retorica non è morta, non appartiene al passato. Fa parte della nostra vita quotidiana molto più di quanto immaginiamo. Siamo tutti retori, consapevoli o inconsapevoli. Tuttavia, per essere buoni retori è necessaria la conoscenza dell'arte oratoria. Ciò non vale solo per i politici ma per tutti coloro che si trovano nella condizione di pronunciare discorsi, presentare relazioni, convincere o motivare i propri interlocutori, argomentare sulla validità di una tesi o di un pensiero. Ecco allora un manuale che analizza le tecniche linguistiche utilizzate dai grandi oratori dei nostri giorni e ne svela i meccanismi di persuasione. Perché anche noi possiamo imparare a "lasciare il segno".
«Grillo è l'invidia», B. è l'inganno', dice Trupia a Rossana Campisi su “L’Espresso”.
Quali sono gli strumenti retorici dei politici? Un'esperta di comunicazione li ha studiati. E sostiene che il fondatore del M5S punta sulla rabbia verso chi sta in alto, mentre il capo del Pdl 'vende' sempre un sogno che non si realizzerà mai.
Che la nostra felicità dipendesse da un pugnetto di anafore, non ce lo avevano ancora detto. O forse si. «Gorgia da Lentini si godeva la Magna Grecia. Un bel giorno, smise di pensare e disse: la parola è farmacon. Medicina ma anche veleno». Flavia Trupia, ghostwriter ed esperta di comunicazione, ce lo ricorda. La storia dell'umanità, del resto, è lunga di esempi che lei ha ripreso in Discorsi potenti. Tecniche di persuasione per lasciare il segno (FrancoAngeli) e nel suo blog. «Spesso dimentichiamo il potere dell'arte della parola. La retorica insomma. Poi arrivano certi anniversari e tutti lì a prendere appunti».
Sono i 50 anni di I Have a Dream. Martin Luther King Jr., davanti al Lincoln Memorial di Washington, tiene il discorso conclusivo della marcia su Washington. Partiamo da qui?
«Sì, è uno di quelli che i linguisti non hanno mai smesso di studiare. Si tratta di un vero atto linguistico: le parole diventano azione. King aveva 34 anni, sarebbe morto dopo cinque anni. Quel 28 agosto del 1963 ha cambiato il mondo».
Con le sue parole?
«Chiamale parole. Lì dentro c'è tutto il mondo in cui credono ancora oggi gli americani: i riferimenti alla Bibbia, ne trovi una in ogni hotel e in ogni casa, quelli alle costituzioni e alle dichiarazioni nazionali, quelli ai motel, luogo tipico della cultura americana dove ti puoi riposare in viaggio. E poi ripeteva sempre "today": l'efficienza americana è da sempre impaziente».
Strategia dei contenuti.
«Magari fossero solo quelli. C'è il ritmo che è fondamentale. E poi cosa dire di quella meravigliosa anafora diventata quasi il ritornello di una canzone? "I Have a Dream" è ripetuto ben otto volte».
Il potere ha proprio l'oro in bocca.
«King ha cambiato il mondo rendendo gli uomini più uomini e meno bestie. Anche Goebbles faceva discorsi molto applauditi. Ma ha reso gli uomini peggio delle bestie».
Anche gli italiani hanno avuto bisogno di "discorsi" veri, no?
«Certo. Beppe Grillo è stato un grande trascinatore, ha emozionato le piazze, le ha fatte ridere e piangere. Il suo stile però è quello delle Filippiche. Inveire sempre. Scatenare l'invidia e l'odio per chi ha il posto fisso, per chi sta in Parlamento. Muove le folle ma costruisce poco».
Abbiamo perso anche questa occasione.
«King diceva di non bere alla coppa del rancore e dell'odio. Questa è una grande differenza tra i due. Il suo era in fondo un invito in fondo all'unità nazionale e la gente, bianca e nera, lo ha sentito».
Ma era anche un invito a sognare.
«Anche Berlusconi ha fatto sognare gli italiani. Indimenticabile il suo discorso d'esordio: "L'Italia è il paese che io amo". La gente aveva iniziato a pensare che finalmente si poteva fare politica in modo diverso e che si poteva parlare di ricchezza senza imbarazzi. Quello che propone però è un sogno infinito».
In che senso?
«Lo scorso febbraio ha fatto ancora promesse: non far pagare l'Imu. Lo ha fatto anche lui in termini biblici sancendo una sorta di alleanza tra gli italiani e lo Stato. Ma non è questo quello di cui abbiamo bisogno».
E di cosa?
«L'Imu da non pagare non basta. Aneliamo tutti a una visione diversa del paese dove viviamo, della nostra storia comune e personale».
Ci faccia un esempio.
«Alcide De Gasperi. Era appena finita la seconda guerra mondiale, lo aspettava la Conferenza di pace a Parigi. Partì per andare a negoziare le sanzioni per l'Italia che ne era uscita perdente. Questo piccolo uomo va ad affrontare letteralmente il mondo. Arriva e non gli stringono neanche la mano».
Cosa otterrà?
«Inizia il suo discorso così: "Avverto che in quest'aula tutto è contro di me...". Ha usato parole semplici ed educate. E' riuscito a far capire che l'Italia era ancora affidabile. Ha ottenuto il massimo del rispetto. Tutti cambiarono idea, capirono che il paese aveva chiuso col fascismo».
Sono passati un bel po' di anni.
«Solo dopo dieci quel discorso l'Italia divenne tra le potenze industriali più potenti del mondo».
La domanda «Perché oggi non ci riusciamo?» potrebbe diventare un'ennesima figura retorica: excusatio non petita accusatio manifesta.... Tanto vale.
STATO DI DIRITTO?
Berlusconi, il discorso integrale. Ecco l’intervento video del Cavaliere: «Care amiche, cari amici, voglio parlarvi con la sincerità con cui ognuno di noi parla alle persone alle quali vuole bene quando bisogna prendere una decisione importante che riguarda la nostra famiglia. Che si fa in questi casi? Ci si guarda negli occhi, ci si dice la verità e si cerca insieme la strada migliore. Siete certamente consapevoli che siamo precipitati in una crisi economica senza precedenti, in una depressione che uccide le aziende, che toglie lavoro ai giovani, che angoscia i genitori, che minaccia il nostro benessere e il nostro futuro. Il peso dello Stato, delle tasse, della spesa pubblica è eccessivo: occorre imboccare la strada maestra del liberalismo che, quando è stata percorsa, ha sempre prodotto risultati positivi in tutti i Paesi dell’Occidente: qual è questa strada? Meno Stato, meno spesa pubblica, meno tasse. Con la sinistra al potere, il programma sarebbe invece, come sempre, altre tasse, un’imposta patrimoniale sui nostri risparmi, un costo più elevato dello Stato e di tutti i servizi pubblici. I nostri ministri hanno già messo a punto le nostre proposte per un vero rilancio dell’economia, proposte che saranno principalmente volte a fermare il bombardamento fiscale che sta mettendo in ginocchio le nostre famiglie e le nostre imprese. Ma devo ricordare che gli elettori purtroppo non ci hanno mai consegnato una maggioranza vera, abbiamo sempre dovuto fare i conti con i piccoli partiti della nostra coalizione che, per i loro interessi particolari, ci hanno sempre impedito di realizzare le riforme indispensabili per modernizzare il Paese, prima tra tutte quella della giustizia. E proprio per la giustizia, diciamoci la verità, siamo diventati un Paese in cui non vi è più la certezza del diritto, siamo diventati una democrazia dimezzata alla mercé di una magistratura politicizzata, una magistratura che, unica tra le magistrature dei Paesi civili, gode di una totale irresponsabilità, di una totale impunità. Questa magistratura, per la prevalenza acquisita da un suo settore, Magistratura Democratica, si è trasformata da “Ordine” dello Stato, costituito da impiegati pubblici non eletti, in un “Potere” dello Stato, anzi in un “Contropotere” in grado di condizionare il Potere legislativo e il Potere esecutivo e si è data come missione, quella - è una loro dichiarazione - di realizzare “la via giudiziaria” al socialismo. Questa magistratura, dopo aver eliminato nel ’92 - ’93 i cinque partiti democratici che ci avevano governati per cinquant’anni, credeva di aver spianato definitivamente la strada del potere alla sinistra. Successe invece quel che sapete: un estraneo alla politica, un certo Silvio Berlusconi, scese in campo, sconfisse la gioiosa macchina da guerra della sinistra, e in due mesi portò i moderati al governo. Ero io. Subito, anzi immediatamente, i P.M. e i giudici legati alla sinistra e in particolare quelli di Magistratura Democratica si scatenarono contro di me e mi inviarono un avviso di garanzia accusandomi di un reato da cui sarei stato assolto, con formula piena, sette anni dopo. Cadde così il governo, ma da quel momento fino ad oggi mi sono stati rovesciati addosso, incredibilmente, senza alcun fondamento nella realtà, 50 processi che hanno infangato la mia immagine e mi hanno tolto tempo, tanto tempo, serenità e ingenti risorse economiche. Hanno frugato ignobilmente e morbosamente nel mio privato, hanno messo a rischio le mie aziende senza alcun riguardo per le migliaia di persone serie ed oneste che vi lavorano, hanno aggredito il mio patrimonio con una sentenza completamente infondata, che ha riconosciuto a un noto, molto noto, sostenitore della sinistra una somma quattro volte superiore al valore delle mie quote, con dei pretesti hanno attaccato me, la mia famiglia, i miei collaboratori, i miei amici e perfino i miei ospiti. Ed ora, dopo 41 processi che si sono conclusi, loro malgrado, senza alcuna condanna, si illudono di essere riusciti ad estromettermi dalla vita politica, con una sentenza che è politica, che è mostruosa, ma che potrebbe non essere definitiva come invece vuol far credere la sinistra, perché nei tempi giusti, nei tempi opportuni, mi batterò per ottenerne la revisione in Italia e in Europa. Per arrivare a condannarmi si sono assicurati la maggioranza nei collegi che mi hanno giudicato, si sono impadroniti di questi collegi, si sono inventati un nuovo reato, quello di “ideatore di un sistema di frode fiscale”, senza nessuna prova, calpestando ogni mio diritto alla difesa, rifiutandosi di ascoltare 171 testimoni a mio favore, sottraendomi da ultimo, con un ben costruito espediente, al mio giudice naturale, cioè a una delle Sezioni ordinarie della Cassazione, che mi avevano già assolto, la seconda e la terza, due volte, su fatti analoghi negando - cito tra virgolette - “l’esistenza in capo a Silvio Berlusconi di reali poteri gestori della società Mediaset”. Sfidando la verità, sfidando il ridicolo, sono riusciti a condannarmi a quattro anni di carcere e soprattutto all’interdizione dai pubblici uffici, per una presunta ma inesistente evasione dello zero virgola, rispetto agli oltre 10 miliardi, ripeto 10 miliardi di euro, quasi ventimila miliardi di vecchie lire, versati allo Stato, dal ’94 ad oggi, dal gruppo che ho fondato. Sono dunque passati vent’anni da quando decisi di scendere in campo. Allora dissi che lo facevo per un Paese che amavo. Lo amo ancora, questo Paese, nonostante l’amarezza di questi anni, una grande amarezza, e nonostante l’indignazione per quest’ultima sentenza paradossale, perché, voglio ripeterlo ancora, con forza, “io non ho commesso alcun reato, io non sono colpevole di alcunché, io sono innocente, io sono assolutamente innocente”. Ho dedicato l’intera seconda parte della mia vita, quella che dovrebbe servire a raccogliere i frutti del proprio lavoro, al bene comune. E sono davvero convinto di aver fatto del bene all’Italia, da imprenditore, da uomo di sport, da uomo di Stato. Per il mio impegno ho pagato e sto pagando un prezzo altissimo, ma ho l’orgoglio di aver impedito la conquista definitiva del potere alla sinistra, a questa sinistra che non ha mai rinnegato la sua ideologia, che non è mai riuscita a diventare socialdemocratica, che è rimasta sempre la stessa: la sinistra dell’invidia, del risentimento e dell’odio. Devo confessare che sono orgoglioso, molto orgoglioso, di questo mio risultato. Proprio per questo, adesso, insistono nel togliermi di mezzo con un’aggressione scientifica, pianificata, violenta del loro braccio giudiziario, visto che non sono stati capaci di farlo con gli strumenti della democrazia. Per questo, adesso, sono qui per chiedere a voi, a ciascuno di voi, di aprire gli occhi, di reagire e di scendere in campo per combattere questa sinistra e per combattere l’uso della giustizia a fini di lotta politica, questo male che ha già cambiato e vuole ancora cambiare la storia della nostra Repubblica. Non vogliamo e non possiamo permettere che l’Italia resti rinchiusa nella gabbia di una giustizia malata, che lascia tutti i giorni i suoi segni sulla carne viva dei milioni di italiani che sono coinvolti in un processo civile o penale. È come per una brutta malattia: uno dice “a me non capiterà”, ma poi, se ti arriva addosso, entri in un girone infernale da cui è difficile uscire. Per questo dico a tutti voi, agli italiani onesti, per bene, di buon senso: reagite, protestate, fatevi sentire. Avete il dovere di fare qualcosa di forte e di grande per uscire dalla situazione in cui ci hanno precipitati. So bene, quanto sia forte e motivata la vostra sfiducia, la vostra nausea verso la politica, verso “questa” politica fatta di scandali, di liti in tv, di una inconcludenza e di un qualunquismo senza contenuti: una politica che sembra un mondo a parte, di profittatori e di mestieranti drammaticamente lontani dalla vita reale. Ma nonostante questo, ed anzi proprio per questo, occorre che noi tutti ci occupiamo della politica. È sporca? Ma se la lasci a chi la sta sporcando, sarà sempre più sporca… Non te ne vuoi occupare? Ma è la politica stessa che si occuperà comunque di te, della tua vita, della tua famiglia, del tuo lavoro, del tuo futuro. È arrivato quindi davvero il momento di svegliarci, di preoccuparci, di ribellarci, di indignarci, di reagire, di farci sentire. È arrivato il momento in cui tutti gli italiani responsabili, gli italiani che amano l’Italia e che amano la libertà, devono sentire il dovere di impegnarsi personalmente. Per questo credo che la cosa migliore da fare sia quella di riprendere in mano la bandiera di Forza Italia. Perché Forza Italia non è un partito, non è una parte, ma è un’idea, un progetto nazionale che unisce tutti. Perché Forza Italia è l’Italia delle donne e degli uomini che amano la libertà e che vogliono restare liberi. Perché Forza Italia è la vittoria dell’amore sull’invidia e sull’odio. Perché Forza Italia difende i valori della nostra tradizione cristiana, il valore della vita, della famiglia, della solidarietà, della tolleranza verso tutti a cominciare dagli avversari. Perché Forza Italia sa bene che lo Stato deve essere al servizio dei cittadini e non invece i cittadini al servizio dello Stato. Perché Forza Italia è l’ultima chiamata prima della catastrofe. È l’ultima chiamata per gli italiani che sentono che il nostro benessere, la nostra democrazia, la nostra libertà sono in pericolo e rendono indispensabile un nuovo, più forte e più vasto impegno. Forza Italia sarà un vero grande movimento degli elettori, dei cittadini, di chi vorrà diventarne protagonista. Una forza che può e che deve conquistare la maggioranza dei consensi perché, vi ricordo, che solo con una vera e autonoma maggioranza in Parlamento si può davvero fare del bene all’Italia, per tornare ad essere una vera democrazia e per liberarci dall’oppressione giudiziaria, per liberarci dall’oppressione fiscale, per liberarci dall’oppressione burocratica. Per questo vi dico: scendete in campo anche voi. Per questo ti dico: scendi in campo anche tu, con Forza Italia. Diventa anche tu un missionario di libertà, diffondi i nostri valori e i nostri programmi, partecipa ai nostri convegni e alle nostre manifestazioni, impegnati nelle prossime campagne elettorali e magari anche nelle sezioni elettorali per evitare che ci vengano sottratti troppi voti, come purtroppo è sempre accaduto. Voglio ripeterlo ancora: in questo momento, nella drammatica situazione in cui siamo, ogni persona consapevole e responsabile che vuol continuare a vivere in Italia ha il dovere di occuparsi direttamente del nostro comune destino. Io sarò sempre con voi, al vostro fianco, decaduto o no. Si può far politica anche senza essere in Parlamento. Non è il seggio che fa un leader, ma è il consenso popolare, il vostro consenso. Quel consenso che non mi è mai mancato e che, ne sono sicuro, non mi mancherà neppure in futuro. Anche se, dovete esserne certi, continueranno a tentare di eliminare dalla scena politica, privandolo dei suoi diritti politici e addirittura della sua libertà personale, il leader dei moderati, quegli italiani liberi che, voglio sottolinearlo, sono da sempre la maggioranza del Paese e lo saranno ancora se sapranno finalmente restare uniti. Sono convinto che mi state dando ragione, sono convinto che condividete questo mio allarme, sono convinto che saprete rispondere a questo mio appello, che è prima di tutto una testimonianza di amore per la nostra Italia. E dunque: Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! Viva l’Italia, viva la libertà: la libertà è l’essenza dell’uomo e Dio creando l’uomo, l’ha voluto libero.»
Lettera aperta al dr Silvio Berlusconi.
«Sig. Presidente, sono Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Diverso, perché, nell’informare la gente dell’imperante ingiustizia, i magistrati se ne lamentano. E coloro che io critico, poi, sono quelli che mi giudicano e mi condannano. Ma io, così come altri colleghi perseguitati che fanno vera informazione, non vado in televisione a piangere la mia malasorte.
Pur essendo noi, per i forcaioli di destra e di sinistra, “delinquenti” come lei.
Sono un liberale, non come lei, ed, appunto, una cosa a Lei la voglio dire.
Quello che le è capitato, in fondo, se lo merita. 20 anni son passati. Aveva il potere economico. Aveva il potere mediatico. Aveva il potere politico. Aveva il potere istituzionale. E non è stato capace nemmeno di difendere se stesso dallo strapotere dei magistrati. Li ha lasciati fare ed ha tutelato gli interessi degli avvocati e di tutte le lobbies e le caste, fregandosene dei poveri cristi. Perché se quello di cui si lamenta, capita a lei, figuriamoci cosa capita alla povera gente. E i suoi giornalisti sempre lì a denunciare abusi ed ingiustizie a carico del loro padrone. Anzi, lei, oltretutto, imbarca nei suoi canali mediatici gente comunista genuflessa ai magistrati. Non una parola sul fatto che l’ingiustizia contro uno, siffatto potente, è l’elevazione a sistema di un cancro della democrazia. Quanti poveri cristi devono piangere la loro sorte di innocenti in carcere per convincere qualcuno ad intervenire? Se è vero, come è vero, che se funzionari di Stato appartenenti ad un Ordine si son elevati a Potere, è sacrosanto sostenere che un leader politico che incarna il Potere del popolo non sta lì a tergiversare con i suoi funzionari, ma toglie loro la linfa che alimenta lo strapotere di cui loro abusano. Ma tanto, chi se ne fotte della povera gente innocente rinchiusa in canili umani.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso! Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente in Italia. Cose che nessuno a lei vicino le dirà mai. Non troverà le cose ovvie. Cose che servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali.
Ad oggi, per esempio, sappiamo che lo studio di due ricercatori svela: i magistrati di sinistra indagano di più gli avversari politici; i magistrati di destra insabbiano di più le accuse contro i loro amici e colleghi. E poi. Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi. Inutile lamentarci dei "Caccamo" alla Cassazione. Carmine Schiavone ha detto: Roma nostra! "Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori. Lo strumento per addentrarsi nei gangli del potere sono gli esami di Stato ed i concorsi pubblici truccati.
Bene, dr Berlusconi, Lei, avendone il potere per 20 anni, oltre che lamentarsi, cosa ha fatto per tutelare, non tanto se stesso, i cui risultati sono evidenti, ma i cittadini vittime dell’ingiustizia (contro il singolo) e della malagiustizia (contro la collettività)?
Quello che i politici oggi hanno perso è la credibilità: chi a torto attacca i magistrati; chi a torto li difende a spada tratta; chi a torto cerca l’intervento referendario inutile in tema di giustizia, fa sì che quel 50 % di astensione elettorale aumenti. Proprio perché, la gente, è stufa di farsi prendere in giro. Oltremodo adesso che siete tutti al Governo delle larghe intese per fottere il popolo. Quel popolo che mai si chiede: ma che cazzo di fine fanno i nostri soldi, che non bastano mai? E questo modo di fare informazione e spettacolo della stampa e della tv, certamente, alimenta il ribrezzo contro l'odierno sistema di potere.
Per fare un sillogismo. Se l’Italia è la Costa Concordia, e come tale è affondata, la colpa non è dello Schettino di turno, ma dell’equipaggio approssimativo di cui si è circondato. E se la Costa Crociere ha la sua Flotta e l’Italia ha la sua amministrazione centrale e periferica, quanti Schettino e relativi equipaggi ci sono in giro a navigare? E quante vittime i loro naufragi provocano? Si dice che l’Italia, come la Costa Concordia, è riemersa dall’affondamento? Sì, ma come? Tutta ammaccata e da rottamare!!! E gli italioti lì a belare……»
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. È uno Stato di diritto che funziona quello che è costretto a sborsare ogni anno decine di milioni per rimborsare cittadini che hanno dovuto trascorrere giorni, mesi, anni in carcere da innocenti? È uno Stato di diritto quello in cui dove dovrebbero stare 100 detenuti ce ne stanno 142? È uno Stato di diritto quello in cui ogni quattro procedimenti già fissati per il dibattimento tre vengono rinviati per motivi vari?
Domande che con Andrea Cuomo su “Il Giornale” giriamo al premier Enrico Letta del Partito Democratico (ex PCI), che - in funzione chiaramente anti-Cav - ha giurato: «In Italia lo Stato di diritto funziona». Postilla: «Non ci sono persecuzioni». Chissà che cosa pensano in particolare di questa ultima affermazione categorica le tantissime vittime di errori giudiziari a cui il quotidiano romano Il Tempo ha dedicato un'inchiesta di cinque giorni che ha contrassegnato l'insediamento alla direzione del nostro ex inviato Gian Marco Chiocci, che di giornalismo giudiziario ne mastica eccome.
Tanti i dati sciorinati e le storie raccontate dal quotidiano di piazza Colonna. Secondo cui per il Censis, nel dopoguerra, sono stati 5 milioni gli italiani coinvolti in inchieste giudiziarie e poi risultati innocenti. Di essi circa 25mila sono riusciti a ottenere il rimborso per ingiusta detenzione a partire dal 1989, per un esborso totale di 550 milioni di euro in tutto: del resto per ogni giorno passato in carcere lo Stato riconosce all'innocente 235,83 euro, e la metà (117,91) in caso di arresti domiciliari. Il tetto massimo di rimborso sarebbe di 516.456,90 euro. Ma Giuseppe Gulotta, che con il marchio di duplice assassino impresso sulla pelle da una confessione estorta a forza di botte (metodo usato per tutti) ha trascorso in cella 22 anni per essere scagionato nel 2012, pretende 69 milioni. Tanto, se si pensa al tetto di cui sopra. Nulla se questo è il prezzo di una vita squartata, merce che un prezzo non ce l'ha. Per il caso Sebai, poi, è calata una coltre di omertà. I condannanti per i delitti di 13 vecchiette, anche loro menati per rendere una confessione estorta, sono ancora dentro, meno uno che si è suicidato. Questi non risultano come vittime di errori giudiziari, nonostante il vero assassino, poi suicidatosi, ha confessato, con prove a sostegno, la sua responsabilità. Lo stesso fa Michele Misseri, non creduto, mentre moglie e figlia marciscono in carcere. Siamo a Taranto, il Foro dell’ingiustizia.
E siccome i cattivi giudici non guardano in faccia nessuno, spesso anche i vip sono caduti nella trappola dell'errore giudiziario. Il più famoso è Enzo Tortora. Ma ci sono anche Serena Grandi, Gigi Sabani, Lelio Luttazzi, Gioia Scola, Calogero Mannino e Antonio Gava nel Who's Who della carcerazione ingiusta. Carcerazione che è a suo modo ingiusta anche per chi colpevole lo è davvero quando è trascorsa nelle 206 carceri italiane. La cui capienza ufficiale sarebbe di 45.588 persone ma ne ospitano 66.632. Lo dice il rapporto «Senza Dignità 2012» dell'associazione Antigone, vero museo degli orrori delle prigioni d'Italia. Il Paese secondo il cui premier «lo Stato di diritto è garantito». Pensate se non lo fosse.
Non solo ci è impedito dire “Italia di Merda” in base alla famosa sentenza della Corte di Cassazione. In questo Stato, addirittura, è vietato dire “Fisco di Merda”. Per gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, con le motivazioni della sentenza del tribunale di Milano che il 19 luglio 2013 li ha condannati a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di omessa dichiarazione dei redditi, è arrivata, dopo il danno, anche la beffa. La sentenza li obbliga a risarcire con 500mila euro il «danno morale» arrecato al Fisco italiano. Di cosa sono colpevoli? Da molti anni i «simboli» della moda italiana denunciano l’eccessiva pressione fiscale. All’indomani della sentenza avevano chiuso per protesta i negozi di Milano. E una critica, pare, può costare cara. La sentenza sembra quasi contenere una excusatio non petita: il danno, scrivono i magistrati, è dovuto «non tanto, ovviamente, per l’esposizione a legittime critiche in merito agli accertamenti, quanto per il pregiudizio che condotte particolarmente maliziose cagionano alla funzionalità del sistema di accertamento ed alla tempestiva percezione del tributo».
Ora venite a ripeterci che le sentenze non si discutono, scrive Filippo Facci. Gli stilisti Dolce & Gabbana sono già stati condannati a un anno e otto mesi per evasione fiscale, e pace, lo sapevamo. Ma, per il resto, chiudere i propri negozi per protesta è un reato oppure non lo è. E non lo è. Il semplice denunciare l’eccesso di pressione fiscale è un reato oppure non lo è. E non lo è. Comprare una pagina di giornale per lamentarsi contro Equitalia è un reato oppure non lo è. E non lo è. Rilasciare interviste contro il fisco rapace è un reato oppure non lo è. E non lo è. E se non lo è - se queste condotte non sono reati - la magistratura non può prendere questi non-reati e stabilire che nell’insieme abbiano inferto un «danno morale» al fisco italiano, come si legge nelle motivazioni della sentenza appena rese note. I giudici non possono stabilire che degli atti leciti «cagionano pregiudizio alla funzionalità del sistema di accertamento e alla tempestiva percezione del tributo». Ergo, i giudici non possono affibbiare a Dolce & Gabbana altri 500mila euro di risarcimento per «danno morale», come hanno fatto: perché significa che il diritto di critica è andato definitivamente a ramengo e che la sola cosa da fare è pagare e stare zitti, perché sennò la gente, sai, poi pensa male di Equitalia. Ecco perché occorre proteggerla da quella moltitudine di crudeli cittadini pronti a infliggerle terrificanti danni morali con le loro lagnanze. Siamo alla follia.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti?
Provi a leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che nessuno le dirà mai.
Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali.
CHI E’ IL POLITICO?
Ora lo dice anche la scienza: la politica manda fuori di testa. Incapace di accettare idee diverse e pronto a manipolare i dati a proprio comodo. Il cervello della casta secondo Yale, scrive “Libero Quotidiano”. Oramai c'è anche il sigillo della scienza: la politica rende intellettualmente disonesti. Lo dimostra uno studio condotto da Dan Kahan della Yale University: la passione politica compromette il funzionamento della mente e induce a distorcere logica e capacità di calcolo. Perché? Perché il cervello del politico, come risulta dallo studio, prova a ogni costo a modificare i dati reali per farli aderire alla propria visione del mondo.
L'esperimento, la prima parte - Tra i vari esperimenti che hanno composto lo studio (pubblicato col titolo “Motivated numeracy and Enlightened self-government”), ce n'è uno che illustra meglio di tutti il meccanismo di deformazione intellettuale dei politici. E' stato chiesto alle "cavie" di interpretare delle tavole numeriche relativa alla capacità di provocare prurito di alcune creme dermatologiche. Non avendo l'argomento implicazioni sociali, i politici sono stati in grado di eseguire correttamente i calcoli aritmetici.
L'esperimento, la seconda parte - In seconda battuta, allo stesso campione umano è stato chiesto di leggere tavole che per tema, però, avevano il rapporto tra licenze dei porti d'armi e variazione del tasso di criminalità. E i nodi sono venuti al pettine. Avendo l'argomento ovvia rilevanza politica, le cavie sono andate in tilt. Quando si trovavano a dover rispondere a quesiti aritmetici in contraddizione con le proprie convinzioni, sbagliavano in maniera inconscia anche calcoli semplici per non dover arrivare a una soluzione sgradita. Insomma: meglio andare fuori strada che imboccare una strada spiacevole.
Le conclusioni - Il prof della Yale non ha dubbi: la passione politica è una fatto congenito che però condiziona il cervello. Una volta che il politico fa sua una certa visione del mondo, non c'è dato o riscontro oggettivo che possa fargli cambiare idea.
CHI E’ L’AVVOCATO?
Chi è l’avvocato: fenomenologia di una categoria, spiega un anonimo sul portale “La Legge per tutti”.
O li si ama o li si odia: non esistono vie di mezzo per gli avvocati, una delle categorie professionali più contraddittorie e discusse dai tempi degli antichi greci.
“E il Signore disse: Facciamo Satana, così la gente non mi incolperà di tutto. E facciamo gli avvocati, così la gente non incolperà di tutto Satana”.
La battuta del comico statunitense, George Burns, è il modo migliore per aprire l’argomento su una delle professioni da sempre più discusse. Perché, diciamoci la verità, appena si parla di “avvocati” la prima idea che corre è quella di una “categoria“: non tanto nel senso di lobby, quanto di un mondo sociale a parte, con i suoi strani modi di essere e di pensare. Insomma, proprio come quando si pensa ad una razza animale.
Difensori dei diritti o azzeccagarbugli abili solo a far assolvere i colpevoli? Professionisti della logica o dotati retori? La linea di confine è così labile che l’immaginario collettivo li ha sempre collocati a cavallo tra la menzogna e il rigore.
Di tutto questo, però, una cosa è certa: gli avvocati formano un mondo a sé.
La parola “avvocato” deriva dal latino “vocatus“‘ ossia “chiamato”. Non nel senso, come verrebbe spontaneo pensare, che all’indirizzo di questa figura vengono rivolti irripetibili epiteti offensivi, ma nel significato che a lui ci si rivolge quando si ha bisogno di aiuto.
L’odio da sempre legato al legale va a braccetto con la parola “parcella“: un peso che ha trascinato questa categoria nel più profondo girone dantesco. Perché – la gente si chiede – bisogna pagare (anche profumatamente) per far valere i propri diritti? In realtà, la risposta è la stessa per cui bisogna remunerare un medico per godere di buona salute o aprire un mutuo per avere un tetto sotto cui dormire. Tuttavia, i fondamenti della difesa legale risalgono a quando, già dagli antichi greci, i soliti individui omaggiati di improvvisa ricchezza erano anche quelli inabissati di profonda ignoranza: costoro trovarono più conveniente affidare ai più istruiti la difesa dei propri interessi. E ciò fu anche la consegna delle chiavi di un’intera scienza. Perché, da allora, il popolo non si è più riappropriato di ciò che era nato per lui: la legge.
I primi avvocati erano anche filosofi, e questo perché non esistevano corpi legislativi definiti e certi. Erano, insomma, la classe che non zappava, ma guardava le stelle. Un’anima teorica che, a quanto sembra, è rimasta sino ad oggi.
Ciò che, però, si ignora è che, ai tempi dei romani, il compenso dell’avvocato era la fama, acquisita la quale si poteva pensare d’intraprendere la carriera politica. In quel periodo sussisteva il divieto di ricevere denaro in cambio delle proprie prestazioni professionali e la violazione di tale precetto era sanzionata con una pena pecuniaria. Il divieto, sin da allora e secondo buona prassi italica, veniva sistematicamente raggirato poiché era consentito – proprio come avviene oggi nei migliori ambienti della pubblica amministrazione – accettare doni e regalie da parte dei clienti riconoscenti. Da qui venne il detto: “ianua advocati pulsanda pede” (“alla porta dell’avvocato si bussa col piede”, visto che le mani sono occupate a reggere i doni).
“La giurisprudenza estende la mente e allarga le vedute”: una considerazione che, seppur vera, si scontra con la prassi. Il carattere di un avvocato, infatti, è permaloso e presuntuoso. Provate a fargli cambiare idea: se ci riuscirete sarà solo perché lui vi ha fatto credere così. In realtà, ogni avvocato resta sempre della propria idea. Giusta o sbagliata che sia. Ed anche dopo la sentenza che gli dà torto. A sbagliare è sempre il giudice o la legge.
L’avvocato è una persona abituata a fare domande e, nello stesso tempo, ad essere evasivo a quelle che gli vengono rivolte. È solito prendere decisioni e a prenderle in fretta (calcolate la differenza di tempi con un ingegnere e vedrete!). È dotato di problem solving e il suo obiettivo è trovare l’escamotage per uscire fuori dal problema, in qualsiasi modo possibile.
Inoltre, l’avvocato, nell’esercizio della propria professione, è un irriducibile individualista: se ne sta nel suo studio, a coltivare le sue pratiche, e l’idea dell’associativismo gli fa venire l’orticaria.
Egli considera ogni minuto sottratto al proprio lavoro una perdita di tempo. Il tempo appunto: ogni legale nasce con l’orologio al polso, e questo perché la vita professionale è costellata di scadenze. Tra termini iniziali, finali, dilatori, ordinatori, perentori, ogni avvocato considera la propria agenda più della propria compagna di letto.
Così come la caratteristica di ogni buon medico è quella di scrivere le ricette con una grafia incomprensibile, dote di ogni avvocato è parlare con un linguaggio mai chiaro per il cittadino. Tra latinismi, istituti, tecnicismi, concettualismi, astrazioni, teorie e interpretazioni, commi, articoli, leggi, leggine e sentenze, il vocabolario del legale è precluso ad ogni persona che non sia, appunto, un altro legale. E questo – a quanto sembra – gratifica infinitamente ogni avvocato che si rispetti.
Su tutto, però, l’avvocato è un relativista nell’accezione più pirandelliana del termine. La realtà non esiste (e chi se ne frega!): esiste solo ciò che appare dalle carte. Tutto il resto è mutevole, contraddittorio, variabile, volubile, capriccioso, instabile. Tanto vale non pensarci e accontentarsi di ciò che racconta il cliente.
Si dice che il problema dell’avvocatura sia il numero. Su 9.000 giudici, in Italia ci sono circa 220.000 avvocati. In realtà, il problema sarebbe di gran lunga più grave se di avvocati ve ne fossero pochi, circostanza che aprirebbe le porte alla scarsità e, quindi, a tariffe ancora più alte e a una certa difficoltà a poter difendere tutti.
La ragione di tale eccesso di offerta risiede nel fatto che la facilità con cui si accede, oggi, all’avvocatura ha fatto si che tale professione venisse considerata una sorta di area di transito in cui potersi parcheggiare in attesa di un lavoro più soddisfacente (e, di questi tempi, remunerativo). Poi, però, le cose non vanno mai come programmato e ciò che doveva essere un impegno momentaneo diventa quello di una vita (salvo tentare il classico concorso pubblico e inseguire la chimera del posto fisso a reddito certo).
Ci piace terminare con le parole di Giulio Imbarcati, pseudonimo di un collega che ha saputo prendere in giro la categoria, disegnandola anche finemente in un suo libro di successo.
“Il problema è che oggi nel campo dell’avvocatura (più che in altre professioni) non è il mercato a operare la selezione.
Se così fosse tutti saremmo più tranquilli e fiduciosi, perché questo vorrebbe dire qualità del servizio. E, come dovrebbe essere in qualsiasi sistema sociale che voglia definirsi giusto, dopo l’uguale allineamento ai nastri di partenza, i più dotati procedono veloci, i mediocri arrancano, gli inadatti si fermano.
Ma, nel mondo all’incontrario che abbiamo costruito con lungimirante impegno, le cose funzionano diversamente.
Capita che siano proprio i più dotati a soccombere e non solo davanti ai mediocri, ma anche rispetti agli inadatti.
Perché? Ma perché proprio i mediocri e gli inadatti sono quelli più disposti al compromesso e all’ipocrisia.
Proprio loro, cioè, per raggiungere gli obiettivi, e consapevoli della modesta dote professionale, hanno meno difficoltà a discostarsi da quelle coordinate di riferimento che i dotati continuano a considerare sacre e inviolabili.
L’effetto, nel settore dell’avvocatura, è dirompente e a pagarne gli effetti non sarà solo il fruitore immediato (ossia il cittadino), ma l’intero sistema giustizia.“
DELINQUENTE A CHI?
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
CHI E’ IL MAGISTRATO?
"Giustizia usata per scopi politici". Se lo dice anche la Boccassini... Una sparata senza precedenti contro le toghe politicizzate, contro quella branca della magistratura che ha usato le aule di tribunale per spiccare il volo in parlamento. A Ilda la Rossa, che la politica l'ha sempre fatta direttamente nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano, proprio non vanno giù i vari Antonio Di Pietro, Luigi De Magistris e Antonio Ingroia che, negli ultimi anni, hanno amaramente tentato di accaparrarsi una poltrona. "Non è una patologia della magistratura - ha spiegato la pm di Milano - ma ci sono dei pubblici ministeri che hanno usato il loro lavoro per altro".
«Ognuno deve fare la sua parte, anche i politici, anche i giornalisti, ma in questi vent'anni lo sbaglio di noi magistrati è di non aver mai fatto un'autocritica o una riflessione. Perché si è verificato ed è inaccettabile che alcune indagini sono servite ad altro (per gli stessi magistrati, per carriere, per entrare in politica)». Alcuni suoi colleghi si sono sentiti portatori di verità assolute per le loro indagini grazie al "consenso sociale", cosa sbagliatissima, una "patologia", sia per lei, sia per Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Roma, seduto al suo fianco. Una sparata senza precedenti contro le toghe politicizzate, contro quella branca della magistratura che ha usato le aule di tribunale per spiccare il volo in parlamento. A Ilda la Rossa, che la politica l'ha sempre fatta direttamente nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano, proprio non vanno giù i vari Antonio Di Pietro, Luigi De Magistris e Antonio Ingroia che, negli ultimi anni, hanno amaramente tentato di accaparrarsi una poltrona. "Non è una patologia della magistratura - ha spiegato la pm di Milano - ma ci sono dei pubblici ministeri che hanno usato il loro lavoro per altro".
«Io - racconta Boccassini, che dopo trent'anni ha cambiato colore e taglio di capelli, è diventata bionda - durante Tangentopoli, stavo in Sicilia. Noi vivevano in hotel "bunkerizzati", con i sacchi di sabbia, intorno era guerra. E quando arrivavo a Milano, per salutare i colleghi, vedevo le manifestazioni a loro favore, "Forza mani pulite""». E non le piaceva, anzi "ho provato una cosa terribile" quando la folla scandiva i nomi dei magistrati, perché a muoverli "non dev'essere l'approvazione". «Non è il consenso popolare che ci deve dare la forza di andare avanti, ma il fatto di far bene il nostro mestiere. Ho sempre vissuto molto male gli atteggiamenti osannanti delle folle oceaniche degli anni di Mani pulite e delle stragi di mafia"». Intervenuta alla presentazione del libro di Lionello Mancini, "L'onere della toga", il 14 settembre 2013 il pm milanese Ilda Boccassini ha sottolineato gli atteggiamenti e le dinamiche che si sono sviluppate nella magistratura negli ultimi vent'anni. «Un'anomalia dalla quale dovremo uscire per forza di cose. Quello che rimprovero alla mia categoria è di non aver mai fatto una seria autocritica in tutti questi anni», ha concluso.
Come ha sottolineato Giuseppe Pignatone, una riflessione dovrebbe nascere in seguito al processo Borsellino: ci sono stati dei condannati sino alla cassazione, ma poi le confessioni di un collaboratore di giustizia hanno raccontato che la verità era un'altra: "Chi ha sbagliato in buona fede deve dirlo", perché i magistrati dell'accusa devono muoversi sempre sulle prove certe, invece, a volte, ripete Pignatone, "quando le prove non ci sono, alcune notizie vengono fatte uscire sui giornali, per una carica moralistica che non deve appartenere alla magistratura". Anzi, è il contrario. La parola che Pignatone usa di più è "equilibrio", sia per fermarsi, per evitare che persone finiscano nei guai senza prove, sia "per partire e andare sino in fondo quando le prove ci sono". Tutti e due hanno collaborato a lungo nelle inchieste che hanno decimato alcune tra le cosche più potenti della 'ndrangheta.
Sono entrambi - e lo dicono - in prima pagina dieci volte di più dei colleghi citati nel libro di Mancini, ma conoscono la "nausea" comune a chiunque debba fare un mestiere difficile, che ha a che fare con la vita, la morte, il dolore. E per questo, "se un giornalista ha una notizia che mette in pericolo la vita di una persona, non la deve dare", dice Boccassini, Pignatone concorda, De Bortoli e Mancini alzano gli occhi al cielo.
L’idolatria è il male endemico di una società debole. Ha come effetti il ridimensionamento della condizione civile del singolo, il suo declassamento da cittadino a cliente oppure a percettore di una identità e/o idealità passive, chiuse nel recinto di una tifoseria. Io sono con te, sempre e comunque. Non amo altro Dio all’infuori di te. Fa dunque bene Ilda Boccassini a denunciare la trasformazione sociale dell’identità del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, che nella storia recente della Repubblica è spesso assurto a stella del firmamento sociale, si è fatto, malgrado ogni sua buona e condivisibile intenzione, parte di una battaglia; ha goduto di un riconoscimento che magari esuberava dalle sue funzioni, dalla qualità di rappresentante della legge (“uguale per tutti”) che gli avrebbe dovuto far osservare l’obbligo di assoluta e rigorosa discrezione.
LA SCIENZA LO DICE: I MAGISTRATI FANNO POLITICA. I ROSSI ATTACCANO. GLI AZZURRI INSABBIANO.
Ecco la prova: i giudici fanno politica. Lo studio di due ricercatori svela: i magistrati di sinistra indagano di più la destra. Ecco la prova: i giudici fanno politica. La persecuzione degli avversari rilevata in un saggio scientifico, scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. Alla fine, la questione può essere riassunta così, un po' cinicamente: ma d'altronde il convegno si tiene nella terra del Machiavelli. «Chiunque di noi fa preferenze. Se può scegliere se indagare su un nemico o su un amico, indaga sul nemico. È l'istinto umano. E vale anche in politologia». Parola di Andrea Ceron, ricercatore alla facoltà di Scienze politiche di Milano. Che insieme al collega Marco Mainenti si è messo di buzzo buono a cercare risposte scientifiche a una domanda che si trascina da decenni: ma è vero che in Italia i giudici indagano in base alle loro preferenze politiche? La risposta Ceron e Mainenti la daranno oggi a Firenze, presentando il loro paper - anticipato ieri dal Foglio - in occasione del convengo annuale della Società italiana di Scienza politica. È una risposta basata su tabelle un po' difficili da capire, modelli matematici, eccetera. Ma la risposta è chiara: sì, è vero. La magistratura italiana è una magistratura politicizzata, le cui scelte sono condizionate dalle convinzioni politiche dei magistrati. I pm di sinistra preferiscono indagare sui politici di destra. I pm di destra chiudono un occhio quando di mezzo ci sono i loro referenti politici. Una tragedia o la conferma scientifica dell'esistenza dell'acqua calda? Forse tutte e due le cose insieme. Ventidue pagine, rigorosamente scritte in inglese, intitolate «Toga Party: the political basis of judicial investigations against MPs in Italy, 1983-2013». Dove MPs è l'acronimo internazionale per «membri del Parlamento». I politici, la casta, quelli che da un capo all'altro della terra devono fare i conti con le attenzioni della magistratura. Racconta Ceron: «Nei paesi dove i magistrati sono eletti dalla popolazione, come l'America o l'Australia, che si facciano condizionare dalla appartenenza politica è noto e quasi scontato. Ma cosa succede nei paesi, come l'Italia, dove in magistratura si entra per concorso e dove non c'è un controllo politico? Questa è la domanda da cui abbiamo preso le mosse». Ricerca articolata su due hypothesis, come si fa tra scienziati empirici: 1) più l'orientamento politico di un giudice è lontano da quello di un partito, più il giudice è disposto a procedere contro quel partito; 2) i giudici sono più disponibili a indagare su un partito, quanto più i partiti rivali aumentano i loro seggi. Come si fa a dare una risposta che non sia una chiacchiera da bar? Andando a prendere una per una le richiesta di autorizzazione a procedere inviate dalle procure di tutta Italia al Parlamento nel corso di trent'anni, prima, durante e dopo Mani Pulite; catalogando il partito di appartenenza dei destinatari. E andando a incrociare questo dato con l'andamento, negli stessi anni e negli stessi tribunali, delle elezioni per gli organi dirigenti dell'Associazione nazionale magistrati, l'organizzazione sindacale delle toghe, catalogandoli in base al successo delle correnti di sinistra (Magistratura democratica e Movimento per la giustizia), di centro (Unicost) e di destra (Magistratura indipendente); e dividendo un po' bruscamente in «tribunali rossi» e in «tribunali blu». «Il responso è stato inequivocabile», dice Ceron. Ovvero, come si legge nel paper: «I risultati forniscono una forte prova dell'impatto delle preferenze dei giudici sulle indagini. I tribunali dove un numero più alto di giudici di sinistra appartengono a Md e all'Mg, tendono a indagare maggiormente sui partiti di destra. La politicizzazione funziona in entrambe le direzioni: un aumento di voti per le fazioni di destra fa scendere le richieste contro i partiti di destra». I numeri sono quelli di una gigantesca retata: 1.256 richieste di autorizzazione a procedere nei confronti di 1.399 parlamentari. Di queste, i due ricercatori hanno focalizzato quelle relative ai reati di corruzione e finanziamento illecito: 526, per 589 parlamentari. Fino al 1993, come è noto, l'autorizzazione serviva anche per aprire le indagini, oggi è necessaria solo per arrestare o intercettare. Ma, secondo la richiesta di Ceron e Mainardi, non è cambiato nulla: almeno nella componente ideologica dell'accusa, che i due considerano scientificamente e platealmente dimostrata. Dietro due grandi alibi, che sono la mancanza di risorse e la presunta obbligatorietà dell'azione penale, di fatto vige la più ampia discrezionalità. È un pm quasi sempre ideologicamente schierato a scegliere su quale politico indagare. E quasi sempre dimentica di dimenticarsi le sue opinioni. «L'analisi dei dati - spiega Ceron - dice che i comportamenti sono lievemente diversi tra giudici di sinistra e di destra: quelli di sinistra sono più attivi nell'indagare gli avversari, quelli di destra preferiscono risparmiare accuse ai politici del loro schieramento». Ma in ogni caso, di giustizia piegata all'ideologia e all'appartenenza politica si tratta. Unita ad un'altra costante, di cui pure qualche traccia si coglie a occhio nudo: fino a quando un partito è saldamente al potere, i pm sono cauti. Ma quando il suo potere traballa e si logora, allora si scatenano.
Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
TRAMONTO ROSSO. I COMUNISTI E LA GIUSTIZIA.
Questo libro va usato come uno strumento per capire chi sono i Rossi, la classe politica di centrosinistra chiamata a rinnovare il paese. Scritto come un viaggio in Italia, da nord a sud, regione per regione, città per città. I protagonisti, gli affari, gli scandali, le inchieste. Uomini chiave come l’ex capo della segreteria politica Pd Filippo Penati, accusato di aver imposto tangenti, o il tesoriere della fu Margherita Luigi Lusi, che ha fatto sparire 22 milioni di euro di fondi elettorali. Roccaforti rosse come l’Emilia investite da casi di malaffare e penetrazioni mafiose mai visti. Nel Comune di Serramazzoni (Modena) indagini su abusi edilizi e gare pubbliche. I 3 milioni di cittadini accorsi alle primarie per la scelta del leader sono un’iniezione di fiducia. Ma nella contesa manca un programma chiaro di riforme in termini di diritti, lavoro, crescita. La difesa del finanziamento pubblico ai partiti spetta al tesoriere dei Ds Ugo Sposetti da Viterbo. Sposetti blinda in una serie di fondazioni il “patrimonio comunista” prima della fusione con la Margherita. Il Pd continua a occuparsi di banche dopo la scalata illegale di Unipol a Bnl (caso Monte dei Paschi). Il sistema sanitario nelle regioni rosse è piegato agli interessi corporativi. Tutta una classe politica che per anni ha vissuto di inciuci con Berlusconi, ora si dichiara ripulita e finalmente pronta a governare. Ma i nomi sono gli stessi di sempre. Ma anche il sistema Ds prima e Pd poi in tutte le regioni d’Italia dove il governo si è protratto per anni e che tra sanità, cemento e appalti e municipalizzata , i conflitti di interesse dal Lazio alla Puglia all’Emilia si moltiplicano.
Così gli ex Pci condizionano le procure. Inchieste insabbiate, politici protetti, giudici trasferiti: le anomalie da Nord a Sud nel libro "Tramonto rosso", scrive Patricia Tagliaferri su “Il Giornale”. Il Pd e i suoi scandali, dal nord al sud d'Italia, dentro e fuori le Procure. Abusi, tangenti, speculazioni edilizie, scalate bancarie, interessi corporativi nel sistema sanitario, magistrati scomodi isolati, intimiditi, trasferiti. Potenti di turno miracolosamente soltanto sfiorati da certe indagini. È un libro che farà discutere quello scritto da Ferruccio Pinotti, giornalista d'inchiesta autore di numerosi libri di indagine su temi scomodi, e Stefano Santachiara, blogger del Fatto. Atteso e temuto Tramonto rosso, edito da Chiarelettere, sarà in libreria a fine ottobre 2013, nonostante le voci di un blocco, smentito dagli autori, e dopo un piccolo slittamento (inizialmente l'uscita era prevista a giugno 2013) dovuto, pare, ad un capitolo particolarmente spinoso su una forte influenza «rossa» che agirebbe all'interno di uno dei tribunali più importanti d'Italia, quello di Milano, dove indagini che imboccano direzioni non previste non sarebbero le benvenute mentre altre troverebbero la strada spianata. Il libro presenta un ritratto della classe politica di centrosinistra, quella che si dichiara pulita e pronta a prendere in mano le redini del Paese, ma che è sempre la stessa. Stessi nomi, stesse beghe, stessi affanni. Un partito, il Pd, per niente diverso dagli altri nonostante si proclami tale. Gli uomini chiave della sinistra troveranno molte pagine dedicate a loro. Ce n'è per tutti. Per il tesoriere dei Ds Ugo Sposetti, che ha blindato in una serie di fondazioni il «patrimonio comunista» prima della fusione con la Margherita, per l'ex componente della segreteria di Bersani, Filippo Penati, accusato di corruzione e di finanziamento illecito, per l'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, che avrebbe fatto sparire 22 milioni di euro di fondi elettorali. Gli autori passano dagli abusi edilizi e dalle infiltrazioni mafiose nell'Emilia rossa al pericoloso rapporto della sinistra con gli istituiti bancari, da Unipol a Monte dei Paschi. Molto è stato scritto sulla scalata Unipol-Bnl, sulla partecipazione ai vertici Ds e sul sequestro di 94 milioni di euro di azioni di Antonveneta disposto nel 2005 dal gip Clementina Forleo. Poco si sa, invece, su cosa è accaduto dopo al giudice che si è trovato tra le mani un fascicolo con i nomi di pezzi molto grossi del Pd. «Tramonto rosso» riordina alcuni fatti e segnala circostanze, talvolta inquietanti, che certamente fanno riflettere. Come le gravi intimidazioni subite dalla Forleo, le minacce, gli attacchi politici, le azioni disciplinari, l'isolamento. Fino al trasferimento per incompatibilità ambientale, nel 2008, poi clamorosamente bocciato da Tar e Consiglio di Stato. Il tutto nel silenzio dei colleghi per i quali i guai del gip erano legati al suo brutto carattere e non certo ai suoi provvedimenti sulle scalate bancarie. «Questa pervicacia contra personam è l'emblema dell'intromissione politica nella magistratura», si legge nel testo. Gli autori approfondiscono poi il noto salvataggio operato dalla Procura di Milano nei confronti di Massimo D'Alema e Nicola Latorre, descritti dalla Forleo nell'ordinanza del luglio 2007, finalizzata a chiedere il placet parlamentare all'uso delle telefonate nei procedimenti sulle scalate, come concorrenti del reato di aggiotaggio informativo del presidente di Unipol Gianni Consorte. Con la Forleo, sempre più nel mirino, oggetto di riunioni pomeridiane in cui alcuni colleghi milanesi avrebbero discusso la strategia contro di lei, come rivelato dal gip Guido Salvini. Per trovare un altro esempio di come riescono ad essere minimizzate le inchieste che coinvolgono il Pd basta scendere a Bari. Qui a fare le spese di un'indagine scomoda su alcuni illeciti nel sistema sanitario regionale è stato il pm Desirèe Digeronimo, duramente osteggiata dai colleghi fino al trasferimento.
DUE PAROLE SULLA MAFIA. QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
«Berlusconi aveva assunto lo stalliere Vittorio Mangano per far entrare Cosa Nostra dentro la sua villa. Il patto sancito in una cena a Milano alla quale avevano partecipato lo stesso Cavaliere e diversi esponenti della criminalità organizzata siciliana». Le motivazioni (pesantissime) della condanna d'appello per Dell'Utri. «E' stato definitivamente accertato che Dell'Utri, Berlusconi, Cinà, Bontade e Teresi (tre mafiosi) avevano siglato un patto in base al quale l'imprenditore milanese avrebbe effettuato il pagamento di somme di denaro a Cosa nostra per ricevere in cambio protezione (...)». E poi: «Vittorio Mangano non era stato assunto per la sua competenza in materia di cavalli, ma per proteggere Berlusconi e i suoi familiari e come presidio mafioso all'interno della villa dell'imprenditore». Sono parole pesantissime quelle che i giudici della terza sezione penale della Corte di appello di Palermo nelle motivazioni della sentenza con cui Marcello Dell'Utri è stato condannato il 25 marzo 2013 a sette anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Parole pesanti verso lo stesso Dell'Utri, che «tra il 1974 e il 1992 non si è mai sottratto al ruolo di intermediario tra gli interessi dei protagonisti», e «ha mantenuto sempre vivi i rapporti con i mafiosi di riferimento», ma anche verso l'ex premier dato che Dell'Utri viene definito «mediatore contrattuale» del patto tra Cosa Nostra e lo stesso Berlusconi. Secondo i giudici, «è stato acclarato definitivamente che Dell'Utri ha partecipato a un incontro organizzato da lui stesso e Cinà (mafioso siciliano) a Milano, presso il suo ufficio. Tale incontro, al quale erano presenti Dell'Utri, Gaetano Cinà, Stefano Bontade, Mimmo Teresi, Francesco Di Carlo e Silvio Berlusconi, aveva preceduto l'assunzione di Vittorio Mangano presso Villa Casati ad Arcore, così come riferito da Francesco Di Carlo e de relato da Antonino Galliano, e aveva siglato il patto di protezione con Berlusconi». «In tutto il periodo di tempo in oggetto (1974-1992) Dell'Utri ha, con pervicacia, ritenuto di agire in sinergia con l'associazione e di rivolgersi a coloro che incarnavano l'anti Stato, al fine di mediare tra le esigenze dell'imprenditore milanese (Silvio Berlusconi) e gli interessi del sodalizio mafioso, con ciò consapevolmente rafforzando il potere criminale dell'associazione», è scritto poi nelle motivazioni. Dell'Utri quindi è «ritenuto penalmente responsabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa dal 1974 al 1992» e la sua personalità «appare connotata da una naturale propensione ad entrare attivamente in contatto con soggetti mafiosi, da cui non ha mai mostrato di volersi allontanare neppure in momenti in cui le proprie vicende personali e lavorative gli aveva dato una possibilità di farlo» .
Per i magistrati è più utile considerare Berlusconi un mafioso, anziché considerarlo una vittima dell’inefficienza dello Stato che non sa difendere i suoi cittadini. Una vittima che è disposta ai compromessi per tutelare la sicurezza dei suoi affari e della sua famiglia.
Chi paga il pizzo per lo Stato è un mafioso. E se non ti adegui ti succede quello che succede a tutti. Una storia esemplare. Valeria Grasso: “Ho denunciato la mafia, ora denuncio lo Stato”. “Una vergogna, una vergogna senza fine”. Con queste poche parole si può descrivere la situazione dei Testimoni di Giustizia in Italia. Dove lo Stato non riesce a fare il proprio dovere. Fino in fondo. Sono troppe le storie drammatiche, che restano nel silenzio. Troppi gli ostacoli, le difficoltà, i pericoli, i drammi. I testimoni di giustizia, fondamentali per la lotta alla criminalità organizzata, devono essere protetti e sostenuti. Nel Paese delle mafie lo Stato abbandona i suoi testimoni. Lo ha fatto in passato e sta continuando a farlo. Non stiamo parlando dei "pentiti", dei collaboratori di giustizia. Di chi ha commesso dei reati e ha deciso, per qualsiasi ragione, di "collaborare" con lo Stato. Anche i "pentiti" (quelli credibili) servono, sono necessari per combattere le organizzazioni criminali. Ma i testimoni sono un’altra cosa. Sono semplici cittadini, che non hanno commesso reati. Hanno visto, hanno subito e hanno deciso di "testimoniare". Per dovere civico, perché è giusto comportarsi in un certo modo. Nel BelPaese il dovere civico è poco apprezzato. I testimoni di giustizia, in Italia, denunciano le stesse problematiche. Ma nessuno ascolta, risponde. Si sentono abbandonati. Prima utilizzati e poi lasciati in un "limbo" profondo. Senza luce e senza futuro.
“La mafia, come ci è inculcata dalla stampa di regime, è un’entità astratta, impossibile da debellare, proprio perché non esiste.”
Lo scrittore Antonio Giangrande sul fenomeno “Mafia” ha scritto un libro: “MAFIOPOLI. L’ITALIA DELLE MAFIE. QUELLO CHE NON SI OSA DIRE”. Book ed E-Book pubblicato su Amazon.it e che racconta una verità diversa da quella profusa dai media genuflessi alla sinistra ed ai magistrati.
«L'Italia tenuta al guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere. La “Politica” deve essere legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione.»
Continua Antonio Giangrande.
«La mafia cos'è? La risposta in un aneddoto di Paolo Borsellino: "Sapete che cos'è la Mafia... faccia conto che ci sia un posto libero in tribunale..... e che si presentino 3 magistrati... il primo è bravissimo, il migliore, il più preparato.. un altro ha appoggi formidabili dalla politica... e il terzo è un fesso... sapete chi vincerà??? Il fesso. Ecco, mi disse il boss, questa è la MAFIA!"
“La vera mafia è lo Stato, alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da mafiosi. Il magistrato che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo voglio in galera”. Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da Pecora su Radio 2.
“Da noi - ha dichiarato Silvio Berlusconi ai cronisti di una televisione greca il 23 febbraio 2013 - la magistratura è una mafia più pericolosa della mafia siciliana, e lo dico sapendo di dire una cosa grossa”. “In Italia regna una "magistocrazia". Nella magistratura c'è una vera e propria associazione a delinquere”. Lo ha detto Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013 durante la riunione del gruppo Pdl a Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi all'attacco ai magistrati: «L'Anm è come la P2, non dice chi sono i loro associati». Il riferimento dell'ex premier è alle associazioni interne ai magistrati, come Magistratura Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile 2013 per un comizio.
Questi sono solo pochi esempi di dichiarazioni ufficiali.
Abbiamo una Costituzione catto-comunista predisposta e votata dagli apparati politici che rappresentavano la metà degli italiani, ossia coloro che furono i vincitori della guerra civile e che votarono per la Repubblica. Una Costituzione fondata sul lavoro (che oggi non c’è e per questo ci rende schiavi) e non sulla libertà (che ci dovrebbe sempre essere, ma oggi non c’è e per questo siamo schiavi). Un diritto all’uguaglianza inapplicato in virtù del fatto che il potere, anziché essere nelle mani del popolo che dovrebbe nominare i suoi rappresentanti politici, amministrativi e giudiziari, è in mano a mafie, caste, lobbies e massonerie.
Siamo un popolo corrotto: nella memoria, nell’analisi e nel processo mentale di discernimento. Ogni dato virulento che il potere mediatico ci ha propinato, succube al potere politico, economico e giudiziario, ha falsato il senso etico della ragione e logica del popolo. Come il personal computer, giovani e vecchi, devono essere formattati. Ossia, azzerare ogni cognizione e ripartire da zero all’acquisizione di conoscenze scevre da influenze ideologiche, religiose ed etniche. Dobbiamo essere consci del fatto che esistono diverse verità.
Ogni fatto è rappresentato da una verità storica; da una verità mediatica e da una verità giudiziaria.
La verità storica è conosciuta solo dai responsabili del fatto. La verità mediatica è quella rappresentata dai media approssimativi che sono ignoranti in giurisprudenza e poco esperti di frequentazioni di aule del tribunale, ma genuflessi e stanziali negli uffici dei pm e periti delle convinzioni dell’accusa, mai dando spazio alla difesa. La verità giudiziaria è quella che esce fuori da una corte, spesso impreparata culturalmente, tecnicamente e psicologicamente (in virtù dei concorsi pubblici truccati). Nelle aule spesso si lede il diritto di difesa, finanche negando le più elementari fonti di prova, o addirittura, in caso di imputati poveri, il diritto alla difesa. Il gratuita patrocinio è solo una balla. Gli avvocati capaci non vi consentono, quindi ti ritrovi con un avvocato d’ufficio che spesso si rimette alla volontà della corte, senza conoscere i carteggi. La sentenza è sempre frutto della libera convinzione di una persona (il giudice). Mi si chiede cosa fare. Bisogna, da privato, ripassare tutte le fasi dell’indagine e carpire eventuali errori dei magistrati trascurati dalla difesa (e sempre ve ne sono). Eventualmente svolgere un’indagine parallela. Intanto aspettare che qualche pentito, delatore, o intercettazione, produca una nuova prova che ribalti l’esito del processo. Quando poi questa emerge bisogna sperare nella fortuna di trovare un magistrato coscienzioso (spesso non accade per non rilevare l’errore dei colleghi), che possa aprire un processo di revisione.
Non sarà la mafia a uccidermi ma alcuni miei colleghi magistrati (Borsellino). La verità sulle stragi non la possiamo dire noi Magistrati ma la deve dire la politica se non proprio la storia (Ingroia). Non possiamo dire la verità sulle stragi altrimenti la classe politica potrebbe non reggere (Gozzo). Non sono stato io a cercare loro ma loro a cercare me (Riina). In Italia mai nulla è come appare. Ipocriti e voltagabbana. Le stragi come eccidi di Stato a cui non è estranea la Magistratura e gran parte della classe politica del tempo.
Chi frequenta bene le aule dei Tribunali, non essendo né coglione, né in mala fede, sa molto bene che le sentenze sono già scritte prima che inizi il dibattimento. Le pronunce sono pedisseque alle richieste dell’accusa, se non di più. Anche perché se il soggetto è intoccabile l’archiviazione delle accuse è già avvenuta nelle fasi successive alla denuncia o alla querela: “non vi sono prove per sostenere l’accusa” o “il responsabile è ignoto”. Queste le motivazioni in calce alla richiesta accolta dal GIP, nonostante si conosca il responsabile o vi siano un mare di prove, ovvero le indagini non siano mai state effettuate. La difesa: un soprammobile ben pagato succube dei magistrati. Il meglio che possono fare è usare la furbizia per incidere sulla prescrizione. Le prove a discarico: un perditempo, spesso dannoso. Non è improbabile che i testimoni della difesa siano tacciati di falso.
Nel formulare la richiesta la Boccassini nel processo Ruby ha fatto una gaffe dicendo: "Lo condanno", per poi correggersi: "Chiedo la condanna" riferita a Berlusconi.
Esemplare anche è il caso di Napoli. Il gip copia o si limita a riassumere le tesi accusatorie della Procura di Napoli e per questo il tribunale del riesame del capoluogo campano annulla l'arresto di Gaetano Riina, fratello del boss di Cosa nostra, Totò, avvenuto il 14 novembre 2011. L'accusa era di concorso esterno in associazione camorristica. Il gip, scrive il Giornale di Sicilia, si sarebbe limitato a riassumere la richiesta di arresto della Procura di Napoli, incappando peraltro in una serie di errori e non sostituendo nella sua ordinanza neanche le parole «questo pm» con «questo gip».
Il paradosso, però, sono le profezie cinematografiche adattate ai processi: «... e lo condanna ad anni sette di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e all'interdizione legale per la durata della pena». Non è una frase registrata Lunedì 24 giugno 2013 al Tribunale di Milano, ma una battuta presa dagli ultimi minuti del film «Il caimano» di Nanni Moretti. La condanna inflitta al protagonista (interpretato dallo stesso regista) è incredibilmente identica a quella decisa dai giudici milanesi per Silvio Berlusconi. Il Caimano Moretti, dopo la sentenza, parla di «casta dei magistrati» che «vuole avere il potere di decidere al posto degli elettori».
Tutti dentro se la legge fosse uguale per tutti. Ma la legge non è uguale per tutti. Così la Cassazione si è tradita. Sconcertante linea delle Sezioni unite civili sul caso di un magistrato sanzionato. La Suprema Corte: vale il principio della discrezionalità.
Ed in fatto di mafia c’è qualcuno che la sa lunga. «Io non cercavo nessuno, erano loro che cercavano me….Mi hanno fatto arrestare Provenzano e Ciancimino, non come dicono, i carabinieri……Di questo papello non ne sono niente….Il pentito Giovanni Brusca non ha fatto tutto da solo, c'è la mano dei servizi segreti. La stessa cosa vale anche per l'agenda rossa. Ha visto cosa hanno fatto? Perchè non vanno da quello che aveva in mano la borsa e si fanno consegnare l'agenda. In via D'Amelio c'erano i servizi……. Io sono stato 25 anni latitante in campagna senza che nessuno mi cercasse. Com'è possibile che sono responsabile di tutte queste cose? La vera mafia sono i magistrati e i politici che si sono coperti tra di loro. Loro scaricano ogni responsabilità sui mafiosi. La mafia quando inizia una cosa la porta a termine. Io sto bene. Mi sento carico e riesco a vedere oltre queste mura……Appuntato, lei mi vede che possa baciare Andreotti? Le posso dire che era un galantuomo e che io sono stato dell'area andreottiana da sempre». Le confidenze fatte da Toto Riina, il capo dei capi, sono state fatte in due diverse occasioni, a due guardie penitenziarie del Gom del carcere Opera di Milano.
Così come in fatto di mafia c’è qualcun altro che la sa lunga. Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
Lo strumento per addentrarsi nei gangli del potere sono gli esami di Stato ed i concorsi pubblici truccati.
I criteri di valutazione dell’elaborato dell’esame di magistrato, di avvocato, di notaio, ecc.
Secondo la normativa vigente, la valutazione di un testo dell’esame di Stato o di un Concorso pubblico è ancorata ad alcuni parametri. Può risultare utile, quindi, che ogni candidato conosca le regole che i commissari di esame devono seguire nella valutazione dei compiti.
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.
Ciò significa che la comprensibilità dell’elaborato — sotto il profilo della grafia, della grammatica e della sintassi — costituisce il primo criterio di valutazione dei commissari. Ne consegue che il primo accorgimento del candidato deve essere quello di cercare di scrivere in forma chiara e scorrevole e con grafia facilmente leggibile: l’esigenza di interrompere continuamente la lettura, per soffermarsi su parole indecifrabili o su espressioni contorte, infastidisce (e, talvolta, irrita) i commissari ed impedisce loro di seguire il filo del ragionamento svolto nel compito. Le varie parti dell’elaborato devono essere espresse con un periodare semplice (senza troppi incisi o subordinate); la trattazione dei singoli argomenti giuridici deve essere il più possibile incisiva; le ripetizioni vanno evitate; la sequenza dei periodi deve essere rispettosa della logica (grammaticale e giuridica). Non va mai dimenticato che ogni commissione esaminatrice è composta da esperti (avvocati, magistrati e docenti universitari), che sono tenuti a leggere centinaia di compiti in tempi relativamente ristretti: il miglior modo di presentarsi è quello di esporre — con una grafia chiara o, quanto meno, comprensibile (che alleggerisca la fatica del leggere) — uno sviluppo ragionato, logico e consequenziale degli argomenti.
Questa è la regola, ma la prassi, si sa, fotte la regola. Ed allora chi vince i concorsi pubblici e chi supera gli esami di Stato e perché si pretende da altri ciò che da sé non si è capaci di fare, né di concepire?
PARLIAMO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, MADRE DI TUTTE LE CORTI. UN CASO PER TUTTI.
La sentenza contro il Cavaliere è zeppa di errori (di grammatica).
Frasi senza soggetto, punteggiatura sbagliata... Il giudizio della Cassazione è un obbrobrio anche per la lingua italiana. Dopodiché ecco l’impatto della realtà nella autentica dettatura delle motivazioni a pag.183: «Deve essere infine rimarcato che Berlusconi, pur non risultando che abbia trattenuto rapporti diretti coi materiali esecutori, la difesa che il riferimento alle decisioni aziendali consentito nella pronuncia della Cassazione che ha riguardato l’impugnazione della difesa Agrama della dichiarazione a non doversi procedere per prescrizione in merito ad alcune annualità precedenti, starebbe proprio ad indicare che occorre aver riguardo alle scelte aziendali senza possibilità. quindi, di pervernire...». Ecco. Di prim’acchito uno si domanda: oddio, che fine ha fatto la punteggiatura? Ma dov’è il soggetto? Qual è la coordinata, quante subordinate transitano sul foglio. «...ad una affermazione di responsabilità di Berlusconi che presumibilmente del tutto ignari delle attività prodromiche al delitto, ma conoscendo perfettamente il meccanismo, ha lasciato che tutto proseguisse inalterato, mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti da lui scelti...». Eppoi, affiorano, «le prove sono state analiticamente analizzate». O straordinarie accumulazioni semantiche come «il criterio dell’individuazione del destinatario principale dei benfici derivanti dall’illecito fornisce un risultato convergente da quello che s’è visto essere l’esito dell’apprezzamento delle prove compito dai due gradi di merito..» E poi, nello scorrere delle 208 pagine della motivazione, ci trovi i «siffatto contesto normativo», gli «allorquando», gli «in buona sostanza», che accidentano la lettura. Ed ancora la frase «ha posto in essere una frazione importante dell’attività delittuosa che si è integrata con quella dei correi fornendo un contributo causale...». Linguaggio giuridico? Bene anch’io ho fatto Giurisprudenza, ed anch’io mi sono scontrato con magistrati ed avvocati ignoranti in grammatica, sintassi e perfino in diritto. Ma questo, cari miei non è linguaggio giuridico, ma sono gli effetti di un certo modo di fare proselitismo.
LE DINASTIE DEI MAGISTRATI.
LA FAMIGLIA ESPOSITO
Qualcuno potrebbe definirla una famiglia “particolare” scrive “Libero Quotidiano”. Al centro c'è Antonio Esposito, giudice della Corte di Cassazione che in una telefonata-intervista al Mattino anticipò le motivazioni della condanna inflitta a Silvio Berlusconi per frode fiscale nel processo Mediaset. E che in più occasioni è stato “pizzicato” da testimoni a pronunciare frasi non proprio di ammirazione nei confronti del Cavaliere. Poi c'è la nipote Andreana, che sta alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui i legali di Berlusconi vorrebbero far ricorso contro la sentenza emessa dalla Cassazione. Paradosso: a passare al vaglio la sentenza pronunciata da Esposito potrebbe essere la nipote. Non bastassero loro, c'è il papà di Andreana, che come scrive, mercoledì 28 agosto, su Libero Peppe Rinaldi, è stato fotografato mentre prende il sole e fa il bagno presso il Lido Oasi di Agropoli, nel Cilento. Il problema è che il lido è abusivo ed è stato soggetto a indagini, interpellanze, ordinanze di abbattimento. In zona tutti sanno. Curioso che Vitaliano Esposito, ex procuratore generale della Cassazione, non sappia di mettersi a mollo in uno stabilimento balneare fuorilegge (abusivo a sua insaputa). Infine, della famiglia fa parte anche Ferdinando Esposito, Pubblico Ministero a Milano, che tempo fa finì sotto indagine del Csm (che poi archiviò) per le cene a lume di candela del giudice (ma va, anche lui?) in Porsche con Nicole Minetti, allora già imputata per istigazione alla prostituzione insieme a Lele Mora ed Emilio Fede.
Una famiglia, gli Esposito, una delle tante dinastie giudiziarie, che non fosse altro dimostra come la magistratura sia una vera, autentica, casta.
Ciononostante viviamo in un’Italia fatta così, con italiani fatti così, bisogna subire e tacere. Questo ti impone il “potere”. Ebbene, si faccia attenzione alle parole usate per prendersela con le ingiustizie, i soprusi e le sopraffazioni, le incapacità dei governati e l’oppressione della burocrazia, i disservizi, i vincoli, le tasse, le code e la scarsezza di opportunità del Belpaese. Perché sfogarsi con il classico "Italia paese di merda", per quanto liberatorio, non può essere tollerato dai boiardi di Stato. E' reato, in quanto vilipendio alla nazione. Lo ha certificato la Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 4 luglio 2013 n. 28730!!!
Ma non di solo della dinastia Esposito è piena la Magistratura.
LA FAMIGLIA DE MAGISTRIS.
La famiglia e le origini, secondo “Panorama”. I de Magistris sono giudici da quattro generazioni. Ma Luigi, l’ultimo erede, della famiglia è stato il primo a essere trasferito per gli errori commessi nell’esercizio delle funzioni. Il bisnonno era magistrato del Regno già nel 1860, il nonno ha subito due attentati, il padre, Giuseppe, giudice d’appello affilato e taciturno, condannò a 9 anni l’ex ministro Francesco De Lorenzo e si occupò del processo Cirillo. Luigi assomiglia alla madre Marzia, donna dal carattere estroverso. Residenti nell’elegante quartiere napoletano del Vomero, sono ricordati da tutti come una famiglia perbene. In via Mascagni 92 vivevano al terzo piano, al primo l’amico di famiglia, il noto ginecologo Gennaro Pietroluongo. Ancora oggi la signora Marzia è la sua segretaria, in una clinica privata del Vomero. Un rapporto che forse ha scatenato la passione del giovane de Magistris per le magagne della sanità. Luigi Pisa, da quarant’anni edicolante della via, ricorda così il futuro pm: "Un ragazzino studioso. Scendeva poco in strada a giocare a pallone e già alle medie comprava Il Manifesto". Il padre, invece, leggeva Il Mattino e La Repubblica. Il figlio ha studiato al Pansini, liceo classico dell’intellighenzia progressista vomerese. Qui il giovane ha conosciuto la politica: le sue biografie narrano che partecipò diciassettenne ai funerali di Enrico Berlinguer. All’esame di maturità, il 12 luglio 1985, ha meritato 51/60. A 22 anni si è laureato in giurisprudenza con 110 e lode. L’avvocato Pierpaolo Berardi, astigiano, classe 1964, da decenni sta battagliando per far annullare il concorso per entrare in magistratura svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo "apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti") e quindi non "furono mai esaminati". I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: "Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione". Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. Uno dei commissari, successivamente, ha raccontato su una rivista giuridica l’esame contestato, narrando alcuni episodi, fra cui quello di un professore di diritto che, avendo appreso prima dell’apertura delle buste della bocciatura della figlia, convocò il vicepresidente della commissione. Non basta. Scrive l’esaminatore: "Durante tutti i lavori di correzione, però, non ho mai avuto la semplice impressione che s’intendesse favorire un certo candidato dopo che i temi di questo erano stati riconosciuti". Dunque i lavori erano anonimi solo sulle buste. "Episodi come questi prevedono, per come riconosciuto dallo stesso Csm, l’annullamento delle prove in questione" conclude con Panorama Berardi. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, Luigi de Magistris.
LA FAMIGLIA BORRELLI.
Biografia di Francesco Saverio Borrelli. Napoli 12 aprile 1930. Ex magistrato (1955-2002). Dal 1992 al 1998 capo della Procura di Milano, divenne noto durante l’inchiesta del pool Mani pulite. Dal 1999 alla pensione procuratore generale della Corte d’appello milanese, in seguito è stato capo dell’ufficio indagini della Federcalcio (maggio 2006-giugno 2007) e presidente del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano (marzo 2007-aprile 2010). Due fratelli maggiori e una sorella minore, Borrelli nacque dal secondo matrimonio del magistrato Manlio (figlio e nipote di magistrati) con Amalia Jappelli detta Miette. «Fino a sette anni non sapevo che i miei fratelli avessero avuto un’altra madre, morta quando erano piccolissimi. Nessuno mi aveva mai detto nulla. Me lo rivelò un uomo stupido ridacchiando: “Ma che fratelli, i tuoi sono fratellastri”. Fu uno shock tremendo. Corsi a casa disperato. Volevo sapere, capire. I miei avevano voluto salvaguardare l’uguaglianza tra fratelli: non dovevo sentirmi un privilegiato perché io avevo entrambi i genitori. Mi chetai, ma mi restò a lungo una fantasia di abbandono, il timore, che più tardi ho saputo comune a molti bambini, di essere un trovatello. Tremavo nel mio lettino e pregavo che non fosse così». Dopo due anni a Lecce, nel 1936 la famiglia traslocò a Firenze: maturità al liceo classico Michelangelo, laurea in giurisprudenza con Piero Calamandrei (titolo della tesi Sentenza e sentimento) prese il diploma di pianoforte al conservatorio Cherubini. Dal 1953 a Milano, dove il padre era stato nominato presidente di Corte d’appello, nel 1955 vinse il concorso per entrare in magistratura. Dal 1957 sposato con Maria Laura Pini Prato, insegnante di inglese conosciuta all’università che gli diede i figli Andrea e Federica, passò vent’anni al Civile, prima in Pretura, poi in Tribunale occupandosi di fallimenti e diritto industriale, infine in Corte d’Appello. Passato al Penale, dal ’75 all’82 fu in corte d’Assise, nel 1983 arrivò alla Procura della Repubblica, nel 1992, l’anno dell’inizio dell’indagine Mani pulite, ne divenne il capo. Quando, nell’aprile del 2002, Borrelli andò in pensione, a Palazzo Chigi c’era nuovamente Silvio Berlusconi. Il 3 gennaio di quell’anno, aprendo il suo ultimo anno giudiziario, l’ex procuratore capo di Milano aveva lanciato lo slogan «Resistere, resistere, resistere». Nel maggio 2006, in piena Calciopoli, Guido Rossi lo chiamò a guidare l’ufficio indagini della Federcalcio: «Rifiutare mi sembrava una vigliaccata». Nel marzo 2007 divenne presidente del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano (la più prestigiosa università musicale d’Italia): «È una nuova sfida, l’ennesima che affronto con gioia e un certo tremore». In contemporanea annunciò l’addio alla Figc: «Per ora mantengo il posto in Federcalcio, non c’è incompatibilità. Se sono uscito dall’ombra lo devo solo a Guido Rossi. Dopo la nomina del calcio mi riconoscono tutti, i taxisti e anche i più giovani. Ma a luglio, con il nuovo statuto da me suggerito, l’ufficio indagini confluirà nella Procura federale. Non voglio fare il Procuratore federale: c’è Stefano Palazzi, è molto più giovane di me». Nell’aprile 2010 il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, cui spetta la nomina della carica di presidente degli istituti musicali, gli negò il secondo mandato triennale alla presidenza del Verdi: «Ragioni evidentemente politiche. Appartengo a una corporazione che è in odio alle alte sfere della politica. Evidentemente non devo essere gradito agli esponenti del governo. Ma la mia amarezza è soprattutto quella di aver saputo della mia mancata conferma in modo indiretto, senza comunicazione ufficiale. Sono sempre stato abbastanza umile da accettare le critiche, ma ciò che mi offende è il metodo. Ho lavorato con passione in questi anni». (Giorgio Dell’Arti Catalogo dei viventi 2015.
ALTRA DINASTIA: LA FAMIGLIA BOCCASSINI.
Boccassini, una delle famiglie di magistrati più corrotte della storia d’Italia, scrive “Imola Oggi”. Il paragone fra certi p.m. di Magistratura Democratica e gli estremisti della Brigate Rosse è sicuramente improprio ma il fanatismo e la propensione agli affari degli uni e degli altri è sicuramente simile. Ilda Boccassini appartiene, secondo la stampa, a una delle famiglie di magistrati più corrotte della storia d’Italia. Suo zio Magistrato Nicola Boccassini fu arrestato e condannato per associazione a delinquere, concussione corruzione, favoreggiamento e abuso di ufficio perchè spillò con altri sodali e con ricatti vari 186 milioni di vecchie lire a un imprenditore. (vendeva processi per un poker repubblica). Anche suo padre Magistrato e suo cugino acquisito Attilio Roscia furono inquisiti. Suo marito Alberto Nobili fu denunciato alla procura di Brescia da Pierluigi Vigna, Magistrato integerrimo e universalmente stimato per presunte collusioni con gli affiliati di Cosa Nostra che gestivano l’Autoparco Milanese di via Salamone a Milano. (attacco ai giudici di Milano Repubblica) (Brescia torna inchiesta autoparco). Non se ne fece niente perchè la denuncia finì nelle mani del giudice Fabio Salomone, fratello di Filippo Salomone, imprenditore siciliano condannato a sei anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. L’Autoparco milanese di via Salomone era un crocevia di armi e di droga ha funzionato per 9 anni di seguito (dal 1984 al 1993), fu smantellato dai magistrati fiorentini e non da quelli milanesi e muoveva 700 milioni di vecchie lire al giorno. A Milano tutti sapevano che cosa si faceva lì dentro. Visto ciò che è emerso a carico del marito per l’Autoparco e visto ciò che sta emergendo a carico del giudice Francesco Di Maggio (anche lui della Procura di Milano) relativamente alla strage di Capaci anche il suo trasferimento a Caltanisetta nel 1992 appare sospetto. In realtà a quel tempo sei magistrati massoni della Procura di Milano appoggiavano il progetto di Riina e Gardini, i quali erano soci, di acquisire Eni e poi di fondare Enimont e quindi da un lato favorivano l’acquisizione di denaro da parte di Cosa Nostra tutelando l’Autoparco (700.000.000 di vecchie lire al giorno di movimento di denaro) tutelando i traffici con il c.d. metodo Ros (502.000.000 di euro di ammanchi) e simulando con altre inchieste minori (Duomo Connenction, Epaminonda) un contrasto alla mafia che in realtà non c’era, dall’altro con Di Maggio intervennero pesantemente in Sicilia già nel 1989 per contrastare un attacco della FBI americana contro i corleonesi attraverso il pentito Totuccio Contorno e facendo ricadere la responsabilità delle lettere del corvo su Falcone, poi attentato simulatamente dalla stessa Polizia. Poi nel 1992 sempre con uomini di Di Maggio contribuirono alla strage di Capaci ove morì Giovanni Falcone il quale si opponeva acchè il progetto Enimont, a quel tempo gestito da Andreotti e da Craxi, tornasse nelle mani di Gardini e di Riina. Ora è noto ormai che anche le Brigate Rosse eseguirono il sequestro Moro per affarismo e rifiutarono dieci miliardi di vecchie lire da parte del Papa Paolo VI per liberare Aldo Moro perchè qualcun altro le remunerò di più. Napolitano ha ben fatto appello più volte a questi Magistrati di moderarsi. Palamara non c’entra niente con questo discorso perchè è un buon Magistrato ed è affiliato a Unicost, una corrente di magistrati seri e responsabili e non a M.D. Il tutto sembrerebbe discutibile se il parente che si è messo in condizione di essere criticato fosse solo uno. Ma qui i parenti chiacchierati sono tre. Fra l’altro osservo che Alberto Nobili, dopo che si è separato dalla Boccassini, è tornato a essere un magistrato stimato, per cui viene il dubbio che nei casini ce lo abbia messo lei.
CARMINE SCHIAVONE. LA VERA MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi . L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
E quindi in tema di giustizia ed informazione. Lettera aperta a “Quarto Grado”.
Egregio Direttore di “Quarto Grado”, dr Gianluigi Nuzzi, ed illustre Comitato di Redazione e stimati autori.
Sono il Dr Antonio Giangrande, scrittore e cultore di sociologia storica. In tema di Giustizia per conoscere gli effetti della sua disfunzione ho scritto dei saggi pubblicati su Amazon.it: “Giustiziopoli. Ingiustizia contro i singoli”; “Malagiustiziopoli”. Malagiustizia contro la Comunità”. Per conoscere bene coloro che la disfunzione la provocano ho scritto “Impunitopoli. Magistrati ed Avvocati, quello che non si osa dire”. Per giunta per conoscere come questi rivestono la loro funzione ho scritto “Concorsopoli. Magistrati ed avvocati col trucco”. Naturalmente per ogni città ho rendicontato le conseguenze di tutti gli errori giudiziari. Errore giudiziario non è quello conclamato, ritenuto che si considera scleroticamente solo quello provocato da dolo o colpa grave. E questo con l’addebito di infrazione da parte dell’Europa. Né può essere considerato errore quello scaturito solo da ingiusta detenzione. E’ errore giudiziario ogni qualvolta vi è una novazione di giudizio in sede di reclamo, a prescindere se vi è stata detenzione o meno, o conclamato l’errore da parte dei colleghi magistrati. Quindi vi è errore quasi sempre.
Inoltre, cari emeriti signori, sono di Avetrana. In tal senso ho scritto un libro: “Tutto su Taranto, quello che non si osa dire” giusto per far sapere come si lavora presso gli uffici giudiziari locali. Taranto definito il Foro dell’Ingiustizia. Cosa più importante, però, è che ho scritto: “Sarah Scazzi. Il delitto di Avetrana. Il resoconto di un avetranese. Quello che non si osa dire”. Tutti hanno scribacchiato qualcosa su Sarah, magari in palese conflitto d’interesse, o come megafono dei magistrati tarantini, ma solo io conosco i protagonisti, il territorio e tutto quello che è successo sin dal primo giorno. Molto prima di coloro che come orde di barbari sono scesi in paese pensando di trovare in loco gente con l’anello al naso e così li hanno da sempre dipinti. Certo che magistrati e giornalisti cercano di tacitarmi in tutti i modi, specialmente a Taranto, dove certa stampa e certa tv è lo zerbino della magistratura. Come in tutta Italia, d’altronde. E per questo non sono conosciuto alla grande massa, ma sul web sono io a spopolare.
Detto questo, dal mio punto di vista di luminare dell’argomento Giustizia, generale e particolare, degli appunti ve li voglio sollevare sia dal punto giuridico (della legge) sia da punto della Prassi. Questo vale per voi, ma vale anche per tutti quei programmi salottieri che di giustizia ne sparlano e non ne parlano, influenzando i telespettatori o da questi sono condizionati per colpa degli ascolti. La domanda quindi è: manettari e forcaioli si è o si diventa guardando certi programmi approssimativi? Perché nessuno sdegno noto nella gente quando si parla di gente rinchiusa per anni in canili umani da innocente. E se capitasse agli ignavi?
Certo, direttore Nuzzi, lei si vanta degli ascolti alti. Non è la quantità che fa un buon programma, ma la qualità degli utenti. Fare un programma di buon livello professionale, si pagherà sullo share, ma si guadagna in spessore culturale e di levatura giuridica. Al contrario è come se si parlasse di calcio con i tifosi al bar: tutti allenatori.
Il suo programma, come tutti del resto, lo trovo: sbilanciatissimo sull’accusa, approssimativo, superficiale, giustizialista ed ora anche confessionale. Idolatria di Geova da parte di Concetta e pubblicità gratuita per i suoi avvocati. Visibilità garantita anche come avvocati di Parolisi. Nulla di nuovo, insomma, rispetto alla conduzione di Salvo Sottile.
Nella puntata del 27 settembre 2013, in studio non è stato detto nulla di nuovo, né di utile, se non quello di rimarcare la colpevolezza delle donne di Michele Misseri. La confessione di Michele: sottigliezze. Fino al punto che Carmelo Abbate si è spinto a dire: «chi delle due donne mente?». Dando per scontato la loro colpevolezza. Dal punto di vista scandalistico e gossipparo, va bene, ma solo dalla bocca di un autentico esperto è uscita una cosa sensata, senza essere per forza un garantista.
Alessandro Meluzzi: «non si conosce ora, luogo, dinamica, arma, movente ed autori dell’omicidio!!!».
Ergo: da dove nasce la certezza di colpevolezza, anche se avallata da una sentenza, il cui giudizio era già stato prematuramente espresso dai giudici nel corso del dibattimento, sicuri di una mancata applicazione della loro ricusazione e della rimessione del processo?
E quello del dubbio scriminante, ma sottaciuto, vale per tutti i casi trattati in tv, appiattiti invece sull’idolatria dei magistrati. Anzi di più, anche di Geova.
Una cosa è certa, però. Non sarà la coerenza di questi nostri politicanti a cambiare le sorti delle nostre famiglie.
2 OTTOBRE 2013. LE GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
«Perché ho scelto di porre un termine al governo Letta». Silvio Berlusconi, lettera a Tempi del 1 ottobre 2013. «Gentile direttore, non mi sfuggono, e non mi sono mai sfuggiti, i problemi che affrontano l’Italia che amo ed i miei concittadini. La situazione internazionale continua a essere incerta. I dati economici nazionali non sono indirizzati alla ripresa. E, nonostante le puntuali resistenze del centrodestra, un esorbitante carico fiscale continua a deprimere la nostra industria, i commerci, i bilanci delle famiglie». Inizia così la lunga lettera che Silvio Berlusconi ha scritto a Tempi. Berlusconi si chiede quanti danni abbia provocato all’Italia «un ventennio di assalto alla politica, alla società, all’economia, da parte dei cosiddetti “magistrati democratici” e dei loro alleati nel mondo dell’editoria, dei salotti, delle lobby? Quanto male ha fatto agli italiani, tra i quali mi onoro di essere uno dei tanti, una giustizia al servizio di certi obiettivi politici?». Berlusconi cita il caso dell’Ilva di Taranto, la cui chiusura è avvenuta «grazie anche a quella che, grottescamente, hanno ancora oggi il coraggio di chiamare “supplenza dei giudici alla politica”», e torna a chiedere: «Di quanti casi Ilva è lastricata la strada che ci ha condotto nell’inferno di una Costituzione manomessa e sostituita con le carte di un potere giudiziario che ha preso il posto di parlamento e governo? (…) Hanno “rovesciato come un calzino l’Italia”, come da programma esplicitamente rivendicato da uno dei pm del pool di Mani Pulite dei primi anni Novanta, ed ecco il bel risultato: né pulizia né giustizia. Ma il deserto». «Non è il caso Berlusconi che conta – prosegue -. Conta tutto ciò che, attraverso il caso Silvio Berlusconi, è rivelatore dell’intera vicenda italiana dal 1993 ad oggi. Il caso cioè di una persecuzione giudiziaria violenta e sistematica di chiunque non si piegasse agli interessi e al potere di quella parte che noi genericamente enunciamo come “sinistra”. Ma che in realtà è rappresentata da quei poteri e forze radicate nello Stato, nelle amministrazioni pubbliche, nei giornali, che sono responsabili della rapina sistemica e del debito pubblico imposti agli italiani. Berlusconi non è uno di quegli imprenditori fasulli che ha chiuso fabbriche o ha fatto a spezzatini di aziende per darsi alla speculazione finanziaria. Berlusconi non è uno di quelli che hanno spolpato Telecom o hanno fatto impresa con gli aiuti di Stato. (…) Berlusconi è uno dei tanti grandi e piccoli imprenditori che al loro paese hanno dato lavoro e ricchezza. Per questo, l’esempio e l’eccellenza di questa Italia che lavora dovevano essere invidiati, perseguitati e annientati (questo era l’obbiettivo di sentenze come quella che ci ha estorto 500 milioni di euro e, pensavano loro, ci avrebbe ridotto sul lastrico) dalle forze della conservazione». Il leader del centrodestra ripercorre poi le vicende politiche degli ultimi anni, ricordando il suo sostegno al governo Monti e, oggi, al governo Letta. Scrive Berlusconi: «Abbiamo contribuito, contro gli interessi elettorali del centrodestra, a sostenere governi guidati da personalità estranee – talvolta ostili – al nostro schieramento. Abbiamo dato così il nostro contributo perché la nazione tornasse a respirare, si riuscisse a riformare lo Stato, a costruire le basi per una nostra più salda sovranità, a rilanciare l’economia. Con il governo Monti le condizioni stringenti della politica ci hanno fatto accettare provvedimenti fiscali e sul lavoro sbagliati. Con il governo Letta abbiamo ottenuto più chiarezza sulle politiche fiscali, conquistando provvedimenti di allentamento delle tasse e l’impostazione di una riforma dello Stato nel senso della modernizzazione e della libertà». «Alla fine, però, i settori politicizzati della magistratura sono pervenuti a un’incredibile, ingiusta perché infondata, condanna di ultima istanza nei miei confronti. Ed altre manovre persecutrici procedono in ogni parte d’Italia». «Enrico Letta e Giorgio Napolitano – scrive l’ex presidente del Consiglio - avrebbero dovuto rendersi conto che, non ponendo la questione della tutela dei diritti politici del leader del centrodestra nazionale, distruggevano un elemento essenziale della loro credibilità e minavano le basi della democrazia parlamentare. Come può essere affidabile chi non riesce a garantire l’agibilità politica neanche al proprio fondamentale partner di governo e lascia che si proceda al suo assassinio politico per via giudiziaria?». «Il Pd (compreso Matteo Renzi) ha tenuto un atteggiamento irresponsabile soffiando sul fuoco senza dare alcuna prospettiva politica. Resistere per me è stato un imperativo morale che nasce dalla consapevolezza che senza il mio argine – che come è evidente mi ha portato ben più sofferenze che ricompense – si imporrebbe un regime di oppressione insieme giustizialista e fiscale. Per tutto questo, pur comprendendo tutti i rischi che mi assumo, ho scelto di porre un termine al governo Letta». Infine la conclusione: «Ho scelto la via del ritorno al giudizio del popolo non per i “miei guai giudiziari” ma perché si è nettamente evidenziata la realtà di un governo radicalmente ostile al suo stesso compagno di cosiddette “larghe intese”. Un governo che non vuole una forza organizzata di centrodestra in grado di riequilibrarne la sua linea ondivaga e subalterna ai soliti poteri interni e internazionali». Berlusconi dice di voler recuperare «quanto di positivo è stato fatto ed elaborato (per esempio in tema di riforme istituzionali) da questo governo che, ripeto, io per primo ho voluto per il bene dell’Italia e che io per primo non avrei abbandonato se soltanto ci fosse stato modo di proseguire su una linea di fattiva, di giusta, di leale collaborazione». Ma spiega anche di non averlo più voluto sostenere «quando Letta ha usato l’aumento dell’Iva come arma di ricatto nei confronti del mio schieramento ho capito che non c’era più margine di trattativa». «Non solo – aggiunge -. Quando capisci che l’Italia è un Paese dove la libera iniziativa e la libera impresa del cittadino diventano oggetto di aggressione da ogni parte, dal fisco ai magistrati; quando addirittura grandi imprenditori vengono ideologicamente e pubblicamente linciati per l’espressione di un libero pensiero, quando persone che dovrebbero incarnare con neutralità e prudenza il ruolo di rappresentanti delle istituzioni pretendono di insegnarci come si debba essere uomini e come si debba essere donne, come si debbano educare i figli e quale tipo di famiglia devono avere gli italiani, insomma, quando lo Stato si fa padrone illiberale e arrogante mentre il governo tace e non ha né la forza né la volontà di difendere la libertà e le tasche dei suoi cittadini, allora è bene che la parola ritorni al nostro unico padrone: il popolo italiano».
Sceneggiata in fondo a destra, scrive Stefania Carini su “Europa Quotidiano”. Nessuna sceneggiatura al mondo può batterci, perché noi teniamo la sceneggiata. Non ci scalfisce manco Sorkin con West Wing e The Newsroom (uno degli attori di quest’ultima serie era pure presente al Roma Fiction Fest per annunciarne la messa in onda su Raitre). Tze, nessun giornalista o politico sul piccolo schermo può batterci in queste ore. Bastava vedere oggi le prime pagine di due giornali dall’opposto populismo: per Il Giornale è tradimento, per Il Fatto è inciucio. Ah, la crisi secondo il proprio target di spettatori! E ‘O Malamente che dice? Ma come in tutti i melodrammi, i gesti sono più importanti. Vedere per capire. In senato prima arriva Alfano e si siede accanto a Letta, vorrà dire qualcosa? Poi arriva Berlusconi, e allora colpa di scena! Marcia indietro? Sardoni (sempre la più brava) racconta di un Bondi che si scrolla dalla pacca sulla spalla di Lupi. Non toccarmi, impuro! Biancofiore e Giovanardi litigano a Agorà, ma ieri sera già aleggiava una forza di schizofrenia sui nostri schermi. Sallusti e Cicchitto erano seduti a Ballarò dalla stessa parte, secondo solita partitura visiva del talk. Solo che invece di scannarsi con i dirimpettai, con quelli della sinistra, si scannavano fra di loro. Una grande sequenza comico-drammatica, riproposta pure da Mentana durante la sua consueta lunga maratona in mattinata.
A Matrix pure Feltri faceva il grande pezzo d’attore, andandosene perché: «Non ne posso più di Berlusconi, di Letta e di queste discussioni interminabili, come non ne possono più gli italiani». Oh, sì, gli italiani non ne possono più, ma davanti a un tale spettacolo come resistere? Siamo lì, al Colosseo pieno di leoni, e noi con i popcorn. Alla fine ‘O Malamente vota il contrario di quanto detto in mattinata, e il gesto plateale si scioglie in un risata farsesca per non piangere. Tze, Sorkin, beccati questo. Noi teniamo Losito. Solo che nella realtà non abbiamo nessuno bello come Garko.
COSA HA RIPORTATO LA STAMPA.
IL CORRIERE DELLA SERA - In apertura: “Resa di Berlusconi, ora il governo è più forte”.
LA REPUBBLICA - In apertura: “La sconfitta di Berlusconi”.
LA STAMPA - In apertura: “Fiducia a Letta e il Pdl si spacca”.
IL GIORNALE - In apertura: “Caccia ai berlusconiani”.
IL SOLE 24 ORE - In apertura: “Resa di Berlusconi, fiducia larga a Letta”.
IL TEMPO - In apertura: “Berlusconi cede ad Alfano e vota la fiducia al governo. Pdl sempre più nel caos”.
IL FATTO QUOTIDIANO – In apertura: “La buffonata”.
Il Financial Times titola a caratteri cubitali sulla "vittoria" del premier Letta al senato e sottolinea che l'Italia si è allontanata dal baratro dopo "l'inversione a U" di Berlusconi.
Sulla homepage di BBC News campeggia la foto di Berlusconi in lacrime con sotto il titolo "Vittoria di Letta dopo l'inversione a U di Berlusconi".
Apertura italiana anche per il quotidiano The Guardian, che evidenzia un piccolo giallo e chiede la partecipazione dei lettori. "Cosa ha detto Enrico Letta subito dopo l'annuncio di Berlusconi di votare per la fiducia al Governo"?. Passando alle testate spagnole, il progressista El Paìs pubblica in homepage una photogallery dal titolo "Le facce di Berlusconi" (tutte particolarmente adombrate) e titola il pezzo portante sulla crisi italiana dicendo che l'ex premier, "avendo avuto certezza di non poter vincere, ha deciso di non perdere".
Il conservatore El Mundo, invece, dedica l'apertura oltre che alla cronaca della giornata al Senato alla figura di Angelino Alfano, con un editoriale intitolato: "Il delfino che ha detto basta", nel quale si evidenzia la spaccatura profonda che ha minato l'integrità finora incrollabile del partito di Silvio Berlusconi.
E poi ci sono i quotidiani tedeschi. Lo Spiegel International titola a tutta pagina "Fallito il colpo di Stato in Parlamento. L'imbarazzo di Berlusconi". Lo Spiegel in lingua madre, invece, pone l'accento sulla "ribellione contro il Cavaliere, che sancisce la fine di un'epoca".
Foto con cravatta in bocca per Enrico Letta sul Frankfurter Allgemeine. Il quotidiano, da sempre molto critico nei confronti di Berlusconi, titola in apertura: "Enrico Letta vince il voto di fiducia" e poi si compiace che sia "stata scongiurata in Italia una nuova elezione" dopo una svolta a 180 gradi di Berlusconi.
Il New York Times dedica uno spazio in prima pagina a "Berlusconi che fa marcia indietro sulla minaccia di far cadere il governo".
Tra i giornali russi, il primo ad aprire sull'Italia è il moderato Kommersant, che dedica al voto di fiducia un articolo di cronaca con foto triste di Berlusconi, sottolineando che "L'Italia ha evitato nuove elezioni". Stessa cosa vale anche per il sito in lingua inglese di Al Jazeera, l'emittente del Qatar, che apre la sua edizione online con una foto di Enrico Letta che sorride sollevato "dopo la vittoria".
Telegrafico Le Monde, che titola: "Il governo Letta ottiene la fiducia. Dopo la defezione di 25 senatori del PdL, Silvio Berlusconi ha deciso di votare la fiducia all'esecutivo".
"Berlusconi cambia casacca" è invece il titolo scelto dal quotidiano di sinistra Liberation.
Infine Le Figaro, quotidiano sarkozysta, titola: "Il voltafaccia di Silvio Berlusconi risparmia all'Italia una crisi".
FARSA ITALIA. UNA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA.
Tra le 12, quando Sandro Bondi scandisce in Aula “fallirete”, e le 13,30, quando Silvio Berlusconi si arrende e, con un sorriso tirato, annuncia il sì al governo, è racchiuso tutto il senso di una giornata che, senza enfasi, il premier Enrico Letta definirà storica. Per la prima volta, infatti, il Cavaliere è costretto a ripiegare e a cedere sovranità alla decisione imposta da Angelino Alfano, il delfino considerato come un figlio che ha ucciso il padre. Che per il Pdl sia stata una giornata convulsa è ormai chiaro a tutti. E lo dimostra anche questa dichiarazione di Renato Brunetta, il quale, uscendo dalla riunione dei parlamentari del partito a Palazzo Madama, annuncia convinto che il Pdl toglierà la fiducia al Governo Letta. Poco dopo, in aula, la retromarcia di Berlusconi. Mercoledì 2 ottobre intorno alle 13.32 Silvio Berlusconi ha preso la parola al Senato e ha detto a sorpresa che il PdL avrebbe confermato la fiducia al governo Letta. Poco prima, il capogruppo del PdL alla Camera Renato Brunetta aveva detto perentoriamente ad alcuni giornalisti che «dopo lunga e approfondita discussione» nel gruppo dei parlamentari PdL, «l’opzione di votare la sfiducia al governo è stata assunta all’u-na-ni-mi-tà dei presenti».
La cronaca della giornata comincia, infatti, molto presto.
2,30 del mattino, Angelino Alfano ha lasciato palazzo Grazioli dopo un lunghissimo faccia a faccia con il Cavaliere, concluso con una rottura dolorosa, ed una sfida, quella lanciata dal leader del centrodestra: "Provate a votare la fiducia a Letta e vedremo in quanti vi seguiranno".
9.30, “L’Italia corre un rischio fatale, cogliere o non cogliere l’attimo, con un sì o un no, dipende da noi”, ha esordito Letta, aggiungendo che "gli italiani ci urlano che non ne possono più di ‘sangue e arena’, di politici che si scannano e poi non cambia niente”, ma al tempo stesso ribadendo che “i piani della vicenda giudiziaria che investe Silvio Berlusconi e del governo, non potevano, né possono essere sovrapposti” e che ”il governo, questo governo in particolare, può continuare a vivere solo se è convincente. Per questo serve un nuovo patto focalizzato sui problemi delle famiglie e dei cittadini”.
Quando il presidente del Consiglio Letta ha cominciato a parlare in Senato, Giovanardi, Roberto Formigoni e Paolo Naccarato, i più decisi fra gli scissionisti, facevano circolare una lista di 23 nomi, aggiungendo però che al momento della conta il risultato finale sarebbe stato ancoro più corposo. "Siamo già in 25 - dice Roberto Formigoni parlando con i cronisti in Transatlantico della scissione dal gruppo Pdl - E' possibile che altri si aggiungano. Nel pomeriggio daremo vita a un gruppo autonomo chiamato 'I Popolari'. Restiamo alternativi al centrosinistra, collocati nel centrodestra". Questi i cognomi dei primi firmatari: Naccarato, Bianconi, Compagna, Bilardi, D'Ascola, Aielo, Augello, Caridi, Chiavaroli, Colucci, Formigoni, Gentile, Giovanardi, Gualdani, Mancuso, Marinello, Pagano, Sacconi, Scoma, Torrisi, Viceconte, L.Rossi, Quagliariello. Con questi numeri, come già aveva pensato anche il ministro Gaetano Quagliariello, il premier Letta aveva già raggiunto il quorum teorico al Senato. Infatti il presidente del Consiglio parte da una base di 137 voti (escluso quello del presidente del Senato che per tradizione non vota), ai quali si aggiungono i 5 dei senatori a vita ed i 4 annunciati dai fuoriusciti M5s. In questo modo il governo supera abbondantemente la fatidica ‘quota 161′ necessaria a Palazzo Madama assestandosi intorno a quota 170.
Berlusconi, che a seduta ancora in corso ha riunito i suoi per decidere il da farsi, ha detto che ''sarà il gruppo in maniera compatta a decidere cosa fare. Prendiamo una decisione comune per non deludere il nostro popolo''. Alla riunione non hanno partecipato i senatori considerati i ormai con le valigie in mano e una prima votazione si è chiusa con una pattuglia di 27 falchi schieratissimi sulla sfiducia al governo, mentre 23 erano per lasciare l'aula al momento del voto (al Senato l'astensione è equiparata al voto contrario) mentre solo due si sono comunque espressi per il voto di fiducia. Nonostante i no assoluti a Letta fossero quindi una netta minoranza rispetto al plenum del gruppo Pdl, Berlusconi ha tagliato corto "voteremo contro la fiducia", come il capo ufficio stampa del partito si è premurato di far sapere a tutti i giornalisti presenti nella sala antistante l'aula. Il Cavaliere dichiara: “voteremo no e resteremo in aula Se uscissimo fuori sarebbe un gesto ambiguo e gli elettori non lo capirebbero''. In aula al Senato è Sandro Bondi a schierarsi contro Enrico Letta con queste parole: “avete spaccato il Pdl ma fallirete.
11.30. Contrariamente a quanto si vociferava, non è Silvio Berlusconi ad intervenire in aula al Senato ma Sandro Bondi. Bondi ricorda a Letta di essere a Palazzo Chigi grazie anche al PdL; rimarca il passaggio di Letta circa il concetto di pacificazione e sostiene che per Letta, la pacificazione sta nell’eliminare politicamente Silvio Berlusconi. Bondi ricorda a Letta che il problema giudiziario di Berlusconi nasce anche da Tangentopoli quando la tempesta giudiziaria travolse anche la Democrazia Cristiana, partito d’origine del Premier. Intanto, il PdL ha deciso: voterà la sfiducia all’unanimità. Questo è il quanto alle 12.00.
Poco dopo le 12.10 Enrico Letta riprende la parola nell’aula del Senato. Parla di giornata storica ma dai risvolti drammatici e ricorda che il travaglio di molti senatori va rispettato. Esprime gratitudine e solidarietà alla Senatrice Paola De Pin, per l’intervento in aula e per aver rischiato un attacco fisico da parte dei suoi ormai ex colleghi del M5S e sottolinea, rivolgendosi ai Senatori grillini che il rispetto della persona è alla base della democrazia. Durante l’intervento di Letta, vibranti proteste contro Letta da parte del Senatore Scilipoti che viene zittito dal Presidente Grasso. Letta aggiunge che i numeri che sostengono il governo sono cambiati ma comunque è fiducioso circa il raggiungimento degli obiettivi di governo verso i quali si pone con le parole “chiari” e “netti”. Il presidente del Consiglio ringrazia chi ha votato prima per l’attuale maggioranza come chi, oggi ha deciso diversamente. Letta rimarca il ruolo importante dell’Italia nel contesto europeo per il quale auspica centralità ed il coinvolgimento del Parlamento per il semestre UE. Si conclude qui, la replica del presidente del Consiglio e si aprono le dichiarazioni di voto. Questo è il quanto alle 12,30.
13.32. Berlusconi, e non il capogruppo Renato Schifani, interviene per la dichiarazione di voto del Pdl. E in meno di tre minuti, con volto terreo, e senza fare nessun riferimento alle convulsioni dei giorni precedenti, ha rinnovato la fiducia a Letta "non senza travaglio". Il suo intervento al Senato è arrivato alle 13.32. Sottolinea che ad aprile ritenne di mettere insieme un governo di centrosinistra col centrodestra per il bene del Paese. Accettando tutte le volontà del presidente incaricato Enrico Letta, accettando di avere solo 5 ministri. “Lo abbiamo fatto con la speranza che potesse cambiare il clima del nostro Paese - ha sostenuto - andando verso una pacificazione. Una speranza che non abbiamo deposto. Abbiamo ascoltato le parole del premier sugli impegni del suo Governo e sulla giustizia. Abbiamo deciso di esprimere un voto di fiducia a questo governo”. Pone fine al proprio intervento, torna a sedersi e scoppia a piangere.
La fiducia al Governo Letta è passata con 235 voti a favore e 70 voti contrari.
Alle 16.00 il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha aperto il suo intervento alla Camera. Sostanzialmente è un rimarcare quanto già espresso stamattina in Senato. Intanto, nelle ore precedenti, si delinea la formazione del nuovo gruppo politico costituito da transfughi del PdL e capitanati da Fabrizio Cicchitto; sono ufficialmente 12 ma si conta di arrivare complessivamente a 26 Parlamentari. A margine della conferenza dei capigruppo alla Camera, la Presidenza ha dato il disco verde per la costituzione del nuovo gruppo che interverrà sin da oggi pomeriggio nel dibattito parlamentare che seguirà l’intervento di Letta.
Poco prima delle 21,30, la Camera ha espresso il proprio voto nei confronti del governo Letta. 435 favorevoli e 162 contrari. Termina qui, questa lunga giornata politica dalla quale il Paese esce con un governo confermato ma sostenuto da una nuova maggioranza.
Vittorio Feltri fa trapelare il suo malessere su Twitter: "Chi incendia la propria casa e poi spegne le fiamme è un incendiario, un pompiere o un pirla?".
ITALIA DA VERGOGNA.
Che Italia di merda. Anzi no, perché non si può dire. Un’Italia da vergogna, però sì. Se volete possiamo continuare ad enucleare le virtù dell’italica vergogna.
È proprio una storiaccia, scrive Nicola Porro. Beccare l’esattore che per quattro danari fa lo sconto sulle tasse da pagare, sembra un roba dell’altro secolo. Secondo la Procura di Roma è quanto facevano alcuni funzionari (ed ex colleghi) di Equitalia. Vedremo presto, si spera, se e quanto fosse diffuso il sistema. Una tangente per alleggerire il proprio carico fiscale fa ribollire il sangue. Equitalia è stata negli ultimi anni il braccio inflessibile della legge (assurda) tributaria. Inflessibile nei suoi atteggiamenti oltre che nelle sue regole. La prima reazione è di sdegno. Come per uno stupro, non si riesce a ragionare, a essere lucidi. Ad aspettare un processo. In galera i presunti delinquenti. Gli aguzzini che hanno rovinato la vita a migliaia di contribuenti in sofferenza. Nei confronti dei quali (i contribuenti, si intende) non hanno mai avuto pietà. Bene. Ora calmiamoci un po’. E ragioniamo. Il dito è l’indagine di ieri. La luna è il caso di oggi e di domani. Ci stiamo forse prendendo in giro? Qualcuno pensa veramente che il catasto sia un luogo di verginelle? Qualcuno ritiene sul serio che le amministrazioni comunali che forniscono licenze siano immacolate? Qualcuno si immagina davvero che le Asl e i relativi controlli che fanno alle imprese siano tutti puliti? La lista potrebbe diventare infinita. Ed è una lista che sarebbe comunque compilata per difetto. Non c’è giorno che la cronaca non ci regali uno scandaletto locale su funzionari o dipendenti pubblici che non svolgono con onestà il proprio lavoro e che si mettono in tasca un stipendio alternativo a quello fornito dalla mamma Stato. Il nostro non è un punto di vista rassegnato. E tanto meno un giudizio complessivo sull’amministrazione pubblica. Il nostro è un puro ragionamento economico, senza alcun intento moralistico. Questo lo lasciamo a chi legge. La cosa è semplice e ha a che fare con la burocrazia statale. Essa ha un potere immenso, a ogni suo livello. Che le deriva dalla legge e dalla possibilità di farla applicare grazie al monopolio della violenza (legale e giudiziaria) di cui lo Stato dispone. Il caso Equitalia è particolarmente odioso per il momento in cui ci troviamo. Ma la stecca sulle tasse era ben più consistente e diffusa prima della riforma tributaria. Il punto è dunque quello di guardare al principio e non al dettaglio. Troppo Stato e la troppa burocrazia che ne consegue vuol dire una cosa sola: incentivo alla corruzione. La nostra bulimia legislativa, normativa e amministrativa nasce dalla presunzione pubblicistica, per la quale i privati sono più o meno potenzialmente tutti dei mascalzoni e devono dunque essere preventivamente controllati. Ecco le norme, le regole, i controlli, le agenzie, i funzionari, le procedure, le carte. Quanto più sono numerose, quanto maggiore è la possibilità che un passaggio sia economicamente agevolato da una commissione di sveltimento/tangente. Niente moralismi: calcolo delle probabilità. Nell’assurda costruzione pubblicistica che ci ha ormai irrimediabilmente contagiati si è commesso un enorme refuso logico. E cioè: i privati sono dei furfanti e come tali debbono essere regolati. Il mercato è in fallimento e dunque deve essere sostituito dallo Stato. E mai si pensa (ecco il refuso) che altrettanti furfanti e fallimenti ci possono statisticamente essere in coloro che dovrebbero legiferare o controllare. La prima vera, grande rivoluzione di questo Paese è ridurre il peso dello Stato, non solo perché costa troppo, ma perché si presume, sbagliando, che sia migliore e più giusto del privato.
ITALIA BARONALE.
I concorsi truccati di un Paese ancora feudale.
Un sistema consolidato di scambio di favori che ha attraversato tutta la Penisola, da Nord a Sud, coinvolgendo otto atenei: Bari, Sassari, Trento, Milano Bicocca, Lum, Valle d'Aosta, Roma Tre, Europea di Roma. È quanto emerge da un'inchiesta condotta dalla procura di Bari, che ha indagato su possibili manipolazioni di 15 concorsi pubblici per incarichi di docenti ordinari e associati nelle università.
L’inchiesta di Bari coinvolge 38 docenti, tra cui i 5 "saggi" chiamati dal governo, ma svela ciò che tutti sanno: le università sono una lobby, scrive Vittorio Macioce su “Il Giornale”. Non servono i saggi per rispondere a questa domanda. Come si diventa professori universitari? Lo sanno tutti. Non basta fare il concorso. Quello è l'atto finale, la fatica è arrivarci con qualche possibilità di vincerlo. È una corsa con regole antiche, dove la bravura è solo una delle tante componenti in gioco. L'università è un mondo feudale. I baroni non si chiamano così per caso. Ognuno di loro ha vassalli da piazzare. Entri se sei fedele, se sei pure bravo tanto meglio. È la logica della cooptazione. Ti scelgo dall'alto, per affinità, per affidabilità, per simpatia, perché apparteniamo allo stesso partito, alla stessa lobby, allo stesso giro. I baroni si riproducono tagliando fuori i devianti, le schegge impazzite, i cani sciolti. Molti sono convinti che in fondo questo sia un buon modo per selezionare una classe dirigente. Magari hanno ragione, magari no e il prezzo che si paga è la «mummificazione». Fatto sta che sotto il concorso pubblico ufficiale ci sono trattative, accordi, arrivi pilotati, rapporti di forza, «questa volta tocca al mio», «tu vai qui e l'altro lo mandiamo lì». La stragrande maggioranza dei futuri accademici vive e accetta questa logica. È l'università. È sempre stato così. Perché cambiare? L'importante è mandare avanti la finzione dei concorsi. È la consuetudine e pazienza se è «contra legem». I concorsi in genere funzionano così e il bello è che non è un segreto. Poi ogni tanto il meccanismo si inceppa. Qualcuno per fortuna ha il coraggio di denunciare o i baroni la fanno davvero sporca. È quello che è successo con un'inchiesta che parte da Bari e tocca una costellazione di atenei: Trento, Sassari, Bicocca, Lum, Valle d'Aosta, Benevento, Roma Tre e l'Europea. Sotto accusa finiscono 38 docenti, ma la notizia è che tra questi ci sono cinque «saggi». Cinque costituzionalisti cari al Colle. Augusto Barbera, Lorenza Violini, Beniamino Caravita, Giuseppe De Vergottini, Carmela Salazar. Che fanno i saggi? Solo pochi illuminati lo hanno davvero capito. Forse qualcuno ancora se li ricorda. Sono quel gruppo di professori nominati da Enrico Letta su consiglio di Napolitano per immaginare la terza Repubblica. Sulla carta dovevano gettare le basi per cambiare la Costituzione. In principio erano venti, poi per accontentare le larghe intese sono diventati trentacinque, alla fine si sono aggiunti anche sette estensori, con il compito di mettere in italiano corrente i pensieri degli altri. Risultato: quarantadue. Il lavoro lo hanno finito. Quando servirà ancora non si sa. I cinque saggi fino a prova contraria sono innocenti. Non è il caso di metterli alla gogna. Il sistema feudale però esiste. Basta chiederlo in privato a qualsiasi barone. Ed è qui che nasce il problema politico. Questo è un Paese feudale dove chi deve cambiare le regole è un feudatario. Non è solo l'università. L'accademia è solo uno dei simboli più visibili. È la nostra visione del mondo che resta aggrappata a un eterno feudalesimo. Sono feudali le burocrazie che comandano nei ministeri, paladini di ogni controriforma. È feudale il sistema politico. Sono feudali i tecnici che di tanto in tanto si improvvisano salvatori della patria. È feudale il mondo della sanità, della magistratura, del giornalismo. È feudale la cultura degli eurocrati di Bruxelles. È feudale il verbo del Quirinale. È stato sempre così. Solo che il sistema negli anni è diventato ancora più rigido. Lo spazio per gli outsider sta scomparendo. L'ingresso delle consorterie è zeppo di cavalli di frisia e filo spinato. La crisi ha fatto il resto. Se prima era tollerata un quota di non cooptazione dall'alto, ora la fame di posti liberi ha tagliato fuori i non allineati. E sono loro che generano cambiamento. Il finale di questa storia allora è tutto qui. Quando qualcuno sceglie 42 saggi per pilotare il cambiamento non vi fidate. Nella migliore delle ipotesi sta perdendo tempo, nella peggiore il concorso è truccato. Il prossimo candidato vincente è già stato scelto. Si chiama Dc.
È una storia antica quanto i baroni. Ma i nomi e i numeri, stavolta, fanno più rumore. Hanno trafficato in cattedre universitarie, sostengono la Procura e la Finanza di Bari. In almeno sette facoltà di diritto, pilotando concorsi per associati e ordinari. Le indagini, spiega Repubblica, iniziano nel 2008 presso l’università telematica “Giustino Fortunato”, di Benevento, che grazie al rettore Aldo Loiodice divenne una succursale dell’università di Bari: “Tirando il filo che parte dalla “Giustino Fortunato”, l’indagine si concentra infatti sui concorsi di tre discipline — diritto costituzionale, ecclesiastico, pubblico comparato — accertando che i professori ordinari “eletti nell’albo speciale” e dunque commissari in pectore della Commissione unica nazionale sono spesso in realtà legati da un vincolo di “reciproca lealtà” che, di fatto, li rende garanti di vincitori già altrimenti designati dei concorsi che sono chiamati a giudicare. Non ha insomma alcuna importanza chi viene “sorteggiato” nella Commissione”. La prova, per la Finanza, sarebbero le conversazioni dei prof insospettiti, che citano Shakespeare e parlano in latino: “È il caso dell’atto terzo, scena quarta del Macbeth. «Ciao, sono l’ombra di Banco», ammonisce un professore, rivolgendosi ad un collega. Già, Banco: la metafora della cattiva coscienza”. Da una minuscola università telematica al Gotha del mondo accademico italiano, scrive Giovanni Longo su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Una intercettazione dietro l’altra: così la Procura di Bari ha individuato una rete di docenti che potrebbe avere pilotato alcuni concorsi universitari di diritto ecclesiastico, costituzionale e pubblico comparato. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria del comando provinciale di Bari avevano iniziato a indagare sulla «Giustino Fortunato» di Benevento. Gli accertamenti si sono poi estesi: basti pensare che i pm baresi Renato Nitti e Francesca Pirrelli stanno valutando le posizioni di un ex ministro, dell'ex garante per la privacy, di cinque dei 35 saggi nominati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’ipotesi è che qualcuno possa avere influenzato i concorsi. Tra i 38 docenti coinvolti nell'inchiesta che da Bari potrebbe fare tremare il mondo accademico italiano ci sono infatti Augusto Barbera (Università di Bologna), Beniamino Caravita di Toritto (Università La Sapienza Roma), Giuseppe De Vergottini (Università di Bologna), Carmela Salazar (Università di Reggio Calabria) e Lorenza Violini (Università di Milano), nominati da Napolitano per affiancare l’esecutivo sul terreno delle riforme costituzionali. La loro posizione, al pari di quella dell'ex ministro per le Politiche Comunitarie Anna Maria Bernini e di Francesco Maria Pizzetti, ex Garante della Privacy, è al vaglio della Procura di Bari che dovrà verificare se ci sono elementi per esercitare l’azione penale. Gli accertamenti non sono legati agli incarichi istituzionali dei docenti, ma riguardano la loro attività di commissari in concorsi da ricercatore e da professore associato e ordinario, banditi nel secondo semestre del 2008. Quella tessuta pazientemente nel tempo dalle fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Bari, sarebbe stata una vera e propria «rete» che per anni avrebbe agito su tutto il territorio nazionale e che a Bari avrebbe avuto una sponda significativa. Quattro i professori baresi sui quali sono da tempo in corso accertamenti: Aldo Loiodice, all’epoca ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Bari, Gaetano Dammacco, ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico alla facoltà di scienze politiche; Maria Luisa Lo Giacco e Roberta Santoro, ricercatrici di diritto ecclesiastico. Le ipotesi di reato a vario titolo sono associazione per delinquere, corruzione, abuso d'ufficio, falso e truffa. E’ una élite di studiosi di diritto che si conoscono da sempre, che si incontrano a seminari e convegni di studio e che, anche in quel contesto, pianificano i concorsi universitari in tutta Italia. Questa è l’ipotesi. Il quadro emerso dalle centinaia di intercettazioni e dalle decine di perquisizioni eseguite negli anni scorsi in abitazioni, studi professionali, istituzioni universitarie, da Milano a Roma, da Teramo a Bari è da tempo al vaglio della Procura. Nove gli Atenei coinvolti. Almeno una decina i concorsi universitari espletati tra il 2006 e il 2010 finiti sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle. A quanto pare non sarebbe emersa una vera e propria cabina di regia, quanto piuttosto una sorta di «circolo privato» in grado di decidere il destino di concorsi per professori di prima e seconda fascia in tre discipline afferenti al diritto pubblico. Gli investigatori ritengono che questi concorsi nascondano un sistema di favori incrociati. Dopo il sorteggio delle commissioni giudicatrici previsto dalla riforma Gelmini, sarebbe insomma scattato un patto della serie: «tu fai vincere il mio “protetto” nella tua commissione ed io faccio vincere il tuo nella mia». «Accordi», «scambi di favore», «sodalizi e patti di fedeltà» per «manipolare» l’esito di molteplici procedure concorsuali pubbliche, bandite su tutto il territorio nazionale in quel quadriennio. Dall’accusa iniziale, evidenziata in uno dei decreti di perquisizione, in oltre due anni, si sarebbero aggiunti molti altri riscontri trovati dagli investigatori. E pensare che l’inchiesta era partita dagli accertamenti sull'università telematica «Giustino Fortunato », considerata dalla Finanza una sorta di «titolificio» dove si poteva diventare professori in men che non si dica. Dietro quella pagliuzza sarebbe spuntata una trave molto più grande.
Università, i baroni si salvano con la prescrizione. Grazie alla riforma voluta da Berlusconi, che garantisce l'impunità ai colletti bianchi, tre docenti dell'ateneo di Bari sono stati assolti dall'accusa di spartizione delle cattedre. Ma le intercettazioni hanno mostrato l'esistenza di una vera e propria cupola in tutta Italia, scrive Gianluca Di Feo su “L’Espresso”. È stata l'inchiesta più clamorosa sulla spartizione delle cattedre, quella che aveva fatto parlare di una mafia che decideva le nomine a professore negli atenei di tutta Italia. E lo faceva nel settore più delicato: la cardiologia. Ma nove anni dopo la retata che ha scosso le fondamenta del mondo universitario, il tribunale di Bari ha assolto tre imputati chiave dall'accusa di associazione a delinquere. Erano innocenti? Il reato è stato dichiarato prescritto perché è passato troppo tempo: i fatti contestati risalgono al 2002. Una beffa, l'ennesima conferma sull'effetto delle riforme berlusconiane che hanno dilatato la durata dei processi e di fatto garantiscono l'impunità ai colletti bianchi. Il colpo di spugna arriva proprio mentre da Roma a Messina si torna a gridare allo scandalo per i concorsi pilotati negli atenei. L'istruttoria di Bari era andata oltre, radiografando quanto fosse diventato profondo il malcostume nel corpo accademico. Grazie alle intercettazioni finirono sotto indagine decine di professori di tutte le regioni. Nel suo atto di accusa il giudice Giuseppe De Benectis scrisse: «I concorsi universitari erano dunque celebrati, discussi e decisi molto prima di quanto la loro effettuazione facesse pensare, a cura di commissari che sembravano simili a pochi “associati” a una “cosca” di sapore mafioso». Stando agli investigatori, al vertice della rete che smistava cattedre e borse da di studio da Brescia a Palermo c'era Paolo Rizzon, trevigiano diventato primario nel capoluogo pugliese. Le intercettazioni lo hanno descritto come un personaggio da commedia all'italiana. È stato registrato mentre manovrava la composizione di una commissione d'esame che approvasse la nomina del figlio. Poi scopre che l'erede non riesce neppure a mettere insieme la documentazione indicata per l'esame da raccomandato («Ho guardato su Internet, non c'è niente») e si dà da fare per trovargli un testo già scritto. Nei nastri finisce una storia dai risvolti boccacceschi con scambi di amanti e persino l'irruzione della vera mafia. Quando un candidato non si piega alle trame della “Cupola dei baroni” e presenta un ricorso per vedere riconosciuti i suoi diritti, gli fanno arrivare questo avvertimento: «Il professore ha fatto avere il tuo indirizzo a due mafiosi per farti dare una sonora bastonata». Secondo gli inquirenti, non si trattava di millanterie. I rapporti con esponenti di spicco della criminalità locale sono stati documentati, persino nel «commercio di reperti archeologici». A uno di loro – che al telefono definisce «il boss dei boss» - il primario chiede di recuperare l'auto rubata nel cortile della facoltà. Salvo poi scoprire che la vettura non era stata trafugata: si era semplicemente dimenticato dove l'aveva parcheggiata. I magistrati sono convinti che tra la metà degli anni Novanta e il 2002 il professore avesse creato una macchina perfetta per decidere le nomine di cardiologia in tutta Italia: «Una vera organizzazione che vedeva Rizzon tra i capi e organizzatori, con una ripartizione di ruoli, regole interne e sanzioni per la loro eventuale inosservanza che consentiva ai baroni, attraverso il controllo dei diversi organismi associativi, di acquisire in ambito accademico il controllo esecutivo e di predeterminare la composizione delle commissioni giudicatrici e prestabilire quindi anche l´esito della procedura». Oggi la sentenza ha prosciolto per prescrizione dall'associazione per delinquere tre docenti di spicco che avevano scelto il rito abbreviato. Assoluzione nel merito invece per gli altri reati contestati. Nonostante le accuse, i tre prof sono tutti rimasti al loro posto e hanno proseguito le carriere accademiche. Uno si è persino candidato alla carica di magnifico rettore. Una tutela garantista nei loro confronti, ma anche un pessimo esempio per chiunque sogni di fare strada con i propri mezzi nel mondo dell'università senza essere costretto a emigrare. I codici etici negli atenei sono stati introdotti solo dopo gli ultimi scandali, ma in tutta la pubblica amministrazione non si ricordano interventi esemplari delle commissioni disciplinari interne: si aspetta la magistratura e la sentenza definitiva, che non arriva praticamente mai. Anche nel caso del professore Rizzon e di altri tre luminari per i quali è in corso il processo ordinario sembra impossibile che si arrivi a un verdetto. Dopo nove anni siamo ancora al primo grado di giudizio e pure per loro la prescrizione è ormai imminente. Una lezione magistrale per chi crede nel merito.
CASA ITALIA.
Case popolari solo a stranieri? Magari non è proprio così ma basta farsi un giro in certe zone per rendersi conto che la realtà sembra sempre di più penalizzare gli italiani. Il record delle case popolari. Una su due va agli stranieri. Ecco le graduatorie per avere accesso agli alloggi di edilizia residenziale. Più del 50% delle domande vengono da immigrati. E i milanesi aspettano, scrive Chiara Campo su “Il Giornale”. Ci sono Aba Hassan, Abad, Abadir. Ventisette cognomi su ventisette solo nella prima pagina (e almeno 17 idonei). Ma scorrendo il malloppo delle 1.094 pagine che in ordine alfabetico formano le graduatorie per accedere alle case popolari del Comune, almeno il 50% dei partecipanti è di provenienza straniera. Basta leggere i primi dieci fogli per avere l'impressione che, tra gli Abderrahman e gli Abebe, gli italiani siano dei «panda» in estinzione. Le graduatorie pubblicate da Palazzo Marino si riferiscono al bando aperto fino a fine giugno 2013 a chi ha bisogno di appartamenti di edilizia residenziale. Chi entra nell'elenco non ha automaticamente la casa perché la lista d'attesa è lunga, ma tra i criteri per avanzare in classifica ci sono ovviamente reddito (basso) e numero di figli (alto). Le proteste dei leghisti sono note: «Gli immigrati lavorano in nero e fanno tanti figli». Nel 2012 (sono dati del Sicet) su 1190 assegnazioni nel capoluogo lombardo 495, quasi la metà 455, sono state a favore di immigrati. A vedere gli elenchi l'impressione è che la percentuale possa alzarsi ancora, a scapito di tante famiglie milanesi che probabilmente versano tasse da più tempo e nella crisi avrebbero altrettanto bisogno di una casa a basso costo. «Sono per l'integrazione - commenta Silvia Sardone, consigliera Pdl della Zona 2 - ma questa non si può realizzare con una potenziale discriminazione per gli italiani. Probabilmente il sistema di costruzione delle graduatorie ha bisogno di essere reso più equo». Ci tiene a sottolineare: «Non sono razzista, non lo sono mai stata e non lo sarò. Non sono nemmeno perbenista né figlia di un buonismo di sinistra cieco della realtà. Ho molto amici italiani con cognomi stranieri, hanno un lavoro ed un mutuo sulla casa». Ma «nella prime pagine degli elenchi in ordine alfabetico si fa fatica a trovare un cognome italiano e complessivamente sono tantissimi i cognomi stranieri. Indipendentemente da chi ha studiato i criteri di partecipazione e assegnazione e di quando siano stati creati penso che oggi, nel 2013, debbano essere rivisti. Perché sono stanca di pagare delle tasse per servizi che spesso godono gli altri». Anche il capogruppo milanese della Lega torna a chiedere agli enti (Regione per prima) di rivedere i criteri di accesso, alzando ad esempio i 5 anni d residenza minima: «Serve una norma che difenda la nostra gente da chi, si dice, porta ricchezza, ma invece rappresenta un costo».
Laddove l’alloggio non viene assegnato, si occupa (si ruba) con il beneplacito delle Istituzioni.
Quando si parla di case occupate abusivamente o illegalmente, in genere la mente è portata a collegare tale fenomeno a quello dei centri sociali, scrive “Mole 24”. Un tema che di per sé sarebbe da approfondire, perché esistono centri sociali occupati da autonomi, altri da anarchici, altri ancora dai cosiddetti “squatter”, termine che deriva dall’inglese “to squat”, che non è solo un esercizio per rassodare i glutei ma significa anche per l’appunto “occupare abusivamente”. Ma l’occupazione abusiva delle case è in realtà un fenomeno assai nascosto e taciuto, praticamente sommerso. Un’anomalia che pochi conoscono, ancor meno denunciano o rivelano, essenzialmente perché non si sa come risolvere. Le leggi ci sono, o forse no, e se anche esistono pare proprio che le sentenze più attuali siano maggiormente orientate a tutelare gli interessi dell’occupante abusivo piuttosto che quelli del proprietario che reclama i suoi diritti da “esautorato”, sia che si parli del Comune in senso lato sia che si parli di un qualsiasi fruitore di case popolari che si ritrova il suo alloggio occupato da “ospiti” che hanno deciso di prenderne il possesso. Il fenomeno si riduce spesso ad essere una guerra tra poveri. Parliamo, per fare un esempio non così lontano dalla realtà, di un anziano pensionato costretto ad essere ricoverato in ospedale per giorni, settimane o anche mesi: ebbene, questo anziano signore, qualora fosse residente in un alloggio popolare, una volta dimesso potrebbe rischiare di tornare a casa e non riuscire più ad aprire la porta d’ingresso. Serratura cambiata, e l’amara sorpresa che nel frattempo alcuni sconosciuti hanno preso possesso dell’abitazione. Un problema risolvibile? Non così tanto. Anzi, potrebbe essere l’inizio di un lungo iter giudiziario, e se il nuovo o i nuovi occupanti, siano essi studenti cacciati di casa, extracomunitari, disoccupati o famiglie indigenti, dimostrano di essere alle prese con una situazione economica insostenibile o di non aver mai potuto accedere a bandi di assegnazione alle case popolari per vari motivi (ad esempio: non ne sono stati fatti per lunghi periodi), l’anziano in questione potrebbe rischiare di sudare le proverbiali sette camicie. Trattandosi di case popolari, la proprietà non è di nessuno ma del Comune. Questo vuol dire che quando qualcuno non è presente, fra gli altri bisognosi scatta una vera e propria corsa a chi arraffa la casa. Ci sarebbero sì le graduatorie per assegnare gli immobili, ma non mai vengono rispettate. Nel sud, affidarsi alla criminalità organizzata, pagando il dovuto, è il metodo più sicuro per assicurarsi una casa popolare. Chi pensa che questo sia un fenomeno di nicchia, si sbaglia di grosso. Le cifre infatti sono clamorose, anche se difficilmente reperibili. L’indagine più recente e affidabile da questo punto di vista è stata realizzata da Dexia Crediop per Federcasa sul Social Housing 2008. E parla di ben 40.000 case popolari occupate abusivamente in tutto lo Stivale, che se venissero assegnate a chi ne ha diritto permetterebbero a circa 100.000 persone di uscire da uno stato di emergenza.
L’onestà non paga. Ti serve una casa? Sfonda la porta e occupa, scrive Arnaldo Capezzuto su “Il Fatto Quotidiano”. L’appartamento di edilizia residenziale è abitato da una famiglia legittima assegnataria del diritto alla casa ottenuto attraverso un regolare quanto raro bando pubblico con relativo posto in graduatoria? Chi se ne fotte. Li cacci a calci in culo. E se non vogliono andare via, aspetti che escano e ti impossessi dell’abitazione. Con calma poi metti i loro mobili, vestiti e effetti personali in strada. Se malauguratamente qualcuno di loro ha la pazza idea di contattare le forze dell’ordine per sporgere denuncia, niente problema: li fai minacciare da qualche “cumpariello” inducendoli a dichiarare che quelle persone sono amici-parenti. Onde evitare però sospetti, con calma fai presentare un certificato di stato di famiglia dove i “signori occupanti” risultano dei conviventi. Il trucco è palese. Non regge l’escamotage dell’appartamento ceduto volontariamente. Certo. Gli investigatori non dormono. Questo è chiaro. Il solerte poliziotto esegue l’accertamento. I nodi alla fine vengo al pettine. La denuncia scatta immediata. La giustizia è lenta ma implacabile. Lo Stato vince. Gli occupanti abusivi in generale ammettono subito che sono abusivi. Quindi? Nei fatti c’è un organismo dello Stato – i verbali delle forze dell’ordine, le lettere di diffida degli enti pubblici gestori degli appartamenti – che certifica che a decorrere dal giorno x , dal mese x, dall’anno x, l’abitazione che era assegnata a tizio, caio e sempronio ora con la violenza e il sopruso è stato occupata da pinco pallino qualsiasi. La malapolitica trasversalmente e consociativamente per puri e bassi calcoli elettoralistici e non solo mascherati da esigenze sociali, di povertà, di coesione sociale e stronzate varie compulsando e piegando le istituzioni si attivano e varano con il classico blitz leggi, norme, regolamenti che vanno a sanare gli abusivi. Chi ha infranto la legge, chi ha prevaricato sul più debole, chi ha strizzato l’occhio al camorrista e al politiconzolo di turno, chi non mai ha presentato una regolare domanda di assegnazione, chi neppure ha i requisiti minimi per ottenere alla luce del sole un’abitazione si ritrova per "legge" un alloggio di proprietà pubblica a canone agevolatissimo. Accade in Campania e dove sennò in Africa?
Martedì 7 maggio 2013 è stato pubblicato sul Burc la nuova sanatoria per chi ha assaltato le case degli enti pubblici. La Regione Campania guidata dal governatore Stefano Caldoro ha varato all’interno della finanziaria regionale un provvedimento che regolarizza e stabilisce che può richiedere l’alloggio chi lo ha occupato prima del 31 dicembre 2010. Si badi bene che lo scorso anno era stato deciso con una legge simile che poteva ottenere la casa chi l’aveva assaltata entro il 2009. L’interrogativo sorge spontaneo: se puntualmente ogni anno varate una sanatoria per gli abusivi ma perché allora pubblicate i bandi di assegnazione con graduatoria se poi le persone oneste sono destinate ad avere sempre la peggio? Misteri regionali. C’è da precisare però che la nuova sanatoria contiene delle norme “innovative” e “rivoluzionarie” a tutela della legalità (non è una battuta!) per evitare che tra gli assegnatari in sanatoria ci siano pregiudicati e che le occupazione siano guidate dalla camorra. A questo punto c’è davvero da ridere. Le norme per entrare in vigore – però – hanno bisogno del “si” degli enti locali. Ecco il Comune di Napoli – ad esempio – ha detto “no”. Non è pragmatismo ma è guardare negli occhi il mostro. A Napoli non è solo malavita ci sono casi davvero di estrema povertà. Ma è facile adoperare, manipolare e nascondersi dietro questi ultimi per far proliferare camorra e fauna circostante. A Napoli i clan hanno sempre gestito le case di edilizia pubblica. Ad esempio a Scampia chi vive nei lotti di edilizia popolare sa bene che la continuità abitativa dipende dalle sorti del clan di riferimento. Chi perde la guerra, infatti, deve lasciare gli appartamenti ai nuovi padroni. Un altro esempio è il rione De Gasperi a Ponticelli. Qui il boss Ciro Sarno – ora fortunatamente dietro le sbarre a scontare diversi ergastoli – decideva le famiglie che potevano abitare negli appartamenti del Comune di Napoli. Una tarantella durata per decenni tanto che il padrino Ciro Sarno era soprannominato in senso dispregiativo ‘o Sindaco proprio per questa sua capacità di disporre di alloggi pubblici. Stesso discorso per le case del rione Traiano a Soccavo, le palazzine di Pianura, i parchi di Casavatore, Melito e Caivano.
Di cosa parliamo? Alle conferenze stampa ci si riempie la bocca con parole come legalità, anticamorra, lotta ai clan. Poi alla prima occasione utile invece di mostrare discontinuità, polso duro, mano ferma si deliberano norme che hanno effetti nefasti: alimentano il mercato della case pubbliche gestite dai soliti professionisti dell’occupazione abusiva borderline con i clan. Circola in Italia una strana idea di legalità, scrive Antonio Polito su “Il Corriere della Sera”. I suoi cultori chiedono alle Procure di esercitare il ruolo improprio di «controllori» ma non appena possono premiano l'illegalità, per demagogia o per calcolo elettorale. È il caso di Napoli, città-faro del movimento giustizialista visto che ha eletto sindaco un pm, dove è stata appena approvata, praticamente all'unanimità, la sanatoria degli occupanti abusivi delle case comunali. Nel capoluogo partenopeo si tratta di un fenomeno vastissimo: sono circa 4.500 le domande di condono giunte al Comune per altrettanti alloggi. Per ogni famiglia che vedrà legalizzato un abuso, una famiglia che avrebbe invece diritto all'abitazione secondo le regole e le graduatorie perderà la casa. Non c'è modo migliore di sancire la legge del più forte, del più illegale; e di invitare altri futuri abusivi a spaccare serrature e scippare alloggi destinati ai bisognosi. Ma nelle particolari condizioni di Napoli la sanatoria non è solo iniqua; è anche un premio alla camorra organizzata. È stato infatti provato da inchieste giornalistiche e giudiziarie che «l'occupazione abusiva di case è per i clan la modalità privilegiata di occupazione del territorio», come ha detto un pubblico ministero. In rioni diventati tristemente famosi, a Secondigliano, Ponticelli, San Giovanni, cacciare con il fuoco e le pistole i legittimi assegnatari per mettere al loro posto gli affiliati o i clientes della famiglia camorristica è il modo per impadronirsi di intere fette della città; sfruttando le strutture architettoniche dell'edilizia popolare per creare veri e propri «fortini», canyon chiusi da cancelli, garitte, telecamere, posti di blocco, praticamente inaccessibili dall'esterno e perfetto nascondiglio per latitanti, armi e droga. Non che tutto questo non lo sappia il sindaco de Magistris, che a Napoli ha fatto il procuratore. E infatti ha evitato di assumersi in prima persona la responsabilità di questa scelta. L'ha però lasciata fare al consiglio comunale, Pd e Pdl in testa, difendendola poi con il solito eufemismo politico: «Non è una sanatoria. Io la chiamerei delibera sul diritto alla casa». E in effetti è una delibera che riconosce il diritto alla casa a chi già ce l'ha, avendola occupata con la forza o l'astuzia.
E gli alloggi di proprietà?
Le Iene, 1 ottobre 2013: case occupate abusivamente.
23.40. L’associazione Action organizza occupazioni di case: prima erano per lo più extracomunitari, ora sempre più spesso esponenti del ceto medio che non riesce più a pagare il mutuo e viene sfrattata. Occupano così case vuote o sfitte. O, peggio, entrano in case abitate, cambiano la serratura e addio (un incubo per molti). Una signora, però, ha rioccupato la casa da cui è stata sfrattata.
23.48. Si racconta la storia di una ragazza non ancora trentenne, fiorista, che ha occupato una casa comprata da una famiglia, che ha acceso un mutuo e che ora si trova con un immobile svalutato e un ambiente ben diverso da quello residenziale che avevano scelto per far crescere i propri figli. “Si è scatenata una guerra tra poveri” dice una signora che vive qui ‘legalmente’, che va a lavorare tutti i giorni per pagare un mutuo per una casa che non rivenderà mai allo stesso prezzo. E’ truffata anche lei.
L’occupazione abusiva degli immobili altrui e la tutela delle vittime.
In sede civile, scrive Alessio Anceschi, chi si veda abusivamente privato del proprio immobile può certamente adire l’autorità giudiziaria al fine di rientrare nella disponibilità di esso da coloro che lo hanno illegittimamente occupato. In tal senso, potrà proporre l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), oppure, entro i termini previsti dalla legge, l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.). Il legittimo proprietario o possessore dell’immobile potrà anche agire al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti, i quali si prestano ad essere molto ingenti, sia sotto il profilo patrimoniale, che esistenziale. In tutti i casi, tuttavia, in considerazione della lunghezza del procedimento civile e soprattutto del procedimento di esecuzione, il legittimo proprietario o possessore dell’immobile si trova concretamente privato della propria abitazione (e di tutti i beni che in essa sono contenuti) e quindi costretto a vivere altrove, da parenti o amici, quando và bene, in ricoveri o per la strada quando và male.
Sotto il profilo penale sono ravvisabili molti reati. Prima di tutti, il reato di invasione di terreni od edifici (art. 633 c.p.), ma anche altri reati contro il patrimonio funzionalmente collegati all’occupazione abusiva, quali il danneggiamento (art. 635 c.p.) ed il furto (artt. 624 e 625 c.p.). Il secondo luogo, colui che occupa abusivamente un immobile altrui commette il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Anche in questo caso, tuttavia, la tutela postuma che consegue alla sentenza non si presta a tutelare adeguatamente la vittima. Infatti, il reato di cui all’art. 633 c.p., unica tra le ipotesi citate ad integrare un reato permanente, non consente l’applicazione né di misure precautelari, né di misure cautelari. Lo stesso vale per gli altri reati sopra indicati, soprattutto quando non vi sia stata flagranza di reato. La vittima dovrà quindi attendere l’interminabile protrarsi del procedimento penale ed anche in caso di condanna, non avrà garanzie sulla reintegrazione del proprio bene immobile, posto che l’esiguità delle pene previste per i reati indicati e le mille vie d’uscita che offre il sistema penale, si presta a beffare nuovamente la povera vittima, anche laddove si sia costituita parte civile. Laddove poi l’abusivo trascini nell’immobile occupato la propria famiglia, con prole minorenne, le possibilità di vedersi restituire la propria abitazione scendono drasticamente, in virtù dei vari meccanismi presenti tanto sotto il profilo civilistico, quanto di quello penalistico.
La mancanza di tutela per la vittima è evidente in tutta la sua ingiustizia. Essa diventa ancora più oltraggiosa quando le vittime sono i soggetti deboli, soprattutto, come accade spesso, gli anziani. Che fare ? Nell’attesa che ciò si compia, ove si ritenga che il nostro “Sistema Giudiziario” sembri tutelare solo i criminali, può osservarsi che esso può tutelare anche le vittime, laddove siano costrette a convertirsi, per “necessità” di sopravvivenza e per autotutela. In effetti, occorre osservare che, il nostro ordinamento penale, che di recente ha anche ampliato la portata applicativa della scriminante della legittima difesa nelle ipotesi di violazione di domicilio (art. 52 c.p., come mod. l. 13.2.2006 n. 59), non consente che una persona ultrasettantenne possa subire una misura custodiale in carcere (artt. 275 co. 4° c.p.p. e 47 ter, l. 354/1975). Conseguentemente, solamente laddove l’anziano ultrasettantenne, spinto dall’amarezza, trovasse il coraggio di commettere omicidio nei confronti di tutti coloro che, senza scrupoli, lo abbiano indebitamente spogliato della propria abitazione, potrebbe rientrare immediatamente nel possesso della propria abitazione, con la sicurezza che, il nostro sistema giudiziario, gli garantirebbe una doverosa permanenza in essa attraverso gli arresti o la detenzione domiciliare. Contraddizioni di questa nostra Italia !!!
"Esci di casa e te la occupano… e alla Cassazione va bene così" ha titolato un quotidiano commentando una sentenza della Cassazione che avrebbe di fatto legittimato l'occupazione abusiva degli alloggi. L'articolo riportava le affermazioni di un sedicente funzionario dell'ex Istituto autonomo case popolari (Iacp) che consigliava all'assegnatario di un alloggio di mettere una porta blindata perché "Se sua mamma e suo papa vanno in ferie un paio di settimane, poi arrivano degli abusivi, quelli sfondano, mettono fuori i mobili, ci mettono i loro, e nessuno ha il potere di sgomberarli… Non ci si crede, ma è così". Ed infatti non bisogna credergli… Non è così, scrive “Sicurezza Pubblica”. Gli ipotetici abusivi di cui sopra commettono il reato di violazione di domicilio, e la polizia giudiziaria deve intervenire d'iniziativa per "impedire che venga portato a conseguenze ulteriori" (art. 55 cpp) allontanando (anche con la forza) i colpevoli dai locali occupati contro la legge. Il secondo comma dell'art. 614 cp commina (cioè minaccia) la pena della reclusione fino a tre anni a chiunque si trattenga nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. La pena è da uno a cinque anni (arresto facoltativo, dunque) e si procede d'ufficio se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è palesemente armato. Il reato è permanente. Perciò possiamo andare tranquillamente in ferie perché se qualcuno viola il nostro domicilio forzando la porta o una finestra, la polizia giudiziaria è obbligata a liberare l'alloggio ed il colpevole può essere arrestato. Quali potrebbero essere le responsabilità della polizia giudiziaria, che eventualmente omettesse o ritardasse l'intervento? Secondo l'art. 55 c.p.p. la p.g. deve (obbligo giuridico) impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze, mentre secondo l'art, 40 comma 2 del c.p.: "Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Perciò le ulteriori conseguenze dell'occupazione potrebbero essere addebitate ai responsabili del ritardo o dell'omissione.
Cosa ha veramente la Cassazione?
L'equivoco è nato dalla errata lettura della sentenza 27 giugno - 26 settembre2007, n. 35580, in cui la suprema Corte ha trattato il caso di una persona che, denunciata per aver occupato abusivamente un alloggio ex Iacp vuoto, aveva invocato l'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 cp, ma era stata condannata. La Corte non ha affatto legittimato il reato, ma si è limitata ad annullare la sentenza d'appello con rinvio ad altro giudice, ritenendo che fosse stata omessa la dovuta indagine per verificare se l'esimente stessa sussistesse o meno. Nulla di rivoluzionario dunque, ma applicazione di un principio: quando il giudice ravvisa l'art. 54 cp, il reato sussiste, ma "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona". In quest'ottica, giova rammentare la sentenza 9265 del 9 marzo 2012, che ha definitivamente fatto chiarezza (qualora ce ne fosse stato bisogno). La Cassazione ha respinto il ricorso di una 43enne contro la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto la donna colpevole del reato di cui agli articoli 633 e 639 bis Cp per avere abusivamente occupato un immobile di proprietà dello Iacp di Palermo. La seconda sezione penale, confermando la condanna, ha escluso lo stato di necessità precisando che in base all’articolo 54 Cp per configurare questa esimente (la cui prova spetta all’imputato che la invoca), occorre che «nel momento in cui l’agente agisce contra ius - al fine di evitare un danno grave alla persona - il pericolo deve essere imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio. L’attualità del pericolo esclude quindi tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo». Nell' ipotesi dell’occupazione di beni altrui, lo stato di necessità può essere invocato soltanto per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla necessità di risolvere la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi Iacp sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate. In sintesi: una precaria e ipotetica condizione di salute non può legittimare, ai sensi dell’articolo 54 Cp, un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa.
Sequestro preventivo dell'immobile occupato abusivamente.
La sussistenza di eventuali cause di giustificazione non esclude l'applicabilità della misura cautelare reale del sequestro preventivo. D'altronde la libera disponibilità dell'immobile comporterebbe un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del reato, che il sequestro preventivo mira invece a congelare. (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 7722/12; depositata il 28 febbraio). Il caso. Due indagati del reato di invasione e occupazione di un edificio di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari ricorrevano per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce, che confermava il sequestro preventivo dell'immobile disposto dal GIP. A sostegno della loro tesi difensiva, gli indagati introducevano un elemento afferente il merito della responsabilità penale, sostenendo come fosse documentato lo stato di assoluta indigenza in cui versavano, tale da averli costretti ad occupare l'immobile per la necessità di evitare un danno maggiore alla loro esistenza e salute. In sostanza, invocavano lo stato di necessità che, secondo la tesi difensiva, avrebbe non solo giustificato l'occupazione, ma che avrebbe potuto determinare una revoca del provvedimento cautelare disposto…non opera per le misure cautelari reali. La Suprema Corte esamina la censura, ma la rigetta perché, nel silenzio della legge, non può applicarsi la regola - prevista dall'art. 273 comma 2 c.p.p. per le sole misure cautelari personali - che stabilisce che nessuna misura (personale) può essere disposta quando il fatto è compiuto in presenza di una causa di giustificazione, quale appunto l'invocato stato di necessità. L'ordinanza impugnata ha chiarito che i due indagati hanno abusivamente occupato un alloggio già assegnato ad altra persona, poi deceduta, e ha correttamente rilevato che è del tutto irrilevante la circostanza che nel lontano 1983 il B. sia stato assegnatario di un altro alloggio del cui possesso sarebbe stato spogliato. Se queste sono le circostanze di fatto non è ravvisabile alcuna violazione di legge, ma solo una diversa valutazione dei fatti stessi non consentita in questa sede di legittimità, per di più con riferimento a misure cautelari reali (art. 325, comma 1, c.p.p.). Per quanto concerne la sussistenza della dedotta causa di giustificazione, se è vero che, in tema di misure cautelari personali, ai sensi dall'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, l'applicabilità di una analoga normativa con riferimento alle misure cautelari reali, in assenza di espressa previsione di legge, deve tenere conto dei limiti imposti al Tribunale in sede di riesame, nel senso che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale da parte del tribunale del riesame non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale (per tutte: Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Bocedi, Rv. 215840). È evidente, pertanto, che una causa di giustificazione può rilevare nell'ambito del procedimento relativo a misure cautelari reali solo se la sua sussistenza possa affermarsi con un ragionevole grado di certezza. Anche sulla sussistenza del periculum in mora l'ordinanza impugnata, espressamente pronunciandosi sul punto, afferma che la libera disponibilità da parte degli indagati dell'immobile in questione comporterebbe un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del reato commesso. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condotta e dolo specifico.
L'articolo 633 cp stabilisce che "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o trame altrimenti profitto è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, o da più di dieci persone anche senz'armi". Si procede altresì d'ufficio (art. 638 bis c.p.) se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Perché sussista il reato, occorre che l'agente penetri dall'esterno nell'immobile (anche senza violenza) e ne violi l'esclusività della proprietà o del possesso per una apprezzabile durata, contro la volontà del titolare del diritto o senza che la legge autorizzi tale condotta. Questo reato non consiste nel semplice fatto di invadere edifici o terreni altrui, ma richiede il dolo specifico, cioè la coscienza e volontà di invaderli al fine di occuparli o trame altrimenti profitto. Non occorre neppure l'intenzione dell'occupazione definitiva, anche se essa deve avere una durata apprezzabile. In caso di immobile già invaso, è possibile il concorso successivo di persone diverse dai primi autori dell'invasione (Cass. pen., Sez. Il, sent. 22 maggio 1975, n. 5459). Quanto al reato di violazione di domicilio, previsto dall'art. 614 del C.P., esso è ravvisabile anche "nella condotta di abusiva introduzione (o abusiva permanenza) nei locali di una guardia medica fuori dell'orario ordinario di apertura al pubblico per l'assistenza sanitaria. Infatti, se nell'orario ordinario di servizio la guardia medica è aperta al pubblico, nell'orario notturno l'acceso è limitato a quelli che hanno necessità di assistenza medica e che quindi sono ammessi all'interno dei locali della stessa. Pertanto in questo particolare contesto l'ambiente della guardia medica costituisce un'area riservata che può assimilarsi a quella di un temporaneo privato domicilio del medico chiamato a permanere lì durante la notte per potersi attivare, ove necessario, per apprestare l'assistenza sanitaria dovuta" (Cass. pen. Sez. III, sent. 6 giugno - 30 agosto 2012, n. 33518, in Guida al diritto n. 39 del 2012, pag. 88).
Flagranza e procedibilità d'ufficio.
Il reato d'invasione di terreno o edifici ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio, o con la sentenza di condanna, dato che l'offesa al patrimonio pubblico perdura sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile. Dopo la pronuncia della sentenza, la protrazione del comportamento illecito da luogo a una nuova ipotesi di reato, che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Cass. pen., Sez. Il, sent. 22 dicembre 2003, n. 49169). Nella distinzione tra uso pubblico e uso privato, una recente pronuncia ha affermato che "l'alloggio realizzato dall'Istituto autonomo delle case popolari (lacp), conserva la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, cui non abbia ancora fatto seguito il definitivo trasferimento della proprietà. Ne deriva che, in tale situazione, l'eventuale invasione ad opera di terzi dell'alloggio medesimo è perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 639 bis cp" (Cass. pen., Sez. Il, 12 novembre 2007, n. 41538). In caso di invasione arbitraria di edifici costruiti da un appaltatore per conto dell'ex lacp e non ancora consegnati all'Istituto, la persona offesa, titolare del diritto di querela è l'appaltatore. Ai fini della procedibilità d'ufficio del reato di cui all'art. 633 c.p., l'uso della disgiuntiva nell'art. 633-bis (edifici pubblici o destinati a uso pubblico) pone il carattere pubblico come di per sè sufficiente a configurare la procedibilità d'ufficio, nel senso che è sufficiente che l'edificio sia di proprietà di un ente pubblico. A tal fine, si devono considerare pubblici, secondo la nozione che il legislatore penale ha mutuato dagli articoli 822 e seguenti del Cc, i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo stato o a un ente pubblico, quindi non solo i beni demaniali, ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti. Mentre, sempre per la procedibilità d'ufficio, sono da considerare "destinati a uso pubblico" quegli altri beni che, pur in ipo0tesi appartenenti a privati, detta destinazione abbiano concretamente ricevuto (Corte Appello di Palermo, sent. 20-22 giugno 2011,n. 2351 in Guida al diritto n. 46 del 19 novembre 2011).
L'art. 634 c.p. - Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 633 c.p., turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone. La maggior parte della dottrina ritiene che l'unica distinzione possibile sia quella che fa perno sull'elemento soggettivo: mentre nell'art. 633 è previsto il dolo specifico, per l'art. 634 è sufficiente il dolo generico. Di conseguenza si dovrà applicare l'art. 634 qualora vi sia un'invasione non qualificata dal fine di occupare i terreno e gli edifici o di trarne altrimenti profitto. Viceversa sussisterà la fattispecie di cui all'art. 633 anche nel caso di invasione violenta finalizzata all'occupazione o al profitto. La turbativa di cui all'art. 634 postula un comportamento minimo più grave della semplice introduzione (art. 637) e meno grave dell'invasione (art. 633). La nozione di turbativa deve intendersi come una non pregnante compromissione dei poteri del possessore. La semplice violenza sulle cose, che non sia usata per coartare l'altrui volontà, non basta ad integrare il reato. Peraltro il comma 2 dell'art. 634, parifica alla violenza alla persona e alla minaccia, la presenza di un numero di persone (che commettono il fatto) superiore a dieci. Si discute se si tratti di un delitto istantaneo o permanente. Prevale l'opinione che ritiene trattarsi di reato istantaneo, potendo assumere connotazione permanente allorchè la perturbazione richieda l'esperimento di una condotta prolungata nel tempo, sostenuta da costante volontà del soggetto agente (Manzini).
Come agire?
Il delitto di violazione di domicilio è permanente ed ammette l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, lett. f-bis c.p.p.) Anche il delitto di invasione al fine di occupazione (art. 633 c.p.) è permanente: la condotta criminosa perdura per tutto il tempo dell'occupazione e deve essere interrotta dalla polizia giudiziaria, che anche di propria iniziativa deve impedire che i reati vengano portati a ulteriore conseguenze (art. 55 cpp). Non appena i titolari del diritto sull'alloggio danno notizia dell'avvenuta invasione agli organi di pg questi ultimi, se dispongono delle forze necessarie, debbono procedere allo sgombero, senza necessità di attendere il provvedimento dell'Autorità. In ambedue i casi spetta al giudice valutare poi l'esistenza di eventuali esimenti.
Inerente l'occupazione abusiva di un immobile, pare opportuno inserire una breve digressione sulle azioni a tutela dei diritti di godimento e del possesso. Il panorama si presenta alquanto vario; troviamo, infatti, le azioni concesse al solo proprietario, quelle esperibili dal titolare di un diritto di godimento su cosa altrui o dal possessore in quanto tale. Tali azioni vengono qualificate come reali, in quanto offrono tutela per il solo fatto della violazione del diritto.
L'azione di rivendicazione, rientrante fra le azioni petitorie, tende ad ottenere il riconoscimento del diritto del proprietario sul bene e presuppone la mancanza del possesso da parte dello stesso; è imprescrittibile e richiede la dimostrazione del proprio diritto risalendo ad un acquisto a titolo originario.
L'azione negatoria è concessa al proprietario al fine di veder dichiarata l'inesistenza di diritti altrui sulla cosa o la cessazione di turbative o molestie; in questo caso al proprietario si richiede soltanto la prova, anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo dal quale risulti il suo acquisto.
L'azione di regolamento di confini mira all'accertamento del proprio diritto nel caso in cui siano incerti i confini dello stesso rispetto a quello confinante; in tale ipotesi la prova del confine può essere data in qualsiasi modo. Nell'azione di apposizione di termini, al contrario, ciò che si richiede al Giudice è l'individuazione, tramite indicazioni distintive, dei segni di confine tra due fondi confinanti.
L'azione confessoria è volta a far dichiarare l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesti l'esercizio, e a far cessare gli atti impeditivi al suo svolgimento.
A difesa del possesso incontriamo le categorie delle azioni possessorie e di enunciazione: le prime si distinguono nell'azione di reintegrazione, che mira a far recuperare il bene a chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso, da proporsi entro un anno dallo spoglio, e l'azione di manutenzione, proposta al fine di far cessare le molestie e le turbative all'esercizio del diritto.
L'azione di manutenzione, al contrario di quella di reintegrazione, ha una funzione conservativa, poiché mira alla cessazione della molestia per conservare integro il possesso, e una funzione preventiva, poiché può essere esperita anche verso il solo pericolo di una molestia. Diversamente dalle azioni a difesa della proprietà, che impongono la prova del diritto, il possessore ha soltanto l'onere di dimostrare il possesso (in quanto questo prescinde dall'effettiva titolarità del diritto). Le azioni di enunciazione, con le quali si tende alla eliminazione di un pericolo proveniente dal fondo vicino, si distinguono nella denunzia di nuova opera e di danno temuto; esse, infatti, vengono qualificate come azioni inibitorie, cautelari, che possono dar luogo a provvedimenti provvisori.
ITALIA. SOLIDARIETA’ TRUCCATA E DI SINISTRA.
Ma come sono cari (e di sinistra) i professionisti dell'accoglienza. L'emergenza sbarchi comporta un giro vorticoso di denaro pubblico. Che si ripete senza soluzione, scrive Stefano Filippi su “Il Giornale”. Dietro l'orrore, la pietà, lo scandalo, il buonismo, le tragedie del mare nascondono il business che non t'aspetti. Il giro d'affari del primo soccorso e dell'accoglienza. Da una parte i milioni di euro stanziati dall'Europa e dall'Italia, dall'altra la pletora di personaggi in attesa di incassare. Onlus, patronati, cooperative, professionisti dell'emergenza, noleggiatori di aerei e traghetti, perfino i poveri operatori turistici di Lampedusa: abbandonati dai vacanzieri si rassegnano a riempire camere d'albergo, appartamenti e ristoranti con agenti, volontari, giornalisti, personale delle organizzazioni non governative, della Protezione civile, della Croce rossa. L'emergenza sbarchi comporta un giro vorticoso di denaro pubblico. Nel 2011, l'anno più drammatico, gli sbarchi provocati dalle sanguinose rivolte nordafricane sono costati all'Italia un miliardo di euro. Ogni giorno le carrette del mare da Libia e Tunisia hanno scaricato in media 1.500 persone. Il governo dovette aumentare le accise sui carburanti per coprire parte di queste spese. E a qualcuno che sborsa corrisponde sempre qualcun altro che incassa. Bisogna gestire la prima accoglienza: acqua, cibo, vestiti, coperte, farmaci. Vanno organizzati i trasferimenti sul continente ed eventualmente i rimpatri; si aggiungono spese legali, l'ordine pubblico, l'assistenza (medici, psicologi, interpreti, mediatori culturali). Ma questo è soltanto l'inizio, perché moltissimi rifugiati chiedono asilo all'Italia. E l'Italia se ne fa carico, a differenza della Spagna che ordina di cannoneggiare i barconi e di Malta che semplicemente abbandona i disperati al loro destino. Nel triennio 2011/13 le casse pubbliche (ministero dell'Interno ed enti locali) hanno stanziato quasi 50 milioni di euro per integrare 3000 persone attraverso il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. A testa fanno più di 5.000 euro l'anno. L'Europa soccorre soltanto in parte. Il finanziamento più cospicuo arriva dal Fondo europeo per le frontiere esterne destinato alle forze di sicurezza di confine (capitanerie di porto, marina militare, guardia di finanza): 30 milioni annui. Altri 14,7 milioni arrivano dal Fondo per l'integrazione, non riservato all'emergenza. Dal Fondo per i rimpatri piovono 7 milioni di euro. Poi c'è il Fondo per i rifugiati, che nel 2012 ha stanziato 7 milioni in via ordinaria più altri 5 per misure di emergenza. Tutti questi denari vanno considerati come co-finanziamento: si aggiungono cioè ai soldi che l'Italia deve erogare. Il fondo più interessante è quello per i rifugiati, che è tale soltanto di nome perché i veri destinatari dei 12 milioni di euro (sono stati 10 milioni nel 2008, 4,5 nel 2009, 7,2 nel 2010 e addirittura 20 nel fatidico 2011) sono Onlus, Ong, cooperative, patronati sindacali e le varie associazioni umanitarie che si muovono nel settore dell'immigrazione. Dal 2008, infatti, l'Europa ha stabilito che quel fiume di contributi vada «non più all'attività istituzionale per l'accoglienza, ma ad azioni complementari, integrative e rafforzative di essa». Anche queste, naturalmente, co-finanziate dal governo italiano. Le organizzazioni operano alla luce del sole, sono autorizzate dal ministero dell'Interno che deve approvare progetti selezionati attraverso concorsi pubblici. I soldi finiscono in fondi spese destinati non ai disperati ma a vitto e alloggio delle truppe di volontari e professionisti. Per la felicità degli albergatori lampedusani. Gli operatori sociali spiegano ai nuovi arrivati i loro diritti. Li mettono in contatto con interpreti, avvocati, mediatori da essi retribuiti. Organizzano la permanenza, li aiutano a restare in Italia o a capire come proseguire il loro viaggio della speranza. Fanno compilare agli sbarcati, che per la legge sono clandestini, un pacco di moduli per avere assistenza legale d'ufficio. Pochissime organizzazioni, e tra queste Terre des hommes e Medici senza frontiere, si fanno bastare i denari privati. A tutte le altre i soldi italo-europei servono anche a sostenere i rispettivi apparati, come gli uffici stampa, gli avvocati e gli attivisti per i diritti umani, per i quali martellare i governi finanziatori è una vera professione. E magari usano l'emergenza immigrazione come trampolino verso la politica.
Destra, sinistra e solidarietà. Come ci segnala un articolo de Il Redattore Sociale, la presenza del Terzo Settore nelle liste dei candidati alle prossime elezioni è piuttosto significativa: presidenti e direttori di molte importanti organizzazioni si presentano nelle liste di PD, SEL, Ingroia e Monti. Questo scrive Gianni Rufini su “La Repubblica”. Gianni Rufini, esperto di aiuto umanitario, ha lavorato in missioni di assistenza in quattro continenti e insegna in numerose università italiane e straniere. Se saranno eletti, buona parte dell’associazionismo e del movimento cooperativo dovrà rinnovare i propri vertici. Molto meno forte, la presenza del mondo della solidarietà internazionale. Ci sono personalità di rilievo, come gli ottimi Laura Boldrini e Giulio Marcon, ma non abbastanza – temo – da far nascere all’interno del parlamento un nucleo significativo di deputati e senatori che possano promuovere un rinnovamento della politica italiana in questo senso. Ma speriamo bene. Tutte queste persone si candidano con partiti di sinistra o di centro, mentre la destra è completamente assente. Se è vero che la sinistra è sempre stata più attenta a questi temi, sono profondamente convinto che questioni come la cooperazione, l’aiuto umanitario o i diritti umani siano assolutamente trasversali. Possono esserci visioni diverse sulle politiche in questi campi, ma dovrebbe esserci un’intesa di fondo per questioni che riguardano tutti i cittadini, di qualunque orientamento, in ogni regime politico. Purtroppo non è così. In altri paesi, esiste un “conservatorismo compassionevole” che ritiene moralmente doveroso impegnarsi in questi ambiti; si trovano politiche estere di destra che vedono comunque nella cooperazione uno strumento fondamentale; ci sono politiche sociali conservatrici che promuovono il volontarismo per ridurre il peso dello Stato; ci sono visioni del capitalismo che ritengono centrali, per il suo sviluppo, i diritti umani. Nella destra italiana sembra invece prevalere una visione che definirei “cattivista”. Sembra che da noi, per essere di destra bisogna necessariamente coltivare cattivi sentimenti: l’irrisione per i poveri, l’avidità, lo sprezzo del senso civico, il calpestamento dei diritti altrui. Cosa particolarmente strana, in un paese che ha una forte cultura cattolica e una storia importante di solidarietà unitaria, per esempio nei grandi disastri. E’ difficile comprendere la mutazione che ha portato la destra italiana a questa deriva antropologica. Forse è un altro dei residuati tossici dell’ultimo ventennio. Questo è un problema per l’Italia, per due ragioni: la prima è che quando si parla di diritti, di umanità, di relazioni con il mondo, si parla dell’identità profonda di un paese, e questa dovrebbe essere in massima parte condivisa dalle forze politiche. E poi, perché le strategie in questo campo esigono tempi lunghi, per produrre risultati, tempi di decenni. E non possono scomparire e ricomparire ad ogni cambio di governo. Credo che il lavoro più importante che dovranno fare quei colleghi che hanno deciso di impegnarsi in politica sia promuovere un cambiamento culturale dentro la politica, dentro il parlamento. Perché certi principi e certi valori diventino un patrimonio condiviso, al di là delle differenze ideologiche.
LA GUERRA TRA ASSOCIAZIONI ANTIRACKET.
“L’efficienza delle associazioni antimafia non si misura in fase ai finanziamenti ricevuti, alle denunce presentate, alla parte politica che li sostiene, alla visibilità data dai media ed alla santificazione di toghe e divise” risponde così il dr Antonio Giangrande alle dichiarazioni di Maria Antonietta Gualtieri presidente dell’Associazione Antiracket Salento (…a Brindisi totale assenza di denunce nonostante tante associazioni antimafia…) ed alla piccata risposta del presidente Salvatore Incalza dell’associazione antiracket di Francavilla Fontana associata FAI (..cerca visibilità perché cessa il foraggiamento di Stato…). Il Dr Antonio Giangrande, presidente nazionale della “Associazione Contro Tutte le Mafie” da Taranto interviene nella polemica su stampa e tv sorta tra le associazioni antiracket ed antiusura brindisine e leccesi. Una polemica che serpeggia, però, in tutta Italia, laddove vi sono costituiti sodalizi antimafia di contrapposti schieramenti. «L’attività delle associazioni antiracket ed antiusura non si misura in base alla visibilità mediatica che certe tv locali politicamente schierate danno ad alcune di loro, finanziate da progetti di passati Ministri dell’Interno o da sottosegretari a loro vicini e comunque di finanziamenti ricevuti perché facenti parte del FAI o di Libera; né tantomeno in base alle denunce presentate da questi sodalizi o dalla loro costituzione in giudizio per interesse di qualcuno. Il tutto per fare numero e molte volte contro poveri cristi a vantaggio di truffatori. Sempre bene attenti a non toccare i poteri forti: tra cui le banche. La loro efficienza non si misura neanche in base al sostegno finanziario da loro ricevuto dallo Stato o da una parte politica regionale. Comunque c’è da dire che il grado di valore che si dà alle associazioni antimafia non è paragonato al fatto di quanto queste siano lo zerbino o passacarte di toghe e divise. La capacità delle associazioni è legata alla loro competenza ed al grado di assistenza e consulenza che loro sanno offrire: senza fare politica. Questo è il loro compito: informare ed assistere nella stesura degli atti. Le denunce le presentano le presunte vittime e l’applicazione della giustizia spetta alle toghe ed i contributi li elargisce lo Stato. Qualcuno non si deve allargare!». Va giù duro il presidente Antonio Giangrande. « Io penso che la vittima di qualsivoglia sopraffazione e violenza non ha bisogno di visibilità, per questo noi usiamo il web oltre che la sede fissa. In questo modo le vittime non hanno bisogno di farsi vedere, quindi si informano e le denunce le scaricano direttamente dal sito e le presentano alle forze dell’ordine. Non mancano, però, le lamentele di abbandono da parte dello Stato. E questo non bisogna tacerlo. Inoltre non siamo affiliati a nessuno e quindi non riceviamo nulla da alcuno, né ritorno di immagine, né copertura delle spese. D’altronde che volontariato è se poi si è sovvenzionati e quindi diventa un lavoro. Alla stampa dico di seguire ed aiutare tutte quelle associazioni che lavorano sul campo a rischio delle vite dei loro componenti, senza ricevere nulla. E se proprio vogliono riportare le polemiche, i giornalisti chiedessero a tutte queste associazioni, che vanno per la maggiore, chi li paga e chi votano e come mai aprono sportelli antiracket in città in cui non sono iscritte presso le locali prefetture, così come vuole la legge, tutto a svantaggio di chi è legalmente iscritto in loco: se ne scoprirebbero delle belle!» Continua Antonio Giangrande. «Additare i difetti altrui è cosa che tutti sanno fare, più improbabile è indicare e correggere i propri. Non abbiamo bisogno di eroi, né, tantomeno, di mistificatori con la tonaca (toga e divisa). L’abito non fa il monaco. La legalità non va promossa solo nella forma, ma va coltivata anche nella sostanza. E’ sbagliato ergersi senza meriti dalla parte dei giusti. Se scrivi e dici la verità con il coraggio che gli altri non hanno, il risultato non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu additato come pazzo. Ti scontri sempre con la permalosità di magistrati e giornalisti e la sornionità degli avvocati avvezzi solo ai loro interessi. Categorie di saccenti che non ammettono critiche. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Questa è sociologia storica, di cui sono massimo cultore. Conosciuto nel mondo come autore ed editore della collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo” pubblicata su www.controtuttelemafie.it ed altri canali web, su Amazon in E-Book e su Lulu in cartaceo, oltre che su Google libri. 50 saggi pertinenti questioni che nessuno osa affrontare. Ho dei canali youtube e sono anche editore di Tele Web Italia: la web tv di promozione del territorio italiano. Bastone e carota. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!»
Il livore del PD, SEL, CGIL e di tutta la loro costellazione di sigle nel Lazio nei confronti dell’Associazione Caponnetto. Perché? Preferiscono forse un’antimafia del bon ton diversa dalla nostra di indagine e denuncia? O avrebbero voluto che ci etichettassimo politicamente assoggettandoci ai loro interessi e facendo un’antimafia soft, più retorica e commemorativa, di parata insomma? Questo di chiede l’Associazione antimafia “Antonino Caponnetto”. Non che ci dispiaccia. Anzi, è tutto il contrario perché più stiamo lontani da queste nomenclature politiche screditate e più guadagniamo in credibilità. Pur tuttavia certe cose vanno annotate per far comprendere ai più sprovveduti e disinformati fino a che punto arrivano la bassezza, la vuotaggine, l’insulsaggine, l’insignificanza e l’irresponsabilità della classe dirigente del PD e del suo accoliti nella provincia di Latina e nel Lazio. Sono oltre 10 anni che il PD del Lazio e della provincia di Latina fa la guerra all’Associazione Caponnetto mostrando, peraltro, in maniera sfacciata di voler privilegiare Libera e solo Libera ed il suo modo di fare antimafia. Non abbiamo mai capito le ragioni di tanta ostilità. Forse perché abbiamo sempre dichiarato la nostra assoluta indipendenza da tutto e da tutti mentre il PD voleva che noi ci fossimo etichettati politicamente ed assoggettati ai suoi interessi? O perché il PD preferisce un modello di antimafia tutto bon ton, all’acqua di rose, culturale e basta, commemorativo e parolaio e niente affatto di indagine e denuncia, nomi e cognomi, come facciamo noi dell’Associazione Caponnetto? Non lo sappiamo e, a questo punto, nemmeno ci interessa saperlo più perché abbiamo preso atto di un dato di fatto incontrovertibile e consolidato: il PD ed i suoi accoliti combattono l’Associazione Caponnetto e riconoscono come propria referente ed amica solo LIBERA. Bene così per il PD, per tutti i suoi accoliti e per Libera. Se questa è l’antimafia che vuole il PD vadano avanti così ma non osino più parlare di lotta alle mafie perché li talloneremo e gli rinfacceremo di volta in volta che la lotta alle mafie non si fa come fanno lor signori che si limitano solo a parlarne senza affrontare e risolvere i problemi veri della lotta alla criminalità mafiosa. Brutto segnale quello che viene da questo partito che dimostra palesemente di non volere l’antimafia reale, quella effettiva, la vera antimafia, ma solo quella di parata, delle commemorazioni, del racconto del passato e via di questo passo. La guerra all’Associazione Caponnetto viene da lontano, dai tempi della Giunta Marrazzo alla Regione Lazio quando la Presidente della Commissione Criminalità -la PD ex DS Luisa Laurelli – volle escludere dai vari organismi consultivi della Regione la nostra Associazione facendo, al contempo, entrarvi sigle assolutamente inconsistenti ed esistenti solo sulla carta ma etichettate PD, oltre ovviamente a Libera. Cosa che si è ripetuta puntualmente all’Amministrazione Provinciale di Roma sotto la gestione Zingaretti, altro campione dell’antimafia parolaia e non di quella reale dell’indagine e della denuncia. Non che le nostre ripetute esclusioni ci siano dispiaciute, vista l’assoluta inutilità ed inerzia di tali organismi che si sono appalesate a posteriori come delle sole sparate propagandistiche senza alcuna efficacia. Evitiamo, per non tediare coloro che ci seguono, di raccontare i dettagli, i continui tentativi di isolarci (dal convegno organizzato sempre dal PD con Piero Grasso durante l’ultima campagna elettorale, con la partecipazione della Fondazione nostra omonima, a sostegno della candidatura dell’ex Procuratore Nazionale antimafia, convegno che, pur avendo visto la nostra esclusione - e ne siamo stati lieti perché era un convegno elettorale e di partito -, i relatori si sono visti costretti ad esaltare proprio l’opera dell’Associazione Caponnetto!!!; all’ultima proprio di stamane 21 giugno con il convegno promosso a livello provinciale e sempre a Gaeta dal Sindacato Pensionati Italiani della CGIL sui problemi della legalità, un convegno che ha visto la partecipazione in massa di elementi di Libera e basta). Potremmo citare altri esempi della faziosità – e, peraltro, anche dell’ottusità politica- della classe dirigente del PD e dei suoi accoliti di SEL (vi risparmiamo di raccontarvi il comportamento inqualificabile di Zaratti uomo di punta di SEL il quale durante una seduta della Commissione criminalità della Regione Lazio della quale era Presidente dopo la Laurelli non spese una sola parola in difesa dell’Associazione Caponnetto aggredita violentemente dal suo vicepresidente, un consigliere di destra di cui non ricordiamo il nome, quasi a mostrare un malcelato piacere -, della CGIL e così via. Ma tutto ciò non ci duole affatto. Anzi, il contrario. Perché tutto questo livore nei nostri confronti da parte del PD, SEL e di tutta la loro costellazione di sigle e siglette nei nostri confronti sta a provare che agiamo bene, che colpiamo bene, senza lacci e lacciuoli e che sono sempre di più coloro che hanno paura di noi in quanto probabilmente sanno di avere qualche scheletro nell’armadio. Questo ovviamente ci ha fatto accendere una lampadina e ci induce a porci la domanda del “perché” di tale comportamento… Quando il cane ringhia rabbioso a difesa di una tana vuol dire che là dentro nasconde qualcosa di importante, la nidiata, un pezzo di carne… Ci lavoreremo… per scoprirlo. Poi, però, non si dica che siamo… cattivi o, peggio, faziosi anche noi.
“LIBERA” di nome ma non di fatto. E’ solo un problema politico, scrive l'associazione antimafia "Casa della legalità e della cultura Onlus della sicurezza sociale". E' difficile che le cose che non funzionano vengano indicate quando riguardano quelli che sono una sorta di “santuari” della cosiddetta società civile. Eppure le distorsioni, i problemi, anche seri, ci sono. Sono fatti che, messi uno accanto all'altro, ci dicono che qualcosa non va. Rompiamo questo silenzio, ponendo alcune semplici domande e dando a queste una risposta. Non è per polemica, ma per dovere di cronaca, per elencare i fatti di una questione “politica”. Siamo convinti che solo guardando in faccia la realtà sia possibile migliorare e correggere quegli errori che troppo spesso impediscono di fare passi avanti nella lotta alle mafie ed all'illegalità. Il confronto e non la chiusura è strumento essenziale nella democrazia, e lo è ancora di più quando si parla di strutture importanti, come è Libera...
Perché criticate “LIBERA”, che universalmente è riconosciuta, da destra a sinistra, quale grande organizzazione antimafia?
«Innanzitutto bisogna premettere che la critica è costruttiva, finalizzata al confronto per risolvere i problemi. Criticare non significa distruggere e questo è ancora più indiscutibile quando, come nel nostro caso, la critica è un elencare di fatti che non si possono tacere ma che impongono, dovrebbero imporre, una riflessione e quindi una reazione. Quindi... Avete mai sentito pronunciare un nome e cognome di quella “zona grigia”, della rete di professionisti e politici collusi e contigui, dagli esponenti di Libera che tanto a slogan punta l'indice contro questa “zona grigia”? Mai, né un nome di un mafioso (se non già condannato in via definitiva), né un nome di una società di famiglie mafiose, né il nome dei politici che nei vari territori sono compromessi, vuoi per contiguità (che non è un reato) o peggio. Mai un nome delle grandi imprese e cooperative che nei propri cantieri, quali fornitori, scelgono le “offerte vantaggiose” delle società di note famiglie mafiose. Non c'è una denuncia che sia una, se non “il giorno dopo” ad un dramma o allo scattare delle manette o dei sigilli a qualche bene.»
Ma questo può essere solo un modo diverso di combattere la stessa battaglia...
«Non è un discussione la “diversità” di metodi, ma i fatti ci testimoniano che la questione non è solo un diverso modo di agire nella lotta alla mafia...La Libera che abbiamo visto da qualche anno a questa parte, diversa, radicalmente diversa, da quella delle origini, ha scelto una strada che, pur qualificandosi come “antimafia”, di antimafia concreta ha ben poco. Cerchiamo di spiegare... Libera, con la struttura che si è data, vive grazie ai contributi pubblici e privati. Tra i suoi sponsor troviamo, ad esempio, l'Unieco, colosso cooperativo emiliano, che si vanta dei finanziamenti che da a Libera. Ma l'Unieco nei propri cantieri fa lavorare società di famiglie notoriamente mafiose, per l'esattezza di 'ndranghetisti. I soldi risparmiati dalla Unieco in quei cantieri, con le famose offerte “economicamente vantaggiose”, ad esempio, di società di famiglie espressione delle cosche MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI e PIROMALLI con i GULLACE-RASO-ALBANESE, restano nelle casse di Unieco che poi finanzia Libera per la lotta alla mafia. E' chiaro il controsenso? La contraddizione è palese. Libera dovrebbe rifiutare quei fondi ed esigere da Unieco, così come dalle grandi cooperative della Lega Coop, che non abbia alcun tipo di contiguità e connivenze con società indecenti! Non lo fa, prende i soldi e fa iniziative al fianco di Unieco e compagnia nel nome dell'antimafia. Ma vi rendete conto di che impatto fortissimo avrebbe invece una scelta da parte di Libera di rispedire al mittente quei contributi con la motivazione: prima fate pulizia tra i vostri fornitori e poi ci potrete finanziare? Sarebbe un segnale concreto importantissimo! Non è questione di illeciti, ma di opportunità... di decenza.»
Può essere un caso, non si può confondere il tutto con un caso.
«Prima di tutto non è “un caso” ma un questione sistematica e non lo diciamo noi, ma una serie di fatti. Per esempio, oltre alle grandi cooperative “rosse”, c'è il caso di Unipol. Oggi sappiamo, grazie alle inchieste su Consorte e furbetti delle “scalate”, di cosa è capace quel gruppo: azioni spregiudicate, sul crinale tra lecito e illecito... così come sappiamo che, come le altre grandi banche, ha una inclinazione nel non notare operazioni sospette che si consumano nelle propri filiali. Ed anche qui Libera si presenta al fianco di Unipol nel nome della Legalità, della lotta alla corruzione ed alle mafie. Anche qui: vi immaginate se quando Unipol o la fondazione Unipolis mandano i contributi a Libera, l'associazione di don Ciotti rimandasse indietro quei contributi con un bel comunicato stampa in cui dice che finché le indecenze di Unipol non saranno eliminare loro non vogliono un centesimo dei loro fondi? Sarebbe un segnale chiaro, durissimo! E poi vi è il campo più prettamente “politico”. Andiamo anche in questo caso con esempi concreti. A Casal di Principe il sindaco e l'assessore con Libera distribuivano targhe anti-camorra, ma quell'amministrazione comunale era legata alla Camorra, ai Casalesi. Cose che si sanno in quei territori. Il sindaco e l'assessore sono stati poi arrestati perché collusi con i Casalesi... Libera li portò sul palco della sua principale manifestazione, nel marzo 2009, a Casal di Principe, per distribuire le targhe intitolate a don Peppe Diana. Ecco: Antonio Corvino e Cipriano Cristiano avevano ottenuto il loro bel “paravento”. Spostiamoci in Sicilia. Nel trapanese, la terra del latitante Matteo Messina Denaro, è stato arrestato Ciro Caravà. L'accusa: associazione mafiosa. Si presentava in tv e nelle piazze nel nome di Libera, ma era parte della rete mafiosa che fa capo al latitante di Cosa Nostra. Libera ha dichiarato che non era nemmeno tesserato... lo ha dichiarato dopo l'arresto. Prima, dell'arresto, che costui andasse per mari e per monti a promuovere Libera e la sua azione antimafia da Sindaco andava bene. Siamo già a due casi eclatanti, pesanti come macigni, in cui Libera era un “paravento”. Non sono opinioni o interpretazioni, sono fatti.»
Ma due casi su scala nazionale sono un’eccezione, non la prassi..
«Drammaticamente non sono solo due casi in tutta Italia. Questi erano due esempi. Vediamone qualche altro...Polistena, giornata della Memoria e dell'Impegno di Libera. Sul palco Libera fa salire, a scandire i nomi delle vittime di mafia, Maria Grazia Laganà vedova Fortugno. In allora già indagata dalla DDA di Reggio Calabria, per truffa aggravata allo Stato in merito alle forniture della ASL di Locri... quella dove la signora era vice-direttore sanitario e responsabile del personale, quella Asl in cui assunzioni, promozioni, incarichi e appalti erano decisi dalle 'ndrine, a partire dal “casato” dei MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI... cosca di cui alcuni esponenti erano in contatto telefonico sia con la Laganà, sia con Fortugno... e non dimentichiamoci la grande amicizia tra gli stessi Laganà e Fortugno con i MARCIANO', riconosciuti responsabili dell'omicidio del Fortugno stesso. E' quella stessa Laganà che subito dopo l'omicidio del marito, omicidio politico-mafioso, ha promosso una lista elettorale per le elezioni provinciali con Domenico CREA, indicato da più parti come il grande beneficiario dell'omicidio Fortugno, nella sua veste di “signore della Sanità” in comunella con la 'ndrangheta. Poi si scoprì anche che il segretario della Laganà, dal telefono della signora, comunicava al sindaco di Gioia Tauro, l'avanzamento in tempo reale del lavoro della Commissione di Accesso che ha portato allo scioglimento di quell'amministrazione perché piegata ai desiderata dei PIROMALLI. La Laganà infatti era membro della Commissione Parlamentare Antimafia e quindi con accesso a informazioni riservate, secretate. Che segnale è, in Calabria, nella Piana di Gioia Tauro, far salire un soggetto del genere sul palco della cosiddetta “antimafia”? Chiaramente devastante. Ma andiamo avanti. A Bari chi è stato il grande protagonista della giornata della Memoria e dell'Impegno di Libera? Massimo D'Alema. Quel D'Alema i cui rapporti indecenti sono ormai noti, a partire da quelli, con gli uomini della sanità pugliese e quella vecchia tangente, andata in prescrizione, da uno degli uomini della sanità legati alla Sacra Corona Unita. A Napoli vi era Bassolino, che sappiamo cosa abbia rappresentato in materia di gestione dei rifiuti a Napoli e Campania. A Torino c'era Chiamparino che nuovamente è espressione di quella componente spregiudicata nella ricerca e costruzione di consenso, e tra i principali supporter della TAV, un'opera inutile, antieconomica, devastante per ambiente e salute e manna per le cosche che vogliono, come già avvenuto per altre tratte di quest'opera, entrarci con i subappalti. Quest'anno è toccato a Genova... Don Ciotti qui si schiera al fianco di Burlando e della Vincenzi, ad esempio. Li ringrazia. Li presenta come esempio di lotta alla mafia... peccato che con le amministrazioni guidate da Burlando e dalla Vincenzi, le mafie abbiano fatto (e continuano a fare, anche nonostante misure interdittive) ottimi affari a Genova ed in Liguria, proprio a partire da quelli con le società pubbliche aventi soci la Regione ed il Comune, o con le grandi cooperative “rosse”. E' più chiara ora la questione? Più che di “giornata della memoria e dell'impegno”, quella a Genova, dello scorso marzo, è stata l'ennesima giornata della memoria corta e dell'ipocrisia! Non ci pare chiedere tanto quando si dice che gli ipocriti della politica, delle Istituzioni, e gli “indecenti”, non vengano fatti salire su quei palchi. Ci sembrerebbe una normalità, un atto di rispetto per le vittime.»
Ma Libera non è una struttura indipendente?
«No! Purtroppo no. Quello che abbiamo detto lo dimostra e se servono ulteriori esempi che Libera si sia piegata a “paravento” di chi la sovvenziona e di chi politicamente le è “caro”, li porto senza esitazione e senza pericolo di smentita alcuna. Ed attenzione: è pienamente legittimo quanto fa Libera. Non vorrei che si pensasse l'opposto. Assolutamente no! E' legittimo che Libera si faccia “braccio” di un blocco di potere politico-economico, ma sarebbe intellettualmente corretto ed onesto che lo dichiarasse, senza negarlo e senza dichiararsi “indipendente”. Parliamo del Piemonte? A Torino Libera ha una forte vicinanza a SEL e già questo basterebbe a chiarire lo strano concetto che Libera ha di “indipendente”. Michele Cutro, persona degnissima, era dal 2007 il referente dell'area europea di Libera; si candida a Torino alle Primarie di centro sinistra e poi per il Consiglio Comunale con SEL, in appoggio a Fassino. Viene eletto ed entra in Comune. SEL è nella maggioranza di centrosinistra, quella stessa maggioranza determinatasi grazie anche ai consensi raccolti tra gli 'ndranghetisti, come ha messo in evidenza l'inchiesta MINOTAURO. Come può quindi Libera, un esponente di primo piano di Libera, avere una vicinanza marcata con un partito quando questi è parte integrante di quella maggioranza in cui vi sono metodi spregiudicati e indecenti di raccolta del consenso? E se poi vogliamo vi è tutto il capitolo TAV, con la posizione di Libera che fa da stampella al blocco di potere politico-economico che persegue questa opera! Scendiamo nell'alessandrino? Qui vi sono pesantissimi interessi ed affari di una delle più potenti cosche della 'ndrangheta, quella dei GULLACE-RASO-ALBANESE. Il “locale” della 'ndrangheta guidato da Bruno Francesco PRONESTI' contava tra i propri affiliati anche il Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Alessandria. A Novi Ligure è consigliere comunale un giovane della famiglia SOFIO, coinvolta in più inchieste legate ai MAMONE, ed operativa proprio nell'alessandrino. Lì vi è uno degli snodi dei traffici e conferimenti illeciti di sostanze tossiche che coinvolge Piemonte, Liguria e Lombardia. Vi era un bene confiscato a Cosa Nostra, a Bosco Marengo. Cosa ha proposto Libera come progetto di riutilizzo a fini sociali per farselo assegnare? Un allevamento di quaglie! Sì: allevamento di quaglie! Ma davvero non si poteva fare altro di più incisivo per una bonifica più ampia di quei territori, in quel bene confiscato? Noi crediamo di sì. Ma non basta. Dopo la presentazione in pompa magna dell'assegnazione a Libera di questo bene che cosa è successo? Che non si è proceduto a sistemare quel casolare e così oggi, dopo gli articoli su come sono brave le Istituzioni e Libera di alcuni anni fa, quel casolare deve essere demolito perché impossibile, economicamente impossibile, ristrutturarlo! Un fallimento devastante! Ma non basta ancora. Libera prima delle ultime elezioni amministrative, cosa fa ad Alessandria, nella sua visione “ecumenica”? Va dal anche dal Sindaco in carica, quello che aveva, con la sua maggioranza, messo il CARIDI, l'affiliato alla 'ndrangheta, alla Presidenza della Commissione Urbanistica, da quel Sindaco che ha contribuito in modo determinante al dissesto del Bilancio di Alessandria, e gli propone di firmare il documentino contro le mafie! Ecco, anziché indicarlo come pessimo esempio di gestione della cosa pubblica e di “sponsor” del CARIDI, loro gli porgono la mano per dichiararsi, con una firmetta antimafioso! Parliamo dell'Emilia-Romagna? Avete mai sentito Libera indicare gli affari sporchi di riciclaggio e speculazione edilizia, di smaltimenti illeciti di rifiuti o altro che non siano quelli più “visibilmente sporchi”, come droga e prostituzione? No. Anche qui mai un nome o cognome... mai una denuncia sull'atteggiamento dei colossi cooperativi emiliani come la Cmc, la Ccc, Coopsette o Unieco che più volte hanno accettato la convivenza con le società delle cosche. Mai una parola sui grandi colossi privati, come la PIZZAROTTI, la gestione dell'Aeroporto di Bologna, le grandi colate di cemento lungo la via Emilia o gli appalti per le infrastrutture dove non mancano gli incendi dolosi ai mezzi di cantiere che non rispondono alle cosche. Solo qualche parola, ma non troppe sui Casalesi a Parma, dove governava il centrodestra. Reggio Emilia è una piccola Beirut, per anni, come il resto dell'Emilia-Romagna, presentata come indenne dalla presenza mafiosa, quando invece la “colonizzazione” si è consumata dopo che politica e settori imprenditoriali hanno aperto le porte alle mafie per riceverne i servizi a “basso costo” e per avere strada spianata alle cooperative nella partita TAV in Campania o, ancor prima, a Bagheria e nel grande ed oscuro patto con i Cavalieri dell'Apocalisse di Catania. A Firenze, Libera era legatissima all'amministrazione di Leonardo Domenici, quella finita nell'occhio del ciclone per gli episodi di corruzione nelle operazioni speculative di Salvatore Ligresti... quella del voto di scambio alle elezioni primarie con cui il Cioni cercava di assicurarsi il consenso. E mentre a Milano Libera accusava l'amministrazione di centrodestra che era in un perfetto connubio con Ligresti, a Firenze tace. Anzi, va oltre: la firma “Libera contro le mafie” siglava un volantino a sostegno del progetto devastante di tramvia dell'Impregilo nel centro fiorentino! Non un volantino contro lo scempio devastante della tramvia, così come nemmeno mai una parola contro il tunnel che dovrebbe sventrare Firenze per la TAV, così come nulla di nulla sulla devastazione del Mugello. Ecco Libera che tanto sostegno ha ricevuto da quell'amministrazione fiorentina, passo dopo passo, ha sempre ricambiato. Bastano come esempi o bisogna andare avanti con questa lista della non-indipendenza di Libera? Ripetiamo: basterebbe che dichiarassero di essere “di parte”, cosa legittima... e non dichiararsi per ciò che non sono: indipendenti...Ancora: in Calabria, per citare un caso e non annoiare, basta ricordare che il referente di Libera è andato ad un'iniziativa di presentazione della “Casa dello Stocco” promossa da Francesco D'AGOSTINO, già Consigliere provinciale dei “Riformisti”... Nella Piana sanno chi è questo imprenditore, Libera non lo sa? Impossibile. Lo si conosce anche in Liguria. Ad esempio il marchio “Stocco & Stocco” era in uso al boss Fortunato BARILARO, esponente apicale del “locale” della 'ndrangheta di Ventimiglia. Perché ci è andato? Non era meglio disertare tale “evento”? A Genova, in occasione delle ultime elezioni amministrative, buona parte di Libera locale si è visibilmente schierata, apertamente, a sostegno di Marco Doria, il candidato del centrosinistra. Scelta legittima, ma... Un giornalista free-lance ha posto una domanda a Marco Doria: “Può nominare qualche famiglia dell’ndrangheta che ha interessi a Genova?” e Doria ha risposto: “No, perché non ho studiato il problema. Se lo sapessi lo direi.”. Ecco: come possono gli esponenti locali di Libera sostenere un candidato che non ha studiato il problema, in una città dove da anni ed anni, ormai, i nomi e cognomi, le imprese ed i fatti sono pubblici, ampiamente noti? Se mi si dice che lo si sosteneva perché “politicamente” è della loro parte, va bene, ma lo si dica! Se mi si dice che invece no, perché sono indipendenti, e lo sostenevano perché con lui si può combattere le mafie, allora non ci siamo, non c'è onestà intellettuale... e non solo per l'intervista. Raccontiamo due fatti, abbastanza significativi, crediamo. Tra gli assessori scelti da Doria, per la delega ai Lavori Pubblici, c'è Gianni Crivello. Questi era il presidente del Municipio Valpolcevera, lo è stato per dieci anni. Quel territorio è quello maggiormente e storicamente, più colonizzato dalle mafie, Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Lì la presenza delle mafie è palpabile. Bene, Crivello per anni ha cercato, ed ancora cerca, di “minimizzare” la questione. Eppure sappiamo che negare e minimizzare sono due linee pericolosissime, devastanti negli effetti che producono. L'altro fatto che vi racconto è questo: tra gli sponsor di Doria vi è l'architetto Giontoni, responsabile dell'Abit-Coop Liguria, il colosso locale, nel settore edile, della Lega Coop Liguria. A parte il fatto che per una cessione alla Cooperativa “Primo Maggio” dell'Abit-Coop l'ex rimessa di Boccadasse dell'azienda per il trasporto pubblico locale (finalizzata alla realizzazione di appartamenti di lusso), l'ex sindaco Pericu ed altri sui uomini sono stati condannati pesantemente dalla Corte dei Conti per i danni alle casse pubbliche, l'Abit-Coop vede nel suo Consiglio di Amministrazione tal Raffa Fortunato. Questi per conto di Abit-Coop è stato nominato nei Cda delle aziende del gruppo Mario Valle... Raffa Fortunato è il cugino dei FOTIA, la famiglia della 'ndrangheta, riferimento nel savonese della cosca dei MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI. Non solo: in diversi cantieri dell'Abit-Coop sono stati incaricati di operare i FOTIA con la loro SCAVOTER (ora interdetta e per cui la DIA ha chiesto la confisca) ed i PELLEGRINO di Bordighera con la loro omonima impresa (sotto sequestro di nuovo per iniziativa della DIA). Doria è stato informato di questo. Risposte giunte? Nessuna!»
Ma da Genova non poteva “scattare” l'occasione delle svolta, dove Libera riaffermava la sua indipendenza...
«A Genova c'è stato e c'è il suggello della dipendenza piena di Libera al blocco politico-economico “rosso” ed asservita, in cambio di fondi e visibilità, agli amministratori peggiori che si possano trovare in circolazione. Altro che svolta... qui c'è stata e si conferma l'apoteosi dell'ipocrisia. Andiamo con ordine con 5 esempi di fatti:
1) Libera è nata in Liguria fondata da Legacoop, Unipol, Arci e qualche altro cespuglio. Tutto il fronte anti-cemento, impegnato da anni contro le attività di riciclaggio delle mafie nella grandi operazioni di speculazione edilizia, a partire dai porticcioli, e contro i condizionamenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli appalti, è stato messo alla porta già ai tempi della fondazione di Libera in Liguria. Noi ed altri. Abbiamo le carte, le abbiamo pubblicate. In una di queste dicono che bisogna stare attenti a noi che abbiamo un gruppo a Ceriale... e sì quel gruppo con cui siamo riusciti a far crollare l'impero del costruttore Andrea NUCERA che dopo un'interdizione antimafia per una sua impresa ed il sequestro che avevamo sollecitato del mega cantiere di Ceriale, è finito in bancarotta ed è latitante. Bella colpa vero?
2) Libera organizzò una fiaccolata antimafia a Sanremo. Chi invitò ad aderire? Quei partiti che hanno tenuto bel saldamente al proprio interno (difendendoli) i vari esponenti con pesanti contiguità e complicità con le cosche. C'era l'Udc di Monteleone, il Pdl degli Scajola, Praticò, Minasso e Saso... il Pd dei Drocchi, Burlando, Vincenzi, Bertaina... Rc degli Zunino... l'Idv della Damonte, Cosma e compagnia, SEL dell'assessore al patrimonio di Genova che dava la casa popolare al boss di Cosa Nostra... ma su questo torniamo dopo. In prima fila, a quella fiaccolata, c'erano i sindaci “antimafia” di Ventimiglia, Gaetano SCULLINO, e quello di Bordighera, Giovanni BOSIO. Quest'ultimo lo hanno anche fatto parlare come testimonianza di impegno per la legalità. Il fatto che le Amministrazioni di BOSIO e SCULLINO fossero piegate dai condizionamenti della 'ndrangheta era un dettaglio che è sfuggito a Libera. Ah naturalmente non ci mandarono nemmeno l'invito... forse sapevano che lo avremmo rimandato al mittente.
3) Libera a Genova ha visto mettersi a disposizione della Giunta comunale della VINCENZI, dopo l'arresto del suo braccio destro e portavoce Stefano FRANCESCA, nientemeno che il Presidente Onorario di Libera, Nando Dalla Chiesa. Quello che a Milano denuncia i silenzi, le contiguità e connivenze mafiose del centrodestra ma che a Genova ha perso la vista e non vede quelle pesantissime delle amministrazioni di centrosinistra... della VINCENZI, di BURLANDO come di REPETTO e di molteplici Comuni della Provincia e delle riviere. Lui è consulente e si occupa di organizzare dei bei convegni e delle rassegne antimafia, con manifesti colorati e tanti bei volantini patinati, ma non si accorge del boss ospitato in albergo dal Comune, degli incarichi con ribassi da brivido assegnati a soggetti attenzionati o addirittura interdetti, delle somme urgenze, appalti vari e agevolazioni date ai MAMONE nonostante l'interdizione atipica antimafia... non parliamo delle varianti urbanistiche promosse dalla Vincenzi (come sul caso Lido, che poi abbiamo contribuito a bloccare) o i rapporti con le imprese del gruppo imprenditoriale dei FOGLIANI di Taurianova... ivi compresa la concessione, poi annullata dal TAR per una clinica privata ad Albaro. Queste cose a Genova Nando non le nota... pare che soffra di una grave patologia di “strabismo”, così, da un lato, da il “patentino” antimafia alle amministrazioni, come quella di cui è consulente (prima pagato e dopo la nostra denuncia pubblica, gratuitamente, senza più le decine di migliaia di euro annui), promuovendo tante belle iniziative e dall'altro tace e “copre” le indecenze.
4) Vi è poi la pantomima con 6... dico SEI... inaugurazioni dei beni confiscati di Vico della Mele. So che la questione è stata anche oggetto di discussione durante la visita della Commissione Parlamentare Antimafia a Genova lo scorso anno. Ad ogni occasione elettorale il Comune di Genova, lo stesso che ospitava in albergo il boss a cui sono stati confiscati e che noi siamo riusciti, con una serie di iniziative pubbliche, a far sì che si sgomberasse, con Dalla Chiesa, faceva una bella inaugurazione... poi il bene tornava ad essere chiuso. Un segnale devastante dopo l'altro, in un territorio dove il controllo del territorio, come si è dimostrato con le nuove inchieste e procedimenti a carico dei CACI, CANFAROTTA e ZAPPONE, era saldamente in mano alla mafia. Qui il Comune, sotto la regia di Dalla Chiesa (lo ha scritto direttamente lui in una lettera di insulti a noi ed agli abitanti della Maddalena che avevano collaborato con noi alle indagini che hanno portato alla confisca di 5 milioni di beni ai CANFAROTTA), ha elaborato un bando in cui il vincitore era già scritto. Se dici che il bene lo dai a chi vende i prodotti di Libera Terra secondo voi chi può vincerlo? E poi perché una bottega in un posto del genere dove invece occorre attività che si dirami e bonifichi i vicoli tutti intorno? Un’attività di quel tipo non è socialmente utile lì... Avevamo proposto, insieme ad altri, un progetto di rete, in cui poteva starci anche Libera, ma senza “monopolio”, e che le attività fossero scelte insieme agli abitanti perché solo così si può coinvolgere la comunità e rendere evidente una risposta collettiva alle cosche, facendo riprendere alla comunità stessa quei beni. Ed invece no... lo hanno dato alla rete di Libera.»
Sì, ma promuovere i prodotti delle terre confiscate non è importante?
«Premettiamo una cosa: molti dei ragazzi che vi operano ci mettono l'anima, così come molti di coloro che credono che Libera sia una struttura che fa antimafia. Ma la realtà dei fatti è diversa. Il quadro che ci viene presentato è utile a Libera, che ha di fatto il monopolio della gestione dei beni confiscati riassegnati, ed alle Istituzioni che così si fanno belle sventolando questo dichiarato “utilizzo” dei beni confiscati. Ma questo quadro è un falso! Prima di tutto perché i beni confiscati che vengono riassegnati sono pochissimi. Sono briciole. Abbiamo pubblicato anche uno studio su questo, sulla normativa e sulla realtà. Uno studio mai smentito! Secondo perché ad un sistema clientelare, nelle regioni meridionali, si promuove un nuovo clientelismo nel nome dell'antimafia. Mi spiego: senza i contributi pubblici quelle cooperative che lavorano sui terreni confiscati non durerebbero un anno! La gestione di quelle cooperative è poi piegata dal clientelismo. Prendiamo le cooperative siciliane. Le principali sono coordinate da Gianluca Faraone, mentre suo fratello fa politica nel PD. E' quel Davide Faraone “scoperto” da Striscia la Notizia cercare di ottenere voti alle primarie di Palermo promettendo posti di lavoro nelle cooperative come contropartita. Questo avrebbe dovuto far sobbalzare sulla sedia chiunque… Invece silenzio... Come silenzio sulla recente convocazione da parte di una Procura siciliana di don Luigi Ciotti perché in una delle cooperative di Libera Terra è stato individuato un soggetto legato a Cosa Nostra. La questione è quindi: perché Libera deve avere il “monopolio” del riutilizzo dei beni confiscati? Dove sta scritto? E poi non ci si rende conto che questa situazione non aiuta a ridare credibilità e fiducia nelle istituzioni, nella concorrenza? Inoltre, è evidente che se una struttura gestisce, da sola, una quantità immane di beni confiscati, qualche falla poi si crea. Ed allora perché non perseguire il lavoro di “rete”, con più soggetti, che concorrono nella gestione dei beni confiscati? L'idea di azione di “rete” era proprio la base della prima ed originaria Libera. Poi vi è un'altra questione. Molte realtà locali di pubbliche amministrazioni usano le assegnazioni dei beni confiscati per farsi una nuova “facciata” e conquistarsi “credibilità”. In questi casi bisognerebbe valutare prima di accettare un bene assegnato. Bisognerebbe considerare se quell'amministrazione è davvero lineare, limpida oppure se ha ombre. Nel primo caso si collabora, nel secondo si declina. Noi l'abbiamo fatto a Terrasini. Ci si voleva usare come “paravento”, abbiamo chiesto all'allora Sindaco: o di qua o di là. Lui ha scelto l'amico che faceva da codazzo al boss Girolamo D'Anna e noi, quindi, abbiamo rinunciato all'assegnazione del bene confiscato. Non ci pare difficile o complesso.»
Ma anche qui si tratta di un caso, o comunque di casi isolati... le cooperative funzionano o no?
«Quelli che si sono citati sono alcuni esempi. I casi preoccupanti sono molteplici e, purtroppo, in aumento. Parte del grano veniva (non so se avvenga ancora) macinato in un mulino dei Riina? Ci è stato raccontato così da chi per anni ha lavorato alla Commissione Parlamentare Antimafia e vive a Palermo. Non è mai stato smentito. Oppure c'è la storia di un agriturismo dove, per il centro di ippoterapia, i cavalli e gli stallieri erano presi dal maneggio della famiglia mafiosa ben nota in quei territori? Li ha ripresi anche Telejato! Anche sul fatto del funzionamento delle cooperative poi vi è molto da dire. Già ricordavo che senza sovvenzioni pubbliche crollerebbero ed altro che riscatto per i giovani di quelle terre. Sarebbe una mazzata... Ma si può vivere di assistenzialismo eterno, promuovendo progetti che nel momento in cui dovessero mancare i fondi pubblici, crollerebbero inesorabilmente? Noi crediamo di no! Lo spirito della legge Rognoni-La Torre non era quello di sostituire al clientelismo democristiano e mafioso una sorta di clientelismo dell'antimafia! Ma entriamo più nello specifico delle cooperative. Pare che nessuno sappia, in questo Paese, fare due conti. Oppure li sanno fare ma ne tacciono i risultati. Prendete la pasta prodotta ed impacchettata nelle bustine della pasta biologica “Libera Terra”. Fate il conto di quanto grano sia necessario per produrre tale quantità di pasta, non più per i numeri originari di una cerchia ristretta di vendita ma sulla grande distribuzione. Scoprirete che buona parte del grano usato per produrre quella pasta non viene affatto dalla coltivazione dei terreni confiscati in concessione a Libera Terra. In quei terreni possono sorgere minime percentuali del grano necessario. E' un dato oggettivo, lampante... sotto gli occhi di tutti. Di “Libera Terra” ci sono quindi, nella grande maggioranza dei casi, in quei pacchi di pasta, solo le confezioni. Il grano viene comprato da terzi, non nasce dalla terra confiscata! Ci è stato riferito che addirittura nei primi anni 2000 giungevano comunicazioni alla Commissione Parlamentare Antimafia, in cui si evidenziava che parte del grano usato per produrre quella pasta veniva comprato in Ucraina! Sul vino o sui pomodori il discorso è lo stesso... In quei pochi ettari di terra confiscata assegnati alle cooperative di Libera Terra non si può materialmente produrre la quantità di prodotti necessari per il mercato. Anche qui di Libera c'è solo la confezione. Tutto si regge su un’illusione che pare nessuno voglia indicare e questo è grave! In ultimo, ma fondamentale, vi è un elemento che nessuno pare voglia vedere ma che, di nuovo, è preoccupante. E' il monopolio! Di fatto la gestione delle terre confiscate avviene in un regime di monopolio da parte delle cooperative di Libera. Ogni possibilità di concorrenza è cancellata. Questo, nuovamente, è nello spirito della Legge Rognoni-La Torre? Non ci pare. Così come non era nello spirito di quel milione di firme che la “prima” Libera ha raccolto per fa sì che quella norma per l'utilizzo sociale dei beni confiscati fosse approvata. Ed attenzione questo stato di monopolio impedisce, o quanto meno impedirebbe, che, ad esempio, in bandi pubblici si possa indicare come criterio l'utilizzo dei prodotti nati dalle terre confiscate. Ci sono pronunce di sentenze che annullano bandi per questa ragione. Perché non si vuole cambiare strada? Perché anziché “monopolizzare” non si promuove una libera concorrenza che sarebbe a vantaggio non solo della “forma” ma anche della sostanza, nel senso che si spingerebbe a costruire realtà che vivono davvero sulle proprie gambe, e non quindi nicchie clientelari.»
Ma perché tanta acredine verso Libera? Degli errori si possono fare. Avete provato a parlare con don Ciotti?
«Non c'è acredine, come abbiamo già detto se si indicano i problemi, i fatti che testimoniano i problemi, è perché si vuole contribuire a risolverli! Premettiamo che siamo convinti che chi è in buona fede, ed in Libera in tanti sono in buona fede, colga che il nostro non è un “attacco” o una “guerra”, come alcuni cercano di far passare per eludere i problemi che poniamo. Chi è in buona fede sa che non diciamo falsità e non compiamo forzature, ma ci limitiamo ad indicare questioni, fatti, che è interesse di tutti, ed in primis di Libera, affrontare e risolvere. Nella vita sociale, di una comunità, così come nella vita privata di ciascuno, se si vive sulle illusioni, nei sogni, vedendo l'irreale come reale perché ci fa stare meglio, facciamo danni. Aggiungiamo danni a quelli che già ci sono. E' come il medico pietoso o che “sbaglia” diagnosi perché è “ottimista” e perché non vuole guardare al peggio e tantomeno vuol dirlo al paziente. Darà una terapia sbagliata o comunque inefficace ed il paziente si aggrava e muore. Non è acredine. E' essere onesti e dire le cose come stanno. A noi farebbe molto meglio accodarci a Libera, entrare nella sua “rete” che tutto può avere, ma per farlo dovremmo rinunciare all'indipendenza ed al rigore di guardare sempre e comunque a 360 gradi, senza mai tacere le cose che devono essere dette e denunciate. E' indiscutibile poi che gli errori li si può commettere tutti. Ci mancherebbe... ma qui non sono errori se li si nega, se si esula dall'affrontarli e risolverli. Qui si è davanti ad una scelta precisa che conduce agli errori e che vive di “errori”... e don Luigi Ciotti non è solo consapevole di tutto questo, ma è il principale fulcro di questo sistema che rappresenta la degenerazione della Libera originaria. Anche perché, se lui volesse, queste questioni le si sarebbe già risolte! Gli errori si ammettono e si correggono. Quando si nega, quando si decide di querelare chi indica le cose che non funzionano, quando si prosegue lungo la strada sbagliata, che è evidente ad un bambino, quando è conclamato dai fatti che si è persa la direzione corretta, significa che siamo davanti ad una scelta consapevole, voluta e perseguita. Questo è l'aspetto che genera rabbia e che impone di non tacere! Noi abbiamo posto alcuni problemi, abbiamo indicato alcuni fatti, reali, tangibili, riscontrabili da chiunque li voglia vedere. Per risposta abbiamo avuto due comunicati ufficiali di Libera, uno della Presidenza ed uno di Nando Dalla Chiesa, in cui non si rispondeva ad una virgola di quanto da noi sollevato, ma si dichiarava che ci avrebbero querelati! Siamo noi o loro che hanno acredine, odio e che rifiutano il confronto sui fatti? Noi viviamo una sorta di “guerra fredda” mossaci da Libera. Noi, come gli altri che non hanno accettato di accodarsi al loro monopolio dell'antimafia. Serve una svolta per ritrovare l'unità del movimento antimafia, ammesso che questa ci sia mai stata effettivamente, al di là della facciata.»
Il vertice di Libera quindi le sa queste cose? Ad esempio quelle sulla Liguria...
«Sì, le sanno. Le sanno da sempre e fanno finta di nulla. Anzi più le sanno, perché i fatti emergono inequivocabili, più isolano noi, ad esempio, che abbiamo contribuito a farli emergere, dando avvio alle azioni giudiziarie, e più fanno da “paravento”. E per coprire quanto accaduto, mistificano la realtà, arrivano a mentire. Dalla Chiesa, ad esempio, disse che assolutamente non stava operando sui beni confiscati di Vico Mele, per poi smentirsi da solo! Incontrò noi e gli abitanti della Maddalena dove gli dicemmo, ad esempio, dell'albergo a CACI... poi un anno dopo fece quello che cadeva dal pero. Davide Mattiello, altro esempio. Lo incontrai a Torino, in un bar davanti alla stazione di Porta Susa. Gli dissi tutto su quelli che volevano fondare Libera in Liguria, gli “amici” del fronte del cemento. Gli mostrai le carte dell'inchiesta della Guardia di Finanza dove emergevano i rapporti illeciti e quelli inopportuni ed indecenti tra Gino MAMONE e gli esponenti politici del centrosinistra genovese, dalla Vincenzi a Burlando, a partire dalla partita viziata da corruzione per la variante urbanistica dell'area dell'ex Oleificio Gaslini. Mi disse che avrebbe provveduto... Sapete chi è stato il “garante” della costruzione di Libera in Liguria, per allestire il grande “paravento”? Proprio Davide Mattiello... Quando in diversi gli chiesero se avesse letto il libro-inchiesta “Il Partito del Cemento” dove vi erano nomi, cognomi e connessioni di quelli che stavano promuovendo Libera in Liguria, la sua risposta è sempre stata: no, non l'ho letto e non intendo leggerlo! Non è questione di “noi” e “loro”. Se Libera non funziona è un problema per tutti! Noi per anni, quando Libera non era ancora questo, abbiamo chiesto e spinto perché si fondasse Libera in Liguria. Era salito due volte a Genova per le riunioni da noi richieste anche Alfio Foti, che in allora per il nazionale di Libera si occupava di queste cose. Inizialmente l'Arci sosteneva che non vi era “necessità” di costruire Libera in Liguria. Poi, con la seconda riunione, fecero naufragare tutto. Noi eravamo affiliati a Libera. In Liguria eravamo solo noi ed il CSI, il Centro Sportivo Italiano. Per anni è stato così... Ma l'Arci continuava a gestire il “marchio” Libera, con la Carovana, escludendo sia noi sia il CSI. A noi rimproveravano di aver indicato i rapporti tra i MAMONE con Burlando e l'amministrazione Pericu del Comune di Genova. Ma erano fatti quelli che noi indicavamo che oggi sono confermati da risultanze molteplici di inchieste, da un’interdizione atipica per i MAMONE e da una condanna proprio di Gino MAMONE e di un ex consigliere comunale della Margherita, STRIANO, per corruzione in merito ad una variante urbanistica di un’area dei MAMONE.»
Ma perché secondo voi è così pericolosa la strada imboccata da Libera?
«La questione è semplice e parte dalla solita questione italica: illusione o concretezza. Il sogno non come speranza che si cerca di perseguire con atti quotidiani concreti, ma il sogno in cui ci si racchiude per stare meglio con se stessi. L'illusione è la cosa che i preti sanno vendere meglio, lo fanno da millenni, ed in mezzo a infinite contraddizioni o misteri riescono sempre a conquistarsi “anime” per atti di fede. Don Ciotti è un prete e questo fa. Ora ad esempio parla di “scomunica” ai mafiosi... bene, ma perché, realtà per realtà, né lui, né gli altri responsabili di Libera, non osano mai pronunciare un nome e cognome! Se si vuole scomunicare qualcuno questo qualcuno è in carne ed ossa, ha un volto, ha un nome... La mafia non è un ectoplasma. Poi sappiamo tutti che la lotta alla mafia è fatta anche di segnali. Se i segnali sono equivoci è un problema. Facciamo un altro esempio concreto. “Avviso Pubblico” è una struttura nata da Libera che raccoglie gli Enti Locali e le Regioni. Una struttura in cui i Comuni, le Province e le Regioni possono aderire, previo versamento di una quota annuale. Ma non c'è verifica, non ci sono discriminanti per l'adesione. Prendiamo la Regione Liguria che recentemente ha aderito ad Avviso Pubblico. Qui si ha un presidente della Regione, Burlando, che era amico dei MAMONE, che frequentava e da cui ha preso sovvenzioni attraverso l'associazione Maestrale, che aveva tra i propri supporter alle ultime elezioni liste che avevano uomini legati alla 'ndrangheta tra le proprie fila. Abbiamo un presidente del Consiglio Regionale che nel 2005 incassò i voti della 'ndrangheta, poi un pacchetto di tessere sempre da questi per vincere il congresso, poi li ricercò ancora per le elezioni del 2010, proponendo al capo locale di Genova, GANGEMI, una bella spaghettata, e che, in ultimo, ha festeggiato la rielezione nel ristorante del boss di Cosa Nostra Gianni CALVO. Abbiamo poi un consigliere regionale, Alessio Saso, indagato per il patto politico-elettorale con la 'ndrangheta alle elezioni del 2010. Davanti a questo panorama Avviso Pubblico, crediamo, avrebbe dovuto dire: Cara Regione Liguria, prima ripulisci il tuo palazzo da questi soggetti e poi la tua domanda di adesione sarà accolta. Invece no, accolta subito, con questo bel quadretto. E così Libera che, per la manifestazione del marzo scorso, incassa dalla Regione quarantamila euro di contributo e poi si presenta con don Ciotti al fianco di Burlando e lo ringrazia per quello che fa nella lotta alla mafia.»
In che senso “grande illusione”?
«Antonino Caponnetto ha indicato la strada maestra della lotta alle mafie: rifiutare la logica del favore, indicare i mafiosi perché questi temono più l'attenzione dell'ergastolo! Paolo Borsellino ha spiegato, credo meglio di ogni altro, che la lotta alla mafia è una questione civile e culturale, perché la sola azione giudiziaria non è sufficiente per sconfiggere le mafie. E ci diceva che bisogna mettere in un angolo i politici compromessi, anche per sole semplici frequentazioni indegne, e pur se non esistono rilievi penali. Ci diceva che occorre negare il consenso alle cosche perché gli si fa venir meno la capacità di condizionamento. Giovanni Falcone invece ha reso evidente già allora che la mafia non è coppola, lupara e omicidi, ma è affari. Ci ha spiegato che tutte le attività più cruente e prettamente “criminali” (droga, estorsione, prostituzione...) servono alle organizzazioni mafiose per avere quei capitali illeciti da riciclare facendosi impresa, finanza, politica. Ci spiegava che è lì, seguendo i soldi, che si può colpire l'interesse mafioso. Ed allora perché Libera questo non lo fa? E perché cerca, in un reciproco scambio di favore con la politica, di monopolizzare la lotta alla mafia a livello sociale come se ci fossero solo loro? Libera ha il vantaggio di rafforzarsi e incassare, la politica ha un ritorno perché usa Libera come paravento per coprire le proprie indecenze. Ci si può dire: ma sono solo modi diversi di perseguire lo stesso obiettivo, cioè sconfiggere le mafie. Non ci pare così... Le iniziative “mediatiche”, il merchandising che diventa la principale attività, le illusioni di combattere le mafie con spaghettate, cene o pranzi, il parlare di una mafia ectoplasma e non della concreta e palpabile rete mafiosa, di contiguità, connivenze e complicità, fatta di soggetti ben precisi, con nomi e cognomi, non è lotta alla mafia... al massimo possiamo considerarla una “buona azione”, come il fare l'elemosina davanti alla chiesa al povero cristo di turno... Non risolve il problema, ci convive! Libera parla sempre dei morti... ci dice che bisogna ricordare i morti, vittime della mafia. Giusto e come si fa a non condividere il dovere della Memoria? Ma dei vivi? Dei vivi non si parla mai... le vittime vive delle mafie sono ben più numerose delle già tante, troppo, vittime morte ammazzate. Di queste Libera si dimentica... Non è un caso se fu proprio don Luigi Ciotti a chiedere che venisse previsto anche per i mafiosi l'istituto della “dissociazione”, cioè ti penti, ti dichiari dissociato ma non confessi nulla, non racconti nulla di ciò che conosci dell'organizzazione. E' chiaro che se mai fosse stata accolta questa proposta, di collaboratori di giustizia non ne avremmo più. Se per avere gli stessi benefici basta dissociarsi, senza rompere l'omertà e denunciare i sodali e i segreti dell'organizzazione, quale mafioso rischierebbe la propria vita e quella dei suoi familiari per collaborare? Nessuno e lo strumento essenziale dei Collaboratori svanirebbe.»
Ma l'azione di Libera arriva a molte persone, alla massa. Le vostre iniziative se pur incisive nell'azione di contrasto civile e, nel vostro caso, anche giudiziario, alle organizzazioni mafiose, le conoscono in pochi.
«Questo è un problema che non dipende da noi. Dipende da ciò che dicevamo prima: Libera è utile alla politica ed alle imprese perché gli fa da “paravento”, nascondendo le loro pratiche indecenti. E' ovvio che Libera in cambio ha qualcosa da questo: visibilità mediatica, grandi riconoscimenti, finanziamenti e strumenti per promuoversi. Noi diamo l'orticaria a 360 gradi con la nostra indipendenza. E quindi la risposta è evidente: l'isolamento! E qui Libera gioca di nuovo un ruolo servile verso il Potere, verso quel potere compromesso, si presenta come unica realtà “credibile” ed oscura chi non è gradito e non accetta di piegarsi alla loro stessa logica. Le operazioni mediatiche non servono a colpire le mafie. Pensate alla grande campagna mediatica dell'ex Ministro Maroni. Ogni giorno sfruttava gli arresti di mafiosi fatti da magistrati e forze dell'ordine per dire che stavano sconfiggendo la mafia. Hanno costruito una campagna mediatica per cui “l'arresto” sconfigge la mafia. Una falsità assoluta... tanto è vero che le mafie sono ancora ben forti e radicate sul territorio, con sempre maggiore capacità di condizionare il voto, e quindi le Amministrazioni Pubbliche, anche al Nord. Ed allora: è servita questa campagna mediatica sulla vulnerabilità dei mafiosi per scalfire il loro potere? No. Facciamo alcuni esempi...Trovate un amministratore pubblico in Italia che abbia speso quanto ha investito Totò Cuffaro in manifesti di ogni dimensione, tappezzando un'intera regione, la Sicilia, con lo slogan “la mafia fa schifo”. Non esiste. Cuffaro ha speso più di ogni altro politico italiano in un’azione mediatica su larga scala. Noi però sappiamo chi era quel Cuffaro. Un fiancheggiatore degli interessi mafiosi. Cosa ci dice questo? Semplice: le azioni mediatiche la mafia non le teme, anzi le vanno pure bene, perché le permettono una più efficace azione di mimetizzazione. Altro esempio. Francesco Campanella, uomo che agevolò la latitanza di Provenzano. Questi ebbe un'idea e la propose a Provenzano che l'accolse con grande entusiasmo. L'idea era semplice: promuovere direttamente manifestazioni antimafia. Chiaro? Ed ancora: dove facevano le riunioni gli 'ndranghetisti di Lombardia per eleggere il loro “capo”? Nel “Centro Falcone e Borsellino”! Si vuole o no capire che i mafiosi sono i primi che hanno l'interesse di “mascherarsi” e presentarsi pubblicamente come attori dell'antimafia? Devono farlo i sindaci e gli eletti che hanno stretto un patto con la mafia, così come devono farlo gli affiliati che hanno un ruolo pubblico o comunque una visibilità pubblica. Gli serve per insabbiarsi! La linea “ecumenica” di Libera lascia troppe porte aperte a queste “maschere”... E' pericoloso! E' un insulto alla buona fede dei tanti che in Libera lavorano seriamente e che da questo vedono, in determinati territori, il proprio lavoro screditato. Quelle porte devono essere sbarrate! Se una persona vive su un territorio sa chi sono i mafiosi. E se alla manifestazione antimafia tu vedi che tra i promotori ci sono i mafiosi, il segnale è devastante! Per semplificare: se tu sai che il responsabile degli edili di un grande sindacato va a braccetto con il capobastone che organizza, con la sua rete, il caporalato o le infiltrazioni nei cantieri edili con le ditte di ponteggi e le forniture, e poi vedi questo sindacalista che promuove le manifestazioni antimafia, magari con Libera... magari dicendoti “venite da me a denunciare”, è evidente che nessuno mai si rivolgerà a lui, al sindacato. Quale lavoratore in nero andrà mai a denunciare da lui? Nessuno. Ecco fatto che senza intimidazione, senza alcun gesto eclatante si sono garantiti la pax.»
Ma allora Libera...
«Libera dovrebbe tornare ad essere Libera “di fatto” oltre che di nome. Oggi non lo è. E questo è un danno per tutti. E' un problema per tutti. Noi vogliamo che Libera torni quello che era all'origine. Anche qui un esempio molto tangibile. Il presidente della Casa della Legalità è una persona a rischio, per le denunce che abbiamo fatto e l'azione di informazione mirata a colpire la mafia che si è fatta impresa, la rete di professionisti asserviti, la mafia nella politica. E', come si dice in gergo, un “obiettivo sensibile”... e lo è perché in questi anni soprattutto in Liguria, ma anche in altre realtà, come Casa della Legalità siamo stati soli ad indicare nome per nome, i mafiosi, i professionisti e le imprese della cosiddetta “zona grigia”, la rete di complicità e contiguità con la politica, le forze dell'ordine e persino nella magistratura. Abbiamo ottenuto risultati con lo scioglimento delle Amministrazioni nel Ponente Ligure, così come con le verifiche in corso su altri Comuni. Abbiamo squarciato l'omertà e spinto ad adottare provvedimenti quali interdizioni a “colossi” delle imprese mafiose. Si è contributo a far emergere i patrimoni illeciti che sono stati aggrediti con sequestri e confische... Con un lavoro difficile, senza soldi, a volte neppure per un bicchiere d'acqua. Si è piano piano conquistata la fiducia di persone che poteva parlare e li si è messi in contatto con i reparti investigativi. In alcuni casi hanno verbalizzato, in altri non vi è stato nemmeno bisogno che si esponessero in questo. Ecco questo le mafie non ce lo perdonano, così come non ce lo perdonano i politici che nel rapporto con le cosche avevano costruito un pezzo determinante del loro consenso elettorale. Se non fossimo stati soli, ma Libera avesse fatto qualcosa, oggi non sarei probabilmente identificato dalle cosche come “il problema” da eliminare. Ed invece no, sapendo la realtà ligure, perché la si conosce e la conoscono anche quelli di Libera, hanno scelto di lasciarci soli e di fare da paravento alla politica ed a quelle imprese che la porta alle mafie, in questo territorio, la spalancarono ed ancora la tengono ben aperta. Non vorremmo che si pensasse che queste cose siano questioni “astratte” o ancor peggio “personali”. Ed allora è meglio che, oltre a quanto ho già raccontato, vi faccia un altro esempio concreto. Alcune mesi fa è finalmente emerso quanto dicevamo da anni: Burlando sapeva che nella sua rete di consensi nel ponente ligure vi erano soggetti legati alla 'ndrangheta, della 'ndrangheta. Denunciamo questo con tutti i dettagli del caso. Quello che è emerso è che il “collettore” era l'ex sindaco di Camporosso, Marco Bertaina. Questi con la sua lista civica alle provinciali di Imperia ha candidato due 'ndranghetisti: MOIO e CASTELLANA. Burlando appoggiò quella lista civica che a sua volta appoggiava Burlando quale candidato alla Presidenza della Regione Liguria. E chi è BERTAINA? E' l'attuale vice-sindaco di Camporosso, dopo due anni di mandato come sindaco e diversi come assessore negli anni Novanta... ed è soprattutto quello che ha promosso un progetto di “educazione alla legalità” proprio con Libera. Dopo le rivelazioni su questo asse BERTAINA-MOIO-CASTELLANA-BURLANDO cosa fa Libera? Organizza un convegno con il Comune di Camporosso dove porta direttamente Gian Carlo Caselli! E' chiaro che il segnale, su quel territorio, a quella comunità, è devastante? Noi crediamo di sì e Libera ne ha tutte le responsabilità!»
Non siete stati alla manifestazione della “Giornata della Memoria e dell'Impegno” che vi è stata a Genova, quindi...
«No, come Casa della Legalità non ci siamo andati. Ci è dispiaciuto di non poter “abbracciare” i parenti delle vittime che hanno sfilato. Ci è dispiaciuto per quelli che in buona fede ci credono... Ma noi non ci prestiamo a fare da “paravento” in cambio di fondi, soldi o visibilità. La lotta alla mafia è una cosa seria e le vittime dovrebbero essere rispettate e non usate. No, non ci siamo andati alla “Giornata della Memoria corta e dell'ipocrisia”... Ma abbiamo una speranza: che le persone che in buona fede credono in Libera la facciano tornare Libera nei fatti. Se queste persone riusciranno a laicizzare e decolonizzare Libera sarebbe importante per tutti. Non credo ci possano riuscire... perché, come dicevo: un'illusione fa vivere meglio... la realtà è più problematica ed in questa ci si deve assumere delle responsabilità concrete, non a parole! Ma la speranza c'è, altrimenti queste cose non le direi, se fossi convinto al 100% che nulla possa cambiare. Dico di più. Per noi della Casa della Legalità, che convenienza c'è ad uno “scontro” con Libera? Nessuno. Loro sono, si potrebbe dire, un “potere forte”, per la rete che hanno e che abbiamo cercato di rendere evidente con i fatti enunciati. E se diciamo queste cose, se indichiamo, ripeto, fatti e non opinioni, è perché vorremmo che chi è in buona fede e crede in Libera, la faccia rinascere, eliminando quelle storture, tutte quelle situazioni problematiche. Le critiche che poniamo sono reali, chiediamo di riflettere su queste. Sappiamo già che qualcuno, quelli non in buona fede, per intenderci, cercheranno di rispondere ignorando tutto quanto si è detto, oppure scatenando una guerra aperta, non più sottotraccia alla Casa della Legalità. Punteranno, in estrema sintesi, ad unire il proprio fronte contro il “nemico” esterno... un'altra delle pratiche italiche che tanti danni hanno fatto. Sappiamo di questo rischio, ma dobbiamo rischiare se vogliamo che quel briciolo di speranza che dicevamo, possa avere una possibilità di concretizzarsi in un cambiamento reale. Non siamo dei pazzi suicidi. Diciamo le cose come stanno, guardando ai fatti, perché si rifletta e si affronti la realtà per quello che è e quindi perché si possa agire per “correggerla”.»
Ma siete gli unici a dire queste cose?
«Assolutamente no. Forse siamo gli unici che riescono in qualche modo a bucare la cappa di omertà che vi è su questa vicenda di Libera. Come dicevamo prima siamo davanti ad un “santuario”. Si parla tanto di “poteri forti”, ma questi non sono solo mica quelli della “politica”, ci sono anche nel “sociale”, nella cosiddetta società civile. E' difficile trovare chi è disposto a subire una reazione spietata per il solo fatto di aver indicato dei fatti che sono ritenuti “indicibili” anche se veri. Chi ha rotto con l'associazione di don Luigi Ciotti perché non ha avuto timore di vedere la realtà e di dirla, sono in molti. Partiamo da un giornalista scrittore calabrese, costretto, nell'isolamento, ad una sorta di perenne esilio dalla sua terra, Francesco Saverio Alessio. Potete poi chiedere a Umberto Santino, del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, anche lui le cose le dice senza reticenze...Il problema è che nessuno domanda a chi risponde senza ipocrisie, perché se si da voce a chi guarda e parla della realtà, dei fatti, allora l'illusione in cui ci vorrebbero far vivere ed operare, svanisce.»
Ma proprio nulla va in Libera, pare impossibile...
«Sarebbe ingiusto dire che tutto non va. Diciamo che l'impostazione assunta da alcuni anni a questa parte è altamente preoccupante, come abbiamo visto dai fatti. Poi non bisogna mai generalizzare. Ci sono realtà locali che operano bene, che fanno cose importanti e lavorano seriamente. Ci sono attività di formazione che vengono promosse da Libera che rappresentano un contributo importante nella sensibilizzazione. Alcune di queste in particolare, altre invece sono una sorta di promozione di una “educazione alla legalità” slegata dal territorio, dalla concretezza, diciamo ecumeniche e non laiche. Dire che da una parta c'è il bene e dall'altra il male, senza dare esempio tangibile, riconoscibile sui territori dove si promuove quell'attività, rischia di non incidere. Ecco qui vi è una diversa visione... loro promuovono questa attività in modo meno “laico”, noi cerchiamo invece di far vedere la realtà dei fatti, partendo da dove vivono quei ragazzi che si incontrano e far scattare in loro quella capacità critica che gli permette di arrivare loro a concludere ciò che è giusto e ciò che invece è sbagliato, quale sia il bene e quale invece il male.»
Ma perché, visto che vi sta a cuore Libera, non vi confrontate con Libera?
«Anche qui la domanda è da rivolgere a loro. Noi non abbiamo mai avuto e non abbiamo problema alcuno a confrontarci su questo e su altre cose con Libera e con chiunque altro. E' proprio Libera che sfugge al confronto... che ci ignora totalmente e cerca di isolarci, di “cancellarci”. Ma anche qui ci sono degli esempi concreti. Andiamo con ordine...A Bologna un’associazione che fa parte di Libera aveva organizzato un incontro di presentazione del libro “Tra la via Emilia e il Clan”, invitando gli autori, Abbondanza ed Amorosi, ed il Procuratore Capo di Bologna. Poi dal Nazionale di Libera arriva il veto: non ci può essere Abbondanza! Viene comunicato che l'iniziativa è quindi rinviata! A Genova, nessun invito formale, nemmeno semplicemente per partecipare come pubblico, ci è stato mai mandato per le iniziative organizzate in preparazione della manifestazione del marzo scorso...Ma vi è di più. Quando il Consiglio dei Ministri approva lo scioglimento della Giunta e Consiglio Comunale di Ventimiglia (a seguito dell'istruttoria seguita alla nostra denuncia), ed il Presidente della Repubblica firma il Decreto di Scioglimento, il referente regionale di Libera, Lupi (che è di Imperia) cosa dichiara? Che è “rammaricato” per l'esito dello scioglimento! Non una parola sulle minacce ed intimidazioni che ci sono giunte e per la situazione di pericolo che ha portato la Prefettura di Genova ad adottare a tutela del presidente della Casa della Legalità le misure di protezione. Silenzio ed isolamento, come se non esistessi, come se non esistessimo...Per il 23 maggio l'Istituto degli Emiliani a Genova ci ha invitato per ricordare Falcone e per far capire che la mafia c'è ancora, che è concreta, che è qui al Nord... Lo scorso anno c'era anche Libera, quest'anno non si è presentata. Hanno pubblicato due rapporti, redatti da loro, uno sulla Liguria ed uno sull'Emilia-Romagna, in nessuno dei due casi appare neppure mezza delle risultanze di indagini che abbiamo contribuito a raggiungere. Non una citazione… fatti ed atti cancellati. Sull'Emilia-Romagna abbiamo anche pubblicato un “atlante”, il libro “Tra la via Emilia e il Clan”, dove si è messo in evidenza, atto dopo atto, che quella regione, quell'economia, non è affatto esente dalla presenza e dalle attività delle mafie. Un libro che non ha avuto neanche mezza contestazione, nessuna smentita e nessuna querela (un anomalo miracolo, si potrebbe dire). Bene, per Libera non esiste...Se non sei dei loro non esisti e non devi esistere! Poi questa ultima storia di Sarzana, evidenzia un nuovo eclatante esempio. Tempo fa ci contatta l'ANPI di Sarzana per sapere a chi potevano assegnare l'onorificenza civica "XXI luglio 1921". Ci dicono che, essendo il ventennale delle stragi del 1992, volevano assegnarla ad un soggetto che abbia operato ed operi nella lotta alle mafie. Non abbiamo dubbi e proponiamo la DIA di Genova. La proposta viene poi accolta. Il Sindaco di Sarzana contatta il presidente della Casa della Legalità, e gli comunica ufficialmente l'accoglimento della proposta, gli chiede se poteva essere presente per un intervento nella tavola rotonda del 20 luglio in cui verrà consegnata l'onorificenza. Gli risponde di sì. Il giorno seguente Abbondanza viene contattato dalla segreteria del Sindaco per avere conferma del suo intervento, dovendo procedere per la stampa degli inviti. Gli viene data conferma. L'altro ieri ci è arrivato l'invito. Non ci siamo più, l'intervento di Abbondanza è svanito. C'è Libera. Ora, premesso che la cosa importante, significativa, è il riconoscimento alla DIA che compie un lavoro straordinario ma viene “tagliata” continuamente nelle risorse a propria disposizione, spesso resta inascoltata anche da magistrati e istituzioni ciechi. Come abbiamo detto anche al Sindaco che si è scusato ed ha fatto inoltrare anche una nota di scuse ufficiali (tra l'altro nel comunicato stampa questo passaggio è svanito, chissà perché?!), è che spunta Libera, espressione e “paravento” di quel blocco politico-economico che corrisponde a quello dell'amministrazione del Comune di Sarzana, e noi spariamo dagli interventi. Il Sindaco dice che Libera è attiva nello spezzino. A parte il fatto che anche noi lo siamo da tempo, ci piacerebbe sapere dove è Libera nella lotta contro le speculazioni edilizie che hanno devastato quel territorio, contro il progetto della grande colata di cemento alla Marinella, nato tra l'avvocato Giorgio Giorgi, uomo di Burlando, Monte dei Paschi di Siena e cooperative rosse? Dove erano nel contrasto alla cricca del “faraone” delle Cinque Terre, che era “pappa e ciccia” con Legambiente, altro grande “paravento” del PD, legatissima a Libera? Il Sindaco risponde ad Abbondanza: hanno proposto la Consulta per la Legalità e l'abbiamo approvata, una struttura indipendente, con Libera, i sindacati ecc. ecc... Ma come, Sindaco, se ci sono Libera ed i Sindacati, dove è “indipendente” questa consulta? Se i Sindacati, a partire da quelli edili, iniziassero a fare il loro lavoro e denunciassero le infiltrazioni nei cantieri, il caporalato, la lotta all'illegalità ed alle mafie farebbe passi da gigante, ed invece tacciono, coprono. La stessa cosa che avviene con le aziende agricole... ricordiamo la Rosarno, dove tutti sapevano, i sindacati in primis, chi sfruttava come schiavi quegli immigrati, e non osavano denunciarne nemmeno mezzo, mai un nome, ma solo parate, fiaccolate, convegni. Noi ad un confronto siamo sempre disponibili, ma come lo possiamo avere se sfuggono come anguille ad ogni possibilità di confronto e se quando vi sarebbero occasioni di intervenire, entrambi, se non saltano le iniziative, come nel caso di Bologna, fanno saltare la nostra presenza o non si presentano loro?»
Cosa vi aspettate dopo questa pubblicazione?
«Vorremmo dire un confronto. Questo è quello che auspichiamo. Pensiamo che invece avremo da un lato un “muro di gomma”, ovvero il tentativo di tenere tutto questo nel silenzio, come se non esistesse, dall'altro lato invece subiremo un attacco feroce, spietato. Crediamo che valga la pena, proprio per quel briciolo di speranza riposto nelle tante persone in buona fede... Tacere ancora tutto questo significherebbe perdere quella speranza di cambiamento necessario, perché ripetiamo: Libera è una struttura importante e se torna alle origini ne abbiamo tutti un vantaggio! Non vogliamo una “guerra” con Libera, vogliamo dare un contributo, anche se attraverso una critica senza veli sui fatti, perché si possa migliorare. Noi non vogliamo la fine di Libera, vogliamo la sua rinascita.... e chi è in buona fede lo capisce, non può non capirlo.»
ITALIA: PAESE ZOPPO.
Roberto Gervaso: terapie per un Paese zoppo. Il nuovo libro racconta l’ultimo secolo dell’Italia. Senza sconti a Grillo, Berlusconi, Renzi, Napolitano...La lezione è quella, come lo stesso Roberto Gervaso racconta a Stefania Vitulli di “Panorama”, appresa da Montanelli, Prezzolini, Buzzati, Longanesi. E quanto questa lezione sia ancora inedita e scomoda nell’Italia contemporanea lo dimostra il suo nuovo libro, Lo stivale zoppo. Una storia d’Italia irriverente dal fascismo a oggi. Nella lista dei nomi che ritroviamo alla fine del volume non manca nessuno: Abu Abbas, Agnelli e Alberto da Giussano aprono un elenco alfabetico che si conclude con Zaccagnini, Zeman e Zingaretti. Nel mezzo, l’ultimo secolo di storia di un Paese a cui Gervaso non risparmia ricostruzioni accurate dei fatti e verità dure da accettare.
Che cosa c’è di nuovo in questo libro?
«Le cose che ho sempre detto. Solo che ora le dico con furia. Perché, se non si fa una diagnosi spietata, l’Italia non avrà mai né terapia né prognosi.»
Filo conduttore?
«La storia di un Paese senza carattere, che sta ancora in piedi perché non sa da che parte cadere.»
Si parte dalla Conferenza di Versailles...
«Sì, perché l’Ottocento finisce nel 1919, e quell’anno getta il seme dei fascismi. Suggellò la Prima guerra mondiale, caddero quattro imperi, nacquero le grandi dittature e l’America soppiantò l’Europa nella leadership mondiale.»
E l’Italia?
«Ha vinto una guerra nelle trincee e sulla carta ma l’ha perduta in diplomazia, società, economia. Era divisa fra le squadracce nere all’olio di ricino e quelle rosse che volevano imporre i soviet. Partiti dilanianti e latitanti, i poteri forti scelsero i fasci nell’illusione di addomesticare Benito Mussolini.»
Che si affacciò al balcone...
«Tutto era a pezzi, tutto in vendita. Oggi la situazione non è certo migliore del 1922.»
Partiti dilanianti e latitanti?
«Non hanno mai litigato tanto. La sinistra è un’insalata russa senza maionese, la destra una macedonia di frutta con troppo maraschino giudiziario. Il Paese è a un bivio: il balcone o la colonia.»
Sarebbe a dire?
«O qualcuno si leva dalla folla interpretando l’incazzatura della gente, si affaccia al balcone e dichiara: «Il carnevale è finito», oppure diventiamo una colonia delle grandi potenze europee o di quelle emergenti, come la Cina. La moda italiana, tranne pochi del nostro Paese, si divide tra François Pinault e Bernard Arnault; l’alimentare è in mano ai francesi, la meccanica è dei tedeschi, gli alberghi diventano spagnoli...»
E gli italiani non se ne accorgono?
«Abbiamo un’ancestrale vocazione al servaggio. Gli italiani se ne infischiano della libertà, le hanno sempre anteposto il benessere. L’uguaglianza non esiste: è l’utopia dell’invidia.»
Ma che cosa ci deve capitare di ancora più grave?
«L’Italia ha sempre dato il meglio di sé in ginocchio, con le spalle al muro, l’acqua alla gola e gli occhi pieni di lacrime. Nell’emergenza risorgeremo.»
Come si chiama questa malattia?
«Mancanza di senso dello stato. Al massimo abbiamo il senso del campanile. L’italiano non crede in Dio ma in San Gennaro, Sant’Antonio, San Cirillo. A condizione che il miracolo non lo faccia agli altri ma a se stesso.»
La cura?
«Utopistica: che ognuno faccia il proprio dovere e magari sacrifici. Che devono cominciare dall’alto.»
E parliamo di chi sta in alto. Mario Monti?
«Un economista teorico, un apprendista politico che ha fatto un passo falso e fatale. Si fosse dimesso alla scadenza del mandato, sarebbe al Quirinale. Deve cambiare mestiere: la politica non è affar suo e temo che non lo sia nemmeno l’economia.»
Beppe Grillo?
«Un Masaniello senza competenza politica, collettore dei voti di protesta. Se si instaurasse una seria democrazia, sparirebbero i grillini, che vogliono la riforma della Costituzione senza averla letta.»
Enrico Letta?
«Un giovane vecchio democristiano, serio e competente, ma senza quel quid che fa di un politico un leader o uno statista, cosa che, fra l’altro, non ha mai preteso. Un buon governante.»
Matteo Renzi?
«Un pallone gonfiato sottovuoto spinto. Un puffo al Plasmon che recita una parte che vorrebbe incarnare ma non è la sua. Se lo si guarda bene quando parla e si muove, si vede che non c’è niente di spontaneo. Ha una virtù: il coraggio. Più teorico che pragmatico, però, perché oggi va a braccetto con Walter Veltroni. Non è un rottamatore, è un illusionista.»
Veltroni?
«Un perdente di successo, ormai attempato e fuori dai tempi. Che ha cercato di conciliare Kennedy e Che Guevara.»
Pier Luigi Bersani?
«Un paesano. Un contadino abbonato a Frate Indovino, che parla per proverbi.»
Massimo D’Alema?
«Un uomo di grandi intuizioni. Tutte sbagliate.»
Silvio Berlusconi?
«Un grande leader d’opposizione. Che sa vincere le elezioni e ama il potere. Ma non la politica.»
Giorgio Napolitano?
«Ottimo presidente della Repubblica. Che conserva una foto dei carri armati che invasero l’Ungheria nel ’56. La tiene in cassaforte e la mostra solo ai compagni.»
Cultura a sinistra, Paese a destra Una «strana» Italia divisa in due. Il vizio d'origine? Un'agenda politica, dettata da un antifascismo non sempre democratico, che trova riscontro solo nelle élite, scrive Roberto Chiarini su “Il Giornale”. Pubblichiamo qui uno stralcio della Premessa del nuovo saggio dello storico Roberto Chiarini Alle origini di una strana Repubblica. Perché la cultura politica è di sinistra e il Paese è di destra. Un libro che spiega i mali che affliggono l'Italia, risalendo alla formazione della democrazia a partire dalla caduta del fascismo. I tratti originari della nostra Repubblica hanno reso operante la democrazia ma, alla distanza, l'hanno anche anchilosata. L'antifascismo ha comportato l'operatività di una precisa sanzione costrittiva del gioco democratico, sanzione controbilanciata presto sul fronte opposto da una opposta e simmetrica, l'anticomunismo. Destra e sinistra si sono trovate in tal modo, invece che protagoniste - come altrove è «normale» - della dialettica democratica, solo comprimarie, stabilmente impedite da una pesante delegittimazione ad avanzare una candidatura in proprio per la guida del paese. Da ultimo, la configurazione di un «paese legale» connotato da una pregiudiziale antifascista e di un «paese reale» animato da un prevalente orientamento anticomunista ha comportato una palese, stridente assimetria tra una società politica orientata a sinistra in termini sia di specifico peso elettorale che di obiettivi proposti e un'opinione pubblica molto larga - una maggioranza silenziosa? - per nulla disposta a permettere svolte politiche di segno progressista. L'emersione nel 1994, grazie al passaggio a un sistema tendenzialmente bipolare, della «destra occulta» rimasta per un cinquantennio senza rappresentanza politica diretta ha risolto solo a metà il problema. È rimasta l'impossibilità per una forza politica mantenuta - e tenutasi - nel ghetto per mezzo secolo di esprimere di colpo una cultura, un disegno strategico, una classe dirigente all'altezza del ruolo di comprimaria della sinistra. Al deficit di maturità democratica ha aggiunto, peraltro, un'inclinazione a secondare posizioni vuoi etno-regionaliste (se non dichiaratamente separatiste) inconciliabili con l'ambizione di costruire una forza politica di respiro nazionale, vuoi populistico-plebiscitarie in aperta dissonanza con la destra liberale europea. Tutto ciò ha offerto il destro - e l'alibi - alla sinistra per persistere in una battaglia di demonizzazione dell'avversario, contribuendo in tal modo a rinviare una piena rigenerazione di questa «strana democrazia», normale a parole ma ancora in larga parte prigioniera di comportamenti ispirati alla delegittimazione del nemico. A pagarne le conseguenze continuano a essere non solo destra e sinistra, ma anche le istituzioni democratiche, ingessate come sono in un confronto polarizzato che ha finito con il comprometterne la capacità operativa, soprattutto sul fronte delle importanti riforme di cui il Paese ha un disperato bisogno. Il risultato è stato di erodere pesantemente la credibilità e persino la rappresentatività delle stesse forze politiche. Lo scontento e la disaffezione insorti per reazione non potevano non ridare nuova linfa a una disposizione stabilmente coltivata dall'opinione pubblica italiana, conformata a un radicato pregiudizio sfavorevole alla politica. Una disposizione che ha accompagnato come un fiume carsico l'intera vicenda politica repubblicana sin dal suo avvio, tanto da rendere «il qualunquismo (...) maggioritario nell'Italia repubblicana, sia presso il ceto intellettuale che presso l'opinione pubblica» (Sergio Luzzatto). Una sorta di controcanto, spesso soffocato, al predominio incontrastato dei partiti. S'è detto che la funzione dei partiti è cambiata nel tempo divenendo da maieutica a invalidante della democrazia, da leva per una politicizzazione della società a strumento di occupazione dello Stato e, per questa via, a stimolo dell'antipolitica così come la loro rappresentatività da amplissima si è progressivamente inaridita. Parallelamente anche le forme, i contenuti, gli stessi soggetti interpreti dell'antipolitica si sono trasformati nel corso di un sessantennio. Da Giannini a Grillo, la critica alla partitocrazia ha avuto molteplici voci (da Guareschi a Montanelli fino a Pannella) e solleticato svariati imprenditori politici a valorizzarne le potenzialità elettorali (dal Msi alla Lega, alla stessa Forza Italia, passando per le incursioni sulla scena politica di movimenti poi rivelatisi effimeri, come la Maggioranza Silenziosa dei primissimi anni settanta o i «girotondini» di pochi anni fa). Costante è stata la loro pretesa/ambizione di offrire una rappresentanza politica all'opinione pubblica inespressa e/o calpestata dai partiti, facendo leva sulla polarità ora di uomo qualunque vs upp (uomini politici professionali) ora di maggioranza silenziosa vs minoranza rumorosa, ora di Milano «capitale morale» vs Roma «capitale politica», ora di cittadini vs casta. Altro punto fermo è stato la denuncia dello strapotere e dell'invadenza dei partiti accompagnata spesso dall'irrisione demolitoria della figura del politico strutturato nei partiti, poggiante sull'assunto che la politica possa - anzi, debba - essere appannaggio di cittadini comuni. Un significativo elemento di discontinuità s'è registrato solo negli ultimi tempi. L'antipartitismo prima attingeva a un'opinione pubblica - e esprimeva istanze - marcatamente di destra, per quanto l'etichetta fosse sgradita. A partire dagli anni Novanta, viceversa, l'antipolitica mostra di attecchire anche presso il popolo di sinistra. Un'antipolitica debitamente qualificata come «positiva» e inserita in un «orizzonte virtuoso», comunque non meno accesamente ostile nei confronti della «nomenk1atura spartitoria», della «degenerazione della politica in partitocrazia», dell'«occupazione dello Stato e della cosa pubblica», dell'«arroccamento corporativo della professione politica». È l'antipolitica che ha trovato la sua consacrazione nel M5S, rendendo l'attacco al «sistema dei partiti» molto più temibile e imponendo all'agenda politica del paese l'ordine del giorno del superamento insieme dell'asimmetria storica esistente tra paese legale e paese reale e del ruolo protagonista dei partiti nella vita delle istituzioni.
QUANDO I BUONI TRADISCONO.
Lunedì 12 luglio 2010. Il tribunale di Milano condanna in primo grado il generale Giampaolo Ganzer a 14 anni di prigione, 65mila euro di multa e interdizione perpetua dai pubblici uffici per traffico internazionale di droga, scrive Mario Di Vito su “Eilmensile”. Il processo andava avanti da cinque anni e nella sua storia poteva contare sul numero record di oltre 200 udienze. La sentenza racconta di un Ganzer disposto a tutto pur di fare carriera, in una clamorosa lotta senza quartiere al narcotraffico. Una lotta che – sostiene il tribunale – passava anche per l’importazione, la raffinazione e la vendita di quintali di droga. Il fine giustifica i mezzi, si dirà. Ma, intanto, l’accusa chiese 27 anni di prigione per il “grande servitore dello Stato”, che “dirigeva e organizzava i traffici”. L’indagine su Ganzer nacque per merito del pm Armando Spataro che, nel 1994, ricevette dal generalissimo l’insolita richiesta di ritardare il sequestro di 200 chili di cocaina. Il Ros sosteneva di essere in grado di seguire il percorso dello stupefacente fino ai compratori finali. Spataro firmò l’autorizzazione, ma i i carabinieri procedettero comunque, per poi non dare più notizia dell’operazione per diversi mesi, cioè fino a quando, di nuovo Ganzer se ne uscì con la proposta di vendere il carico di cocaina sequestrata a uno spacciatore di Bari. Spataro – verosimilmente con gli occhi fuori dalle orbite – ordinò la distruzione immediata di tutta la droga. Quasi vent’anni dopo, la procura di Milano avrebbe sostenuto che i carabinieri agli ordini di Ganzer fossero al centro di un traffico enorme e “le brillanti operazioni non erano altro che delle retate di pesci piccoli messe in atto per gettare fumo negli occhi dell’opinione pubblica”. La prima vera, grande, pietra miliare dell’inchiesta è datata 1997, cioè, quando il giudice bresciano Fabio Salamone raccolse la testimonianza di un pentito, Biagio Rotondo, detto “il rosso”, che gli raccontò di come alcuni agenti del Ros lo avvicinarono nel 1991 per proporgli di diventare una gola profonda dall’interno del mercato della droga. Rotondo si sarebbe poi suicidato in carcere a Lucca, nel 2007. Secondo l’accusa, i “confidenti del Ros” – reclutati a decine per tutti gli anni ’90 – erano degli spacciatori utilizzati come tramite con le varie organizzazioni malavitose. L’indagine – che negli anni è stata rimpallata tra Brescia, Milano, Torino, Bologna e poi di nuovo Milano, con centinaia di testimonianze e migliaia di prove repertate– sfociò nella condanna del generalissimo e di altri membri del Reparto, che, comunque, sono riusciti tutti ad evitare le dimissioni – e il carcere – poiché si trattava “solo” di una sentenza di primo grado. Il nome di Ganzer viene messo in relazione anche con uno strano suicidio, quello del 24enne brigadiere Salvatore Incorvaia che, pochi giorni prima di morire, aveva detto al padre Giuseppe, anche lui ex militare, di essere venuto a conoscenza di una brutta storia in cui erano coinvolti “i pezzi grossi”, addirittura “un maresciallo”. Incorvaia sarebbe stato ritrovato cadavere il 16 giugno 1994, sul ciglio di una strada, con un proiettile nella tempia che veniva dalla sua pistola di ordinanza. Nessuno ebbe alcun dubbio: suicidio. Anche se il vetro della macchina di Incorvaia era stato frantumato, e non dal suo proiettile – dicono le perizie – che correva nella direzione opposta. Altra brutta storia che vede protagonista Ganzer – questa volta salvato dalla prescrizione – riguarda un carico di armi arrivato dal Libano nel 1993: 4 bazooka, 119 kalashnikov e 2 lanciamissili che, secondo l’accusa, i Ros avrebbero dovuto vendere alla ‘ndrangheta. Zone d’ombra, misteri, fatti sepolti e mai riesumati. Tutte cose che ora non riguarderanno più il generale Giampaolo Ganzer, già proiettato verso una vecchiaia da amante dell’arte. Fuori da tutte quelle vicende assurde, ma “nei secoli fedele”.
«Traditore per smisurata ambizione». Questa una delle motivazioni per le quali i giudici dell’ottava sezione penale di Milano hanno condannato a 14 anni di carcere il generale del Ros Giampaolo Ganzer, all’interdizione dai pubblici uffici e alla sanzione di 65 mila euro, scrive “Il Malcostume”. Erano i giorni di Natale del 2010 quando arrivò questa incredibile sentenza di primo grado. Secondo il Tribunale, il comandante del Reparto operativo speciale dell’arma, fiore all’occhiello dei Carabinieri, tra il 1991 e il 1997 «non si è fatto scrupolo di accordarsi con pericolosissimi trafficanti ai quali ha dato la possibilità di vendere in Italia decine di chili di droga garantendo loro l’assoluta impunità», dunque «Ganzer ha tradito per interesse lo Stato e tutti i suoi doveri tra cui quello di rispettare e fare rispettare la legge». Tutto questo possibile perché «all’interno del raggruppamento dei Ros c’era un insieme di ufficiali e sottufficiali che, in combutta con alcuni malavitosi, aveva costituito un’associazione finalizzata al traffico di droga, al peculato, al falso, al fine di fare una rapida carriera». La pm Maria Luisa Zanetti aveva chieso 27 anni per il generale Ganzer, ma il tribunale aveva ridotto la condanna a 14 anni, in quanto la Corte presieduta da Luigi Capazzo non ha riconosciuto il reato di associazione a delinquere. Ma non ha concesso nemmeno le attenuanti generiche all’alto ufficiale, in quanto «pur di tentare di sfuggire alle gravissime responsabilità della sua condotta, Ganzer ha preferito vestire i panni di un distratto burocrate che firmava gli atti che gli venivano sottoposti, dando agli stessi solo una scorsa superficiale». Secondo i giudici, inoltre «Ganzer non ha minimamente esitato a fare ricorso a operazioni basate su un metodo assolutamente contrario alla legge ripromettendosi dalle stesse risultati di immagine straordinari per sé stesso e per il suo reparto». 17 i condannati nel processo, tra cui il narcotrafficante libanese Jean Bou Chaaya (tuttora latitante) e molti carabinieri: il colonnello Mario Obinu (ai servizi segreti) con 7 anni e 10 mesi, 13 anni e mezzo a Gilberto Lovato, 10 anni a Gianfranco Benigni e Rodolfo Arpa, 5 anni e 4 mesi a Vincenzo Rinaldi, 5 anni e 2 mesi a Michele Scalisi, 6 anni e 2 mesi ad Alberto Lazzeri Zanoni, un anno e mezzo a Carlo Fischione e Laureano Palmisano. La clamorosa condanna del generale Ganzer fu accolta tra il silenzio dell’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa, la solidarietà dell’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni e la difesa dell’ex procuratore antimafia Pierluigi Vigna, benché questa brutta vicenda che “scuote l’arma” avrebbe dovuto portare alla sospensione della carica e quindi del servizio di Ganzer, in ottemperanza all’articolo 922 del decreto legislativo 15 marzo 2010, la cosiddetta “norma di rinvio” che dice: “Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall’impiego previste dall’art 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97” che attiene alle “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” e che all’articolo 4 dice espressamente: “In caso di condanna, anche non definitiva, per alcuno dei delitti indicati all’articolo 3 comma 1, i dipendenti sono sospesi dal servizio”. Tra i delitti considerati c’è pure il peculato, reato contemplato nella sentenza a carico di Ganzer. Eppure, da allora, il generale Ganzer è rimasto in carica nonostante “I Carabinieri valutano il trasferimento“, malgrado i numerosi appelli alla responsabilità e all’opportunità delle dimissioni giunti da più parti. Ganzer non ha mai mollato la poltrona e nessun ministro (La Russa allora, Di Paola poi) gli ha fatto rispettare la legge, a parte un’interrogazione parlamentare del deputato radicale Maurizio Turco. Ganzer ha continuato a dirigere il Ros, ad occuparsi di inchieste della portata di Finmeccanica, degli attentatori dell’ad di Ansaldo Roberto Adinolfi, senza contare le presenze ai dibattiti sulla legalità al fianco dell’ex sottosegretario del Pdl Alfredo Mantovano, suo grande difensore. Proprio in questi giorni l’accusa in un processo parallelo, ha chiesto 8 anni di condanna per Mario Conte, ex pm a Bergamo che firmava i decreti di ritardato sequestro delle partite di droga per consentire alla cricca di militari guidati da Ganzer di poterla rivendere ad alcune famiglie di malavitosi. La posizione di Conte era stata stralciata per le sue precarie condizioni di salute. Ebbene, in attesa della sentenza e senza un solo provvedimento di rimozione dall’incarico anche a protezione del buon nome del Ros, ora Ganzer lascia il comando del Reparto. Non per l’infamante condanna. Ma “per raggiunti limiti d’età” . Ganzer lascerà il posto al generale Mario Parente per andare in pensione. Da «Traditore per smisurata ambizione» a fruitore di (smisurata?) pensione. Protetto dagli uomini delle istituzioni e alla faccia di chi la legge la rispetta.
E poi ancora. Sono stati arrestati dai loro stessi colleghi, per il più odioso dei reati, quello di violenza sessuale, ancora più odioso perché compiuto su donne sotto la loro custodia, una delle quali appena maggiorenne. A finire nei guai tre agenti di polizia in servizio a Roma raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della capitale ed eseguita dagli agenti della Questura.
Ed ancora. Erano un corpo nel corpo. Sedici agenti della Polizia Stradale di Lecce sono stati arrestati con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al falso ideologico e alla concussione ambientale. I poliziotti erano 20 anni che, stando alle accuse, omettevano i controlli ai mezzi di trasporto di circa 100 ditte del Salento in cambio di denaro e merce varia. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che ogni agente racimolasse da questa attività extra qualcosa come 40.000 euro ogni 3 anni . Il “leader” dell’ organizzazione sarebbe l’ ispettore capo Francesco Reggio, 57 anni, leccese. Nel corso di una telefonata intercettata Reggio si sarebbe complimentato con un suo collega che, grazie alle somme intascate, sarebbe andato anticipatamente in pensione. L’ indagine è partita solo quando sulla scrivania del procuratore capo di Lecce, Cataldo Motta, è arrivata una denuncia anonima contenente i nomi degli agenti e delle ditte coinvolte. Un’ altra lettera, questa volta non anonima, arrivata successivamente in Procura è partita invece proprio dall’interno della sezione di Polizia Stradale di Lecce.
Ed Ancora. Tre agenti di polizia e cinque
immigrati sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di
Venezia nell'ambito di un'inchiesta che ha accertato il rilascio di permessi di
soggiorno in mancanza di requisiti di legge, sulla base di documentazione
falsificata.
Ed Ancora. Arrestati due carabinieri nel Barese, chiedevano soldi per chiudere un occhio. Facevano coppia, sono stati bloccati dai loro colleghi del comando provinciale di Bari e della squadra mobile del capoluogo. A due ragazzi fermati durante un controllo anti-prostituzione avevano chiesto denaro prospettando una denuncia per sfruttamento.
Ecc. Ecc. Ecc.
G8 Genova. Cassazione: "A Bolzaneto accantonato lo Stato di Diritto". La Suprema corte rende note le motivazioni della sentenza dello scorso 14 giugno 2013. "Contro i manifestanti portati in caserma violenze messe in atto per dare sfogo all'impulso criminale". "Inaccoglibile", secondo la Quinta sezione penale, "la linea difensiva basata sulla pretesa inconsapevolezza di quanto si perpetrava all’interno delle celle", scrive "Il Fatto Quotidiano". Un “clima di completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di diritto”. La Cassazione mette nero su bianco quello che accadde nella caserma di Bolzaneto dove furono portati i manifestanti no global arrestati e percossi durante il G8 di Genova nel luglio del 2001: “Violenze senza soluzione di continuità” in condizioni di “assoluta percettibilità visiva e auditiva da parte di chiunque non fosse sordo e cieco”. Nelle 110 pagine depositate oggi dalla Suprema corte si spiega perché, lo scorso 14 giugno 2013, sono state rese definitive sette condanne e accordate quattro assoluzioni per gli abusi alla caserma contro i manifestanti fermati. La Cassazione ha così chiuso l’ultimo dei grandi processi sui fatti del luglio 2001. Nel precedente verdetto d’appello, i giudici avevano dichiarato prescritti i reati contestati a 37 dei 45 imputati originari tra poliziotti, carabinieri, agenti penitenziari e medici – riconoscendoli comunque responsabili sul fronte dei risarcimenti. Risarcimenti che però la sentenza definitiva ha ridotto. I giudici puntano il dito contro chi era preposto al comando: “Non è da dubitarsi che ciascuno dei comandanti dei sottogruppi, avendo preso conoscenza di quanto accadeva, fosse soggetto all’obbligo di impedire l’ulteriore protrarsi delle consumazioni dei reati”. Oltretutto, scrive la Cassazione “non risulta dalla motivazione della sentenza che vi fossero singole celle da riguardare come oasi felici nelle quali non si imponesse ai reclusi di mantenere la posizione vessatoria, non volassero calci, pugni o schiaffi al minimo tentativo di cambiare posizione, non si adottassero le modalità di accompagnamento nel corridoio (verso il bagno o gli uffici) con le modalità vessatorie e violente riferite” dai testimoni ascoltati nel processo. I giudici di piazza Cavour denunciano come il “compimento dei gravi abusi in danno dei detenuti si fosse reso evidente per tutto il tempo, data l’imponenza delle risonanze vocali, sonore, olfattive e delle tracce visibili sul corpo e sul vestiario delle vittime”. Ecco perché, osserva la Quinta sezione penale, è “inaccoglibile la linea difensiva basata sulla pretesa inconsapevolezza di quanto si perpetrava all’interno delle celle, e anche nel corridoio durante gli spostamenti, ai danni di quei detenuti sui quali i sottogruppi avrebbero dovuto esercitare la vigilanza, anche in termini di protezione della loro incolumità”.
La Cassazione descrive inoltre i comportamenti inaccettabili di chi aveva il comando e non ha mosso un dito per fermare le violenze sui no global: “E’ fin troppo evidente che la condotta richiesta dei comandanti dei sottogruppi consisteva nel vietare al personale dipendente il compimento di atti la cui illiceità era manifesta: ciò non significa attribuire agli imputati una responsabilità oggettiva, ma soltanto dare applicazione” alla norma che regola “la posizione di garanzia da essi rivestita in virtù della supremazia gerarchica sugli agenti al loro comando”. Erano poi “ingiustificate” le vessazioni ai danni dei fermati “non necessitate dai comportamenti di costoro e riferibili piuttosto alle condizioni e alle caratteristiche delle persone arrestate, tutte appartenenti all’area dei no global”, si legge nelle motivazioni. Insomma, conclude la Suprema corte, le violenze commesse alla caserma di Bolzaneto sono state un “mero pretesto, un’occasione per dare sfogo all’impulso criminale“.
Scaroni, l'ultras reso invalido dalla polizia: "Dopo anni aspetto giustizia". Il giovane tifoso del Brescia il 24 settembre del 2005 è stato ridotto in fin di vita alla stazione di Verona dagli agenti. Nella sentenza di primo grado i giudici hanno stabilito la responsabilità delle forze dell'ordine ("hanno picchiato con il manganello al contrario"), ma nessuna possibilità di individuare le responsabilità personali. Per questo gli imputati sono stati tutti assolti, scrive David Marceddu su "Il Fatto Quotidiano". ”Sai cosa? Secondo me quel giorno alla stazione di Verona cercavano il morto”. Paolo Scaroni a otto anni esatti da quel pomeriggio di fine estate in cui la sua vita è totalmente cambiata, alcune idee le ha chiare. Sa che lui, che ne è uscito miracolosamente vivo, è uno dei pochi che può, e deve, raccontare. ”Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi, me lo dice sempre: io posso essere quella voce che altri non hanno più”, spiega a ilfattoquotidiano.it. Per il giovane tifoso del Brescia, ridotto in fin di vita a colpi di manganello da agenti di polizia il 24 settembre 2005, per tragica coincidenza proprio la sera prima dell’omicidio di “Aldro” a Ferrara, la battaglia nelle aule di giustizia continua: il pubblico ministero della procura scaligera, Beatrice Zanotti ha presentato a fine aprile il ricorso in appello contro l’assoluzione di sette poliziotti del Reparto mobile di Bologna. Per la sentenza di primo grado a pestare l’ultras dopo la partita tra Hellas e Brescia furono sicuramente dei poliziotti, ma non c’è la prova che siano stati proprio Massimo Coppola, Michele Granieri, Luca Iodice, Bartolomeo Nemolato, Ivano Pangione, Antonio Tota e Giuseppe Valente, e non invece altri appartenenti alla Celere (l’ottavo imputato, un autista, è stato scagionato per non aver commesso il fatto). Erano 300 in stazione quel pomeriggio tutti in divisa, tutti col casco, irriconoscibili. Paolo Scaroni, 36 anni, fino al ”maledetto giorno” era un fiero allevatore di tori. Ora, invalido al 100%, dalla sua casa di Castenedolo dove abita con la moglie, lotta giorno per giorno per ritrovare una vita un po’ normale. Adesso potrà forse avere un risarcimento: ora che un giudice ha detto che quello fu un ”pestaggio gratuito”, ”immotivato rispetto alle esigenze di uso legittimo della forza, di un giovane, con danni gravissimi allo stesso”, avere qualcosa indietro dallo Stato potrebbe essere più facile. Il giudice infatti dice che non ci sono prove sull’identità dei poliziotti colpevoli, ma sulla responsabilità della Polizia non ci sono dubbi. ”E finora, anche se proprio in questi giorni lo Stato ha avviato con me una sorta di trattativa, non ho avuto neanche un euro”. Per tutti questi anni Scaroni è stato omaggiato da migliaia di tifosi in tutta Italia, che ne hanno fatto un simbolo delle ingiustizie subite dal mondo ultras. Lui, che ormai raramente va allo stadio, si gode questa vicinanza, ma lamenta la lontananza delle autorità: ”Solo il questore di Brescia mi ha fatto sentire la sua solidarietà. Avevo scritto a Roberto Maroni quando era ministro dell’Interno, persino al Papa. Niente”. Paolo porta sul suo corpo i segni di quel giorno. La diagnosi dei medici non lasciava molte speranze: ”Trauma cranio cerebrale. Frattura affondamento temporale destra. Voluminoso ematoma extradurale temporo parietale destro”. Una persona spacciata: ”Il medico legale si spaventò perché nonostante fossi in fin di vita non avevo un livido nel corpo. Avevano picchiato solo in testa”. E avevano picchiato, certifica il giudice Marzio Bruno Guidorizzi, ”con una certa impugnatura” del manganello ”al contrario”.
Diritti umani, governo Usa attacca l'Italia: “Polizia violenta, carceri invivibili, Cie, femminicidio…”. Un dossier governativo analizza la situazione di 190 Paesi. Nel nostro, sotto accusa forze dell'ordine, carceri, Cie, diritti dei rom, violenza sulle donne..., scrive “FanPage”. Secondo il Governo americano i “principali problemi risiedono nelle condizioni dei detenuti, con le carceri sovraffollate, la creazione dei Cie per i migranti, i pregiudizi e l'esclusione sociale di alcune comunità”. Senza dimenticare “l'uso eccessivo della forza da parte della polizia, un sistema giudiziario inefficiente, violenza e molestie sulle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, le aggressioni agli omosessuali, bisessuali e trans e la discriminazione sui luoghi di lavoro sulla base dell'orientamento sessuale”. Al sud, denunciati anche i casi di sfruttamento di lavoratori irregolari. Il prende in esame il caso di Federico Aldrovandi e quello di Marcello Valentino Gomez Cortes, entrambi uccisi a seguito di normali controlli di polizia. Ma si critica anche l'assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico e le violenze che subiscono autori di piccoli reati da parte di alcuni agenti. Sotto accusa anche i rimpatri forzati degli immigrati irregolari, oppure la loro detenzione nei centri di identificazione ed espulsione: “Il 24 maggio decine di detenuti in un centro di Roma sono stati coinvolti in una rivolta contro quattro guardie, che hanno utilizzato gas lacrimogeni per impedirne la fuga. L'episodio ha seguito le proteste della settimana precedente nei Cie di Modena e Bologna. Un rapporto del Comitato dei Diritti Umani del Senato ha denunciato la promiscuità tra adulti e minori, il sovraffollamento, i lunghi periodi di detenzione e l'inadeguato accesso di avvocati e mediatori culturali”. Sotto accusa anche le frequenti discriminazioni ai danni dei cittadini romanì: “Le violenze nei confronti di rom, sinti e camminanti rimangono un problema. Durante il 2012 le popolazioni rom sono state sottoposte a discriminazioni da parte di autorità comunali, soprattutto attraverso sgomberi forzati non autorizzati”. Naturalmente il report governativo non tralascia le violenze sulle donne, il femminicidio, l'antisemitismo e il lavoro nero.
Polizia violenta, la garanzia dell'anonimato. In Europa gli agenti portano un codice personale sulla divisa. In Italia no. E, in caso di abusi, non sono identificabili, scrive di Alessandro Sarcinelli su “Lettera 43. Sarebbero bastati tre numeri e tre lettere sulla divisa e sul casco dei poliziotti in tenuta anti-sommossa. Sarebbe bastato un semplice codice alfanumerico e Lorenzo Guadagnucci, giornalista del Quotidiano Nazionale, avrebbe potuto denunciare chi a manganellate gli spaccò entrambe le braccia, la notte del 21 luglio 2001 alla scuola Diaz durante il G8. Invece non ha mai saputo chi stava dietro la furia incontrollata dei manganelli. Dopo 12 anni in Italia nulla è cambiato e i poliziotti del reparto mobile non sono ancora identificabili. Per questo in caso di abusi, la magistratura non ha la possibilità di individuarne i responsabili. In tutto questo tempo ci sono state numerose petizioni e raccolte firme. Lo scorso febbraio durante l’ultima campagna elettorale, 117 candidati poi divenuti parlamentari hanno sottoscritto la campagna Ricordati che devi rispondere proposta da Amnesty International: il primo punto riguardava proprio la trasparenza delle forze di polizia. Tuttavia non si è mai arrivati neanche a una proposta di legge in parlamento. «Nel nostro Paese c’è una bassa consapevolezza su quali siano i limiti all’uso della forza dei pubblici funzionari. Viviamo nelle tenebre», ha attaccato Guadagnucci. L’articolo 30 del nuovo ordinamento di pubblica sicurezza del 1981 recita: «Il ministro dell’Interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso». Se in fondo a questa legge si aggiungesse la formula «compresi i codici alfanumerici» la questione sarebbe risolta. In oltre 30 anni nessun ministro dell’Interno ha mai preso in considerazione questa modifica. Non è andata così invece nei principali paesi europei: i codici alfanumerici sulle divise delle forze dell’ordine sono infatti attualmente in uso in Inghilterra, Germania, Svezia, Spagna, Grecia, Turchia e Slovacchia. In Francia non esistono ancora ma qualche mese fa, Manuel Valls, attuale ministro dell’Interno, ne ha annunciato l'introduzione a breve. Inoltre, nel dicembre 2012 una risoluzione del parlamento Europeo ha chiesto esplicitamente ai paesi che non hanno ancora adottato i codici di avviare una riforma. Ciononostante, la politica italiana non ha mostrato particolare interesse sull’argomento: dei tre principali partiti solo il M5s si è detto completamente favorevole all’introduzione dei codici. Mentre Pd e Pdl non hanno trovato il tempo per esprimere la loro opinione. A causa di questo disinteresse è calato il silenzio sul tema. Ma ogni volta che la cronaca riaccende il dibattito l’opinione pubblica si divide tra chi è a favore della polizia e chi è a favore dei manifestanti. Posizioni intermedie non sembrano esistere. Secondo Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, l’arroccamento su queste posizioni è frutto di un malinteso: «In Italia introdurre norme riguardanti i diritti umani delle forze di polizia equivarrebbe a stigmatizzarne il comportamento. In realtà l’introduzione dei codici servirebbe a individuare solo i comportamenti penalmente rilevanti». In qualche modo quindi sarebbe uno strumento per tutelare il corpo di polizia nel suo insieme dalle azioni illegali dei singoli. Non la pensa così Nicola Tanzi, segretario generale Sap (Sindacato autonomo di polizia): «Il manifestante violento tramite il codice sulla divisa può risalire all’identità del poliziotto mettendo in pericolo l’incolumità sua e dei suoi familiari». È bene precisare, tuttavia, che per abbinare a un codice l’identità di un agente bisognerebbe avere un infiltrato all’interno della polizia che fornisse queste informazioni. Secondo molte realtà della società civile, l’uso (e l’abuso) della forza da parte della polizia non va affrontato solo da un punto di vista legislativo ma anche culturale. Guadagnucci è convinto che uno dei problemi principali sia la poca trasparenza: «All’interno della polizia si risente ancora di cultura militare e corporativa e non si è sviluppato un forte senso democratico», un’atmosfera da «non vedo, non sento, non parlo». I vertici del Sap, però, non ci stanno, dicendosi convinti che «non ci sia nel modo più assoluto un problema di trasparenza». Il primo in Italia a proporre i codici identificativi per le forze dell’ordine fu Giuseppe Micalizio, braccio destro dell’allora capo della polizia Gianni De Gennaro. Era il 22 luglio 2001 e Micalizio era stato inviato a Genova per fare una relazione dettagliata sull’irruzione alla scuola Diaz, ma i suoi consigli rimasero rimasti inascoltati da tutti, politica compresa. All’orizzonte non si intravede nessun cambiamento e, secondo Amnesty International, per questo si è interrotto il rapporto di fiducia tra cittadinanza e forze dell’ordine, fondamentale in uno stato democratico. Ma per Noury c’è qualcosa di ancora più grave: «Tutto ciò che ha consentito che la “macelleria messicana” della Diaz accadesse c’è ancora. Quindi potrebbe succedere ancora». A Genova o in qualsiasi altra città italiana.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti?
Provi a leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che nessuno le dirà mai.
Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali.
“Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni.
DUE COSE SU AMNISTIA, INDULTO ED IPOCRISIA.
“Gli italiani, giustizialisti? No! Disinformati ed ignoranti. Se l'amnistia e l'indulto serve a ristabilire una sorta di giustizia riparatrice per redimere anche i peccati istituzionali: ben vengano.”
E’ chiaro e netto il pensiero di Antonio Giangrande, scrittore e cultore di sociologia storica ed autore della Collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che Siamo" edita su Amazon.it con decine di titoli.
Gli italiani non vogliono né l'indulto né l'amnistia. A mostrarlo e dimostrarlo il sondaggio Ispo per il Corriere: il 71 per cento degli intervistati ha detto no a ogni provvedimento di clemenza. Un vero e proprio plebiscito contro che unisce, trasversalmente, l'elettorato da sinistra a destra. Sempre secondo Ispo tra chi vota Pd è la maggioranza (il 67%) a essere contraria. Così come nell'elettorato del Pdl dove, nonostante ci sia di mezzo il futuro politico e non solo di Berlusconi, qualunque idea di "salvacondotto " non piace per nulla. Il 63 (% contro 35) dice no. Allineanti sulla linea intransigente anche gli elettori M5s: contrari 3 e su 4. Questi sondaggi impongono ai politicanti l'adozione di atti che nel loro interesse elettorale devono essere utili, più che giusti.
Da cosa nasce questo marcato giustizialismo italico?
Dall’ignoranza, dalla disinformazione o dall’indole cattiva e vendicativa dei falsi buonisti italici?
Prendiamo in esame tre fattori, con l’ausilio di Wikipedia, affinchè tutti possano trovare riscontro:
1. Parliamo dei giornalisti e della loro viltà a parlare addirittura delle loro disgrazie. Carcere per aver espresso la loro libertà di stampa scomoda per i potenti. Dice Filippo Facci: «Siamo una masnada di fighetti neppure capaci di essere una corporazione, anzi peggio, siamo dei professionisti terminali e già «morti» come direbbe un qualsiasi Grillo. La Corte di Strasburgo ha sancito che il carcere per un giornalista - Maurizio Belpietro, nel caso - costituisce una sproporzione e una violazione della libertà di espressione. È una sentenza che farà giurisprudenza più di cento altri casi, più della nostra Cassazione, più degli estenuanti dibattiti parlamentari che da 25 anni non hanno mai partorito una legge decente sulla diffamazione. Il sindacato dei giornalisti si è detto soddisfatto e anche molti quotidiani cartacei (quasi tutti) hanno almeno dato la notizia, che resta essenzialmente una notizia: ora spiegatelo ai censori del Fatto Quotidiano, a questi faziosi impregnati di malanimo che passano la vita a dare dei servi e chi non è affiliato al loro clan. Non una riga. Niente». Bene. I giornalisti, censori delle loro disgrazie, possono mai spiegare bene cosa succede prima, durante e dopo i processi? Cosa succede nelle quattro mura delle carceri, laddove per paura e per viltà tutto quello che succede dentro, rimane dentro?
2. Parliamo dei politici e della loro ipocrisia.
Sovraffollamento e mancanza di dignità. «È inaccettabile, non più tollerabile, il sovraffollamento delle carceri italiane». La presidente della Camera Laura Boldrini visita Regina Coeli, nel quartiere di Trastevere, a Roma, dove lei vive. «Dignità, dignità», urlano i detenuti della terza sezione, le cui celle ospitarono durante il fascismo Pertini e Saragat, al passaggio della presidente della Camera denunciando le condizioni «insostenibili» di sovraffollamento in cui sono costretti a vivere. «Il tema carceri è una cruciale cartina di tornasole del livello di civiltà di un Paese», dice Boldrini, che si ferma ad ascoltare storie e istanze. «Chi ha sbagliato è giusto che paghi, non chiediamo sconti - aggiunge - ma che ci sia la rieducazione del detenuto: che chi entra in carcere possa uscirne migliore. E invece con il sovraffollamento, che è come una pena aggiuntiva, si crea tensione, abbrutimento, promiscuità e si tira fuori il peggio delle persone. Questo, come ha detto il presidente della Repubblica, è inaccettabile in un Paese come l'Italia». Boldrini invoca «quanto prima» una «risposta di dignità» per superare «una condizione disumana che non fa onore al Paese di Beccaria».
Innocenti in carcere. Ma soprattutto, secondo la presidente della Camera, bisogna «ripensare il sistema della custodia cautelare, perché non è ammissibile che più del 40% dei detenuti sia in attesa di condanna definitiva, con il rischio di danni irreparabili se innocenti. E bisogna pensare a misure alternative alle pene detentive».
3. Parliamo della sudditanza alla funzione giudiziaria e della convinzione della sua infallibilità.
Il giustizialismo. Nel linguaggio politico e giornalistico italiano indica una supposta ideologia che vede la funzione giudiziaria al pari di un potere e come tale il più importante e lo sostiene, o anche la presunta volontà di alcuni giudici di influenzare la politica o abusare del proprio potere. Esso si contrappone al garantismo, che invece è un principio fondamentale del sistema giuridico: le garanzie processuali e la presunzione di non colpevolezza hanno un valore prevalente su qualsiasi altra esigenza di esercizio e pubblicità dell'azione penale anche nella sua fase pre-giudiziale; tale principio è sancito anche dalla Costituzione: « La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.»
La negazione dell’errore giudiziario e la idolatria dei magistrati.
E’ certo che gli umani siano portati all’errore. E’ certo anche che gli italiani hanno il dna di chi è propenso a sbagliare, soprattutto per dolo o colpa grave. E' palese l'esistenza di 5 milioni di errori giudiziari dal dopo guerra ad oggi. E' innegabile che il risarcimento per l'ingiusta detenzione dei detenuti innocenti è un grosso colpo all'economia disastrata dell'Italia. Nonostante l'idolatria è risaputo che i magistrati italiani non vengono da Marte.
Sin dal Corpus iuris il reato di denegata giustizia era oggetto di previsione normativa. La novella 17 colpiva quei magistrati che obbligavano i sudditi ad andare ad implorare giustizia dall'imperatore, perché gli era stata negata dai magistrati locali. La novella 134 puniva con la multa di 3 libbre d'oro il giudice di quella provincia, che, malgrado avesse ricevuto lettere rogatorie, trascurasse l'arresto di un malfattore che si fosse rifugiato nella detta provincia; la medesima pena era comminata agli ufficiali del giudice. In tempi più recenti, nonostante il plebiscitario esito della consultazione referendaria tenutasi sul tema nel 1987, la legge n. 117 del 1989 di fatto snaturò e vanificò il diritto al conseguimento del risarcimento del danno per una condotta dolosa o colposa del giudice. Essa stravolse il risultato del referendum e il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermare quello, opposto, della responsabilità dello Stato: vi si prevede che il cittadino che abbia subìto un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo entro il limite di un terzo di annualità di stipendio, (di fatto è un quinto, oltretutto coperto da una polizza assicurativa che equivale intorno ai cento euro annui). Quella legge ha così raggiunto il risultato di confermare un regime di irresponsabilità per i magistrati. L'inadeguatezza della legge n. 117 del 1989 è dimostrata dal fatto che, a decenni dalla sua entrata in vigore, non si registra una sola sentenza di condanna dello Stato italiano per responsabilità colposa del giudice, nonostante le numerosissime sentenze con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha acclarato inadempimenti dello Stato italiano. L'esigenza di rivedere la legge n. 117 del 1989 viene ora avvertita anche al fine di dare piena attuazione alla novella costituzionale approvata sul tema del giusto processo, nonché al fine di dare concreta esecuzione del principio consacrato dall'articolo 28 della Costituzione: tali norme subiscono ingiustificabili limitazioni in riferimento alla responsabilità dei giudici.
Il sistema della responsabilità civile dei magistrati in Italia deroga quindi alla "grande regola" della responsabilità aquiliana, secondo quanto è riconducibile agli altri pubblici funzionari (ai sensi dell'articolo 28 Cost. e con la possibilità di agire in regresso verso lo Stato). La peculiarità giustificata ai magistrati è quella della delimitazione al dolo ed alla colpa grave (articolo 3), e la garanzia di insindacabilità (articolo 2) che fu riconosciuta nella citata sentenza n. 18 del 1989, per la quale "l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto (…) non può dar luogo a responsabilità del giudice". Il rapporto tra questa peculiarità e la denegata giustizia è però assai problematico. La responsabilità civile del giudice sussiste in un giudizio procedurale, non del merito, ad esempio per la violazione di termini perentori per l'uso delle intercettazioni, custodia cautelare, notifica di atti o precetti, prescrizione dei reati. Stante questo vincolo, con la normativa attuale restano necessari comunque due procedimenti separati (coi relativi tre gradi di giudizio), uno per l'ammissibilità, perché la richiesta non deve sindacare l'autonomia del giudice, e uno vero e proprio per la richiesta di risarcimento.
Detto questo, cosa ne sa la massa di come si abilita alla funzione giudiziaria e quali siano le capacità, anche psicologiche di chi giudica? Cosa ne sa la massa di cosa significa errore giudiziario e questo riguarda prima o poi una persona (anche se stessi, non solo gli altri) e la sua dignità nella società ed in carcere, dove torture e violenze sono relegate all’oblio o al segreto del terrore? Cosa ne sa la massa se chi (i giornalisti), dovendo loro dare corretta e completa informazione, non sa tutelare nemmeno se stesso?
Ed ecco allora che l'ultimo sport dei giustizialisti è attaccare Balotelli.
Il commissario della Nazionale Prandelli ha deciso di portarlo ugualmente a Napoli, nonostante Balotelli fosse infortunato, per la sfida contro l'Armenia. Qualcuno ha scritto che ci sarebbe andato anche come testimonial anti-camorra perché prima del match l'Italia avrebbe giocato su un campo sequestrato ai clan. Senza dire questo qualcuno, però, come il campo sia stato assegnato ed a chi. Questo qualcuno si è arrogato il diritto di dare una funzione a Balotelli, senza che questo sia consultato. Lui ha letto e ha spiegato su Twitter: «Questo lo dite voi. Io vengo perché il calcio è bello e tutti devono giocarlo dove vogliono e poi c'è la partita». Questo è bastato a scatenare la reazione indignata di politici, parroci, pseudointellettuali. Tutti moralisti, perbenisti e giustizialisti. Perché, secondo loro, questa affermazione sarebbe scorretta, volgare non nella forma ma nella sostanza, perché ci si legge un sottotesto che strizza l'occhio ai clan.
Poi, naturalmente c’è chi va sopra le righe, per dovere di visibilità. Perche? Bisogna chiederlo a Rosaria Capacchione, senatrice Pd e giornalista che è stata la prima ad attaccarlo: «È un imbecille». Subito dopo al parroco don Aniello Manganiello: «Mi chiedo se Balotelli abbia ancora diritto a essere convocato nella Nazionale». Aggiungetevi una serie di insulti sui social network, le dichiarazioni dei politici locali e avrete il quadro della situazione. Napoli. In terra di Camorra spesso è difficile diversificare il camorrista da chi non lo è. C'è chi sparla e c'è chi tace; c'è chi spara e c'è chi copre. A voi sembra che meriti tutto questo (il bresciano Balotelli)? Si chiede Giuseppe De Bellis su “Il Giornale”. È tornato quello stanco ritornello dei personaggi popolari che devono essere da esempio. Dovere, lo chiamano. È un insulto all'intelligenza di chi queste frasi le dice.
C'è il legittimo sospetto che Balotelli sia soltanto uno straordinario capro espiatorio. Un bersaglio facile: lo attacchi e non sbagli, perché tanto qualche sciocchezza la fa di sicuro. Siamo alla degenerazione della critica: sparo su Balotelli perché così ho i miei trenta secondi di popolarità. È questo ciò che è accaduto. Lui sbaglia, eccome se sbaglia. In campo e fuori è già successo un sacco di volte. Questa sarà solo un'altra, devono aver pensato i professionisti dell'anticamorra: buttiamoci, perché noi siamo i giusti e lui è quello sbagliato. Coni, Federazione, Nazionale non hanno avuto nulla di meglio da dire che «Balotelli se le cerca», oppure, «poteva risparmiarsela». Avrebbero dovuto dire solo una cosa: non usate lo sport e gli sportivi per le vostre battaglie partigiane. Ci vuole coraggio per stare al proprio posto. A ciascuno il suo e l'anticamorra non spetta al centravanti della Nazionale. Lui vuole solo giocare a pallone. Lui deve solo giocare a pallone. Il resto è ipocrisia. Balotelli l'ha solo svelata una volta di più.
Cosa ne sanno gli italiani della mafia dell’antimafia, o degli innocenti in carcere. Gli italiani bevono l’acqua che gli danno ed è tutta acqua inquinata e con quella sputano giudizi sommari che sanno di sentenze.
E la colpa è solo e sempre di una informazione corrotta ed incompleta da parte di una categoria al cui interno vi sono rare mosche bianche.
Quindi, ecco perché "Gli italiani, giustizialisti? No! Disinformati ed ignoranti. Se l'amnistia e l'indulto serve a ristabilire una sorta di giustizia riparatrice per redimere anche i peccati istituzionali: ben vengano".
Tanti sono gli esempi lampanti su come disfunziona la Giustizia in Italia.
Che dire, per esempio, dei 12 mesi di carcere di Scaglia, l'innocente. L'ex fondatore di Fastweb assolto per non aver commesso il fatto. Storia di ordinaria ingiustizia, scrive Annalisa Chirico su “Panorama”. Alla fine sono stati assolti. Il pm aveva chiesto sette anni per Silvio Scaglia e per Stefano Mazzitelli, rispettivamente fondatore e presidente di Fastweb e amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle. Entrambi accusati di una frode fiscale da circa 365 milioni di euro. Entrambi passati sotto il torchio delle manette preventive. Insieme a loro sono stati assolti gli ex funzionari di Tis Antonio Catanzariti e Massimo Comito, gli ex dirigenti di Fastweb Stefano Parisi, Mario Rossetti e Roberto Contin. Tutti innocenti per “non aver commesso il fatto” o perché “il fatto non costituisce reato”. Secondo i giudici della prima sezione penale del tribunale di Roma, i manager non sapevano quello che stava succedendo, mentre ad aver ideato e manovrato il sistema di megariciclaggio da due miliardi di euro era Gennaro Mokbel, faccendiere napoletano con un passato di attivismo nell’estrema destra. Su di lui adesso pende una condanna di primo grado a 15 anni di reclusione. “Il mondo è un posto imperfetto. Quando succedono cose di questo tipo ti senti una vittima. Poi però ti guardi attorno e scopri che non sei solo: in Italia ci sono decine di migliaia di innocenti che stanno dietro le sbarre”, è il commento a caldo di Scaglia, pochi minuti dopo la lettura del dispositivo della sentenza. La sua vicenda è solo la miniatura di una piaga ben più imponente: circa il 40 percento dei detenuti nelle galere italiane sono persone in attesa di un giudizio definitivo. Sono, letteralmente, imputati da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva, lo statuisce l’articolo 27 della nostra veneranda Costituzione. Oltre 12mila persone attendono un giudizio di primo grado. Tra questi c’era Scaglia, c’era Mazzitelli, la cui innocenza è stata adesso certificata da una sentenza giudiziaria. L’operazione Broker scatta il 23 febbraio 2010. Cinquantasei persone vengono arrestate nell’ambito di una inchiesta su una maxi operazione di riciclaggio e frode fiscale internazionale che coinvolgerebbe i vertici di Fastweb e Telekom Sparkle. Tra le misure cautelari disposte dai magistrati romani, spicca il mandato di cattura per Scaglia, che trovandosi all’estero noleggia un aereo privato e dalle Antille atterra all’aeroporto romano di Fiumicino. I beni di Scaglia vengono posti sotto sequestro preventivo e i carabinieri traducono l’imprenditore nel carcere di Rebibbia, dove viene rinchiuso in una cella di otto metri quadrati al secondo piano, sezione G11. In regime di isolamento giudiziario non può avere contatti con nessuno, neppure col suo avvocato. Attende tre giorni per l’interrogatorio di garanzia e oltre quaranta per rispondere alle domande dei suoi accusatori, secondo i quali lui sarebbe membro di una associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e a dichiarazione infedele mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti. Ora sono stati smentiti dai giudici. Ma dietro le sbarre Scaglia trascorre tre mesi prima di ottenere gli arresti domiciliari il 19 maggio 2010. In totale, collezionerà 363 giorni di detenzione da innocente. Ancora oggi viene da chiedersi quali fossero le esigenze cautelari nei confronti di un indagato, che non ricopriva più alcun incarico societario in Fastweb e che era montato su un aereo per farsi oltre diecimila chilometri e consegnarsi all’autorità giudiziaria italiana. Nei suoi confronti i giudici hanno rigettato il teorema dipietresco del “non poteva non sapere”. Ecco, sì, all’epoca dei fatti Scaglia era Presidente di Fastweb, ma poteva non sapere. Nel dibattimento dati, prove e testimonianze hanno dimostrato che Scaglia non sapeva, e neppure Mazzitelli sapeva. Si poteva evitare tutto questo? Che giustizia è quella che tratta i cittadini come presunti colpevoli? Arresti infondati, vite dilaniate e i riverberi economici di una vicenda che ha colpito, tra gli altri, il guru italiano della New Economy, l’uomo che il “Time” nel 2003 aveva annoverato nella lista dei quindici manager tech survivors, profeti dell’innovazione usciti indenni dalla bolla della New Economy. Ecco, della New Economy ma non della giustizia made in Italy.
Nel 2010, quando il gip di Roma ordina l’arresto di Silvio Scaglia, Stefano Parisi è amministratore delegato di Fastweb, continua Annalisa Chirico su “Panorama”. A ventiquattro ore dalla notizia dell’ordinanza di custodia cautelare, mentre Scaglia organizza il suo rientro dalle Antille con un volo privato, Parisi decide di convocare una conferenza stampa per spiegare urbi et orbi che Fastweb non ha commesso alcun reato e che gli ipotetici fondi neri non esistono. “A distanza di tre anni e mezzo posso dire che i giudici mi hanno dato ragione”. Parisi è stato solo lambito dall’inchiesta Fastweb – Telecom Italia Sparkle. Destinatario di un avviso di garanzia, la sua posizione è stata archiviata la scorsa primavera. “Avrebbero potuto archiviare nel giro di quindici giorni, invece ci sono voluti tre anni”. Ora che il Tribunale di Roma ha assolto l’ex presidente di Fastweb Scaglia e altri dirigenti della società di telecomunicazioni, Parisi prova un misto di soddisfazione e rabbia. “Mi chiedo perché accadano vicende come questa in un Paese civile. Le vite di alcuni di noi sono state letteralmente stravolte. La giustizia dovrebbe innanzitutto proteggere cittadini e imprese, non rendersi responsabile di errori simili”. Perché di errori si tratta. Quando nel 2007 su Repubblica compare il primo articolo da cui cui filtrano informazioni riservate sulle indagini condotte dalla procura di Roma su una presunta frode fiscale internazionale che coinvolgerebbe Fastweb, l’azienda avvia immediatamente un audit interno per fare chiarezza. “A distanza di sei anni una sentenza conferma quanto noi abbiamo sostenuto e provato sin dall’inizio. Da quella analisi interna vennero fuori nel giro di un mese dati e informazioni che noi trasmettemmo subito alla procura perché sin dall’inizio ci fu chiaro che la truffa veniva ordita, con la complicità di due dirigenti infedeli (ora condannati in primo grado per corruzione, ndr), ai danni di Fastweb. Insomma noi eravamo la vittima di un raggiro che, come hanno certificato i giudici, ha sottratto circa 50 milioni di euro alla nostra società e 300 milioni a Tis”. Certo, dalle parole di Parisi trapela l’amarezza per quello che si poteva evitare e invece non si è evitato. “Purtroppo la stessa sentenza ha fatto chiarezza su un punto: c’erano dei delinquenti, che sono stati condannati, e degli innocenti perseguitati dalla giustizia”.
Scaglia dopo l'assoluzione: "Il carcere peggio di come lo raccontano". L'imprenditore assolto con formula piena dall'accusa di riciclaggio parla con Toberto Rho su “La Repubblica” dell'anno trascorso in stato di detenzione, prima a Rebibbia poi nella sua casa di Antagnod. "In cella meno spazio che per i maiali. Quel pm non voleva cercare la verità, ma ora so che in Italia la giustizia funziona". Silvio Scaglia, trecentosessantatré giorni, tre ore, trentacinque minuti, quaranta secondi. Ovvero, "la battaglia più dura che ho combattuto nella mia vita, ma sono contento di averla fatta e di non averla evitata, come avrei facilmente potuto". Il counter del sito che amici e sostenitori hanno aperto durante il periodo della sua detenzione per denunciarne pubblicamente l'assurdità, è ancora fermo su quelle cifre, che misurano il periodo che Silvio Scaglia, uno dei manager che hanno costruito il successo di Omnitel, l'imprenditore che è diventato miliardario (in euro) durante il periodo della New economy grazie all'intuizione di eBiscom-Fastweb, ha passato agli arresti. Prima a Rebibbia, tre mesi, poi altri nove rinchiuso nella sua casa di Antagnod, in cima alla Val d'Ayas, finestre affacciate sul gruppo del Monte Rosa. Le sue montagne, che però non poteva guardare: "Nei primi tempi degli arresti domiciliari non mi potevo affacciare, tantomeno uscire sul balcone, per disposizione dei giudici". Oggi che è stato assolto con formula piena dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata a quella che la Procura definì "la più grande frode mai attuata in Italia", Scaglia ripercorre l'anno più difficile della sua esistenza. A cominciare da quella notte in cui, alle Antille per affari, rispose alla telefonata della figlia, ventenne, che chiamava dalla loro casa di Londra. "Era stata svegliata dagli agenti inglesi, avevano in mano un mandato di cattura. Per noi era un mistero, non capivamo cosa stesse accadendo. Ho compreso la gravità delle accuse solo quando ho letto l'ordine di arresto con i miei avvocati".
Ha deciso di rientrare in Italia, subito.
«Sapevo esattamente quel che mi aspettava appena scesa la scaletta dell'aereo, ma immaginavo un'esperienza breve. Poche settimane, il tempo di spiegare che di quella vicenda avevo già parlato in un interrogatorio di tre anni prima, che da anni ero uscito da Fastweb, e che l'azienda e i suoi manager non erano gli artefici, ma le vittime di quella frode».
Come fu quella notte in volo tra i Caraibi e l'Italia, ingegner Scaglia?
«Presi una pastiglia per dormire, per non pensare. L'incubo cominciò a Ciampino, era notte fonda. Si rilegga i giornali di quei giorni, per capire quale era il peso che mi sono trovato addosso, all'improvviso, quale era la tensione, la pressione su di me e sulle aziende coinvolte».
Subito in carcere?
«Prima una lunghissima procedura di identificazione e notifica dell'arresto. Poi Rebibbia, in isolamento. Una cella lunga tre metri e larga uno e mezzo, il cesso in vista, intendo in vista anche dall'esterno. Ero nel braccio dei delinquenti comuni. Il carcere è un posto orribile, sporco, affollato all'inverosimile. C'è meno spazio di quello che le leggi prevedono per gli allevamenti dei maiali».
Quale è la privazione più dura?
«Più ancora della libertà, delle umiliazioni, dello spazio che manca, è il senso di impotenza, l'impossibilità di difendersi, di spiegare. Dopo cinque giorni di isolamento, venne il giudice per l'interrogatorio cosiddetto di garanzia. Fu una farsa. Poi, per due mesi, più nulla. Finalmente l'interrogatorio con il Pm: mi sembrava di aver spiegato, di aver dimostrato con il mio ritorno dai Caraibi di non aver alcun progetto di fuga, anzi il contrario. Quanto al possibile inquinamento delle prove, si trattava di fatti avvenuti anni prima, in un'azienda da cui ero uscito da anni. Invece, tornai in carcere. Quel Pm, evidentemente, non aveva interesse a capire».
Poi gli arresti domiciliari, un po' di respiro.
«Al contrario. Fu il periodo più duro. Ero chiuso nella mia casa di Antagnod, l'unica mia abitazione italiana, perché con la mia famiglia vivo da tempo a Londra. Ero completamente solo, non potevo neppure uscire sul balcone, vedevo solo la signora che mi procurava il cibo e la mia famiglia nel fine settimana. Nove mesi così, senza potermi difendere».
Cosa le resta addosso, di quell'anno?
«Certo non la voglia di dimenticare. È stata un'esperienza troppo forte per me e per le persone che mi vogliono bene. Semmai avverto l'urgenza di dire forte che queste cose non dovrebbero più succedere».
Cosa pensa della giustizia, oggi?
«Il mio caso dimostra che la giustizia, in Italia, funziona. Io ho avuto giustizia. Ma ci sono voluti troppo tempo e troppe sofferenze: il problema è la mancanza di garanzie per chi è in attesa di giudizio. Vede, in carcere ho parlato con tantissimi detenuti: la metà di loro erano in attesa di un processo. La metà della metà risulteranno innocenti, come me».
Mai rimpianto quel viaggio di ritorno dalle Antille a Roma, pendente un ordine di arresto, neppure nei giorni più duri?
«Mai, neppure per un secondo. Lo rifarei domattina. Era l'unico modo per reclamare la mia innocenza e cancellare ogni possibile ombra. Fu proprio quella scelta a rendere superflua ogni spiegazione alle persone che mi vogliono bene. La mia famiglia, le mie figlie si sono fidate del loro padre, della sua parola, dei suoi gesti. Non c'è stato bisogno d'altro».
Che ne è del Silvio Scaglia "mister miliardo", l'imprenditore lungimirante e spregiudicato, uno dei dieci uomini più ricchi e potenti d'Italia?
«Sono sempre qui. Faccio ancora quel che so fare, cioè l'imprenditore, pochi mesi fa ho acquistato un'azienda (La Perla, ndr). Certo, la mia reputazione ha subito danni pesanti. Ancora oggi non posso andare negli Stati Uniti, se compilo il modulo Esta mi negano il visto. Ma ad altri è andata peggio: vivendo a Londra, per la mia famiglia è stato relativamente più facile mantenere il distacco dall'onda di riprovazione che si accompagna ad accuse così gravi come quelle che ho subito. E poi, ai miei coimputati è stato sequestrato tutto, hanno vissuto per anni della generosità di amici e conoscenti».
Come vive le eterne polemiche italiane sulla giustizia?
«Con fastidio. Mi sembrano agitate strumentalmente per ottenere un vantaggio politico, non per risolvere i problemi reali delle migliaia di persone che vivono sulla loro pelle quel che ho vissuto io».
Ma il caso Fastweb (a proposito così è stato conosciuto da tutti come se Telecom non ci fosse, ingiustamente, anche lei) ha dimostrato in modo lampante come si debba ragionare seriamente sul funzionamento della giustizia, scrive Nicola Porro su “Il Giornale”. Le tesi dell'accusa (come ha denunciato un'altra vittima dell'accanimento giudiziario, il generale Mario Mori) diventa immediatamente la tesi della verità. I media non pensano, non riflettono, non investigano, copiano gli atti dell'accusa. Gli indagati diventano subito colpevoli. Chiunque conoscesse le carte della difesa, sarebbe stato in grado in un secondo di verificare l'enormità dell'accusa. Ma andiamo oltre. Anche i pm hanno un obbligo legale di ricercare la verità. Come hanno potuto aver avuto così poco buon senso (sì sì certo, non c'è un articolo del codice che lo prevede) nell'applicare misure cautelari così dure? Gli imputati sono stati tosti. Hanno resistito al carcere e non hanno accettato sconti, patteggiamenti, ammissioni. Non sono passati per la strada più facile. Hanno pagato un prezzo altissimo dal punto di vista personale. Una piccola lezione, l'ennesima, ma forse la più clamorosa: una persona, un'azienda, un processo non si giudica solo dalla carte dell'accusa. Ma continuando a fare il nostro mestiere. Il processo Fastweb per il momento è finito. Un terzo della nostra popolazione carceraria è dietro alle sbarre senza una sentenza definitiva come Scaglia e soci. Forse prima dell'amnistia ci si potrebbe occupare di questa mostruosità giuridica.
FACILE DIRE EVASORE FISCALE A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN E MARADONA.
Per tutti coloro che del giustizialismo fanno la loro missione di vita si deve rammentare la storia di Sofia Loren che non doveva finire in carcere. La Cassazione dà ragione alla Loren dopo 31 anni: "Non doveva finire in carcere". Dopo un iter giudiziario di 31 anni, la Suprema Corte dà ragione all'attrice finita in carcere nel 1982: l'attrice utilizzò correttamente il condono fiscale. Ha vinto Sofia Loren. Giunge al capolinea, dopo quasi 40 anni, una delle cause fiscali ancora aperte tra l’attrice due volte premio Oscar Sofia Loren - nata Scicolone (sorella della madre di Alessandra Mussolini, nipote di Benito), e rimasta tale all’anagrafe dei contribuenti - e l’ Agenzia delle Entrate. Dopo una così lunga attesa, per una vicenda legata alla presentazione a reddito zero del modello 740 della dichiarazione dei redditi del 1974, la Cassazione ha dato ragione alla Loren concedendole, a norma di quanto previsto dal condono del 1982, di pagare le tasse solo sul 60% dell’imponibile non dichiarato e non sul 70% di quei 920 milioni di vecchie lire sottratti alla tassazione e, invece, accertati dal fisco. Ma non è l'aspetto fiscale da tenere in considerazione, ma come sia facile finire dentro, anche per i big non protetti dal Potere. Sophia Loren aveva ragione e non doveva essere arrestata per evasione fiscale nel 1982. Ha perso la giustizia, ancora una volta. Lo ha riconosciuto, definitivamente, la Cassazione. A riconoscerlo, in maniera definitiva, dopo un iter giudiziario durato 31 anni, è stata la Corte di Cassazione. La sezione tributaria della Suprema Corte, con una sentenza depositata il 23 ottobre 2013, ha infatti accolto il ricorso dell’attrice contro una decisione della Commissione tributaria centrale di Roma risalente al 2006. L'attrice di Pozzuoli vince la causa contro il fisco per una dichiarazione dei redditi del 1974, poi sottoposta al condono 8 anni dopo. Il caso suscitò grande scalpore quando la stella del cinema si consegnò alla polizia a Fiumicino per essere arrestata. Lei finì in carcere 31 anni fa per 17 giorni con l'accusa di evasione fiscale. Il caso suscitò grande scalpore dopo che l'attrice decise di consegnarsi alla polizia all'aeroporto di Fiumicino di ritorno dalla Svizzera dove risiedeva con la famiglia. Le responsabilità della frode vennero poi attribuite al suo commercialista. Al centro del procedimento, la dichiarazione dei redditi per il 1974 che la Loren presentò, congiuntamente al marito Carlo Ponti, in cui si escludeva, per quell’anno, «l’esistenza di proventi e spese», poiché «per i film ai quali stava lavorando erano sì previsti compensi ma da erogarsi negli anni successivi». Sofia Loren, nella dichiarazione dei redditi del 1974 presentata congiuntamente al marito, aveva escluso - ricorda il verdetto della Cassazione - «l’esistenza di proventi e spese per il detto anno e chiariva che per i film ai quali stava lavorando erano sì previsti compensi ma da erogarsi negli anni successivi al 1974, in quanto per gli stessi era stata concordata una retribuzione pari al 50% dei ricavi provenienti dalla distribuzione dei film». Il fisco non ci ha creduto ed è andato a scovare quel quasi miliardo non dichiarato, tassato per poco più della metà del suo valore. Meno propensa all’applicazione delle ganasce soft era stata la Procura della Suprema Corte, rappresentata da Tommaso Basile, che aveva chiesto il rigetto del ricorso della Loren. Nel 1980 all’attrice venne notificato un avviso di accertamento, per un reddito complessivo netto assoggettabile all’Irpef per il 1974 pari a 922 milioni di vecchie lire (l’equivalente, valutando il potere d’acquisto che avevano allora quei soldi, di oltre 5.345.000 di euro di oggi). La Loren, dunque, usufruendo del condono fiscale previsto dalla legge 516/1982, aveva presentato una dichiarazione integrativa facendo riferimento a un imponibile di 552 milioni di vecchie lire, pari al 60% del reddito accertato, ma il Fisco aveva iscritto a ruolo un imponibile maggiore, pari a 644 milioni, sostenendo che la percentuale da applicarsi fosse quella del 70%, poiché la dichiarazione sul 1974 presentata dall’attrice, doveva considerarsi omessa, perché «priva degli elementi attivi e passivi necessari alla determinazione dell’imponibile». Le Commissioni di primo e secondo grado avevano dato ragione alla Loren, mentre la Commissione tributaria centrale di Roma aveva dichiarato legittima la liquidazione del condono con l’imponibile al 70%. Nonostante gli ermellini abbiano sconfessato la pretesa dei giudici fiscali di secondo grado di Roma di sottoporre a tassazione il 70% dei 920 milioni di lire non dichiarati nel 1974 (ossia di calcolare come imponibile 644 milioni anziché 552 milioni, come sostenuto dai legali della Loren che si sono battuti per un imponibile pari al 60% della cifra evasa), nulla dovrà essere ridato all’attrice perché il fisco - in questi tanti anni - le ha usato la cortesia di non chiederle quel 10% di differenza in attesa della decisione della Cassazione. Oltre alla certificazione, ora garantita dalla Suprema Corte, di aver presentato un condono fatto bene, alla Loren rimane anche la soddisfazione di vedere addossate all’Agenzia delle Entrate le spese legali dei suoi avvocati pari a settemila euro. La Loren si è detta "felice" per il verdetto della Cassazione: "Finalmente si chiude una storia che è durata quaranta anni". E Sophia commenta: «Il miracolo della giustizia: quando non ci credi più trova un modo di ridarti speranza. È una vicenda vecchia di 30 anni fa in cui ho avuto finalmente ragione». Interviene anche l‘avvocato Giovanni Desideri che ha difeso Sophia Loren nel ricorso in Cassazione: «È una vicenda kafkiana durata quaranta anni quella vissuta dalla signora Loren, per di più per delle tasse correttamente pagate: adesso la Cassazione ha reso, finalmente, il fisco giusto. Ma l’amministrazione tributaria, senza arrivare a disturbare la Cassazione, avrebbe potuto autocorreggersi da sola prendendo atto delle dichiarazioni in autotutela presentate dalla contribuente Loren anni orsono!».
Forse si sarebbero lasciati andare a qualche parola di più se non fossero ancora calde le polemiche sul gesto dell’ombrello rivolto da Maradona al fisco: chi conosce la Loren - madrina e testimonial di tanti eventi, dalle sfilate di moda al varo di navi da crociera - sa che non ci tiene a finire in compagnia dell’ex pibe de oro nel novero di chi si ritiene «vittima» delle tasse. Si sa in Italia: sono le stesse vittime di ingiustizie che si rendono diverse dai loro disgraziati colleghi e se ne distanziano. Questo perchè in Italia ognuno guarda ai cazzi suoi. Non si pensa che si sia tutti vittime della stessa sorte e per gli effetti fare fronte comune per combatterla. Intanto è polemica sulle dichiarazioni di Diego Armando Maradona a Che tempo che fa. L'ex "pibe de oro" ha parlato dei propri problemi fiscali e ha dichiarato: "Io non sono mai stato un evasore. Io non ho mai firmato contratto, lo hanno fatto Coppola e Ferlaino che ora possono andare tranquillamente in giro mentre a me hanno sequestrato l’orologio e l’orecchino, tanti volevano transare per me con fisco per farsi pubblicità, ma io ho detto no, io non sono un evasore, voglio andare in fondo. Equitalia si fa pubblicità venendo da me, perché il loro lavoro non è Maradona. Io non mi nascondo". Poi il gesto dell'ombrello rivolto a Equitalia. E ripartiamo dunque da Maradona che ha fatto il gesto dell'ombrello a Equitalia «che mi vuole togliere tutto: tié». Nessun commento da parte del conduttore Fabio Fazio. Il gesto invece non è piaciuto al viceministro dell'Economia, Stefano Fassina: "È un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione, funzionari di Equitalia hanno notificato nei giorni scorsi a Diego Armando Maradona un avviso di mora da oltre 39 milioni di euro, stiamo parlando di quasi 40 milioni di euro, farebbe bene a imparare a rispettare le leggi", ha tuonato l'esponente del Pd a Mix 24 su Radio 24.
Diego Armando Maradona e il gesto dell’ombrello contro Equitalia. Ma perché il Pibe de oro ha reagito in modo così plateale e non educato durante la trasmissione di Fabio Fazio? Una possibile motivazione la dà il quotidiano di Napoli, il Mattino. Maradona sarebbe stato indispettito da quanto accaduto al suo arrivo in Italia: appena sceso dall’aereo sarebbe stato “ispezionato” da un funzionario di Equitalia per verificare se addosso avesse oggetti pignorabili come orecchini, anelli o affini. Memore di quanto accaduto nel 2010, quando gli fu sequestrato l’orecchino, Maradona si è presentato senza beni pignorabili. Ma spiega il Mattino, la visita degli ispettori, avvenuta davanti alla figlia Dalma e alla compagna Rocio, lo ha indispettito. E quindi, al sentir nominare Equitalia, Diego ha risposto con l’ombrello. Diego Armando Maradona non ci sta. Finito nel mirino di Equitalia, che lo accusa di aver evaso il fisco per la cifra di 39 milioni di euro, l'ex calciatore argentino ha deciso di reagire. E la controffensiva non si è limitata al gesto dell'ombrello verso l'agenzia di riscossione italiana durante la trasmissione di Fabio Fazio, che già di per se aveva smosso un marasma di polemiche. Il Pibe de Oro ha infatti annunciato un'azione legale nei confronti dell'ente tributario. La ragione? Gli agenti del fisco lo avrebbero perquisito al suo arrivo a Ciampino "davanti al suo legale Angelo Pisano, alla figlia Dalma e alla compagna Rocio", mettendogli le mani addosso per cercare presunti oggetti di valore da poter sequestrare. La denuncia è per "ingiusta attività esecutiva degli organi tributari". Un'offesa, un'umiliazione che il campione non ha sopportato. Soprattutto dopo che Equitalia continua a pretendere soldi che in realtà non sono giustificati sul piano sostanziale. Infatti, la contestazione - notificata al calciatore argentino solo 11 anni dopo i fatti - riguarda un eventuale mancato versamento al fisco dal 1985 al 1990 di 13 miliardi di lire, pari a 6,7 milioni di euro. Quella cifra nel 2013 ammonterebbe a 11,4 milioni di euro. I 28 milioni di euro in più che vengono pretesi da Equitalia sono la somma di mora, interessi di mora e sanzioni.
Dopo il "tiè" al Fisco. Maradona ha ragione: non è un evasore scrive Franco Bechis su “Libero Quotidiano”. Diego non fece ricorso nel '94 contro la presunta frode perché era all'estero: lo avrebbero scagionato. Il Fisco lo sa, ma non rinuncia a sequestri e show. Diego Armando Maradona non ha evaso al fisco italiano i 39 milioni di euro che continuano a chiedergli. Questo è certo, perché nemmeno il fisco italiano lo sostiene: la contestazione - notificata al calciatore argentino solo 11 anni dopo i fatti - riguarda un eventuale mancato versamento al fisco dal 1985 al 1990 di 13 miliardi di lire, pari a 6,7 milioni di euro. Quella cifra nel 2013 ammonterebbe a 11,4 milioni di euro. I 28 milioni di euro in più che vengono pretesi da Equitalia sono la somma di mora, interessi di mora e sanzioni. E questo sarebbe un primo problema di equità per qualsiasi contribuente, anche per Maradona. Ma anche sui 13 miliardi di lire dell’epoca il fisco ha torto sul piano sostanziale e lo sa benissimo: per pretenderli ne fa esclusivamente una questione di forma. Il gruppo di finanzieri e di «messi» di Equitalia che notifica cartelle, avvisi di mora, e sequestra orecchini e orologi a Maradona ogni volta che questo entra in Italia, sa benissimo di avere torto sul piano sostanziale, anche se la forma consente questo show. Maradona è innocente, ma non si è difeso nei tempi e nei modi consentiti: quando lo ha fatto era troppo tardi, e la giustizia tributaria italiana non gli ha consentito di fare valere le sue ragioni (conosciute e indirettamente riconosciute da altre sentenze) perché era prescritta la possibilità di ricorrere e contestare le richieste del fisco. Quello di Maradona così è uno dei rarissimi casi in cui la prescrizione va a tutto danno dell’imputato. Il calciatore più famoso del mondo è finito nel mirino del fisco insieme alla società calcistica per cui aveva lavorato in Italia (il Napoli di Corrado Ferlaino), e a due giocatori dell’epoca: Alemao e Careca. Il fisco ha emesso le sue cartelle esattoriali, e la giustizia tributaria ha iniziato il suo processo quando Maradona era già tornato in Argentina, dove avrebbe ancora giocato quattro anni. Conseguenza naturale: le notifiche del fisco sono arrivate a chi era in Italia (Napoli calcio, Alemao e Careca), e naturalmente non a chi era in Argentina, perché né il fisco italiano né altri lo hanno comunicato laggiù. Il fisco si è lavato la coscienza appendendo le sue cartelle all’albo pretorio di Napoli. Oggi quell’albo è on line e in teoria uno che fosse curioso potrebbe anche guardarlo dall’Argentina (ma perché mai dovrebbe farlo?). Allora no: per conoscere quelle cartelle bisognava andare in comune a Napoli. Non sapendo nulla di quelle cartelle (fra cui per altro c’erano anche alcune multe prese per violazione al codice della strada), Maradona non ha potuto fare ricorso. Né conoscere il tipo di contestazione che veniva fatta. Riassunto in breve. I calciatori allora come oggi erano lavoratori dipendenti delle società per cui giocavano. Maradona, Careca e Alemao erano dipendenti del Napoli. Che pagava loro lo stipendio e fungeva da sostituto di imposta: tratteneva cioè l’Irpef dovuta per quei redditi e la versava al fisco. Tutti e tre i giocatori (e molti altri in Italia) oltre al contratto da dipendenti avevano anche una sorta di contratto ulteriore, con cui cedevano alla società calcistica i propri diritti di immagine anche per eventuali sponsorizzazioni e pubblicità. In tutti e tre i casi, come avveniva all’epoca con i calciatori di tutto il mondo e in tutto il mondo, non erano i calciatori ad incassare dal Napoli il corrispettivo di quei diritti, ma delle società estere di intermediazione (tre diverse nel caso di Maradona), che poi avrebbero dovuto dare ai giocatori gli utili di intermediazione. Secondo il fisco italiano quei diritti in realtà erano stipendio extra per Alemao, Maradona e Careca. Il Napoli quindi avrebbe dovuto versare al fisco trattenute simili a quelle operate sugli stipendi base. Non avendolo fatto il Napoli, avrebbero dovuto versare l’Irpef i singoli giocatori. Squadra di calcio, Alemao e Careca fanno ricorso (Maradona no, perché non ne sa nulla): in primo grado hanno torto. In secondo grado vedono riconosciute pienamente le loro ragioni, con una sentenza che per Careca e Alemao verrà confermata dalla Cassazione. Il Napoli calcio incassa la sentenza favorevole, ma quando la ottiene sta fallendo. Preferisce non allungare i tempi: aderisce a un condono fiscale e sana tutto il passato, pagando in misura ridotta anche l’Irpef che secondo le contestazioni non era stata versata a nome di Alemao, Careca e Maradona. In teoria il caso Maradona avrebbe dovuto considerarsi concluso con quel condono operato dal sostituto di imposta. Ma il fisco va avanti. Si deve fermare davanti a Careca e Alemao perché la sentenza tributaria di appello che verrà poi confermata prende a schiaffoni quelli che sarebbero diventati Agenzia delle Entrate ed Equitalia. La sentenza tributaria ricorda che in parallelo si era già svolto un processo penale sulla stessa materia, e che il pm aveva proposto e il Gip accolto l’archiviazione per Maradona, Alemao e Careca, escludendo «per tutti e tre i calciatori che i corrispettivi versati agli sponsor fossero in realtà ulteriori retribuzioni destinate ai calciatori». I giudici tributari poi accusano il fisco italiano di avere preso un abbaglio: avevano accusato tutti sulla base di norme che per altro sono entrate nel codice italiano con una legge di fine 1989: quindi al massimo si poteva contestare qualcosa solo per il 1990, non potendo essere retroattive le regole tributarie. Ma anche per il 1990 la contestazione non era motivata: nessuna prova che quei diritti fossero cosa diversa e si fossero trasformati in stipendi. Assolti e liberati dal fisco italiano dunque sia Alemao che Careca. Maradona no, perché non aveva fatto ricorso. Quando ha provato a farlo dopo la prima notifica del 2001, è stato respinto perché tradivo. Quindi Maradona ha ragione, ma non può avere ragione perché la sua ragione ormai è prescritta. Cose da azzeccagarbugli. Che però giustificano assai poco lo show che il fisco mette in onda ogni volta che Maradona atterra in Italia.
Maradona, l'avvocato su "La Gazzetta dello Sport": "Stufo dell'Italia: lo trattino come qualsiasi cittadino...". L'appello di Pisani, legale di Diego: "È un campione anche di pignoramenti. E il bello è che alle multinazionali del gioco con debiti di 2 miliardi e mezzo fanno lo sconto, a lui tolgono l'orologio. L'ombrello? Totò faceva la pernacchia..." L'ultima puntata del Maradona-show è un appello accorato di Angelo Pisani via etere. "Faccio un appello ai politici affinchè trattino Maradona come un qualsiasi cittadino", ha detto l'avvocato di Diego a "Radio Crc". La visita in Gazzetta, Roma-Napoli all'Olimpico e l'intervista di Fazio che ha scatenato le polemiche: Diego è andato via, l'onda lunga delle sue parole è rimasta. "In Italia chi è innocente viene perseguitato e chi invece è palesemente colpevole viene agevolato dalle leggi - spiega Pisani - Secondo Equitalia, che all'epoca dei fatti non esisteva, e quindi non secondo i giudici che hanno assolto il mio assistito, Maradona è responsabile di un'evasione di 6 milioni di euro e non 39 milioni, come appare sui giornali Quella cifra è la somma di interessi che non rappresentano evasione fiscale. Il paradosso è che le multinazionali del gioco e delle slot machine, del gioco d'azzardo, che hanno accumulato un debito enorme, pari a 2miliardi e 500milioni di euro relativi a tasse, concessioni e tributi non pagati, godranno di uno sconto. Pare che il Governo abbia inserito, nella legge sull'IMU, un provvedimento relativo allo sconto del 75% su questa somma enorme accumulata dalle multinazionali. È responsabile per un cavillo, viene perseguitato ed è l'unica persona al mondo alla quale viene sequestrato l'orologio e gli orecchini. Maradona è un campione anche nei pignoramenti ed è quasi stufo dell'Italia". Sul gesto dell'ombrello, definito "miserabile" da Fassina e mal valutato anche da Letta, Pisani ribatte: "Si lamentano del gesto di Maradona, di satira, quasi di soddisfazione per non essere vittima di un pignoramento ingiusto, per essere scampato da un agguato. Maradona non voleva offendere nessuno. Totò addirittura faceva la pernacchia che è un gesto goliardico, un gesto che fa parte dell'arte. Tra l'altro, se guardiamo le immagini, il gesto di Maradona era rivolto a se stesso".
ANCHE GESU' E' STATO CARCERATO.
Come non dare ragione al Papa. Il Papa prega per i detenuti: "Facile punire i più deboli, i pesci grossi nuotano". Il 23 ottobre 2013 prima dell'udienza generale il Pontefice ha incontrato 150 cappellani delle carceri italiane. "Anche Gesù è stato un carcerato". Poi rivela: "Chiamo spesso i reclusi di Buenos Aires". Il Papa ha voluto "far arrivare un saluto a tutti i detenuti" nelle carceri italiane, ricevendo i cappellani, prima dell'udienza generale che ha raccolto anche oggi circa 100mila persone. Gremite, oltre a piazza San Pietro, anche piazza Pio XII e le vie limitrofe, compreso il primo tratto di via Conciliazione. Il Pontefice ha parlato a braccio toccando diversi argomenti. "È facile punire i più deboli, mentre i pesci grossi nuotano" ha detto Bergoglio ai cappellani. "Ai detenuti - ha aggiunto - potete dire che il Signore è dentro con loro. Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore". Anche il Signore è stato "carcerato dai nostri egoismi, dai nostri sistemi, dalle tante ingiustizie. È facile punire i più deboli, mentre i pesci grossi nuotano". Parlando a braccio durante l'udienza, il Pontefice ha detto: "Recentemente avete parlato di una giustizia di riconciliazione, ma anche una giustizia di speranza, di porte aperte, di orizzonti, questa non è una utopia, si può fare, non è facile perché le nostre debolezze sono dappertutto, il diavolo è dappertutto, ma si deve tentare". Il Papa ha raccontato che spesso, soprattutto la domenica, telefona ad alcuni carcerati a Buenos Aires e che la domanda che gli viene in mente è: "Perché lui è lì e non io?". "Mi domando: perché lui è caduto e non io? Le debolezze che abbiamo sono le stesse... È un mistero che ci avvicina a loro". Poi ha detto ai cappellani di portare un messaggio da parte sua: "Ai detenuti, a nome del Papa, potete dire questo: il Signore è dentro con loro. Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore, il suo amore paterno e materno arriva dappertutto". Il fondamento evangelico. Gesù stesso si riconosce nel carcerato: "ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi" (Mt.25,35-36). Gesù non giudica e non condanna come fanno i tribunali delle nostre società civili. Egli muore tra due ladri, non tra due innocenti condannati ingiustamente, e a uno dei due dice: "Oggi sarai con me nel paradiso" (Lc 23,43). Gesù insegna a non giudicare e a non condannare: "Non giudicate, per non essere giudicati…"(Mt.7,1).
ANCHE GLI STUDENTI SONO UNA CASTA.
E poi ancora, neanche gli studenti si salvano da questo marasma. Imparare ad essere Casta sin dalle elementari. Pretendere presunti diritti e ignorare i sacrosanti doveri. Altro che proteste, gli studenti sono una Casta iniziatica a future corporazioni: magistrati, avvocati, notai, ecc. Costano molto più di quel che pagano, si laureano dopo i 27 anni, non si muovono da casa. E non azzeccano una battaglia, scrive Filippo facci su “Libero Quotidiano. Non è un Paese per studenti, questo: a meno che siano svogliati, viziati, rammolliti dalla bambagia familiare, cioè bamboccioni, iper-protetti dal familismo e da un welfare schizofrenico. Allora sì, ecco che questo diventa un Paese per studenti: purché siano quelli che sfilavano nel corteo romano, sabato, col fegato di sostenere che «gli stanno rubando il futuro», quelli che il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha sconsigliato dal laurearsi perché avrebbero meno probabilità di trovare lavoro, quelli che hanno scambiato la condizione studentesca per un parcheggio post-puberale, quelli, insomma, ai quali potete anche dirlo: che sono una casta. Loro rimarranno di sale, li farete imbestialire, ma lo sono e lo restano. Lo sono perché lo Stato gli chiede soltanto mille o duemila euro l’anno di tasse universitarie, mentre ne costano - allo stesso Stato - una media di settemila: soldi a carico nostro, della fiscalità generale, soldi pagati anche da chi magari i figli all’università non ce li può mandare, magari perché non può, perché non ce la fa. Una casta è proprio questo: il privilegio di una minoranza a spese di una maggioranza. Ma voi provate a dirglielo. Provate a spiegarglielo. Provate a spiegare a tanti coccolatissimi giovani, che per definizione hanno sempre ragione, che da una quarantina d’anni non hanno azzeccato una battaglia che sia una, spesso rincoglioniti dalla cultura bipolare e catastrofista dei loro cattivissimi maestri sessantottini: dediti, quest’ultimi, a condire il loro progressivo accomiatarsi con profezie di sciagura che hanno trasformato ogni futuro in un funerale sociale, ambientale, economico e tecnologico. Provate a dirglielo senza che vi saltino addosso: loro, i loro genitori e ovviamente la stampa conformista. Provate a dirgli che l’ex ministro Elsa Fornero, quando diceva che i giovani non devono essere schizzinosi all’ingresso nel mondo del lavoro, aveva ragione e basta. Provate a dirgli che Annamaria Cancellieri, quando parlò degli italiani «mammoni», aveva ragione pure lei, o, peggio, che ce l’aveva anche l’ex viceministro Michel Martone quando disse che un 28enne non ancora laureato è spesso uno sfigato. Oh certo, un laureato italiano resta sfigato a qualsiasi età, molte volte: perché manca il lavoro, perché la scuola non forma, e poi certo, perché un sacco di giovani si chiudono nelle università anche per prolungare una sorta di anticamera della vita reale, sfuggendo ogni minimo approccio col mondo del lavoro. Sta di fatto che gli studenti lavoratori in Italia restano una minoranza: c’è poco da sproloquiare. Da noi ci si laurea in media dopo i 27 anni quando in Europa non si arriva ai 24, con un mercato che ormai è senza confini e rende i giovani italiani dei potenziali ritardatari agli appuntamenti che contano. A sostenerlo ci sono tutti i dati del mondo, e il governatore di Bankitalia l’ha detto chiaro: il livello di istruzione dei nostri giovani è ancora ben distante da quello degli altri Paesi avanzati, c’è dispersione scolastica, un laureato italiano ha meno possibilità di trovare lavoro di un diplomato, c’è una percentuale spaventosa di analfabetismo funzionale e cioè un’incapacità diffusa, in sostanza, di usare efficacemente la lettura e la scrittura e il calcolo nelle situazioni quotidiane. Ma dire questo, politicamente, non serve: ci sono animi da non frustrare - ti spiegano. Teniamoci dunque la patetica casta degli studenti, questi poveracci che siamo riusciti a rovinare con la scusa di proteggerli. Non diciamogli che sono gli studenti con meno mobilità al mondo (l’80 per cento è iscritto nella regione di residenza) e che spesso la facoltà viene scelta secondo la distanza da casa, anche perché cinque giovani su dieci, dai 25 ai 34 anni, vivono ancora coi genitori. Non diciamogli che quello sciagurato e falso egualitarismo chiamato «valore legale del titolo di studio» ha prodotto milioni di false illusioni perché un pezzo di carta non insegna un lavoro né ti aiuta davvero a trovarlo, se nel frattempo non l’hai imparato e non hai capito che una professione e un’emancipazione non sono regali, non sono diritti, non sono pezzi di carta: sono una durissima conquista.
QUANTO SONO ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME?
Ogni anno a dicembre c’è un evento che stravolge la vita di molte persone. Il Natale? No! L’esame di avvocato che si svolge presso ogni Corte di Appello ed affrontato da decine di migliaia di candidati illusi.
La domanda sorge spontanea: c’è da fidarsi delle commissioni dei concorsi pubblici o degli esami di Stato?
«Dai dati emersi da uno studio effettuato: per nulla!». Così opina Antonio Giangrande, lo scrittore, saggista e sociologo storico, che sul tema ha scritto un libro “CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. L’Italia dei concorsi e degli esami pubblici truccati” tratto dalla collana editoriale “L’ITALIA DEL TRUCCO, L’ITALIA CHE SIAMO”.
E proprio dalle tracce delle prove di esame che si inizia. Appunto. Sbagliano anche le tracce della Maturità. “Le parole sono importanti”, urlava Nanni Moretti nel film Palombella Rossa alla giornalista che, senza successo, provava a intervistarlo. E’ proprio dalla commissione dell’esame di giornalismo partiamo e dalle tracce da queste predisposte. Giusto per saggiare la sua preparazione. La commissione è quella ad avere elaborato le tracce d’esame. In particolare due magistrati (scelti dalla corte d’appello di Roma) e cinque giornalisti professionisti. Ne dà conto il sito de l’Espresso, che pubblica sia i documenti originali consegnati ai candidati, sia la versione degli stessi per come appare sul sito dell’Ordine, cioè con le correzioni (a penna) degli errori. Ossia: “Il pubblico ministero deciderà se convalidare o meno il fermo”. Uno strafalcione: compito che spetta al giudice delle indagini preliminari. Seguono altre inesattezze come il cognome del pm (che passa da Galese a Galesi) e una citazione del regista Carlo Lizzani, in cui “stacco la chiave” diventa “stacco la spina”.
Sarà per questo che Indro Montanelli decise di non affrontare l’esame e Milena Gabanelli di non riaffrontarlo? Sarà per questo che Paolo Mieli è stato bocciato? E che dire di Aldo Busi il cui compito respinto era considerato un capolavoro e ricercato a suon di moneta? È in buona compagnia la signora Gabanelli & Company. Infatti si racconta che anche Alberto Moravia fu bocciato all’esame da giornalista professionista. Poco male. Sono le eccezioni che confermano la regola. Non sono gli esami giudicate da siffatte commissioni che possono attribuire patenti di eccellenza. Se non è la meritocrazia ha fare leva in Italia, sono i mediocri allora a giudicare. Ed a un lettore poco importa sapere se chi scrive ha superato o meno l'esame di giornalismo. Peccato che per esercitare una professione bisogna abilitarsi ed anche se eccelsi non è facile che i mediocri intendano l'eccellenza. L’esperienza e il buon senso, come sempre, sono le qualità fondamentali che nessuno (pochi) può trasmettere o sa insegnare. Del resto, si dice che anche Giuseppe Verdi fu bocciato al Conservatorio e che Benedetto Croce e Gabriele D’Annunzio non si erano mai laureati.
Che dire delle Commissioni di esame di avvocato. Parliamo della sessione 2012. Potremmo parlarne per le sessioni passate, ma anche per quelle future: tanto in questa Italia le cose nefaste sono destinate a durare in eterno.
A Lecce sarebbero solo 440 su 1258 i compiti ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania, presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame: troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale, so che alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20 minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Oltretutto l’arbitrio non si motiva nemmeno rilasciando i compiti corretti immacolati.
Prescindendo dalla caccia mirata alle streghe, c’è forse di più?
Eppure c’è chi queste commissioni li sputtana. TAR Lecce: esame forense, parti estratte da un sito? Legittimo se presenti in un codice commentato. È illegittimo l’annullamento dell’elaborato dell’esame di abilitazione forense per essere alcune parti estratte da un sito, se tali parti sono presenti all’interno di un codice commentato. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima, Ordinanza 19 settembre 2013, n. 465).
E’ lo stesso Tar Catania che bacchetta la Commissione d’esame di Avvocato della stessa città Esame di avvocato...Copiare non sempre fa rima con annullare - TAR CATANIA ordinanza n. 1300/2010. Esame avvocato: Qualora in sede di correzione dell'elaborato si accerta che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche manuale, per condurre all’annullamento della prova, deve essere esatto e rigoroso. Tale principio di diritto è desumibile dall’ordinanza in rassegna n. 1300/2010 del TAR Catania che ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale avanzata avverso la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di avvocato. In particolare, per il Tar etneo “il ricorso appare fondato, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che il compito di diritto penale della ricorrente conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato di penale contenuto” in altra busta recante il n. 459 senza alcuna specificazione, anche sul compito, che consenta di appurare che questa presunta “identità” vada oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la consultazione dei medesimi codici”. Per il TAR siciliano, inoltre, “l’elaborato di penale del candidato contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una diversa sottocommissione durante la seduta del 19 marzo 2010, e tale elaborato non risulta essere stato parimenti annullato”.
E a sua volta è la stessa Commissione d’esame di Avvocato di Lecce ad essere sgamata. Esami di avvocato. Il Tar di Salerno accoglie i ricorsi dei bocciati. I ricorsi accolti sono già decine, più di trenta soltanto nella seduta di giovedì 24 ottobre 2013, presentati da aspiranti avvocati bocciati alle ultime prove scritte da un giudizio che il Tar ha ritenuto illegittimo in quanto non indica i criteri sui cui si è fondato. Il Tribunale amministrativo sta quindi accogliendo le domande cautelari, rinviando al maggio del 2014 il giudizio di merito ma indicando, per sanare il vizio, una nuova procedura da affidare a una commissione diversa da quella di Lecce che ha deciso le bocciature. Il numero dei bocciati, reso noto lo scorso giugno 2013, fu altissimo. Soltanto 366 candidati, su un totale di 1.125, passarono le forche caudine dello scritto e furono ammessi alle prove orali. Una percentuale del 32,53: quasi 17 punti in meno del 49,16 registrato alla sessione dell’anno precedente. Numeri, questi ultimi, in linea con una media che, poco più o poco meno, si è attestata negli ultimi anni sull’ammissione della metà dei partecipanti. Nel 2012, invece, la ghigliottina è caduta sul 64,09 per cento degli esaminandi. In numeri assoluti i bocciati furono 721, a cui vanno aggiunti i 38 compiti (3,38 per cento) annullati per irregolarità come il rinvenimento di svolgimenti uguali. Adesso una parte di quelle persone ha visto accogliere dal Tar i propri ricorsi. I criteri usati dai commissari per l’attribuzione del punteggio, hanno spiegato i giudici, «non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale». La valutazione, quindi, «deve ritenersi l'illegittima».
Che ne sarà di tutti coloro che quel ricorso non lo hanno presentato. Riproveranno l’esame e, forse, saranno più fortunati. Anche perché vatti a fidare dei Tar.
Ci si deve chiedere: se il sistema permette da sempre questo stato di cose con il libero arbitrio in tema di stroncature dei candidati, come mai solo il Tar di Salerno, su decine di istituzioni simili, vi ha posto rimedio?
Esami di Stato: forche caudine, giochi di prestigio o giochi di azzardo? Certo non attestazione di merito.
Sicuramente nell’affrontare l’esame di Stato di giornalismo sarei stato bocciato per aver, questo articolo, superato le 45 righe da 60 caratteri, ciascuna per un totale di 2.700 battute, compresi gli spazi. Così come previsto dalle norme.
Certamente, però, si leggerà qualcosa che proprio i giornalisti professionisti preferiscono non dire: tutte le commissioni di esame sono inaffidabili, proprio perché sono i mediocri a giudicare, in quanto in Italia sono i mediocri a vincere ed a fare carriera!
LO STATO CON LICENZA DI TORTURARE ED UCCIDERE.
"Licenza di tortura". Ilaria Cucchi. La famiglia di Federico Aldrovandi, Aldo Bianzino, Riccardo Rasman. La nipote di Franco Mastrogiovanni. Parenti e amici di persone picchiate o uccise da forze dell'ordine, guardie penitenziarie, medici. La giovane fotografa Claudia Guido ha deciso di immortalare i loro volti. Per mostrare che potrebbe succedere ad ognuno di noi, scrive Francesca Sironi su “L’Espresso”. Rudra Bianzino indossa una giacca blu, ha le mani in tasca, sullo sfondo le colline di Perugia. Suo padre, Aldo, è morto in carcere cinque anni fa. Era entrato in ottima salute. È uscito due giorni dopo in una bara. L'unica certezza che Rudra e i suoi fratelli hanno avuto dal processo, finora, è che il padre si sarebbe potuto salvare, se qualcuno avesse ascoltato le sue urla di dolore. Ma la guardia carceraria ch'era servizio non ha chiamato i soccorsi. Per questo l'agente è stata condannato a un anno e mezzo di reclusione: ma in carcere non ci andrà perché la pena è sospesa. Quella di Aldo Bianzino e dei suoi figli è una delle undici storie raccontate attraverso i ritratti dei parenti e dei “sopravvissuti” da Claudia Guido, giovane fotografa padovana che li ha raccolti in una mostra itinerante intitolata “ Licenza di tortura ”. Un progetto che, spiega l'autrice, è diventato anche una forma di protesta: «Per due anni ho vissuto con queste famiglie. Ho conosciuto le loro battaglie, lo sconforto, la difficoltà di arrivare non dico a una sentenza, alla punizione dei colpevoli, ma anche semplicemente al processo: che costa tanto, economicamente ed emotivamente. Con loro ho conosciuto anche la tortura quotidiana dell'abbandono e delle parole di chi accusa, deride o rilegge le loro storie senza pensare alla sofferenza che provano intere famiglie». Gli scatti della Guido sono frontali, scarni, senza forzature: «Non ho aggiunto elementi distintivi, non ho associato ai ritratti le immagini agghiaccianti delle vittime che abbiamo visto sui giornali», spiega l'autrice: «Perché quello che vorrei trasmettere è il sentimento che ho provato io stessa leggendo queste storie sui quotidiani: l'idea che quelle violenze sarebbero potute capitare a me. Quando mia madre ha visto la foto di Patrizia Moretti ha detto: “Potrei essere io”». Lucia Uva - sorella di Giuseppe. La notte tra il 13 e il 14 luglio 2008 Giuseppe Uva rimase per tre ore nella caserma dei carabinieri di Varese. Da lì fu trasferito in ospedale, dove morì. Il giudice di primo grado, Orazio Muscato, ha scritto che le cause del decesso andrebbero individuate "in una tempesta emotiva legata al contenimento, ai traumi auto e/o etero prodotti, nonché all'agitazione da intossicazione alcolica acuta". Se ha assolto i medici, il tribunale ha stabilito però che "permangono ad oggi ignote le ragioni per le quali Giuseppe Uva, nei cui confronti non risulta esser stato redatto un verbale di arresto o di fermo, mentre sarebbe stata operata una semplice denuncia per disturbo della quiete pubblica, è prelevato e portato in caserma, così come tutt'ora sconosciuti rimangono gli accadimenti intervenuti all'interno della stazione dei carabinieri di Varese (certamente concitati, se è vero che sul posto confluirono alcune volanti di polizia) ed al cui esito Uva, che mai in precedenza aveva manifestato problemi di natura psichiatrica, verrà ritenuto necessitare di un intervento particolarmente invasivo quale il trattamento sanitario obbligatorio". Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi , ucciso di botte da quattro poliziotti la notte del 25 settembre 2005, è stata uno dei primi contatti della ventinovenne padovana. Poi sono arrivati il padre e il fratello di Federico, insieme alle altre vittime che ora stanno girando per tutta Italia : la mostra arriverà a breve anche a Roma e a Milano. «Dopo undici casi mi son dovuta fermare: ero troppo coinvolta. Ma non escludo la possibilità di continuare: l'argomento è purtroppo sempre attuale». Nel frattempo, dall'aprile del 2011, la Guido ha portato davanti al suo obiettivo Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano , morto dopo esser stato arrestato, picchiato, e lasciato senza cure il 22 ottobre del 2009; la famiglia di Riccardo Rasman, il giovane con problemi psichici immobilizzato, colpito e asfissiato da tre agenti, a casa sua, il 27 ottobre del 2006; un sopravvissuto come Paolo Scaroni , il tifoso che nel 2005 finì in coma per le manganellate della polizia e dal suo risveglio ha avviato una battaglia legale per individuare i colpevoli; o come Stefano Gugliotta, menato da uomini in divisa il 5 maggio del 2010 e salvatosi da una condanna per “resistenza a pubblico ufficiale” solo grazie ai video girati col cellulare dagli abitanti della zona. Nella mostra ci sono poi Grazia Serra, nipote di Franco Mastrogiovanni , il maestro morto il 4 agosto 2009 in un reparto psichiatrico dell'ospedale di Vallo della Lucania, dopo esser rimasto per ore legato a un letto senza cure né acqua. Si sono fatti ritrarre anche il padre, la madre e la sorella di Carlo Giuliani , il ragazzo di 23 anni ucciso da un proiettile della polizia il 20 luglio 2001 durante le contestazioni del G8 di Genova ; la figlia di Michele Ferrulli , il 51enne morto d'infarto mentre veniva arrestato il 30 giugno del 2011; Luciano Isidro Diaz , fermato la notte del 5 aprile del 2009 mentre guidava troppo forte e reso vittima di lesioni così gravi da causargli la perforazione di un timpano e il distacco della retina; e infine la sorella e il migliore amico di Giuseppe Uva , l'uomo morto in ospedale dopo esser stato trattenuto per tre ore nella caserma dei carabinieri di Varese. Ci sono i volti di tutti loro. Che interrogano, per primo, lo Stato. Perché non lasci ripetere quelle violenze.
27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.
La decadenza di Berlusconi. Cronaca, frasi, retroscena di una giornata entrata nella storia della politica, scrive Paola Sacchi su “Panorama”. Aldo Cazzullo editorialista e commentatore del "Corriere della sera" inarca il sopracciglio e un po' sorride quando, in uno dei corridoi di Palazzo Madama, il verace senatore dalemiano Ugo Sposetti confessa: "La decadenza di Silvio Berlusconi è come la caduta del muro di Berlino, ma i miei ora devono stare attenti: quel muro in Italia venne addosso tutto a chi lo aveva preso a picconate, la Dc e il Psi....". Il senatore Pd, Stefano Esposito, anche lui di rito dalemiano a Panorama.it ammette chiaramente: "Sì, Berlusconi è decaduto, ma è uscito solo dalla vita parlamentare, non dalla politica. L'uomo è ancora vivo e vegeto e guai se il Pd lo dà per morto, commetterebbe lo stesso errore fatto con la sottovalutazione di Beppe Grillo". Se queste sono le grida d'allarme che vengono dalla sinistra (tendenza riformista), figuriamoci quelle che vengono da Forza Italia. "Sarà per loro un boomerang", dice secco il senatore Fi Altero Matteoli. E il vicepresidente del Senato (Fi) Maurizio Gasparri è caustico sulla conduzione dei lavori in aula da parte del presidente Pietro Grasso: "Lui è l'ultima rotella di un ingranaggio molto più vasto che voleva cacciare Berlusconi dal Parlamento a tutti i costi". Gasparri ricorre al Manzoni: "E' il piccolo untorello .... non sarà lui che spianta Milano". Quasi in contemporanea, con l'annuncio della sua decadenza da senatore, Silvio Berlusconi in Via del Plebiscito arringa la folla e annuncia dopo la "giornata di lutto per la democrazia", già il "primo appuntamento elettorale: l'8 dicembre riunione dei club di Fi di tutt'Italia", lo stesso giorno delle primarie del Pd. Rompe di fatto la tregua con Angelino Alfano. La folla urla: "Traditori" E il Cav: "Parole ruvide ma efficaci". Alfano in serata dirà: "Giornata nera per la democrazia". Ma "noi andremo avanti con il governo, in un rapporto di collaborazione-conflittualità", spiega a Panorama.it l'ex governatore lombardo e ora pezzo da novanta di Ndc, Roberto Formigoni. Che annuncia una formula di craxiana memoria e cioè "la collaborazione-competizione" del Psi con la Dc, in questo caso nelle parti del Pd. Sono le 17,40 quando Grasso annuncia con tono routinario, quasi fosse una pratica burocratica, la "non convalida dell'elezione a senatore di Silvio Berlusconi in Molise". Grasso ad un certo punto nel rush sembra ricorrere anche una celebre frase di Nanni Moretti. "E continuiamo così, continuiamo cosi...". Moretti concludeva "a farci del male". Ma quel "continuiamo così" non riguardava la mancata conoscenza della torta sacher. Era "la violazione del regolamento del Senato". Denunciato da Forza Italia con una valanga di ordini del giorno, ben nove, presentati da Fi (Elisabetta Alberti Casellati, ne ha presentati la maggioranza e a seguire Francesco Nitto Palma, Anna Maria Bernini e lo stato maggiore dei senatori azzurri. Si è invano chiesto il rispetto del regolamento del Senato tornando al voto segreto. Così come è previsto nelle votazioni che riguardano una singola persona. Grasso ha risposto picche anche a Pier Ferdinando Casini e al socialista Enrico Buemi, che hanno tentato di far passare la proposta di buon senso di aspettare almeno la decisione della Cassazione sulla richiesta di interdizione per Berlusconi da parte della Corte d'Appello di Milano. Niente da fare. Alla fine è stato Sandro Bondi ad avvertire tutti "gli amici di Fi" e i garantisti in generale a fermarsi: "Basta, inutile andare avanti, questa è una decisione già scritta. Lasciateli fare, lasciateli di fronte alle loro responsabilità". Poi stilettata ad Alfano: "E ora il Nuovo centrodestra che governi insieme con questi signori". E' l'inizio di un'opposizione durissima. E con numeri per la maggioranza meno robusti di quanto Enrico Letta abbia vantato. Sulla stabiliità c'è stato uno scarto di 36 voti. 171 sono stati quelli della maggioranza, 135 quelli dell'opposizione. Ma questo perché in realtà una decina di forzisti non si sarebbero presentati. Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, che di numeri si intende, a Panorama.it conferma: "Almeno sei non c'erano e ho visto anche qualche senatore a vita, mai visto di giorno, figuriamoci a quell'ora di notte". Era presente ieri per la prima volta Renzo Piano, incorrendo negli strali di Gasparri. Il leader dei lealisti di Fi Raffaele Fitto avverte: "E' incredibile che Letta faccia finta di nulla".
Decadenza Berlusconi. Le reazioni della stampa estera. Dalla Spagna al Brasile, passando per Francia, Usa, Germania, Gran Bretagna, Turchia e Qatar. Le prime pagine dei media mondiali aprono sul Cavaliere e in molti credono che non sia finita qui, scrive Anna Mazzone su “Panorama”. La decadenza di Silvio Berlusconi e la sua uscita dai palazzi ufficiali della politica è un vero e proprio caso internazionale. Praticamente tutti i media del pianeta pubblicano la notizia o corposi dossier sul Cavaliere sulle loro pagine online. Mancano all'appello solo i russi e gli asiatici, ma solo per questione di fuso orario. In Germania la Frankfurter Allgemeine titola subito dopo la grande coalizione tedesca su "Berlusconi espulso dal Senato". Sottolineando che con la decisione di un ramo del Parlamento italiano l'ex premier perde la sua carica politica più importante. "Fino a poco tempo fa - scrive la FAZ - Berlusconi e il suo partito avevano tentato di tutto per scongiurare l'espulsione dal Senato. I sostenitori di Berlusconi hanno dimostrato a Roma denunciando un golpe e la fine della democrazia". Lo stesso Berlusconi ha nuovamente gridato la sua innocenza davanti ai suoi seguaci, definendo quello di oggi "Un giorno amaro e un giorno di lutto per la democrazia". Die Welt mette prima Berlusconi di Angela Merkel nella priorità delle notizie e sottolinea che "L'ex premier italiano non reagisce in modo morbido all'espulsione dal Senato e annuncia un'opposizione serrata", e cita un duro attacco di Berlusconi alla sinistra italiana: "Oggi sono contenti perché hanno messo i loro avversari davanti al plotone di esecuzione. Sono euforici, perché aspettavano questo momento da 20 anni". Il quotidiano tedesco conclude con la frase del Cavaliere sulla scia delle parole dell'inno di Mameli: "Le parole ci Mameli le prendiamo come un dovere, siamo pronti a morire ..". Per Die Welt l'espulsione di Berlusconi dal Parlamento è un momento storico, che segna la fine della Seconda Repubblica italiana. Lo Spiegel non regala a Berlusconi la sua apertura online, ma mette la sua decadenza comunque in prima pagina. Nel sottolineare che l'ex premier non ha alcuna intenzione di arrendersi, il giornale tedesco pubblica un video che mostra i sostenitori di berlusconi assiepati fuori palazzo Grazioli a poche ore dal voto del Senato, in cui molti giovano dichiarano alle telecamere tedesche che "Loro devono decadere e non Silvio". Lo Spiegel poi affianca Berlusconi a Beppe Grillo, che guida il M5S pur stando fuori dal Parlamento, ma - comunque - scrive il quotidiano teutonico "Per il Cavaliere, in politica dal 1994, restare sulla cresta dell'onda da oggi in poi sarà molto difficile". E passiamo alla Gran Bretagna. Al momento in cui scriviamo la rivista finanziaria The Economist - che già aveva dedicato in passato copertine al vetriolo contro Berlusconi - non ha ancora pubblicato il suo commento sull'avvenuta decadenza. L'ultimo articolo dedicato alle cose della politica italiana risale al 21 novembre scorso a parla di "Una opportunità d'oro" per la politica italiana, dopo la decisione di un gruppo di ex fedelissimi di Berlusconi di passare dall'altra parte. "La divisione del partito di Berlusconi potrebbe rilanciare la coalizione di governo", scommette The Economist. Il Guardian apre la sua edizione online con la decadenza del Cavaliere e pubblica un ricco dossier sull'ex premier italiano, a cominciare da una dettagliata timeline dal titolo Ups and downs of Berlusconi's career - Alti e bassi della carriera di Berlusconi. Il quotidiano britannico, sempre molto duro nei confronti dell'ex presidente del Consiglio, sottolinea che "Con il loro leader sbattuto fuori dal Senato adesso i parlamentari di Forza Italia si cimenteranno in un'opposizione serrata e metteranno in pericolo le riforme istituzionali che il governo di Letta afferma di voler portare a termine". Immancabile la prima pagina del Financial Times che pubblica una foto scattata a Roma con un sostenitore di Berlusconi che agita un manifesto con il Cavlaiere sotto il simbolo delle Brigate Rosse e la scritta: "Prigioniero politico". Mentre il quotidiano conservatore di Londra, The Telegraph scrive nella sua apertura online: "Silvio Berlusconi, l'uomo che ha dato un nuovo significato alla parola 'faccia tosta', con aria di sfida ha promesso di rimanere al centro della politica italiana di ieri, nonostante sia stato ignominiosamente spogliato del suo seggio in parlamento a seguito di una condanna per massiccia frode fiscale". La versione in inglese di Al Jazeera , l'emittente del Qatar, mette Berlusconi nelle sue notizie di apertura, sottolineando che "L'ex primo ministro italiano è stato cacciato dal Senato in seguito alla sua condanna per frode fiscale". Ma - aggiunge Al Jazeera - "In molti credono che il 77enne possa risorgere ancora". Andiamo ora dall'altra parte dell'oceano. Berlusconi campeggia sulle homepage delle principali testate statunitensi. Sul Wall Street Journal la sua decadenza è la notizia di apertura. Il quotidiano della City americana titola sul "Voto per espellere il politico miliardario condannato per frode fiscale". La testata finanziaria sottolinea che la decadenza di Berlusconi "Ha segnato il culmine di quasi quattro mesi di furore politico che ha avuto inizio in agosto con la condanna per frode fiscale dell'uomo che ha dominato la vita politica italiana per due decenni". In più il WSJ pubblica la storia di Berlusconi e una sua gallery di foto. Il New York Times dà a Berlusconi la sua prestigiosa colonna di sinistra in homepage. L'articolo è firmato da Jim Yardley, che scrive che "L'ex primo ministro, un tempo molto potente, è stato allontanato dal Senato". Yardley prosegue dicendo che "Dopo aver speso mesi fabbricando ad arte ritardi procedurali o congiurando melodrammi politici con il fine di salvarsi, Silvio Berlusconi oggi ha dovuto accettare l'inevitabile: essere espulso dal Senato, un'espulsione tragica ed umiliante, mentre altri potenziali problemi si profilano al suo orizzonte". Il Washington Post preferisce invece aprire sulla politica interna americana e poi passare solo in seconda battuta al caso della decadenza del Cavaliere. E sulla "resistenza" di Berlusconi il giornale di Washington è possibilista: "Anche se Berlusconi non avrà più un seggio in Parlamento - scrive il giornalista - in molti si aspettano che resti comunque influente nella politica italiana". Grancassa decadenza sul quotidiano spagnolo El Pais, che dedica un'apertura a 8 colonne a Berlusconi e un corposo dossier che ricorda - passo dopo passo - tutta la storia del Cavaliere, dalla sua discesa in campo all'espulsione dal Senato. Corredano il dossier due gallery di immagini. L'incipit dell'articolo principale del quotidiano progressista spagnolo ha toni molto ironici: "Dicono che (Berlusconi) non dorma da molti giorni, che alterna momenti di depressione profonda con altri di un'euforia spropositata che lo porta a esclamare: "Giuro che tornerò a Palazzo Chigi [la sede del Governo]. Il sempre teatrale Silvio Berlusconi sta perdendo la bussola. E, a pensarci bene, questa non è una sorpresa". Meno ironico e più ottimista per le sorti del Cavaliere il quotidiano El Mundo , di area conservatrice. In un editoriale a firma di Miguel Cabanillas che commenta la notizia sulla decadenza pubblicata in apertura dell'edizione online, si definisce Berlusconi "Un'araba fenice con molti epitaffi politici sulle spalle". Un politico sempre pronto a sorprendere e a rinascere. "Come un'araba fenice che rinasce dalle sue cenerei quando tutti lo danno per politicamente morto, il magnate italiano - scrive Cabanillas - non rinuncia al pedigree della sua vita che, nelle ultime due decadi, lo ha trasformato in uno dei leader più popolari nel mondo, idolatrato da una parte e odiato dall'altra". Infine, El Pais riporta le parole dell'ex premier italiano che oggi ha dichiarato: "La battaglia non è ancora finita". Fuoco di fila contro Berlusconi sui quotidiani francesi. Le Monde titola in apertura: "L'Italia senza Berlusconi" e pubblica un corposo dossier che include "I suoi 20 anni di processi" e un articolo sui "Fedelissimi che lo hanno abbandonato passando all'opposizione". Liberation pubblica la notizia tra le prime ma non in apertura e sottolinea il j'accuse di Berlusconi che si dice "vittima di una persecuzione" politica e giudiziaria. Per Le Figaro (quotidiano conservatore) "Questo è l'ultimo atto di una discesa agli Inferi cominciata a novembre de 2011", quando Silvio Berlusconi fu "Attaccato dai mercati, umiliato al G20 di Cannes e congedato dal presidente Giorgio Napolitano che lo ha rimpiazzato al governo con l'economista Mario Monti. Apertura anche per O Globo , primo quotidiano brasiliano, che senza mezzi termini titola: "Il Senato italiano fa fuori Berlusconi" e poi pubblica un dossier che inizia con un articolo di commento che recita: "Berlusconi, la fine è arrivata", con fotografie di manifestanti anti-Cavaliere fuori dal Senato in attesa dell'esito della votazione. O Globo cita anche un twit di Beppe Grillo, che festeggia "cinguettando" la decadenza scrivendo: "Berlusconi è stato licenziato dal Senato. Uno di loro è fuori. Ora dobbiamo mandare a casa anche tutti gli altri". Infine, prima pagina per Berlusconi anche sui principali media turchi. Hurriyet scrive che "La decisione del Senato potrebbe essere uno spartiacque nella carriera del leader che ha dominato la politica italiana per due decenni". Il quotidiano di Ankara così commenta: "Il voto, che arriva dopo mesi di scontri politici, apre una fase incerta nella politica italiana, con il 77enne miliardario che si prepara a usare tutte le sue enormi risorse per attaccare la coalizione di Governo guidata dal premier Enrico Letta".
Il Cav fu costretto da Napolitano a dimettersi perché voleva che l'Italia uscisse dall'euro, scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Alla luce delle recenti rivelazioni, si conferma che il 12 novembre 2011 Berlusconi fu costretto da Napolitano a dimettersi da presidente del Consiglio, pur in assenza di un voto di sfiducia del Parlamento, perché in seno ai vertici dell'Ue aveva ventilato la possibilità che l'Italia esca dall'euro. Di fatto fu un colpo di Stato ordinato dai poteri forti in seno all'Unione europea e alla Bce, innanzitutto la Germania di Angela Merkel, manovrando l'impennata dello spread (il differenziale tra Btp-Bund) che sfiorò i 600 punti alimentando un clima di terrorismo finanziario, politico e mediatico, con la connivenza dei poteri finanziari speculativi che determinarono il crollo delle azioni Mediaset in Borsa, realizzato con un comportamento autocratico di Napolitano che in quattro giorni ottenne le dimissioni di Berlusconi, nominò Mario Monti senatore a vita e lo impose a capo di un governo tecnocratico a cui lo stesso Berlusconi fu costretto a dare fiducia. Questo complotto contro il governo legittimo di uno Stato sovrano va ben oltre l'ambito personale. Lorenzo Bini Smaghi, membro del Comitato esecutivo della Bce dal giugno 2005 al 10 novembre 2011, a pagina 40 del suo recente libro Morire d'austerità rivela: «Non è un caso che le dimissioni del primo ministro greco Papandreou siano avvenute pochi giorni dopo il suo annuncio di tenere un referendum sull'euro e che quelle di Berlusconi siano anch'esse avvenute dopo che l'ipotesi di uscita dall'euro era stata ventilata in colloqui privati con i governi degli altri Paesi dell'euro». Hans-Werner Sinn, presidente dell'Istat tedesco, durante il convegno economico Fuehrungstreffen Wirtschaft 2013 organizzato a Berlino dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung, ha rivelato negli scorsi giorni: «Sappiamo che nell'autunno 2011 Berlusconi ha avviato trattative per far uscire l'Italia dall'euro». Lo stesso Berlusconi, intervenendo sabato scorso a un raduno della Giovane Italia, ha rivelato: «Oggi operiamo con una moneta straniera, che è l'euro»; «Siamo nelle stesse condizioni dell'Argentina che emetteva titoli in dollari»; «Il Giappone ha un debito pubblico del 243% rispetto al Pil ma ha sovranità monetaria»; «Le mie posizioni nell'Ue hanno infastidito la Germania»; «La Germania ordinò alle sue banche di vendere i titoli italiani per far salire lo spread, provocando l'effetto gregge»; «Nel giugno 2011 Monti e Passera preparavano già il programma del governo tecnico»; «Nel 2011 ci fu una volontà precisa di far fuori il nostro governo»; «Al Quirinale mi dissero che per il bene del Paese avrei dovuto cedere la guida del governo ai tecnici». Nessuno si illude che la magistratura, ideologicamente schierata a favore della sinistra, interverrà per sanzionare Napolitano (che è il presidente del Csm) o per salvaguardare la sovranità nazionale dell'Italia dalla dittatura dell'Eurocrazia e della finanza globalizzata. Dobbiamo prendere atto che siamo in guerra. Abbiamo perso del tutto la sovranità monetaria, all'80% la sovranità legislativa e ci stanno spogliando della sovranità nazionale. Berlusconi, a 77 anni, limitato sul piano dell'agibilità politica, può oggi dare un senso alto alla sua missione politica contribuendo con tutto il suo carisma e le sue risorse al riscatto della nostra sovranità monetaria, legislativa, giudiziaria e nazionale dalla schiavitù dell'euro, dalla sudditanza di questa Ue alla Germania, ai banchieri e ai burocrati, dalla partitocrazia consociativa che ha ucciso la democrazia sostanziale e lo Stato di diritto, perpetuando uno Stato onerosissimo che impone il più alto livello di tassazione al mondo che finisce per condannare a morte le imprese. Ma bisogna rompere ogni indugio schierandosi con imprenditori, famiglie, sindaci e forze dell'ordine, promuovendo subito la rete di tutti coloro che condividono la missione di salvare gli italiani e far rinascere l'Italia libera, sovrana e federalista. Zapatero rivela: il Cav obiettivo di un attacco dei leader europei.
In un libro l'ex premier spagnolo svela i retroscena del G20 di Cannes nel 2011 e il pressing sull'Italia per accettare i diktat Fmi: "Si parlava già di Monti", scrive Riccardo Pelliccetti su “Il Giornale”. Vorremmo dire «clamoroso», ma non è così perché sapevamo da tempo, e lo abbiamo più volte scritto, che non solo in Italia ma anche dall'estero arrivavano pesanti pressioni per far fuori Silvio Berlusconi. L'ultima prova, che conferma la volontà di rovesciare un governo democraticamente eletto, la rivela l'ex premier spagnolo Luis Zapatero, che nel libro El dilema (Il dilemma), presentato a Madrid, porta alla luce inediti retroscena sulla crisi che minacciò di spaccare l'Eurozona. Il 3 e 4 novembre 2011 sono i giorni ad altissima tensione del vertice del G-20 a Cannes, sulla Costa Azzurra. Tutti gli occhi sono puntati su Italia e Spagna che, dopo la Grecia, sono diventate l'anello debole per la tenuta dell'euro. Il presidente americano Barack Obama e la cancelliera tedesca Angela Merkel mettono alle corde Berlusconi e Zapatero, cercando di imporre all'Italia e alla Spagna gli aiuti del Fondo monetario internazionale. I due premier resistono, consapevoli che il salvataggio da parte del Fmi avrebbe significato accettare condizioni capestro e cedere di fatto la sovranità a Bruxelles, com'era già accaduto con Grecia, Portogallo e Cipro. Ma la Germania con gli altri Paesi nordici, impauriti dagli attacchi speculativi dei mercati, considerano il vertice di Cannes decisivo e vogliono risultati a qualsiasi costo. Le pressioni sono altissime. Zapatero descrive la cena del 3 novembre, con il tavolo «piccolo e rettangolare per favorire la vicinanza e un clima di fiducia». Ma l'atmosfera è esplosiva. «Nei corridoi si parlava di Mario Monti», rivela il premier spagnolo. Già, Monti. Che solo una settimana dopo sarà nominato senatore a vita da Napolitano e che il 12 novembre diventerà premier al posto di Berlusconi. Il piano era già congegnato, con il Quirinale pronto a soggiacere ai desiderata dei mercati e di Berlino. La Merkel domanda a Zapatero se sia disponibile «a chiedere una linea di credito preventiva di 50 miliardi di euro al Fondo monetario internazionale, mentre altri 85 sarebbero andati all'Italia. La mia risposta fu diretta e chiara: no», scrive l'ex premier spagnolo. Allora i leader presenti concentrano le pressioni sul governo italiano perché chieda il salvataggio, sperando di arginare così la crisi dell'euro. «C'era un ambiente estremamente critico verso il governo italiano», ricorda Zapatero, descrivendo la folle corsa dello spread e l'impossibilità da parte del nostro Paese di finanziare il debito con tassi che sfiorano il 6,5 per cento. Insomma, i leader del G-20 sono terrorizzati dai mercati e temono che il contagio possa estendersi a Paesi europei come la Francia se non prendono il toro per le corna. Il toro in questo caso è l'Italia. «Momenti di tensione, seri rimproveri, invocazioni storiche, perfino invettive sul ruolo degli alleati dopo la seconda guerra mondiale...», caratterizzano il vertice. «Davanti a questo attacco - racconta l'ex leader socialista spagnolo - ricordo la strenua difesa, un catenaccio in piena regola» di Berlusconi e del ministro dell'Economia Giulio Tremonti. «Entrambi allontanano il pallone dall'area, con gli argomenti più tecnici Tremonti o con le invocazioni più domestiche di Berlusconi», che sottolinea la capacità di risparmio degli italiani. «Mi è rimasta impressa una frase che Tremonti ripeteva: conosco modi migliori di suicidio». Alla fine si raggiunge un compromesso, con Berlusconi che accetta la supervisione del Fmi ma non il salvataggio. Ma tutto ciò costerà caro al Cavaliere. «È un fatto - sostiene Zapatero - che da lì a poco ebbe effetti importantissimi sull'esecutivo italiano, con le dimissioni di Berlusconi, dopo l'approvazione della Finanziaria con le misure di austerità richieste dall'Unione europea, e il successivo incarico al nuovo governo tecnico guidato da Mario Monti».
Un governo, ora sappiamo con certezza, eletto da leader stranieri nei corridoi di Cannes e non dalla volontà popolare degli italiani. Verrà un giorno in cui l’Italia troverà il coraggio e l’onestà di rileggere (alcuni, se la coscienza li soccorrerà, lo faranno non senza vergogna) la storia di questi giorni, prima ancora di dedicarsi all’analisi del cosiddetto ventennio di Silvio Berlusconi. Perché è da qui, dai giorni tristi e terribili dell’umiliazione del Diritto, che bisognerà partire per spiegare come sia stato possibile arrivare al sabbah giacobino contro il Cavaliere al Senato in barba a regole, buon senso e dignità, scrive Giorgio Mulè, direttore di “Panorama”, nel suo editoriale. Era cominciato tutto dopo la sentenza di condanna del 2 agosto emessa (prima anomalia) da una sezione feriale della Cassazione, presieduta da un magistrato chiacchierone (seconda anomalia) che non avrebbe dovuto giudicare l’ex premier. Una sentenza in palese contraddizione con i verdetti di due sezioni «titolari» della Suprema corte (terza anomalia) che avevano valutato le stesse identiche prove nella vicenda della compravendita dei diritti televisivi giungendo alla conclusione opposta, e cioè che l’ex premier era innocente. Ma innocente nel profondo, senza ombra di dubbio e senza nemmeno una formula dubitativa che, come un sigaro, non si nega mai a nessuno. Una classe politica prigioniera della sua mediocrità e ossessionata dalla presenza di Berlusconi non poteva far altro che cogliere l’occasione. A cominciare da Beppe Grillo e dai suoi accoliti, arrivati in Parlamento con l’ambizioso programma fondato sull’eliminazione del Cav. Così, dal 2 agosto, è iniziata una corsa orgiastica e forsennata per liberarsi dell’odiato Caimano. In prima fila, a battere il tamburo per la caccia grossa, ci sono stati sempre loro, gli avanguardisti della Repubblica con i cugini del Fatto quotidiano, la falange editoriale che tiene al guinzaglio la mejo sinistra e che ha sempre vissuto con il complesso di disfarsi del male assoluto incarnato nell’uomo di Arcore. Il tutto portato avanti con la solita tecnica becera delle inchieste da buco della serratura grazie all’ausilio di compiacenti magistrati (quarta anomalia), della lettura distorta degli atti, del moralismo ipocrita un tanto al chilo e a senso unico. Una sentina maleodorante spacciata per giornalismo nobile dove si sorvola se a finire accusato di gravissimi reati c’è Carlo De Benedetti. Chi poteva fermare questa ordalia non l’ha fatto. Avrebbe potuto e dovuto farlo Giorgio Napolitano, in virtù dell’alto ed esclusivo ruolo che gli assegna la Costituzione. Avrebbe dovuto usare la tanto sbandierata moral suasion (quinta anomalia) per ricondurre alla ragione i sanculotti del suo ex partito e provare nell’ardua impresa di riuscirci con gli attuali maggiorenti; a cominciare da Matteo Renzi che scimmiotta Fonzie, si indigna per una battuta in un cartone animato dei Simpson e non si rende conto di essere la copia spiccicata (per la profondità delle riflessioni…) del simpatico Kermit, il leader indiscusso dei pupazzi del Muppet show. E invece dal Colle sono venute fuori interpretazioni pelose delle procedure e più o meno pubblici risentimenti per le sacrosante lamentele espresse da un Berlusconi profondamente deluso. Bisogna prendere atto chiaramente che Napolitano poteva concedere la grazia al Cavaliere e non solo per la pena principale ma anche per quella accessoria, cioè l’interdizione dai pubblici uffici, eventualità da lui espressamente negata nella lunga nota del 13 agosto. Non è vero che per la concessione del beneficio fosse necessario aver accettato la sentenza o aver iniziato a espiare la pena (sesta anomalia). È una balla. Il 5 aprile di quest’anno, il Quirinale comunicava: «Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ai sensi dell’articolo 87, comma 11, della Costituzione, ha oggi concesso la grazia al colonnello Joseph L. Romano III, in relazione alla condanna alla pena della reclusione (7 anni, ndr) e alle pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici, ndr) inflitta con sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2012. La decisione è stata assunta dopo aver acquisito la documentazione relativa alla domanda avanzata dal difensore avvocato Cesare Graziano Bulgheroni, le osservazioni contrarie del procuratore generale di Milano e il parere non ostativo del ministro della Giustizia». Per la cronaca: il colonnello era fra gli imputati del rapimento e delle successive torture dell’imam Abu Omar, non si è presentato mai al processo, non ha mai confessato alcunché, non si è mai pentito del gesto, non ha chiesto scusa a nessuno, non ha mai scontato un giorno di carcere e per la giustizia italiana era un latitante al pari del superboss Matteo Messina Denaro. La grazia giunse dal Colle dopo appena 7 mesi dalla pronuncia definitiva della Cassazione e con il parere contrario dei magistrati. C’è ancora qualche anima bella o dannata disposta a sostenere la tesi che il presidente della Repubblica non poteva adottare lo stesso metodo nei confronti di Silvio Berlusconi? Chiamiamo le cose con il loro nome: è mancato il coraggio per concedere la grazia. Il provvedimento avrebbe aperto una fase nuova nella storia di questo Paese, sarebbe stato l’atto di non ritorno verso la pacificazione dopo vent’anni di guerra combattuta nel nome dell’eliminazione per via giudiziaria del Cavaliere il quale, statene certi, avrebbe abbandonato la politica attiva. Il capo dello Stato ha avuto l’opportunità di consegnarsi alla storia e non l’ha fatto. E solo quando giungerà quel famoso giorno in cui gli avvenimenti di oggi potranno essere riletti senza veli e senza partigianerie capiremo se al suo mancato gesto dovremo aggiungere i caratteri poco commendevoli del cinismo, della pavidità o del calcolo politico. Nel quadro tenebroso dell’oggi trova un posto nitido Enrico Letta, il presidente del Consiglio che ha conferito a questo Paese una stabilità degna di un cimitero, come ha giustamente notato il Wall Street Journal. Incapace di avviare le riforme oramai improcrastinabili per l’Italia, Letta non è stato neppure capace di imporre il più impercettibile distinguo sulla giustizia (settima anomalia) ed è rimasto avvinghiato al doroteismo stucchevole di una linea che voleva tenere distinte la vicenda di Berlusconi e le sorti dell’esecutivo quando anche un bambino ne coglieva l’intimo intreccio. Ma i bambini, si sa, hanno la vista lunga. E ora tutti sanno, anche quelli dell’asilo, che l’unico orizzonte di Letta non è quello di varare le riforme, giustizia compresa, ma quello di mantenere il potere. E infatti eccoci all’ottava anomalia, Angelino Alfano: ha mollato il Pdl per fondare il Nuovo centrodestra, che al momento si distingue solo per la fedeltà interessata al governo. Sarebbe toccato proprio ad Angelino costringere Napolitano e Letta a guardare la realtà, a spalancare gli occhi sullo scempio del diritto che si stava consumando, a denunciare con argomenti solidi e di verità l’inganno di una procedura interpretata in maniera torbida e manigolda. Come quella della retroattività della legge Severino sulla decadenza (nona anomalia), che una pletora di giuristi e politici di buon senso non affini ma certamente lontani dal mondo berlusconiano voleva affidare al vaglio della Corte costituzionale per un’interpretazione autentica. Anche per questo motivo il luogotenente del Cav avrebbe dovuto elevare il caso B a caso internazionale, avrebbe dovuto sfidare in campo aperto i satrapi dell’informazione truccata. E invece ha preferito chinarsi sulla propria poltroncina, talmente affascinato, e impaurito di perderla, da consumare lo strappo di ogni linea politica e di ogni rapporto umano con il proprio leader. Napolitano, Letta, Alfano: in questo triangolo delle Bermude, che si autoalimenta nel nome dello status quo e di un governo fatto solo di tasse e bugie, c’è finito Silvio Berlusconi. E la conclusione della storia è stata ovvia: l’hanno inghiottito, macinato ed espulso senza tanti complimenti. Neppure il colpo di reni finale hanno sfruttato i tre del triangolo mortale, quello offerto dalle nuove prove squadernate dall’ex premier per chiedere la revisione del processo. Un percorso perfettamente legalitario, quello del Cav, condotto all’interno del perimetro disegnato dal Codice di procedura penale e che avrebbe dovuto fermare la mannaia dell’espulsione dal Senato. Per mille motivi, ma soprattutto per una possibile e atroce beffa: se la Corte d’appello darà ragione al Cavaliere e lo proscioglierà, lui si troverà già fuori da Palazzo Madama. E nessuno potrà dirgli: «Prego, ci scusi, si accomodi e riprenda il suo posto». Con il corollario non secondario che, senza lo scudo da senatore, i picadores in toga potranno infilzare il Cav e compiere l’ultimo sfregio: l’arresto (decima anomalia). In questa cornice assai triste tocca togliersi il cappello di fronte al coraggio di Francesco Boccia, deputato del Pd di prima fila (almeno fino al 9 dicembre, quando Matteo «Kermit» si presenterà sul palco della segreteria del partito) che martedì 26 novembre, dopo aver visto gli elementi esposti da Berlusconi, ha dichiarato: «Se fosse così mi aspetto una revisione del processo come per qualsiasi altro cittadino». E ancora: «In un Paese normale si sarebbe aspettata la delibera della Corte costituzionale sull’interpretazione della legge Severino». Un Paese normale questo? È una battutona, ditelo a Matteo «Kermit», che magari se la rivende. Dovrà fare in fretta, però. Perché adesso inizia un’altra faida, che lo metterà contro Letta e Napolitano. I tre non possono convivere: i loro interessi non sono convergenti, i loro orizzonti non corrispondono. Per questo, già prima dell’8 dicembre, ne vedremo delle belle. Sarà il seguito della politica da avanspettacolo che ci hanno rifilato negli ultimi mesi. Successe più o meno la stessa cosa ai tempi di monsieur de Robespierre e dei giacobini. Fatto fuori il re, si illusero di avere la Francia in pugno. Manco per niente. Iniziarono a scannarsi l’un l’altro. Fin quando un giorno accompagnarono Robespierre, l’Incorruttibile, al patibolo. Gli gridavano dietro: «Morte al tiranno». Avete capito la storia?
Dopo gli Anni di piombo e le decine di magistrati uccisi dalle Brigate rosse e dall'eversione di destra e di sinistra la corrente di Md più vicina al Partito comunista scala le gerarchie della magistratura e impone il suo diktat, come racconta al Giornale un ex giudice di Md: «Serve una giurisprudenza alternativa per legittimare la lotta di classe e una nuova pace sociale». Ma serviva una legittimazione incrociata. Non dallo Stato né dal popolo, ma da quel Pci diventato Pds in crisi d'identità dopo il crollo del Muro di Berlino. Tangentopoli nacque grazie a un matrimonio d'interessi e un nemico comune: Bettino Craxi.
Quell'abbraccio tra Pci e Md che fece scattare Mani pulite. Magistratura democratica pianificò l'alleanza col Pds sul giustizialismo per ridare smalto alle toghe e offrire agli eredi del Pci il ruolo di moralizzatore contro la corruzione in Italia, scrive Sergio d'Angelo su “Il Giornale”. «La piattaforma politico-programmatica elaborata per la nuova Magistratura democratica poteva convincere ed attirare buona parte dei giovani magistrati, cresciuti politicamente e culturalmente nel crogiolo sessantottino. Ma bisognava fornire a Md una base giuridica teorica che potesse essere accettata dal mondo accademico e da una parte consistente della magistratura. Ancora una volta fu la genialità di Luigi Ferrajoli a trovare una risposta: «La giurisprudenza alternativa (...) è diretta ad aprire e legittimare (...) nuovi e più ampi spazi alle lotte delle masse in vista di nuovi e alternativi assetti di potere (...). Una formula che configura il giudice come mediatore dei conflitti in funzione di una pace sociale sempre meglio adeguata alle necessità della società capitalistica in trasformazione». In qualunque democrazia matura la prospettiva tracciata da Ferrajoli non avrebbe suscitato altro che una normale discussione accademica tra addetti ai lavori: ma la verità dirompente era tutta italiana. Celato da slogan pseudorivoluzionari, il dibattito nel corpo giudiziario ad opera di Md negli anni '70 e '80 presentava questo tema fondamentale: a chi spetta assicurare ai cittadini nuovi fondamentali diritti privati e sociali? Al potere politico (e di quale colore) attraverso l'emanazione di norme (almeno all'apparenza) generali ed astratte, o all'ordine giudiziario con la propria giurisprudenza «alternativa»? Un dubbio devastante cominciò a infiltrarsi tra i magistrati di Md. Se la magistratura (o almeno la sua parte «democratica») era una componente organica del movimento di classe e delle lotte proletarie, allora da dove proveniva la legittimazione dei giudici a «fare giustizia»? Dallo Stato (come era quasi sempre accaduto), che li aveva assunti previo concorso e li pagava non certo perché sovvertissero l'ordine sociale? Dal popolo sovrano? Da un partito? Quelli furono anni tragici per l'Italia. Tutte le migliori energie della magistratura furono indirizzate a combattere i movimenti eversivi che avevano scelto la lotta armata e la sfida violenta allo Stato borghese: i giudici «democratici» pagarono un prezzo elevato, l'ala sinistra della corrente di Md rimase isolata mentre l'ala filo-Pci di Md mantenne un basso profilo. Dell'onore postumo legato al pesante prezzo di sangue pagato dai giudici per mano brigatista beneficiarono indistintamente tutte le correnti dell'ordine giudiziario, compresa Md e la magistratura utilizzò questo vernissage per rifarsi un look socialmente accettabile. Solo la frazione di estrema sinistra di Md ne fu tagliata fuori, e questo determinò - alla lunga - la sua estinzione. Alcuni furono - per così dire - «epurati»; a molti altri fu garantito un cursus honorum di tutto rispetto, che fu pagato per molti anni a venire (Europarlamento, Parlamento nazionale, cariche prestigiose per chi si dimetteva, carriere brillanti e fulminee per altri). Quelli che non si rassegnarono furono di fatto costretti al silenzio e poi «suicidati» come Michele Coiro, già procuratore della Repubblica di Roma, colpito il 22 giugno 1997 da infarto mortale, dopo essere stato allontanato dal suo ruolo (promoveatur ut amoveatur) dal Csm. L'ala filo Pci/Pds di Md, vittoriosa all'interno della corrente, non era né poteva diventare un partito, in quanto parte della burocrazia statale. Cercava comunque alleati per almeno due ragioni: difendere e rivalutare un patrimonio di elaborazione teorica passato quasi indenne attraverso il terrorismo di estrema sinistra e la lotta armata e garantire all'intera «ultracasta» dei magistrati gli stessi privilegi (economici e di status) acquisiti nel passato, pericolosamente messi in discussione fin dai primi anni '90. Questo secondo aspetto avrebbe di sicuro assicurato alla «nuova» Md l'egemonia (se non numerica certo culturale) sull'intera magistratura associata: l'intesa andava dunque trovata sul terreno politico, rivitalizzando le parole d'ordine dell'autonomia e indipendenza della magistratura, rivendicando il controllo di legalità su una certa politica e proclamando l'inscindibilità tra le funzioni di giudice e pubblico ministero. Non ci volle molto ad individuare i partiti «nemici» e quelli potenzialmente interessati ad un'alleanza di reciproca utilità. Alla fine degli anni '80 il Pci sprofondò in una gravissima crisi di identità per gli eventi che avevano colpito il regime comunista dell'Urss. Non sarebbe stato sufficiente un cambiamento di look: era indispensabile un'alleanza di interessi fondata sul giustizialismo, che esercitava grande fascino tra i cittadini, in quanto forniva loro l'illusione di una sorta di Nemesi storica contro le classi dirigenti nazionali, che avevano dato pessima prova di sé sotto tutti i punti di vista. La rivincita dei buoni contro i cattivi, finalmente, per di più in forme perfettamente legali e sotto l'egida dei «duri e puri» magistrati, che si limitavano a svolgere il proprio lavoro «in nome del popolo». Pochi compresero che sotto l'adempimento di un mero dovere professionale poteva nascondersi un nuovo Torquemada. Il Pci/Pds uscì quasi indenne dagli attacchi «dimostrativi» (tali alla fine si rivelarono) della magistratura che furono inseriti nell'enorme calderone noto come Mani Pulite: d'altronde il «vero» nemico era già perfettamente inquadrato nel mirino: Bettino Craxi. Chi scrive non è ovviamente in grado di dire come, quando e ad opera di chi la trattativa si sviluppò: ma essa è nei fatti, ed è dimostrata dal perfetto incastrarsi (perfino temporale) dei due interessi convergenti. Naturalmente esistono alleanze che si costituiscono tacitamente, secondo il principio che «il nemico del mio nemico è mio amico», e non c'è bisogno di clausole sottoscritte per consacrarle. Quando il pool graziò il Pds e i giudici diventarono casta. Mani pulite con la regia di Md sfiorò il partito per dimostrare che avrebbe potuto colpire tutti Il Parlamento si arrese, rinunciando all'immunità. E così consegnò il Paese ai magistrati - continua Sergio d'Angelo su “Il Giornale”. - Per rendersi credibile alla magistratura, il tacito accordo tra Md e Pds avrebbe dovuto coinvolgere magistrati della più varia estrazione e provenienza politica e culturale. Nel 1989 era entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale che apriva la strada ad un'attività dell'accusa priva di qualunque freno, nonostante l'introduzione del Gip (giudice delle indagini preliminari), in funzione di garanzia dei diritti della difesa. C'è un significativo documento - intitolato I mestieri del giudice - redatto dalla sezione milanese di Md a conclusione di un convegno tenutosi a Renate il 12 marzo 1988, in casa del pm Gherardo Colombo. In quel testo l'allora pm di Milano Riccardo Targetti tracciò una netta distinzione tra «pm dinamico» e «pm statico», schierandosi naturalmente a favore della prima tipologia, come il nuovo codice gli consentiva di fare. Che cosa legava tra loro i componenti del pool Mani pulite? Nulla. Che Gerardo D'Ambrosio (chiamato affettuosamente dai colleghi zio Jerry) fosse «vicino» al Pci lo si sapeva (lui stesso non ne faceva mistero), ma non si dichiarò mai militante attivo di Md. Gherardo Colombo era noto per aver guidato la perquisizione della villa di Licio Gelli da cui saltò fuori l'elenco degli iscritti alla P2: politicamente militava nella sinistra di Md, anche se su posizioni moderate. Piercamillo Davigo era notoriamente un esponente di Magistratura indipendente, la corrente più a destra. Francesco Greco era legato ai gruppuscoli dell'estrema sinistra romana (lui stesso ne narrava le vicende per così dire «domestiche»), ma nel pool tenne sempre una posizione piuttosto defilata. Infine, Di Pietro, una meteora che cominciò ad acquistare notorietà per il cosiddetto «processo patenti» (che fece piazza pulita della corruzione nella Motorizzazione civile di Milano) e l'informatizzazione accelerata dei suoi metodi di indagine, per la quale si avvalse dell'aiuto di due carabinieri esperti di informatica. Il 28 febbraio 1993, a un anno dall'arresto di Mario Chiesa, cominciano a manifestarsi le prime avvisaglie di un possibile coinvolgimento del Pds nell'inchiesta Mani pulite con il conto svizzero di Primo Greganti alias «compagno G» militante del partito, che sembra frutto di una grossa tangente. Il 6 marzo fu varato il decreto-legge Conso che depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti. Il procuratore Francesco Saverio Borrelli va in tv a leggere un comunicato: la divisione dei poteri nel nostro Paese non c'era più. Il presidente Oscar Luigi Scalfaro si rifiuta di firmare il decreto, affossandolo. Alla fine di settembre il cerchio sembra stringersi sempre di più intorno al Pds, per tangenti su Malpensa 2000 e metropolitana milanese: tra smentite del procuratore di Milano Borrelli e timori di avvisi di garanzia per Occhetto e D'Alema, la Quercia è nel panico. Il 5 ottobre Il Manifesto titola I giudici scagionano il Pds: l'incipit dell'articolo - a firma Renata Fontanelli - è il seguente: «. La posizione di Marcello Stefanini, segretario amministrativo della Quercia e parlamentare, verrà stralciata e Primo Greganti (il «compagno G») verrà ritenuto un volgare millantatore. Il gip Italo Ghitti (meglio noto tra gli avvocati come «il nano malefico») impone alla Procura di Milano di indagare per altri quattro mesi poi il 26 ottobre come titola il Manifesto a pagina 4 titola D'Ambrosio si ritira dal pool per impedire speculazioni sui suoi rapporti «amicali» con il Pds. Quali indicazioni si possono trarre da questa vicenda? Il pool dimostrò che la magistratura sarebbe stata in grado di colpire tutti i partiti, Pds compreso; la Quercia era ormai un partito senza ideologia e il suo elettorato si stava fortemente assottigliando (era al 16%): c'era dunque la necessità di trovare un pensiero politico di ricambio, che poteva venire solo dall'esterno; nessuna forza politica avrebbe mai potuto modificare l'assetto istituzionale nonché l'ordinamento giudiziario senza il consenso della magistratura; alla magistratura fu fatto quindi comprendere che l'unico modo di conservare i propri privilegi sarebbe stato quello di allearsi con un partito in cerca di ideologia. Il Psi con Bettino Craxi, Claudio Martelli e Giuliano Amato avevano minacciato o promesso un drastico ridimensionamento dei poteri e privilegi dell'ordine giudiziario. Ma la reazione delle toghe fu tanto forte da indurre un Parlamento letteralmente sotto assedio e atterrito a rinunciare ad uno dei cardini fondamentali voluto dai costituenti a garanzia della divisione dei poteri: l'immunità parlamentare. A questo punto il pallino passò al Pds, che non tardò a giocarselo. Senza una vera riforma il Paese resterà ostaggio del potere giudiziario. I giudici sono scesi in guerra per non rinunciare ai privilegi, guidati dalla nuova "giustizia di classe" che Md è riuscita a imporre alle toghe. È arrivato il momento di tirare le somme su quanto è accaduto tra magistratura e politica negli ultimi venti anni. Magistratura democratica avrebbe dovuto rappresentare una componente del «movimento di classe» antagonista allo sviluppo capitalistico della società. L'ala filo-Pci della corrente fu decisamente contraria a questa scelta così netta, e per molti anni praticò una sorta di «entrismo» (né aderire né sabotare). La scelta di classe operata dalla sinistra di Md presentava rischi pesantissimi di isolamento all'interno della magistratura e tra le forze politiche egemoni nella sinistra, che la lotta armata delle brigate rosse evidenziò immediatamente nel corso degli anni '80 («né con lo Stato né con le Br? I brigatisti compagni che sbagliano?»). Alla fine degli Anni di piombo, in pratica l'ala «rivoluzionaria» della magistratura non esisteva già più, e quella filo-Pci ebbe campo libero. Il crollo dell'Urss gettò il partito egemone della sinistra nello sconcerto: il Pci non aveva più un'ideologia, né il cambiamento di sigla (Pds) poteva rivitalizzarlo. Al contrario, l'ala di Md filo Pci/Pds aveva costruito una immagine ed una ideologia di sé stessa - pagata anche col sangue di suoi aderenti di spicco - che poteva essere spesa su qualunque piazza, ma le mancava un alleato sotto la forma partito. L'interesse di entrambi era comunque troppo forte perché l'alleanza sfumasse, anche se non mancarono resistenze e ricatti reciproci: così, il Pci/Pds fu duramente minacciato (ed anche in piccola parte colpito) durante la stagione di Mani Pulite. Alla fine, intorno al 1994, l'alleanza andò in porto, e un partito senza ideologia accolse e fece propria (probabilmente senza salti di gioia) un'ideologia senza partito. Due ostacoli, tuttavia, si frapponevano tra questa alleanza e la conquista del potere: uno era il cosiddetto Caf (Craxi, Andreotti, Forlani); l'altro era interno alla magistratura, formato da tutti quei giudici che da sponde opposte si opponevano a questa operazione. Il primo ostacolo fu eliminato attraverso Mani pulite, al secondo si applicarono vari metodi; dal promoveatur ut amoveatur, ai procedimenti disciplinari, alla elevazione al soglio parlamentare eccetera. Così la magistratura più restia fu lusingata con l'obiettivo di mantenere i privilegi e la fetta di potere (anche economico) cui era stata abituata, al punto di farle accettare impunemente l'accordo che era sotto gli occhi di tutti. Il compito di questa Md era pressochè esaurito, in quanto il nemico principale (il Caf ma soprattutto Bettino Craxi) era stato abbattuto. Quando un nuovo nemico si presentò all'orizzonte, i cani da guardia dell'accordo (ora la magistratura nel suo complesso) non ci misero molto a tirar fuori zanne ed artigli, con l'appoggio del loro referente politico. Fantasie, opinioni personali, dirà qualcuno. Può darsi, ma certo occorre riflettere su tre punti cruciali dell'inchiesta Mani pulite, che sono - come tanti altri elementi - caduti nel dimenticatoio della Storia. Come abbiamo detto in precedenza, tra i membri del pool non c'era assolutamente nessuna identità culturale o «politica», e non può non destare perplessità la circostanza che essi furono messi insieme per compiere un'operazione così complessa e delicata: fu davvero per garantire il pluralismo e l'equidistanza fra i soggetti coinvolti o, come abbiamo sostenuto, per raccogliere e compattare tutte le diverse anime della magistratura? Quando esattamente fu costituito il pool? Al riguardo non abbiamo nessuna certezza, ma di sicuro esso esisteva già il 17 febbraio 1992, data dell'arresto di Mario Chiesa: chi, nei palazzi di giustizia milanesi e non solo, aveva la sfera di cristallo? L'allora console statunitense a Milano Peter Semler dichiarò di aver ricevuto da Antonio Di Pietro - nel novembre '91 - indiscrezioni sulle indagini in corso, il quale gli avrebbe anticipato l'arresto di Mario Chiesa (avvenuto nel febbraio '92) e l'attacco a Craxi e al Caf. In realtà, la magistratura nell'arco di oltre vent'anni e fino ai giorni nostri ha difeso sé stessa e il proprio status di supercasta: non già per motivi ideologico-politici bensì per autotutela da un nemico che appariva pericolosissimo. La casta, in altri termini, ha fatto e sempre farà quadrato a propria difesa, a prescindere dall'essere «toghe rosse» o di qualunque altro colore. L'accanimento contro Silvio Berlusconi riguarda - più che la sua persona - il ruolo da lui svolto ed il pericolo che ha rappresentato e potrebbe ancora rappresentare per la burocrazia giudiziaria e per gli eredi del Pci/Pds. Si può senz'altro convenire che i giudici Nicoletta Gandus (processo Mills), Oscar Magi (processo Unipol, per rivelazione di segreto istruttorio), Luigi de Ruggero (condanna in sede civile al risarcimento del danno per il lodo Mondadori in favore di De Benedetti) abbiano militato nella (ex) frazione di sinistra di Md, come pure il procuratore Edmondo Bruti Liberati (noto come simpatizzante del Pci/Pds): si può supporre che a quella corrente appartenga pure la presidente Alessandra Galli (processo di appello Mediaset). Nel novero dei giudici di sinistra si potrebbe anche ricomprendere la pm Boccassini: ma gli altri? Chi potrebbe attribuire in quota Md il giudice Raimondo Mesiano (primo processo con risarcimento del danno a favore di De Benedetti), il presidente Edoardo D'Avossa (I° grado del processo Mediaset), la presidente Giulia Turri (processo Ruby), il pm Fabio De Pasquale, il pm Antonio Sangermano, il presidente di cassazione Antonio Esposito e tutti gli altri che si sono occupati e si stanno occupando del «delinquente» Berlusconi? La verità è che la magistratura italiana da tempo è esplosa in una miriade di monadi fuori da qualunque controllo gerarchico e territoriale, essendo venuto meno (grazie anche al codice di procedura penale del 1989) perfino l'ultimo baluardo che le impediva di tracimare; quello della competenza territoriale, travolto dalla disposizione relativa alle cosiddette «indagini collegate» (ogni pm può indagare su tutto in tutto il Paese, salvo poi alla fine trasmettere gli atti alla Procura territorialmente competente). Ciascun pm è padrone assoluto in casa propria, e nessuno - nemmeno un capo dell'ufficio men che autorevole - può fermarlo. E la situazione non fa altro che peggiorare, come è sotto gli occhi di tutti coloro che sono interessati a vedere. La magistratura italiana - unica nel panorama dei Paesi occidentali democratici - è preda di un numero indeterminato di «giovani» (e meno giovani, ma anche meno sprovveduti) magistrati pronti a qualunque evenienza e autoreferenziali. Focalizzare l'attenzione solo su Magistratura democratica significa non cogliere appieno i pericoli che le istituzioni nazionali stanno correndo e correranno negli anni a venire, con o senza la preda Berlusconi.
L'ala «ex» comunista del Pd - dal canto suo - non può più abbandonare l'ideologia giustizialista, che ormai resta l'unica via che potrebbe portare quella forma-partito al potere. Una democrazia occidentale matura non può fare a meno di riflettere su questi temi, cercando una via di uscita dall'impasse politico-istituzionale in cui questo Paese si è infilato per la propria drammatica incoscienza, immaturità ed incapacità di governo: con buona pace di una ormai inesistente classe politica.» Sergio D'Angelo Ex giudice di Magistratura democratica.
A riguardo sentiamo il cronista che fa tremare i pm. "Sinistra ricattata dalle procure". Dopo 35 anni a seguire i processi nelle aule dei tribunali Frank Cimini è andato in pensione ma dal suo blog continua a svelare le verità scomode di Milano: "Magistrati senza controllo", scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. «Antonio Di Pietro è meno intelligente di me»: nel 1992, quando i cronisti di tutta Italia scodinzolavano dietro il pm milanese, Frank Cimini fu l'unico cronista giudiziario a uscire dal coro. Sono passati vent'anni, e Cimini sta per andare in pensione. Confermi quel giudizio? «Confermo integralmente». Sul motivo dell'ubriacatura collettiva dei mass media a favore del pm, Cimini ha idee precise: «C'era un problema reale, la gente non ne poteva più dei politici che rubavano, e la magistratura ha colto l'occasione per prendere il potere. Di Pietro si è trovato lì, la sua corporazione lo ha usato. Mani pulite era un fatto politico, lui era il classico arrampicatore sociale che voleva fare carriera. Infatti appena potuto si è candidato: non in un partito qualunque, ma nelle fila dell'unico partito miracolato dalle indagini». Uomo indubbiamente di sinistra, e anche di ultrasinistra («ma faccio l'intervista al Giornale perché sennò nessuno mi sta a sentire») Cimini (ex Manifesto, ex Mattino, ex Agcom, ex Tmnews) resterà nel palazzo di giustizia milanese come redattore del suo blog, giustiziami.it. E continuerà, dietro l'usbergo dell'enorme barba e dell'indipendenza, a dire cose per cui chiunque altro verrebbe arrestato. Sulla sudditanza degli editori verso il pool di Mani Pulite ha idee precise: «Gli editori in Italia non sono editori puri ma imprenditori che hanno un'altra attività, e come tali erano sotto scacco del pool: c'è stato un rapporto di do ut des. Per questo i giornali di tutti gli imprenditori hanno appoggiato Mani pulite in cambio di farla franca. Infatti poi l'unico su cui si è indagato in modo approfondito, cioè Berlusconi, è stato indagato in quanto era sceso in politica, sennò sarebbe stato miracolato anche lui. C'è stato un approfondimento di indagine, uso un eufemismo, che non ha pari in alcun paese occidentale. Ma lui dovrebbe fare mea culpa perché anche le sue tv hanno appoggiato la Procura». Da allora, dice Cimini, nulla è cambiato: nessuno controlla i magistrati. «Il problema è che la politica è ancora debole, così la magistratura fa quello che vuole. Il centrosinistra mantiene lo status quo perché spera di usare i pm contro i suoi avversari politici ma soprattutto perché gran parte del ceto politico del centrosinistra è ricattato dalle procure. Basta vedere come escono le cose, Vendola, la Lorenzetti, e come certe notizie spariscono all'improvviso». Nello strapotere della magistratura quanto conta l'ideologia e quanto la sete di potere? «L'ideologia non c'entra più niente, quella delle toghe rosse è una cavolata che Berlusconi dice perché il suo elettorato così capisce. Ma le toghe rosse non ci sono più, da quando è iniziata Mani pulite il progetto politico che era di Borrelli e non certo di Di Pietro o del povero Occhetto è stata la conquista del potere assoluto da parte della magistratura che ha ottenuto lo stravolgimento dello Stato di diritto con la legge sui pentiti. Un vulnus da cui la giustizia non si è più ripresa e che ha esteso i suoi effetti dai processi di mafia a quelli politici. Oggi c'è in galera uno come Guarischi che avrà le sue colpe, ma lo tengono dentro solo perché vogliono che faccia il nome di Formigoni». Conoscitore profondo del palazzaccio milanese, capace di battute irriferibili, Cimini riesce a farsi perdonare dai giudici anche i suoi giudizi su Caselli («un professionista dell'emergenza») e soprattutto la diagnosi impietosa di quanto avviene quotidianamente nelle aule: «Hanno usato il codice come carta igienica, hanno fatto cose da pazzi e continuano a farle». Chi passa le notizie ai giornali? «Nelle indagini preliminari c'è uno strapotere della Procura che dà le notizie scientemente per rafforzare politicamente l'accusa». E i cronisti si lasciano usare? «Se stessimo a chiederci perché ci passano le notizie, i giornali uscirebbero in bianco».
"La politica ha delegato alla magistratura tre grandi questioni politiche, il terrorismo, la mafia, la corruzione, e alcuni magistrati sono diventati di conseguenza depositari di responsabilità tipicamente politiche". A dirlo è Luciano Violante, ex presidente della Camera e esponente del Partito democratico. Secondo il giurista, inoltre, "la legge Severino testimonia il grado di debolezza" della politica perché non è "possibile che occorra una legge per obbligare i partiti a non candidare chi ha compiuto certi reati". "È in atto un processo di spoliticizzazione della democrazia che oscilla tra tecnocrazia e demagogia", ha aggiunto, "Ne conseguono ondate moralistiche a gettone tipiche di un Paese, l’Italia, che ha nello scontro interno permanente la propria cifra caratterizzante". Colpa anche di Silvio Berlusconi, che "ha reso ancora più conflittuale la politica italiana", ma anche della sinistra che "lo ha scioccamente inseguito sul suo terreno accontentandosi della modesta identità antiberlusconiana". "Ma neanche la Resistenza fu antimussoliniana, si era antifascisti e tanto bastava", aggiunge. Quanto alle sue parole sulla legge Severino e la decadenza del Cavaliere, Violante aggiunge: "Ho solo detto che anche Berlusconi aveva diritto a difendersi. Quando ho potuto spiegarmi alle assemblee di partito ho ricevuto applausi, ma oggi vale solo lo slogan, il cabaret. Difficile andare oltre i 140 caratteri di Twitter". E sulle toghe aggiunge: "Pentiti e intercettazioni hanno sostituito la capacità investigativa. Con conseguenze enormi. Occorrerebbe indicare le priorità da perseguire a livello penale, rivedendo l’obbligatorietà dell’azione che è un’ipocrisia costituzionale resa necessaria dal fatto che i pubblici ministeri sono, e a mio avviso devono restare, indipendenti dal governo".
Io quelli di Forza Italia li rispetto, scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”. Conoscendoli, singolarmente, li rispetto molto meno: ma nell'insieme potrebbero anche sembrare appunto dei lealisti, dei coerenti, delle schiene dritte, gente che ha finalmente trovato una linea del Piave intesa come Berlusconi, come capo, come leader, come rappresentante di milioni di italiani che non si può cancellare solo per via giudiziaria: almeno non così. Non con sentenze infarcite di «convincimenti» e prove che non lo sono. Dunque rispetto quelli di Forza Italia - anche se in buona parte restano dei cavalier-serventi - perché tentano di fare quello che nella Prima Repubblica non fu fatto per Bettino Craxi e per altri leader, consegnati mani e piedi alla magistratura assieme al primato della politica. Solo che, dettaglio, Forza Italia ha perso: ha perso quella di oggi e ha perso quella del 1994. E non ha perso ieri, o un mese fa, cioè con Napolitano, la Consulta, la legge Severino, la Consulta, la Cassazione: ha colpevolmente perso in vent'anni di fallimento politico sulla giustizia. Dall’altra c’è qualcuno che ha vinto, anche se elencarne la formazione ora è complicato: si rischia di passare dal pretenzioso racconto di un’ormai stagliata «jurecrazia» - fatta di corti che regolano un ordine giuridico globale - all'ultimo straccione di pm o cronista militante. Resta il dato essenziale: vent’anni fa la giustizia faceva schifo e oggi fa identicamente schifo, schiacciata com'è sul potere che la esercita; e fa identicamente schifo, per colpe anche sue, la giustizia ad personam legiferata da Berlusconi, che in vent'anni ha solo preso tempo - molto - e alla fine non s'è salvato. Elencare tutte le forzature palesi o presunte per abbatterlo, magari distinguendole dalle azioni penali più che legittime, è un lavoro da pazzi o da memorialistica difensiva: solo la somma delle assoluzioni - mischiate ad amnistie e prescrizioni - brucerebbe una pagina. Basti l'incipit, cioè il celebre mandato di comparizione che fu appositamente spedito a Berlusconi il 21 novembre 1994 per essere appreso a un convegno Onu con 140 delegazioni governative e 650 giornalisti: diede la spallata decisiva a un governo a discapito di un proscioglimento che giungerà molti anni dopo. L’elenco potrebbe proseguire sino a oggi - intralciato anche da tutte le leggi ad personam che Berlusconi fece per salvarsi - e infatti è solo oggi che Berlusconi cade, anzi decade. Ciò che è cambiato, negli ultimi anni, è la determinazione di una parte della magistratura - unita e univoca come la corrente di sinistra che ne occupa i posti chiave - a discapito di apparenze che non ha neanche più cercato di salvare. I processi per frode legati ai diritti televisivi non erano più semplici di altri, anzi, il contrario: come già raccontato, Berlusconi per le stesse accuse era già stato prosciolto a Roma e pure a Milano. Ciò che è cambiato, appunto, è la determinazione dei collegi giudicanti a fronte di quadri probatori tuttavia paragonabili ai precedenti: ma hanno cambiato marcia. Si poteva intuirlo dai tempi atipici che si stavano progressivamente dando già al primo grado del processo Mills, che filò per ben 47 udienze in meno di due anni e fece lavorare i giudici sino al tardo pomeriggio e nei weekend; le motivazioni della sentenza furono notificate entro 15 giorni (e non entro i consueti 90) così da permettere che il ricorso in Cassazione fosse più che mai spedito. Ma è il processo successivo, quello che ora ha fatto fuori Berlusconi, ad aver segnato un record: tre gradi di giudizio in un solo anno (alla faccia della Corte Europea che ci condanna per la lunghezza dei procedimenti) con dettagli anche emblematici, tipo la solerte attivazione di una sezione feriale della Cassazione che è stata descritta come se di norma esaminasse tutti i processi indifferibili del Paese: semplicemente falso, la discrezionalità regna sovrana come su tutto il resto. Il paradosso sta qui: nel formidabile e inaspettato rispetto di regole teoriche - quelle che in dieci mesi giudicano un cittadino nei tre gradi - al punto da trasformare Berlusconi in eccezione assoluta. Poi, a proposito di discrezionalità, ci sono le sentenze: e qui si entra nel fantastico mondo dell'insondabile o di un dibattito infinito: quello su che cosa sia effettivamente una «prova» e che differenza ci sia rispetto a convincimenti e mere somme di indizi. Il tutto sopraffatti dal dogma che le sentenze si accettano e basta: anche se è dura, talvolta. Quando uscirono le 208 pagine della condanna definitiva in Cassazione, in ogni caso, i primi commenti dei vertici piddini furono di pochi minuti dopo: un caso di lettura analogica. E, senza scomodare espressioni come «teorema» o «prova logica» o peggio «non poteva non sapere», le motivazioni della sentenza per frode fiscale appalesavano una gigantesca e motivata opinione: le «prove logiche» e i «non poteva non sapere» purtroppo abbondavano e abbondano. «È da ritenersi provato» era la frase più ricorrente, mentre tesi contrarie denotavano una «assoluta inverosimiglianza». Su tutto imperava l’attribuzione di una responsabilità oggettiva: «La qualità di Berlusconi di azionista di maggioranza gli consentiva pacificamente qualsiasi possibilità di intervento», «era assolutamente ovvio che la gestione dei diritti fosse di interesse della proprietà», «la consapevolezza poteva essere ascrivibile solo a chi aveva uno sguardo d’insieme, complessivo, sul complesso sistema». Il capolavoro resta quello a pagina 184 della sentenza, che riguardava la riduzione delle liste testimoniali chieste dalla difesa: «Va detto per inciso», è messo nero su bianco, «che effettivamente il pm non ha fornito alcuna prova diretta circa eventuali interventi dell’imputato Berlusconi in merito alle modalità di appostare gli ammortamenti dei bilanci. Ne conseguiva l'assoluta inutilità di una prova negativa di fatti che la pubblica accusa non aveva provato in modo diretto». In lingua italiana: l’accusa non ha neppure cercato di provare che Berlusconi fosse direttamente responsabile, dunque era inutile ammettere testimoni che provassero il contrario, cioè una sua estraneità. Ma le sentenze si devono accettare e basta. Quando Berlusconi azzardò un videomessaggio di reazione, in settembre, Guglielmo Epifani lo definì «sconcertante», mentre Antonio Di Pietro fece un esposto per vilipendio alla magistratura e Rosy Bindi parlò di «eversione». Il resto - la galoppata per far decadere Berlusconi in Senato - è cronaca recente, anzi, di ieri, Il precedente di Cesare Previti - che al termine del processo Imi-Sir fu dichiarato «interdetto a vita dai pubblici uffici» - è pure noto: la Camera ne votò la decadenza ben 14 mesi dopo la sentenza della Cassazione. Allora come oggi, il centrosinistra era dell’opinione che si dovesse semplicemente prendere atto del dettato della magistratura, mentre il centrodestra pretendeva invece che si entrasse nel merito e non ci si limitasse a un ruolo notarile. Poi c’è il mancato ricorso alla Corte Costituzionale per stabilire se gli effetti della Legge Severino possano essere retroattivi: la Consulta è stata investita di infinite incombenza da una ventina d’anni a questa parte - comprese le leggi elettorali e i vari «lodi» regolarmente bocciati – ma per la Legge Severino il Partito democratico ha ritenuto che la Corte non dovesse dire la sua. Il 30 ottobre scorso, infine, la Giunta per il regolamento del Senato ha stabilito che per casi di «non convalida dell’elezione» il voto dovesse essere palese, volontà ripetuta ieri dal presidente del Senato: nessun voto segreto o di coscienza, dunque. Poi - ma è un altro articolo, anzi, vent'anni di articoli - ci sono le mazzate che il centrodestra si è tirato da solo. La Legge Severino, come detto. Il condono tombale offerto a Berlusconi dal «suo» ministro Tremonti nel 2002 - che l'avrebbe messo in regola con qualsivoglia frode fiscale – ma che al Cavaliere non interessò. Il demagogico inasprimento delle pene per la prostituzione minorile promosso dal «suo» ministro Carfagna nel 2008. Però, dicevamo, non ci sono solo gli autogol: c’è il semplice non-fatto o non-riuscito degli ultimi vent’anni. Perché nei fatti c’era, e c’è, la stessa magistratura. Non c’è la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del Csm, le modifiche dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione, la responsabilità civile dei giudici, i limiti alle intercettazioni. Ci sono state, invece, le leggi sulle rogatorie, la Cirami, i vari lodi Maccanico-Schifani-Alfano, l’illegittimo impedimento: pannicelli caldi inutili o, per un po’, utili praticamente solo a lui. Per un po’. Solo per un po’. Fino al 27 novembre 2013.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
DELINQUENTE A CHI?
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Parla l’ex capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli esaminatori.
"Noi avevamo la nostra idea. Dovevamo formare, per la fine del millennio, i nostri giovani come degli infiltrati dentro lo Stato: quindi dovevano diventare magistrati, poliziotti, carabinieri e perché no, anche ministri e presidenti del Consiglio. Per avere i nostri referenti nelle istituzioni".
"I mafiosi non sono solo i Riina o i Provenzano. I soggetti collusi con la mafia sono ovunque, sono nelle istituzioni pubbliche, siedono anche in Parlamento". Così il presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarnotta, al convegno “La mafia non è solo un problema meridionale”, organizzato a Palermo il 29 novembre 2013 dall'associazione Espressione Libre. "In mancanza di sanzioni, ma soprattutto in assenza di una autoregolamentazione deontologica, la responsabilità politica rimarrà impunita, nulla più che un pio desiderio, con la conseguenza che si è arrivati a candidare e fare eleggere a Palermo, politici sotto processo per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, come Marcello Dell'Utri e Calogero Lo Giudice" ha detto ancora Guarnotta al convegno. Il riferimento a Dell'Utri e Lo Giudice arriva nella parte della relazione di Leonardo Guarnotta, quando parla di lotta alla mafia perché "è indispensabile l'impegno della società civile perché la partita, cioè la lotta alla mafia, che non possiamo assolutamente permetterci di perdere, si gioca nella quotidianità", ha detto il presidente del Tribunale di Palermo. Guarnotta poi ha voluto rimarcare che questa lotta si gioca "nelle scelte, individuali e collettive, non escluse le scelte elettorali, cioè le scelte che vengono fatte dai segretari di partito nel selezionare i candidati, da inserire nelle liste e quelle che operano gli elettori nell'esercizio del diritto-dovere di designare i loro rappresentanti al Parlamento e nelle istituzioni".
FIGLI DI QUALCUNO E FIGLI DI NESSUNO.
L’Italia dei figli di qualcuno e dei figli di nessuno, scrive Luigi Sanlorenzo su “Sicilia Informazioni”. Quel termometro, ancora per poco infrangibile, dell’indignazione degli italiani ha raggiunto in queste ore un nuovo picco alla notizia dell’intervento del Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri in favore della scarcerazione per motivi umanitari di Giulia Ligresti. Già ora montano polemiche roventi, immaginabili paragoni con vicende simili, richieste di dimissioni e promesse di giustificazioni che occuperanno i giornali e le televisioni in interminabili dietrologie, pindariche rievocazioni, ardite ipotesi. Ma non c’è da preoccuparsi, perché prima o poi, una cortina fumogena sarà sapientemente fatta posare sui fatti. Proprio per tale ragione, questo articolo ha la pretesa di soffermarsi su una diversa e più pressante preoccupazione degli italiani circa il diverso destino dei figli di nessuno e dei figli di qualcuno. E’ noto come il decantato benessere italiano, i cosiddetti anni del boom che interessarono gli anni ’50 e ’60, si fondò su due principali eventi sociali: la politica industriale sorretta dagli ingenti fondi del Piano Marshall nel centro nord del Paese e l’accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione – ed alle migliaia di enti collegati – di intere coorti di giovani del Mezzogiorno mediante centinaia di concorsi che rappresentarono in un Sud maggiormente scolarizzato, una risposta occupazionale e un inedito e rapido ascensore sociale. Grazie alla possibilità per milioni di diplomati e decine di migliaia di laureati di accedere ad un posto stabile e sicuro, anche se non sempre disponibile nella regione di nascita, la società italiana nel complesso passò nel volgere di un decennio dai bisogni ai desideri, alimentando consumi alti e medio alti e inaugurando stili di vita molto vicini a quelli dei Paesi europei più avanzati, se non, in molti casi, degli Stati Uniti del tempo. Per la prima volta nella storia, il figlio di un contadino poteva diventare qualcuno, rompendo così l’atavico destino riservato a chi lo aveva preceduto. Per la prima volta il neo dottore, diventato funzionario ministeriale, impiegato di una banca pubblica, medico della mutua o semplicemente, assolto l’obbligo scolastico, usciere alla Provincia o portantino in un ospedale, poteva a propria volta sognare un futuro ancora migliore per i figli che, numerosi, – i baby boomers – sarebbero venuti al mondo. Certo, dopo i primi anni, i concorsi divennero sempre più politicizzati e all’insegna della raccomandazione ma il “borghese piccolo piccolo” che alberga in tutti noi sapeva che far studiare un figlio avrebbe comunque portato prima o poi, alle soglie del fatidico concorso, varcate le quali altri sogni potevano diventare realtà: una famiglia, un sorriso assicurato da parte di una banca lieta di offrire un mutuo per la casa, l’autovettura di dimensioni crescenti in proporzione alla carriera, l’assistenza sanitaria, le ferie al mare o all’estero, magari, presto, la seconda casa per le vacanze. Con il crollo rovinoso di quel mondo, che pur in modo imperfetto e non sempre trasparente, sembrava voler realizzare i migliori auspici della Costituzione Repubblicana, i giovani italiani si sono trovati come coloro cui un uragano scoperchia la casa. Cresciuti ed educati nella prima parte della propria vita in famiglia e a scuola con la certezza delle opportunità garantite ai propri genitori, scelta una facoltà universitaria più con l’occhio al “concorso” che alla propria reale vocazione, si sono trovati davanti il vuoto. Mentre essi precipitavano nel baratro del precariato infinito del corpo e dell’anima, risuonavano da ogni possibile mezzo di comunicazione le ipocrisie di una classe dirigente farisaica e compromessa. Era giusto infatti che i ministri dei nuovi governi mettessero in guardia i giovani dall’illusione del posto fisso e li spronassero a mettersi in gioco. La doppiezza di tale morale emerge oggi quando si scopre, sempre più spesso, che proprio i figli di quei ministri avevano tutti già un posto fisso, grazie sicuramente all’influenza di mamma e papà. Mario Monti ha un figlio, Giovanni Monti, ora 39enne. Ripercorriamo la sua carriera: a 20 anni è già associato per gli investimenti bancari per la Goldman Sachs, banca d’affari in cui il padre ha ricoperto il ruolo di International Advisor. A 25 anni diventa consulente di direzione da Bain & company e ci rimane fino al 2001. Dal 2004 al 2009, ha lavorato a Citigroup e in Morgan & Stanley occupandosi in particolare di transazioni economico-finanziarie sui mercati di Europa, Medio Oriente e Africa, alle dipendenze dirette degli uffici centrali di New York. La figlia di Elsa Fornero – l’indimenticabile, sensibile fino alle lacrime, Ministro del Lavoro che dopo aver chiamato i giovani “choosy”, ovvero con poco spirito di adattamento e dopo aver consigliato a tutti di “tornare a lavorare la terra” tacciò gli italiani di essere “scansafatiche” – Silvia Deaglio, ha soli 24 anni quando ottiene un incarico presso un prestigioso college di Boston e 30 quando inizia ad insegnare medicina. Diventa associata all’università di Torino, l’università dove mamma e papà hanno la cattedra, a soli 37 anni. Il figlio di Annamaria Cancellieri per la quale gli italiani devono liberarsi dell’idea del posto fisso vicino ai genitori, Piergiorgio Peluso, appena laureato, inizia una carriera sfolgorante: dall’Arthur Andersen a Mediobanca, fino a Aeroporti di Roma, Credit Suisse, Unicredit e Fondiaria Sai, dove è direttore generale guadagnando circa 500mila euro all’anno. Il resto sarà cronaca dei prossimi giorni. Certamente i citati sono tutti giovani preparati e in gamba ma probabilmente ambiti da multinazionali anche per altre ragioni. Essi comunque non saranno stati certo delle menti così eccezionali rispetto a migliaia di altri coetanei preparati e volenterosi che ormai alle soglie dei 40 anni non avranno mai una famiglia propria, una casa o una pensione. In una democrazia i figli di “nessuno” come chi scrive, possono salire la scala sociale soltanto se messi alla prova del merito comparativo e dei meccanismi dei concorsi da reinventare modernamente nel nostro disperato Paese. Diverso è infatti il destino dei figli di qualcuno che, nella vita, “qualcuno” diventano comunque, spesso ben oltre le proprie reali capacità. Con qualche eccezione di chi, per sensibilità personale o scelta esistenziale, decide di rifiutare i privilegi a di rischiare una vita normale e di cui essere il vero, spesso drammatico, protagonista. La mattina del 15 novembre 2000 il corpo senza vita di Edoardo Agnelli, 46 anni, venne trovato da un pastore cuneese, Luigi Asteggiano, presso la base del trentacinquesimo pilone del viadotto autostradale Generale “Franco Romano” della Torino-Savona, nei pressi di Fossano. La sua Croma scura, con il motore ancora acceso e il bagagliaio socchiuso, era parcheggiata a lato della carreggiata del viadotto che sovrasta il fiume Stura di Demonte. La magistratura concluse presto le indagini formulando l’ipotesi del suicidio. Nelle rare interviste concesse alla stampa, il figlio del più noto Avvocato della storia italiana, aveva affermato di voler prendere le distanze dai valori del capitalismo e di volersi dedicare a studi di teologia. Edoardo Agnelli non nascondeva di simpatizzare per il marxismo-leninismo in chiave mistica e verso l’Iran sciita; secondo voci non confermate negli ultimi anni aveva cambiato persino nome, assumendo un nome islamico. Era comparso in pochissime occasioni pubbliche e in qualche manifestazione religiosa o antinuclearista. I tentativi di inserirlo in attività collaterali del grande gruppo aziendale di famiglia, tra cui anche una breve esperienza nel Consiglio d’Amministrazione della Juventus nel 1986, non avevano dato buon esito. Edoardo era diverso. La fine di Edoardo Agnelli, contrapposta all’aridità e all’egoismo di una borghesia che si auto perpetua non attraverso i meriti ma grazie alla fitta trama di relazioni ed alleanze che vanno ben oltre gli schieramenti ufficiali nella vita politica o delle cordate imprenditoriali, mi ha sempre ricordato la figura di Hanno Buddenbrook, la saga della cui famiglia fu il testo pretesto della mia tesi di laurea, nel lontano 1980. Hanno Buddenbrook è l’ultimo discendente dei Buddenbrook, fiorente famiglia della borghesia mercantile tedesca, di cui il romanzo racconta attraverso tre generazioni la progressiva decadenza che segna la decomposizione di un certo tipo di società. Hanno ne incarna l’epilogo, attraverso la sua inettitudine, che tanto più poeticamente risalta in quanto diviene icona di un’intera epoca che tramonta, schiacciata dal peso dei suoi riti, dei suoi mascheramenti, dei suoi valori opprimenti. Nei giorni scorsi Rachid Khadiri Abdelmoula, il 27enne marocchino torinese, dopo una vita passata a vendere accendini e fazzoletti tra Palazzo Nuovo e la Mole di giorno e a studiare di notte, si è laureato in ingegneria al Politecnico. Il “marocchino” (così definisce se stesso, scherzando su provenienza e senso dato in Italia al termine) più famoso d’Italia è tornato oggi a far parlare di sè per una scelta decisamente controcorrente. Rachid sta infatti resistendo in questi giorni alle lusinghe della televisione commerciale rispondendo con insistiti “no, grazie” alle reiterate proposte che arrivano da Endemol per partecipare all’edizione 2014 del Grande Fratello. Tra lo stupore di tutti ha dichiarato: “I miei valori sono altrove. Non mi riconosco neanche un po’ in una trasmissione che non trovo seria ed educativa. Cosa ci andrei a fare? A recitare? Il successo è un mondo di nicchia, lo stringono in pochissimi. Gli altri si illudono, poi rimangono spiazzati quando la fama svanisce. Ai sogni bisogna obbedire. Il mio è di fare l’ingegnere con la cravatta. Come mi vedo tra dieci anni? Spero di aver svoltato. Non in uno studio televisivo, ma in uno di progettisti.” Nel Capitolo 38 dedicato alle cause della decadenza di Roma , l’illuminista Edward Gibbon, autore de The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776) ha scritto: “ essa fu conseguenza naturale della sua grandezza. La prosperità portò a maturazione il principio della decadenza…Invece di chiederci perché fu distrutto, dovremmo sorprenderci che abbia retto tanto a lungo”. Un monito estremamente contemporaneo che dovrebbe bastare ad una società come la nostra che ha smarrito da tempo anche il ricordo delle energie vitali da cui nacque e che sembra ogni giorno di più di intravedere nelle storie esemplari dei tanti figli di immigrati che, forse, rifaranno l’Italia.
E che dire ancora. Non ci sono anormali, ma normali diversi, scrive Michele Marzano su “La Repubblica”. Pochi giorni fa, il Tribunale dei Minori di Roma ha autorizzato una coppia ad adottare un bambino straniero, a patto però che il bimbo fosse "perfettamente sano". La decisione è stata subito contestata non solo dall'Aibi (l'associazione Amici dei bambini) - che intende presentare un esposto alla Procura generale della Cassazione - ma anche dal Presidente del Tribunale dei minori, Melita Cavallo, che spera che una cosa del genere "non si ripeta più". Ma al di là di queste contestazioni più che opportune, che cosa rivela l'utilizzo di questo tipo di espressioni? Chi di noi può definirsi "perfettamente sano"? All'epoca del mito della perfezione, sembra scontato ed evidente poter giudicare le persone e valutarle in base ad una serie di criteri reputati oggettivi. Come se l'intelligenza, la salute e la bellezza potessero essere veramente calcolate e misurate. Come se il valore di una persona dipendesse dalla sua capacità o meno di corrispondere a determinati criteri. E se tutto ciò fosse solo il retaggio di un determinismo biologico e genetico ormai desueto? Se il valore di una persona fosse altrove, non solo perché la perfezione non esiste, ma anche perché, molto spesso, sono proprio coloro che sembrano "oggettivamente sani" che poi si rivelano "soggettivamente malati"? Come spiegava bene Georges Canguilhem negli anni Sessanta, la salute non è un'entità fissa. Anzi, varia a seconda dei contesti e delle persone, e solo chi soffre può veramente valutare il proprio stato di salute. Ecco perché non esiste alcuna definizione oggettiva della normalità e dell'anormalità. Tanto più che le persone sono tutte differenti l'una dall'altra e che, inevitabilmente, ognuno presenta "un'anomalia" rispetto agli altri. "L'anormale non è ciò che non è normale", scrive in proposito Canguilhem, "ma è piuttosto un normale differente". Peccato che, nonostante tutto, la differenza continui ancora oggi ad essere identificata con l'inferiorità, e che persista un'insopportabile intolleranza nei confronti delle fragilità umane, al punto da illudersi che la felicità dipenda dal proprio essere "perfettamente sani". La fragilità, in sé, non è un problema. Anzi, è proprio nel momento in cui ci fermiamo un istante e cerchiamo di entrare in contatto con noi stessi, che ci rendiamo poi conto che questa nostra fragilità può diventare un punto di forza. Perché ci aiuta a crescere e a cambiare. Perché ci rivela qualcosa di noi che per tanto tempo, a torto, abbiamo fatto di tutto per ignorare. Soprattutto quando capiamo che l'essere umano non è una semplice somma di competenze più o meno sviluppate, e che i successi, come ricorda sempre Georges Canguilhem, sono spesso dei "fallimenti ritardati". Speriamo che lo capiscano anche i giudici quando autorizzano o meno una coppia ad adottare. Non solo perché l'essere "perfettamente sano" è un'espressione priva di senso, ma anche perché l'amore dei genitori non può certo dipendere dallo stato di salute dei propri figli.
E poi c’è l’anormalità fatta normalità con un commento di Susanna Tamaro. «La notizia dei tre miliardi sottratti allo Stato da parte di 5.000 dipendenti pubblici, che si aggiunge a quella dei finti poveri, dei falsi ciechi o dei turlupinatori di pensioni che ogni giorno vengono «scoperti» dalla Guardia di Finanza, non può che turbare - dove «turbare» è un eufemismo - le tante persone oneste di questo Paese, sempre più perseguitate da un Fisco che li ritiene gli unici «privilegiati» interlocutori. Non è populismo affermare che molti dei nostri problemi economici sarebbero in parte risolvibili con una bella e definitiva pulizia degli sprechi e degli assurdi privilegi che l’apparato statale permette e concede a tutti coloro che sono riusciti a infilarsi sotto le sue ali mafiosamente protettive. Com’è possibile, infatti, ci chiediamo noi contribuenti, che per dieci, venti, trent’anni una persona percepisca una pensione di invalidità come cieco pur essendo perfettamente vedente, mentre una nostra qualsiasi minima mancanza, che sia una multa o un mancato pagamento di un contributo, viene immediatamente sanzionata e punita con severità? Quanti ciechi ci vogliono per non vedere un finto cieco? Come ci interroghiamo anche - e purtroppo sappiamo già la risposta - su quanti di questi 5.073 dipendenti dello Stato che hanno rubato, truffato, corrotto avranno come conseguenza la perdita del loro posto di lavoro. Non sono un’esperta di amministrazione statale, ma temo che la risposta sia «nessuno». Questi uomini e donne che hanno tradito il patto di fiducia etico su cui si regge la società, hanno anche danneggiato i loro colleghi che lavorano con serietà e dedizione. Quali conseguenze avrà questo tradimento? Forse soltanto una multa o il trascinarsi in un processo che durerà anni e che finirà in una bolla di sapone. Il messaggio che ci viene costantemente dato dallo Stato è che in fondo le nostre azioni non sono influenti, che il comportarsi bene o male non cambia nulla, se si ha un posto garantito. Il messaggio che quindi passa alle generazioni future è quello che il merito e l’etica in Italia non hanno alcun peso, cosa che peraltro viene confermata in ogni ambito della nostra società, dall’università alla pubblica amministrazione. A volte, quando guardo i politici immersi nelle loro costanti e sterili polemiche televisive, mi domando: si rendono veramente conto dello stato di esasperazione della parte sana del nostro Paese? Credo proprio di no. Se si rendessero conto, infatti, agirebbero di conseguenza, senza timore dell’impopolarità, sfrondando, pulendo, liberandoci da tutto ciò che è inutile, offensivo e dannoso. È la mancanza di questa semplice azione a spingere sempre più italiani verso l’indifferenza, il cinismo, il disinteresse o tra le braccia dei movimenti che afferrano le viscere e le torcono, perché è lì che, alla fine, si annida la disperazione degli onesti. È su questo che riflettevo, andando in bicicletta per le colline umbre, desolata dallo spettacolo che ormai accompagna ogni mia escursione. Avevo appena superato la carcassa di un televisore abbandonato in mezzo ai rovi; doveva essere un lancio recente, dato che la settimana scorsa non c’era, come non c’era neppure il water di porcellana rovesciato in un fosso, sulla via del ritorno. Anche lui una new entry nel mio paesaggio ciclistico. Chi, come i nostri politici, viaggia sempre in automobile forse non sa che quasi la totalità dei bordi delle nostre strade e autostrade è costellato di rifiuti e spazzatura. Ogni metro quadrato è invaso da bottiglie di acqua minerale, lattine, scatole di sigarette, pannolini, preservativi, batterie di automobili, plastiche: tutto viene allegramente scaraventato fuori dai finestrini. Se poi si abbandonano le strade asfaltate e si imboccano quelle bianche, il panorama diventa ancora più orrendamente variegato: frigoriferi, lavatrici, pneumatici di tutte le dimensioni, reti da letto sfondate, materassi, divani, poltrone, computer, bidet, carcasse di biciclette o di motorino e spesso anche automobili senza targa, per non parlare delle lastre di amianto, residui di pollai e di stalle, maldestramente nascosti sotto pochi centimetri di terra. E tutto questo non accade soltanto nella terra dei fuochi, ma anche nella verde e felice Umbria. Bisogna aver il coraggio di dirlo apertamente: il nostro Paese - il meraviglioso giardino d’Europa - è una discarica a cielo aperto, di cui la «Terra dei fuochi» non è che la punta di un iceberg. Questo disprezzo per il luogo in cui viviamo, oltre a provocare un enorme danno all’ambiente e al turismo, è uno specchio fedele dell’assenza di senso civico che permea ormai tutto il Paese e di cui la classe politica è stata, fino ad ora, la garante. Dopo di me il diluvio, potrebbe assurgere a nostro motto nazionale. Il fatto che esistano, in ogni comune, delle isole ecologiche in cui smaltire ciò che non serve più cambia solo in parte le cose, perché questi luoghi hanno orari e leggi da rispettare, e perché mai dovrei rispettare un orario e una legge, se posso non farlo? Per anni, camminando in montagna, mi sono arrabbiata vedendo tutto quello che veniva abbandonato lungo i sentieri. Poi ho capito che quello sporco riguardava anche me, che arrabbiarsi e non fare niente mi rendeva complice del degrado. Così ho cominciato a raccogliere bottigliette di plastica, rifiuti e lattine come fossero fiori, riportandoli a valle con me. È questo che tutti noi dovremmo fare. Ciò che è fuori è sempre lo specchio di ciò che è dentro. L’immondizia che devasta il nostro Paese non è che la manifestazione del degrado etico che pervade ogni ambito della nostra società. Così, pedalando desolata, pensavo: come sarebbe se ogni comune, ogni quartiere di città, mettesse a disposizione di noi cittadini dei mezzi per permetterci di raccogliere in prima persona i rifiuti abbandonati criminalmente per strada o nei boschi. E poi sarebbe anche bello che tutta questa spazzatura, invece di venir immediatamente smaltita e dimenticata, lasciando spazio all’arrivo di nuova, venisse portata nelle piazze principali dei paesi e dei quartieri e affidata alle mani esperte di ragazzi diplomati alle varie Accademie di belle arti, per venir trasformata, grazie alla loro creatività, in temporanei monumenti alla nostra inciviltà. Così, durante la passeggiata domenicale, prendendo un caffè o conversando con gli amici, tutti noi potremmo ammirare per un anno gli oggetti che abbiamo abbandonato: guarda, la mia vecchia lavatrice, il mio bidet, il televisore della nonna! Sarebbe istruttivo che poi tutti questi precari monumenti al nostro degrado venissero fotografati e raccolti in un delizioso libretto dal titolo: «Ciò che eravamo, ciò che non vogliamo più essere». Susanna Tamaro».
LA TERRA DEI CACHI, DEI PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
La Terra dei Cachi (di Belisari, Conforti, Civaschi, Fasani) è la canzone cantata da Elio e le Storie Tese al Festival di Sanremo 1996, classificatasi al secondo posto nella classifica finale e vincitrice del premio della critica. Prima nelle classifiche temporanee fino all'ultima serata, il secondo posto nell'ultima provocò molte polemiche su presunte irregolarità del voto, confermate dalle indagini dei carabinieri che confermarono che La terra dei cachi era stata la canzone più votata. Il testo racconta la vita e le abitudini dell'Italia travolta da scandali su scandali (il pizzo, episodi criminali mai puniti, la malasanità) e piena di comportamenti che caratterizzano il cittadino italiano nel mondo, come la passione per il calcio, la pizza e gli spaghetti.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi,
Villette abusive, abusi sessuali abusivi;
Tanta voglia di ricominciare abusiva.
Appalti truccati, trapianti truccati,
Motorini truccati che scippano donne truccate;
Il visagista delle dive è truccatissimo.
Papaveri e papi, la donna cannolo,
Una lacrima sul visto: Italia sì, Italia no.
Italia sì, Italia no, Italia bum, la strage impunita.
Puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita.
Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè:
C'è un commando che ci aspetta per assassinarci un pò.
Commando sì, commando no, commando omicida.
Commando pam, commando prapapapam,
Ma se c'è la partita
Il commando non ci sta e allo stadio se ne va,
Sventolando il bandierone non più il sangue scorrerà.
Infetto sì? Infetto no? Quintali di plasma.
Primario sì, primario dai, primario fantasma.
Io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no;
Se dimentichi le pinze fischiettando ti dirò:
"Fi fi fi fi fi fi fi fi, ti devo una pinza.
Fi fi fi fi fi fi fi fi, ce l'ho nella panza".
Viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze. Eh
Quanti problemi irrisolti, ma un cuore grande così.
Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo dù spaghi.
Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi.
Una pizza in compagnia, una pizza da solo;
Un totale di due pizze e l'Italia è questa qua.
Fufafifi, fufafifi, Italia evviva.
Squerellerellesh, cataraparupai,
Italia perfetta, perepepè nainananai.
Una pizza in compagnia, una pizza da solo;
In totale molto pizzo ma l'Italia non ci sta.
Italia sì, Italia no, scurcurrillu currillo.
Italia sì: uè.
Italia no, spereffere fellecche.
Uè, uè, uè, uè,uè.
Perchè la terra dei cachi è la terra dei cachi.
«Una società sciapa e infelice in cerca di connettività».Così il Censis definisce la situazione sociale italiana nel suo 47mo illustrato a Roma dal direttore generale Giuseppe Roma e dal presidente Giuseppe De Rita. Una società, quella italiana, che sembra sempre ad un passo dal crollo ma che non crolla. «Negli anni della crisi - si legge nel rapporto del Censis - abbiamo avuto il dominio di un solo processo, che ha impegnato ogni soggetto economico e sociale: la sopravvivenza. C’è stata la reazione di adattamento continuato (spesso il puro galleggiamento) delle imprese e delle famiglie. Abbiamo fatto tesoro di ciò che restava nella cultura collettiva dei valori acquisiti nello sviluppo passato (lo «scheletro contadino», l’imprenditorialità artigiana, l’internazionalizzazione su base mercantile), abbiamo fatto conto sulla capacità collettiva di riorientare i propri comportamenti (misura, sobrietà, autocontrollo), abbiamo sviluppato la propensione a riposizionare gli interessi (nelle strategie aziendali come in quelle familiari). Siamo anche una «società sciapa e infelice» secondo il Censis «senza fermento e dove circola troppa accidia, furbizia generalizzata, disabitudine al lavoro, immoralismo diffuso, crescente evasione fiscale, disinteresse per le tematiche di governo del sistema, passiva accettazione della impressiva comunicazione di massa». Di conseguenza siamo anche «infelici, perché viviamo un grande, inatteso ampliamento delle diseguaglianze sociali». A giudizio dei ricercatori del Censis si sarebbe «rotto il “grande lago della cetomedizzazione”, storico perno della agiatezza e della coesione sociale. Troppa gente non cresce, ma declina nella scala sociale. Da ciò nasce uno scontento rancoroso, che non viene da motivi identitari, ma dalla crisi delle precedenti collocazioni sociali di individui e ceti». Ciò avrebbe determinato una vera e propria fuga all’estero. Nell’ultimo decennio il numero di italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero è più che raddoppiato, passando dai circa 50mila del 2002 ai 106mila del 2012. Ma è stato soprattutto nell’ultimo anno che l’aumento dei trasferimenti è stato particolarmente rilevante: (+28,8% tra il 2011 e il 2012). Una reazione al grave disagio sociale, all’ instabilità lavorativa e sottoccupazione che interessa il 25,9% dei lavoratori: una platea di 3,5 milioni di persone ha contratti a termine, occasionali, sono collaboratori o finte partite Iva. Ci sono poi 4,4 milioni di italiani che non riescono a trovare un’occupazione «pure desiderandola». Per il Censis «2,7 milioni sono quelli che cercano attivamente un lavoro ma non riescono a trovarlo, un universo che dallo scoppio della crisi è quasi raddoppiato (+82% tra il 2007 e il 2012)». Ci sono poi 1,6 milioni di italiani che, «pur disponibili a lavorare, hanno rinunciato a cercare attivamente un impiego perché convinti di non trovarlo». Cresce sempre più il disinteresse per la politica: il 56% degli italiani (contro il 42% della media europea) non ha attuato nessun tipo di coinvolgimento civico negli ultimi due anni, neppure quelli di minore impegno, come la firma di una petizione. Più di un quarto dei cittadini manifesta una lontananza pressoché totale dalla dimensione politica, non informandosi mai al riguardo. Al contrario, si registrano nuove energie difensive in tanta parte del territorio nazionale contro la chiusura di ospedali, tribunali, uffici postali o presidi di sicurezza. Tuttavia il Censis vede anche dei segnali positivi e di tenuta sociale. «Si registra una sempre più attiva responsabilità imprenditoriale femminile (nell’agroalimentare, nel turismo, nel terziario di relazione), l’iniziativa degli stranieri, la presa in carico di impulsi imprenditoriali da parte del territorio, la dinamicità delle centinaia di migliaia di italiani che studiano e/o lavorano all’estero (sono più di un milione le famiglie che hanno almeno un proprio componente in tale condizione) e che possono contribuire al formarsi di una Italia attiva nella grande platea della globalizzazione». Nuove energie si sprigionano inoltre in due ambiti che permetterebbero anche l’apertura di nuovi spazi imprenditoriali e di nuove occasioni di lavoro. «Il primo -si legge nel rapporto- è il processo di radicale revisione del welfare. Il secondo è quello della economia digitale: dalle reti infrastrutturali di nuova generazione al commercio elettronico, dalla elaborazione intelligente di grandi masse di dati, dallo sviluppo degli strumenti digitali ai servizi innovativi di comunicazione, alla crescita massiccia di giovani “artigiani digitali”». Il nuovo motore dello sviluppo, secondo il Censis, potrebbe essere la connettività (non banalmente la connessione tecnica) fra i soggetti coinvolti in questi processi». Se infatti «restiamo una società caratterizzata da individualismo, egoismo particolaristico, resistenza a mettere insieme esistenze e obiettivi, gusto per la contrapposizione emotiva, scarsa immedesimazione nell’interesse collettivo e nelle istituzioni» avremmo anche raggiunto il punto più basso dal quale non potrà che derivare un progressivo superamento di questa «crisi antropologica». Per fare connettività, secondo il Censis, non si può contare sulle istituzioni «perché autoreferenziali, avvitate su se stesse, condizionate dagli interessi delle categorie, avulse dalle dinamiche che dovrebbero regolare, pericolosamente politicizzate, con il conseguente declino della terzietà necessaria per gestire la dimensione intermedia fra potere e popolo». Neanche la politica può sviluppare questa connettività perché «più propensa all’enfasi della mobilitazione che al paziente lavoro di discernimento e mediazione necessario per fare connettività, scivolando di conseguenza verso l’antagonismo, la personalizzazione del potere, la vocazione maggioritaria, la strumentalizzazione delle istituzioni, la prigionia decisionale in logiche semplificate e rigide». Se dunque, conclude il Censis, «istituzioni e politica non sembrano in grado di valorizzarla, la spinta alla connettività sarà in orizzontale, nei vari sottosistemi della vita collettiva. A riprova del fatto che questa società, se lasciata al suo respiro più spontaneo, produce frutti più positivi di quanto si pensi».
Quella che emerge è una nazione senza scrupoli, che lucra su ogni fonte di guadagno fregandosene delle leggi, della salute della gente e del territorio. Scorie tossiche nelle campagne, rigassificatori a un chilometro dai templi di Agrigento, la decadenza dei Sassi di Matera beneficiari di finanziamenti per la tutela di milioni di euro. L’annientamento di due giudici e dei loro tecnici, avviato e pianificato con precisione maniacale da politici e colleghi, e approvato senza batter ciglio da un Consiglio Superiore della Magistratura che anziché proteggerli dagli attacchi, li consegna agli sciacalli per voce di Letizia Vacca (non me ne voglia il bovino): “due cattivi magistrati”. Il “non sapevo” oggi non è più tollerato, perché se un giorno De Magistris sarà punito dal Csm nonostante la Procura di Salerno dice che contro di lui è in atto un complotto, se la Forleo perderà la funzione di Gip per aver fatto scoprire all’Italia gli alpinisti della sinistra, questo avverrà di fronte ad una nazione cosciente, che forse allora reagirà. Ignorantia legis non excusat.
La certezza della pena non esiste più. Ci troviamo in una situazione di «indulto quotidiano», in cui tutti parlano ma nessuno fa. Il capo della Polizia non usa mezzi termini per definire lo stato della certezza della pena in Italia. «Viviamo una situazione di indulto quotidiano - dice alle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato - di cui tutti parlano. Ma su cui non si è fatto nulla negli ultimi anni». La pena, aggiunge, «oggi è quando di più incerto esiste in Italia»; un qualcosa che rende «assolutamente inutile» la risposta dello Stato e «vanifica» gli sforzi di polizia e magistratura. «Non gioco a fare il giurista - prosegue il capo della Polizia - nè voglio entrare nelle prerogative del Parlamento, ma quella che abbiamo oggi è una situazione vergognosa. La criminalità diffusa in Italia ha un segmento di fascia delinquenziale ben identificato che si chiama immigrazione clandestina» ha aggiunto il capo della polizia. «Il 30 per cento degli autori di reato di criminalità diffusa sono immigrati clandestini, ma questa media nazionale del 30 per cento va disaggregata». Così, ha proseguito il capo della polizia, si scopre, che se al Sud i reati commessi da clandestini incidono relativamente poco («i reati compiuti da irregolari si attesta intorno al 30 per cento»), al Nord e in particolare nel Nord est «si toccano picchi del 60-70 per cento». La maggior parte degli immigrati clandestini entra in Italia non attraverso gli sbarchi ma con un visto turistico. «Solo il 10 per cento dei clandestini entra nel nostro Paese attraverso gli sbarchi a Lampedusa- dice il capo della polizia- mentre il 65-70 per cento arriva regolarmente e poi si intrattiene irregolarmente». E conclude: «Il 70 per cento di quei crimini commessi nel Nord est da irregolari è compiuta proprio da chi arriva con visto turistico e poi rimane clandestinamente sul nostro territorio». Per contrastare la clandestinità, riflette Manganelli, «occorre quindi non solo il contrasto all'ingresso, ma il controllo della permanenza sul territorio dei clandestini». Ma le randellate sono riservate anche alla polizia. "La polizia ha una cultura deviata delle indagini perché pensa che identificare una persona che partecipa a una manifestazione consenta, poi, di attribuirle tutti i reati commessi nell’ambito della stessa manifestazione". A sottolinearlo il sostituto procuratore generale della Cassazione Alfredo Montagna nella sua requisitoria del 27 novembre 2008 innanzi alla prima sezione penale della Cassazione nell’ambito dell’udienza per gli scontri avvenuti a Milano, l’11 marzo 2006 a corso Buenos Aires, durante una manifestazione antifascista non autorizzata promossa dalla sinistra radicale dei centri sociali e degli autonomi per protestare contro un raduno della formazione di estrema destra "Forza Nuova". Lo ha detto in contrarietà ai suoi colleghi dei gradi di giudizio precedenti.
"Quello affermato per la Diaz deve valere anche per i cittadini" "La Giustizia deve essere amministrata - ha proseguito Montagna - con equità e non con due pesi e due misure: quel che è stato affermato per i poliziotti della Diaz, nel processo di Genova, deve valere anche per il cittadino qualunque e non solo per i colletti bianchi. Se è vero, come è vero nel nostro ordinamento che è personale il principio della responsabilità penale, questo deve valere per tutti mentre ho l’impressione che nel nostro Paese oggi, si stia allargando la tendenza ad una minor tutela dei soggetti più deboli, come possono essere i ragazzi un pò scapestrati". Montagna ha aggiunto che "non può passare, alla pubblica opinione, un messaggio sbagliato per cui sui fatti della Diaz i giudici decidono in maniera differente rispetto a quando si trovano a giudicare episodi come quelli di corso Buenos Aires". Invece i giudici hanno deciso in modo differente: per i poliziotti e i loro dirigenti assoluzione quasi generale; per i ragazzi condanne confermate per tutti.
Ma le stoccate vengono portate su tutto il sistema. "Profili di patologie emergono nel settore dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture, nonché nella materia sanitaria, fornendo un quadro di corruzione ampiamente diffuso". Lo ha sottolineato il procuratore generale della Corte dei Conti, nella Relazione all'apertura dell'anno giudiziario della magistratura contabile. Il Pg ha aggiunto che "in particolare l'accertamento del pagamento di tangenti è correlato ad artifici ed irregolarità connesse a fattispecie della più diversa natura, quali la dolosa alterazione di procedure contrattuali, i trattamenti preferenziali nel settore degli appalti d'opera, la collusione con le ditte fornitrici, la illecita aggiudicazione, la irregolare esecuzione o l'intenzionale alterazione della regolare esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi". Comportamenti illeciti di cui e' conseguenza "il pagamento di prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato o addirittura il pagamento di corrispettivi per prestazioni mai rese".
L’Italia non crede più nelle istituzioni che dovrebbero guidarla. Il potere "esercita il comando senza obiettivi e senza principi, perde ogni rapporto con la realtà del Paese", diventa autoreferenziale e alla fine forma "una società separata", con una sua lingua, le sue gazzette, i suoi clan, i suoi privilegi. Questa "società separata ha le finestre aperte solo su se stessa", denuncia il Rapporto Italia dell'Eurispes. In realtà, sottolinea l'Istituto di studi economici e sociali, la politica non c'è più: è estinta, grazie alla tenacia dei poliburocrati, i burocrati dei due poli, ora quasi tutti in "overdose", sopraffatti dai loro stessi abusi.
È una fotografia impietosa quella scattata dal Censis nel suo Rapporto sulla situazione sociale del Paese. L’Italia, secondo l’istituto di ricerca socioeconomica presieduto da Giuseppe De Rita, è un Paese apatico, senza speranza verso il futuro, nel quale sono sempre più evidenti, sia a livello di massa sia a livello individuale, «comportamenti e atteggiamenti spaesati, indifferenti, cinici, prigionieri delle influenze mediatiche». Gli italiani si percepiscono, scrive il Censis, come «condannati al presente senza profondità di memoria e di futuro», vittime di fittizi «desideri mai desiderati» come l’ultimo cellulare alla moda e in preda spesso a «narcisismo autolesionistico», come è testimoniato dal fenomeno del «balconing». Quella italiana sarebbe, in sostanza, una società «pericolosamente segnata dal vuoto».
"Una mucillagine sociale che inclina continuamente verso il peggio".
Così il Censis descrive la realtà italiana, costituita da una maggioranza che resta "nella vulnerabilità, lasciata a se stessa", "più rassegnata che incarognita", in un'inerzia diffusa "senza chiamata al futuro".
La realtà diventa ogni giorno "poltiglia di massa - spiega il Rapporto sulla situazione sociale del paese - indifferente a fini e obiettivi di futuro, ripiegata su se stessa"; la società è fatta di "coriandoli" che stanno accanto per pura inerzia.
Una minoranza industriale, dinamica e vitale, continua nello sviluppo, attraverso un'offerta di fascia altissima del mercato, produzioni di alto brand, strategie di nicchia, investimenti all'estero; cresce così la voglia di successo degli imprenditori e il loro orgoglio rispetto al mondo di finanza e politica.
Ma "siamo dentro una dinamica evolutiva di pochi e non in uno sviluppo di popolo": "la minoranza industriale va per proprio conto, il governo distribuisce 'tesoretti'", ma lo sviluppo non filtra perché non diventa processo sociale e la società sembra adagiata in un'inerzia diffusa.
Lo sviluppo di una minoranza non ha saputo rilanciare i consumi e la maggioranza si orienta per acquisizioni low cost e su beni durevoli, senza un clima di fiducia.
L'italiano medio dovunque giri lo sguardo sembra pensare di fare esperienza del peggio: nella politica, nella violenza intrafamiliare, nella micro-criminalità e nella criminalità organizzata, nella dipendenza da droga e alcool, nella debole integrazione degli immigrati, nella disfunzione delle burocrazie, nella bassa qualità dei programmi tv.
La minoranza industriale, dinamica e vitale, non ce la fa a trainare tutti, visto che é concentrata sulla conquista di mercati ricchi e lontani, con prodotti a prezzo così alto che non possono scatenare effetto imitativo.
La pur indubbia ripresa - fa notare il Censis - rischia di essere malata se non si immette fiducia nel futuro.
La classe politica, scossa dalla ventata di antipolitica, non può fare da collettore di energie.
Solo delle minoranze "possono trovare la base solida da cui partire" e "sprigionare le energie necessarie per uscire dallo stallo odierno"; si tratta delle minoranze che fanno ricerca e innovazione, giovani che studiano all'estero, professionisti che esplorano nuovi mercati; chi ha scelto di vivere in realtà locali ad alta qualità della vita; minoranze che vivono l'immigrazione come integrazione, che credono in un'esperienza religiosa e sono attente alla persona, che hanno scelto di appartenere a gruppi, movimenti, associazioni, sindacati.
Le diverse minoranze dovranno gestire da sole una sfida faticosa, immaginando spazi nuovi di impegni individuali e collettivi: una sfida assolutamente necessaria - per il Censis - per allontanare l'inclinazione al peggio che "fa rasentare l'ignominia intellettuale e un'insanabile noia".
Il presidente del Censis, De Rita: “Italia rassegnata e furba senza senso del peccato. Lo Stato ha perso autorità morale e sta saltando.”
Nella reazione dell’opinione pubblica ai ripetuti scandali, c’è una sorta di rassegnazione al peggio, un atteggiamento diverso rispetto all’era Tangentopoli, eppure questo approccio non stupisce il presidente del Censis Giuseppe De Rita: «Sì, in giro c’è una rassegnazione vera, ma anche furba. Chiunque di noi può ascoltare grandi dichiarazioni indignate: “Qui sono tutti mascalzoni!”. La gente ragiona così: sento tutti parlare male di tutti e anche io faccio lo stesso. Dopodiché però non scatta la molla: e io che faccio? Non scatta per l’assenza di codici ai quali ubbidire. Non scatta perché non c’è più un vincolo collettivo. Tutto può essere fatto se io stesso ritengo giusto che sia fatto».
La profondità e l’autorevolezza della sua lettura della società e del costume italiano già da tempo hanno fatto di Giuseppe De Rita un’autorità morale, una dei pochissimi intellettuali italiani che è impossibile incasellare.
«Siamo passati dal grande delitto ai piccoli delitti. Dall’Enimont al piccolo appalto. Ma questa è la metafora del Paese. A furia di frammentare, anche i reati sono diventati più piccoli e ciascuno se li assolve come vuole. E’ entrato in crisi il senso del peccato, ma lo Stato che dovrebbe regolare i comportamenti sconvenienti, non ha più l’autorità morale per dire: quel reato è veramente grave. E allora salta lo Stato. Come sta accadendo adesso. Se sei un piccolo ladruncolo, cosa c’è di meglio che prendersela col grande ladro? Se fai illegalmente il secondo lavoro da impiegato pubblico, poter dire che quelli lì erano ladri e si sono mangiati tutto, non è un alibi, ma è una messa in canto della propria debolezza. Le formichine italiane hanno fatto il Paese, ma hanno preso tutto quello che era possibile dal corpaccione pubblico. Noi che predicavamo le privatizzazioni “alte”, non abbiamo capito che il modo italico di privatizzare era tradurre in interesse privato qualsiasi cosa. Un fenomeno di massa: ognuno si è preso il suo pezzetto di risorsa pubblica. La classe dirigente della Seconda Repubblica non è stata soltanto la “serie B” della Prima, ma le sono mancati riferimenti di autorità morale. Una classe dirigente si forma sotto una qualche autorità etica. De Gasperi si era formato nell’Austria-Ungheria, il resto della classe dirigente democristiana, diciamoci la verità, si è formata in parrocchia. La classe dirigente comunista si era formata in galera o nella singolare moralità del partito. Questa realtà di illegalità diffusa ha inizio con don Lorenzo Milani. Con don Milani e l’obiezione di coscienza. Ci voleva una autorità morale come la sua per dire che la norma della comunità e dello Stato è meno importante della mia coscienza. E’ da lì che inizia la stagione del soggettivismo etico. Un’avventura che prende tre strade. La prima: la libertà dei diritti civili. Prima di allora non dovevi divorziare, non dovevi abortire, dovevi fare il militare, dovevi obbedire allo Stato e poi sei diventato libero di fare tutto questo. Seconda strada: la soggettività economica, ciascuno ha voluto essere padrone della propria vita, non vado sotto padrone, mi metto in proprio. E’ il boom delle imprese. La terza strada, la più ambigua: la libertà di essere se stessi e quindi di poter giudicare tutto in base ad un criterio personale. Il marito è mio e lo cambio se voglio, il figlio è mio e lo abortisco se voglio. L’azienda è mia e la gestisco io. Io stesso, certe volte parlando con i miei figli, dico: il peccato è mio, me lo “gestisco” io».
Il Csm, è la convinzione del capo dello Stato nella cerimonia al Quirinale di commiato dai componenti del Csm uscenti e di saluto a quelli entranti, deve «contrastare decisamente oscure collusioni di potere ed egualmente esposizioni e strumentalizzazioni mediatiche, a fini politici di parte o a scopo di "autopromozione personale"». Il 31 luglio 2010 l'inquilino del Quirinale cita «fenomeni di corruzione di trame inquinanti che turbano e allarmano, apparendo essi tra l’altro legati all’operare di "squallide consorterie"».
Per il Colle è importante «alzare la guardia nei confronti di deviazioni che finiscono per colpire fatalmente quel bene prezioso che è costituito dalla credibilità morale e dall'imparzialità e dalla terzietà del magistrato». «Già nella risoluzione adottata dal Csm il 20 gennaio 2010 - ricorda Napolitano nel discorso di saluto dei nuovi componenti del Csm - si è mostrata consapevolezza della percezione da parte dell'opinione pubblica che, alcune scelte consiliari siano in qualche misura condizionate da logiche diverse, che possono talvolta affermarsi in "pratiche spartitorie", rispondenti ad "interessi lobbistici, logiche trasversali, rapporti amicali o simpatie e collegamenti politici"».
Nel documento base della ‘Settimana sociale’, di Agosto 2010, la Cei definisce l’Italia “un Paese senza classe dirigente”.Nel documento è possibile leggere: “L’Italia è un paese senza classe dirigente, senza persone che per ruolo politico, imprenditoriale, di cultura, sappiano offrire alla nazione una visione e degli obiettivi condivisi e condivisibili”.
L’Italia è un Paese «sfilacciato», addirittura ridotto «a coriandoli», che ha paura del futuro. È dirompente la radiografia che il presidente dei vescovi italiani, ha fatto aprendo i lavori del Consiglio permanente della Cei.
“La verità è che ‘il Paese da marciapiede’ i segni del disagio li offre (e in abbondanza) da tempo, ma la politica li toglie dai titoli di testa, sviando l’attenzione con le immagini del ‘Presidente spazzino’, l’inutile ‘gioco dei soldatini’ nelle città, i finti problemi di sicurezza, la lotta al fannullone”. Questo scrive Famiglia Cristiana. Ciò svia l’attenzione dai problemi economici del Paese, e con il rischio “di provocare una guerra fra poveri, se questa battaglia non la si riconduce ai giusti termini, con serietà e senza le ‘buffonate’, che servono solo a riempire pagine di giornali”.
Il Vaticano non recepisce più automaticamente, come fonte del proprio diritto, le leggi italiane. Tre i motivi principali di questa drastica scelta: il loro numero esorbitante, l'illogicità e l'amoralità di alcune norme. Lo riferisce l'Osservatore Romano all’atto di presentazione della nuova legge della Santa Sede sulle fonti del diritto firmata da Benedetto XVI, vigente dal primo gennaio 2009 e in sostituzione della legge del 7 giugno 1929.
E che dire della malattia dei politici. Poltronismo, poltronite. La malattia è presto definita: raccogliere sotto lo stesso corpo più incarichi possibili. La prima poltrona dà potere e visibilità. La seconda fiducia e tranquillità. Se casco lì, rimango in piedi qui. O viceversa.
La Prima Repubblica aveva molti difetti ma alcune virtù nascoste. Tra queste separare in modo indiscutibile la guida degli enti locali con l'impegno da parlamentare. Il divieto, contenuto in una legge del 1957 e limitato ai centri con più di ventimila abitanti e alle province, tutte, trovava fondamento nell'idea di offrire parità di condizioni ai candidati. Un deputato che fosse in corsa per fare il sindaco aveva più possibilità di captare voti. Dunque avrebbe violato la par condicio. Per anni norma osservata, e disciplina dei sensi unici assoluta. Con Tangentopoli il mercato della politica si è però ristretto. Molti presentabili sono divenuti impresentabili. Molti politici in carriera si sono ritrovati in panchina. Molti altri colleghi addirittura oltre le tribune, fuori dal gioco, alcuni dietro le sbarre.
Col favore delle tenebre, nel silenzio assoluto e nella distrazione collettiva, il 2 giugno del 2002 la Giunta per le elezioni, organo politico a cui sono affidati poteri giurisdizionali, cambia i sensi, inverte i passaggi. Chi fa il sindaco di una città che abbia più di ventimila abitanti o il presidente della Provincia non può candidarsi a deputato o senatore. Ma chi è parlamentare può. Senso inverso possibile. La cosa è piaciuta ai più: fare il sindaco-deputato è molto meglio che fare soltanto il sindaco. E se è vero che le indennità non sono cumulabili è certo che le prerogative invece lo sono. Esempio su tutte: l'immunità.
E quindi è iniziata la processione. Prima quello, poi quell'altro. Dopo di te io. E allora io. Un deputato è sindaco a Viterbo, un senatore è sindaco a Catania; una deputata è presidente della Provincia di Asti, un senatore presiede quella di Avellino. Un deputato è sindaco a Brescia, un collega è presidente a Napoli. E via così...
I più hanno trasmesso ai nuovi uffici la stessa foto di rappresentanza data agli uffici parlamentari. Quando serve siamo qui. Col tesserino. Quando non serve siamo lì. Con la fascia tricolore. E' un bel segno in questi tempi di crisi: più poltrone per tutti.
Da una ricerca emergono i difetti del “belpaese”. Italiani maleducati, arroganti e corrotti, con scarso rispetto per l'ambiente e le diversità. I più viziosi? Senza ombra di dubbio, i politici seguiti, a ruota, da sindacalisti, imprenditori e banchieri.
Inizia con in esclusiva dell'indagine, curata dal sociologo Enrico Finzi, che il 'Messaggero di “Sant’Antonio” ha commissionato ad Astra Ricerche, istituto di ricerca demoscopica di cui Finzi è presidente.
Uno zoom sui nuovi vizi dal quale emerge una radiografia 'in presa diretta' sull'Italia.
''Nell'anteprima dell'indagine pubblicata in questo numero della Rivista, si possono trovare le prime istantanee - afferma il direttore della rivista, padre Ugo Sartorio - ossia quali sono i nuovi vizi più diffusi, le cause e, soprattutto, l'identikit degli italiani più 'viziosi'''.
In testa alla classifica dei vizi ci sono i politici, secondo il 78% degli interpellati; seguono i sindacalisti al secondo posto, 40% circa, e poi i giovani, i giornalisti e gli immigrati, attorno al 35%. Tra i nuovi vizi più diffusi l'arroganza e la maleducazione, la corruzione, la disonestà, il consumismo, ma anche l'indifferenza e l'irresponsabilità.
Al primo posto, per quanto riguarda i vizi nella società, troviamo la maleducazione: ben nove su dieci abitanti del Belpaese puntano il dito contro questo vizio.
Al terzo posto, col 77% delle indicazioni, incontriamo il menefreghismo. In stretta connessione, con un valore di poco inferiore (74%), quel tipo di degenerazione etica che si traduce nella disonestà e anche nella corruzione.
Insomma, la più aspra preoccupazione della gente riguarda in generale l'imbarbarimento della vita e delle relazioni interpersonali, fondato sul trionfo dell''io isolato dagli altri' e sul venir meno dell'etica personale e collettiva.
Di diversa natura, ''ma in fondo non così dissimile'', è il quinto macro-difetto, lamentato dal 71% dei 18-79enni: ''lo scarso rispetto per la natura e per l'ambiente''.
Il 49% del campione indica come vizio più grave ''il carrierismo e la competizione senza regole e senza freni, essi stessi determinati dall'egoismo o dal considerare gli altri solo un mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Al penultimo posto in questa triste classifica - rileva il presidente di Astra ricerche - ecco il dilagare tra gli italiani dell'immaturità e spesso dell'infantilismo.
Infine il 42% denuncia la crescita nella nostra società dell'intolleranza (a volte religiosa, a volte politica, spesso culturale, spessissimo sportiva): quell'incapacità di accettare e anzi di valorizzare la pluralità delle opinioni e dei comportamenti che rende democratica e civile, oltre che moralmente solida, qualunque civiltà.
Una fotografia, quella voluta dal 'Messaggero di sant'Antonio', che aiuta a rilevare attraverso un'ottica il più possibile imparziale i tratti di un Paese dai mille volti.
Un occhio agli italiani anche da parte straniera, e il risultato per noi non è proprio dei migliori.
Impietosa analisi del Belpaese dove regna "una dilagante impunità e uno standard di vita in declino".
"L'Italia è oggi una terra inondata da corruzione, decadenza economica, noia politica, dilagante impunità e uno standard di vita in declino".
E' l'impietosa analisi che fa del nostro Paese il Los Angeles Times in occasione delle elezioni politiche del 2008 per la scelta del "62esimo governo in 63 anni". Elezioni nelle quali gli elettori potranno scegliere fra "rei condannati" o "ballerine della tv". Il titolo dell'articolo di Tracy Wilkinson è: "In Italia il crimine paga e vi può far eleggere".
Il Los Angeles Times descrive l'Italia - un tempo "leggendaria icona di cultura" - come un Paese dove la gestione di un'impresa "è un'esperienza torbida e frustrante, a meno di non essere la Mafia, oggi il più grande business in Italia".
Un Paese dove "il sistema giudiziario raramente funziona", e "i parlamentari sono i più pagati d'Europa ma, secondo l'opinione di molti, i meno efficaci, una elite che si autoperpetua" e sembra "voler trascinare giù il Paese con sé".
Un' Italia ormai in ginocchio, con una classe politica "iper-pagata" preda dell' "immobilismo" e del "trasformismo" che sta inesorabilmente perdendo "legittimità"' tra i cittadini stanchi e disillusi. E' un quadro nero della Penisola, il Paese "peggio governato d'Europa", quello che il professor Martin Rhodes traccia nella pagina dei commenti del Financial Times.
I giornali lo dicono chiaramente: non siamo più emblema di stile, ma quintessenza della maleducazione. "Dimenticatevelo il Bel Paese. Musica rap strombazza da una radio portatile e un pallone rotola sul vostro asciugamano mentre una mamma italiana urla a suo figlio insabbiato. Questa è la vita da spiaggia, almeno alla maniera italiana" sentenzia il Sydney Morning Herald. Ma non solo: "un turista visto una sola volta viene considerato non una persona, bensì un’incombenza" (The Guardian), "nelle code ai musei ti ritrovi spinto addirittura da suore" si sostiene su travelpod.com. E ancora, "ci sono preservativi usati ovunque ad inquinare i parchi protetti" (italy.net), mentre in città "la colonna sonora simbolica dell'Italia è il ronzio del motore a due marce degli scooter che sfrecciano ignorando le regole tra il traffico impenetrabile" (New York Times).
Immagine italiana all'estero: sempre più opaca. È il quadro che emerge da una ricerca sulla stampa estera dell’Osservatorio Giornalistico Internazionale Nathan il Saggio (www.nathanilsaggio.com), reso noto dall’Agenzia KlausDavi, che ha monitorato le principali testate straniere (dal New York Times a Le Monde, dall’Herald Tribune al Der Spiegel) e i più importanti portali di informazioni turistiche sul tema "l’Italia vista dagli altri". Ne scaturisce un’analisi critica e a volte dura da parte della stampa estera che denota l’opacizzazione dell’immagine dello stile italiano all’estero.
"Che fine ha fatto la dolce vita?", il titolo di un articolo del Guardian, pare essere emblematico di questo cambiamento di percezione nei confronti del paese del sole. Da simpatici burloni, pronti ad accogliere con il sorriso gli ospiti e pieni del celeberrimo fascino Italian Style riconosciuto in tutto il mondo, gli italiani di oggi riempiono le colonne della stampa estera per maleducazione ed eccessi di arroganza e furbizia. Per strada sono sempre pronti a fischiare le ragazze, concentrati solo sul proprio aspetto fisico e gettano immondizia ovunque (The Sidney Morning Herald). Nella classifica compare la città di Viareggio, "invasa d’estate dalla solita calca italiana stravaccata sotto gli ombrelloni e sempre impegnata a far squillare i cellulari" (Times) e "meta di chi vuol esibire il proprio status" (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Segue Rimini con le sue spiagge sovrappopolate e addirittura da evitare, secondo Liberation. Alberghi non accoglienti e infestati da ragni (Focus), valgono a Bibione la terza posizione in questa ’classificà. Chiudono Varigotti, perla della costa ligure che però è invasa da parcheggiatori e bagni abusivi (Abc), e Amalfi, dove strombazzate e insulti in auto sono la normalità (The Globe and Mail).
Questo per quanto riguarda l'Italia degli adulti. E i nostri figli ??
Cresce fra le ragazzine il fenomeno della microprostituzione: sesso a scuola e sul web per arrotondare la “paghetta”.
Ricordate, appena qualche anno fa, quando si parlava di immagini spinte che gli adolescenti facevano girare con i telefonini? Allora quel fenomeno, che era ai suoi albori, venne inquadrato in una specie di patologia “esibizionistica” imitativa fra teenagers. Capitarono anche casi di video “hard” di ragazzine, destinati all’auto-contemplazione all’interno della coppia o al ristretto giro delle amicizie più intime, diffusi, invece, sempre tramite i cellulari, ad intere scolaresche ed intercettati anche dagli allibiti genitori. Alcuni di questi episodi divennero casi di cronaca anche in Emilia, a Bologna e Modena, con povere ragazze messe in piazza in quel modo, e genitori costretti a rivolgersi ai carabinieri.
Si parlò poi di “bullismo elettronico”, quando, oltre alle scene di sesso precoce, vennero fatte circolare dai cellulari anche immagini girate a scuola di pestaggi (anche ai danni di minorati) o di “scherzi pesanti” a professori (ricordate il caso di Lecce della professoressa in perizoma, palpeggiata dagli alunni?). Ci si interrogò allora sul bisogno dei giovani di “apparire” a tutti i costi, di “visibilità” anche negativa, per esistere….
Ebbene a distanza di pochi anni, il fenomeno ha cambiato definizione e modalità: non più “esibizionismo”, non più “bullismo”, non più violenza gratuita, non più gratuita ostentazione… nel senso che le ragazzine continua a riprendersi o a farsi riprendere in situazioni “osè”, ma adesso pretendono di essere pagate. Il fenomeno si sta cioè convertendo in “microprostituzione” a scuola o tramite web. Una forma di prostituzione per così dire “under”, estemporanea, praticata per lo più fra coetanei (per questo la si chiama “micro”), ma è certo alta la possibilità che queste stesse ragazze possano diventare anche “prede” di adulti senza scrupoli, ed ovviamente più danarosi dei loro compagni di classe.
Il fenomeno è osservato ed in preoccupante espansione. Per molte ragazze sta diventando “normale” concedere prestazioni sessuali, o ritrarsi in pose erotiche tramite la webcam o gli stessi cellulari, in cambio di soldi per arrotondare la paghetta dei genitori. Paghetta che magari la crisi può aver un po’ ristretto.
E che dire delle leggi?
Guida pratica comune del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a coloro che partecipano alla redazione dei testi legislativi delle istituzioni europee.
La redazione degli atti deve essere:
chiara, facilmente comprensibile, priva di equivoci;
semplice, concisa, esente da elementi superflui;
precisa, priva di indeterminatezze.
Tale regola ispirata al buon senso è espressione di principi generali del diritto come i seguenti:
l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, nel senso che la legge deve essere accessibile e comprensibile a tutti;
la certezza del diritto, in quanto l’applicazione della legge deve essere prevedibile.
Invece in Italia così non è. L'aspirante dannunziano Roberto Calderoli ha fatto un miracolo: denunciata la presenza di 29.100 leggi inutili, ne ha bruciate in un bel falò 375.000, scrive Gian Antonio Stella su “Il Corriere della Sera”. Fatti i conti, lavorando 12 ore al giorno dal momento in cui si è insediato, più di una al minuto: lettura del testo compresa. Wow! Resta il mistero dell’ingombro di quelle appena fatte. Stando al «Comitato per la legislazione» della Camera, i soli decreti del governo attuale hanno sfondato la media di 2 milioni di caratteri l’uno: 56 decreti, 112 milioni di caratteri. Per capirci: l’equivalente di 124,4 tomi di 500 pagine l’uno. Dicono le rappresentanze di base dei vigili del fuoco che quella del ministro è stata «una sceneggiata degna del Ventennio». E c’è chi sottolinea che i roghi di carta, in passato, hanno sempre contraddistinto i tempi foschi. Per non dire delle perplessità sui numeri: se la relazione della commissione parlamentare presieduta da Alessandro Pajno e più volte citata da Calderoli aveva accertato «circa 21.000 atti legislativi, di cui circa 7.000 anteriori al 31 dicembre 1969», come ha fatto lo stesso Calderoli a contarne adesso 375.000? Al di là le polemiche, tuttavia, resta il tema: fra i faldoni bruciati ieri nel cortile di una caserma dei pompieri (lui avrebbe voluto fare lo show a Palazzo Chigi ma Gianni Letta, poco marinettiano, si sarebbe opposto...) c’erano soltanto antichi reperti burocratici quali l’enfiteusi o anche qualcosa di più recente? Prendiamo l’articolo 7 delle norme sul fondo perequativo a favore delle Regioni: «La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 6 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l’esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base imponibile...». Il ministro Calderoli concorderà: un delirio. Il guaio è che non si tratta di una legge fatta ai tempi in cui Ferdinando Petruccelli della Gattina scriveva «I moribondi del Palazzo Carignano». È una legge del governo attuale, presa mesi fa ad esempio di demenza burocratese da un grande giornalista non certo catalogabile fra le «penne rosse»: Mario Cervi. Direttore emerito del Giornale berlusconiano. Eppure c’è di peggio. Nel lodevolissimo sforzo di rendere più facile la lettura e quindi il rispetto delle leggi, il governo approvò il 18 giugno 2009 una legge che aveva un articolo 3 titolato «Chiarezza dei testi normativi». Vi si scriveva che «a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo...». Insomma: basta con gli orrori da azzeccagarbugli. Eppure, ecco il comma dell’articolo 1 dell’ultimo decreto milleproroghe del governo in carica: «5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31». Cioè? Boh...È questo il punto: che senso c’è a incendiare un po' di scatoloni di detriti burocratici che parlano di «concessioni per tranvia a trazione meccanica» o di «acquisto di carbone per la Regia Marina» se poi gli spazi svuotati da quelle regole in disuso vengono riempiti da nuove norme ancora più confuse, deliranti, incomprensibili? La risposta è in un prezioso libretto curato dal preside della facoltà di lettere e filosofia di Padova Michele Cortellazzo. Si intitola: Le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione tradotte in italiano. Sottotitolo: Omaggio al ministero dell’Interno. Non fosse una cosa seria, potrebbe essere scambiata per satira: se le regole elettorali fossero comprensibili, perché mai dovrebbero essere «tradotte in italiano»? Anche negli armadi impolverati delle legislazioni straniere esistono mucchi di leggi in disuso. Un sito internet intitolato «gogna del legislatore scemo» ne ha steso un elenco irresistibile. In certi Stati del Far West americano è proibito «pescare restando a cavallo». Nell’Illinois chi abbia mangiato aglio può essere incriminato se va a teatro prima che siano trascorse quattro ore. A Little Rock dopo le 13 della domenica non si può portare a spasso mucche nella Main Street. Ogni tanto, senza farla tanto lunga, i legislatori svuotano i magazzini. Magari cercando di non fare gli errori sui quali, nello sforzo di fare in fretta, era incorsa la "ramazza" di Calderoli, la quale, come via via hanno segnalato i giornali consentendo di rimediare alle figuracce, aveva spazzato via per sbaglio anche il trasferimento della capitale da Firenze a Roma, l’istituzione della Corte dei Conti o le norme che consentono a un cittadino di non essere imputato per oltraggio a pubblico ufficiale se reagisce ad atti arbitrari o illegali. Ciò che più conta, però, è fare le leggi nuove con chiarezza. Se no, ogni volta si ricomincia da capo. Qui no, non ci siamo. E a dirlo non sono i «criticoni comunisti» ma il Comitato parlamentare per la legislazione presieduto dal berlusconiano Antonino Lo Presti. Comitato che due mesi fa spiegò che i decreti del governo Prodi, già gonfi di parole, numeri e codicilli, contenevano mediamente 1 milione e 128 mila caratteri. Quelli del governo Berlusconi, a forza di voler tener dentro tutto, hanno superato i 2 milioni. E sarebbe questa, la semplificazione? Ci siamo liberati delle ottocentesche norme sulla «riproduzione tramite fotografia di cose immobili» per tenerci oggi astrusità come i rimandi «all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l’applicazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 853...»? Ma dai...
Non basta sono gli stessi legislatori ad essere illegittimi, quindi abusivi. Incostituzionalità della Legge elettorale n. 270/2005. Dal Palazzo della Consulta, 4 dicembre 2013. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza. Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici. Resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali.
Il Porcellum è illegittimo, dice la Corte costituzionale. Bocciato il premio di maggioranza, bocciate le liste bloccate. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme sul premio di maggioranza, per Camera e Senato, attribuito alla lista o alla coalizione che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e non abbiano avuto almeno 340 seggi a Montecitorio e il 55 per cento dei seggi assegnati a ogni regione, a Palazzo Madama. Contrarie alla Carta anche le norme sulle liste «bloccate»,perché non consentono all’elettore di dare una preferenza. Accoglie in toto il ricorso contro la legge elettorale del 2005, l’Alta Corte. Ma nella lunga camera di consiglio è battaglia. Perché dopo il voto unanime sull’ammissibilità del ricorso e poi sull’eliminazione del premio di maggioranza, sulla terza questione ci si spacca 7 a 8. Sembra che i giudici più vicini alla sinistra, dal presidente Gaetano Silvestri a Sabino Cassese e Giuliano Amato (di nomina presidenziale), allo stesso Sergio Mattarella (scelto dal parlamento e padre del sistema precedente), volessero che l’Alta Corte affermasse che abolite le liste bloccate ci fosse la «reviviscenza» del vecchio sistema. Ma la manovra non sarebbe riuscita perché si sarebbero opposti lo stesso relatore Giuseppe Tesauro, il vicepresidente Sergio Mattarella, i giudici Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo e altri scelti da Cassazione e Consiglio di Stato.
GLI EFFETTI GIURIDICI INCONTESTABILI: SONO DA CONSIDERARSI INESISTENTI, QUINDI NON LEGITTIMATI A LEGIFERARE, A DECRETARE ED A NOMINARE CHI E’ STATO ELETTO CON UNA LEGGE INCOSTITUZIONALE, QUINDI INESISTENTE. INESISTENTI SONO, ANCHE, GLI ATTI DA QUESTI PRODOTTI: NORME GIURIDICHE O NOMINE ISTITUZIONALI.
L'abrogazione di una norma giuridica, ossia la sua perdita di efficacia, può avvenire mediante l'emanazione di una norma successiva di pari grado o di grado superiore. Fanno eccezione le leggi temporanee nelle quali l'abrogazione è indicata con il termine della durata indicata dal Legislatore.
L'articolo 15 delle Preleggi delinea tre distinti casi di abrogazione: Art. 15 Abrogazione delle leggi. "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore." Nel caso in cui la norma è abrogata, in tutto o in parte, mediante una legge posteriore con esplicito riferimento alla norma precedente si parla di "abrogazione espressa". Quando l'abrogazione deriva dall'incompatibilità delle precedenti norme con quelle emanate successivamente si parla di "abrogazione tacita". Infine, quando una nuova legge disciplina un'intera materia già regolamentata, conferendogli una nuova sistematicità logico-giuridica, le precedenti norme sono abrogate. In quest'ultimo caso si parla di "abrogazione implicita".
Abrogazione per incostituzionalità. Una norma giuridica può essere abrogata anche mediante sentenza di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale. Articolo 136 – Costituzione. "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [cfr. art. 134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali."
Abrogazione per referendum. Infine, un altro fenomeno estintivo di una norma giuridica previsto dal nostro ordinamento giuridico è dato dal referendum abrogativo. Articolo 75 – Costituzione. "E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80]. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum."
Abrogazione per desuetudine. Nell'ordinamento giuridico italiano non è valida l'abrogazione per desuetudine. L'abrogazione di una norma giuridica, ossia la sua perdita di efficacia, può avvenire mediante l'emanazione di una norma successiva di pari grado o di grado superiore. Fanno eccezione le leggi temporanee nelle quali l'abrograzione è indicata con il termine della durata indicata dal Legislatore.
L'abrogazione è l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) dell'efficacia di una norma giuridica. Si distingue dalla deroga (posta in essere da una norma speciale o eccezionale) in quanto una norma "derogata" resta in vigore per la generalità dei casi, mentre una norma abrogata cessa di produrre effetti giuridici. Si distingue dall'annullamento, che priva retroattivamente di efficacia una norma. Tutte le norme giuridiche si sviluppano necessariamente su due piani, quello temporale e quello spaziale. In questo scritto sarà la dimensione temporale ad essere presa in considerazione. Questo implica che si muovano i primi passi da una norma ulteriore rispetto a quelle citate in precedenza.
L'articolo 11 delle Preleggi disciplina il principio di irretroattività della legge: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Il significato di tale regola è che una norma non può essere applicata a situazioni di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Il principio di irretroattività, previsto dall'articolo 11 delle Preleggi, è ripreso dall'articolo 25 della Costituzione il quale lo codifica, meglio lo costituzionalizza, limitatamente all'ambito penale, disponendo, per assicurare un'esigenza di certezza ai comportamenti dei consociati, che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". La previsione costituzionale del principio di irretroattività delle leggi, anziché definire, almeno in ambito penale, le problematiche sottese alla efficacia delle norme nel tempo apre delle problematiche ulteriori soprattutto quando viene letto in combinato con l'articolo 2 del codice penale. L'articolo 2 del codice penale statuisce che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
Quanto detto analiticamente vale per gli att. Per quanto riguarda le persone elette con norme abrogate perché ritenute incostituzionali?
Nel diritto la nullità è una delle massime sanzioni in quanto opera di diritto (ipso iure) cioè non è richiesto l'intervento del giudice: l'atto nullo è inefficace di diritto. Nel codice civile si ha un atto nullo quando manca di uno degli elementi essenziali o risulta in contrasto con norme imperative. Anche la nullità degli atti amministrativi è riconducibile a questa disciplina avendo però, ovviamente, elementi essenziali diversi e norme imperative differenti da rispettare. La conseguenza della nullità è la stessa: l’atto è come mai esistito. Le cause di nullità, quindi, sono:
- Casi previsti dalla legge, nel diritto amministrativo non basta il semplice contrasto con una norma ma occorre che tale norma preveda come conseguenza della sua inosservanza la nullità dell’atto. Ecco perché si parla più propriamente di casi previsti dalla legge.
- Inottemperanza alle sentenze, può essere considerato un sottoinsieme della categoria dei casi previsti dalla legge, in quanto una legge prevede che nel caso che un atto non si conformi ad un precedente giudicato sia nullo.
- Mancanza degli elementi essenziali, si cerca di applicare l’art. 1325 c.c. per individuare gli elementi degli atti amministrativi.
Partendo dal suddetto articolo la giurisprudenza ha individuato gli elementi essenziali degli atti amministrativi in:
- soggetto, è nullo l’atto il cui autore non sia identificabile;
- oggetto, è nullo l’atto avente un oggetto inesistente, indeterminato o indeterminabile, o inidoneo (espropriare un bene demaniale);
- forma, vige il principio di libertà della forma ma in alcuni casi si ritiene che sia essenziale una certa forma, perché richiesta da una disposizione espressa o dalla prassi. In tali casi il difetto di forma causa nullità dell’atto;
- contenuto, è nullo l’atto con contenuto indeterminato, indeterminabile, inidoneo o illecito (autorizzare ad uccidere, autorizzare un’attività non definita, ecc…);
- causa, si discute se sia elemento essenziale e quindi causa di nullità, o consista nell’interesse pubblico specifico che l’atto deve perseguire e in tal caso la sua violazione comporta illegittimità per eccesso di potere.
- Difetto assoluto di attribuzione (incompetenza assoluta), può essere considerato un sottoinsieme in quanto corrisponde alla mancanza di un elemento essenziale: il soggetto.
Si ha incompetenza assoluta quando l’atto emanato
era di competenza non-amministrativa oppure di altra amministrazione (Regione
che interviene in materie statali è incompetenza assoluta). La c.d. carenza di
potere, che non è prevista espressamente tra le cause di nullità, se ha quando
l’amministrazione adotta un atto senza che sussistessero i presupposti legali
che la autorizzassero ad emanarlo. Le conseguenze della nullità prevedono che
l’atto sia privo di efficacia giuridica in maniera retroattiva, cioè le
eventuali attività già svolte risultano prive di giustificazione.
Non è necessario che l’atto nullo sia eliminato, è sufficiente la sentenza
dichiarativa del giudice competente.
La nullità è assoluta (può essere chiesta da chiunque, anche d’ufficio) ed è
imprescrittibile.
Spiego meglio. Gli atti sono invalidi quando risultano difformi da ciò che la legge stabilisce. Possono essere: inesistenti (o nulli), o annullabili.
1. Inesistenza. È la mancanza di un elemento essenziale che comporta la totale nullità dell'atto. I principali casi sono:
a) inesistenza del soggetto; quando l'atto non può essere considerato espressione del pubblico potere poiché emanato da un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione;
b) incompetenza assoluta per territorio; quando l'atto è stato emanato da un organo della pubblica amministrazione ma al di fuori della sua sfera di competenza territoriale;
c) incompetenza assoluta per materia; è inesistente quello emanato da un organo della pubblica amministrazione in una materia che la legge attribuisce a un altro potere pubblico;
d) inesistenza dell'oggetto; è inesistente quando manca il destinatario o quando l'oggetto è indeterminato, indeterminabile o inidoneo: ad es., l'atto di matrimonio tra due persone dello stesso sesso;
e) inesistenza per mancanza di forma essenziale; si verifica quando la legge prevede che l'atto sia espresso in un certo modo (solitamente per iscritto) ed esso è emanato in modo diverso.
2. Annullabilità. L'atto amministrativo è annullabile quando, pur presentando tutti gli elementi essenziali previsti dall'ordinamento, è stato formato in modo diverso da quanto stabilito dalle norme sulla sua emanazione, ed è pertanto illegittimo; l'illegittimità deve riguardare uno dei suoi elementi essenziali. Mentre non esiste un testo normativo che indichi le cause di inesistenza dell'atto amministrativo, la legge rd 1024 26/6/1924 26 prevede espressamente i vizi di illegittimità che rendono l'atto annullabile: l'incompetenza relativa, l'eccesso di potere e la violazione di legge.
a) Incompetenza relativa. Mentre l'incompetenza assoluta si riscontra solo tra organi di diverse amministrazioni, e produce l'inesistenza dell'atto, quella relativa si verifica tra organi dello stesso settore di amministrazione e costituisce uno dei tre vizi di legittimità dell'atto che lo rendono annullabile. Essa si verifica nei seguenti casi:
- quando un organo gerarchicamente inferiore emana un atto di competenza di quello superiore;
- quando un organo esercita la potestà di un altro organo dello stesso settore di amministrazione;
- quando un organo emana un atto riservato all'ambito territoriale di un altro organo del medesimo ramo di amministrazione.
b) Eccesso di potere. Si riscontra nei casi in cui la pubblica amministrazione utilizza il potere di cui è dotata per conseguire uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge, o quando il provvedimento appare illogico, irragionevole o privo di consequenzialità tra premesse e conclusioni. L'eccesso di potere è configurabile soltanto per gli atti discrezionali e mai per quelli vincolati.
c) Violazione di legge. Comprende tutte le cause di illegittimità non previste nei due punti precedenti: si verificano casi di violazione di legge quando, ad es., non sono rispettate le regole sul procedimento amministrativo, quando manca la forma prevista dalla legge, quando mancano i presupposti per l'emanazione dell'atto. L'atto illegittimo, fino a quando non viene annullato, è efficace e può essere eseguito. L'annullamento che ha efficacia retroattiva non si verifica di diritto ma dev'essere fatto valere dagli interessati ed essere pronunciato o con un provvedimento della pubblica amministrazione o con una sentenza del giudice amministrativo; in seguito a essi l'atto si considera come mai emanato e gli effetti eventualmente prodotti vengono annullati; anziché annullato può essere suscettibile di convalida o di sanatoria.
La inesistenza? L’ ultima parola, come sempre, alla giurisprudenza, scrive Sergio De Felice. Ancora una volta il diritto amministrativo mima e mutua le categorie giuridiche del provvedimento (in particolare, le sue invalidità) dal diritto civile e dal diritto romano, le madri di tutti i diritti. Si conferma l’assunto di quel grande autore secondo il quale il civile è il diritto, il penale è il fatto, l’amministrativo è il nulla, se non altro, perché esso deve rivolgersi alle altre branche del diritto per disciplinare le categorie patologiche (come dimostra il tentativo di costruzione negoziale del provvedimento).
E’ noto che la disciplina delle invalidità (in particolare della annullabilità, che richiede l’intervento del giudice) deriva dalla sovrapposizione, in diritto romano, dello jus civile e del diritto pretorio, e dalla integrazione, quindi, del diritto processuale con quello sostanziale. Quanto ai confini tra l’atto nullo e l’atto inesistente, ferma restando la chiara distinzione in teoria generale, tanto che l’una appartiene al mondo del giuridicamente rilevante, l’altra no, nella pratica, occorrerà vedere in quale categoria verranno comprese le fattispecie prima liquidate sotto la generale e onnicomprensiva “nullità-inesistenza” dell’atto amministrativo. Sotto tale aspetto, mentre non desteranno problemi pratici, i cosiddetti casi di scuola (atto emesso ioci o docendi causa, la violenza fisica), maggiori problemi, al limite tra nullità e inesistenza, creeranno altre fattispecie, come il caso dell’usurpatore di pubbliche funzioni (art. 347 c.p.), i casi più gravi di funzionario di fatto, i casi di imperfezione materiale (per non completamento della fattispecie), il difetto di sottoscrizione di un atto. Ancora una volta, sarà la giurisprudenza amministrativa a chiarire se residuano ipotesi di inesistenza, quali sono i requisiti essenziali dell’atto ai sensi dell’art. 21 septies e così via. Allo stesso modo, la giurisprudenza dovrà affrontare i nodi tra il rimedio della azione dichiarativa di nullità, il rapporto con la disapplicazione o inapplicazione, che considera l’atto tamquam non esset e non lo applica (e che perciò dovrebbe riguardare solo gli atti imperativi), ne prescinde, ma non lo espunge definitivamente dal sistema - mentre la nullità dichiara che l’atto è di diritto difforme dall’ordinamento. La giustizia amministrativa conferma ancora una volta, ed è chiamata a confermare, il suo ruolo di creatrice del diritto amministrativo. Essa è senz’altro giurisdizione (lo conferma la sentenza n.204/2004 della Corte Costituzionale); essa è amministrazione (judgér l’administration est administrer) quando compara interessi (nella fase cautelare) o quando entra in punto di contatto, annullando l’atto, o quando sostituisce un segmento di attività, nella giurisdizione di merito. Soprattutto, nella specie, la giurisprudenza si conferma il legislatore di fatto del diritto amministrativo, avendo, il legislatore nazionale ripreso dagli orientamenti consolidati in via giurisprudenziale le varie definizioni di invalidità, di nullità, conseguimento dello scopo, i casi di esecutorietà e così via. Resta la osservazione finale che sarà la giurisprudenza a completare (vel adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi) l’opera del legislatore del 2005. Venuta meno la fiducia nel mito della completezza della legge, è chiaro che il legislatore non è né completo, né perfetto (né, d’altronde, deve esserlo). Osservava la dottrina commercialistica a seguito della invenzione della categoria della inesistenza delle delibere assembleari (nata proprio per contrastare la rigida regola, voluta dal legislatore, della generale annullabilità a pena di decadenza, e la tassatività delle nullità delle delibere agli artt. 2377-2379 c.c.), che il legislatore non è onnipotente, ma è il giudice che adegua la norma al fatto, che trova il punto di equilibrio del sistema, unendo “ li mezzi alle regole e la teoria alla pratica”. La storia, e anche il futuro, della invalidità del provvedimento, ma in realtà tutto il diritto amministrativo, poggeranno ancora una volta, emulando una espressione della dottrina francese, sulle ginocchia del Consiglio di Stato.
Legge Elettorale: ITALIA allo sbando ! Il popolo non riconosce più l’autorità dello Stato ! Non sono un esperto di diritto Costituzionale ma, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l’illegittimità del Porcellum, immagino che qualsiasi semplice cittadino come il sottoscritto, si ponga numerosi interrogativi ai quali, almeno apparentemente, non risulta agevole trovare risposta, scrive Paolo Cardenà. Certo che, in prima istanza, una sentenza di questo genere stimolerebbe il dubbio se questa possa avere effetto retroattivo o meno. Perché, nel primo caso, si determinerebbero effetti sconvolgenti di difficile immaginazione. Ciò deriverebbe dal fatto che, a rigor di logica, essendo incostituzionale una legge elettorale, sarebbero illegittimi anche tutti gli effetti prodotti in virtù di una norma incostituzionale. Quindi, già da otto anni, i parlamentari eletti con questa legge avrebbero occupato una posizione in maniera illegittima, poiché in contrasto con lo spirito costituzionale e quindi con quanto affermato dalla Consulta. Ne deriverebbe che sarebbero illegittimi anche tutti gli atti normativi (e non solo) prodotti in questo periodo. Di conseguenza tutte le leggi varate e tutti gli atti compiuti dal Parlamento sarebbero affetti dal vizio di illegittimità.
Pensate: secondo questa logica sarebbe illegittima anche la semplice fiducia votata ai vari governi che si sono succeduti in questo periodo, che sarebbero essi stessi illegittimi, quindi naturalmente non abilitati a formare o porre in essere alcuna azione di governo: decreti compresi. Sarebbero illegittime leggi, modifiche costituzionali (Fiscal Compact compreso), nomine dei vari organi dello Stato di competenza del Parlamento, o la nomina stessa del Capo dello Stato e quant’altro prodotto da organi che, in tutto questo tempo, hanno operato per effetto di attribuzioni derivanti da atti parlamentari formati da un parlamento illegittimo, quindi fuori dal perimetro costituzionale. Pensate ancora agli effetti economici e sociali prodotti in tutto questo periodo. Tutto sarebbe affetto dal vizio di legittimità. Quanto affermato trova fondamento giuridico nel fatto che si suole farsi discendere detta efficacia retroattiva dal fatto che la norma caducata è viziata da nullità e quindi non può produrre ab origine alcun effetto giuridico. Tuttavia autorevoli commentatori e costituzionalisti avvertono come un’applicazione così radicale e generalizzata di tale principio possa determinare gravi inconvenienti. Potrebbero invero prodursi effetti profondamente sconvolgenti sul piano sociale, ovvero oneri economici insopportabili, rispetto a situazioni da molto tempo cristallizzate. In fattispecie del genere si afferma che la pronuncia costituzionale, nel suo concreto risultato, non aderirebbe affatto alla propria funzione, in quanto darebbe luogo ad un grave turbamento della convivenza. Facendo una semplice ricerca in rete, ci si accorgerebbe che quanto appena affermato trova sostegno in numerose sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e dei Tribunali di merito che sono stati chiamati dirimere la problematica relativa a rapporti costituitisi in base ad una norma dichiarata successivamente incostituzionale.
Ve ne riporto alcune:
“Mentre l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è giustificata dalla stessa eliminazione della norma che non può più regolare alcun rapporto giuridico salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, in ipotesi di successione di legge – dal momento che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è sostituita – la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali vale il principio che la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si p realizzata la situazione giuridica o il fatto generatore del diritto. (Cass. civile, sez. 28 maggio 1979, n. 311 in giustizia civile mass 1979 fasc. 5)”.
“L’efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale. (Trib. Roma 14 febbraio 1995)”.
“Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall’origine la validità e l’efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche “consolidate” per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudica, l’atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza. (Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057).”
“La retroattività delle sentenze interpretative additive, pronunciate dalla Corte costituzionale, trova il suo naturale limite nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici ormai esauriti in epoca precedente alla decisione della Corte ( Fattispecie nella quale il provvedimento di esclusione dai corsi speciali I.S.E.F. è stato impugnato in sede giurisdizionale e in quella sede è stato riconosciuto legittimo con sentenza passata in giudicato, con conseguente intangibilità del relativo rapporto) (Con. giust. amm. Sicilia 24 settembre 1993, n. 319).”
“Sebbene la legge non penale possa avere efficacia retroattiva, tale retroattività, specialmente nel settore della c.d. interpretazione legislativa autentica, incontra limiti nelle singole disposizioni costituzionali e nei fondamentali principi dell’ordinamento, tra i quali va annoverata l’intangibilità del giudicato, nella specie giudicato amministrativo, in quanto il suo contenuto precettivo costituisce un modo di essere non più mutabile della realtà giuridica; pertanto, l’amministrazione non può più esimersi ancorché sia intervenuta una nuova legge (nella specie, la l. 23 dicembre 1992 n. 498 art. 13) dall’ottemperare al giudicato, dovendosi anzi ritenere, onde il legislatore, adottando la norma d’interpretazione autentica, abbia comunque inteso escludere dalla sua applicazione le situazioni coperte dal giudicato. (Consiglio di Stato a. plen., 21 febbraio 1994, n. 4).”
“Il principio secondo il quale l’efficacia retroattiva delle pronunce della Corte Costituzionale recanti dichiarazione de illegittimità costituzionale incontra il limite della irrevocabilità degli effetti prodotti dalla norma invalidata nell’ambito dei rapporti esauriti, è applicabile alle sentenze così dette additive. (Consiglio di Stato sez. VI, 20 novembre 1995).
Quindi, tutto il ragionamento proposto, di fatto, a quanto sembra, risolve la questione degli effetti retroattivi della pronuncia della Corte Costituzionale. Ma se da una parte risulta risolta la questione della retroattività della pronuncia, non altrettanto può dirsi riguardo al da farsi, stante un quadro reso ancor più complesso dalla fragile condizione dell’Italia e dalla necessità di approvare la Legge di Stabilità al vaglio delle aule parlamentari. Infatti, sia la citata giurisprudenza che la stessa dottrina, sembrerebbero convergere sul fatto che siffatta pronuncia della Corte, dovrebbe produrre effetti sui rapporti futuri, quindi, a parer di chi scrive, su tutti gli atti e i fatti che dovrebbe compiere il parlamento in carica, dalla data di effetto della pronuncia della Corte. Tuttavia, secondo quanto si legge nella stampa nazionale sembrerebbe che la consulta abbia lasciato qualche margine di manovra al Parlamento. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’efficacia delle novità decise dalla Corte si avrà dal momento in cui le motivazioni della sentenza saranno pubblicate e questo avverrà nelle prossime settimane. Un’indicazione offerta esplicitamente dalla Corte, il che indica che la Consulta ha in qualche modo voluto mettere in mora il Parlamento, affinchè si affretti a legiferare o a sanare i punti illegittimi dell’attuale legge. Resta fermo che le Camere possono approvare una nuova legge elettorale “secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali” sottolinea la Consulta. La corte ha respinto tutti e due i punti sottoposti al giudizio di costituzionalità: premio di maggioranza e preferenze. In ogni caso “L’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale decorrerà dal momento in cui le motivazioni saranno pubblicate». Le motivazioni della sentenza, informa una nota di Palazzo della Consulta, saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici. Da ciò, a parere di chi scrive, se ne deriverebbe che il Parlamento, dalla data di deposito delle motivazioni, decadrebbe dalla possibilità di legiferare in ogni materia, salvo la riforma della legge elettorale che superi la carenza di legittimità del Porcellum. Ma per un quadro di riflessione più ampio e concreto, bisognerà comunque attendere il deposito delle motivazioni. Il Parlamento è (dovrebbe essere) il tempio più elevato della democrazia popolare. Ancorché la giurisprudenza sani l’illegittimità degli atti consolidati, rimane comunque il fatto che questo Parlamento risulta illegittimo da un punto di vista sostanziale e morale rispetto ai principi di democrazia sanciti dalla Costituzione, e naturalmente appartenenti ad uno stato di diritto. Napolitano, anch’esso eletto in maniera illegittima, dopo gli strappi alla democrazia perpetrati in questi anni, dovrebbe rimuovere tutti gli elementi che compromettono l’esercizio libero della democrazia e quindi, dal momento di efficacia della sentenza, limitare l’azione del Parlamento alla sola riforma della legge elettorale da concludersi in tempi strettissimi. Dopodiché, sciogliere le camere e portare a nuove elezioni ristabilendo la democrazia di questo Paese. In mancanza di questo, il rischio è proprio quello che la popolazione non riconosca più l’autorità dello Stato, con tutte le imprevedibili e nefaste conseguenze che ne deriverebbero, che troverebbero terreno fertile in animi esasperati da anni di crisi e in questa classe politica.
Il Parlamento abusivo rischia l'arresto.
Dopo la bocciatura del Porcellum, associazioni e
sindacati pronti a bloccare le prossime leggi. Pioggia di ricorsi in arrivo,
scrive Antonio Signorini su “Il Giornale”. Illegittimo il sistema elettorale
che ha portato quasi mille parlamentari a Roma. Illegittime le leggi che hanno
approvato o che, più verosimilmente, approveranno in seguito. Il sospetto è al
momento quasi solo un argomento da accademia, materia per i giuristi. Ma il tema
c'è e su questo ragionamento stanno rizzando le antenne, avvocati, associazioni,
sindacati e, più in generale, tutti quelli che hanno qualche conto aperto con la
legge di Stabilità o con altri provvedimenti approvati o all'esame del
Parlamento. Per tutti questi soggetti, la decisione della Corte costituzionale
che ha dichiarato illegittimo il sistema elettorale, può diventare un argomento
da spendere in tribunale. Ad accennarlo per prima è stato il presidente emerito
della Corte costituzionale Pietro Alberto Capotosti. «In teoria - ha detto in
un'intervista a Qn - dovremmo annullare le elezioni due volte del presidente
della Repubblica, la fiducia data ai vari governi dal 2005, e tutte le leggi che
ha fatto un Parlamento illegittimo. Sennonché il passato si salva applicando i
principi sulle situazioni giuridiche esaurite».
Il futuro no, quindi. E se la questione venisse posta, spiega un avvocato, non
sarebbe respinta. Tra i provvedimenti che il Parlamento eletto con la legge
incostituzionale dovrà approvare c'è appunto la «finanziaria» del governo Letta.
I consumatori già affilano le armi. Il presidente di Adusbef Elio Lannutti
individua i temi sui quali dal suo punto di vista varrebbe la pena giocare la
carta della illegittimità. «Staremo a vedere, ma nella legge ci sono dei
provvedimenti che vanno a favore delle banche come la rivalutazione delle quote
Bankitalia. Una truffa. Poi ci sono 19,4 miliardi di euro per le banche e la
questione della Cassa depositi e prestiti, ormai diventata peggio dell'Iri».
«Se il Parlamento non fosse abilitato a fare le leggi ci troveremmo di fronte a
una situazione allucinante», aggiunge Rosario Trefiletti, presidente di
Federconsumatori. «Io ho sostenuto la nascita del governo delle larghe intese,
ma se la prospettiva è che ogni legge votata dalle Camere finisca al Tar, a
questo punto sarebbe meglio andare a elezioni».
Tutto dipende da cosa scriverà la Consulta nelle motivazioni. Ed è possibile che
alla fine i giudici costituzionali cerchino di salvare gli atti prodotti durante
la legislatura. «La Corte - spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi -
regola l'efficacia delle sentenze e dirà che l'efficacia vale dalla prossima
legislatura». Il nodo è politico, spiega Rienzi. La legge elettorale è
illegittima, i parlamentari dovrebbero approvarne una nuova. «Ma siccome nessuno
vuole farlo, alla fine si realizzerà quello che volevano Letta e Alfano». Cioè
che arrivare a fine legislatura con questo Parlamento e questa legge. Se
succederà una cosa è certa: gli avvocati dello Stato avranno molto lavoro.
Perché la sentenza è piombata in un momento che ad alcuni sarà sembrato
politicamente perfetto (per fare durare il governo e il mandato parlamentare),
ma pessimo per la politica economica. In piena sessione di bilancio, con diversi
capitoli della legge sui quali sono stati annunciati ricorsi. Ad esempio sul
capitolo pubblico impiego con gli insegnanti delle sigle autonome (dalla Gilda
allo Snals-Confsal all'Anief) sul piede di guerra per il blocco degli stipendi.
Poi le mancate rivalutazioni delle pensioni. Per non parlare del capitolo casa.
Tutti temi sui quali sarà chiamato a pronunciarsi un Parlamento - secondo la
Consulta - eletto con una legge illegittima.
Avete presente le nane bianche? La morte delle stelle che lascia nel cielo un lucore che a noi sembra una stella viva ed è invece la traccia di un astro “imploso” secoli fa? Bene, l’Italia è quest’illusione ottica, questo effetto visivo che è solo una truffa, scrive Marco Ventura su “Panorama”. È questa l’impressione che ho, l’associazione d’idee con la decisione della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità del Porcellum. La legge elettorale con la quale siamo andati a votare nelle politiche degli ultimi otto-nove anni era fasulla, illegittima, contraria alla Costituzione. Bisognerebbe riavvolgere la pellicola a rifare tutto da capo. Barrare con un rigo le liste di eletti, la composizione dei Parlamenti, e poi le fiducie date ai governi. Uno, due, tre, quattro esecutivi. E tutto ciò che consegue dalla ripartizione dei seggi a Montecitorio e a Palazzo Madama. Comprese le nomine pubbliche e la composizione della Consulta che ha sancito l’illegittimità del Porcellum. Tutto per l’ennesima sentenza tardiva, per i tempi di una giustizia che non riesce a restaurare la legittimità perché non può modificare a ritroso gli effetti delle situazioni che riconosce, fuori tempo massimo, contro la legge. Contro la Carta fondamentale. È un po’ come le decisioni della Sacra Rota. Matrimonio nullo. È stato uno sbaglio.
Ma il problema non riguarda soltanto il Porcellum. È di pochi giorni fa la notizia che il procuratore del Lazio della Corte dei Conti, Raffaele De Dominicis, ha sollevato questione di legittimità davanti alla Consulta sul finanziamento pubblico dei partiti. “Tutte le disposizioni a partire dal 1997 e via via riprodotte nel 1999, nel 2002, nel 2006 e per ultimo nel 2012” hanno, scrive, “ripristinato i privilegi abrogati col referendum del 1993” grazie ad “artifici semantici, come il rimborso al posto del contributo; gli sgravi fiscali al posto di autentici donativi; così alimentando la sfiducia del cittadino e l’ondata disgregante dell’anti-politica”. Se la Consulta (tra quanti mesi o anni?) darà ragione alla Corte dei Conti, i partiti dovranno restituire quello che hanno continuato a intascare in tutti questi anni? Voi ci credete che succederà? Io no. E che dire delle eccezioni di costituzionalità che neppure arrivano alla Consulta, ma che si trascinano in un silenzio assordante finché qualcuno, sull’onda di qualche rivoluzione cultural-politica, solleverà il problema? Mi riferisco alla responsabilità civile dei magistrati, per la quale siamo stati condannati dall’Europa. E che è uno scandalo per un Paese che pretende di appartenere al novero delle culture giuridiche civili e liberali. Nel Paese nel quale il cavillo è elevato al rango di Discrimine Massimo, nella patria dei legulei e degli avvocati, nel paradiso della casta giudiziaria, il cittadino è senza difese, privo di tutele, schiavo dei tempi della giustizia che dalla piccola aula di tribunale fino alle sale affrescate della Consulta dispensa sentenze intempestive e controverse, contaminate dai tempi della politica. Col risultato che nella patria delle toghe che esercitano un potere superiore anche a quello del popolo e dei suoi rappresentanti, non c’è pace né giustizia, e le regole in vigore oggi domani potrebbero rivelarsi una truffa tra dieci anni. Sempre ai nostri danni. Chi mai ci risarcirà del Porcellum? Chi mai ci risarcirà della lentezza della giustizia e dell’irresponsabilità dei magistrati? Chi mai ci risarcirà dei soldi pubblici destinati a chi non ne aveva diritto?
Filippo Facci: La Casta? Siete solo dei pezzenti. Siete dei pezzenti, avete lasciato tutto in mano ai giudici e siete ancora lì a fare calcoli, a preventivare poltrone. I giudici arrestano o no, sequestrano conti, fermano cantieri, giudicano se stessi e cioè altri giudici, non pagano per i propri errori, decidono se questo articolo sia diffamatorio, se una conversazione debba finire sui giornali, se una cura sia regolare o no, se un bambino possa vedere il padre, se un Englaro possa terminare la figlia, se uno Welby possa terminare se stesso, i giudici fanno cose buone e colmano il ritardo culturale e legislativo che voi avete creato in vent’anni, ma i giudici fanno anche un sacco di porcate, e sono in grado di svuotare e piegare ogni leggina che voi gli offriate su un piatto d’argento. Ma siete voi pezzenti che glielo avete lasciato fare. Siete voi che avete lasciato sguarniti gli spazi dei quali loro - o l’Europa - non hanno potuto non occuparsi. E non è che captare il ritardo culturale e legislativo fosse impresa da rabdomanti: della necessità di cambiare il Porcellum lo sapevano tutti, anche i cani, il Porcellum lo odiano tutti, da anni, e voi esistereste solo per questo, per cambiarlo, siete in Parlamento espressamente per questo, e proprio per questo sareste stati eletti: se non fosse che non siete neanche degli eletti. Ma lo abbiamo già detto, che cosa siete. E, ormai, c’è una sola cosa che rende ingiustificata l’antipolitica: che non c’è più la politica. Ci siete voi.
Parlamento dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, anch’essa illegittima perché nominata dal Parlamento e dal Capo dello Stato, anch’esso nominato dal Parlamento Gli effetti sono che la sentenza di incostituzionalità del Parlamento è anch’essa illegittima, perché nominata proprio da un Organo abusivo.
Magari fosse incostituzionale solo il Parlamento, qui siamo tutti incostituzionali, compreso il Capo dello Stato (perchè eletto da un Parlamento illegittimo), e per lo stesso motivo tutte le leggi votate da organismi legislativi illegittimi, e la stessa Corte Costituzionale a rotazione. Paradossalmente, se la corte costituzionale è illegittima, la stessa sentenza di i incostituzionalità è illegittima: paradossale ma assolutamente vero. Mi pare uno dei paradossi filosofici, siamo senza organi istituzionali legittimi e quindi indirettamente nelle mani di chiunque abbia potere effettivo, visto che il potere formale non c'è più.
Elementare…….Watson! Il modo di dire più tipico attribuito ad Holmes è la frase "Elementare, Watson!" ("Elementary, my dear Watson!"), quando egli spiega, con una certa sufficienza, all'amico medico la soluzione di un caso.
Il governo dei giudici? Si chiede Domenico Ferrara su “Il Giornale”. Dal Porcellum all'Ilva, da Stamina alle province e altro ancora. Ormai la magistratura ha preso il posto del Parlamento. Quando fu coniata, l'espressione descriveva l'atteggiamento delle toghe conservatrici della Corte Suprema degli Stati Uniti che per lungo tempo si opposero alle riforme di Roosvelt e del Congresso, ergendosi a impropria opposizione politica. A distanza di decenni, in Italia, la magistratura ha fatto passi da gigante e si è seduta direttamente sui banchi del governo. Parliamo in senso figurato, per carità, epperò l'immagine rispecchia fedelmente la fotografia degli ultimi anni della vita politica italiana. Complice, per non dire colpevole, un Parlamento inetto, incapace di legiferare di suo pugno (chi ricorda a quando risale l'ultima legge propugnata dal Transatlantico?) e svuotato da ogni funzione di rappresentanza, la magistratura – ora contabile ora amministrativa ora ordinaria – ha spesso dettato l'agenda politica, interpretato norme non scritte o financo imposto decisioni non suffragate da legittimità popolare e rappresentativa. L'ultima decisione della Consulta in materia di legge elettorale – arrivata peraltro dopo otto anni di vacatio decisionis – è solo la punta dell'iceberg. Basti citare il caso dell'Ilva di Taranto, dove i giudici hanno pure ammesso di aver preso il posto delle istituzioni. Emblematiche le dichiarazioni dell'Anm: “La vicenda dell’Ilva è un chiaro esempio del fallimento di altri poteri dello Stato, delle altre autorità che dovevano prevenire questa situazione. Non è che la magistratura si diverta a fare supplenza: è costretta a intervenire di fronte a certe ipotesi di reato con gli strumenti propri del codice". E che dire del taglio alle superpensioni? Bocciato dalla Corte Costituzionale, che ha salvato la casta dei pensionati ricchi, di quelli cioè che incassano pensioni da 90mila euro lordi l'anno (e tra questi ci sono anche i magistrati, guarda caso). Nessun taglio: si sarebbe trattato di un provvedimento discriminatorio perché toccava i redditi dei soli pensionati e non di tutti i lavoratori. Amen. Lo stesso dicasi per la Legge 40, approvata dal Legislatore e dalla volontà popolare. Stessa fine per spesometro e redditometro, cassati e corretti dalla Corte dei Conti, la stessa che si è opposta all'abolizione delle province (motivando la decisione con “basse possibilità di risparmio per gli enti e paventando il rischio di confusione amministrativa nel periodo transitorio”). Ha suscitato critiche anche la decisione sul metodo Stamina presa dal Tar del Lazio, accusato di essersi sostituito ai medici e al governo e di non aver preso in considerazione i pareri del comitato scientifico e di alcuni premi Nobel. Poi c'è la magistratura ordinaria che a volte è passata alle cronache per le diverse interpretazioni date a una legge. Solo per fare un esempio: a Genova un giudice ha pensato bene di non applicare la legge Bossi-Fini nei confronti di un immigrato. Motivazione? Contrasta – a suo dire - con una norma europea. E ancora: dall'affidamento di minori a coppie omosessuali, alle tematiche sul lavoro, passando per i temi etici e altro ancora, la magistratura è sempre lì, pronta a colmare il vuoto o il ritardo della politica, o ancora di più pronta a sostituirsi ad essa. Con buona pace della sovranità popolare.
«Abusivi». Li chiama proprio così, l’avvocato Gianluigi Pellegrino intervistato da Tommaso Montesano su “Libero Quotidiano”, i 148 deputati eletti a Montecitorio grazie al premio di maggioranza del Porcellum, dichiarato incostituzionale. Un premio contro cui lui, prima ancora della pronuncia della Corte costituzionale, già a marzo 2013 aveva presentato ricorso alla Giunta delle elezioni della Camera. Non ci sarebbe niente di particolare se Gianluigi Pellegrino, figlio del noto avvocato e politico leccese, Giovanni Pellegrino, più volte in Parlamento, non fosse che è il legale di fiducia del Partito Democratico. Gianluigi Pellegrino, come il padre, amministrativista di fama nazionale, è attivissimo nel campo del centrosinistra per aver condotto nelle aule giudiziarie battaglie sulla legge elettorale, sui quesiti referendari, perché si andasse a elezioni anticipate per il consiglio regionale. Fu lui, per esempio, a investire il Tar del Lazio per spingere l’ex presidente della Regione Lazio a rassegnare finalmente le dimissioni (gesto al quale era legata la tempistica per l’indizione del voto del 2013). E’ certo, però, che la famiglia Pellegrino non ha remore a lavorare con i fascisti. La prova è lì, sul cornicione all’ingresso: anno XII dell’Era Fascista. Era il 1934 e Benito Mussolini era in città a inaugurare questo sanatorio, lavori diretti dall’ingegnere Oronzo Pellegrino, padre del senatore Giovanni. Si parla a Lecce dell’ex ospedale Galateo. È questo l’ospedale che venne utilizzato per la cura della tubercolosi prima, per quella del cancro al polmone poi.
Adesso il giurista incalza: «La mancata convalida delle 148 elezioni è doverosa. Ho presentato in tal senso una memoria in Giunta».
Non sarebbe meglio attendere il deposito delle motivazioni della sentenza da parte della Corte?
«Ci sono già alcuni punti fermi che sono più che sufficienti».
Quali, avvocato?
«La Corte ha emesso una sentenza in parte additiva, cambiando il contenuto delle norme laddove ha previsto l’incostituzionalità del voto ai listoni bloccati senza la possibilità di esprimere almeno una preferenza. Una disposizione solo per il futuro».
E l’altra parte della sentenza, quella sul premio di maggioranza?
«Una pronuncia di tipo classico. Con la quale la Corte ha ritenuto illegittimi i commi da due a cinque dell’articolo 82 del testo unico sull’elezione della Camera così come modificato dal Porcellum. Quei commi sono stati cassati».
E questo che incidenza ha sul Parlamento attuale?
«Nel momento in cui la Giunta delle elezioni affronterà la convalida degli eletti, la procedura dovrà essere compiuta senza applicare i commi che sono stati eliminati dalla Corte».
Ma cosa succede se a Montecitorio, fiutato il pericolo, procedono alle convalide prima che la sentenza produca i suoi effetti?
«Sarebbe un atto indecoroso ed eversivo dinanzi al quale mi aspetterei l’intervento del presidente della Repubblica. E comunque non ci sarebbe il tempo. Devono ancora essere convalidate le elezioni di tutti i deputati. L’articolo 17 del regolamento della Camera stabilisce che alla convalida degli eletti provveda in via definitiva, alla fine di tutti i conteggi e dopo la proposta della Giunta, l’Aula».
Perché la convalida a tempo di record sarebbe un atto eversivo?
«Già a marzo ho impugnato l’elezione dei deputati promossi grazie al premio. E ora il premio è ufficialmente incostituzionale. Rigettare il ricorso ora è impossibile se non con un atto eversivo».
Come deve avvenire l’espulsione degli abusivi?
«Con lo stesso iter adottato per Silvio Berlusconi. La Giunta delle elezioni deve proporre all’Aula della Camera, e la Camera votare, la mancata convalida dei 148 deputati».
Al loro posto chi dovrebbe subentrare?
«Quei seggi andrebbero ripartiti in base ai voti ottenuti. La gran parte andrebbe a Forza Italia, poi, a cascata, al M5S, Scelta civica e così via. Una piccola parte andrebbe anche al Pd».
Un terremoto che avrebbe effetti sui numeri della maggioranza che sostiene il governo.
«Non è importante e non si tratta di una motivazione giuridica. Il rischio è un altro».
Che pericoli vede all’orizzonte?
«Si scatenerà una pressione sulla Corte costituzionale perché i giudici, in sede di stesura delle motivazioni della sentenza, dicano qualche parola in più a favore della salvezza dei deputati sub judice».
Quanto è alto il rischio che ci sia una valanga di ricorsi da parte dei possibili subentranti qualora il Parlamento non procedesse sulla strada delle mancate convalide?
«Premesso che sarebbe un imbroglio, so già che molti di loro si stanno muovendo. E potranno anche chiedere i danni puntando ad ottenere, oltre alla proclamazione, le rispettive indennità per i cinque anni di legislatura. Un ulteriore danno per le casse dello Stato».
LO SPRECO DI DENARO PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
L’opinione di un saggista, Antonio Giangrande, che sul tema qualcosa ne sa.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
Detto questo, quanto si risparmierebbe per le casse dello Stato a far cessare la farsa degli annuali esami di avvocato?
Gli emolumenti per migliaia di Commissari d’esame diversificati per gli esami scritti ed orali. Gli oneri per gli impiegati dello Stato. Le spese della transumanza dei compiti. Le spese di vitto, alloggio e trasferte per i candidati. Spese astronomiche per codici spesso inutili. Problemi psicologici non indifferenti per i candidati. Non sarebbe meglio, almeno una volta far decidere chi non ha interesse in conflitto e si estinguesse questa inutile prova che serve solo a far pavoneggiare chi non ha merito? I bravi, se sono bravi, si vedono sul campo. L’avvocato è tale solo se ha lo studio pieno di gente. Chi ha studiato tanti anni, che faccia un periodo di tirocinio con cause limitate, e poi sia valutato dal mercato, anziché farsi giudicare dai primi di questo mondo.
SONO BRAVI I COMUNISTI. NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
Di seguito un comunicato dei Giuristi Democratici che entra nel merito delle modifiche che il governo Letta ha imposto col voto di fiducia sulla legge di stabilità. “Non se ne è parlato molto, ma nella nuova legge di stabilità sono state introdotte, e già approvate al Senato, alcune importanti variazioni economiche anche in materia di giustizia: innanzitutto la riduzione di un 30% dei compensi per i difensori (ma anche per i consulenti tecnici, gli ausiliari e gli investigatori autorizzati) dei soggetti ammessi al cosiddetto “gratuito patrocinio”. Le spettanze che possono essere liquidate per la difesa dei soggetti non abbienti, già ridotte perchè calcolate in base ai valori medi e decurtate del 50% subiscono così un'ulteriore drastica riduzione. Gli effetti sono facilmente prevedibili: sempre meno avvocati, consulenti, investigatori privati si renderanno disponibili a difendere chi si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello stato; si parla di persone che possono vantare il non invidiabile primato di percepire un reddito lordo di poco più di 10.000 euro di reddito l'anno. Sempre meno difesa per chi non può, sempre meno garanzie, sempre meno diritti. Verso il basso, ovviamente. Dal punto di vista dell'avvocatura, ovviamente, questa ulteriore riduzione dei compensi (che vengono materialmente erogati, lo ricordiamo per i profani, dopo qualche anno dalla conclusione dei procedimenti) rende la remunerazione di questa attività difensiva inferiore ad ogni limite dignitoso. Se lo Stato per difendere un poveraccio ti paga meno di un quarto di una parcella media quanti saranno i professionisti seri ad accettare la mancetta posticipata di alcuni anni dal lavoro svolto ? Altro che dignità della professione forense, altro che diritto alla difesa, altro che importanza del ruolo professionale... Aumentano poi i costi di notifica e, last but not least, viene chiarito che, in caso di ricorsi con i quali vengono impugnati più atti, il contributo unificato va conteggiato in relazione ad ogni singolo atto impugnato, anche in grado d'appello. Si tratta, tipicamente, dei ricorsi in materia amministrativa, in cui è ordinario impugnare l'atto principale unitamente ai presupposti. Quando si pensa che il contributo unificato, in queste materie, è normalmente di 600 euro, ben si comprende che la giustizia amministrativa diventa veramente un lusso per pochi. Come Giuristi Democratici riteniamo intollerabile questo continuo attacco alla giustizia sostanziale operata sempre verso il basso, a scapito dei soggetti più deboli che incappano nel sistema giustizia o che al sistema giustizia non possono accedere. Pensiamo cosa significa l'applicazione di questi tagli in danno delle migliaia di detenuti prodotto delle leggi criminogene di cui la legislazione ha fatto autentico abuso in questi anni, in materia di stupefacenti, in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, in materia di recidiva. Pensiamo cosa significano questi aumenti per le centinaia di comitati di cittadini che si muovono contro grandi e piccole opere devastanti nei territori. Non possiamo quindi che esprimere una profonda e ragionata avversità alle misure economiche che il governo vuol mettere in campo nel settore giustizia e chiedere la cassazione senza rinvio di queste disposizioni, che rappresentano un vero e proprio attentato al diritto di giustizia dei cittadini meno abbienti.”
MENTRE PER LE LOBBIES LE PORTE SONO SEMPRE APERTE.
I deputati del Movimento 5 Stelle hanno usato espressioni altrettanto forti contro lo strapotere delle lobby in Parlamento. Scandaloso - hanno ribadito ancora in aula durante il voto per la legge di Stabilità del Governo Letta - che il Partito democratico si faccia comandare a bacchetta non dal segretario o dal premier bensì da abili lobbisti che hanno facile accesso alle stanze che contano. Nel ruolo del censore c'è questa volta Girgis Giorgio Sorial, il giovane deputato grillino che nel corso del dibattito in Aula ha usato più volte toni e parole tutt'altro che diplomatiche all'indirizzo del partito del premier. «Questo governo - ha aggiunto - è fallimentare e fallito perché permette agli squali di mettere mano ai conti dello Stato. Mentre lavoravamo in commissione c'erano in giro lobbisti di ogni genere. Mercanteggiavano e barattavano la sicurezza degli incarichi con la garanzia che i propri privilegi e interessi non sarebbero stati toccati». Sorial ha quindi ricordato il nome del relatore Maino Marchi (Pd), non casuale, a suo giudizio, «per una legge che deve essere chiamata marchetta». Sorial si è spinto oltre e ha rivelato il nome del presunto lobbista che avrebbe avuto l'impudenza di vantarsi al telefono, proprio nell'anticamera della commissione Bilancio, di aver «fatto bloccare l'emendamento che prevedeva il taglio delle pensioni d'oro». In Aula la protesta dei grillini non ha risparmiato nemmeno la faccia di Luigi Tivelli, ex funzionario della Camera e, secondo i parlamentari del Movimento 5 Stelle, lobbista di area Pd. Mentre Sorial stigmatizzava il dilagare dell'attività lobbista dentro le istituzioni, i suoi colleghi mostravano volantini con sopra la faccia dell'«indagato». Raggiunto al telefono dalle agenzie di stampa il diretto interessato ha smentito la sua «funzione», giustificando la sua presenza alla Camera per ricerche documentali per un libro. «Quelle parole al telefono? Con i miei amici siamo soliti usare ironia e iperboli, figure retoriche che i grillini non conoscono».
Proprio come uno stipendio. Con regolarità. Mensilmente, racconta Pier Francesco Borgia su “Il Giornale. Ad alcuni senatori e deputati arriverebbero ogni mese finanziamenti da parte di alcune multinazionali che farebbero attività di lobby sfruttando soprattutto l'ingordigia dei nostri rappresentanti politici. Questo almeno il senso dell'accusa lanciata dalla puntata delle Iene andata in onda su Italia Uno il 19 maggio 2013. Nel servizio si vede un assistente parlamentare ripreso di spalle che con la voce alterata racconta il sistema utilizzato da alcune multinazionali per far passare emendamenti «favorevoli». Il meccanismo, racconta la gola profonda, è semplice. «Ci sono multinazionali che hanno a libro paga alcuni senatori». Come funziona il meccanismo? «Semplice - spiega il portaborse - un emissario della società viene da noi a Palazzo Madama e ci consegna i soldi per i parlamentari per cui lavoriamo». Le cifre? Si tratterebbe di operazioni che prevedono addirittura una sorta di tariffario: «Per quel che mi riguarda - spiega l'intervistato - conosco due multinazionali, una del settore dei tabacchi e un'altra nel settore dei videogiochi e delle slot machine ed entrambe elargiscono dai mille ai duemila euro ogni mese». La tariffa, inoltre, cambia «a seconda dell'importanza del senatore e quindi, se è molto influente, sale fino a 5mila euro». Lo scopo è facile da intuire. Questi parlamentari si devono impegnare a far passare emendamenti favorevoli su leggi che interessano le stesse aziende. Per fare un esempio preciso, l'anonimo portaborse cita le sale Bingo per le quali «si sono formati due gruppi, partecipati sia da uomini del centro sinistra che da uomini del centro destra. I due gruppi fanno capo ad ex ministri del centro sinistra». Inutile precisare che questo tipo di attività di lobby non è corretta e, anzi, viola non solo codici morali ma anche le leggi scritte, nonché i patti con gli elettori. Immediata la reazione di Pietro Grasso, presidente dell'aula del Senato. «Dal servizio delle Iene - si legge in una nota di Palazzo Madama - emerge la denuncia di un comportamento che, se provato, sarebbe gravissimo. Purtroppo la natura di denuncia, anonima nella fonte e nei destinatari, rende difficile procedere all'accertamento della verità. Spero quindi che gli autori del servizio e il cittadino informato di fatti così gravi provvedano senza indugio a fare una regolare denuncia alla Procura, in modo da poter accertare natura e gravità dei fatti contestati». Il servizio delle Iene non si limita a questa grave denuncia. La trasmissione mostra, poi, il diffuso malcostume, da parte dei parlamentari, di rimborsare in nero i loro assistenti. Molti «portaborse» prenderebbero, a quanto riferiscono Le iene, 800 euro in nero al mese pur disponendo del regolare tesserino per entrare a Palazzo Madama. La confessione di questo sfruttamento e questo malcostume arriva ovviamente in forma anonima: «Il 70% dei colleghi si trova nelle mie stesse condizioni», racconta la gola profonda spiegando di lavorare in nero da circa dieci anni e di essere stato assistente «sia di un senatore di destra che di un senatore di sinistra». Tutta colpa dell'autodichìa, dice il questore del Senato ed esponente grillina Laura Bottici: «All'interno di Palazzo Madama, dove si approvano le leggi, non hanno validità le leggi stesse ma solo i regolamenti interni. È questo il vero problema». È vero che modificare i regolamenti parlamentari è altrettanto complicato che redigere nuove leggi. Tuttavia non è su questo aspetto che si focalizza l'attenzione del presidente del Senato. «Giorni fa ho evidenziato - ricorda Grasso - l'esigenza di una legge che disciplini, in maniera chiara e trasparente, l'attività lobbistica che al momento, seppur sempre presente, si muove in maniera nascosta».
LA LOBBY DEI DENTISTI E LA MAFIA ODONTOIATRICA.
In una sequela di corpi nudi, da quale particolare tra loro riconosceresti un indigente? Dai denti, naturalmente! Guardalo in bocca quando ride e quando parla e vedrai una dentatura incompleta, cariata e sporca.
In fatto di salute dentale gli italiani non si rivolgono alla ASL. I dentisti della ASL ci sono, eppure è solo l'8% degli italiani ad avvalersi dei dentisti pubblici. Nel 92% dei casi gli italiani scelgono un dentista privato. Più che altro ad influenzare la scelta per accedere a questa prestazione medica è perché alla stessa non è riconosciuta l’esenzione del Ticket. Ci si mette anche la macchinosità burocratica distribuita in più tempi: ricetta medica; prenotazione, pagamento ticket e finalmente la visita medica lontana nel tempo e spesso a decine di km di distanza, che si protrae in più fasi con rinnovo perpetuo di ricetta, prenotazione e pagamento ticket. La maggiore disponibilità del privato sotto casa a fissare appuntamenti in tempi brevi, poi, è la carta vincente ed alla fine dei conti, anche, la più conveniente. Ciononostante la cura dei denti ci impone di aprire un mutuo alla nostra Banca di fiducia.
Il diritto alla salute dei denti, in questo stato di cose, in Italia, è un privilegio negato agli svantaggiati sociali ed economici.
LA VULNERABILITA’ SOCIALE. Può essere definita come quella condizione di svantaggio sociale ed economico, correlata di norma a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale, che impedisce di fatto l’accesso alle cure odontoiatriche oltre che per una scarsa sensibilità ai problemi di prevenzione e cura dei propri denti, anche e soprattutto per gli elevati costi da sostenere presso le strutture odontoiatriche private. L’elevato costo delle cure presso i privati, unica alternativa oggi per la grande maggioranza della popolazione, è motivo di ridotto accesso alle cure stesse anche per le famiglie a reddito medio - basso; ciò, di fatto, limita l’accesso alle cure odontoiatriche di ampie fasce di popolazione o impone elevati sacrifici economici qualora siano indispensabili determinati interventi.
Pertanto, tra le condizioni di vulnerabilità sociale si possono individuare tre distinte situazioni nelle quali l’accesso alle cure è ostacolato o impedito:
a) situazioni di esclusione sociale (indigenza);
b) situazioni di povertà:
c) situazioni di reddito medio – basso.
Perché il Servizio Sanitario Nazionale e di rimando quello regionale e locale non garantisce il paritetico accesso alle cure dentali? Perché a coloro che beneficiano dell’esenzione al pagamento del Ticket, questo non è applicato alla prestazione odontoiatrica pubblica?
Andare dal dentista gratis è forse il sogno di tutti, visti i conti che ci troviamo periodicamente a pagare e che non di rado sono la ragione per cui si rimandano le visite odontoiatriche, a tutto discapito della salute dentale. Come avrete capito, insomma, non è così semplice avere le cure dentistiche gratis e spesso, per averle, si devono avere degli svantaggi molto forti, al cui confronto la parcella del dentista, anche la più cara, non è nulla. E' però importante sapere e far sapere che, chi vive condizioni di disagio economico o ha malattie gravi, può godere, ma solo in rare Regioni, di cure dentistiche gratuite a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale. Diciamo subito che non tutti possono avere questo diritto: le spese odontoiatriche non sono assimilabili a quelle di altre prestazioni mediche offerte nelle ASL, negli ospedali e nelle cliniche convenzionate di tutta Italia. Inoltre, qualora si rendano necessarie protesi dentarie o apparecchi ortodontici, questi sono a carico del paziente: vi sono però alcune condizioni particolari che permettono, a seconda dei regolamenti regionali, di ottenere protesi dentali gratuite e apparecchi a costo zero o quasi. Le regioni amministrano la sanità, e dunque anche le cure dentistiche, con larghe autonomie che a loro volta portano a differenze anche sostanziali da un luogo all'altro. Bisogna, quando si nasce, scegliersi il posto!
Alla fine del racconto, la morale che se ne trae è una. E’ possibile che la lobby dei dentisti sia così forte da influenzare le prestazioni sanitarie delle Asl italiane e gli indirizzi legislativi del Parlamento? In tempo di crisi ci si deve aspettare un popolo di sgangati senza denti, obbligati al broncio ed impediti al sorriso da una ignobile dentatura?
«Siamo un paese di gente che, presi uno ad uno, si definisce onesta. Per ogni male che attanaglia questa Italia, non si riesce mai a trovare il responsabile. Tanto, la colpa è sempre degli altri!». Così afferma il dr Antonio Giangrande, noto saggista di fama mondiale e presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Associazione fuori dal coro e fuori dai circuiti foraggiati dai finanziamenti pubblici.
«Quando ho trattato il tema dell’odontoiatria, parlando di un servizio non usufruibile per tutti, non ho affrontato l’argomento sulla selezione degli odontoiatri. Non ho detto, per esempio, che saranno processati a partire dal prossimo 6 marzo 2014 i 26 imputati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari Michele Parisi nell'ambito del procedimento per i presunti test di ingresso truccati per l'ammissione alle facoltà di odontoiatria e protesi dentaria delle Università di Bari, Napoli, Foggia e Verona, negli anni 2008-2009. Ho scritto solo un articolo asettico dal titolo eclatante.»
Questo articolo è stato pubblicato da decine di testate di informazione. E la reazione dei dentisti non si è fatta attendere, anche con toni minacciosi. Oggetto degli strali polemici è stato, oltre che Antonio Giangrande, il direttore di “Oggi”.
«I Dentisti non sono mafiosi bensì gli unici che si prendono cura dei cittadini». ANDI protesta con Oggi per una delirante lettera pubblicata. Così viene definito l’articolo. Il 14 gennaio 2014 sul sito del settimanale Oggi, nella rubrica “C’è posta per noi”, è stata pubblicata una missiva del dott. Antonio Giangrande presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie dal titolo “La lobby dei dentisti e la mafia odontoiatrica”. Nella nota Giangrande analizza il bisogno di salute orale e le difficoltà del servizio pubblico di dare le risposte necessarie chiedendosi se tutto questo non è frutto del lavoro della lobby dei dentisti talmente potente da influenzare le prestazioni sanitarie delle Asl e le decisioni del Parlamento. ANDI, per tutelare l’immagine dei dentisti liberi professionisti italiani, sta valutando se intraprendere azioni legali nei confronti dell’autore della lettera e del giornale. Intanto ha chiesto di pubblicare la nota che riportiamo sotto. La Redazione di Oggi ha scritto il 24.1.2014 alle 16:59, Il precedente titolo della lettera del Dottor Giangrande era fuorviante e di questo ci scusiamo con gli interessati. Qui di seguito l’intervento dell’Associazione Nazionale Dentisti italiani, a nome del Presidente Dott. Gianfranco Prada, in risposta allo stesso Dottor Giangrande. «A nome dei 23 mila dentisti italiani Associati ad ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) che mi onoro di presiedere vorrei rispondere alla domanda che il dott. Antonio Giangrande, presidente dell’Associazione Contro tutte le Mafie ha posto sul suo giornale il 14 gennaio. “E’ possibile che la lobby dei dentisti sia così forte da influenzare le prestazioni sanitarie delle Asl italiane e gli indirizzi legislativi del Parlamento? In tempo di crisi ci si deve aspettare un popolo di sgangati senza denti, obbligati al broncio ed impediti al sorriso da una ignobile dentatura?” La risposta è no. No, dott. Giangrande non c’è una lobby di dentisti così forte da influenzare le scelte della sanità pubblica. La causa di quanto lei scrive si chiama spending review o se vogliamo utilizzare un termine italiano dovremmo dire tagli: oltre 30 miliardi negli ultimi due anni quelli per la sanità. Poi io aggiungerei anche disinteresse della politica verso la salute orale che non ha portato, mai, il nostro SSN ad interessarsi del problema. Vede dott. Giangrande lei ha ragione quando sostiene che un sorriso in salute è una discriminante sociale, ma non da oggi, da sempre. Ma questo non per ragioni economiche, bensì culturali. Chi fa prevenzione non si ammala e non ha bisogno di cure. Mantenere sotto controllo la propria salute orale costa all’anno quanto una signora spende alla settimana dalla propria parrucchiera. Ed ha anche ragione quando “scopre” che le cure odontoiatriche sono costose, ma non care come dice lei. Fare una buona odontoiatria costa e costa sia al dentista privato che alla struttura pubblica, che infatti non riesce ad attivare un servizio che riesca a soddisfare le richieste dei cittadini. Inoltre, oggi, lo stato del SSN quasi al collasso, non consente investimenti nell’odontoiatria: chiudono i pronto soccorso o vengono negati prestazioni salva vita. Ma le carenze del pubblico nell’assistenza odontoiatrica non è neppure di finanziamenti, è di come questi soldi vengono investiti. Qualche anno fa il Ministero della Salute ha effettuato un censimento per capire le attrezzature ed il personale impiegato da Ospedali ed Asl nell’assistenza odontoiatrica e da questo è emerso che i dentisti impiegati utilizzano gli ambulatori pubblici in media per sole 3 ore al giorno. Ma non pensi sia per negligenza degli operatori, molto spesso è la stessa Asl che non può permettersi di attivare il servizio per più tempo. Non ha i soldi. Però poi succede anche che utilizzi le strutture pubbliche per dare assistenza odontoiatrica a pagamento e quindi per rimpinguare i propri bilanci. Come mai non ci indigna per questo? Il problema non è di carenza di attrezzature (mediamente quelle ci sono) sono i costi per le cure. Una visita odontoiatria è molto più costosa di una visita di qualsiasi altra branca della medicina. Pensi quando il suo dermatologo o cardiologo la visita e poi allo studio del suo dentista in termini di strumenti, attrezzature e materiali utilizzati. Anche con i pazienti che pagano il ticket l’Asl non riesce a coprire neppure una piccola parte dei costi sostenuti per effettuare la cure. Da tempo chiediamo ai vari Ministri che negli anni hanno trascurato l’assistenza odontoiatrica di dirottare quegli investimenti in un progetto di prevenzione odontoiatrica verso la fasce sociali deboli e i ragazzi. Una seria campagna di prevenzione permetterebbe di abbattere drasticamente le malattie del cavo orale, carie e malattia parodontale, diminuendo drasticamente la necessità di interventi costosi futuri come quelli protesici. Invece nelle nostre Asl e negli ospedali non si previene e non si cura neppure, perché costa troppo curare, così si estraggono solo denti… creando degli “sdentati” che avranno bisogno di protesi. Dispositivo che il nostro SSN non può erogare. Ma molto spesso lo fa a pagamento. Pensi, dott. Giangrande, siamo talmente lobbie che l’unico progetto di prevenzione pubblica gratuito attivo su tutto il territorio nazionale è reso possibile da 35 anni dai dentisti privati aderenti all’ANDI. Stesso discorso per l’unico progetto di prevenzione del tumore del cavo orale, 6 mila morti all’anno per mancata prevenzione. Per aiutare gli italiani a tutelare la propria salute orale nell’immediato basterebbe aumentare le detrazioni fiscali della fattura del dentista (oggi è possibile detrarre solo il 19%) ma questo il Ministero dell’Economia dice che non è possibile. Però da anni si permette ai cittadini di detrarre oltre il 50% di quanto spendono per ristrutturare casa o per comprare la cucina. Come vede, caro dott. Giangrande, il problema della salute orale è molto serio così come molto serio il problema della mafia. Ma proprio perché sono problemi seri, per occuparsene con competenza bisogna sforzarsi di analizzare il problema con serietà e non fare le proprie considerazioni utilizzando banali lunghi comuni. In questo modo insulta solo i dentisti italiani che sono seri professionisti e non truffatori o peggio ancora mafiosi. Fortunatamente questo i nostri pazienti lo sanno, ecco perché il 90% sceglie il dentista privato e non altre strutture come quelle pubbliche o i low cost. Perché si fida di noi, perché siamo seri professionisti che lavorano per mantenerli sani. Aspettiamo le sue scuse. Il Presidente Nazionale ANDI, Dott. Gianfranco Prada».
Antonio Giangrande, come sua consuetudine, fa rispondere i fatti per zittire polemiche strumentali e senza fondamento, oltre che fuorvianti il problema della iniquità sociale imperante.
Palermo. Morire, nel 2014, perché non si vuole - o non si può - ricorrere alle cure di un dentista. Da un ospedale all'altro: muore per un ascesso. Quando il dolore è diventato insopportabile ha deciso di rivolgersi ai medici, ma la situazione è precipitata, scrive Valentina Raffa su “Il Giornale”, martedì 11/02/2014. Una storia alla Dickens, con la differenza però che oggi non siamo più nell'800 e romanzi sociali come «Oliver Twist», «David Copperfield» e «Tempi difficili» dovrebbero apparire decisamente anacronistici. Eppure... Eppure succede che ai nostri giorni si possa ancora morire per un mal di denti. Un dolore a un molare che la protagonista di questa drammatica vicenda aveva cercato di sopportare. Difficile rivolgersi a un dentista, perché curare un ascesso avrebbe richiesto una certa spesa. E Gaetana, 18enne di Palermo, non poteva permettersela. Lei si sarebbe dovuta recare immediatamente in Pronto soccorso. Quando lo ha fatto, ossia quando il dolore era divenuto lancinante al punto da farle perdere i sensi, per lei non c'era più nulla da fare. È stata accompagnata dalla famiglia all'ospedale Buccheri La Ferla, di Palermo, dove avrebbe risposto bene alla terapia antibiotica, ma purtroppo il nosocomio (a differenza del Policlinico) non dispone di un reparto specializzato. Quando quindi la situazione si è aggravata, la donna è stata portata all'ospedale Civico. Ricoverata in 2^ Rianimazione, i medici hanno tentato il possibile per salvarle la vita. A quel punto, però, l'infezione aveva invaso il collo e raggiunto i polmoni. L'ascesso al molare era divenuto fascite polmonare. L'agonia è durata giorni. La vita di Gaetana era appesa a un filo. Poi è sopraggiunto il decesso. Le cause della morte sono chiare, per cui non è stata disposta l'autopsia. Nel 2014 si muore ancora così. E pensare che esiste la «mutua». Ma Gaetana forse non lo sapeva. Sarebbe bastato recarsi in ospedale con l'impegnativa del medico di base. è una storia di degrado, non di malasanità: ci sono 4 ospedali a Palermo con servizio odontoiatrico. Ma nella periferia tristemente famosa dello Zen questa non è un'ovvietà.
Morire di povertà. Gaetana Priola, 18 anni, non aveva i soldi per andare dal dentista scrive “Libero Quotidiano”. La giovane si è spenta all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverata dai primi giorni di febbraio 2014. A ucciderla, un infezione polmonare causata da un ascesso dentale mai curato. All'inizio del mese, la giovane era svenuta in casa senza più dare segni di vita. I medici le avevano diagnosticato uno choc settico polmonare, condizione che si verifica in seguito a un improvviso abbassamento della pressione sanguigna. Inizialmente, Gaetana era stata trasportata al Bucchieri La Ferla e, in seguito, era stata trasferita nel reparto di rianimazione del Civico. Le sue condizioni sono apparse da subito come gravi. I medici hanno provato a rianimarla ma, dopo una settimana di cure disperate, ne hanno dovuto registrare il decesso. Disperazione e dolore nel quartiere Zen della città, dove la vittima risiedeva insieme alla famiglia.
All'inizio era un semplice mal di denti, scrive “Il Corriere della Sera”. Sembrava un dolore da sopportare senza drammatizzare troppo. Eppure in seguito si è trasformato in un ascesso poi degenerato in infezione. Una patologia trascurata, forse anche per motivi economici, che ha provocato la morte di una ragazza di 18 anni, Gaetana Priolo. La giovane, che abitava a Palermo nel quartiere Brancaccio, non si era curata; qualcuno dice che non aveva i soldi per pagare il dentista. Un comportamento che le è stato fatale: è spirata nell'ospedale Civico per uno «shock settico polmonare». Le condizioni economiche della famiglia della ragazza sono disagiate ma decorose. Gaetana era la seconda di quattro figli di una coppia separata: il padre, barista, era andato via un paio di anni fa. Nella casa di via Azolino Hazon erano rimasti la moglie, la sorella maggiore di Gaetana, il fratello e una bambina di quasi cinque anni. Per sopravvivere e mantenere la famiglia la madre lavorava come donna delle pulizie. «È stata sempre presente, attenta, una donna con gli attributi», dice Mariangela D'Aleo, responsabile delle attività del Centro Padre Nostro, la struttura creato da don Pino Puglisi, il parroco uccisa dalla mafia nel '93, per aiutare le famiglie del quartiere in difficoltà. L'inizio del calvario per Gaetana comincia il 19 gennaio scorso: il dolore è insopportabile tanto da far perdere i sensi alla diciottenne. La ragazza in prima battuta viene trasportata al Buccheri La Ferla e visitata al pronto soccorso per sospetto ascesso dentario. «Dopo due ore circa, in seguito alla terapia, essendo diminuito il dolore, - afferma una nota della direzione del nosocomio - è stata dimessa per essere inviata per competenza presso l'Odontoiatria del Policlinico di Palermo». Dove però Gaetana non è mai andata. Si è invece fatta ricoverare il 30 gennaio al Civico dove le sue condizioni sono apparse subito gravi: in seconda rianimazione le viene diagnosticata una fascite, un'infezione grave che partendo dalla bocca si è già diffusa fino ai polmoni - dicono all'ospedale -. I medici fanno di tutto per salvarla, ma le condizioni critiche si aggravano ulteriormente fino al decesso avvenuto la settimana scorsa. Al momento non c'è nessuna denuncia della famiglia e nessuna inchiesta è stata aperta. «È un caso rarissimo - spiega una dentista - ma certo non si può escludere che possa accadere». Soprattutto quando si trascura la cura dei denti. Ed è questo un fenomeno in crescita. «L'11% degli italiani rinuncia alle cure perchè non ha le possibilità economiche, e nel caso delle visite odontoiatriche la percentuale sale al 23% - denuncia il segretario nazionale Codacons, Francesco Tanasi - In Sicilia la situazione è addirittura peggiore. Chi non può permettersi un medico privato, si rivolge alla sanità pubblica, settore dove però le liste d'attesa sono spesso lunghissime, al punto da spingere un numero crescente di utenti a rinunciare alle cure».
“È un caso rarissimo – spiega una dentista – ma certo non si può escludere che possa accadere”, scrive “Canicattiweb”. Soprattutto quando si trascura la cura dei denti. Ed è questo un fenomeno in crescita. Il Codacons si è schierato subito al fianco dei familiari e dei cittadini indigenti. “Il caso della 18enne morta a Palermo a causa di un ascesso non curato per mancanza di soldi, è uno degli effetti della crisi economica che ha colpito la Sicilia in modo più drammatico rispetto al resto d’Italia”. “L’11% degli italiani rinuncia alle cure mediche perché non ha le possibilità economiche per curarsi, e nel caso delle le visite odontoiatriche la percentuale sale al 23% – denuncia il segretario nazionale Codacons, Francesco Tanasi – Ed in Sicilia la situazione è addirittura peggiore. Chi non può permettersi cure private, si rivolge alla sanità pubblica, settore dove però le liste d’attesa sono spesso lunghissime, al punto da spingere un numero crescente di utenti a rinunciare alle cure. Tale stato di cose genera emergenze e situazioni estreme come la morte della ragazza di Palermo. E’ intollerabile che nel 2014 in Italia si possa morire per mancanza di soldi – prosegue Tanasi – Il settore della sanità pubblica deve essere potenziato per garantire a tutti le prestazioni mediche, mentre negli ultimi anni abbiamo assistito a tagli lineari nella sanità che hanno prodotto solo un peggioramento del servizio e un allungamento delle liste d’attesa”.
Bene, cari dentisti, gli avvocati adottano il gratuito patrocinio, ma non mi sembra che voi adottiate il “Pro Bono Publico” nei confronti degli indigenti. Pro bono publico (spesso abbreviata in pro bono) è una frase derivata dal latino che significa "per il bene di tutti". Questa locuzione è spesso usata per descrivere un fardello professionale di cui ci si fa carico volontariamente e senza la retribuzione di alcuna somma, come un servizio pubblico. È comune nella professione legale, in cui - a differenza del concetto di volontariato - rappresenta la concessione gratuita di servizi o di specifiche competenze professionali al servizio di coloro che non sono in grado di affrontarne il costo.
UNIONE EUROPEA: ITALIA 60 MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
Il 3 febbraio 2014 Cecile Malmstrom, commissario europeo per gli affari interni, presenta il primo rapporto sulla corruzione nell’Unione, stimata in 120 miliardi di euro, scrive Emilio Casalini su “Il Corriere della Sera” . Nel capitolo dedicato all’Italia si ricorda che la nostra Corte dei Conti ha valutato la corruzione italiana in 60 miliardi di euro. La maggior parte dei giornali, tg, agenzie di stampa ribatte a caratteri cubitali la notizia per cui metà della corruzione europea è in Italia. I due dati però non sono omogenei né sovrapponibili. Il nostro in particolare lo troviamo nel discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012, dove a pagina 100 si legge che "Se l’entità monetizzata della corruzione annuale in Italia è stata correttamente stimata in 60 miliardi di euro dal Saet "... sarebbe un’esagerazione. Quindi nemmeno la Corte dei Conti ha mai fatto calcoli di prima mano, ma si riferisce, ritenendolo peraltro esagerato, al rapporto di un altro organismo, il Saet, ossia il Servizio Anticorruzione e Trasparenza. Quest'ultimo però, a pagina 10 nel suo rapporto del 2009, ha scritto esattamente l’opposto, ossia che “le stime che si fanno sulla corruzione, 50-60 miliardi l’anno, senza un modello scientifico, diventano opinioni da prendere come tali, ma che complice la superficialità dei commentatori e dei media, aumenta la confusione e anestetizza qualsiasi slancio di indignazione e contrasto”. Solo opinioni dunque. Il Servizio Anticorruzione negli anni successivi continua a spiegare che si tratta di cifre inventate e cita (a pagina 130) perfino il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, il quale “ha confermato l’infondatezza della fantasiosa stima di 60 miliardi di euro quale costo della corruzione ogni anno in Italia". Quella cifra sembra essere troppo alta perfino per noi! Ma da dove è nata allora questa cifra che da molti anni tutti ripetono come un mantra? Forse da un semplice calcolo, magari citato in un convegno. Nel 2004 la Banca Mondiale aveva pubblicato un rapporto in cui teorizzava che la corruzione del mondo fosse stimabile in mille miliardi di dollari. Considerato il Pil globale dell’epoca, la corruzione corrispondeva quindi ad oltre il 3% del Pil mondiale. Applicando la stessa percentuale al PIL italiano, ecco saltare fuori la cifra tonda di 60 miliardi. Una cifra inventata ma citata ormai anche dalle istituzioni comunitarie. Ma la cosa più grave, come dice il primo rapporto della Saet, è che un elemento che non si misura, non si gestisce, e quindi non si combatte, non si contrasta.
FATTI DI CRONACA, DISFATTI DI GIUSTIZIA.
Quello che la gente non capisce……e quello che non si osa dire.
Colloquio con il dr Antonio Giangrande, scrittore e sociologo storico, noto per i suoi saggi d’inchiesta letti in tutto il mondo e per i suoi articoli pubblicati in tutta Italia, ma ignorato dai media generalisti foraggiati dallo Stato.
«Da anni racconto ai posteri ed agli stranieri quello che in Italia non si osa dire. In tema di Giustizia la gente si spella le mani ad osannare quelli che certa politica e certa informazione ha santificato: ossia, i magistrati. Dico questo senza alcun pregiudizio e, anzi, con il rispetto che devo ad amici e magistrati che stimo ed ai quali questa percezione, che non credo sia mio esclusivo patrimonio, non rende il giusto merito. Bene. Io, nei miei testi e nei miei video, parlo di chi, invece da innocente non ha voce. Racconto le loro storie, affinchè in un’altra vita venga reso a loro quella giustizia che in questa realtà gli è negata. Un indennizzo o un risarcimento per quello che gli è stato tolto e mai più gli può essere reso. La dignità ed ogni diritto. Specialmente se poi le pene sono scontate nei canili umani. Cosa orrenda se io aborro questa crudeltà e perciò, addirittura, non ho il mio cane legato alle catene. Ogni città ha le sue storie di ingiustizie da raccontare che nessuno racconta. La mia missione è farle conoscere, pur essendo irriconoscenti le vittime. Parlo di loro, vittime d’ingiustizia, ma parlo anche delle vittime del reato. Parlo soprattutto dell’ambiente sociale ed istituzionale che tali vicende trattano. Vita morte e miracoli di chi ha il potere o l’indole di sbagliare e che, con i media omertosi, invece rimane nell’ombra o luccica di luce riflessa ed immeritata. Sul delitto di Sarah Scazzi ad Avetrana, il mio paese, ho raccontato quello che in modo privilegiato ho potuto vedere, ma non è stato raccontato. Ma non solo di quel delitto mi sono occupato. Nel libro su Perugia mi sono occupato del delitto di Meredith Kercher. Per esempio.
FIRENZE. 30 gennaio 2014. Ore 22.00 circa. Come volevasi dimostrare. Ogni volta che un delitto si basa su indizi aleatori che si sottopongono a contrastanti interpretazioni, i magistrati condannano, pur sussistendo gravi dubbi che lasciano sgomenti l'opinione pubblica. Condannano non al di là del ragionevole dubbio e lo fanno per non recare sgarbo ai colleghi dell'accusa. I sensitivi hanno delle sensazioni e li palesano, spesso non creduti. I pubblici ministeri, in assenza di prove, anch’essi hanno delle sensazioni. Solo che loro vengono creduti dai loro colleghi. Sia mai che venga lesa l’aurea di infallibilità di chi, con un concorso all’italiana, da un giorno all’altro diventa un dio in terra. Osannato dagli italici coglioni, che pur invischiati nelle reti dell’ingiustizia, nulla fanno per ribellarsi.
«Grazie a quei giudici coscienziosi e privi di animosità politica che spero sempre di trovare - ha detto Silvio Berlusconi riferendosi ai suoi guai giudiziari - gli italiani potranno comprendere appieno la vera e propria barbarie giudiziaria in cui l’Italia è precipitata. Una degenerazione dei principali capisaldi del diritto - ha, infine, concluso - che ha riservato a me e alle persone che mi stimano e mi vogliono bene un’umiliazione e, soprattutto, un dolore difficilmente immaginabili da parte di chi non vive l’incubo di accuse tanto ingiuste quanto infondate».
Se lo dice lui che è stato Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana?
Silvio Berlusconi: «Venti anni di guerra contro di me. In Italia giustizia ingiusta per tutti».
Raffaele Sollecito: «Io sono innocente. Come mi sento? Vorrei che gli altri si mettessero al mio posto. E’ così...».
Sabrina Misseri: «Io non c'entro niente, sono innocente».
Alberto Stasi: «Io sono innocente».
Queste sono solo alcune delle migliaia di testimonianze riportate nei miei saggi. Gente innocente condannata. Gente innocente rinchiusa in carcere. Gente innocente rinchiusa in carcere addirittura in attesa di un giudizio che arriverà con i tempi italici e rilasciato da magistrati che intanto si godono le loro ferie trimestrali.
Questo può bastare a dimostrare la mia cognizione di causa?
Quale altro ruolo istituzionale prevede l’impunità di fatto per ogni atto compiuto nell’esercizio del proprio magistero? Quale altro organo dello Stato è il giudice di se stesso?
Di questa sorte meschina capitata ai più sfortunati, la maggioranza dei beoti italici se ne rallegra. Il concetto di Schadenfreude potrebbe anche venire parafrasato come "compiacimento malevolo". Il termine deriva da Schaden (danno) e Freude (gioia). In tedesco il termine ha sempre una connotazione negativa. Esiste una distinzione tra la "schadenfreude segreta" (un sentimento privato) e la "schadenfreude aperta" (Hohn). Un articolo del New York Times del 2002 ha citato una serie di studi scientifici sulla Schadenfreude, che ha definito come "delizia delle disgrazie altrui".
Ecco perché Antonio Giangrande è orgoglioso di essere diverso.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?
Noi siamo animali. Siamo diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.
Al di là delle questioni soggettive è il sistema giustizia ed i suoi operatori (Ministri, magistrati, avvocati e personale amministrativo) che minano la credibilità di un servizio fondamentale di uno Stato di Diritto.
Noi, miseri umani, prima di parlare o sparlare dei nostri simili, facciamo come dice il nostro amico Raffaele Sollecito: “Vorrei che gli altri si mettessero al mio posto”. Quindi, facciamolo! Solo allora si vedrà che la prospettiva di giudizio cambia e di conseguenza si possono cambiare le cose. Sempre che facciamo in tempo, prima che noi stessi possiamo diventare oggetto di giudizio. Ricordiamoci che quello che capita agli altri può capitare a noi, perché gli altri, spesso, siamo proprio noi. Oggi facciamo ancora in tempo. Basta solo non essere ignavi!»
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO ARRIVA LA PREDICA, SE LO STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
«Siamo un paese di truffatori, o, magari, qualcuno ha interesse a farci passare come tali». Così afferma il dr Antonio Giangrande, noto saggista di fama mondiale e presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Associazione fuori dal coro e fuori dai circuiti foraggiati dai finanziamenti pubblici.
Evasione fiscale, buco di 52 miliardi nel 2013. In base alle indagini delle Fiamme Gialle, l'evasione fiscale italiana del 2013 è pari a 51,9 miliardi di euro, scrive Angelo Scarano su “Il Giornale”. Le evasioni fiscali in Italia sono all'ordine del giorno: niente scontrino, niente fatture, insomma, niente di niente. È così, oggi lo Stato italiano ha scoperto che nelle sue casse c'è un buco di 51,9 miliardi di euro non versati: colpa delle società italiane, che per non incappare nel Fisco hanno attuato i tanto famosi "trasferimenti di comodo", spostando le proprie residenze o le basi delle società nei cosiddetti paradisi fiscali - Cayman, Svizzera, Andorre -. Quanto agli oltre ottomila evasori totali scoperti, hanno occultato redditi al fisco per 16,1 miliardi, mentre i ricavi non contabilizzati e i costi non deducibili riferibili ad altri fenomeni evasivi - dalle frodi carosello ai reati tributari fino alla piccola evasione - ammontano a 20,7 miliardi, una cifra più che consistente. Il totale dell'IVA evasa dagli italiani sarebbe di circa 5 miliardi: un dato che non sorprende, se si considera che secondo una recente ricerca della Guardia di finanza su 400.000 controlli effettuati, il 32% delle attività almeno un paio di volte hanno emesso uno scontrino falso, o non lo hanno emesso proprio. Per frodi e reati fiscali, lo scorso anno sono state denunciate 12.726 persone, con 202 arresti. Nei confronti dei responsabili delle frodi fiscali, i finanzieri hanno avviato procedure di sequestro di beni mobili, immobili, valuta e conti correnti per 4,6 miliardi di euro. Oltretutto, in Italia sono presenti 14.220 lavoratori completamente in nero, scoperti nel 2013, e 13.385 irregolari, impiegati da 5.338 datori di lavoro. Con una media di una su tre società che non emette scontrini, non sorprende come l'evasione sia arrivata a cifre stellari, e come tendenzialmente è destinata ad aumentare col tempo.
I datori di lavoro versano i contributi (altrimenti è un reato). Lo stato il primo evasore fiscale: INPDAP non versa i contributi come fanno le aziende ordinariamente. Lo Stato è il primo evasore contributivo. Secondo stime attendibili (ma non ufficiali) il datore di lavoro di oltre 3 milioni di persone avrebbe mancato di versare circa 30 miliardi di contributi. Risultato? Un buco enorme nell'Inpdap che poi è stato scaricato sull'Inps con un'operazione di fusione alquanto discutibile. Non ha versato all'INPDAP i contributi previdenziali dei suoi dipendenti...
Cresce il buco nei conti dell'INPS. Nel 2015 lo Stato dovrà sborsare 100 miliardi per ripianare l'ammanco dell'istituto. Prendendoli da pensionati e contribuenti. Inps, Mastrapasqua al governo: "Allarme conti". Ma Saccomanni lo smentisce, scrive Il Fatto Quotidiano. Il presidente dell'istituto scrive ai ministri Saccomanni e Giovanni: "Valutare un intervento dello Stato per coprire i deficit dell'ex Inpdap, altrimenti le passività aumenteranno". L'ultimo bilancio segnava un rosso di quasi 10 miliardi. E a "La Gabbia" su La7 aveva detto: "Possiamo sopportare solo 3 anni di disavanzo". Angeletti: "Avvertimento tardivo" e Bonanni chiede di fare chiarezza.
Lo stato italiano non ha versato per anni i contributi pensionistici ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quindi li ha fatti confluire nell’Inps, ponendoli a carico di coloro che la sventura pose a lavorare nel comparto produttivo. Forse che i pensionati italiani non saranno solidali con i poveri dipendenti delle pubbliche amministrazioni?
Cerchiamo di raccontare la questione del presunto buco dell’Inps come se fossimo dei privati e non mamma Stato, scrive Nicola Porro su “Il Giornale”. La cosa in fondo è semplice. Un paio di anni fa il governo Monti ha deciso di fondere nella grande Inps, la più piccola Inpdap. È il fondo previdenziale che si occupa dei 2,8 milioni di pensionati pubblici. E ovviamente dei prossimi dipendenti statali che andranno in quiescenza. Il motivo formale era nobile: ridurre di 100 milioni il costo di queste burocrazie. In fondo, Inps e Inpdap facevano e fanno lo stesso mestiere: incassano i contributi sociali da lavoratori e datori di lavoro e pagano le pensioni. Si è rivelato, dobbiamo presumere senza malizia, come un modo di annacquare un gigantesco buco di bilancio. Se fossimo dei privati sarebbe una bancarotta, più o meno fraudolenta. E vi spieghiamo perché. L’Inpdap è nato nel 1994. Prima lo Stato italiano la faceva semplice e male. Non pagava i contributi per i propri dipendenti pubblici, ritenendola una partita di giro. Perché accantonare risorse per le future pensioni pubbliche, si saranno detti i furbetti della Prima repubblica? Paghiamo il dovuto, cioè apriamo la cassa, solo quando la pensione sarà maturata. Se volete si tratta di una variazione ancora peggiore rispetto allo schema Ponzi (dal grande truffatore italo americano) del metodo retributivo. Quando nel 1994 si crea l’ente previdenziale si pone dunque il problema. Come facciamo? Semplice, da oggi in poi la Pubblica amministrazione è costretta a pagare anno per anno i suoi contributi, così come tutti i datori privati lo fanno ogni mese con l’Inps, al suo fondo di riferimento: l’Inpdap, appunto. Il sistema diventa così corretto e identico a quello di un’azienda privata: il costo del personale pubblico, in questo modo, diventa fedele alla realtà e pari (anche in termini di cassa) a stipendio netto, più tasse e contributi sociali. Ma restava un problema. Cosa fare con i contributi che si sarebbero dovuti versare nel passato? La genialata se la inventa il governo Prodi nel 2006 insieme al ministro del lavoro Damiano. All’Inpdap (semplifichiamo per farci capire) lo Stato avrebbe dovuto dare più di 8 miliardi di euro di contributi non versati, ma maturati dai dipendenti pubblici. Una bella botta. E anche all’epoca avevamo bisogno di fare i fighetti con l’Europa. Per farla breve, lo Stato non ha trasferito gli 8 miliardi all’Inpdap, ma ha fatto come lo struzzo: ha anticipato volta per volta ciò che serviva per pagare i conti. Di modo che alla fine dell’anno i saldi con l’Europa quadrassero. I nodi vengono al pettine quando Monti decide di fondere l’Inps con l’Inpdap. Antonio Mastrapasqua, che è il super boss delle pensioni private, sa fare bene i suoi conti. E appena si accorge che gli hanno mollato il pacco inizia a tremare. Un imprenditore privato che omettesse di versare i contributi per i propri dipendenti, pur assumendosi l’impegno di pagare la pensione quando maturasse, verrebbe trasferito in un secondo a Regina Coeli o a San Vittore. In più, il medesimo imprenditore privato non dovendo versare ogni anno i contributi all’Inps, potrebbe fare il fenomeno con le banche o la Borsa, dicendo di avere molta più cassa di quanto avrebbe se dovesse andare a versare ogni mese il dovuto. Un mega falso in bilancio da 8 miliardi, questo è ciò che plasticamente è emerso fondendo l’Inpdap nell’Inps. Mastrapasqua resta un servitore dello Stato e, secondo il cuoco, non lo ammetterebbe neanche a sua nonna, ma la fusione dei due enti ha in buona parte compromesso molti degli sforzi fatti per mettere ordine nel suo carrozzone (che tale in buona parte purtroppo resta). Si è dovuto sobbarcare un’azienda fallita e non può prendersela più di tanto con il suo principale creditore: che si chiama Stato Italiano. La morale è sempre quella. Mentre i privati chiudono, falliscono, si disperano per pagare tasse e contributi sociali, lo Stato centrale se ne fotte. Come diceva il marchese del Grillo: «Io so io e voi nun siete un cazzo.»
C'è soltanto una categoria professionale che invece sta versando molti più contributi di quanto riceve in termini di assegni pensionistici, scrive Andrea Telara su “Panorama”. Si tratta degli iscritti alla Gestione Separata, cioè quel particolare fondo dell'Inps in cui confluiscono i versamenti previdenziali dei lavoratori precari (come i collaboratori a progetto) e dei liberi professionisti con la partita iva, non iscritti agli Ordini. Nel 2013, il bilancio della Gestione Separata sarà in attivo per oltre 8 miliardi di euro. Va detto che questo risultato ha una ragion d'essere ben precisa: tra i precari italiani e tra le partite iva senza Ordine, ci sono infatti molti giovani ancora in attività, mentre i pensionati di questa categoria sono pochissimi (il rapporto è di 1 a 6). Non si può tuttavia negare che, se non ci fossero i contributi della Gestione Separata, il bilancio dell'Inps sarebbe in una situazione ancor peggiore di quella odierna. In altre parole, oggi ci sono in Italia quasi 2 milioni di lavoratori precari e di partite iva che tengono in piedi i conti dell'intero sistema previdenziale e che pagano una montagna di soldi per mantenere le pensioni di altre categorie, compresi gli assegni d'oro incassati da qualche ex-dirigente d'azienda. tema dei «contributi pensionistici silenti», che vengono versati dai lavoratori precari, parasubordinati e libero professionisti privi di un ordine di categoria, alla gestione separata dell’Inps. Contributi che però non si trasformano in trattamenti previdenziali, poiché quei cittadini non riescono a maturare i requisiti minimi per la pensione: e che restano nelle casse dell’ente pubblico per pagare quelle degli altri. È un assetto che penalizza proprio i giovani e i precari, che con maggiore difficoltà raggiungono i 35 anni di anzianità, visto che nel mercato legale del lavoro si entra sempre più tardi e in modo intermittente. Anche quando si matura il minimo di contribuzione richiesto, la pensione non supera i 400-500 euro. Ad aggravare la condizione di questa fascia di popolazione è anche l’elevata aliquota dei versamenti, quasi il 27 per cento della retribuzione: una quota che per la verità fu stabilita nel 2006 dal governo di Romano Prodi su pressione dei sindacati. Peraltro il problema non tocca esclusivamente i lavoratori trentenni, sottoposti al regime contributivo, ma anche i più anziani, soggetti a quello retributivo, che richiede almeno vent’anni di attività per maturare la pensione.
L’ITALIA, IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI NIMBY.
Vengo anch'io. No, tu no (1967 - Fo, Jannacci)
Inserita nell'album omonimo (che contiene una schidionata di brani indimenticabili: si va da "Giovanni, telegrafista" a "Pedro, Pedreiro", da "Ho visto un re" a "Hai pensato mai", quest'ultima versione in lingua della stupenda "Gastu mai pensà" di Lino Toffolo), "Vengo anch'io. No, tu no" (1967) porta Enzo Jannacci in cima alle classifiche di vendite, con esiti commerciali mai più ripetuti nel corso della sua lunga carriera. Assai accattivante nell'arrangiamento, attraversato da elementi circensi, la canzone divenne una sorta di inno di tutti gli esclusi d'Italia dai grandi rivolgimenti in atto - siamo, ricordiamolo, nel '68 - perchè snobbati dall'intellighenzia dell'epoca. Grazie a versi beffardi e surreali, scritti da Jannacci in sostituzione di quelli originariamente vergati perlopiù da Dario Fo e maggiormente ancorati al reale, il brano s'imprime nella memoria collettiva, diviene una sorta di tormentone nazionale, contribuisce in larga misura a far conoscere ad un pubblico più vasto la figura di un artista inclassificabile quanto geniale.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale
Vengo anch'io? No tu no
Per vedere come stanno le bestie feroci
e gridare "Aiuto aiuto e` scappato il leone"
e vedere di nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera
Vengo anch'io? No tu no
Con la bella sottobraccio a parlare d'amore
e scoprire che va sempre a finire che piove
e vedere di nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore
Vengo anch'io? No tu no
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano
un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore
e vedere di nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale
Vengo anch'io? No tu no
per vedere se la gente poi piange davvero
e scoprire che è per tutti una cosa normale
e vedere di nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no
No, no e 354 volte no. La sindrome Nimby (Not in my back yard, "non nel mio cortile") va ben oltre il significato originario. Non solo contestazioni di comitati che non vogliono nei dintorni di casa infrastrutture o insediamenti industriali: 354, appunto, bloccati solo nel 2012 (fonte Nimby Forum). Ormai siamo in piena emergenza Nimto – Not in my term of office, "non nel mio mandato" – e cioè quel fenomeno che svela l’inazione dei decisori pubblici. Nel Paese dei mille feudi è facile rinviare decisioni e scansare responsabilità. La protesta è un’arte, e gli italiani ne sono indiscussi maestri. Ecco quindi pareri "non vincolanti" di regioni, province e comuni diventare veri e propri niet, scrive Alessandro Beulcke su “Panorama”. Ministeri e governo, in un devastante regime di subalternità perenne, piegano il capo ai masanielli locali. Tempi decisionali lunghi, scelte rimandate e burocrazie infinite. Risultato: le multinazionali si tengono alla larga, le grandi imprese italiane ci pensano due volte prima di aprire uno stabilimento. Ammonterebbe così a 40 miliardi di euro il "costo del non fare" secondo le stime di Agici-Bocconi. E di questi tempi, non permettere l’iniezione di capitali e lavoro nel Paese è una vera follia.
NO TAV, NO dal Molin, NO al nucleare, NO all’ingresso dei privati nella gestione dell’acqua: negli ultimi tempi l’Italia è diventata una Repubblica fondata sul NO? A quanto pare la paura del cambiamento attanaglia una certa parte dell’opinione pubblica, che costituisce al contempo bacino elettorale nonché cassa di risonanza mediatica per politici o aspiranti tali (ogni riferimento è puramente casuale). Ciò che colpisce è la pervicacia con la quale, di volta in volta, una parte o l’altra del nostro Paese si barrica dietro steccati culturali, rifiutando tutto ciò che al di fuori dei nostri confini è prassi comune. Le battaglie tra forze dell’ordine e manifestanti NO TAV non si sono verificate né in Francia né nel resto d’Europa, nonostante il progetto preveda l’attraversamento del continente da Lisbona fino a Kiev: è possibile che solo in Val di Susa si pensi che i benefici dell’alta velocità non siano tali da compensare l’inevitabile impatto ambientale ed i costi da sostenere? E’ plausibile che sia una convinzione tutta italica quella che vede i treni ad alta velocità dedicati al traffico commerciale non rappresentare il futuro ma, anzi, che questi siano andando incontro a un rapido processo di obsolescenza? Certo, dire sempre NO e lasciare tutto immutato rappresenta una garanzia di sicurezza,soprattutto per chi continua a beneficiare di rendite di posizione politica, ma l’Italia ha bisogno di cambiamenti decisi per diventare finalmente protagonista dell’Europa del futuro. NO?
Il Paese dei "No" a prescindere. Quando rispettare le regole è (quasi) inutile. In Italia non basta rispettare le regole per riuscire ad investire nelle grandi infrastrutture. Perché le regole non sono una garanzia in un Paese dove ogni decisione è messa in discussione dai mal di pancia fragili e umorali della piazza. E di chi la strumentalizza, scrive l’imprenditore Massimiliano Boi. Il fenomeno, ben noto, si chiama “Nimby”, iniziali dell’inglese Not In My Backyard (non nel mio cortile), ossia la protesta contro opere di interesse pubblico che si teme possano avere effetti negativi sul territorio in cui vengono costruite. I veti locali e l’immobilismo decisionale ostacolano progetti strategici e sono il primo nemico per lo sviluppo dell’Italia. Le contestazioni promosse dai cittadini sono “cavalcate” (con perfetta par condicio) dalle opposizioni e dagli stessi amministratori locali, impegnati a contenere ogni eventuale perdita di consenso e ad allontanare nel tempo qualsiasi decisione degna di tale nome. Dimenticandosi che prendere le decisioni è il motivo per il quale, in definitiva, sono stati eletti. L’Osservatorio del Nimby Forum (nimbyforum.it) ha verificato che dopo i movimenti dei cittadini (40,7%) i maggiori contestatori sono gli amministratori pubblici in carica (31,4%) che sopravanzano di oltre 15 punti i rappresentanti delle opposizioni. Il sito nimbyforum.it, progetto di ricerca sul fenomeno delle contestazioni territoriali ambientali gestito dall'associazione no profit Aris, rileva alla settima edizione del progetto che in Italia ci sono 331 le infrastrutture e impianti oggetto di contestazioni (e quindi bloccati). La fotografia che emerge è quella di un paese vecchio, conservatore, refrattario ad ogni cambiamento. Che non attrae investimenti perché è ideologicamente contrario al rischio d’impresa. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è la tendenza allo stallo. Quella che i sociologi definiscono “la tirannia dello status quo”, cioè dello stato di fatto, quasi sempre insoddisfacente e non preferito da nessuno. A forza di "no" a prescindere, veti politici e pesanti overdosi di burocrazia siamo riusciti (senza grandi sforzi) a far scappare anche le imprese straniere. La statistica è piuttosto deprimente: gli investimenti internazionali nella penisola valgono 337 miliardi, la metà di quelli fatti in Spagna e solo l’1,4% del pil, un terzo in meno di Francia e Germania. Un caso per tutti, raccontato da Ernesto Galli Della Loggia. L’ex magistrato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, città assurta come zimbello mondiale della mala gestione dei rifiuti, si è insediato come politico “nuovo”, “diverso”, “portatore della rivoluzione”. Poi, dicendo “no” ai termovalorizzatori per puntare solo sulla raccolta differenziata, al molo 44 Area Est del porto partenopeo, ha benedetto l’imbarco di 3 mila tonn di immondizia cittadina sulla nave olandese “Nordstern” che, al prezzo di 112 euro per tonn, porterà i rifiuti napoletani nel termovalorizzatore di Rotterdam. Dove saranno bruciati e trasformati in energia termica ed elettrica, a vantaggio delle sagge collettività locali che il termovalorizzatore hanno voluto. Ma senza andare lontano De Magistris avrebbe potuto pensare al termovalorizzatore di Brescia, dove pare che gli abitanti non abbiano l’anello al naso. Scrive Galli Della Loggia: “Troppo spesso questo è anche il modo in cui, da tempo, una certa ideologia verde cavalca demagogicamente paure e utopie, senza offrire alcuna alternativa reale, ma facendosi bella nel proporre soluzioni che non sono tali”.
«C’è un disegno, che lacera, scoraggia e divide e quindi è demoniaco, al quale non dobbiamo cedere nonostante esempi e condotte disoneste, che approfittano del denaro, del potere, della fiducia della gente, perfino della debolezza e delle paure. E’ quello di dipingere il nostro Paese come una palude fangosa dove tutto è insidia, sospetto, raggiro e corruzione. - Aprendo i lavori del parlamentino dei vescovi italiani del 27-30 gennaio 2014 , il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, rassicura sulla tenuta morale del paese e chiede a tutti – di reagire ad una visione esasperata e interessata che vorrebbe accrescere lo smarrimento generale e spingerci a non fidarci più di nessuno. L’Italia non è così - afferma il cardinale - nulla – scandisce – deve rubarci la speranza nelle nostre forze se le mettiamo insieme con sincerità. Come Pastori – rileva il porporato – non possiamo esimerci dal dire una parola sul contesto sociale che viviamo, consapevoli di dover dare voce a tanti che non hanno voce e volto, ma che sono il tessuto connettivo del Paese con il loro lavoro, la dedizione, l’onestà.»
L’ITALIA DEI COLPI DI STATO.
Letta, Renzi e tutti i governi "non eletti". La "staffetta" non è certo una novità della politica italiana, tra ribaltoni e svolte di ogni tipo (che durano meno di un anno), scrive Sabino Labia su “Panorama”. E sono tre. Stiamo parlando del terzo governo, in tre anni o poco più, non eletto dal popolo ma creato, senza arte ne parte, nella segreteria di un partito con l’avallo autorevole del Quirinale. Già, perché con la nascita del governo Renzi (il sessantesimo della storia Repubblicana) che, a suo dire, mai sarebbe andato a Palazzo Chigi senza passare dalle urne, ma passando solo dalla sede del Pd, sembra di aver fatto l’ennesimo tuffo nel passato. E pensare che ci eravamo convinti che questo tipo di operazione appartenesse a una di quelle mitiche alchimie politiche che tanto deliziavano i partiti della Prima Repubblica, quando i governi non nascevano dalle consultazioni elettorali, ma nella segreteria della DC. E, invece, la Seconda Repubblica e, con ogni probabilità visti i presupposti, anche la Terza Repubblica si avvarrà della facoltà di stabilire l’inquilino di Palazzo Chigi sulla fiducia non dei cittadini ma dei nominati e, per non farci mancare nulla, anche dei non nominati visto che Renzi è soltanto il sindaco di Firenze. In fondo siamo passati da Piazza del Gesù a via del Nazareno. Elencare tutte quelle volte che, dal 1948 a oggi, si è stabilita la fine di un esecutivo, non basterebbe un libro. Per citarne solo alcuni:
- Governo Letta (2013) composto da un'ammucchiata di centro destra e centro sinistra, nato dopo lo sciagurato tentativo di Bersani di coinvolgere l’universo mondo.
- Governo Monti (2011), nato dopo il Friedman-gate dello spread che inseguiva Berlusconi.
- Governo D’Alema (1998), nato dopo il boicottaggio/sabotaggio al primo governo Prodi.
- Governo Dini (1995), nato dopo il ribaltone della Lega, alleata di Berlusconi.
- Governo Ciampi (1993), dopo il sacco dei conti correnti del governo D’Amato.
- Governo De Mita (1988), nato come la vera e unica staffetta, quella con il governo Craxi.
- Governi Rumor/Colombo (1970), Tra l’agosto del 1969 e l’agosto 1970 si ebbe il record di crisi e governi, ben quattro. Ma quelli erano anni veramente difficili.
- Governo Tambroni (1960), nato dopo la decisione presa all’interno della segreteria della Dc di far cadere il governo Segni.
E, proprio in questa occasione, il 25 febbraio 1960 il presidente del Senato, Cesare Merzagora, pronunciò a Palazzo Madama un durissimo discorso contro il Parlamento attaccando i partiti che sostenevano la maggioranza che, nel chiuso delle segreterie, avevano stabilito di far cadere il secondo Governo presieduto da Antonio Segni sostituendolo con un esecutivo guidato da Tambroni. Per di più, Segni, aveva deciso di dimettersi senza fare alcun passaggio dalle Camere. “Se i partiti politici, all’interno dei loro organi statutari, dovessero prendere le decisioni più gravi sottraendole ai rappresentanti del popolo, tanto varrebbe - lo dico, naturalmente, per assurdo – trasformare il Parlamento in un ristretto comitato esecutivo. Risparmieremmo tempo e denaro…". Se poi vogliamo aggiungere un po’ di statistica abbinata alla scaramanzia, che come si sa in Italia non guasta mai, ebbene tutti questi governi non hanno mai avuto una durata superiore a un anno. Prepariamoci ad aggiornare il pallottoliere.
Il Colpo di Stato continua: Renzi sarà il 27mo premier non eletto dal Popolo, scrive Giovanni De Mizio su “Ibtimes”. Mentre continua la sfilata di volti noti e meno noti della politica italiana nel palazzo del Quirinale per le consultazioni del presidente della (ancora per poco) Repubblica Giorgio "Primo" Napolitano e mentre Matteo Renzi, primo ministro in pectore, si riscalda a bordo campo facendo stretching in Piazza della Signoria a Firenze prima di recarsi (a piedi) a Roma, la politica al di fuori del Palazzo continua a rimarcare che il futuro ex-sindaco di Firenze sarà il terzo premier di seguito a non essere stato eletto dal popolo, e come tale privo di legittimazione democratica. Si tratta di un argomento, tuttavia, errato: Renzi non sarà il terzo, bensì il ventisettesimo premier scelto senza mandato popolare a legittimarlo. È un colpo di stato, senza dubbio alcuno, e, a giudicare dalla storia d'Italia del dopoguerra, si tratta di un colpo di stato che parte da lontano, con il chiaro intento di rovesciare la Repubblica per restaurare la Monarchia così come era prima dello Statuto Albertino, possibilmente completando lo svuotamento del Parlamento in atto già da diversi anni. Ne è la prova, fra le altre cose, la volontà di Renzi di mutare il Senato in una camera a parziale nomina regia, pardon, presidenziale. Il colpo di stato attualmente in atto nasce probabilmente a metà degli anni Cinquanta quando, nel corso della Seconda legislatura, si successero ben sei presidenti del Consiglio: De Gasperi, Pella, Fanfani, Scelba, Segni e Zoli. Curiosità: le elezioni si tennero in base alla legge elettorale "truffa" del 1953, che la Corte Costituzionale avrebbe potuto censurare (oppure no), se solo fosse stata istituita (sarebbe "nata" solo nel 1956). Tralasciando De Gasperi (che fallì nell'ottenere la fiducia a causa delle forze monarchiche, carbonare e amatriciane), il primo premier della seconda legislatura, Giuseppe Pella, è dichiaratamente un presidente tecnico, come lo è stato Mario Monti (entrambi, tra l'altro, sono stati ministri degli Esteri e del Bilancio ad interim, a confermare che il complotto, come la Storia, si ripete), e la sua squadra di governo era formata da numerosi ministri altrettanto tecnici. Siamo nel 1953 e Pella ha più o meno la stessa età che avrebbe avuto Monti anni più tardi: dubitiamo sia una coincidenza. Nel gennaio 1954 è Amintore Fanfani ad essere incaricato di formare un governo: anche Fanfani non aveva vinto le elezioni, neppure le primarie del proprio partito, visto che sarebbe stato eletto segretario della DC solo nel giugno successivo (peraltro da un congresso, e non attraverso regolari, libere e democratiche elezioni). Il tentativo delle forze reazionarie, comunque, non va a buon fine, poiché Fanfani non riesce a ottenere la fiducia. Un brutto presagio per il governo Renzi? Lo sapremo nei prossimi giorni. Ciò che avvenne dopo è ancora più disarmante: Mario Scelba riuscì poi a formare un governo, ma fu sostituito da Mario Segni quando fu eletto presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, grazie ai voti, guarda caso, dei monarchici. La Storia si ripeterà, abbastanza simile, anche in seguito, con il governo Tambroni. Ma gli esempi sono tanti anche nella storia successiva: le staffette e la nomina di presidenti del Consiglio che non hanno vinto le elezioni sono state a lungo una regola della Repubblica italiana, a testimonianza del fatto che si tratta di un tentativo ultradecennale di spogliare il popolo dei suoi diritti; basti pensare al fatto che in Italia vi sono stati 62 governi in 18 legislature (una media di 3,44 governi a legislatura), presieduti da 26 presidenti del consiglio (2,39 governi per premier). Solo due presidenti del Consiglio sono rimasti in carica (in più governi) dalle elezioni fino alla scadenza naturale della legislatura: De Gasperi e Berlusconi. Ciò dimostra non certo che il ricambio degli inquilini di palazzo Chigi è fisiologico data la natura del sistema politico italiano nonché il dettato costituzionale (sempre formalmente rispettato), bensì che il complotto per il ripristino della Monarchia in Italia ha più forza di quanto si pensi. Da dove nasce l'equivoco? Nasce dal fatto che, secondo la Costituzione, il presidente del Consiglio è nominato dal presidente della Repubblica e deve avere la fiducia delle Camere. Il popolo elegge il Parlamento ed è questi che decide se una persona può essere o meno il presidente del Consiglio, e può anche togliergli la fiducia per darla a un'altra persona, sempre nominata dal Capo dello Stato. I Padri Costituenti hanno insomma tolto al popolo il diritto di eleggere il proprio presidente del Consiglio sin dalla nascita della Repubblica: a ben guardare, insomma, la Repubblica italiana ha avuto ventisei presidenti del Consiglio (su ventisei) non eletti dal popolo, e Renzi, pertanto, si avvia ad essere non il terzo, bensì il ventisettesimo perpetuatore di questa ignobile tradizione che ormai da oltre sessant'anni infanga l'articolo 1 della Costituzione, secondo la quale, al secondo comma, la sovranità appartiene al Popolo, che viene sottratta ad ogni legislatura. Il complotto, insomma, continua. Nota per chi non se ne fosse accorto. Il presente articolo ha un chiaro intento satirico: l'articolo 1 della Costituzione prevede che la sovranità popolare sia esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa. La carta fondamentale prevede che il presidente del Consiglio non abbia legittimazione popolare (non è eletto dal popolo), poiché l'Italia è una Repubblica parlamentare, ovvero il popolo è sovrano attraverso il Parlamento e non attraverso altri organi, men che meno monocratici. Asserire una presunta incostituzionalità (o peggio) delle nomine di Monti, Letta e (eventualmente) Renzi significa ignorare la storia d'Italia, la sua Costituzione e spingere (ulteriormente) verso un pericoloso presidenzialismo populista privo di un adeguato sistema di pesi e contrappesi che eviti derive ancora peggiori di quelle che l'Italia sta sperimentando da una trentina di anni, ovvero più o meno da quando il declino del Belpaese ha impiantato i propri semi nella penisola. Con questo non vogliamo dire che il presidenzialismo sia un male, ma solo che è necessario modificare l'equilibrio costituzionale per evitare gravi storture e menomazioni della democrazia italiana (come avvenute, per altre ragioni, negli ultimi decenni di quasi-presidenzialismo de facto). In sintesi. Un presidente del Consiglio (nella pienezza dei propri poteri) è tale se, e solo fin quando, ha la fiducia di una maggioranza parlamentare: solo per rifarsi alla storia recente, Berlusconi è caduto nel novembre 2011 perché ad ottobre, benché non sfiduciato, non aveva più una maggioranza in Parlamento, tanto che il rendiconto dello Stato fu approvato solo grazie all'assenza delle opposizioni; stesso discorso per Monti, che ha perso la fiducia dopo l'uscita dalla maggioranza del PDL, e per Letta, che ha perso l'appoggio del suo stesso partito, il PD. Queste situazioni sono state una costante nella storia italiana, se si considera che la prima crisi di governo scoppiata in Parlamento risale al primo governo Prodi: in tutti gli altri casi (tranne il Prodi II) la crisi si è sempre consumata fuori dal Parlamento. Allo stesso modo è stata rispettata la Costituzione nella formazione dei governi che si sono via via succeduti negli anni. La staffetta può non piacere, ma ciò che sta accadendo in queste ore è la regola, non l'eccezione, e che soprattutto si sta rispettando il dettato democratico espresso dalla Costituzione che tanti difensori all'amatriciana della Carta stessa continuano a dimenticare (così come non viola la Costituzione il non presentarsi alle consultazioni del Capo dello Stato). E provoca un senso di vergogna essere costretti a ripetere l'ovvio per via di una diffusa ignoranza delle regole costituzionali anche da chi dovrebbe conoscerle a memoria viste le poltrone su cui sono seduti. L'ignoranza è forza, pare.
Sono giorni che su Internet e nel Paese reale, il popolo protesta perché Renzi andrà a Palazzo Chigi senza elezioni, scrive Fabio Brinchi Giusti su “L’Inkiesta”. “Ma il premier non dovremmo eleggerli noi?” Si domanda la gente mormorando rabbiosa contro la democrazia scippata. A volte non sono solo le persone comuni, a volte si uniscono al coro anche coloro che dovrebbero aiutarli a capire come giornalisti e politici. “No ai premier nominati” “Il popolo deve scegliere” e magari per gettare benzina sul fuoco, si urla anche al golpe. Il guaio che è spesso le voci che urlano contro i governi non-eletti sono le stesse che poi urlano “Giù le mani dalla Costituzione” e “La Costituzione non si tocca”. Ma per difenderla la Costituzione prima andrebbe perlomeno letta. E capirla. Perché è la Costituzione ad aver dato all’Italia un sistema dove il Presidente del Consiglio non viene eletto dal popolo. Il popolo elegge il Parlamento e vota i partiti. Dopo le elezioni i partiti eletti vanno dal Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni ricevute nomina il Presidente del Consiglio. Se quest’ultimo perde il consenso della maggioranza dei parlamentari cade e il gioco di cui sopra si ripete. I partiti vanno dal Capo dello Stato e il Capo dello Stato cerca un nuovo nome (oppure lo stesso se quest’ultimo è in grado di riunire di nuovo una maggioranza). Se non si trova un nome si va ad elezioni anticipate. In tutto questo sistema il popolo non ha voce in capitolo. O meglio lo ha indirettamente tramite i suoi rappresentanti, ma non attraverso votazioni! È così dal 1948, anzi è così da sempre perché a livello nazionale il nostro Paese non ha mai conosciuto l’elezione diretta del capo del Governo. A partire dagli anni ’90 una serie di riforme ha introdotto l’elezione diretta dei sindaci o poi dei leader degli enti locali e il passaggio alla legge elettorale maggioritaria (il cosiddetto Mattarellum poi abolito nel 2005) ha favorito questa tendenza anche a livello nazionale dove le coalizioni di centrodestra e centrosinistra si sono sempre presentate agli elettori guidate da un leader-candidato che in caso di vittoria è poi andato a Palazzo Chigi. Ma non essendo cambiata la Costituzione, di fatto, la scelta del Presidente del Consiglio è rimasto un potere nelle mani del Parlamento e del Presidente della Repubblica. E gli elettori sulla scheda elettorale hanno continuato a sbarrare il simbolo di un partito e non il nome di una persona. I governi in Italia si formano così e dunque è perfettamente costituzionale e legittimo la nascita di un governo non votato dagli elettori. Lo è anche se si regge su una maggioranza completamente modificata da cambi di casacca e voltagabbana vari. Se non vi piace questo sistema, pensateci la prossima volta che urlate: “La Costituzione non si cambia!”.
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
«Non è possibile che nel 2014 gli indigenti muoiano per i denti o sono detenuti pur innocenti. Se i comunisti da 70 anni non lo hanno ancora fatto, propongo io la panacea di questi mali.»
Così afferma il dr Antonio Giangrande, noto saggista di fama mondiale e presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Associazione fuori dal coro e fuori dai circuiti foraggiati dai finanziamenti pubblici.
«Al fine di rendere effettivo l’accesso ai servizi sanitari e legali a tutti gli indigenti, senza troppi oneri per le categorie professionali interessate, presento ai parlamentari, degni di questo incarico, questa mia proposta di legge:
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INDIGENTI
PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO
“Per tutelare i diritti dei non abbienti si obbliga, a mo' di PRO BONO PUBLICO, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'art.359 c.p., a destinare il 20 % della loro attività o volume di affari al servizio gratuito a favore degli indigenti.
E' indigente chi percepisce un reddito netto mensile non maggiore di 1.000 euro, rivalutato annualmente in base all’inflazione.
L'onere ricade sulla collettività, quindi, ai fini fiscali e contributivi, ogni attività pro bono publico, contabilizzata con il minimo della tariffa professionale, è dedotta dal reddito complessivo.
Le attività professionali svolte in favore degli indigenti sono esentati da ogni tributo o tassa o contributo.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamenti incompatibili con la presente legge.”
NON VI REGGO PIU’.
Il testo più esplicito e diretto di Rino dà il titolo all'album uscito nel 1978.
"Nuntereggaepiù" è un brillante catalogo dei personaggi che invadono radio, televisioni e giornali. Clamorosa la coincidenza con quello che succederà nel 1981, quando la magistratura scopre la lista degli affiliati alla P2 di Licio Gelli, loggia massonica in cui compaiono alcuni nomi citati nella filastrocca di Rino.
A dispetto del titolo, nel brano non c'è un briciolo di reggae. Il titolo gioca sull'assonanza fra il genere musicale giamaicano e la coniugazione romanesca del verbo reggere. Come già era accaduto in "Mio fratello è figlio unico", il finale è dissonante rispetto al tema trattato, con l'introduzione di una frase d'amore:
" E allora amore mio ti amo
Che bella sei
Vali per sei
Ci giurerei. "
È uno sfottò come un altro per dire: "Vabbè, visto
che vi ho detto tutte 'ste cose, visto che tanto la canzone non fa testo
politico, la canzone non è un comizio, il cantautore non è Berlinguer né
Pannella, allora a questo punto hanno ragione quelli che fanno solo canzoni
d'amore..". Possiamo immaginare che, oggi, sarebbero entrati di diritto nella
filastrocca Umberto Bossi o Antonio Di Pietro per la politica, Fabio Fazio e
Maria De Filippi o il Grande Fratello per la tivvù, calciatori super pagati come
Totti, Vieri e Del Piero e chissà quante altre invadenti presenze del nostro
quotidiano destinate a ronzarci intorno per altri vent'anni. Quando incide la
versione spagnola, che in ottobre scala le classifiche spagnole, "Corta el rollo
ya" ("Dacci un taglio”), inserisce personaggi di spicco dell'attualità iberica,
come il politico Santiago Carrillo, il calciatore Pirri (che più avanti sarà
vittima di un rapimento), la soubrette Susana Estrada e altri.
Qui sta la grandezza di Rino Gaetano, se leggete oggi il testo di "Nun te reggae
più" vi accorgerete che i personaggi citati sono quasi tutti ancora sulla
breccia e, se scomparsi o ritirati dalla vita pubblica, hanno lasciato un segno
indelebile nel loro campo, si pensi a Gianni Brera o all'avvocato Agnelli, o a
Enzo Bearzot che, un anno dopo la dipartita del cantautore calabrese, regalerà
con la sua nazionale (Causio, Tardelli, Antognoni) il terzo mondiale di calcio
dopo quarantaquattro anni.
Abbasso e Alè (nun te reggae più)
Abbasso e Alè (nun te reggae più)
Abbasso e Alè con le canzoni
senza patria o soluzioni
La castità (Nun te reggae più)
La verginità (Nun te reggae più)
La sposa in bianco, il maschio forte,
i ministri puliti, i buffoni di corte
..Ladri di polli
Super-pensioni (Nun te reggae più)
Ladri di stato e stupratori
il grasso ventre dei commendatori,
diete politicizzate,
Evasori legalizzati, (Nun te reggae più)
Auto blu, sangue blu,
cieli blu, amori blu,
Rock & blues (Nun te reggae più!)
Eja-eja alalà, (Nun te reggae più)
DC-PSI (Nun te reggae più)
DC-PCI (Nun te reggae più)
PCI-PSI, PLI-PRI
DC-PCI, DC DC DC DC
Cazzaniga, (nun te reggae più)
avvocato Agnelli,
Umberto Agnelli,
Susanna Agnelli, Monti Pirelli,
dribbla Causio che passa a Tardelli
Musiello, Antognoni, Zaccarelli.. (nun te reggae più)
..Gianni Brera,
Bearzot, (nun te reggae più)
Monzon, Panatta, Rivera, D'Ambrosio
Lauda, Thoeni, Maurizio Costanzo, Mike Bongiorno,
Villaggio, Raffà e Guccini..
Onorevole eccellenza
Cavaliere senatore
nobildonna, eminenza
monsignore, vossia
cheri, mon amour!.. (Nun te reggae più!)
Immunità parlamentare (Nun te reggae più!)
abbasso e alè!
Il numero cinque sta in panchina
si e' alzato male stamattina
– mi sia consentito dire: (nun te reggae più!)
Il nostro è un partito serio.. (certo!)
disponibile al confronto (..d'accordo)
nella misura in cui
alternativo
alieno a ogni compromess..
Ahi lo stress
Freud e il sess
è tutto un cess
si sarà la ress
Se quest'estate andremo al mare
soli soldi e tanto amore
e vivremo nel terrore
che ci rubino l'argenteria
è più prosa che poesia...
Dove sei tu? Non m'ami più?
Dove sei tu? Io voglio, tu
Soltanto tu, dove sei tu? (Nun te reggae più!)
Uè paisà (..Nun te reggae più)
il bricolage,
il '15-18, il prosciutto cotto,
il '48, il '68, le P38
sulla spiaggia di Capo Cotta
(Cardin Cartier Gucci)
Portobello, illusioni,
lotteria, trecento milioni,
mentre il popolo si gratta,
a dama c'è chi fa la patta
a sette e mezzo c'ho la matta..
mentre vedo tanta gente
che non ha l'acqua corrente
e nun c'ha niente
ma chi me sente? ma chi me sente?
E allora amore mio ti amo
che bella sei
vali per sei
ci giurerei
ma è meglio lei
che bella sei
che bella lei
vale per sei
ci giurerei
sei meglio tu
nun te reg più
che bella si
che bella no
nun te reg più!
NUN TE REGGAE PIÙ, NUN TE REGGAE PIÙ, NUN TE REGGAE PIÙ...
LA LIBERTA' Giorgio Gaber (1972)
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Vorrei essere libero come un uomo.
Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura
e cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un’avventura,
sempre libero e vitale, fa l’amore come fosse un animale,
incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia
e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia,
che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare
e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come l’uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza
e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza,
con addosso l’entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo
e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche un gesto o un’invenzione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.
“LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE” – Dal testo di Gaber alla realtà che ci circonda. Così cantava il mitico Gaber in una delle sue canzoni “La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.” Come rispondereste alla domanda “chi è colui che può definirsi libero?”, certamente molti diranno subito “colui che può fare ciò che vuole, esprimere le proprie opinioni, manifestare la propria fede e via discorrendo” … invece non proprio. Non proprio perché questa sarebbe anarchia o per lo meno la rasenterebbe; per capire meglio il significato di tale termine, allora, prendiamo in esame la frase di Gaber libertà è partecipazione: partecipare, filologicamente inteso significa “essere parte di …” e quindi essere inseriti in un dato contesto. Libertà non è dunque dove non esistono limitazioni ma bensì dove queste vigono in maniera armoniosa e, naturalmente, non oppressiva. Posso capire che la cosa strida a molti ma se analizzata in maniera posata si potrà evincere come una società senza regole sia l’antitesi di sé stessa. Dove sta la libertà, allora? Innanzitutto comincerei parlando di rispetto: rispetto per l’altro, per le sue idee, per la sua persona: se non ci rispettiamo vicendevolmente non otterremo mai un vivere civile e quindi alcuna speranza di libertà. La libertà è un diritto innegabile. Chi ha il diritto di stabilire quali libertà assegnare a chi? Pensiamo agli schiavi di ieri e , purtroppo, anche di oggi: perché negare loro le libertà? Per la pigrizia di chi gliele nega, chiaramente; su questo si basa il rapporto padrone-schiavo (anche quello hegeliano del servo-padrone), sulla forza ed il terrore, terrore non dell’asservito ma del servito. Dall’Antichità al Medioevo, dal Rinascimento ad oggi gli uomini hanno sempre tentato di esercitare la propria egemonia sugli altri, secondo diritti divini, di nobiltà di natali, tramite l’ostentazione della propria condizione economica e via discorrendo, falciando così in pieno il diritto alla libertà di alcuni. “Libertà è partecipazione”, tale frase continua a ronzarmi in testa e mi sprona ad esortare: rispettiamoci per essere liberi… a tali parole mi sovviene la seconda strofa del nostro inno nazionale (di cui pochi, ahime, conoscono l’esistenza, poiché molti ritengono che il nostro inno sia costituito d’una sola strofa):
“Noi fummo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popolo,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.”
e quindi l’invito della terza strofa: “Uniamoci, amiamoci”
Dignità, rispetto dell’altro, partecipazione, lievi seppur necessarie limitazioni: questi sono gli ingredienti per un’ottima ricetta di libertà, non certo paroloni da politicanti come “lotta alla criminalità”, “lotta all’evasione fiscale”, “lotta alle cricche”, giusto per citare le più quotate in questi ultimi tempi. La libertà necessita di semplicità, non certo di pompose cerimonie: essa è bella come una ragazza a quindici-sedici anni (o per lo meno, rifacendomi allo Zibaldone leopardiano), tutta acqua e sapone e sempre con un sorriso gentile pronto per tutti. Forse è anche per questo che gli uomini raffigurano la Libertà come una giovane donna…!
IO SE FOSSI DIO di Giorgio Gaber – 1980
Io se fossi Dio
E io potrei anche esserlo
Se no non vedo chi.
Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente
Non sarei mica un dilettante
Sarei sempre presente
Sarei davvero in ogni luogo a spiare
O meglio ancora a criticare, appunto
Cosa fa la gente.
Per esempio il cosiddetto uomo comune
Com'è noioso
Non commette mai peccati grossi
Non è mai intensamente peccaminoso.
Del resto poverino è troppo misero e meschino
E pur sapendo che Dio è il computer più perfetto
Lui pensa che l'errore piccolino
Non lo veda o non lo conti affatto.
Per questo io se fossi Dio
Preferirei il secolo passato
Se fossi Dio rimpiangerei il furore antico
Dove si amava, e poi si odiava
E si ammazzava il nemico.
Ma io non sono ancora nel regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.
Io se fossi Dio
Non sarei mica stato a risparmiare
Avrei fatto un uomo migliore.
Si, vabbè, lo ammetto
non mi è venuto tanto bene
ed è per questo, per predicare il giusto
che io ogni tanto mando giù qualcuno
ma poi alla gente piace interpretare
e fa ancora più casino.
Io se fossi Dio
Non avrei fatto gli errori di mio figlio
E specialmente sull'amore
Mi sarei spiegato un po' meglio.
Infatti voi uomini mortali per le cose banali
Per le cazzate tipo compassione e finti aiuti
Ci avete proprio una bontà
Da vecchi un po' rincoglioniti.
Ma come siete buoni voi che il mondo lo abbracciate
E tutti che ostentate la vostra carità.
Per le foreste, per i delfini e i cani
Per le piantine e per i canarini
Un uomo oggi ha tanto amore di riserva
Che neanche se lo sogna
Che vien da dire
Ma poi coi suoi simili come fa ad essere così carogna.
Io se fossi Dio
Direi che la mia rabbia più bestiale
Che mi fa male e che mi porta alla pazzia
È il vostro finto impegno
È la vostra ipocrisia.
Ce l'ho che per salvare la faccia
Per darsi un tono da cittadini giusti e umani
Fanno passaggi pedonali e poi servizi strani
E tante altre attenzioni
Per handicappati sordomuti e nani.
E in queste grandi città
Che scoppiano nel caos e nella merda
Fa molto effetto un pezzettino d'erba
E tanto spazio per tutti i figli degli dèi minori.
Cari assessori, cari furbastri subdoli altruisti
Che usate gli infelici con gran prosopopea
Ma io so che dentro il vostro cuore li vorreste buttare
Dalla rupe Tarpea.
Ma io non sono ancora nel regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.
Io se fossi Dio maledirei per primi i giornalisti e specialmente tutti
Che certamente non sono brave persone
E dove cogli, cogli sempre bene.
Signori giornalisti, avete troppa sete
E non sapete approfittare della libertà che avete
Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate
E in cambio pretendete
La libertà di scrivere
E di fotografare.
Immagini geniali e interessanti
Di presidenti solidali e di mamme piangenti
E in questo mondo pieno di sgomento
Come siete coraggiosi, voi che vi buttate senza tremare un momento:
Cannibali, necrofili, deamicisiani, astuti
E si direbbe proprio compiaciuti
Voi vi buttate sul disastro umano
Col gusto della lacrima
In primo piano.
Si, vabbè, lo ammetto
La scomparsa totale della stampa sarebbe forse una follia
Ma io se fossi Dio di fronte a tanta deficienza
Non avrei certo la superstizione
Della democrazia.
Ma io non sono ancora nel regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.
Io se fossi Dio
Naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente.
Nel regno dei cieli non vorrei ministri
Né gente di partito tra le palle
Perché la politica è schifosa e fa male alla pelle.
E tutti quelli che fanno questo gioco
Che poi è un gioco di forze ributtante e contagioso
Come la febbre e il tifo
E tutti quelli che fanno questo gioco
C' hanno certe facce
Che a vederle fanno schifo.
Io se fossi Dio dall'alto del mio trono
Direi che la politica è un mestiere osceno
E vorrei dire, mi pare a Platone
Che il politico è sempre meno filosofo
E sempre più coglione.
È un uomo a tutto tondo
Che senza mai guardarci dentro scivola sul mondo
Che scivola sulle parole
E poi se le rigira come lui vuole.
Signori dei partiti
O altri gregari imparentati
Non ho nessuna voglia di parlarvi
Con toni risentiti.
Ormai le indignazioni son cose da tromboni
Da guitti un po' stonati.
Quello che dite e fate
Quello che veramente siete
Non merita commenti, non se ne può parlare
Non riesce più nemmeno a farmi incazzare.
Sarebbe come fare inutili duelli con gli imbecilli
Sarebbe come scendere ai vostri livelli
Un gioco così basso, così atroce
Per cui il silenzio sarebbe la risposta più efficace.
Ma io sono un Dio emotivo, un Dio imperfetto
E mi dispiace ma non son proprio capace
Di tacere del tutto.
Ci son delle cose
Così tremende, luride e schifose
Che non è affatto strano
Che anche un Dio
Si lasci prendere la mano.
Io se fossi Dio preferirei essere truffato
E derubato, e poi deriso e poi sodomizzato
Preferirei la più tragica disgrazia
Piuttosto che cadere nelle mani della giustizia.
Signori magistrati
Un tempo così schivi e riservati
Ed ora con la smania di essere popolari
Come cantanti come calciatori.
Vi vedo così audaci che siete anche capaci
Di metter persino la mamma in galera
Per la vostra carriera.
Io se fossi Dio
Direi che è anche abbastanza normale
Che la giustizia si amministri male
Ma non si tratta solo
Di corruzioni vecchie e nuove
È proprio un elefante che non si muove
Che giustamente nasce
Sotto un segno zodiacale un po' pesante
E la bilancia non l'ha neanche come ascendente.
Io se fossi Dio
Direi che la giustizia è una macchina infernale
È la follia, la perversione più totale
A meno che non si tratti di poveri ma brutti
Allora si che la giustizia è proprio uguale per tutti.
Io se fossi Dio
Io direi come si fa a non essere incazzati
Che in ospedale si fa morir la gente
Accatastata tra gli sputi.
E intanto nel palazzo comunale
C'è una bella mostra sui costumi dei sanniti
In modo tale che in questa messa in scena
Tutto si addolcisca, tutto si confonda
In modo tale che se io fossi Dio direi che il sociale
È una schifosa facciata immonda.
Ma io non sono ancora nel regno dei cieli
Sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.
Io se fossi Dio
Vedrei dall'alto come una macchia nera
Una specie di paura che forse è peggio della guerra
Sono i soprusi, le estorsioni i rapimenti
È la camorra.
È l'impero degli invisibili avvoltoi
Dei pescecani che non si sazian mai
Sempre presenti, sempre più potenti, sempre più schifosi
È l'impero dei mafiosi.
Io se fossi Dio
Io griderei che in questo momento
Son proprio loro il nostro sgomento.
Uomini seri e rispettati
Cos'ì normali e al tempo stesso spudorati
Così sicuri dentro i loro imperi
Una carezza ai figli, una carezza al cane
Che se non guardi bene ti sembrano persone
Persone buone che quotidianamente
Ammazzano la gente con una tal freddezza
Che Hitler al confronto mi fa tenerezza.
Io se fossi Dio
Urlerei che questi terribili bubboni
Ormai son dentro le nostre istituzioni
E anzi, il marciume che ho citato
È maturato tra i consiglieri, i magistrati, i ministeri
Alla Camera e allo Senato.
Io se fossi Dio
Direi che siamo complici oppure deficienti
Che questi delinquenti, queste ignobili carogne
Non nascondono neanche le loro vergogne
E sono tutti i giorni sui nostri teleschermi
E mostrano sorridenti le maschere di cera
E sembrano tutti contro la sporca macchia nera.
Non ce n'è neanche uno che non ci sia invischiato
Perché la macchia nera
È lo Stato.
E allora io se fossi Dio
Direi che ci son tutte le premesse
Per anticipare il giorno dell'Apocalisse.
Con una deliziosa indifferenza
E la mia solita distanza
Vorrei vedere il mondo e tutta la sua gente
Sprofondare lentamente nel niente.
Forse io come Dio, come Creatore
Queste cose non le dovrei nemmeno dire
Io come Padreterno non mi dovrei occupare
Né di violenza né di orrori né di guerra
Né di tutta l'idiozia di questa Terra
E cose simili.
Peccato che anche Dio
Ha il proprio inferno
Che è questo amore eterno
Per gli uomini.
IL CONFORMISTA di Giorgio Gaber – 1996
Io sono un uomo nuovo
talmente nuovo che è da tempo che non sono neanche più fascista
sono sensibile e altruista
orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista
da un po’ di tempo ambientalista
qualche anno fa nell'euforia mi son sentito come un po' tutti socialista.
Io sono un uomo nuovo
per carità lo dico in senso letterale
sono progressista al tempo stesso liberista
antirazzista e sono molto buono
sono animalista
non sono più assistenzialista
ultimamente sono un po' controcorrente son federalista.
Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta,
il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa
è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani
e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire
forse da buon opportunista si adegua senza farci caso
e vive nel suo paradiso.
Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza,
il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza
è un animale assai comune che vive di parole da conversazione
di notte sogna e vengon fuori i sogni di altri sognatori
il giorno esplode la sua festa che è stare in pace con il mondo
e farsi largo galleggiando
il conformista
il conformista.
Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario
sono femminista
son disponibile e ottimista
europeista
non alzo mai la voce
sono pacifista
ero marxista-leninista e dopo un po' non so perché mi son trovato cattocomunista.
Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone
il conformista aerostato evoluto che è gonfiato dall'informazione
è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie
poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato
vive e questo già gli basta e devo dire che oramai
somiglia molto a tutti noi
il conformista
il conformista.
Io sono un uomo nuovo
talmente nuovo che si vede a prima vista
sono il nuovo conformista.
Una canzone molto ironica quella di Giorgio Gaber, un’analisi su chi sia veramente il conformista e proprio per questo proviamo prima di tutto a capire noi cosa sia il conformismo, perchè senza di quello non possiamo comprendere cosa ci voglia dire Gaber con questa canzone.
Il termine conformismo indica una tendenza a conformarsi ad opinioni, usi, comportamenti e regole di un determinato gruppo sociale. Attenzione però qui stiamo parlando di gruppo sociale qualunque e non per forza quello “dominante” (come in genere molti pensano) che sarebbe anche piuttosto difficile da identificare visto che la nostra società è molto grande, complessa ed esistono infinite sfumature. Questo vuol dire che se apparteniamo ad un gruppo sociale che accettiamo in modo assoluto allora siamo conformisti rispetto a quel gruppo. Il prete per esempio è un conformista rispetto al suo gruppo sociale di preti che a loro volta fanno riferimento al Papa. Chi per esempio appartiene ad una famiglia malavitosa e fa il bullo a scuola insieme ad altri bulli suoi amici che disturbano, rubano ecc. è un conformista rispetto al suo gruppo sociale di delinquenti. Molti giovani pensano ingenuamente che conformismo vuol dire solo mettersi giacca, cravatta e comportarsi bene, mentre anticonformismo vuol dire mettersi maglietta, jeans e comportarsi male, ma non è così.
Con questa canzone Gaber prende in giro il conformista, facendone notare tutte le sue possibili caratteristiche che lo contraddistinguono e allo stesso tempo ne fa emergere tutta una serie di contraddizioni: guardiamo per esempio alla prima strofa in cui il conformista nel giro di pochi anni passa prima ad essere “fascista“, per poi diventare “orientalista“, ricordandosi però di essere stato un “sessantottista” e da tempo anche “ambientalista” e pure “socialista“! Da subito quindi una forte critica implicita all’uomo conformista, che alla fine continuando a cambiare idea, risulta essere tutto tranne che conformista. Questa successione di cambio di idee improvvise, seguendo la massa a seconda di cosa sia più comodo e non secondo ciò in cui si creda veramente, porta Gaber a dare lui stesso la definizione del conformista moderno:
“Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta,
il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa
è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani
e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire
forse da buon opportunista si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso”
La critica dunque è forte, un uomo che non è quasi più in grado di pensare con la sua testa, ma si adegua alle circostanze creandosi un mondo tutto suo in cui vivere senza problemi e senza lotte. Ma come è abituato a fare, Gaber lancia una frecciatina a tutti noi, perchè guardandoci in faccia, probabilmente i primi ad essere conformisti siamo proprio noi:“e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi, il conformista“.
LA DEMOCRAZIA di Giorgio Gaber – 1997
Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno stato di organizzarsi ho capito che la democrazia... è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c’è la dittatura, la democrazia e... basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura chi l’ha vista sa cos’è, gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. lo, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico pazienza, apostolico non so cosa sia, ma anche romano... Va be’, del resto come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c’è scritto che la parola "democrazia" deriva dal greco e significa "potere al popolo". L’espressione è poetica e suggestiva. Sì, ma in che senso potere alta popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c’è scritto. Però si sa che dal ‘45, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto di voto. È nata così la “Democrazia rappresentativa” nella quale tu deleghi un partito che sceglie una coalizione che sceglie un candidato che tu non sai chi sia e che tu deleghi a rappresentarti per cinque anni. E che se io incontri ti dice: “Lei non sa chi sono io!” Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo. Ci sono delle forme ancora più partecipative. Per esempio il referendum è addirittura una pratica di “Democrazia diretta”... non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla Variante di Valico Barberino-Roncobilaccio ha qualche difficoltà. Anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire un “Sì” se vuoi dire no e un “No” se vuoi dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccarla. Comunque il referendum ha più che altro un valore folkloristico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati tutto resta come prima. Un altro grande vantaggio che la democrazia offre a mia nonna, cioè al popolo, è la libertà di stampa. Nei regimi totalitari, per esempio durante il fascismo, si chiamava propaganda e tu non potevi mai sapere la verità. Da noi si chiama “informazione”, che per maggior chiarezza ha anche il pregio di esser pluralista. Sappiamo tutto. Sappiamo tutto, ma anche il contrario di tutto. Pensa che bello. Sappiamo che l’Italia va benissimo, ma che va anche malissimo. Sappiamo che l’inflazione è al 3, o al 4, o al 6, o anche al 10%. Che abbondanza! Sappiamo che i disoccupati sono il 12% e che aumentano o diminuiscono a piacere, a seconda di chi lo dice. Sappiamo dati, numeri, statistiche. Alla fine se io voglio sapere quanti italiani ci sono in Italia, che faccio? Vado sulla Variante di Valico Barberino-Roncobilaccio e li conto: Zzzz! Chi va al sud. Zzzz! Chi va al nord! Altro che Istat! Comunque è innegabile che fra un regime totalitario e uno democratico c’è una differenza abissale. Per esempio, durante il fascismo non ti potevi permettere di essere antifascista. In democrazia invece si può far tutto, tranne che essere antidemocratici. Durante il fascismo c’era un partito solo al potere. O quello o niente. In democrazia invece i partiti al potere sono numerosi e in crescita. Alle ultime elezioni, fra partiti, liste autonome, liste di area, gruppi misti, eccetera, ce ne sono stati duecentoquarantotto. Più libertà di cosi si muore! Del resto una delle caratteristiche della democrazia è che si basa esclusivamente sui numeri… come il gioco del Lotto, anche se è meno casuale, ma più redditizio. Più largo è il consenso del popolo, più la democrazia, o chi per lei, ci guadagna. Quello del popolo è sempre stato un problema, per chi governa. Se ti dà il suo consenso vuoi dire che ha capito, che è cosciente, consapevole, e anche intelligente. Se no è scemo. Comunque l’importante è coinvolgere più gente possibile. Intendiamoci, la democrazia non è nemica della qualità. È la qualità che è nemica della democrazia. Mettiamo come paradosso che un politico sia un uomo di qualità. Mettiamo anche che si voglia mantenere a livelli alti. Quanti lo potranno apprezzare? Pochi, pochi ma buoni. No, in democrazia ci vogliono i numeri, e che numeri. Bisogna allargare il consenso, scendere alla portata di tutti. Bisogna adeguarsi. E un’adeguatina oggi, un’adeguatina domani... e l’uomo di qualità a poco a poco ci prende gusto... e “tac”, un’altra abbassatina... poi ce n’è un altro che si abbassa di più, e allora anche lui... “tac”... “tac”... ogni giorno si abbassa di cinque centimetri. E così, quando saremo tutti scemi allo stesso modo, la democrazia sarà perfetta.
DESTRA-SINISTRA di Giorgio Gaber – 2001
Destra-Sinistra è un singolo di Giorgio Gaber, pubblicato nel 2001, tratto dall'album La mia generazione ha perso.
La canzone vuol mettere ironicamente in risalto le presunte differenze tra destra e sinistra politiche, delle quali è una bonaria critica. Tutta la canzone verte infatti su luoghi comuni anziché sulle differenze di tipo idealistico, ed è lo stesso Gaber a specificare che, attualmente, le differenze fra le due parti sono ormai minime, e che chi si definisce di una fazione rispetto ad un'altra lo fa per mera «ideologia», e per «passione ed ossessione» di una diversità che «al momento dove è andata non si sa». In altre parole, la differenza fra chi si definisce di una parte piuttosto che dall'altra è solamente ostentata, ed è nulla per quanto riguarda il lato pratico.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia
ma io dico che la colpa è nostra
è evidente che la gente è poco seria
quando parla di sinistra o destra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Fare il bagno nella vasca è di destra
far la doccia invece è di sinistra
un pacchetto di Marlboro è di destra
di contrabbando è di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Una bella minestrina è di destra
il minestrone è sempre di sinistra
tutti i films che fanno oggi son di destra
se annoiano son di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Le scarpette da ginnastica o da tennis
hanno ancora un gusto un po' di destra
ma portarle tutte sporche e un po' slacciate
è da scemi più che di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
I blue-jeans che sono un segno di sinistra
con la giacca vanno verso destra
il concerto nello stadio è di sinistra
i prezzi sono un po' di destra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
I collant son quasi sempre di sinistra
il reggicalze è più che mai di destra
la pisciata in compagnia è di sinistra
il cesso è sempre in fondo a destra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
La piscina bella azzurra e trasparente
è evidente che sia un po' di destra
mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare
sono di merda più che sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
L'ideologia, l'ideologia
malgrado tutto credo ancora che ci sia
è la passione, l'ossessione
della tua diversità
che al momento dove è andata non si sa
dove non si sa, dove non si sa.
Io direi che il culatello è di destra
la mortadella è di sinistra
se la cioccolata svizzera è di destra
la Nutella è ancora di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Il pensiero liberale è di destra
ora è buono anche per la sinistra
non si sa se la fortuna sia di destra
la sfiga è sempre di sinistra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Il saluto vigoroso a pugno chiuso
è un antico gesto di sinistra
quello un po' degli anni '20, un po' romano
è da stronzi oltre che di destra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
L'ideologia, l'ideologia
malgrado tutto credo ancora che ci sia
è il continuare ad affermare
un pensiero e il suo perché
con la scusa di un contrasto che non c'è
se c'è chissà dov'è, se c'é chissà dov'é.
Tutto il vecchio moralismo è di sinistra
la mancanza di morale è a destra
anche il Papa ultimamente
è un po' a sinistra
è il demonio che ora è andato a destra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
La risposta delle masse è di sinistra
con un lieve cedimento a destra
son sicuro che il bastardo è di sinistra
il figlio di puttana è di destra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Una donna emancipata è di sinistra
riservata è già un po' più di destra
ma un figone resta sempre un'attrazione
che va bene per sinistra e destra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Tutti noi ce la prendiamo con la storia
ma io dico che la colpa è nostra
è evidente che la gente è poco seria
quando parla di sinistra o destra.
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Ma cos'è la destra cos'è la sinistra...
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Basta!
IO NON MI SENTO ITALIANO di Giorgio Gaber – 2003
La canzone "Io non mi sento italiano" è tratta dall'omonimo album uscito postumo di Giorgio Gaber, nel gennaio 2003, titolo che all'apparenza è di forte impatto evocativo che sa di delusione, di rabbia, di denuncia. Ma poi, per ribilanciare l'affermazione, basta leggere la frase nel seguito, “Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono”, c'è un grande concetto all'interno, quello di appartenenza, a cui Gaber è legato, che lascia trasparire la sua dolcezza, nonostante il sentimento di sdegno di cui si fa portavoce. Stupisce, e non poco, a distanza di anni, la modernità del testo, l'attualità delle situazioni, che già allora Giorgio Gaber raccontava come quotidianità di quel paese, in quel periodo storico. Album registrato poco prima della sua scomparsa, fu scritto con Sandro Luporini, pittore di Viareggio, suo compagno di scrittura in tutte le sue produzioni più importanti musicali e teatrali. Giorgio Gaber, è il suo nome d'arte, si chiama in effetti Giorgio Gaberscik e nasce a Milano il 25 gennaio 1939 (scompare a Montemagno di Camaiore il 1º gennaio 2003), da padre di origine istriane-goriziano slovene e madre veneziania. Inizia a suonare la chitarra da bambino a 8-9 anni per curare un brutto infortunio ad un braccio. Diventa un ottimo chitarrista e, con le serate, da grande, si pagherà gli studi universitari. E' il 1970 l'anno della svolta artistica di Giorgio Gaber. Gaber è celebre ma si sente “ingabbiato”, costretto a recitare un ruolo nella parte di cantante e di presentatore televisivo. Rinuncia così alla grandissima notorietà, si spoglia del ruolo di affabulatore e porta "la canzone a teatro" (creando il genere del teatro canzone). Gaber si presenta al pubblico così com'è, ricomincia da capo. Per questo crea un personaggio che non recita più un ruolo, il «Signor G», recita se stesso. Quindi un signore come tutti, “una persona piena di contraddizioni e di dolori”.
TESTO - Io non mi sento italiano - parlato:
Io G. G. sono nato e vivo a Milano.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Mi scusi Presidente
non è per colpa mia
ma questa nostra Patria
non so che cosa sia.
Può darsi che mi sbagli
che sia una bella idea
ma temo che diventi
una brutta poesia.
Mi scusi Presidente
non sento un gran bisogno
dell'inno nazionale
di cui un po' mi vergogno.
In quanto ai calciatori
non voglio giudicare
i nostri non lo sanno
o hanno più pudore.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Mi scusi Presidente
se arrivo all'impudenza
di dire che non sento
alcuna appartenenza.
E tranne Garibaldi
e altri eroi gloriosi
non vedo alcun motivo
per essere orgogliosi.
Mi scusi Presidente
ma ho in mente il fanatismo
delle camicie nere
al tempo del fascismo.
Da cui un bel giorno nacque
questa democrazia
che a farle i complimenti
ci vuole fantasia.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Questo bel Paese
pieno di poesia
ha tante pretese
ma nel nostro mondo occidentale
è la periferia.
Mi scusi Presidente
ma questo nostro Stato
che voi rappresentate
mi sembra un po' sfasciato.
E' anche troppo chiaro
agli occhi della gente
che tutto è calcolato
e non funziona niente.
Sarà che gli italiani
per lunga tradizione
son troppo appassionati
di ogni discussione.
Persino in parlamento
c'è un'aria incandescente
si scannano su tutto
e poi non cambia niente.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Mi scusi Presidente
dovete convenire
che i limiti che abbiamo
ce li dobbiamo dire.
Ma a parte il disfattismo
noi siamo quel che siamo
e abbiamo anche un passato
che non dimentichiamo.
Mi scusi Presidente
ma forse noi italiani
per gli altri siamo solo
spaghetti e mandolini.
Allora qui mi incazzo
son fiero e me ne vanto
gli sbatto sulla faccia
cos'è il Rinascimento.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Questo bel Paese
forse è poco saggio
ha le idee confuse
ma se fossi nato in altri luoghi
poteva andarmi peggio.
Mi scusi Presidente
ormai ne ho dette tante
c'è un'altra osservazione
che credo sia importante.
Rispetto agli stranieri
noi ci crediamo meno
ma forse abbiam capito
che il mondo è un teatrino.
Mi scusi Presidente
lo so che non gioite
se il grido "Italia, Italia"
c'è solo alle partite.
Ma un po' per non morire
o forse un po' per celia
abbiam fatto l'Europa
facciamo anche l'Italia.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Io non mi sento italiano
ma per fortuna o purtroppo
per fortuna o purtroppo
per fortuna
per fortuna lo sono.
Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di Bertolt Brecht.
Povera Italia. Povera Calabria, scrive Luciano regolo, direttore de “L’Ora della Calabria”. Non sono renziano, ma neppure lettiano o berlusconiano o alfaniano o grillino. Anzi vi confesso che non voto da un bel po', specialmente da quando, dirigendo un settimanale nazionale popolare a vasta tiratura, ebbi modo di toccare con mano quali e quanti mali attraversino trasversalmente i nostri partiti e come difficilmente i vari leader del nostro scenario politico si tirino indietro dal lobbysmo che domina in Italia. Tuttavia trovo questa staffetta Letta-Renzi ancora più inquietante. Per mesi abbiamo sentito dire a destra e manca che Letta doveva restare in sella per emergenze basilari nella vita del nostro Paese, dalla crisi economica alla riforma elettorale. Ora invece si cambia registro. Ma non si va a nuove elezioni, la volontà popolare, in tutto questo, viene sempre più messa da parte. La scusa è che senza nuove regole per le elezioni si rischierebbe di avere nuovamente una maggioranza troppo risicata per garantire la stabilità governativa. Ma se non si è avuto fino ad ora quel certo senso di responsabilità necessario per mettere da parte gli interessi e i protagonismi personali per arrivare a questo (minimo) obiettivo perché mai le cose dovrebbero cambiare con Renzi premier? Non sarebbe stato più equo e più democratico chiedere agli elettori di andare alle urne, magari esercitando il proprio diritto di voto riflettendo un po' di più, visto quello che stiamo tuttora vivendo? Napolitano avrà pure le sue buone ragioni, anche se a volte riesce difficile condividerle. Però, lo spazio non se l'è preso da solo, gli è dato da tutta una situazione, da tutto un cecchinaggio diffuso e mirato al proprio tornaconto personale. Il sospetto è che il "cancro" della voglia sconfinata di poltrone oramai dilaghi e la faccia da padrona fino ad annientare anche il minimo rispetto per tutte quelle famiglie italiane che stanno versando in condizioni di gravissime difficoltà. La gente si toglie la vita per i debiti (di qualche giorno fa la drammatica scelta dell'editore Zanardi), la gente è disperata. Ma il palazzo continua imperterrito nelle sue logiche. E il male si riverbera dal centro alla periferia, con le stesse modalità. La Calabria ne è un esempio eclatante. Guerre intestine nella destra, guerre intestine a sinistra (difficile che queste sospirate primarie del Pd siano la panacea per vecchie e croniche conflittualità). Intanto i rifiuti ci sommergono, intanto la 'ndrangheta erode sempre più spazi della società civile, intanto la disoccupazione lievita, al pari della malasanità. Povera Italia, povera Calabria.
E poi c’è lei, la fonte di tutti i mali.
Magistratura, la casta e le degenerazioni, scrive Andrea Signini su “Rinascita”. “IMAGISTRATI SONO INCAPACI E CORROTTI, NE CONOSCO MOLTISSIMI”. Il Presidente Francesco Cossiga (Sassari, 26 Luglio 1928 – Roma, 17 Agosto 2010), appartenente ad una famiglia di altissimi magistrati e lui stesso capo del Consiglio Superiore della Magistratura, intervistato dal giornalista Vittorio Pezzuto, disse: “La maggior parte dei magistrati attuali sono totalmente ignoranti a cominciare dall’amico Di Pietro che un giorno mi disse testualmente: “Cosa vuoi, appena mi sarò sbrigato questi processi, mi leggerò il nuovo codice di procedura penale”. Nel corso della medesima intervista Cossiga sottolineava le scadenti qualità dei membri della magistratura, li definiva “incapaci a fare le indagini”. Da Presidente della Repubblica inviò i carabinieri a Palazzo dei Marescialli. Accadde nel 91, il 14 novembre, quando il presidente-picconatore ritirò la convocazione di una riunione del plenum nella quale erano state inserite cinque pratiche sui rapporti tra capi degli uffici e loro sostituti sull’assegnazione degli incarichi. Cossiga riteneva che la questione non fosse di competenza del plenum e avvertì che se la riunione avesse avuto luogo avrebbe preso «misure esecutive per prevenire la consumazione di gravi illegalità». I consiglieri del Csm si opposero con un documento e si riunirono. In piazza Indipendenza, alla sede del Csm, affluirono i blindati dei carabinieri e due colonnelli dell’Arma vennero inviati a seguire la seduta. Ma il caso fu risolto subito, perché il vicepresidente, Giovanni Galloni, non permise la discussione. Invitato a dare una spiegazione sull’incredibile ed ingiustificato avanzamento di carriera toccato ai due magistrati (Lucio di Pietro e Felice di Persia) noti per aver condannato ed arrestato Enzo Tortora e centinaia di persone innocenti nell’ambito dello stesso processo (tutti rilasciati dopo mesi di carcere per imperdonabili errori macroscopici), Cossiga rispose: “Come mi è stato spiegato, la magistratura deve difendere i suoi, soprattutto se colpevoli”. La sicurezza di quanto affermava il Presidente Cossiga gli proveniva da una confessione fattagli da un membro interno di cui non rivelò mai il nome ma risulta evidente che si tratti di un personaggio di calibro elevatissimo, “Un giovane membro del Consiglio Superiore della Magistratura, appartenente alla corrente di magistratura democratica, figlio di un amico mio, il quale mi è ha detto: “Noi dobbiamo difendere soprattutto quei magistrati che fanno errori e sono colpevoli perché sennò questa diga che noi magistrati abbiamo eretto per renderci irresponsabili ed incriticabili crolla”! invitato a dare delle spiegazioni sul come mai il nostro sistema (comunemente riconosciuto come il migliore al Mondo) fosse così profondamente percorso da fatali fratture, Cossiga tuonò: “La colpa di tutto questo è della DC! Lì c’è stato chi, per ingraziarsi la magistratura, ha varato la famosa “Breganzola” che prevede l’avanzamento di qualifica dei magistrati senza demerito. Ci pronunciammo contro quella Legge in quattro: uno era l’Avvocato Riccio, il deputato che poi fu sequestrato ed ucciso in Sardegna; Giuseppe Gargani, io ed un altro. Fummo convocati alla DC e ci fu detto che saremmo stati sospesi dal gruppo perché bisognava fare tutto quello che dicevano di fare i magistrati altrimenti avrebbero messo tutti in galera”. Questo breve preambolo ci deve servire come metro per misurare, con occhio nuovo, quanto più da vicino possibile, l’attuale situazione italiana. Dal 1992 (mani pulite), ad oggi, di acqua sotto ai ponti ne è passata assai. E tutta questa acqua, per rimanere nel solco dell’allegoria, ha finito con l’erodere i margini di garanzia della classe politica (vedi perdita delle immunità dei membri del Parlamento – 1993) espandendo quelli dei membri della magistratura. Membri i quali, poco alla volta, hanno preferito fare il “salto della scimmia” passando da un ramo all’altro (dal ramo giudiziario a quello legislativo e/o esecutivo) e ce li siamo ritrovati in politica come missili (di Pietro, de Magistris, Grasso, Ingroia, Finocchiaro…). Pertanto, quella che da decenni a questa parte viene rivenduta al popolo italiano come una “stagione di battaglia contro la corruzione politica”, in realtà nascondeva e tutt’ora nasconde ben altro. Il potere legislativo (facente capo al Parlamento), quanto il potere esecutivo (facente capo al governo), si sono ritrovati in uno stato di progressiva sofferenza indotta dalla crescente ed inarrestabile affermazione del potere giudiziario (facente capo alla magistratura). Che le cose stiano così, è fuor di dubbio! E “La cosa brutta è che i giornalisti si prestino alle manovre politiche dei magistrati” [Cossiga Ibid.]. Ecco spiegato come mai ci si ostini a ritenere “mani pulite” una battaglia alla corruzione e non già una battaglia tra i tre poteri dello Stato. Ma, scusate tanto, e il POPOLO?!? No, dico, siamo o non siamo noi italiani ed italiane – e non altri popoli diversi dal nostro – a pagare sulla nostra pelle lo scotto generato dalle conseguenze di queste “scalate al potere”? Non siamo forse noi quelli/e che stanno finendo dritti in bocca alla rovina totale, alla disperazione ed al suicidio di massa? COSA CI STANNO FACENDO DI MALE E’ PRESTO DETTO. Innanzi tutto, il riflesso peggiore che ci tocca subìre è dato dal fatto che, dal precedente (prima di “mani pulite”) clima culturale in cui eravamo usi vivere sentendoci protetti dalla magistratura (vedi garanzia di presunzione d’ innocenza), ci siamo ritrovati catapultati in un clima orrido in cui è “la presunzione di colpevolezza” a dettare il ritmo. E, di conseguenza, tutto il discorso è andato a gambe all’aria e le nostre libertà, nonché le nostre sovranità sono andate in fumo. E poi, chi di voi può affermare di non aver mai sentito ripetere sino alla nausea frasi del tipo “Lo deve stabilire la magistratura”, oppure “Lo ha stabilito una sentenza” od anche “Lo ha detto in giudice”; e allora? Forse queste persone (che restano sempre impiegati statali al servizio dello Stato e di chi vi abita) discendono dallo Spirito Santo? Sono o non sono esseri umani? E se lo sono allora posso commettere degli sbagli, sì o no? E se sbaglia un magistrato le conseguenze sono letali, sì o no? E allora per quale ragione da 22 anni a questa parte si sta facendo di tutto per collocarli nell’olimpo della saggezza? Perché è possibile sputtanare un esponente del ramo legislativo o di quello esecutivo e GUAI se si fa altrettanto con uno del ramo giudiziario? L’ex magistrato ed ex politico Antonio Di Pietro (definito da Cossiga “Il famoso cretino… che ha nascosto cento milioni in una scatola delle scarpe” e “Ladro” che si è laureato “Probabilmente con tutti 18 e si è preso pure l’esaurimento nervoso per prepararsi la Laurea” quando era a capo dell’IDV ci ha assillato per anni, farcendo all’inverosimile i suoi discorsi con frasi come quelle succitate. E come lui, ma dall’altro lato della barricata, Silvio Berlusconi ha infarcito i suoi discorsi contro la magistratura corrotta e bla bla bla. Ci hanno fatto un vero e proprio lavaggio del cervello, arrivando a dividere la popolazione in due: una parte garantista ed una giustizialista. Il vecchio e amatissimo strumento del “dividi et impera” inventato dai nostri avi latini per esercitare il potere sulla massa ignorante. Ma se due terzi della medesima torta sono marci e putrescenti (il potere legislativo e quello esecutivo), possibile che il rimanente terzo (potere giudiziario) sia l’unico commestibile? Certo che non lo è, è ovvio! La corruzione, in magistratura è a livelli raccapriccianti, “E’ prassi dividere il compenso con il magistrato. Tre su quattro sono corrotti” confessa Chiara Schettini (nomen omen) impiegata statale con la qualifica di giudice presso il Tribunale dei Fallimenti di Roma, anzi ex, visto che le hanno messo le manette ai polsi e poi sbattuta in galera con gravissime accuse di corruzione e peculato. Ricostruiamo quello che la stampa di regime non osa nemmeno sfiorare. “SONO PIU’ MAFIOSA DEI MAFIOSI” DICE SPAVALDAMENTE IL GIUDICE DI ROMA. La gente normale, quella che lavora per guadagnare e consegnare il bottino allo Stato vampiro, lo sa molto bene: se si può, meglio non fare causa! Si perde tempo, si perdono soldi e non si sa se ti andrà bene. E, stando a quanto sta emergendo da una prodigiosa inchiesta di cui prima o poi anche la stampa di regime sarà costretta a parlare, l’impressione poggia su basi solidissime. E sarebbe bene prendere le distanze da certa gente… più pericolosa dei delinquenti veri. In una elaborazione di un articolo de Il Fatto Quotidiano del 31 Dicembre 2013 apparsa l’1 Gennaio 2014 sul sito malagiustiziainitalia.it, si parla di “Perizie affidate a consulenti dall’ampio potere discrezionale e dai compensi stratosferici, mazzette spartite anche con i giudici. Un crocevia affaristico in cui è coinvolto il vertice dell’ufficio [quello di Roma]”, in riferimento alla vicenda che ha visto coinvolta Chiara Schettini di cui abbiamo appena accennato. La stessa Schettini, chiama in causa (è il caso di dire) anche la magistratura umbra, passivamente prona ai desiderata di quella romana: insabbiare gli esposti, far finta di nulla ed attendere che trascorrano i tempi era l’ordine da eseguire. Sotto interrogatorio, la Schettini ha confessato al giudice (onesto e che ringraziamo a nome di tutti i lettori e le lettrici di signoraggio.it): “Si entrava in camera di consiglio e si diceva questo si fa fallire e questo no”. Chi si esprime così non è un temibile boss della mala ma è sempre lei, il veramente temibile giudice Schettini, lei sì appartenente al ramo pulito del potere, proprio quello!!! Nella sua crassa arroganza venata di ottusa prosaicità, ella ricorreva sovente ad uscite agghiaccianti, sfornando un gergo truce da gangster matricolato. Intercettata telefonicamente mentre parlava col curatore fallimentare Federico Di Lauro (anche lui in galera) minacciava di farla pagare al suo ex compagno: “Guarda, gli ho detto, sono più mafiosa dei mafiosi, ci metto niente a telefonare ai calabresi che prendono il treno, te danno una corcata de botte e se ne vanno” (da Il Fatto, 8 Luglio 2013, R. Di Giovacchino). Non finisce qui. Sempre questo giudice donna, in un’altra intercettazione che ha lasciato di stucco gli inquirenti che l’hanno più e più volte riascoltato il nastro, parlando con un ignoto interlocutore, minacciava il “povero” Di Lauro in questi termini: “Io a Di Lauro l’avrei investito con la macchina… Lui lavorava con la banda della Magliana”. Ciliegina sulla torta: parlando al telefono con un perito del Tribunale, riferendosi all’insistenza di un Avvocato che non aveva intenzione di piegarsi supinamente al comportamento della Schettini, commentava: “Il suo amico Massimo [l’Avvocato insistente Ndr.] ha chiesto la riapertura di due procedimenti. Una rottura senza limiti. Gli dica di non insistere perché non domani, né dopo domani ma fra 10 anni io lo ammazzo”. Alla faccia della magistratura a cui tocca attenersi! Alla faccia delle parole del magistrato “che c’azzecckkhhA” Di Pietro colui il quale, dopo il salto della scimmia ci ha assillato ripetendo come un disco scassato che dobbiamo “affidarci alla magistratura”! come no! Si accomodi lei Di Pietro, prima di noi (senza balbettare come le accadde quando se la vide bruttina a Milano). Nell’articolo della Di Giovacchino leggiamo inoltre: “L’amico Massimo è in realtà l’avvocato Vita. Mai ricevuto minacce? “Non da Grisolia, però mi hanno telefonato persone con accento calabrese, consigli…”. Messaggi? “Mi dicevano lasci perdere la vecchietta…” La “vecchietta” è Diana Ottini, un tipo tosto, La giudice le consegnò 500 mila euro stipulando una promessa di vendita posticipata di 10 anni, affinché acquistasse la sua casa dal Comune. Ma venuto il momento lei la casa se l’è tenuta e il Tribunale le ha dato ragione. Non è andata altrettanto bene a Francesca Chiumento, altra cliente dell’avvocato Vita, che da anni si batte per riconquistare il “suo” attico in via Germanico: 170 metri quadri, terrazza su tre livelli, che il padre aveva acquistato dagli eredi di Aldo Fabrizi. La casa finì all’asta, nei salotti romani si parla ancora della polizia arrivata con le camionette. Anche quell’asta porta la firma della Schettini: la famiglia Chiumento era pronta a pagare, a spuntarla fu un medico del Bambin Gesù che offrì 50 mila euro di meno. L’appartamento di via Germanico alla fine fu rivenduto per 1 milione e 800 mila euro a una coppia importante. Lei figlia di un costruttore, che ha tirato su villaggi turistici tra Terracina e Sperlonga, lui avvocato della banca che aveva offerto il mutuo ai legittimi proprietari” [Il Fatto Ibid.]. E pensare che questa sguaiata stipendiata statale ha campato una vita sulle spalle di noi contribuenti ed ha potuto nascondere le sue malefatte per anni dietro la protezione del ruolo affidatole dallo Stato e di persone della sua medesima risma. Tutti suoi colleghi e colleghe. Allucinante. Semplicemente allucinante. Solamente dopo essersi impaurita a causa dei giorni trascorsi in prigione, ha confessato che il suo ex compagno “Trafficava anche con il direttore di una filiale di Unicredit su 900 mila euro gliene dava 200 mila” come stecca [malagiustizia. Ibid.]. L’organizzazione funzionava a gonfie vele, il timore di essere scoperti non li sfiorava nemmeno: ‘Non ti preoccupare [la rincuorava il compagno, quello della stecca all’Unicredit] sarà rimesso tutto perfettamente”. Suscita la ripugnanza leggere la storia di questa squallida persona la quale, nel frattempo, con lo stipendio da funzionario statale è riuscita ad accumulare un patrimonio di quasi 5 milioni di euro (quasi 10 miliardi di Lire) oltre ad attici a Parigi e Miami, ville a Fregene, un rifugio a Madonna di Campiglio… A proposito: il figlio della carcerata si è rivelato meno sveglio della mamma ma comunque fatto della medesima pasta! Infatti, mentre alla madre venivano serrati i polsi con le manette, lui riceveva l’sms in cui la madre stessa gli ordinava di fare “quello che sa” (Il Fatto, ibid.). Si avete proprio capito bene. Il figlio diciottenne, evidentemente al corrente delle attività della madre (e del padre) ed istruito a dovere su come agire in caso di necessità, si è prontamente attivato rendendosi complice della vicenda facendo sparire la valigetta col contante, frutto di una delle corruzioni cui la madre era avvezza. Solo che le sue limitate capacità hanno consentito, a chi ha effettuato la perquisizione, di ritrovare tutto all’istante. Ed il Consiglio Superiore della Magistratura dormiva in questi anni? Certo che no! Provvedeva, come fa spessissimo, a trasferirla presso la procura di l’Aquila per ragioni di incompatibilità ambientale. Non sarebbe male saperne di più su questa scelta curiosa. Che questa sia una vicenda riguardante un pugno di magistrati e non tutti i componenti della magistratura è lapalissiano, scontato ed evidente. E CI MANCHEREBBE ALTRO! Ma sappiate che il punto della questione non è arrivare a pronunciare frasi vuote quanto idiote del genere “Sono tutti uguali. Tra cani non si mordono…” qui c’è solo da fare una cosa: il POPOLO deve riconoscere il proprio ruolo di SOVRANO! E poi, non resta che risalire alla fonte del problema e, per farlo, NOI uomini e donne della cosiddetta “società civile” abbiamo il dovere di emanciparci. Se c’intendessimo (mi ci metto dentro anch’io – sebbene non sia un tifoso) di finanza e Stato come di calcio e cucina, con l’aiuto dei nostri veri angeli custodi seri (ed in magistratura ce ne sono eccome), il nostro futuro sarebbe radioso. Ripartire da un punto fermo è cogente. Tale punto risiede nella battaglia “persa contro la magistratura che è stata perduta quando abbiamo abrogato l’immunità parlamentare, che esistono in tutto il Mondo, ovvero quando Mastella, da me avvertito, si è abbassato il pantalone ed ha scritto sotto dittatura di quell’associazione sovversiva e di stampo che è l’Associazione Nazionale Magistrati” – F. Cossiga, Di Pietro… Ibid.
Non dimentichiamoci che di magistrati parliamo e delle loro ambizioni.
Il giudice "pagato" con prostitute di lusso. Quell'ambizione: «Dovevo fare il mafioso». Il profilo di un magistrato finito nell'occhio del ciclone per i suoi rapporti molto stretti con il boss Lampada, già condannato a quattro anni di carcere e sospeso dal servizio, scrive “Il Quotidiano Web”. Il giudice Giancarlo Giusti, arrestato e posto ai domiciliari il 14 febbraio 2014 dalla squadra mobile di Reggio Calabria, era stato condannato dal gup di Milano a 4 anni di reclusione il 27 settembre 2012 ed il giorno successivo aveva tentato il suicidio nel carcere milanese di Opera in cui era detenuto. Soccorso dalla polizia penitenziaria, era stato poi ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Successivamente aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Giusti, dal 2001 giudice delle esecuzioni immobiliari a Reggio Calabria e poi dal 2010 gip a Palmi, era stato arrestato per corruzione aggravata dalle finalità mafiose il 28 marzo 2012 nell’ambito di una inchiesta della Dda di Milano sulla presunta cosca dei Valle-Lampada e, in particolare, in un filone relativo alla cosiddetta "zona grigia". La Dda di Milano gli ha contestato di essere sostanzialmente a “libro paga” della 'ndrangheta. In particolare, i Lampada, sempre secondo l’accusa, non solo gli avrebbero offerto ''affari”, ma avrebbero anche appagato quella che il gip di Milano, nell’ordinanza di custodia cautelare, aveva definito una vera e propria “ossessione per il sesso”, facendogli trovare prostitute in alberghi di lusso milanesi. Per il giudice di Palmi il clan organizzava viaggi nel nord Italia e incontri con alcune escort. Una ventina di fine settimana di piacere al Nord, in cui gli venivano messe a disposizione prostitute con le quali avrebbe intrattenuto rapporti in un hotel della zona del quartiere San Siro. L’inchiesta che scoperchia qualche figura della “zona grigia” che protegge, favorisce, aiuta o in qualche modo è amica della ‘ndrangheta tra Milano e Reggio Calabria allinea numerosi episodi, e ovviamente si avvale di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali. Eccone una che riguarda proprio Giancarlo Giusti, invitato a Milano, all’hotel Brun. La toga non paga mai. Per lui il conto è saldato da un boss del calibro di Giulio Lampada, per una spesa totale di 27mila euro. Senza parlare di quanto costavano le ragazze, tutte identificate. C’era la ceca Jana, quarantenne, le russe Zhanna 36 anni, ballerina al Rayto de Oro, a La Tour, al Venus, e altri night di Milano e del nord, ed Elena, 41 anni, la kazaca Olga, 34 anni, e la slovena Denisa, 27 anni. Giusti, per telefono, si lascia andare: «... Dovevo fare il mafioso, non il giudice...» Giusti e Lampada sono ovviamente in ottimi rapporti, il magistrato gli dice che arriva a Milano «la settimana che entra o la prossima... Dipende dal cugino del tuo caro amico medico!... di Giglio!! no?!», e Giglio sta per Vincenzo, il collega magistrato, presidente del tribunale per le misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria, come conferma lo stesso Lampada. Parlando del “medico”, che si chiama pure lui Vincenzo Giglio. Ecco uno stralcio delle intercettazioni:
LAMPADA (riferendosi al magistrato Vincenzo Giglio): «...Del nostro Presidente, dobbiamo dire!!... Il Presidente delle misure di prevenzione di tutta Reggio Calabria! Sai che dobbiamo fare?.....».
GIUSTI: «... che facciamo, che facciamo??».
LAMPADA: «lo convochiamo qualche giorno su a Milano e lo invitiamo... come la vedi tu?».
GIUSTI: «... minchia!! guarda!! dobbiamo parlarne col medico!!!...(ride)...».
LAMPADA: «Non dirgli nulla che ti ho detto che è un mese che non ci sentiamo!».
GIUSTI: «... Tu ancora non hai capito chi sono io... sono una tomba, peggio di.. ma io dovevo fare il mafioso, non il Giudice... però l’idea di portarci il Presidente a Milano non è male, sai?!... Lo vorrei vedere di fronte ad una steccona!!».
BELLA ITALIA, SI’. MA ITALIANI DEL CAZZO!!!
Italiani del Cazzo, sì. Italiani che, anzichè prender a forconate i potenti impuniti, responsabili della deriva italica, per codardia le loro ire le rivolgono a meridionali ed extracomunitari. D’altro canto, per onestà intellettuale, bisogna dire che i meridionali questi strali razzisti se li tirano, perchè nulla fanno per cambiare le loro sorti di popolo occupato ed oppresso dalle forze politiche ed economiche nordiche.
Radio Padania. Radio Vergogna. Scandali e le mani della giustizia sulla Lega Padania. Come tutti. Più di tutti. I leghisti continuano a parlare, anziché mettersi una maschera in faccia per la vergogna. Su di loro io, Antonio Giangrande, ho scritto un libro a parte: “Ecco a voi i leghisti: violenti, voraci, arraffoni, illiberali, furbacchioni, aspiranti colonizzatori. Non (ri)conoscono la Costituzione Italiana e la violano con disprezzo”. Molti di loro, oltretutto, sono dei meridionali rinnegati. Terroni e polentoni: una litania che stanca. Terrone come ignorante e cafone. Polentone come mangia polenta o, come dicono da quelle parti, po’ lentone: ossia lento di comprendonio. Comunque bisognerebbe premiare per la pazienza il gestore della pagina Facebook “Le perle di Radio Padania“, ovvero quelli che per fornire una “Raccolta di frasi, aforismi e perle di saggezza dispensate quotidianamente dall’emittente radiofonica “Radio Padania Libera” sono costretti a sentirsela tutto il giorno. Una gallery di perle pubblicate sulla radio comunitaria che prende soldi pubblici per insultare i meridionali.
Questa è la mia proposta di riforma costituzionale senza intenti discriminatori.
PRINCIPI COSTITUZIONALI
L'ITALIA E' UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA E FEDERALE FONDATA SULLA LIBERTA'. I CITTADINI SONO TUTTI UGUALI E SOLIDALI.
I RAPPORTI TRA CITTADINI E TRA CITTADINI E STATO SONO REGOLATI DA UN NUMERO RAGIONEVOLE DI LEGGI, CHIARE E COERCITIVE.
LE PENE SONO MIRATE AL RISARCIMENTO ED ALLA RIEDUCAZIONE, DA SCONTARE CON LA CONFISCA DEI BENI E CON LAVORI SOCIALMENTE UTILI.
E' LIBERA OGNI ATTIVITA' ECONOMICA, PROFESSIONALE, SOCIALE, CULTURALE E RELIGIOSA. IL SISTEMA SCOLASTICO O UNIVERSITARIO ASSICURA L'ADEGUATA COMPETENZA. LE SCUOLE O LE UNIVERSITA' SONO RAPPRESENTATE DA UN PRESIDE O UN RETTORE ELETTI DAGLI STUDENTI O DAI GENITORI DEI MINORI. IL PRESIDE O IL RETTORE NOMINA I SUOI COLLABORATORI, RISPONDENDO DELLE LORO AZIONI PRESSO LA COMMISSIONE DI GARANZIA.
LO STATO ASSICURA AI CITTADINI OGNI MEZZO PER UNA VITA DIGNITOSA.
IL LAVORO SUBORDINATO PUBBLICO E PRIVATO E' REMUNERATO SECONDO EFFICIENZA E COMPETENZA. LE COMMISSIONI DISCIPLINARI SONO COMPOSTE DA 2 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI E PRESIEDUTE DA UN DIRIGENTE PUBBLICO O AZIENDALE.
LO STATO CHIEDE AI CITTADINI IL PAGAMENTO DI UN UNICO TRIBUTO, SECONDO IL SUO FABBISOGNO, SULLA BASE DELLA CONTABILITA' CENTRALIZZATA DESUNTA DAI DATI INCROCIATI FORNITI TELEMATICAMENTE DAI CONTRIBUENTI, CON DEDUZIONI PROPORZIONALI E DETRAZIONI TOTALI. AGLI EVASORI SONO CONFISCATI TUTTI I BENI. LO STATO ASSICURA A REGIONI E COMUNI IL SOSTENTAMENTO E LO SVILUPPO.
E' LIBERA LA PAROLA, CON DIRITTO DI CRITICA, DI CRONACA, D'INFORMARE E DI ESSERE INFORMARTI.
L'ITALIA E' DIVISA IN 30 REGIONI, COMPRENDENTI I COMUNI CHE IVI SI IDENTIFICANO.
IL POTERE E' DEI CITTADINI. IL CITTADINO HA IL POTERE DI AUTOTUTELARE I SUOI DIRITTI.
I SENATORI E I DEPUTATI, IL CAPO DEL GOVERNO, I MAGISTRATI, I DIFENSORI CIVICI SONO ELETTI DAI CITTADINI CON VINCOLO DI MANDATO. ESSI RAPPRESENTANO, AMMINISTRANO, GIUDICANO E DIFENDONO SECONDO IMPARZIALITA', LEGALITA' ED EFFICIENZA IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DEI CITTADINI. ESSI SONO RESPONSABILI DELLE LORO AZIONI E GIUDICATI DA UNA COMMISSIONE DI GARANZIA CENTRALE E REGIONALE.
GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI NOMINANO I LORO COLLABORATORI, RISPONDENDONE DEL LORO OPERATO.
LA COMMISSIONE DI GARANZIA, ELETTA DAI CITTADINI, E' COMPOSTA DA UN SENATORE, UN DEPUTATO, UN MAGISTRATO, UN RETTORE, UN DIFENSORE CIVICO CON INCARICO DI PRESIDENTE. LA COMMISSIONE CENTRALE GIUDICA IN SECONDO GRADO E IN MODO ESCLUSIVO I MEMBRI DEL GOVERNO. ESSA GIUDICA, ANCHE, SUI CONTRASTI TRA LEGGI E TRA FUNZIONI.
IL DIFENSORE CIVICO DIFENDE I CITTADINI DA ABUSI OD OMISSIONI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, SANITARIE O DI ALTRE MATERIE DI INTERESSE PUBBLICO. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE.
I 150 SENATORI SONO ELETTI PROPORZIONALMENTE, CON LISTE REGIONALI, TRA I MAGISTRATI, GLI AVVOCATI, I PROFESSORI UNIVERSITARI, I MEDICI, I GIORNALISTI.
I 300 DEPUTATI SONO ELETTI, CON LISTE REGIONALI, TRA I RESTANTI RAPPRESENTANTI LA SOCIETA' CIVILE.
IL PARLAMENTO VOTA E PROMULGA LE LEGGI PROPOSITIVE E ABROGATIVE PROPOSTE DAL GOVERNO, DA UNO O PIÙ PARLAMENTARI, DA UNA REGIONE, DA UN COMITATO DI CITTADINI. IL GOVERNO, ENTRO 30 GIORNI DALLA LEGGE, EMANA I REGOLAMENTI ATTUATIVI DI CARATTERE FEDERALE. LE REGIONI, ENTRO 30 GIORNI DALLA LEGGE, EMANANO I REGOLAMENTI ATTUATIVI DI CARATTERE REGIONALE.
LA PRESENTE COSTITUZIONE SI MODIFICA CON I 2/3 DEL VOTO DELL’ASSEMBLEA PLENARIA, COMPOSTA DAI MEMBRI DEL PARLAMENTO, DEL GOVERNO E DAI PRESIDENTI DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI REGIONALI. ESSA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL SENATO.
Invece c'è chi vuole solamente i meridionali: föra,o foeura, di ball.
L'Indipendentismo padano, da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La bandiera della Padania proposta dalla Lega Nord, con al centro il Sole delle Alpi. L'indipendentismo padano o secessionismo padano è un'ideologia politica nata negli anni novanta del XX secolo e promossa storicamente dal partito politico Lega Nord, che cita testualmente nel proprio statuto l'indipendenza della Padania. L'ideologia è stata sostenuta o è sostenuta anche da altri partiti, come la Lega Padana, alternativa alla Lega Nord, da essi considerata filo-romana, e da figure, afferenti nella loro storia politica alla Lega Nord, come lo scrittore Gilberto Oneto, il politologo Gianfranco Miglio e Giancarlo Pagliarini. La Padania per alcuni geografi economici di inizio Novecento, corrispondeva al territorio italiano sito a nord degli Appennini. Gli indipendentisti padani di fine Novecento affermano che un territorio comprensivo di gran parte dell'Italia settentrionale (la Lega Padana teorizza una Padania formata da quattro nazioni: Subalpina, Lombarda, Serenissima e Cispadana) o centro-settentrionale (la Lega Nord estende più a sud tale confine), di estensione territoriale differentemente definita dai partiti stessi, e da essi stessi ribattezzato "Padania" (toponimo sinonimo di val padana, la valle del fiume Po, in latino Padus), sarebbe abitato da popoli distinti per lingua, usi, costumi e storia, chiamati nazioni della Padania e riconducibili, nelle loro differenze, a un unico popolo padano e che sarebbero stati resi partecipi contro la loro volontà del Risorgimento e, conseguentemente, dello Stato italiano; pertanto propugnano la secessione di queste nazioni dalla Repubblica Italiana e la creazione di una repubblica federale della Padania rispettosa delle peculiarità di ciascuna di esse. A fronte di alcuni geografi che ad inizio XX secolo solevano dividere il Regno d'Italia in Padania ed Appenninia, sino agli anni ottanta il termine Padania era principalmente usato con significato geografico per la pianura Padana, ma anche con accezione poetica, come dimostra l'opera dello scrittore Gianni Brera e nell'ambito di studi linguistici ed etnolinguistici nonché socio-economici. Il termine acquisisce, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, un significato politico - ovverosia comincia a essere utilizzato per indicare la Padania come, a seconda delle posizioni, reale o pretesa entità politica -, grazie al suo utilizzo costante da parte degli esponenti e dei simpatizzanti del partito politico Lega Nord, nato il 22 novembre 1989 dall'unione di vari partiti autonomisti dell'Italia settentrionale originatesi nel decennio precedente, tra i quali la Lega Lombarda, fondata il 10 marzo 1982 da Umberto Bossi, che diviene guida del nuovo movimento politico. Grazie al successo politico del partito e ai mezzi di comunicazione di massa, tale accezione politica del termine è entrata da allora a far parte della lingua corrente e del dibattito politico. La Lega propose inizialmente un'unione federativa della macro-regione Padania, dotata di autonomia, con le restanti parti dello Stato italiano, come forma di riconoscimento e tutela delle peculiarità etnico-linguistiche delle nazioni della Padania. Fallito il progetto e raggiunto un successo elettorale considerevole promosse il concetto di secessione della Padania dall'Italia, proclamata il 15 settembre 1996 a Venezia. La secessione è stata, successivamente al Congresso di Varese, messa parzialmente da parte a favore della Devoluzione, ovverosia del trasferimento di parte significativa delle competenze legislative e amministrative dallo Stato centrale alle regioni, e del federalismo fiscale. Una prima riforma della costituzione verso una maggiore autonomia delle regioni è stata approvata nel 2001. Una seconda riforma sempre in questo senso del 2005 è stata invece bocciata con il referendum costituzionale del 2006.
« Noi, popoli della Padania, solennemente proclamiamo: la Padania è una Repubblica federale indipendente e sovrana. Noi offriamo, gli uni agli altri, a scambievole pegno, le nostre vite, le nostre fortune e il nostro sacro onore.» (Umberto Bossi, dichiarazione d'indipendenza della Padania, 15 settembre 1996)
Il 15 settembre 1996 a Venezia, nel corso di una manifestazione della Lega Nord, Umberto Bossi ha proclamato, al culmine della politica secessionista del partito, l'indizione di un referendum per l'indipendenza della Padania e ha battezzato il nuovo soggetto istituzionale con il nome di Repubblica Federale della Padania. Il 25 maggio 1997 si è svolto il "Referendum per l'Indipendenza della Padania". Oltre al SI/NO per il referendum, si è votato anche per il Presidente del "Governo Provvisorio della Repubblica Federale della Padania" e per sei disegni di legge di iniziativa popolare da presentare al Parlamento italiano. La Lega Nord ha predisposto i seggi elettorali in tutti i Comuni della supposta Padania. La Repubblica Federale della Padania non è stata mai riconosciuta formalmente da alcuno stato sovrano, né dalle altre forze politiche italiane. L'unico supporto in tal senso è venuto dal partito svizzero della Lega dei Ticinesi. In seguito alla dichiarazione d'indipendenza furono avviate delle inchieste giudiziarie a Venezia, Verona, Torino, Mantova e Pordenone per attentato all'unità dello stato, poi archiviate, e si ebbero scontri tra forze dell'ordine e militanti leghisti in Via Bellerio a Milano, sede della Lega Nord. Per quanto la dichiarazione di secessione non abbia comportato la reale separazione della Padania dall'Italia, la Lega Nord ha da allora promosso e continua a promuovere attivamente la concezione della Padania come entità politica attraverso la creazione e il mantenimento di strutture e organi rappresentativi delle Nazioni della Padania nonché attraverso la promozione di iniziative sportive e sociali di carattere indipendentista o quantomeno autonomista: ha costituito un Governo padano con un proprio parlamento, ha designato Milano capitale della Padania, il Va, pensiero di Giuseppe Verdi suo inno ufficiale, il Sole delle Alpi verde in campo bianco sua bandiera ufficiale, il verde come colore nazionale, ha creato le lire padane e i francobolli padani, una propria Guardia Nazionale, un proprio ente sportivo riconosciuto nel CONI sport Padania e, come organi di stampa ufficiali, il quotidiano La Padania, il settimanale Il Sole delle Alpi, l'emittente radiofonica Radio Padania Libera e l'emittente televisiva TelePadania. Vi fu anche la formazione spontanea, tra i militanti leghisti, delle cosiddette camicie verdi. La Lega Nord ha anche creato una Nazionale di calcio della Padania, non riconosciuta né a livello italiano, né a livello internazionale. Questa selezione Padana ha vinto per 3 volte consecutive il mondiale per le nazioni non riconosciute, la VIVA World Cup, battendo la selezione del Samiland (2008), quella del Kurdistan (2009) e quella della Lapponia (2010). Inoltre il partito padano sponsorizza il concorso di bellezza Miss Padania, aperto a tutte le giovani donne residenti in una regione della Padania da almeno 10 anni consecutivi e di età compresa tra i 17 e i 28 anni. Tra i requisiti necessari per partecipare al concorso vi è anche l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni non in linea con gli ideali dei movimenti che promuovono la Padania. Nel 2009 la Lega Nord, in particolare tramite Umberto Bossi, promosse la realizzazione del film storico Barbarossa, coprodotto dalla Rai. Il film, incentrato sulle vicende della Lega Lombarda nel XII secolo, non ebbe buon riscontro né di critica né di pubblico. Il 2011 ha visto la prima edizione dell'evento ciclistico Giro di Padania. Il 26 ottobre 1997 la Lega Nord organizzò le prime elezioni per i 210 seggi del Parlamento Padano. Circa 4 milioni di Italiani residenti nelle regioni settentrionali, 6 secondo il Partito, si recarono ai seggi e scelsero tra diversi partiti padani. Il Parlamento della Padania, creato nel 1996 e oggi denominato Parlamento del Nord, ha sede nella Villa Bonin Maestrallo di Vicenza, che ha sostituito l'originale sede a Bagnolo San Vito in Provincia di Mantova. Si affianca al Governo della Padania, con sede a Venezia, che, storicamente, è stato guidato prima da Giancarlo Pagliarini (1996-97), da Roberto Maroni (1997-98), da Manuela Dal Lago (1998-99) ed è attualmente guidato da Mario Borghezio (dal 1999). Nell'esecutivo presieduto da Pagliarini, Fabrizio Comencini era Ministro degli esteri, subito dimessosi fu sostituito da Enrico Cavaliere, Giovanni Fabris della Giustizia, Alberto Brambilla del Bilancio e Giovanni Robusti, capo dei Cobas del latte, dell'Agricoltura. Nel governo presieduto da Maroni, il cui vice era Vito Gnutti, è stato introdotto un Ministero dell'Immigrazione, presieduto da Farouk Ramadan. L'esecutivo guidato da Manuela Dal Lago comprendeva Giancarlo Pagliarini come vice presidente e Ministro dell'Economia, Giovanni Fabris alla Giustizia, Alessandra Guerra agli Esteri, Flavio Rodeghiero alla Cultura e all'Istruzione, Giovanni Robusti all'Agricoltura, Roberto Castelli ai Trasporti, Francesco Formenti all'Ambiente, Sonia Viale agli Affari Sociali e della Famiglia, Alfredo Pollini, presidente della Guardia Nazionale Padana, alla Protezione Civile, Francesco Tirelli, del CONI sport Padania, allo Sport e Roberto Faustinelli, presidente di Eridiana Records, allo Spettacolo. Secondo l'art. 2 dello Statuto 2012, la Lega Nord considera il Movimento come una Confederazione delle Sezioni delle seguenti Nazioni: La Lega afferma dunque che il progetto della Padania comprende tutte le otto regioni dell'Italia settentrionale più le regioni dell'Italia centrale Toscana, Umbria e Marche, mentre al 2011 la sua attività si è estesa anche in Abruzzo e Sardegna. Il territorio rivendicato dalla Lega Nord come costituente la Padania comprende 160.908 km² di Italia, ossia il 53,39% del territorio dell'Italia (di 301.340 km²) e il 56,15% della sua popolazione (vedere tabella sottostante). Le rivendicazioni politiche padane ricomprendono quindi un territorio maggiore di quello riconducibile al significato geografico del termine Padania, che è geograficamente riferito alla sola Pianura Padana. La linea apertamente secessionista fatta propria dalla Lega Nord portò, tra il 1996 e il 2000, a un isolamento del movimento nel panorama politico italiano, col risultato che, nelle zone dove il radicamento leghista era minore, i suoi candidati alle elezioni amministrative erano nettamente svantaggiati rispetto a quelli di centrodestra e di centrosinistra, generalmente appoggiati da più liste. Per cercare di rimediare a questa situazione, nel settembre del 1998 Bossi lanciò il cosiddetto Blocco padano, una coalizione formata dalla Lega Nord con diverse liste in rappresentanza di varie categorie sociali e produttive del territorio. Già alle elezioni amministrative dell'aprile 1997 altre liste che si richiamavano apertamente all'indipendentismo avevano affiancato la Lega Nord: Agricoltura padana; Lavoratori padani; Padania pensione sicura; Non chiudiamo per tasse! - Artigianato, commercio, industria. Il risultato di queste liste fu complessivamente molto modesto, e nella maggior parte dei casi esse non riuscirono a portare i candidati leghisti al ballottaggio. Le ultime tre liste ottennero complessivamente l'1,1% al comune di Milano e lo 0,8% al comune di Torino. L'Agricoltura padana ebbe l'1,9% alla provincia di Pavia e i Lavoratori padani lo 0,9% alla provincia di Mantova. Un risultato di un certo rilievo fu però ottenuto dai Lavoratori padani nell'autunno dello stesso anno al comune di Alessandria, dove con il 4,4% contribuirono alla rielezione del sindaco uscente Francesca Calvo ed ebbero diritto a tre consiglieri. Nel 1998 il Blocco padano, di cui il coordinatore doveva essere il parlamentare europeo ed ex sindaco di Milano Marco Formentini, fu annunciato come costituito fondamentalmente da cinque partiti, oltre alla Lega: Terra (evoluzione di Agricoltura padana, con a capo Giovanni Robusti, portavoce dei Cobas del latte); Lavoratori padani; Pensionati padani (evoluzione di Padania pensione sicura, con a capo Roberto Bernardelli); Imprenditori padani (evoluzione di Non chiudiamo per tasse!); Cattolici padani (già presentatosi alle elezioni per il Parlamento della Padania del 1997, con a capo Giuseppe Leoni). A questi si unirono a seconda dei casi anche liste civiche di portata locale, che talvolta ebbero maggior fortuna: a Udine Sergio Cecotti raggiunse il ballottaggio e fu poi eletto sindaco grazie all'apporto di due liste civiche, senza che i partiti "regolari" del Blocco padano fossero presenti. La coalizione nel suo complesso risentì del calo di consensi generalizzato subito dalla Lega Nord, tanto che dopo il 1999 non fu più ripresentata se non in maniera sporadica, anche perché la Lega Nord, entrando a pieno titolo nella Casa delle Libertà, trovò alleati di maggiore consistenza elettorale.
Lega secessionista: ora vuole il Veneto indipendente, scrive "Globalist". L'1 e il 2 marzo 2014 i gazebo per la raccolta firme. Dopo oltre vent'anni di lotta per la Padania, ancora in Italia, ora il Carroccio riparte dal Nord Est. Che la voglia di secessione della Lega non si sia mai placata, è cosa nota. A volte viene messa da parte, per lasciare spazio ad altre battaglie come quella contro l'euro o contro lo ius soli, ma comunque è sempre lì, appesa alla mente del segretario Matteo Salvini e dei suoi compagni. E così ogni tanto torna a galla, come in questi giorni. E se tutto il Nord non si può staccare, almeno ci si può provare con una sua parte. Come il Veneto, ad esempio. "La Lega corre, la Lega c'è. La voglia d'indipendenza è tanta, sia da Roma, sia da Bruxelles" ha detto Salvini, intervendo a Verona con i vertici regionali del Carroccio per presentare la raccolta firme per il referendum per l'indipendenza del Veneto, che si terrà sabato e domenica in tutta la regione. "L'indipendenza da Bruxelles - ha aggiunto - è necessaria perchè fuori dall'euro riparte la speranza, riparte il lavoro, ripartono gli stipendi. L'indipendenza da Roma perchè sostanzialmente l'Italia ormai è un Paese fallito". Ogni anno, è la considerazione del segretario, "il Veneto regala 21 miliardi allo stato italiano ricevendo in cambio servizi da poco o niente". Dopo oltre 20 anni di tentativi secessionisti, dunque, la Lega riparte dal Nord-Est. Perché magari, potrebbe essere il pensiero, l'indipendenza si può ottenere a piccoli passi visto che la Padania, nonostante il loro impegno, continua a restare in Italia. "I veneti sono uniti da una lingua e da una cultura e hanno diritto alla propria autodeterminazione - ha detto la senatrice leghista, Emanuela Munerato -. Solo compatti e votando sì a questo referendum potremo fare scuola e aprire la strada anche alle altre regioni decretando l'inizio della fine del centralismo romano che sta uccidendo la nostra cultura e la nostra economia".
Non solo legisti.....
Grillo chiama gli italiani alla secessione. Sul suo blog il comico contro «l'arlecchinata» dei mille popoli, scrive Barbara Ciolli “Lettera 43”. Altro che Lega Nord, anche Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, archiviate le espulsioni dal partito, grida alla secessione. Peggio ancora, al big bang, all'«effetto domino di un castello di carta», alla diaspora dei mille «popoli, lingue e tradizioni che non hanno più alcuna ragione di stare insieme» e «non possono essere gestiti da Roma». «Un'arlecchinata» bella e buona, a detta del comico ligure che ha postato sul suo blog l'ennesima e forse maggiore provocazione: «E se domani l'Italia si dividesse, alla fine di questa storia, iniziata nel 1861, funestata dalla partecipazione a due guerre mondiali e a guerre coloniali di ogni tipo, dalla Libia all'Etiopia» scrive il Beppe, suo malgrado, nazionale, parafrasando ironicamente - e populisticamente - la canzone di Mina? Sotto, il testo apparso l'8 marzo 2014 in Rete: «Italia, incubo dove la democrazia è scomparsa. Non può essere gestita da Roma». «Quella iniziata nel 1861 è una storia brutale, la cui memoria non ci porta a gonfiare il petto, ma ad abbassare la testa. Percorsa da atti terroristici inauditi per una democrazia assistiti premurosamente dai servizi deviati (?) dello Stato. Quale Stato? La parola "Stato" di fronte alla quale ci si alzava in piedi e si salutava la bandiera è diventata un ignobile raccoglitore di interessi privati gestito dalle maitresse dei partiti. E se domani, quello che ci ostiniamo a chiamare Italia e che neppure più alle partite della Nazionale ci unisce in un sogno, in una speranza, in una qualunque maledetta cosa che ci spinga a condividere questo territorio che si allunga nel Mediterraneo, ci apparisse per quello che è diventata, un'arlecchinata di popoli, di lingue, di tradizioni che non ha più alcuna ragione di stare insieme? La Bosnia è appena al di là del mare Adriatico. Gli echi della sua guerra civile non si sono ancora spenti. E se domani i Veneti, i Friulani, i Triestini, i Siciliani, i Sardi, i Lombardi non sentissero più alcuna necessità di rimanere all'interno di un incubo dove la democrazia è scomparsa, un signore di novant'anni decide le sorti della Nazione e un imbarazzante venditore pentole si atteggia a presidente del Consiglio, massacrata di tasse, di burocrazia che ti spinge a fuggire all'estero o a suicidarti, senza sovranità monetaria, territoriale, fiscale, con le imprese che muoiono come mosche. E se domani, invece di emigrare all'estero come hanno fatto i giovani laureati e diplomati a centinaia di migliaia in questi anni o di "delocalizzare" le imprese a migliaia, qualcuno si stancasse e dicesse "Basta!" con questa Italia, al Sud come al Nord? Ci sarebbe un effetto domino. Il castello di carte costruito su infinite leggi e istituzioni chiamato Italia scomparirebbe. È ormai chiaro che l'Italia non può essere gestita da Roma da partiti autoreferenziali e inconcludenti. Le regioni attuali sono solo fumo negli occhi, poltronifici, uso e abuso di soldi pubblici che sfuggono al controllo del cittadino. Una pura rappresentazione senza significato. Per far funzionare l'Italia è necessario decentralizzare poteri e funzioni a livello di macroregioni, recuperando l'identità di Stati millenari, come la Repubblica di Venezia o il Regno delle due Sicilie. E se domani fosse troppo tardi? Se ci fosse un referendum per l'annessione della Lombardia alla Svizzera, dell'autonomia della Sardegna o del congiungimento della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige alla Francia e all'Austria? Ci sarebbe un plebiscito per andarsene. E se domani...» Si attendono reazioni.
ADDIO AL SUD.
"Addio al sud" di Angelo Mellone, scrive Paolo Tripaldi su “Il Corriere Romano”. Verrà un giorno in cui tutti i meridionali d'Italia, sparsi un po' ovunque, faranno rientro in patria per sconfiggere definitivamente tutti i mali che hanno affossato per anni il Sud. "Addio al Sud", poema dello scrittore tarantino Angelo Mellone, non è una resa bensì una voglia di rinascita, una chiamata alle armi contro il Sud malato e incapace di riscatto. Un poema che parla al cuore e allo stomaco di ogni meridionale e che cerca di farla finita con ogni stereotipo, con il piangersi addosso e con il pensare che le colpe siano sempre degli altri. "Il punto di vista di questa voce narrante - scrive Andrea Di Consoli nella prefazione di Addio al Sud - è il punto di vista di chi è scampato a un naufragio, cioè di chi, senza sapere bene da cosa, si è salvato da un male ineffabile". Mellone ci ricorda però che anche se lontani il Sud continua a chiamare: "Tu, chiunque sarai, i vestiti e i profumi e l'accento che saprai sfoggiare, sempre da lì vieni. Da lì. Lì dove la salsedine non dà tregua e l'umido fa sudare d'inverno e sconfigge qualsiasi acconciatura e il sole, quando c'è, e si fa tramonto, ti uccide di bellezza". Lo sapeva bene Leonida di Taranto, poeta del III secolo a.c., che aveva scelto l'esilio dalla propria patria per non essere schiavo dei romani e che aveva scritto in un suo celebre epitaffio: "riposo molto lontano dalla terra d'Italia e di Taranto mia Patria e ciò m'è più amaro della morte". L'Addio al Sud di Angelo Mellone è un addio ai mali del meridione: alla criminalità, all'assistenzialismo, alla industrializzazione selvaggia che ha inquinato i territori, al nuovo fenomeno del turismo predatorio. E' un invito anche ad abbandonare il 'pensiero meridiano' del sociologo Franco Cassano. "Smettiamola con la follia del pensiero meridiano - scrive Mellone - questa scemenza dell'attesa, dell'andare lento, della modernità differente, della sobrietà della decrescita", tutte scusanti "al difetto meridionale dell'amor fati". Mellone passa in rassegna tutti gli episodi che negli ultimi anni hanno affossato ancora di più il Sud: il fenomeno del caporalato, i fatti di Villa Literno, gli omicidi di camorra. Il racconto ci consegna immagini di una sottocultura del sud che partendo dall'omicidio di Avetrana giunge fino ai fenomeni populisti di Luigi de Magistris e Nichi Vendola. "Voglio tornare a Sud a fare la guerra - scrive Angelo Mellone - senza quartiere, senza paese, senza tregua, senza compromessi, con le micce del carbonaro di patria folle, con le ruspe spianando strade a un esercito che si tiene per mano, con la sola divisa dipinta dell'amore infedele che testardamente continui ad amare”. Addio al Sud, che nel sottotitolo e’ chiamato “un comizio furioso del disamore”, è in realtà un atto d’amore per una terra che è sempre nel centro del cuore.
Perché è impossibile dire addio al Sud. Il Meridione ha ancora la forza per rialzarsi, scrive Aldo Cazzullo su “Il Corriere della Sera”. Di Sud, in Italia, si parla tanto e si ragiona poco. E così le domande che si ponevano i grandi meridionalisti - i Cuoco, i Salvemini, i Fortunato - da decenni restano senza risposta: perché il Meridione italiano, terra di assoluta bellezza e di immense potenzialità, continua a galleggiare nel sottosviluppo e non impedire che i suoi figli migliori, quelli che Piercamillo Falasca ha definito «Terroni 2.0», facciano la valigia per emigrare (anche con un pizzico di risentimento)? A questa domanda prova a rispondere un poema civile scritto da Angelo Mellone, Addio al Sud, definito nel sottotitolo «un comizio furioso del disamore» (Irradiazioni, pp. 80, 8, prefazione di Andrea Di Consoli), una sorta di orazione civile tecno-pop congegnata come reading teatrale. Mellone ribalta due cliché dominanti. Il primo è quello del brigantaggio: qui l'autore trova il coraggio, da meridionale, di ammettere - in quanto «fottuto nazionalista» - che avrebbe scelto di arruolarsi con l'esercito italiano per combattere i Carmine Crocco e i Ninco Nanco, per «piantare tricolori su antiche maledizioni». Il secondo oggetto polemico di Addio al Sud è il nuovo meridionalismo, ovvero quel «pensiero meridiano» - sostenuto, ad esempio, dal sociologo Franco Cassano - che vorrebbe un Sud lento, sobrio, canicolare, che cammina a piedi e ammicca al mito della decrescita o all'idea del Meridione italiano come avanguardia di un'improbabile «alternativa allo sviluppo». Al contrario, il Sud di Mellone anela alla velocità, alla modernità, sia pure a una modernità intrisa di miti antichi e di antichi caratteri comunitari. Scrive Di Consoli nella prefazione: «Questo poema è, in definitiva, una dolorosa "possibilità di prendere congedo", ma è anche una possibilità della rifondazione di un patto "oscuro", ancestrale, e che dunque può essere tramandato nei tempi come accade in tutte le comunità che hanno conosciuto la diaspora, o il suo fantasma». Mellone infatti non sigla una lettera di abbandono dall'identità meridionale, ma rilancia la sfida immaginando che il Sud migliore - emigrato ovunque negli ultimi anni - a un certo punto decida di tornare a casa. In quel momento, dice l'autore, il Sud potrà finalmente essere salutato:
«Finita la guerra prenderò congedo
e solo allora dirò a mia figlia
e solo allora dirò a mio figlio:
tu questo sei.
Anche tu porti cenere, ulivo e salsedine.
Adesso anche tu vieni da Sud».
Quasi un congedo militare, anche se "i fuoriusciti" e i figli saranno chiamati, allorquando terminerà la fatica di Sisifo dell'eterno rientro - che è quasi un giorno d'attesa biblica - a una guerra civile contro il male del Sud: il fatalismo, il degrado, l'incuria del territorio, la dissoluzione del legame sociale, l'accettazione di un modello predatorio di turismo che rischia di distruggere nel breve periodo le bellezze meridionali. Difficile da argomentare, ma questo testo è un "addio" ed è anche un foglio di chiamate alle armi, e in questa contraddizione c'è tutta la modernità della posizione ineffettuale, e dunque estetizzante, di Mellone, che alla maniera di Pasolini si considera, rispetto al Sud, «con lui e contro di lui». Il suo è un appassionato "addio" al Mezzogiorno del rancore, della malavita, dell'inciviltà, della subcultura televisiva. È però anche un disperato e struggente ricordo di una giovinezza meridionale, al cui centro c'è Taranto, della quale Mellone ricorda le icone (il calciatore Erasmo Jacovone), le tragedie (l'Ilva, la mattanza criminale degli anni '80), gli aspetti più "privati" (la prematura morte del padre, la vendita della casa di famiglia). La narrazione scorre per icone, fotogrammi, eventi: dal delitto di Avetrana al matrimonio di Sofia Coppola, dai nuovi populismi (Vendola, de Magistris) alla camorra, dal caso Claps alla piaga del caporalato, Mellone attraversa e scandaglia con straordinaria velocità, e con alternarsi di registro basso e alto, l'immaginario contemporaneo collettivo del Meridione. Scrive per esempio su Sarah Scazzi: «Prendete tutta questa pornografia dell'incubo d'amore simboleggiata dallo scarto incolmabile tra il viso di Sarah Scazzi e il piercing, ripeto: il piercing, della cugina culona Sabrina Misseri di anni venti e due che forse a Taranto e nemmeno a Lecce sarà mai andata ma a Uomini e donne ha conosciuto il piercing che al padre dovrà essere parso roba da bestie all'aratro e non da esseri umani oggi le borgate di Pasolini sono i paesi del Sud in entroterra come Avetrana, tuguri dischiusi al mondo solo grazie all'antenna parabolica». Pugliese trapiantato a Roma, giornalista, scrittore, ora dirigente Rai, Angelo Mellone fa parte di quella generazione nata nei primi anni ’70 che da un giorno all’altro si sono ritrovati senza luoghi del dibattere e del confronto. Caduti i muri e le cortine, con essi sono crollati anche le sezioni e i partiti, luoghi simbolo del confronto e della sfida dialettica. E per chi aveva qualcosa da dire o da scrivere la strada è improvvisamente diventata ripida e scoscesa. Ma impegno e determinazione premiano sempre e se i luoghi non esistono, chi vuol farcela se li crea. La notorietà raggiunta nella capitale non gli ha fatto dimenticare le origini pugliesi, tarantine per la precisione. Una città che negli ultimi anni è balzata agli onori delle cronache prima per un tremendo dissesto di bilancio, poi per una sconsiderata gestione degli impianti industriali presenti sul territorio. E per dimostrare l’amore a l’attaccamento alla sua terra, Mellone ha ideato e messo in scena due monologhi poetici che andranno a far parte di una trilogia dedicata a Taranto: “Addio al Sud” e “Acciaiomare”. Quest’ultimo in particolare è una lunga requisitoria, (J’accuse!, direbbe Zola) nei confronti di un lembo di terra che oltre ad avergli offerto la vita lo ha costretto troppo presto a fare i conti con la morte. Ma quello scritto e cantato per la città di Taranto rimanendo pur sempre un eroico canto d’amore. «Acciaiomare. Il canto dell’industria che muore» (Marsilio Editore), tributo di amore e rabbia verso la propria terra martoriata. Un racconto impetuoso e rutilante, dedicato ai 500 caduti del siderurgico di Taranto, che diventa anche l’occasione per un reading teatrale che, mescolando parole, musica, immagini e rumori industriali, alza il sipario sull’industria morente del Sud che ha nell’ILVA il suo occhio del ciclone. Con lui sul palco, Raffaella Zappalà, Dj set Andrea Borgnino e Video di Marco Zampetti. Dopo il successo di «Addio al Sud. Un comizio furioso del disamore», Angelo Mellone scrive il secondo capitolo di una trilogia sulla sua terra, sempre nella forma di monologo poetico, di comizio civile e lirico. «AcciaioMare» è, in particolare, un canto funebre e peana d’amore, ma anche requisitoria e arringa al tempo stesso, invettiva ed engagez-vous, per un Sud e per una città (Taranto) al centro di uno dei più grandi casi economico-industriali al mondo. Mellone, in un caleidoscopio di immagini e ricordi, di luoghi e persone, di visioni ed emozioni, «scioglie all’urna un cantico» che ha la rabbia di una rivendicazione e l’amore di un figlio, il respiro della planata e la precisione del colpo secco. Perché "acciaio" a Taranto vuol dire tante, troppe cose, per chi ci vive e per chi da lì proviene. Lo scrittore (anche giornalista e dirigente di Radio Rai) concluderà la sua trilogia nel 2014, ma questo suo secondo lavoro è senz’altro quello più «doloroso»: con queste pagine Mellone si augura, infatti, di risvegliare «un minimo di coscienza» sul dramma del declino industriale italiano, nell’illusione di trasformare il Belpaese in una nazione di terziario avanzato, dimenticando così la Fabbrica e gli operai. Ma ora quei 500 e più eroi e martiri dell’acciaio (tra i quali c’è anche il papà di Mellone) hanno grazie a questo libro il loro "canto corale" e un sentito risarcimento alla loro memoria. Pagine toccanti dedicate soprattutto a suo padre, che Mellone accende di passione e rabbia, laddove racconta «di quando acciaio chiamava mare e su questa costa di Sparta nasceva l’industria della navi d’Impero e dei toraci siderurgici. Voglio raccontarti una storia d’amore. D’amore che muore». Così, che lo scorso mese d’agosto 2013 Mellone prese subito le difese «di un orgoglio siderurgico impacchettato in fretta e furia» per far posto «all’ondata ambientalqualunquista». E trasfromò le sue vacanze in un’indagine del suo passato. C’era una volta un ragazzino che quando a pranzo c’erano fave e cicoria restava digiuno. Sua madre voleva a tutti costi che le mangiasse, altrimenti pancia vuota. Oggi quel ragazzino mangerebbe tutti i giorni a pranzo e a cena il piatto principe della cucina pugliese. Che cosa è cambiato? Del piatto nulla, solo che allora gli era imposto oggi è una libera scelta.
Il vero Sud lo riscopri solo dal finestrino del treno. "Meridione a rotaia". Angelo Mellone conclude la sua trilogia lirica sul Meridione italiano, giungendo anche all’ultima fermata di un viaggio che è un canto appassionato e dolente, ma al tempo stesso un grido di rabbia, per la sua terra. Un ritorno nella propria terra, che è stata abbandonata anni prima con rabbia. Un ritorno a Meridione, compiuto con il mezzo che più associamo al viaggio: il treno. Sui treni sono partiti i primi emigrati meridionali, sulle carrozze di treni locali scassati, regionali in perenne ritardo, Intercity improbabili, l’Autore fa macchina indietro e, da Roma, arriva a Taranto. In mezzo a partenza e arrivo si alternano situazioni grottesche, aneddoti, ricordi, memorie dolorose, persino una pagina dedicata ai fanti meridionali mandati al massacro nella Prima guerra mondiale. Tutte queste pagine, che Mellone ci regala con lo stile consueto delle sue “orazioni civile”, accostano il tema tradizionale del ritorno a quello, nuovo per l’autore, di una riflessione sull’amore, che viaggia a ritroso attraverso due figure femminili e una singolare disquisizione sui tacchi... E dunque, se l’amore è contesto, radici, terra, e «Meridione tiene sempre i piedi per terra», per trovare amore autentico a Sud bisogna tornare. E questo fa, Meridione a rotaia, nelle scorribande tra paesini, locomotori diesel, vagoni stipati di varia umanità, stazioni metropolitane e stazioncine di montagna. Offrendo, alla fine, un affresco di meridionalità divertente, surreale, commuovente. Un tempo si tornava in rotaia per restare, oggi per ripartire. Ma il lento viaggio verso casa porta alle radici e invita a trovare la propria strada, scrive Giuseppe De BellisI treni che vanno a Sud sono diversi. D'aspetto, d'odore, d'umore. Non hanno niente di professionale. Non hanno cravatte e collane di perle. Il professionista che dal Nord sale su un treno verso casa, la vecchia casa del padre, è come Clark Kent che toglie l'abito di Superman. Via il vestito da lavoro nobile, su quello dell'essere umano così com'è. Perché è un viaggio nell'anima, quello che si sta per fare. È incredibile quanto il ritorno a Sud sia ancora nel 2014 legato al treno. Controintuitivo e persino antistorico. Da Milano a Bari ci vogliono più di otto ore, contro un'ora e un quarto d'aereo. Da Roma a Reggio Calabria, sei ore di treno contro le... Eppure chi è del Sud sa che in una conversazione con un altro meridionale arriverà a questo punto. - «Sai che “vado giù?”? Solo sabato e domenica». - «Come, ti fai tutto quel viaggio in treno per stare solo due giorni?». Il viaggio in treno è dato per scontato, perché ancestralmente è ormai sinonimo di trasferimento Nord-Sud. Puoi «salire» come vuoi, ma sembra che tu debba sempre «scendere» in treno. Perché è ricordo, memoria, passato che torna, è emigrazione e immigrazione. Noi terroni siamo legati alla ferrovia anche al di là della nostra volontà. Angelo Mellone lo sa perché appartiene alla categoria: professionista meridionale che per obbligo, passione e capacità è stato costretto a lasciare casa e andare verso Nord. Ha portato la testa e il corpo a Roma, ha mantenuto l'anima a Taranto. È uno degli intellettuali sudisti che meglio ha raccontato in questi ultimi anni la nuova questione meridionale, espressione tanto abusata quanto inevitabile. Lo fa anche ora, con il suo Meridione a rotaia (Marsilio, pagg. 92, euro 10), che chiude quella che lui stesso ha definito «trilogia delle radici». Il treno è il mezzo per tornare e tornando raccontare che cos'è il Sud e soprattutto com'è il rapporto tra quelle radici e chi le ha dovute lasciare superficialmente e poi scopre di avercele comunque attaccate al corpo e allo spirito: «Noi meridionali siamo fatti così. Amiamo la terra che abbiamo abbandonato quando la lasciamo, e la odiamo se ci costringe a restare o ci rende impossibile partire. In questo ha ragione Mario Desiati: la letteratura presuppone sempre una partenza. Un momento di straniamento, un distacco, una mancanza. Nel mio caso un'irrequietezza che è tutto il mio riassunto di meridionale atipico, innamorato di una terra ma distante, antropologicamente, dall'“andare lento” meridionalista. Preferisco viaggiare, consumare suole e bruciare le radici che poi voglio conservare. In questo sentimento pendolare sta il senso di Meridione a rotaia. Che è, a suo modo, un ritorno. Un viaggio a ritroso trasognato, surreale, infelice, virile, spavaldo, intimista, appresso alla memoria, dove si incontrano donne, amici, nemici, loschi figuri, personaggi improbabili, odori, panorami, sfondi e valigie di ricordi». Mellone parte da una casa posticcia di Roma per tornare a Taranto, dove è nato, cresciuto, l'Ilva gli ha tolto il padre, dandogli un dolore che nessuno potrà mai placare, ma nonostante il quale non ha ceduto all'idea che quello stabilimento fosse solo morte e non anche vita per tanta gente. È lì che torna a bordo di questo treno che è reale e onirico allo stesso tempo. Sceglie la formula del poema per rendere magico e però duro questo viaggio. Cita luoghi, paesaggi, facce, pensieri che sono familiari a ciascun meridionale che quel viaggio l'ha fatto davvero o anche con la fantasia. Perché è un dovere tornare, anche quando non si ha voglia. Perché è inevitabile farlo. Un viaggio che non è come gli altri, perché non porta a scoprire nulla che non si sappia già, ma è un modo per trovare la strada. La propria: «Meridione restituisce sempre/ ciò che avevi smarrito...». «Ritorno a Sud allora/ è condizione necessaria/ polvere a polvere, sasso a sasso/ tratturo a tratturo, chianca a chianca/ complanare a complanare, binario a binario specialmente/ al momento in cui il corpo sudato/ in discesa puzza/ e l'alito impasta/ la lingua assetata/ per riacciuffare i brandelli di tutto quello/ che ho abbandonato». È un libro malinconico, come dice Mellone, è l'ammissione della sconfitta di chi ha combattuto se stesso pensando di poter essere meridionale senza fare ritorno al Sud. Ecco, dal Sud non si può scappare, anche quando si emigra: te lo porti dentro esattamente come i settentrionali si portano dentro il Nord. Ciò che contraddistingue le nuove generazioni di fuggiaschi da una terra che non può dare non perché non abbia, ma perché è schiava dei propri vizi, è un orgoglio differente: prima si tornava per rimanere, per dire «ce l'ho fatta, ho combattuto lontano, ho vinto, adesso torno dalla mia amata». Era lo stesso spirito di un soldato mandato al fronte con l'unico obiettivo di riabbracciare una ragazza diventata donna o bambini diventati adolescenti. Ora si torna per ripartire, per tenersi agganciati, emigrati con l'elastico che ti riporta indietro fisicamente o idealmente. La sconfitta di Mellone è in un certo senso una vittoria. Perché ammettere di non riuscire a sganciarsi dalle proprie radici è una forza spacciata per debolezza solo per un gioco di forze che fa leva sulla maledizione della nostalgia. Si perde se si rincorre il Sud come passato, si vince se il Sud è vissuto oggi come consapevolezza di non poterne fare a meno. Accettare di essere comunque terrone a qualunque latitudine. Il treno porta giù, un altro mezzo ti può portare in qualunque altro luogo senza farti dimenticare chi sei e da dove vieni. A chi appartieni? Così si dice al Sud quando ti chiedono chi sia la tua famiglia. È un'espressione meravigliosa: si appartiene a qualcuno, si appartiene anche ai luoghi che vivono dentro di te. «Amore fatto di terra», dice Mellone. «Amore per la terra».
Ciononostante i nordisti, anzichè essere grati al contributo svolto dagli emigrati meridionali per il loro progresso sociale ed economico, dimostrano tutta la loro ingratitudine.
FENOMENOLOGIA RANCOROSA DELL’INGRATITUDINE.
“Ingrati. La sindrome rancorosa del beneficiato”. Libro di Maria Rita Parsi, Mondadori 2011. Cos'è la "sindrome rancorosa del beneficato"? Una forma di ingratitudine? Ben di più. L'eccellenza dell'ingratitudine. Comune, per altro, ai più. Senza che i molti ingrati "beneficati" abbiano la capacità, la forza, la decisionalità interiore, il coraggio e, perfino, l'onestà intellettuale ed etica di prenderne atto. La "sindrome rancorosa del beneficato" è, allora, quel sordo, ingiustificato rancore (il più delle volte covato inconsapevolmente; altre volte, invece, cosciente) che coglie come una autentica malattia chi ha ricevuto un beneficio, poiché tale condizione lo pone in evidente "debito di riconoscenza" nei confronti del suo benefattore. Un beneficio che egli "dovrebbe" spontaneamente riconoscere ma che non riesce, fino in fondo, ad accettare di aver ricevuto. Al punto di arrivare, perfino, a dimenticarlo o a negarlo o a sminuirlo o, addirittura, a trasformarlo in un peso dal quale liberarsi e a trasformare il benefattore stesso in una persona da dimenticare se non, addirittura, da penalizzare e calunniare. Questo nuovo libro di Maria Rita Parsi parla dell'ingratitudine, quella mancanza di riconoscenza che ognuno di noi ha incontrato almeno una volta nella vita. Attraverso una serie di storie esemplari, l'analisi delle tipologie di benefattori e beneficati, il decalogo del buon benefattore e del beneficato riconoscente e un identikit interattivo, l'autrice insegna a riconoscere l'ingratitudine e a difendersene, arginare i danni e usarla addirittura per rafforzarsi.
La culla dell'ingratitudine. Quand’è che proviamo riconoscenza per qualcuno? A prima vista diremmo che la proviamo verso tutti coloro che ci hanno aiutato, ma non è così. Quelli che si amano non la provano, scrive Francesco Alberoni su “Il Giornale”. Quand’è che proviamo riconoscenza per qualcuno? A prima vista diremmo che la proviamo verso tutti coloro che ci hanno aiutato, ma non è così. Quelli che si amano non la provano. Pensate a due innamorati. Ciascuno fa tutto quello che può per l’amato ma nessuno sente un debito di riconoscenza. Chi si ama non tiene una contabilità del dare e dell’avere: i conti sono sempre pari. Solo quando l’amore finisce riappare la contabilità e ciascuno scopre di aver dato più di quanto non abbia ricevuto. Però anche fra innamorati ci sono dei momenti in cui il tuo amato ti dona qualcosa di straordinario, qualcosa che non ti saresti mai aspettato ed allora ti viene voglia di dirgli un «grazie» che è anche riconoscenza. Insomma la riconoscenza nasce dall’inatteso, da un «di più». Perciò la proviamo spesso verso persone con cui non abbiamo nessun rapporto ma che ci fanno del bene spontaneamente. Per esempio a chi si getta in acqua per salvarci rischiando la vita, a chi ci soccorre in un incidente, a chi ci cura quando siamo ammalati. Ma anche a chi ci aiuta a scoprire e a mettere a frutto i nostri talenti nel campo della scienza, dell’arte, della professione per cui, quando siamo arrivati, gli siamo debitori. La riconoscenza è perciò nello stesso tempo un grazie e il riconoscimento dell'eccellenza morale della persona che ci ha aiutato. Quando proviamo questo sentimento, di solito pensiamo che durerà tutta la vita, invece spesso ce ne dimentichiamo. E se quella persona ci ha fatto veramente del bene allora la nostra è ingratitudine. Ma la chiamerei una ingratitudine leggera, perdonabile. Perché purtroppo c’è anche una ingratitudine cattiva, malvagia. Vi sono delle persone che, dopo essere state veramente beneficiate, anziché essere riconoscenti, provano del rancore, dell’odio verso i loro benefattori. Ci sono allievi che diventano i più feroci critici dei loro maestri e dirigenti che, arrivati al potere diffamano proprio chi li ha promossi. Da dove nasce questa ingratitudine cattiva? Dal desiderio sfrenato di eccellere. Costoro pretendono che il loro successo sia esclusivamente merito della propria bravura e si vergognano ad ammettere di essere stati aiutati. Così negano l’evidenza, aggrediscono il loro benefattore. E quanti sono! State attenti: quando sentite qualcuno diffamare qualcun altro, spesso si tratta di invidia o di ingratitudine malvagia. Guardatevi da questo tipo di persone.
QUALCHE PROVERBIO AFORISMO
Amico beneficato, nemico dichiarato.
Avuta la grazia, gabbato lo santo.
Bene per male è carità, male per bene è crudeltà.
Chi non dà a Cristo, dà al fisco.
Chi rende male per bene, non vedrà mai partire da casa sua la sciagura.
Comun servizio ingratitudine rende.
Dispicca l’impiccato, impiccherà poi te.
Fate del bene al villano, dirà che gli fate del male.
Il cane che ho nutrito è quel che mi morde.
Il cuor cattivo rende ingratitudine per beneficio.
Il mondo ricompensa come il caprone che dà cornate al suo padrone.
L’ingratitudine converte in ghiaccio il caldo sangue.
L’ingratitudine è la mano sinistra dell’egoismo.
L’ingratitudine è un’amara radice da cui crescono amari frutti.
L’ingratitudine nuoce anche a chi non è reo.
L’ingratitudine taglia i nervi al beneficio.
Maledetto il ventre che del pan che mangia non si ricorda niente.
Non c’è cosa più triste sulla terra dell’uomo ingrato.
Non far mai bene, non avrai mai male.
Nutri il corvo e ti caverà gli occhi.
Nutri la serpe in seno, ti renderà veleno.
Quando è finito il raccolto dei datteri, ciascuno trova da ridire alla palma.
Render nuovi benefici all’ingratitudine è la virtù di Dio e dei veri uomini grandi.
Tu scherzi col tuo gatto e l’accarezzi, ma so ben io qual fine avran quei vezzi
Val più un piacere da farsi che cento di quelli fatti.
In amore, chi più riceve, ne è seccato: egli prova la noia e l’ingratitudine di tutti i ricchi.
Philippe Gerfaut
L’ingratitudine è sempre una forma di debolezza. Non ho mai visto che uomini eccellenti fossero ingrati.
Johann Wolfgang Goethe, Massime e riflessioni, 1833 (postumo)
Spesso l’ingratitudine è del tutto sproporzionata al beneficio ricevuto.
Karl Kraus, Di notte, 1918
Ci sono assai meno ingrati di quanto si creda, perché ci sono assai meno generosi di quanto si pensi.
Charles de Saint-Evremond, Sugli ingrati, XVII sec.
Il cuore dell’uomo ingrato somiglia alle botti delle Danaidi; per quanto bene tu vi possa versare dentro, rimane sempre vuoto.
Luciano di Samosata, Scritti, II sec.
Un solo ingrato nuoce a tutti gli infelici.
Publilio Siro, Sentenze, I sec. a.c.
Quando di un uomo hai detto che è un ingrato, hai detto tutto il peggio che puoi dire di lui.
Fenomenologia rancorosa dell'ingratitudine. La rabbia dell'ignorare il beneficio ricevuto. Le relazioni d'aiuto contraddistinguono i diversi momenti del ciclo vitale di una persona e ne favoriscono l'autonomia e l'indipendenza. Esiste tuttavia la possibilità che nella sottile dinamica di dipendenza/indipendenza, caratterizzante questo tipo di rapporto, alla gratitudine per un beneficio ricevuto si sostituisca un sentimento d'ingratitudine, di rancore e di rabbia verso il "benefattore". Questo lavoro di Andrea Brundo prende in esame i fenomeni connessi alle relazioni d'aiuto e i processi collegati alla costruzione della personalità nel corso dell'età evolutiva (a partire dall'iniziale rapporto diadico madre-figlio). In base a questa ipotesi, chi prova rancore non ha avuto la possibilità di sperimentare, aggregare ed elaborare contenuti affettivi significativi nelle prime fasi della vita. Ignora, quindi, l'esistenza di autentiche relazioni d'affetto. È incapace di viverle, proprio per la mancanza di informazioni e per la carenza dei relativi schemi cognitivi. Il "rancoroso", pur potendo ammettere l'aiuto ricevuto, non è in grado di essere riconoscente perché ignora i contenuti affettivi che sono dietro la relazione di aiuto. Non potendoli riconoscere in se stesso non li può trovare neanche negli altri. L'incapacità di provare gratitudine è sostenuta da una generale difficoltà a condividere sentimenti e contenuti psichici. Nelle relazioni che instaura, la condivisione non è mediata dalla sfera affettiva, ma dalle prevalenti esigenze dell'io. Chi manca delle informazioni atte a soddisfare le proprie necessità può ricorrere all'aiuto dell'altro che le possiede. Ciò comporta, sul piano relazionale, il riconoscimento dell’autorevolezza e del relativo "potere" di chi dispone le conoscenze. Nel momento in cui si deve predisporre ad accettare le informazioni, il beneficiato, con prevalente modalità narcisistica va incontro ad una serie di difficoltà legate a:
non sapere;
essere in una posizione subordinata di "potere";
fidarsi e considerare giusta l'informazione ricevuta;
disporsi a ridefinire i propri schemi cognitivi e stili comportamentali;
vivere il disagio provocato dal contenuto affettivo associato all'informazione-aiuto.
Nel caso in cui le informazioni risultino troppo complesse rispetto alla rappresentazione della realtà del soggetto, lo sforzo per elaborarle e integrarle nei propri schemi mentali è eccessivo. A questo punto tale soggetto preferisce ricorrere a una modalità più semplice, quale è quella antagonista, e si mette contro la persona che lo sta aiutandolo. E ancora. Quando il divario tra l'immagine di sé (in termini di sistema di credenze, schemi cognitivi, stili comportamentali, ecc.) e le implicazioni di mutamento insite nelle informazioni-aiuto si rivela insostenibile, il beneficiato non può accettare di cambiare e il peso di questa difficoltà viene proiettato sul beneficiante. L'informazione donata e non elaborata rimane a livello dell'io, ristagna e diventa un qualcosa di stantio, di "rancido", di inespresso che risulta insopportabile. Un qualcosa che alimenta un incessante rimuginio, sostenuto anche dalla vergogna e dal senso di colpa. Nasce l'esigenza di eliminare il fastidio e il senso di oppressione, esigenza che conduce all'odio verso la causa (il beneficiante) di tanto "dolore". Si instaura così un circolo vizioso nel pensiero a cui solo gli sfoghi rabbiosi possono dare un minimo, seppur temporaneo, sollievo. Gli eccessi di rabbia costituiscono l'unica soluzione per tentare una comunicazione (impossibile) attraverso la naturale via dell'affettività. Pertanto, il rancore trova un’auto giustificazione in quanto permette di manifestare al mondo e alla persona beneficante contenuti mentali che non trovano altre modalità espressive.
Altra storica menzogna è stata sbugiardata da "Mai più terroni. La fine della questione meridionale" di Pino Aprile. Come abbattere i pregiudizi che rendono il meridione diverso? Come mettere fine a una questione costruita ad arte sulla pelle di una parte d'Italia? La risposta sta anche negli strumenti di comunicazione odierni, capaci di abbattere i confini, veri o fittizi, rompere l'isolamento, superare le carenze infrastrutturali. E se per non essere più "meridionali" bastasse un clic? Con la sua solita vis polemica, Pino Aprile ci apre un mondo per mostrare quanto questo sia vero, potente e dilagante. "Ops... stanno finendo i terroni. Ma come, già? E così, da un momento all'altro?"
Terroni a chi? Tre libri sul pregiudizio antimeridionale. Come è nata e come si è sviluppata la diffidenza verso il Sud. Tre libri ne ricostruiscono le origini e provano a ipotizzarne gli scenari.
"Negli ormai centocinquant'anni di unità italiana il Mezzogiorno non ha mai mancato di creare problemi". D'accordo, la frase è netta e controversa. Sulla questione meridionale, nell'ultimo secolo e mezzo, si sono sprecati fiumi di inchiostro, tonnellate di pagine, migliaia di convegni. In gran parte dedicati all'indagine sociologica, al pregiudizio politico o alla rivendicazione identitaria. Ciò che colpisce allora di "La palla al piede" di Antonino De Francesco (Feltrinelli) è lo sguardo realistico e l'approccio empirico. De Francesco è ordinario di Storia moderna all'Università degli studi di Milano, ma definire il suo ultimo lavoro essenzialmente storico è quantomeno limitativo. In poco meno di duecento pagine, l'autore traccia l'identikit di un pregiudizio, quello antimeridionale appunto, nei suoi aspetti sociali, storici e politici. Lo fa rincorrendo a una considerevole pubblicistica per niente autoreferenziale, che non si ostina nel solito recinto storiografico. Il risultato si avvicina a una controstoria dell'identità italiana e, al tempo stesso, a un'anamnesi dei vizi e dei tic dell'Italia Unita. Ma per raccontare una storia ci si può ovviamente mettere sulle tracce di una tradizione e cercare, attraverso le sue strette maglie, di ricostruire una vicenda che ha il respiro più profondo di una semplice schermaglia localistica. E' quello che accade nel "Libro napoletano dei morti" di Francesco Palmieri (Mondadori). Racconta la Napoli eclettica e umbratile che dall’Unità d'Italia arriva fino alla Prima guerra mondiale. Per narrarla, si fa scudo della voce del poeta napoletano Ferdinando Russo ricostruendo con una certa perizia filologica e una sottile verve narrativa le luci e le smagliature di un'epopea in grado di condizionare la realtà dei giorni nostri. Ha il respiro del pamphlet provocatorio e spiazzante invece l'ultimo libro di Pino Aprile, "Mai più terroni" (Piemme), terzo volume di una trilogia di successo (Terroni e Giù al Sud i titoli degli altri due volumi). Aprile si domanda se oggi abbia ancora senso dividere la realtà sulla base di un fantomatico pregiudizio etnico e geografico che ha la pretesa di tagliare Nord e Sud. E si risponde che no, che in tempi di iperconnessioni reali (e virtuali), quelli stereotipo è irrimediabilmente finito. "Il Sud - scrive - è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se riferito a un altro che lo sovrasta". Nelle nuove realtà virtuali, vecchie direzioni e punti cardinali non esistono più, relegati come sono a un armamentario che sa di vecchio e obsoleto.
D'altronde siamo abituati alle stronzate dette da chi in mala fede parla e le dice a chi, per ignoranza, non può contro ribattere. Cominciamo a dire: da quale pulpito viene la predica. Vediamo in Inghilterra cosa succede. I sudditi inglesi snobbano gli italiani. Ci chiamano mafiosi, ma perché a loro celano la verità. Noi apprendiamo la notizia dal tg2 delle 13.00 del 2 gennaio 2012. Il loro lavoro è dar la caccia ai criminali, ma alcuni ladri non sembrano temerle: le forze di polizia del Regno sono state oggetto di furti per centinaia di migliaia di sterline, addirittura con volanti, manette, cani ed uniformi tutte sparite sotto il naso degli agenti. Dalla lista, emersa in seguito ad una richiesta secondo la legge sulla libertà d'informazione, emerge che la forza di polizia più colpita è stata quella di Manchester, dove il valore totale degli oggetti rubati arriva a quasi 87.000 sterline. Qui i ladri sono riusciti a fuggire con una volante da 10.000 sterline e con una vettura privata da 30.000.
E poi. Cosa sarebbe oggi la Germania se avesse sempre onorato con puntualità il proprio debito pubblico? Si chiede su “Il Giornale” Antonio Salvi, Preside della Facoltà di Economia dell’Università Lum "Jean Monnet". Forse non a tutti è noto, ma il Paese della cancelliera Merkel è stato protagonista di uno dei più grandi, secondo alcuni il più grande, default del secolo scorso, nonostante non passi mese senza che Berlino stigmatizzi il comportamento vizioso di alcuni Stati in materia di conti pubblici. E invece, anche la Germania, la grande e potente Germania, ha qualche peccatuccio che preferisce tenere nascosto.
Polentoni (mangia polenta o come dicono loro po' lentoni, ossia lenti di comprendonio) e terroni (cafoni ignoranti) sono pregiudizi da campagna elettorale inventati ed alimentati da chi, barbaro, dovrebbe mettersi la maschera in faccia e nascondersi e tacere per il ladrocinio perpetrato anche a danno delle stesse loro popolazioni.
Ma si sa parlar male dell'altro, copre le proprie colpe.
Terroni a chi? Tre libri sul pregiudizio antimeridionale. Come è nata e come si è sviluppata la diffidenza verso il Sud. Tre libri ne ricostruiscono le origini e provano a ipotizzarne gli scenari.
"Negli ormai centocinquant'anni di unità italiana il Mezzogiorno non ha mai mancato di creare problemi". D'accordo, la frase è netta e controversa. Sulla questione meridionale, nell'ultimo secolo e mezzo, si sono sprecati fiumi di inchiostro, tonnellate di pagine, migliaia di convegni. In gran parte dedicati all'indagine sociologica, al pregiudizio politico o alla rivendicazione identitaria. Ciò che colpisce allora di "La palla al piede" di Antonino De Francesco (Feltrinelli) è lo sguardo realistico e l'approccio empirico. De Francesco è ordinario di Storia moderna all'Università degli studi di Milano, ma definire il suo ultimo lavoro essenzialmente storico è quantomeno limitativo. In poco meno di duecento pagine, l'autore traccia l'identikit di un pregiudizio, quello antimeridionale appunto, nei suoi aspetti sociali, storici e politici. Lo fa rincorrendo a una considerevole pubblicistica per niente autoreferenziale, che non si ostina nel solito recinto storiografico. Il risultato si avvicina a una controstoria dell'identità italiana e, al tempo stesso, a un'anamnesi dei vizi e dei tic dell'Italia Unita. Ma per raccontare una storia ci si può ovviamente mettere sulle tracce di una tradizione e cercare, attraverso le sue strette maglie, di ricostruire una vicenda che ha il respiro più profondo di una semplice schermaglia localistica. E' quello che accade nel "Libro napoletano dei morti" di Francesco Palmieri (Mondadori). Racconta la Napoli eclettica e umbratile che dall’Unità d'Italia arriva fino alla Prima guerra mondiale. Per narrarla, si fa scudo della voce del poeta napoletano Ferdinando Russo ricostruendo con una certa perizia filologica e una sottile verve narrativa le luci e le smagliature di un'epopea in grado di condizionare la realtà dei giorni nostri. Ha il respiro del pamphlet provocatorio e spiazzante invece l'ultimo libro di Pino Aprile, "Mai più terroni" (Piemme), terzo volume di una trilogia di successo (Terroni e Giù al Sud i titoli degli altri due volumi). Aprile si domanda se oggi abbia ancora senso dividere la realtà sulla base di un fantomatico pregiudizio etnico e geografico che ha la pretesa di tagliare Nord e Sud. E si risponde che no, che in tempi di iperconnessioni reali (e virtuali), quelli stereotipo è irrimediabilmente finito. "Il Sud - scrive - è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se riferito a un altro che lo sovrasta". Nelle nuove realtà virtuali, vecchie direzioni e punti cardinali non esistono più, relegati come sono a un armamentario che sa di vecchio e obsoleto.
Il sud? Una palla al piede? “La palla al piede. Una storia del pregiudizio antimeridionale” è il libro di Antonino De Francesco. Declinata in negativo, è tornata a essere un argomento ricorrente nei discorsi sulla crisi della società italiana. Sprechi di risorse pubbliche, incapacità o corruzione delle classi dirigenti locali, attitudini piagnone delle collettività, forme diffuse di criminalità sono stati spesso evocati per suggerire di cambiare registro nei riguardi del Mezzogiorno. I molti stereotipi e luoghi comuni sono di vecchia data e risalgono agli stessi anni dell'unità, ma quel che conta è la loro radice propriamente politica. Fu infatti la delusione per le difficoltà incontrate nel Mezzogiorno all'indomani dell'unificazione a cancellare presto l'immagine di un Sud autentico vulcano di patriottismo che nel primo Ottocento aveva dominato il movimento risorgimentale. Da allora lo sconforto per una realtà molto diversa da quella immaginata avrebbe finito per fissare e irrobustire un pregiudizio antimeridionale dalle tinte sempre più livide ogni qual volta le vicende dello stato italiano andarono incontro a traumatici momenti di snodo. Il libro rilegge la contrapposizione tra Nord e Sud dal tardo Settecento sino ai giorni nostri. Si capisce così in che modo il pregiudizio antimeridionale abbia costituito una categoria politica alla quale far ricorso non appena l'innalzamento del livello dello scontro politico lo rendesse opportuno. Per il movimento risorgimentale il Mezzogiorno rappresentò sino al 1848 una terra dal forte potenziale rivoluzionario. Successivamente, la tragedia di Pisacane a Sapri e le modalità stesse del crollo delle Due Sicilie trasformarono quel mito in un incubo: le regioni meridionali parvero, agli occhi della nuova Italia, una terra indistintamente arretrata. Nacque così un'Africa in casa, la pesante palla al piede che frenava il resto del paese nel proprio slancio modernizzatore. Nelle accuse si rifletteva una delusione tutta politica, perché il Sud, anziché un vulcano di patriottismo, si era rivelato una polveriera reazionaria. Si recuperarono le immagini del meridionale opportunista e superstizioso, nullafacente e violento, nonché l'idea di una bassa Italia popolata di lazzaroni e briganti (poi divenuti camorristi e mafiosi), comunque arretrata, nei confronti della quale una pur nobile minoranza nulla aveva mai potuto. Lo stereotipo si diffuse rapidamente, anche tramite opere letterarie, giornalistiche, teatrali e cinematografiche, e servì a legittimare vuoi la proposta di una paternalistica presa in carico di una società incapace di governarsi da sé, vuoi la pretesa di liberarsi del fardello di un mondo reputato improduttivo e parassitario. Il libro ripercorre la storia largamente inesplorata della natura politica di un pregiudizio che ha condizionato centocinquant'anni di vita unitaria e che ancora surriscalda il dibattito in Italia. I meridionali sono allegri e di buon cuore ma anche «oziosi, molli e sfibrati dalla corruzione». Sono simpatici e affettuosi, è un altro giudizio sempre sulla gente del Sud, ma pure «cinici, superstiziosi, pronti a rispondere con la protesta di piazza a chi intende disciplinarli». A separare il barone di Montesquieu e Giorgio Bocca, (sono dette da loro queste opinioni sul Mezzogiorno), vi sono circa 250 anni. Eppure nemmeno i secoli contano e fanno la differenza quando si tratta di sputar sentenze sul meridione. Così scrive Mirella Serri su “La Stampa”. Già, proprio così. Credevamo di esser lontani anni luce dall’antimeridionalismo (il suo viaggio nell’Inferno del Sud, Bocca lo dedica alla memoria di Falcone e di Borsellino), pensavamo di essere comprensivi e attenti alle diversità? Macché, utilizziamo gli stessi stereotipi di tantissimi lustri fa: è questa la provocazione lanciata dallo storico Antonino De Francesco in un lungo excursus in cui esamina tutte le dolenti note su "La palla al piede. Una storia del pregiudizio antimeridionale". La nascita dei pregiudizi sul Sud si verifica, per il professore, nel secolo dei Lumi, quando numerosi viaggiatori europei esplorarono i nostri siti più incontaminati e selvaggi. E diedero vita a una serie di luoghi comuni sul carattere dei meridionali che si radicarono dopo l’Unità d’Italia e che hanno continuato a crescere e a progredire fino ai nostri giorni. E non basta. A farsi portavoce e imbonitori di questa antropologia negativa sono stati spesso artisti, scrittori, registi, giornalisti, ovvero quell’intellighentia anche del Sud che l’antimeridionalismo l’avrebbe dovuto combattere accanitamente.
Uno dei primi a intuire questa responsabilità degli intellettuali fu il siciliano Luigi Capuana. Faceva notare a Verga che loro stessi, i maestri veristi, avevano contribuito alla raffigurazione del siculo sanguinario con coltello e lupara facile. E che sulle loro tracce stava prendendo piede il racconto di un Mezzogiorno di fuoco con lande desolate, sparatorie, sgozzamenti, rapine, potenti privi di scrupoli e plebi ignare di ordine e legalità. Ad avvalorare questa narrazione che investiva la parte inferiore dello Stivale dettero il loro apporto anche molti altri autori, da Matilde Serao, che si accaniva sui concittadini partenopei schiavi dell’attrazione fatale per il gioco del lotto, a Salvatore di Giacomo, che dava gran rilievo all’operato della camorra in Assunta Spina. Non fu esente dall’antimeridionalismo nemmeno il grande Eduardo De Filippo che in Napoli milionaria mise in luce il sottomondo della città, fatto di mercato nero, sotterfugio, irregolarità. Anche il cinema neorealista versò il suo obolo antisudista con film come Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, testimonial dei cruenti e insondabili rapporti familiari e sociali dei meridionali. Pietro Germi, ne In nome della legge, e Francesco Rosi, ne Le mani sulla città, vollero denunciare i mali del Sud ma paradossalmente finirono per evidenziare i meriti degli uomini d’onore come agenzia interinale o società onorata nel distribuire ai più indigenti lavori e mezzi di sussistenza, illegali ovviamente. A rendere la Sicilia luogo peculiare del trasformismo politico che contaminerà tutto lo Stivale ci penserà infine il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In generale prevale il ritratto di un Sud antimoderno e clientelare, palla al piede del Nord. Milano, per contrasto, si fregerà dell’etichetta di «capitale morale», condivisa tanto dal meridionalista Salvemini quanto da Camilla Cederna, non proprio simpatizzante del Sud. Quest’ultima, per attaccare il presidente della Repubblica Giovanni Leone, reo di aver fatto lo scaramantico gesto delle corna in pubblico, faceva riferimento alla sua napoletanità, sinonimo di «maleducazione, smania di spaghetti, volgarità». «L’antimeridionalismo con cui ancora oggi la società italiana si confronta non è così diverso da quello del passato», commenta De Francesco. Non c’è dubbio.
Benvenuti al Sud, che di questi antichi ma persistenti pregiudizi ha lanciato la parodia, si è posizionato al quinto posto nella classifica dei maggiori incassi in Italia di tutti i tempi. Come un vigile che si materializza nell’ora di punta o un poliziotto che sopraggiunge nel vivo della rissa. Dopo le polemiche sugli afrori dei napoletani, dopo le dispute sul bidet dei Borbone e sulle fogne dei Savoia, mai libro è arrivato più puntuale. Edito da Feltrinelli, «La palla al piede» di Antonino De Francesco è, infatti, come recita il sottotitolo, «una storia del pregiudizio antimeridionale». E come tale non solo capita a proposito, ma riesce anche a dare ordine a una materia per molti versi infinita e dunque inafferrabile. Cos’è del resto l’antimeridionalismo? «È — spiega l’autore a Marco Demarco su “Il Corriere della Sera” — un giudizio tanto sommario quanto inconcludente, che nulla toglie e molto (purtroppo) aggiunge ai problemi dell’Italia unita, perché favorisce il declino nelle deprecazioni e permette alle rappresentazioni, presto stereotipate, di prendere il sopravvento». Non solo. «Ed è — aggiunge De Francesco — anche un discorso eversivo, perché corre sempre a rimettere in discussione il valore stesso dell’unità italiana». Fin qui la quarta di copertina, ma poi, all’interno, pagina dopo pagina, ecco i testi, le tesi, i personaggi che hanno affollato la scena dello scontro tra meridionalisti e antimeridionali: da Boccaccio a Matilde Serao, da Montesquieu a Prezzolini, passando per Cuoco e Colletta, per Lauro e Compagna, per Mastriani e Totò. Fino a Indro Montanelli, che commentando il milazzismo picchia duro sui siciliani e scrive che «se in Italia si compilasse una geografia dell’abbraccio ci si accorgerebbe che più si procede verso le regioni in cui esso rigogliosamente fiorisce, e più frequente si fa l’uso del coltello e della pistola, della lettera anonima e dell’assegno a vuoto»; o a Camilla Cederna, che addirittura mette in forse la religiosità del presidente Leone: «Tutt’al più — scrive in piena campagna per le dimissioni — il suo è un cristianesimo di folclore...». Materiali preziosi, alcuni noti e altri no, ma tutti riletti all’interno di uno schema molto chiaro. Che è il seguente: negli anni di fuoco a ridosso dell’unità d’Italia, l’antimeridionalismo nasce molto prima del meridionalismo, non ha lasciato testimonianze meritevoli di interesse sotto il profilo culturale, ma, «ha svolto un preciso ruolo normativo nell’immaginario sociale del mondo». Ha creato, cioè, categorie mentali, visioni e schemi interpretativi che hanno condizionato politiche e strategie, alleanze e scelte di campo. In questo senso, l’antimeridionalismo si è rivelato per quello che davvero è: niente altro che uno strumento della lotta politica. L’antimeridionalismo appare e scompare, va e viene, morde e fugge, ma sempre secondo le convenienze del momento storico, del contesto. Così a Masaniello può accadere una volta di assurgere a simbolo del riscatto meridionale e di essere messo sullo stesso asse rivoluzionario che porta fino al ’99, quando del Sud serve l’immagine tutta tesa al riscatto liberatorio; un’altra di precipitare a testimonianza del velleitarismo plebeo, di un ribellismo pari a quello dei briganti, quando del Sud bisogna dare invece l’idea di un mostro da abbattere. Sulla stessa altalena possono salirci anche interi territori, come la Sicilia. Quella pre-garibaldina immaginata dalle camicie rosse è tutto un ribollire di passioni civili e di ansie anti borboniche; quella post-garibaldina descritta dai militari piemontesi è violenta, barbara, incivile. È andata così anche con il Cilento di Pisacane: prima dello sbarco, era la terra promessa del sogno risorgimentale; dopo, la culla del tradimento e del popolo imbelle. Perfino la considerazione della camorra cambia secondo il calcolo politico. Nel 1860 la stampa piemontese, prova ne è «Mondo illustrato», arriva perfino a elogiarla, ritenendola capace di dare organizzazione ai lazzaroni favorevoli al cambio di regime. Ma poi la scena si ribalta. Con Silvio Spaventa comincia l’epurazione del personale sospetto inserito negli apparati statali e la «Gazzetta del Popolo» prontamente plaude. Come strumento della battaglia politica, l’antimeridionalismo non viene usato solo nello scontro tra Cavour e Garibaldi, ma diventa una costante. Liberali e democratici lo usano per giustificare le rispettive sconfitte. E come alibi usano sempre il popolo, che di colpo diventa incolto, superstizioso, asociale, ingovernabile. Ai socialisti succede di peggio. Negli anni del positivismo, arrivano, sulle orme di Lombroso, a cristallizzare il razzismo antimeridionale. Niceforo parla di due razze, la peggiore, la maledetta, è naturalmente quella meridionale; mentre Turati, in polemica con Crispi, vede un Nord tutto proiettato nella modernità e un Sud che è «Medio Evo» e «putrefatta barbarie». Prende forma così quel dualismo culturale che vede ovunque due popoli, uno moderno e l’altro arretrato, dove è chiaro che il secondo, come già ai tempi di Cuoco, giustifica il primo. Ma questo dualismo finisce per mettere in trappola anche la produzione culturale. I veristi, ad esempio, raccontano con passione la vita degli ultimi, della minorità sociale. Ma come vengono lette a Milano queste storie? Chi fa le dovute differenze? Il dubbio prende ad esempio Luigi Capuana quando decide di polemizzare con Franchetti e Sonnino per come hanno descritto la Sicilia. Capuana addebita addirittura a se stesso, a Federico De Roberto e soprattutto all’amico Giovanni Verga, la grave responsabilità di aver favorito, con i loro racconti e con i loro romanzi, la ripresa dei luoghi comuni sull’isola. Credevamo di produrre schiette opere d’arte — scrive avvilito a Verga — «e non abbiamo mai sospettato che la nostra sincera produzione, fraintesa o male interpretata, potesse venire adoperata a ribadire pregiudizi, a fortificare opinioni storte, a provare insomma il contrario di quel che era nostra sola intenzione rappresentare alla fantasia dei lettori». E in effetti, commenta De Francesco, l’opera di Verga, nel corso degli anni Settanta, aveva liquidato l’immagine di una Sicilia esotica e mediterranea a tutto vantaggio della costruzione di potenti quadri di miseria e di atavismo. Il libro si chiude con il caso Bocca, forse il più emblematico degli ultimi anni. Inviato nel Sud sia negli anni Novanta, sia nel 2006. Racconta sempre la stessa Napoli, persa tra clientele, degrado e violenza criminale, ma la prima volta piace alla sinistra; la seconda, invece, la stessa sinistra lo condanna senza appello. La ragione? Prima Bassolino era all’opposizione, poi era diventato sindaco e governatore.
Ed a proposito di Napoli. “Il libro napoletano dei morti” di Francesco Palmieri. Bella assai è Napoli. E non nel senso sciuè sciuè. E’ bella perché sta archiviando una menzogna: quella di essere costretta allo stereotipo e infatti non ha più immondizia per le strade. Non ha più quella patina di pittoresco tanto è vero che il lungomare Caracciolo, chiuso al traffico, è come un ventaglio squadernato innanzi a Partenope. C’è tutto un brulicare di vita nel senso proprio della qualità della vita. Ovunque ci sono vigili urbani, tante sono le vigilesse in bici, sono sempre più pochi quelli che vanno senza casco e quelli che li indossano, i caschi, anche integrali, non hanno l’aria di chi sta per fare una rapina. E’ diventata bella d’improvviso Napoli. Sono uno spasso gli ambulanti abusivi che se ne scappano per ogni dove inseguiti dalla forza pubblica e se qualcuno crede che il merito sia di De Magistris, il sindaco, si sbaglia. Se Napoli è tornata capitale – anche a dispetto di quella persecuzione toponomastica che è la parola “Roma”, messa dappertutto per marchiare a fuoco la sconfitta dell’amato Regno – il motivo è uno solo: Francesco Palmieri ha scritto “Il Libro napoletano dei Morti” e le anime di don Ferdinando Russo e quelle dei difensori di Gaeta hanno preso il sopravvento sui luoghi comuni. Dall'Unità d'Italia alla Prima guerra mondiale, Napoli vive il suo periodo più splendido e più buio. Un'epopea di circa sessant'anni non ancora raccontata e che ne ha segnato il volto attuale. Le vicende avventurose dei capitani stranieri, arrivati per difendere la causa persa dei Borbone, s'intrecciano con quelle di camorristi celebri e dei loro oscuri rapporti con il nuovo Stato italiano. L'ex capitale si avvia verso il Novecento tra contraddizioni storiche e sociali risolte nel sangue o in un paradossale risveglio culturale. Ma, quando calerà il sipario sul drammatico processo Cuocolo, un clamoroso assassinio in Galleria rivelerà che la camorra non è stata sconfitta. E il "prequel" della futura Gomorra. Narratore dell'intera vicenda è il poeta Ferdinando Russo. Celebre un tempo e amato dalle donne, da giornalista ha coraggiosamente denunciato la malavita ma è stato attratto dai codici antichi di coraggio della guapparia. Russo cerca il fil rouge che collega i racconti dei cantastorie napoletani alla tragica fine dei capitani borbonici: questo nesso lo ritrova nell'ineffabile enigma della Sirena Partenope, la Nera, l'anima stessa di Napoli, che si rivela nel coltello dei camorristi o irretisce incarnata in quelle sciantose di cui fu vittima egli stesso, prima con un grande amore perso poi sposando un'altra che invece non amò.
“Il libro napoletano dei morti” è un viaggio alle radici di Gomorra, scrive Luca Negri su “L’Occidentale”. Esiste un antico Libro egiziano dei morti, anche uno tibetano. In poche parole, si tratta di affascinanti manuali di sopravvivenza per l’anima nei regni dell’oltretomba. La versione italica, universalmente nota per l’altissimo valore poetico, è la Commedia di Dante. Commedia appunto perché il finale è lieto: l’anima non si perde negli inferi, fra demoni, ma ascende a Dio, come pressappoco succede nelle versioni egizia e tibetana. Ora il lettore italiano ha a disposizione anche “Il libro napoletano dei morti” (Mondadori, nella collana Strade Blu), che non è un manuale per cittadini partenopei ed italiani prossimi alla fine. O forse sì, lo è. Soprattutto se consideriamo la città sotto il Vesuvio come paradigmatica dei nodi irrisolti della nostra esausta storia patria. Comunque, è un romanzo, un grande romanzo, il migliore uscito quest’anno, a nostro giudizio. Per lo stile felicissimo che combina momenti lirici, squarci storici, immagini cinematografiche. E poi riesce a toccare temi universali, partendo da un luogo e da un tempo ben precisi: Napoli negli anni che corrono dalla conquista garibaldina all’avvento del fascismo.
L’autore si chiama Francesco Palmieri, è un maestro di Kung Fu napoletano che nella vita fa il giornalista e si occupa di economia e Cina. Uno che conosce bene misteri d’oriente, vicende e canzoni della sua città e come va la vita. Per raccontare il suo libro dei morti, Palmieri è entrato nell’esistenza e nella lingua di Ferdinando Russo, poeta, giornalista, romanziere e paroliere di canzoni (la più nota è “Scetate”) nato ovviamente a Napoli nel 1866 e morto nel 1927. Russo era amico di d’Annunzio, firma di punta del quotidiano il Mattino, partenopeo verace che detestava la napoletanità di maniera delle commedie di Eduardo Scarpetta e nelle cantate di Funiculì funicolà. Per lui, come per l’amico-nemico Libero Bovio (autore di “Reginella”), le canzoni con il mandolino rappresentavano il Romanticismo esploso a Napoli con cinquant’anni di ritardo sul resto d’Europa, non roba da cartolina. Russo era una persona seria ed onorata, un guappo, cultore di Giordano Bruno e conoscitore di molti camorristi ma sempre spregiatore della camorra. E con i suoi occhi e le sue parole vere e immaginarie, in versi e prosa, Palmieri ci racconta proprio la degenerazione della camorra: dalla confraternita fondata e regolata nel 1842 nella Chiesa di Santa Caterina a Formello, figlia di “semi spagnoli e nere favole mediterranee” alle spietate bande di “malavitosi senza norma e senza morale”. Al guappo armato solo di scudiscio e coltello, talvolta della sola minacciosa presenza, si sostituiscono “facce patibolari” bramose di soldi e potere, vigliacche al punto da imbracciare solo armi da fuoco, che male modellano le mani di chi le usa. Russo, fin da bambino, si ispirava al teatrino dei Pupi, si sentiva un paladino, un Rinaldo sempre in lotta contro il male: il traditore Gano di Magonza. E vide gli antichi paladini reincarnati negli stranieri che combatterono per la causa persa dei Borbone contro i Piemontesi invasori. Non solo per il piacere di “tirare una sassata sulla faccia di liberali biondi”, ma per difendere “più che un principe, un principio”. Franceschiello diventava un novello Carlo Magno, sconfitto, però da un’imponente macchina bellica che nemmeno schifava il fomentare odi e delazioni e l’ammazzare cristiani appena sospettati di simpatia per l’insorgenza, per i “briganti”. A proposito, Palmieri e Russo ci ricordano che lo Stato risorgimentale si servì proprio della camorra per garantire l’ordine nel regno conquistato ed assicurarsi il successo nel plebiscito del 1860. Il processo di corruzione dell’”Onorata Società” ben s’accompagnò a quello del neonato Regno d’Italia; anzi, i rapporti si fecero sempre più stretti, i fili più inestricabili, al di là di tutte le repressioni di facciata e della professione retorica di antimafia. Sconfitti zuavi e lealisti, non rimarrà che cercare la “presenza dei paladini nelle notti scugnizze”, fra i guappi non ancora degenerati in spietati assassini ed avidi imprenditori senza scrupoli e freni. Ma è sempre più difficile, la cavalleria scompare, i proiettili uccidono anche gli innocenti. La camorra, circondata da una nazione irrisolta e corrotta, svela il suo volto, la sua dipendenza dal “perenne problema demoniaco” legato alla doppia natura della Sirena Partenope che come vuole la tradizione giace sotto Napoli; creatura bellissima e mostruosa “che fu madre di quei pezzenti tarantati, di cantanti e sciantose, di camorristi” e poeti come Russo. Siamo allora sull’orlo del baratro, sotto il vulcano, a Gomorra, come epicentro delle tensioni italiche. E allora serve più che mai “una mano capace di trasformare qualsiasi cosa in Durlindana”, in spada da paladino. Con la consapevolezza evangelica che fare il crociato, “crociarsi”, significa saper portare la propria croce. Ed aiutare i propri simili in questo “strabiliante Purgatorio umano che ci avvampa tra merda e sentimenti”.
"Mai più terroni. La fine della questione meridionale" di Pino Aprile. Come abbattere i pregiudizi che rendono il meridione diverso? Come mettere fine a una questione costruita ad arte sulla pelle di una parte d'Italia? La risposta sta anche negli strumenti di comunicazione odierni, capaci di abbattere i confini, veri o fittizi, rompere l'isolamento, superare le carenze infrastrutturali. E se per non essere più "meridionali" bastasse un clic? Con la sua solita vis polemica, Pino Aprile ci apre un mondo per mostrare quanto questo sia vero, potente e dilagante. "Ops... stanno finendo i terroni. Ma come, già? E così, da un momento all'altro?" Così Pino Aprile inizia, nel modo provocatorio che gli è congeniale, questo suo pamphlet, che affronta l'annosa e scontata Questione meridionale da un'angolatura completamente diversa. In un mondo che sta cambiando a incredibile velocità, ha ancora senso definire la realtà in base a criteri geografici, come quelli di Nord e Sud, che nell'interpretazione dei più portano con sé una connotazione meritocratica ormai superata? E possibile utilizzare ancora definizioni di questo tipo quando internet, la Rete, sta tracciando una mappa che non tiene più conto dei vecchi confini, anzi se ne è liberata per ridisegnare uno spazio davvero globale, senza Sud e senza Nord, di cui fa parte la nuova generazione, tutta, figli dei "terroni" compresi? No, dice Aprile, tutto questo è irrimediabilmente finito, passato, travolto dal vento delle nuove tecnologie che, spinto da molte volontà, sta creando un futuro comune, un futuro che unisce, invece di dividere. Forse i padri non se ne sono ancora accorti, ma i figli sì, lo sanno, così come sanno che quella che hanno imboccato è una strada di non ritorno. "Il Sud è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se riferito a un altro che lo sovrasta." Ma nello spazio virtuale, lo spazio dei giovani di tutti i paesi, le direzioni non esistono più. Boom di vendite, dice Antonino Cangemi su “Sicilia Informazioni”. E’ quasi una regola: ogni libro di Pino Aprile scatena un boom di vendite e un mare di polemiche.
Così è accaduto con “Terroni” e con “Giù al Sud”. Nel primo il giornalista raccontava, all’anniversario del secolo e mezzo dell’Unità d’Italia, stragi, violenze, saccheggi, sottaciuti dalla storiografia ufficiale, commessi dal Settentrione contro il Meridione per accentuarne la subalternità, provocando le ire dei “nordisti” e le perplessità della maggior parte degli storici accademici. Nel secondo il meridionalista Aprile ribadiva le denunce contro i soprusi subiti dal Sud Italia, ma nello stesso tempo individuava nel Meridione le risorse migliori per “salvare l’Italia”. Nelle librerie “Mai più terroni”, un pamphlet edito da Piemme che già dal sottotitolo, “La fine della questione meridionale”, preannuncia dibattiti accesi.
Molti si chiederanno: come mai Pino Aprile paladino delle ragioni dei “terroni”, che non ha esitato a denunciare, in modo eclatante, i torti subiti dalla gente del Sud per opera di governi filosettentrionali, adesso cambia registro sino a sostenere che la questione meridionale non esiste più? Che cosa è successo nel giro di pochi anni? Lo si scopre leggendo l’agile saggio. Che sostiene una teoria piuttosto originale. E, secondo alcuni, azzardata. Nell’era industriale la distanza tra Nord e Sud si accentuava perché rilevava la posizione geografica dei luoghi dove si produceva ricchezza. Poiché le fabbriche, o la stragrande maggioranza di esse, si trovavano nel Settentrione, i meridionali erano costretti a spostarsi per lavorare e, con l’emigrazione, a vivere in un rapporto di sudditanza. Tutto è ora cambiato con l’avvento di internet. Nella stagione che si è da ultimo avviata, definita da Aprile l’era del Web, la geografia dei territori non assume più rilievo. La rete ha annullato le distanze geografiche, e non importano più dove sono collocate le imprese, la condizione delle sovrastrutture, se le autostrade o le ferrovie funzionano nel Nord e sono dissestate nel Meridione, tanto non occorre percorrerle grazie alla magia telematica. Almeno per i giovani, che a colpi di clic possono cambiare la realtà, dare sfogo al proprio estro creativo, inventare nuove fonti di ricchezza. Non a caso, sostiene l’autore, oggi l’omologazione del web ha fatto sì che tanta ricchezza sia concentrata in Paesi del Sud del mondo, quali ad esempio la Cina e l’India. D’altra parte, secondo Aprile “il Sud è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se riferito a un altro che lo sovrasta”. Non vi sarà perciò più Sud e non vi saranno più “terroni” per effetto della rete che permette di viaggiare restando seduti e di superare ogni barriera geografica. Niente più sopraffazioni e prevaricazioni. Alla fine la spunta, nella competizione democratica del web, chi è più creativo. Ipse dixit Aprile. E’ proprio cosi, o le sue analisi peccano di superficialità? La discussione è aperta. Da "Terroni" a "Mai più terroni", spiega Lino Patruno su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Dal sottotitolo del primo libro («Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali») al sottotitolo di questo («La fine della questione meridionale»). È l’itinerario di Pino Aprile: dalla denuncia di 150 anni ai danni del Sud, alla profezia che fra poco il Sud non sarà più Sud e che gli italiani del Sud non saranno più figli di una patria minore. Ci si chiede cosa sia successo in due soli anni. E come il giornalista-scrittore pugliese dai libri tanto vendutissimi quanto contestatissimi possa passare dalla rabbia per le verità nascoste sulla conquista del Sud, alla convinzione che nonostante tutto il Sud è entrato nella nuova era della parità di condizioni di partenza. Esagerazione ora o prima?La risposta è nelle stesse parole di Aprile: «Per condannare i meridionali a uno stato di minorità civile ed economica, sono state necessarie prima le armi e i massacri, poi è bastato isolarli. Ma il web è viaggiare senza percorrere spazi: scompare, così, lo svantaggio di ferrovie mai fatte e treni soppressi, di autostrade e aeroporti mancanti. Il Sud è, da un momento all’altro, alla pari. E può prendere il largo, su quella pista, perché per la prima volta, dopo 150 anni, è nelle stesse condizioni dei concorrenti». Dire web è dire Internet. Che annulla le distanze: tu puoi stare in un qualsiasi posto del mondo e lavorare per qualsiasi altro posto del mondo. E con Internet vale il tuo talento davanti al computer e basta, anche se stai, chessò, a Matera, unica città italiana senza il treno delle Ferrovie dello Stato. In questo senso Internet annulla anche le differenze di opportunità fra i territori. Con un computer un cittadino in Bangladesh ha le stesse possibilità di lavoro di un cittadino degli Stati Uniti. Così Internet può cancellare anche l’attuale svantaggio del Sud, la sua perifericità geografica: che lo Stato in 150 anni ha accentuato invece di ridurla.
Come? Creando un divario nelle infrastrutture fra Centro Nord e Sud che supera 1140 per cento. E non solo infrastrutture materiali (dalle autostrade agli aeroporti, appunto), ma anche immateriali (ricerca, formazione, sicurezza) e sociali (scuole, ospedali, assistenza). Ecco perché il terrone per la prima volta in 150 anni potrà cessare di emigrare. Facendo da casa ciò che finora può fare soltanto andando via. E dimostrandosi, se lo è, bravo quanto un privilegiato italiano del Centro Nord che finora ha avuto più possibilità di lui perché la produzione di oggetti e il lavoro crescono dove ci sono più mezzi a disposizione: a cominciare dalle infrastrutture. Il «capitale sociale», beni pubblici alla base di qualsiasi sviluppo. Aprile ci ha abituato allo sguardo lungo. Dopo quello all’indietro sulle bugie storiche verso il Sud, ecco ora quello immaginifico su un futuro possibile a favore del Sud. Col superamento di un ritardo tanto tenace e mortificante quanto mai affrontato con leggi e mezzi necessari. E col sospetto che si fingesse di cambiare qualcosa per lasciare tutto come prima. In poche parole: la ricchezza di una parte del Paese basata sulla minore ricchezza dell’altra. Con Internet oggi si fanno la metà dei lavori del mondo. E se finora il vantaggio del Nord era sfornare merci, ora il vantaggio del Sud è poter sfornare idee. E di idee i giovani terroni scoppiano: ecco la grande occasione comunicata con la perentorietà della rivelazione. Ovvio che non tutto spunti per magia: anche i computer sono meno al Sud, e non c’è in Italia quella banda larga che li faccia funzionare da computer e non da catorci. Ma la forza evocativa, la visione di Aprile è contagiosa e irresistibile anche quando suona più controversa e forse (stavolta) troppo ottimistica. Ma col pessimismo non si fa nulla. E poi leggiamo questa sua sorta di libro-testamento: ci sono racconti su ciò che fanno i giovani sudisti proiettati nel domani tecnologico da convincere che il futuro d’Italia è proprio qui. Cose entusiasmanti che nessuno avrebbe potuto immaginare (soprattutto in Puglia), meno che mai chi non guarda, sentenzia. Come nessuno avrebbe potuto immaginare, conclude Aprile, che ciò che non è riuscito ai padri, può riuscire ai figli. Cosicché presto sarà solo un ricordo che per un secolo e mezzo fummo terroni. “Giù al Sud. Perché i terroni salveranno l’Italia” di Pino Aprile è il racconto di un’Italia ancora spaccata in due, di rancori non sopiti, di ferite non rimarginate, dove i ricordi di un passato di sudditanza e soprusi non sono stati cancellati. Ma è anche la storia di nuove generazioni, colte ed intraprendenti, che fanno ribaltare atavici pregiudizi. Già autore di "Terroni", l’autore conosce bene la Storia e si è documentato con serietà e rigore prima di stendere denunce e dare aggiornamenti sulle nuove risorse. In questo viaggio giù al sud si incontrano realtà inattese, che stimolano e inorgogliscono. Il libro può essere letto per capitoli separati, ognuno spunto di riflessione. Lucida ed interessante l’analisi della nuova generazione di trentenni meridionali, colti, scaltri e fantasiosi, affamati di storia, di ricostruzione dell’identità meridionale, avvertita come risorsa economica e personale. Esenti da quel senso di inferiorità che spesso ha frenato e ancora frena i loro padri, si sentono e sono cittadini del mondo, un mondo in cui si muovono sicuri. Forte è l’interesse per l’antropologia in Calabria: è una necessità di sapere di sé, è un “bisogno di passato”, di recupero di un terreno perduto.
Come l’Odisseo omerico, il cui futuro è nella sua radice: ha già fatto il viaggio e ora torna a casa, per essere completo. Hanno desiderio e capacità di riscatto, usano i problemi come risorse, hanno idee, e le portano avanti con creatività e fiducia. Sono interessati alla riscoperta di nomi e bellezze, di luoghi e di cose, dalla toponomastica all’agricoltura, alla produzione di olii, vini, pani; forte l’orgoglio e il senso di appartenenza, per una terra “ritrovata”, per la forza fisica e morale delle sue donne, per la musica che si miscela alla poesia di antichi testi grecanici, che i giovani studiano e tramandano. In questo viaggio si incontra la Murgia, “giardino di ulivi, ricamo di vigne, regione di orgoglio” grazie alla tenacia dei suoi abitanti, che dalla sterile roccia hanno fatto emergere terra grassa e feconda. E poi la Puglia, dove “un deserto si è fatto un orto” a prezzo di un lavoro disumano. Benessere e convivenza anche a Riace, altra tappa di questo percorso, dove nel convivere e condividere di Calabresi ed extra-comunitari integrati, o di passaggio, si evidenzia un forte senso di ospitalità e umanità, e così a Sovereto, luogo di accoglienza per stranieri e tossicodipendenti, luogo di rinascita fisica e morale. Esaltanti le tante storie di giovani coraggiosi, ricchi di ingegno ed iniziative, che restano nella loro terra, rendendola migliore. Di contro, altri emigrati sembrano voler prendere le distanze dai luoghi natii, rinnegando le proprie origini, disprezzando ciò che si è perso e sopravalutando ciò che si è acquisito, in una sorta di “amputazione della memoria”.
La minorità del Calabrese è atavica, è un senso di inferiorità non scalfito dal tempo. Le privazioni subite, l’espoliazione delle antiche ricchezze, hanno costruito ed alimentato la minorità meridionale.
Ma bisogna reagire, esorta l’autore, cercando la solidarietà e l’appoggio di tutti al Nord, perché tutti sappiano, perché si raggiunga un equilibrio perduto. I testi di Pino Aprile sono il tentativo di un riscatto storico, quello di un’Italia che 160 anni fa aveva una propria identità di stato e che dopo l’Unità l’ha persa, col dominio del Nord sul Sud; sono un’esortazione, soprattutto per i giovani, al recupero di questa identità. Questo testo è una guida, ricca, aggiornata, colta, che va al di là ed oltre i luoghi e la Storia, è un compendio di storie personali e familiari, che si intersecano col territorio, sino a trasformarlo, ad arricchirlo, a renderlo appetibile. Le pagine più belle sono quelle descrittive, in cui i luoghi fisici si trasformano in luoghi dell’anima; Vieste e il suo faraglione, la cui sommità uno stilita rubava ad un gabbiano; Aliano, in Lucania, nella valle dell’Agri, “fra due marce muraglie di terra lebbrosa, tagliata dal fiume e dai suoi affluenti, disciolta dalla pioggia, butterata dal sole, che asciuga e svuota gli alveoli di creta.” … e la loro struggente bellezza si fonde nella malinconia dell’abbandono, mentre l’animo si perde nel sublime di fronte ai calanchi “orridi, belli e paurosi”. La presenza di elementi naturali, come il mare, il vento e l’energia che da essi si crea, conferisce forza e pathos ai movimenti dell’uomo sulla terra, rendendo le vicende umane grandiose. Lo sguardo dell’autore ha il privilegio della lontananza, che consente una visione d’insieme, quindi più completa e reale. Le sue parole trasudano orgoglio di appartenenza, ampiezza di orizzonti, fisici e mentali. Sono arrivato alla fine del libro, ma non sono riuscito a trovare una risposta alla domanda che mi ero fatta leggendo il sottotitolo del libro: perché i terroni dovrebbero salvare l'Italia? Così commenta Rocco Biondi. Non vedo un motivo plausibile che dovrebbe spingere i meridionali, che per 150 anni sono stati annientati dalla cultura e dall'economia nordista, ad avere un qualsiasi interesse ad impegnarsi in un qualche modo per risollevare le sorti dell'Italia cosiddetta unita. Questa convinzione mi proviene dall'attenta lettura fatta a suo tempo di "Terroni" ed ora di "Giù al Sud". I due libri di Pino Aprile sono accomunati dal riuscito tentativo di indicare possibili strade di "guerriglia culturale" per far uscire i meridionali dalla minorità cui sono stati condannati dagli artefici della malefica unità. La strada maestra è stata ed è la ricerca della "propria storia denigrata e taciuta". E questa fame di storia è avvertita come risorsa economica e personale. Si cercano i documenti, si scrive l'altra storia, quella della stragrande maggioranza degli abitanti del Sud che dopo il 1860 si sono opposti alla invasione piemontese. Si scoprono i nostri padri briganti, che hanno lottato e sono morti per la loro terra, le loro famiglie, la loro patria. Si dà vita a progetti artistici che hanno come protagonista il proprio passato, del quale non ci si vergogna più. Per andare avanti bisogna ripartire da quel che eravamo e da quel che sapevamo. I nostri antenati subirono e si auto-imposero la cancellazione forzosa della verità storica. Bisogna riscoprirla questa verità se vogliamo diventare quello che meritiamo di essere. Nel Sud i guai arrivarono con l'Unità. Le tasse divennero feroci per «tenere in piedi la bilancia dei pagamenti del nuovo Stato e concorsero a finanziare l'espansione delle infrastrutture nel Nord».A danno del Sud, dove le infrastrutture esistenti vennero smantellate. Messina, perno commerciale dell'intera area dello Stretto, perse il privilegio di porto franco, con scomparsa di molte migliaia di posti di lavoro. La Calabria, che oggi appare vuota e arretrata, era partecipe di fermenti e traffici della parte più avanzata d'Europa. In Calabria si producevano bergamotto, seta, gelsomino, lavanda, agrumi, olio, liquirizia, zucchero di canna. Per favorire l'industria del Nord si provocò il crollo dell'agricoltura specializzata del Sud, chiudendo i suoi mercati che esportavano oltralpe. Scrive Pino Aprile: «L'Italia non è solo elmi cornuti a Pontida, pernacchie padane e bunga bunga».L'Italia è anche la somma di tantissime singolarità positive esistenti nel Sud. E il suo libro è la narrazione, quasi resoconto, degli incontri avuti con queste realtà nei suoi viaggi durati tre anni dopo l'uscita di "Terroni". Pino Aprile si chiede ancora: «Perché la classe dirigente del Sud non risolve il problema del Sud, visto che il Nord non ha interesse a farlo?». E risponde: perché la classe dirigente nazionale è quasi tutta settentrionale, perché il Parlamento è a trazione nordica, perché le banche sono tutte settentrionali o centrosettentrionali, perché l'editoria nazionale è quasi esclusivamente del Nord, perché la grande industria è tutta al Nord e solo il 7,5 per cento della piccola e media industria è meridionale. E allora che fare? «Finché resterà la condizione subordinata del Sud al Nord - scrive Pino Aprile -, la classe dirigente del Sud avrà ruoli generalmente subordinati. Quindi non "risolverà", perché dovrebbe distruggere la fonte da cui viene il suo potere delegato. Si può fare; ma si chiama rivoluzione o qualcosa che le somiglia. E può essere un grande, pacifico momento di acquisizione di consapevolezza, maturità. Succede, volendo».E non ci si può limitare alla denuncia, bisogna lasciarsi coinvolgere direttamente e personalmente, per governare questi fenomeni.
Negli Stati Uniti d'America i persecutori hanno saputo pacificarsi con le loro vittime indiane, riconoscendo il loro sacrificio ed onorandole. In Italia questo non è ancora avvenuto, gli invasori piemontesi non hanno ancora riconosciuto le motivazioni della rivolta contadina e dei briganti. Noi meridionali dobbiamo pretendere questo riconoscimento. Noi meridionali l'unità l'abbiamo subita, non vi è stata un'adesione consapevole. Nei fatti essa unità è consistita nel progressivo ampliamento del Piemonte, con l'applicazione forzata delle sue leggi, strutture, tasse e burocrazia. Il Sud, ridotto a colonia, doveva smettere di produrre merci, per consumare quelle del Nord: da concorrente, a cliente. Non è vero che la mafia esiste solo al Sud. Milano è la principale base operativa per 'ndrangheta e mafia siciliana, dove si trasforma il potere criminale in potere economico, finanziario, politico. Stiamo per uscire dalla minorità, dopo un sonno di un secolo e mezzo, il Sud sembra aprire gli occhi. Lo sconfitto smette di vergognarsi di aver perso e recupera il rispetto per la propria storia. L'interesse primario dei meridionali non deve essere quello di salvare l'Italia, ma quello di valorizzare se stessi. Solo indirettamente e conseguentemente, forse, potrà avvenire il salvataggio dell'Italia intera.
SE NASCI IN ITALIA…
Quando si nasce nel posto sbagliato e si continua a far finta di niente.
Steve Jobs è cresciuto a Mountain View, nella contea di Santa Clara, in California. Qui, con il suo amico Steve Wozniak, fonda la Apple Computer, il primo aprile del 1976. Per finanziarsi, Jobs vende il suo pulmino Volkswagen, e Wozniak la propria calcolatrice. La prima sede della nuova società fu il garage dei genitori: qui lavorarono al loro primo computer, l’Apple I. Ne vendono qualcuno, sulla carta, solo sulla base dell’idea, ai membri dell’Homebrew Computer Club. Con l’impegno d’acquisto, ottengono credito dai fornitori e assemblano i computer, che consegnano in tempo. Successivamente portano l’idea ad un industriale, Mike Markkula, che versa, senza garanzie, nelle casse della società la somma di 250.000 dollari, ottenendo in cambio un terzo di Apple. Con quei soldi Jobs e Wozniak lanciano il prodotto. Le vendite toccano il milione di dollari. Quattro anni dopo, la Apple si quota in Borsa.
Io sono Antonio Giangrande, noto autore di saggi pubblicati su Amazon, che raccontano questa Italia alla rovescia. A tal fine tra le tante opere da me scritte vi è “Italiopolitania. Italiopoli degli italioti”. Di questo, sicuramente, non gliene fregherà niente a nessuno. Fatto sta che io non faccio la cronaca, ma di essa faccio storia, perché la quotidianità la faccio raccontare ai testimoni del loro tempo. Certo che anche di questo non gliene può fregar di meno a tutti. Ma una storiella raccontata da Antonio Menna che spiega perché, tu italiano, devi darti alla fuga dall’Italia, bisogna proprio leggerla. Mettiamo che Steve Jobs sia nato in Italia. Si chiama Stefano Lavori. Non va all’università, è uno smanettone. Ha un amico che si chiama Stefano Vozzini. Sono due appassionati di tecnologia, qualcuno li chiama ricchioni perchè stanno sempre insieme. I due hanno una idea. Un computer innovativo. Ma non hanno i soldi per comprare i pezzi e assemblarlo. Si mettono nel garage e pensano a come fare. Stefano Lavori dice: proviamo a venderli senza averli ancora prodotti. Con quegli ordini compriamo i pezzi. Mettono un annuncio, attaccano i volantini, cercano acquirenti. Nessuno si fa vivo. Bussano alle imprese: “volete sperimentare un nuovo computer?”. Qualcuno è interessato: “portamelo, ti pago a novanta giorni”. “Veramente non ce l’abbiamo ancora, avremmo bisogno di un vostro ordine scritto”. Gli fanno un ordine su carta non intestata. Non si può mai sapere. Con quell’ordine, i due vanno a comprare i pezzi, voglio darli come garanzia per avere credito. I negozianti li buttano fuori. “Senza soldi non si cantano messe”. Che fare? Vendiamoci il motorino. Con quei soldi riescono ad assemblare il primo computer, fanno una sola consegna, guadagnano qualcosa. Ne fanno un altro. La cosa sembra andare. Ma per decollare ci vuole un capitale maggiore. “Chiediamo un prestito”. Vanno in banca. “Mandatemi i vostri genitori, non facciamo credito a chi non ha niente”, gli dice il direttore della filiale. I due tornano nel garage. Come fare? Mentre ci pensano bussano alla porta. Sono i vigili urbani. “Ci hanno detto che qui state facendo un’attività commerciale. Possiamo vedere i documenti?”. “Che documenti? Stiamo solo sperimentando”. “Ci risulta che avete venduto dei computer”. I vigili sono stati chiamati da un negozio che sta di fronte. I ragazzi non hanno documenti, il garage non è a norma, non c’è impianto elettrico salvavita, non ci sono bagni, l’attività non ha partita Iva. Il verbale è salato. Ma se tirano fuori qualche soldo di mazzetta, si appara tutto. Gli danno il primo guadagno e apparano. Ma il giorno dopo arriva la Finanza. Devono apparare pure la Finanza. E poi l’ispettorato del Lavoro. E l’ufficio Igiene. Il gruzzolo iniziale è volato via. Se ne sono andati i primi guadagni. Intanto l’idea sta lì. I primi acquirenti chiamano entusiasti, il computer va alla grande. Bisogna farne altri, a qualunque costo. Ma dove prendere i soldi? Ci sono i fondi europei, gli incentivi all’autoimpresa. C’è un commercialista che sa fare benissimo queste pratiche. “State a posto, avete una idea bellissima. Sicuro possiamo avere un finanziamento a fondo perduto almeno di 100mila euro”. I due ragazzi pensano che è fatta. “Ma i soldi vi arrivano a rendicontazione, dovete prima sostenere le spese. Attrezzate il laboratorio, partire con le attività, e poi avrete i rimborsi. E comunque solo per fare la domanda dobbiamo aprire la partita Iva, registrare lo statuto dal notaio, aprire le posizioni previdenziali, aprire una pratica dal fiscalista, i libri contabili da vidimare, un conto corrente bancario, che a voi non aprono, lo dovete intestare a un vostro genitore. Mettetelo in società con voi. Poi qualcosa per la pratica, il mio onorario. E poi ci vuole qualcosa di soldi per oliare il meccanismo alla regione. C’è un amico a cui dobbiamo fare un regalo sennò il finanziamento ve lo scordate”. “Ma noi questi soldi non ce li abbiamo”. “Nemmeno qualcosa per la pratica? E dove vi avviate?”. I due ragazzi decidono di chiedere aiuto ai genitori. Vendono l’altro motorino, una collezione di fumetti. Mettono insieme qualcosa. Fanno i documenti, hanno partita iva, posizione Inps, libri contabili, conto corrente bancario. Sono una società. Hanno costi fissi. Il commercialista da pagare. La sede sociale è nel garage, non è a norma, se arrivano di nuovo i vigili, o la finanza, o l’Inps, o l’ispettorato del lavoro, o l’ufficio tecnico del Comune, o i vigili sanitari, sono altri soldi. Evitano di mettere l’insegna fuori della porta per non dare nell’occhio. All’interno del garage lavorano duro: assemblano i computer con pezzi di fortuna, un po’ comprati usati un po’ a credito. Fanno dieci computer nuovi, riescono a venderli. La cosa sembra poter andare. Ma un giorno bussano al garage. E’ la camorra. Sappiamo che state guadagnando, dovete fare un regalo ai ragazzi che stanno in galera. “Come sarebbe?”. “Pagate, è meglio per voi”. Se pagano, finiscono i soldi e chiudono. Se non pagano, gli fanno saltare in aria il garage. Se vanno alla polizia e li denunciano, se ne devono solo andare perchè hanno finito di campare. Se non li denunciano e scoprono la cosa, vanno in galera pure loro. Pagano. Ma non hanno più i soldi per continuare le attività. Il finanziamento dalla Regione non arriva, i libri contabili costano, bisogna versare l’Iva, pagare le tasse su quello che hanno venduto, il commercialista preme, i pezzi sono finiti, assemblare computer in questo modo diventa impossibile, il padre di Stefano Lavori lo prende da parte e gli dice “guagliò, libera questo garage, ci fittiamo i posti auto, che è meglio”. I due ragazzi si guardano e decidono di chiudere il loro sogno nel cassetto. Diventano garagisti. La Apple in Italia non sarebbe nata, perchè saremo pure affamati e folli, ma se nasci nel posto sbagliato rimani con la fame e la pazzia, e niente più.
DIRITTO E GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
In Italia, spesso, ottenere giustizia è una chimera. In campo penale, per esempio, vige un istituto non previsto da alcuna norma, ma, di fatto, è una vera consuetudine. In contrapposizione al Giudizio Perenne c’è l’Insabbiamento.
Rispetto al concorso esterno all’associazione mafiosa, un reato penale di stampo togato e non parlamentare, da affibbiare alla bisogna, si contrappone una norma non scritta in procedura penale: l’insabbiamento dei reati sconvenienti.
A chi è privo di alcuna conoscenza di diritto, oltre che fattuale, spieghiamo bene come si forma l’insabbiamento e quanti gradi di giudizio ci sono in un sistema che a livello scolastico lo si divide con i fantomatici tre gradi di giudizio.
Partiamo col dire che l’insabbiamento è applicato su un fatto storico corrispondente ad un accadimento che il codice penale considera reato.
Per il sistema non è importante la punizione del reato. E’ essenziale salvaguardare, non tanto la vittima, ma lo stesso soggetto amico, autore del reato.
A fatto avvenuto la vittima incorre in svariate circostanze che qui si elencano e che danno modo a più individui di intervenire sull’esito finale della decisione iniziale.
La vittima, che ha un interesse proprio leso, ha una crisi di coscienza, consapevole che la sua querela-denuncia può recare nocumento al responsabile, o a se stessa: per ritorsione o per l’inefficienza del sistema, con le sue lungaggini ed anomalie. Ciò le impedisce di proseguire. Se si tratta di reato perseguibile d’ufficio, quindi attinente l’interesse pubblico, quasi sempre il pubblico ufficiale omette di presentare denuncia o referto, commettendo egli stesso un reato.
Quando la denuncia o la querela la si vuol presentare, scatta il disincentivo della polizia giudiziaria.
Ti mandano da un avvocato, che si deve pagare, o ti chiedono di ritornare in un secondo tempo. Se poi chiedi l’intervento urgente delle forze dell’ordine con il numero verde, ti diranno che non è loro competenza, ovvero che non ci sono macchine, ovvero di attendere in linea, ovvero di aspettare che qualcuno arriverà………
Quando in caserma si redige l’atto, con motu proprio o tramite avvocato, scatta il consiglio del redigente di cercare di trovare un accordo e poi eventualmente tornare per la conferma.
Quando l’atto introduttivo al procedimento penale viene sottoscritto, spesso l’atto stanzia in caserma per giorni o mesi, se addirittura non viene smarrito o dimenticato…
Quando e se l’atto viene inviato alla procura presso il Tribunale, è un fascicolo come tanti altri depositato su un tavolo in attesa di essere valutato. Se e quando….. Se il contenuto è prolisso, non viene letto. Esso, molte volte, contiene il nome di un magistrato del foro. Non di rado il nome dello stesso Pubblico Ministero competente sul fascicolo. Il fascicolo è accompagnato, spesso, da una informativa sul denunciante, noto agli uffici per aver presentato una o più denunce. In questo caso, anche se fondate le denunce, le sole presentazioni dipingono l’autore come mitomane o pazzo.
Dopo mesi rimasto a macerare insieme a centinaia di suoi simili, del fascicolo si chiede l’archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari. Questo senza aver svolto indagini. Se invece vi è il faro mediatico, allora scatta la delega delle indagini e la comunicazione di garanzia alle varie vittime sacrificali. Per giustificare la loro esistenza, gli operatori, di qualcuno, comunque, ne chiedono il rinvio a giudizio, quantunque senza prove a carico.
Tutti i fascicoli presenti sul tavolo del Giudice per l’Udienza Preliminare contengono le richieste del Pubblico Ministero: archiviazione o rinvio a giudizio. Sono tutte accolte, a prescindere. Quelle di archiviazione, poi, sono tutte accolte, senza conseguire calunnia per il denunciante, anche quelle contro i magistrati del foro. Se poi quelle contro i magistrati vengono inviate ai fori competenti a decidere, hanno anche loro la stessa sorte: archiviati!!!
Il primo grado si apre con il tentativo di conciliazione con oneri per l’imputato e l’ammissione di responsabilità, anche quando la denuncia è infondata, altrimenti la condanna è già scritta da parte del giudice, collega del PM, salvo che non ci sia un intervento divino, (o fortemente terrestre sul giudice), o salvo che non interviene la prescrizione per sanare l’insanabile. La difesa è inadeguata o priva di potere. Ci si tenta con la ricusazione, (escluso per il pm e solo se il giudice ti ha denunciato e non viceversa), o con la rimessione per legittimo sospetto che il giudice sia inadeguato, ma in questo caso la norma è stata sempre disapplicata dalle toghe della Cassazione.
Il secondo grado si apre con la condanna già scritta, salvo che non ci sia un intervento divino, (o fortemente terrestre sul giudice), o salvo che non interviene la prescrizione per sanare l’insanabile. Le prove essenziali negate in primo grado, sono rinegate.
In terzo grado vi è la Corte di Cassazione, competente solo sull’applicazione della legge. Spesso le sue sezioni emettono giudizi antitetici. A mettere ordine ci sono le Sezioni Unite. Non di rado le Sezioni Unite emettono giudizi antitetici tra loro. Per dire, la certezza del diritto….
Durante il processo se hai notato anomalie e se hai avuto il coraggio di denunciare gli abusi dei magistrati, ti sei scontrato con una dura realtà. I loro colleghi inquirenti hanno archiviato. Il CSM invece ti ha risposto con una frase standard: “Il CSM ha deliberato l’archiviazione non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale”.
Quando il processo si crede che sia chiuso, allora scatta l’istanza al Presidente della Repubblica per la Grazia, ovvero l’istanza di revisione perchè vi è stato un errore giudiziario. Petizioni quasi sempre negate.
Alla fine di tutto ciò, nulla è definitivo. Ci si rivolge alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che spesso rigetta. Alcune volte condanna l’Italia per denegata giustizia, ma solo se sei una persona con una difesa capace. Sai, nella Corte ci sono italiani.
Per i miscredenti vi è un dato, rilevato dal foro di Milano tratto da un articolo di Stefania Prandi del “Il Fatto Quotidiano”. “Per le donne che subiscono violenza spesso non c’è giustizia e la responsabilità è anche della magistratura”. A lanciare l’accusa sono avvocate e operatrici della Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano che puntano il dito contro la Procura della Repubblica di Milano, “colpevole” di non prendere sul serio le denunce delle donne maltrattate. Secondo i dati su 1.545 denunce per maltrattamento in famiglia (articolo 572 del Codice penale) presentate da donne nel 2012 a Milano, dal Pubblico ministero sono arrivate 1.032 richieste di archiviazione; di queste 842 sono state accolte dal Giudice per le indagini preliminari. Il che significa che più della metà delle denunce sono cadute nel vuoto. Una tendenza che si conferma costante nel tempo: nel 2011 su 1.470 denunce per maltrattamento ci sono state 1.070 richieste di archiviazione e 958 archiviazioni. Nel 2010 su 1.407 denunce, 542 sono state archiviate.
«La tendenza è di archiviare, spesso de plano, cioè senza svolgere alcun atto di indagine, considerando le denunce manifestazioni di conflittualità familiare – spiega Francesca Garisto, avvocata Cadmi – Una definizione, questa, usata troppe volte in modo acritico, che occulta il fenomeno della violenza familiare e porta alla sottovalutazione della credibilità di chi denuncia i maltrattamenti subiti. Un atteggiamento grave da parte di una procura e di un tribunale importanti come quelli di Milano». Entrando nel merito della “leggerezza” con cui vengono affrontati i casi di violenza, Garisto ricorda un episodio accaduto di recente: «Dopo una denuncia di violenza anche fisica subita da una donna da parte del marito, il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione de plano qualificandola come espressione di conflittualità familiare e giustificando la violenza fisica come possibile legittima difesa dell’uomo durante un litigio».
Scarsa anche la presa in considerazione delle denunce per il reato di stalking (articolo 612 bis del codice penale). Su 945 denunce fatte nel 2012, per 512 è stata richiesta l’archiviazione e 536 sono state archiviate. Per il reato di stalking quel che impressiona è che le richieste di archiviazione e le archiviazioni sono aumentate, in proporzione, negli anni. In passato, infatti, la situazione era migliore: 360 richieste di archiviazione e 324 archiviazioni su 867 denunce nel 2011, 235 richieste di archiviazione e 202 archiviazioni su 783 denunce nel 2010. Come stupirsi, dunque, che ci sia poca fiducia nella giustizia da parte delle donne? Manuela Ulivi, presidente Cadmi ricorda che soltanto il 30 per cento delle donne che subiscono violenza denuncia. Una percentuale bassa dovuta anche al fatto che molte, in attesa di separazione, non riescono ad andarsene di casa ma sono costrette a rimanere a vivere con il compagno o il marito che le maltrattata. Una scelta forzata dettata spesso dalla presenza dei figli: su 220 situazioni di violenza seguite dal Cadmi nel 2012, il 72 per cento (159) ha registrato la presenza di minori, per un totale di 259 bambini.
Non ci dobbiamo stupire poi se la gente è ammazzata per strada od in casa. Chiediamoci quale fine ha fatto la denuncia presentata dalla vittima. Chiediamoci se chi ha insabbiato non debba essere considerato concorrente nel reato.
Quando la giustizia è male amministrata, la gente non denuncia e quindi meno sono i processi, finanche ingiusti. Nonostante ciò vi è la prescrizione che per i più, spesso innocenti, è una manna dal cielo. In queste circostanze vien da dire: cosa hanno da fare i magistrati tanto da non aver tempo per i processi e comunque perché paghiamo le tasse, se non per mantenerli?
GIUSTIZIA DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.
Giustizia da matti. L'ultima follia delle toghe: un'indagine sul morso di Suarez, scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”. Una giornata come un’altra, quella di ieri 8 luglio 2014: assolvono i vertici di una delle prime aziende italiane (Mediaset) dopo aver però condannato il fondatore, condannano intanto il pluri-governatore dell’Emilia Romagna che perciò si dimette, aprono un’inchiesta surreale sul morso di Suarez a Chiellini - non l’inchiesta della Fifa: un'altra inchiesta tutta italiana - e per finire la magistratura apre, di passaggio, anche un’indagine sul concorso per magistratura. Questo senza contare le polemiche per gli sms inviati da un sottosegretario alla giustizia (un magistrato) i quali invitavano a votare un candidato per le elezioni del Csm, e senza contare, appunto, le elezioni del Csm, e senza contare, ancora, le dure parole del procuratore generale milanese Manlio Minale in polemica con l’archiviazione dell’esposto del procuratore aggiunto Alfredo Robledo contro il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati per presunte irregolarità nelle assegnazioni - prendete respiro - dopodiché Bruti Liberati ha provveduto a nuove assegnazioni che hanno portato a un nuovo esposto del procuratore aggiunto Robledo: tutto chiaro, no? Una giornata come un’altra, quella di ieri: e non dite che la magistratura sia un potere ormai incontrollabile e irresponsabile, perché potrebbero punirvi e togliervi i benefici di legge, non dite che la magistratura occupi ormai tutta la scena e, ormai priva di contrappesi, si stia cannibalizzando e al tempo stesso respinga qualsiasi riforma che possa farla riassomigliare a qualcosa di normale: non fate i berlusconiani, non fate i renziani travestiti. Da che cosa dovremmo incominciare? Quanto dovrebbe essere lungo, questo articolo, se davvero volessimo approfondire i vari addendi della giornata di ieri? Anche perché è la somma che lascia storditi. La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul morso di Suarez durante Uruguay-Italia: l’ipotesi è violenza privata. Che dire? Come commentare? Cioè: davvero in questo preciso momento c’è un pubblico dipendente - ciò che è un magistrato - che sta occupandosi di questa sciocchezza per via di una denuncia del Codacons? E che gliene frega, al Codacons, del morso degli uruguaiani? Ma soprattutto: che ce ne frega, a noi, in un Paese che affoga nelle cause arretrate e dove gli imprenditori rinunciano ai contenziosi perché durerebbero 15 anni?
Poi c’è l’indagine della magistratura sul concorso per magistratura: e qui, invece, che cosa dovremmo pensare? Già è assurdo che basti un pubblico concorso, subito dopo gli studi universitari, per trascorrere tutta la vita da magistrato e percorrere automaticamente tutte le tappe di una lunga carriera: ma - domanda - è solo una battuta chiedersi che razza di magistrati possano uscire da un concorso truccato? Il concorso è quello del 25 e 26 e 27 giugno scorsi: un candidato ha denunciato una serie di irregolarità, il solito impiccione di un Codacons ha chiesto l’accesso ai verbali della commissione, c’è stata un’interrogazione parlamentare bipartisan, su un banco hanno trovato tre codici vidimati e timbrati dalla commissione nonostante il regolamento ne vietasse l’utilizzo: non male. Una candidata è stata scoperta mentre scriveva un tema prima ancora che la traccia venisse dettata: e questa ragazza, se passerà il concorso, finirà sino alla Cassazione. Stiamo facendo i brillanti e gli spiritosi? Rischiamo di scivolare, dite, nel qualunquismo anticasta? Ovunque rischiamo di scivolare, in verità, ci siamo già scivolati: è da almeno vent’anni che questo Paese è subordinato all’azione sempre più discrezionale delle magistrature: procure e tribunali avanzano in territori che appartenevano alla politica e l’imprigionano come i laccetti che imbrigliavano Gulliver. Quando non ci sarà più nessun mediocre politico con cui prendercela, forse, sarà a tutti più chiaro.
Strage Borsellino, errori o depistaggi? Ecco la storia “Dalla parte sbagliata”. In libreria nei primi giorni di luglio 2014 il volume di Rosalba De Gregorio, legale di sette imputati ingiustamente condannati nel primo processo su via D'Amelio, e Dina Lauricella, giornalista di Servizio pubblico. La redazione de “Il Fatto Quotidiano” ne anticipa un brano. “Chi si nasconde dietro quel tanto vituperato «terzo livello» che ha legato mafia e pezzi delle Istituzioni attraverso il «papello», ha verosimilmente lo stesso profilo di chi ha ucciso il giudice Borsellino e di chi per 22 anni ci ha dato in pasto una storia da due lire, alla quale abbiamo voluto credere per sedare la diffusa ansia di giustizia che ha scosso il Paese nell’immediato dopo strage”, scrivono l’avvocato Rosalba Di Gregorio e la giornalista Dina Lauricella nel libro “Dalla parte sbagliata”, edito da Castelvecchi, con prefazione del magistrato Domenico Gozzo.Tre processi, 15 anni di indagini, 11 persone ingiustamente condannate all’ergastolo e un nuovo processo, il “borsellino quater” che sta rimettendo tutto in discussione. Che cosa sappiamo oggi della strage di via d’Amelio e della morte di Paolo Borsellino? Davvero poco se consideriamo che la procura di Caltanissetta ha chiesto la revisione del vecchio processo. Un nuovo pentito, Gaspare Spatuzza, ha rimescolato le carte e oggi in aula, chi stava sul banco degli imputati, siede fra le parti civili. È il caso “dell’avvocato di mafia” Rosalba Di Gregorio, che da oltre vent’anni grida al vento le anomalie di un processo che si è basato sulle affermazioni di uno dei pentiti più anomali che i nostri tribunali abbiano mai visto, Vincenzo Scarantino. Per tutti e tre i gradi di giudizio ha inutilmente difeso 7 degli imputati condannati all’ergastolo (oggi tornati in libertà grazie alle dichiarazioni di Spatuzza), e nel libro racconta, con l’impeto e la passione che le è propria, in una sorta di diario di bordo, questi lunghi anni di processi e sentenze. Dina Lauricella, inviata di Servizio Pubblico, riavvolge il nastro di questa oscura storia del nostro Paese provando a riguardarla da una nuova prospettiva. I due punti di osservazione speciale sono quelli dell’ex pentito Vincenzo Scarantino e dell’avvocato Di Gregorio, legale di numerosi boss di Cosa Nostra, tra cui Bernardo Provenzano, Michele Greco e Vittorio Mangano. “Un racconto che parte dal basso, sicuramente di parte, dalla parte sbagliata, per costringerci all’esercizio di tornare indietro nel tempo, per sbarazzarci della confusione accumulata negli anni e, atti alla mano, rimettere al posto giusto le poche pedine certe”. Le stesse sulle quali, a 22 anni di distanza, è tornata ad indagare la procura di Caltanissetta. Seri e rodati cronisti, formati nell’aula bunker di Palermo durante il maxi processo, arrivati per primi sulle macerie e sui corpi dilaniati di via d’Amelio, hanno una fitta al cuore al pensiero che nei successivi 15 anni di vicende giudiziarie hanno visto, sentito e raccontato una storia che è crollata all’improvviso mostrandosi in tutta la sua fragilità. È stato l’ex procuratore generale di Caltanissetta Roberto Scarpinato a chiedere che i processi «Borsellino» e «Borsellino bis» venissero revisionati a seguito delle rivelazioni del nuovo collaboratore, Gaspare Spatuzza. È per questo che tre anni fa, undici imputati, di cui sette condannati all’ergastolo, sono tornati in libertà. Clamoroso errore giudiziario o vile depistaggio che sia, la storia è da riscrivere e chi ha penna non dovrebbe risparmiare inchiostro. Ne serve molto per raccontare fedelmente i punti salienti dei tre processi che dal 1996 al 2008 hanno indagato sull’omicidio Borsellino. Sarebbe una semplificazione giornalistica dire che dobbiamo buttare all’aria tutti questi anni per colpa di Scarantino o di chi ha creduto in lui. Le sentenze del Borsellino ter, infatti, sopravvivono al terremoto Spatuzza, ma non è un caso: in questo processo Scarantino non ha alcun ruolo. Carcere a vita per l’allora latitante Bernardo Provenzano e per altri 10 imputati di grosso calibro, nessuno dei quali tirato in ballo da Scarantino. Questo troncone scaturisce infatti dalle dichiarazioni di mafiosi doc come Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi, Giovan Battista Ferrante o Calogero Ganci. Il processo che la Procura di Catania dovrà revisionare, quando Caltanissetta stabilirà se Scarantino è o meno un calunniatore, come emerso dalle dichiarazioni di Spatuzza, è il Borsellino bis. È qui che Enzino fa da pilastro. Faticherà a distinguere i nomi dei mafiosi che coinvolge, non li riconoscerà in foto, talvolta si contraddirà, ma a fronte di un’informativa del Sisde che metteva in luce la sua parentela con il boss Salvatore Profeta, ha goduto di una fiducia che si è rivelata a dir poco esagerata.
Mostri a prescindere. Misteri e depistaggi. Finti pentiti e inchieste sballate. La strage palermitana di via Mariano D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 morirono Paolo Borsellino e 5 agenti di scorta, non è soltanto uno dei peggiori drammi italiani: è anche uno dei più velenosi ingorghi giudiziari di questo Paese, scrive Rosalba Di Gregorio su “Panorama”. Tre processi, decine d’imputati, 7 persone ingiustamente condannate all’ergastolo e tenute in carcere 18 anni per le false verità (incassate senza riscontri dai magistrati) del pentito Vincenzo Scarantino. Poi una nuova inchiesta, partita nel giugno 2008, ha iniziato a ribaltare tutto grazie alle rivelazioni (stavolta riscontrate) di Gaspare Spatuzza. Nel marzo 2013, a Caltanissetta, è iniziato un nuovo procedimento, con nuovi imputati: il "Borsellino quarter". Da oltre 21 anni Rosalba Di Gregorio, avvocato di Bernardo Provenzano e altri boss di Cosa nostra, contesta nei tribunali le anomalie di una giustizia che si è mostrata inaffidabile come alcuni dei suoi peggiori collaboratori. Con Dina Lauricella, giornalista di Servizio pubblico, la penalista cerca adesso di riannodare i fili di una delle vicende più sconcertanti della nostra giustizia e lo fa in un libro difficile e duro, ma spietatamente onesto: Dalla parte sbagliata (Castelvecchi editore, 190 pagine, 16,50 euro). Per capire la portata del disastro d’illegalità di cui si occupa il libro, bastano poche righe della prefazione scritta da Domenico Gozzo, procuratore aggiunto a Caltanissetta: "Non ha funzionato la polizia. Non ha funzionato la magistratura. Non hanno funzionato i controlli, sia disciplinari sia penali. Non ha funzionato il Csm (...). Solo un avvocato di mafia ha gridato le sue urla nel vuoto". Urla che non sono bastate a evitare mostruosi errori giudiziari, per i quali nessun magistrato pagherà, e sofferenze indicibili per le vittime di tanta malagiustizia. Panorama pubblica ampi stralci del diario di una visita dell’avvocato Di Gregorio a un cliente sottoposto al "regime duro" del 41 bis nel carcere di Pianosa, appena un mese dopo via D’Amelio. Piombino, agosto 1992. Sotto il sole, all’imbarco, fa caldissimo anche se sono le 8 del mattino. Consegno i documenti e aspetto, ci sono altri due o tre colleghi e dobbiamo imbarcarci per Pianosa. Passano due ore di attesa e io cerco di capire perché mi sento ansiosa: in fondo, al carcere, ci vado da tanti anni. Alcuni colleghi mi hanno detto di vestirmi con abiti che possono essere buttati via, perché a Pianosa c’è troppa sporcizia, e ho indossato zoccoletti di legno, pantaloni di cotone e una maglia: tutto rigorosamente senza parti metalliche e sufficientemente brutto. Aspettiamo ancora, sotto il sole, e non si capisce perché. Tutte le autorizzazioni per i colloqui sono in regola e, infastidita dall’attesa, vado al posto di polizia per capire. "È per colpa sua se ancora non si parte". Non avevano previsto avvocati donne! Stanno convocando il personale femminile che si occupa dei colloqui dei detenuti con i parenti. Si parte. Il panorama è unico e spettacolare. Siamo arrivati a Pianosa e ci accolgono poliziotti e grossi cani che si lanciano ad annusarci appena scesi da una traballante passerella di legno. Meno male che non soffro di vertigini e non ho paura dei cani! Benvenuti a Pianosa. Sbarcati sull’isola, ci informano che è vietato avvicinarsi al mare, che non potremo acquistare né acqua, né altro: dovremo stare digiuni e assetati fino alle 17 sotto il sole, perché non c’è "sala avvocati", né luogo riparato ove attendere, né è consentito andare allo "spaccio delle guardie". (...) La perquisizione per me non è una novità, penso per rassicurarmi. E sbaglio. Nella stanzetta lurida, spoglia, vengo controllata col metal detector. Non suona perché non ho nulla di metallico addosso e allora sto per andarmene. Mi intimano di fermarmi, bisogna perquisire. Ma che significa? La perquisizione manuale non ha senso visto che non ho oggetti metallici. Chiedo a una delle due donne addette alla perquisizione perché ha indossato i guanti di lattice. Le due si guardano e una bisbiglia: "No, forse a lei no, perché fa l’avvocato". Ma che vuol dire? Ho imparato subito e ho sperimentato anche in successive visite, che a Pianosa nessuno sorride, tutti sembrano incazzati, gli avvocati sono i difensori dei mostri e quindi sembra che l’ordine sia di trattarli male: loro sono lo Stato e noi i fiancheggiatori dell’antistato. Questa etichetta, nei processi per le stragi del ’92, ce la sentiremo addosso, ma in modo diverso, forse più subdolo, certamente più sfumato: a Pianosa, invece, è proprio disprezzo. (...) Finalmente esco da quella stanzetta, sudata, anche innervosita, e passo nell’altra stanza a riprendermi il fascicolo di carte processuali, le sigarette e la penna per prendere appunti. O, almeno, pensavo di riprendere queste cose, ma la mia penna è "pericolosa" e mi danno una bic trasparente. Le mie sigarette resteranno lì, perché, per perquisire il pacchetto, sono state tutte tirate fuori e sparse sul bancone sporchissimo. Le mie carte processuali vengono lette, giusto per la sacralità del diritto di difesa. Sono di nuovo con i miei colleghi e sono nervosissima. Ci fanno salire su una jeep, con due del Gom, il Gruppo operativo mobile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che, seduti davanti a noi, ci puntano i mitra in faccia, lungo tutto il percorso che va dal punto di approdo alla "Agrippa". Terra battuta, campetti coltivati dai detenuti: gli altri detenuti di Pianosa, non quelli del 41 bis. (...) Entriamo nella "sala colloqui", se così può definirsi quella stanza stretta, divisa in due, per tutta la sua lunghezza, da un muro di cemento ad altezza di tavolino, sormontato dal famoso "vetro del 41 bis". Come sedile c’è un blocco di cemento, alle nostre spalle c’è il "blindato" che viene chiuso rumorosamente. I rumori di Pianosa sono particolari: non senti parlare nessuno, la consegna pare sia il silenzio, senti solo rumori metallici, forti, sinistri, nel silenzio dell’isola. Non parlano nemmeno i 5 detenuti che ci portano dall’altro lato del vetro. I "boss" – fra loro c’erano anche incensurati, ma questo si scoprirà con 19 anni di ritardo – hanno lo sguardo terrorizzato, si limitano ad abbassare la testa, entrano già con la testa bassa e alle loro spalle viene rumorosamente chiuso il "blindato". Provo a chiedere, per educazione, come stiano, ma nessuno risponde. Io sono uscita da lì senza aver sentito la voce di nessuno di loro. Ma che succede? Perché, anziché guardare me o ascoltarmi, questi guardano, verso l’alto, alle mie spalle? Mi giro di scatto e vedo che lo sportellino del blindato dietro di me, quello che era stato chiuso al mio ingresso, è stato aperto e una guardia del Gom li osserva. No, forse è più giusto dire che li terrorizza con lo sguardo. (...) Torno sulla jeep e sono sconvolta. Per pochi minuti di non-colloquio, sono stata trattata come un delinquente. (...) Ho parlato con giornalisti, con colleghi, con magistrati, al mio ritorno da Pianosa e mi sono sentita dire che, in fondo, non ero obbligata ad andarci e che la mafia aveva fatto le stragi. Inutile ribattere che alcuni di quelli che erano a Pianosa erano presunti innocenti, persone in attesa di giudizio: in tempo di guerra le garanzie costituzionali vengono sospese. (...) "In ogni caso" mi ha detto un avvocato civilista illuminato "se hanno arrestato loro, vuol dire che, come minimo, si sono messi nelle condizioni di essere sospettati". E già... Un vantaggio estetico, però, c’è stato sicuramente. Alla mia seconda visita a Pianosa ho trovato i miei assistiti in forma fisica migliore: tutti magri, asciutti, quasi ossuti, direi. Il cibo razionato e immangiabile ha la sua influenza sulla dieta. (...) Nel ’94 sono stati arrestati, grazie a Vincenzo Scarantino, anche i futuri condannati (oggi scarcerati) del processo Borsellino bis: tra questi, Gaetano Murana, Cosimo Vernengo, Giuseppe Urso e Antonino Gambino erano incensurati e furono accusati da Scarantino di concorso nella strage di via D’Amelio. Di questi solo Nino Gambino sarà assolto dalla grave accusa d’aver partecipato al massacro del 19 luglio ’92. Gli altri, assolti in primo grado dopo la ritrattazione di Scarantino, saranno condannati e poi riarrestati a seguito dell’ulteriore ritrattazione della ritrattazione del "pentito a corrente alternata". Oggi, dopo Gaspare Spatuzza, sono scarcerati. Tutti, comunque, erano stati amorevolmente accolti nelle carceri di Pianosa e Asinara. Uno di questi, a Pianosa, ha subìto una lesione alla retina, per lo "schiaffo" di una guardia del Gom. A un altro sono state fratturate le costole. (...) Racconta, oggi, Tanino Murana: "Appena entrato a Pianosa dopo l’interrogatorio del gip, mi hanno portato alla “discoteca". La discoteca è il nome che i detenuti hanno dato alle celle dell’isolamento, perché li si balla per le percosse e per la paura. "Eppure" dice Tanino "so che dal ’92 al ’94, che è quando arrivai io, si stava peggio. Alcuni detenuti mi hanno detto, poi, quando li ho incontrati in altre carceri, che all’inizio il trattamento era peggiore". E perché non glielo hanno raccontato subito, mentre eravate a Pianosa? "Lì non si poteva parlare: si doveva stare in silenzio nelle celle a tre, o quattro posti. Le guardie del Gom non ci volevano sentire neppure bisbigliare. Ma questo vale da quando ci portavano in sezione. Alla discoteca si stava in cella singola". Era l’isolamento. L’accoglienza al supercarcere prevedeva, per iniziare, che il detenuto si spogliasse completamente e, nudo, iniziasse a fare le flessioni sulle gambe... tante, fino a non avere più fiato e, nel frattempo, veniva preso a botte dalle guardie, cinque, sei, otto... "Non lo so quanti erano... a un certo punto non capivi più nulla e trascinandoti di peso, ti portavano, nudo e stremato, fino alla cella, in discoteca, scaraventandoti dentro la stanzetta spoglia e sporca". Qui iniziava la seconda parte del trattamento: perquisizioni, flessioni, acqua e brodaglia razionati, botte, di giorno e di notte, per non farti dormire. "Appena ti addormentavi entravano le guardie, alcune pure incappucciate, spesso ubriache e davano pugni, calci, schiaffi... Dopo un po’ di tempo ho chiesto che mi uccidessero, non ce la facevo più". (...) Ma cosa vi davano da mangiare? "Una pagnotta al giorno, due tetrapak di acqua e poi se riuscivi a mangiarlo, il piatto del giorno". Cosa sarebbe? "Una brodaglia in cui, accanto a qualche pezzetto, o filo di pasta, galleggiava roba di qualunque genere". E cioè? "Io una volta ho trovato pure un preservativo". Ecco perché erano tutti magri e asciutti. Ecco perché, quando Scarantino, nel corso del processo Borsellino, il 15 settembre ’98, ha raccontato il suo trattamento a Pianosa, i detenuti sono rimasti impassibili e noi avvocati avevamo voglia di vomitare. All’epoca, non volendo prestare fede a Scarantino, neppure in ritrattazione, ho cercato di documentarmi. Ho trovato una sentenza del pretore di Livorno10, a carico di due guardie del Gom, processate a seguito della denuncia di un ex ospite di Pianosa, per fatti accaduti in quell’isola "dal luglio ’92 all’08/01/94". (...)
La sentenza (...) riporta il racconto del denunciante, giunto a Pianosa il 20 luglio ’92. "Manganellate, strattoni, pedate, sputi e schiaffi", sia all’entrata, sia all’uscita per andare all’aria. E se "all’aria" non ci andavi, il "trattamento" ti veniva fatto in cella. Il tragitto lungo il corridoio era scivoloso (cera, o detersivo, secondo altre fonti), così si cadeva a terra, diventando bersaglio del "cordone " di 10 o 20 uomini del Gom, che si schieravano nel corridoio, a dare libero sfogo al comportamento "animalesco". Racconta il denunciante – ma non è solo lui, oggi, a riferirlo – che nello shampoo si trovava l’olio, nell’olio si trovava lo shampoo e la pasta era a volte "condita" con i detersivi. Nessuno all’epoca denunciava nulla, perché avevano tutti paura di essere uccisi. Preferivano sopportare le angherie, le botte, gli scherzi, "l’inutile crudeltà" come dice la sentenza. (...) A cosa serviva tanta violenza? Scarantino, che narra d’averla subita tutta quella violenza, sostiene d’essersi determinato a fare il "falso" pentito, perché non era capace più di resistere e non solo alle costrizioni fisiche. Oggi, e nel tempo, ascoltando i racconti di ex detenuti di Pianosa, ti accorgi che il ricordo più vivo sembra quello delle torture psicologiche: le percosse hanno certamente segnato quei corpi, ma te le narrano in modo quasi distaccato. Le hanno subite e, sembra, ormai quasi metabolizzate.
Presentazione su “La Valle dei Templi di Nico Gozzo, procuratore aggiunto di Caltanissetta, “Dalla parte sbagliata – La morte di Paolo Borsellino e i depistaggi di via D’Amelio”. Un boato, sei morti, tanti misteri. Il 19 luglio del 1992 un’autobomba esplodeva in via D’Amelio uccidendo Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta. A ventidue anni di distanza, nonostante le inchieste, i processi, le condanne e le successive assoluzioni, oggi ne sappiamo tanto quanto prima, tranne che per il fatto di aver preso coscienza che molto di più, rispetto la strage mafiosa, si cela dietro quell’evento criminale che ha visto falsi pentiti autori di depistaggi che ci hanno portati sempre più lontani dalla verità. Fallimenti dell’apparato investigativo e giudiziario, carenze e incongruenze che emergono sempre più chiare dalle carte processuali, che ci obbligano a fare i conti con una realtà che vorremmo inconsciamente ignorare e che ci mettono dinanzi ad una domanda alla quale non abbiamo una risposta da dare: furono soltanto madornali errori giudiziari o qualcosa di diverso e molto più grave si cela dietro le tante anomalie che hanno caratterizzato l’intera vicenda? “Dalla parte sbagliata – La morte di Paolo Borsellino e i depistaggi di via D’Amelio” è il libro della giornalista palermitana Dina Lauricella e dell’avvocato Rosalba Di Gregorio che racconta questi venti anni di indagini e processi, partendo dalle dichiarazioni del pentito Vincenzo Scarantino, ambigua figura le cui dichiarazioni sono spesso state smentite, per arrivare ad una certa antimafia parolaia e spesso fine a sé stessa alla quale forse poco importa che venga una volta per tutte fatta chiarezza sull’attentato che il 19 luglio del 1992 provocò la morte del Giudice Paolo Borsellino e di altri cinque innocenti caduti nell’adempimento del loro dovere. Non avrei mai pensato di dover scrivere dell’ “Avvocato del diavolo” – come ignominiosamente viene definita Rosalba Di Gregorio – difensore di fiducia di imputati dai cognomi “pesanti” quali Bontate,Pullarà, Vernengo, Marino Mannoia, Mangano, per finire con Provenzano, se non fosse stato per questo libro e per la coltre di silenzio con cui è stata artatamente coperta ogni sua presentazione. Ho conosciuto personalmente l’Avvocato Rosalba Di Gregorio e l’ho conosciuta in quelle aule giudiziarie laddove era in corso un processo per strage contro i vertici di Cosa Nostra. Lei “dalla parte sbagliata”, difensore di fiducia del boss o ex tale, io per scriverne “dalla parte giusta”, accanto ai familiari di vittime innocenti di mafia. In quell’aula non c’erano gli antimafiosi di professione, né, purtroppo, i tanti giornalisti che oggi artatamente ignorano la Di Gregorio. È facile fare antimafia così. Facile come porre il marchio di mafiosità a chi per ragioni professionali si trova a difendere “la parte sbagliata”, il “mostro”. Senza entrare nel merito del diritto, del codice deontologico della professione e su quel sacrosanto diritto alla difesa che è consentito ad ogni imputato, dell’Avvocato Di Gregorio ho avuto modo di apprezzare la professionalità, le doti umane e il contegno mantenuto durante le udienze che – a differenza di tanti difensori di cosiddette “persone per bene” che ho avuto modo di incontrare in questi anni – non l’hanno mai spinta ad andare oltre quella che era la difesa del proprio assistito avendo rispetto per l’altrui dolore e per il lavoro e la professionalità del rappresentante legale della controparte. Se questo libro dovesse servire anche a mettere un solo tassello al posto giusto per cercare di ricostruire quello che realmente accadde nel ‘92, sarebbe molto più di quanto tanti di coloro che si professano antimafiosi hanno dato come contributo ad una Verità che forse in molti vorrebbero venisse taciuta per sempre. Se si è alla ricerca della Verità, perchè ignorare o censurare chi può dare un contributo? Perchè non conoscere o voler non fare conoscere le opinioni di chi per ragioni professionali ha seguito le vicende osservandole da un’ottica diversa ma non per questo meno valida o totalmente non rispondente a verità? Del resto – piaccia o meno -, ad oggi, la ricostruzione più verosimile di quei tragici eventi sembra essere proprio quella che emerge dal libro la cui esistenza si vorrebbe fosse ignorata. La prossima manifestazione in cui si parlerà del libro si terrà a Trieste il 12 luglio, organizzata da Libera, che da due anni è riuscita a coinvolgere i parenti di Walter Cosina, morto anche Lui nella strage del 19/7/92. Questi parenti dimenticati, di Vittime trattate come se fossero di serie” b”, hanno tanta fame anche Loro di Verità.
Questa la prefazione di Domenico Gozzo, procuratore aggiunto di Caltanissetta, al libro “Dalla parte sbagliata”, di Rosalba Di Gregorio e Dina Lauricella, edito da Castelvecchi: “Normalmente chi scrive la prefazione ha piena conoscenza del libro. Io ammetto di non averla, e per questo la mia è una «prefazione anomala». Ma conosco le autrici. E di loro parlerò. Conosco la vicenda, di cui non parlo, ma penso di avere il dovere, dopo le prime sentenze vicine al giudicato, di stimolare una riflessione che sino ad oggi è, incredibilmente, mancata. E allora, parlando in primis delle autrici, dico che Dina Lauricella mi è sembrata una giornalista indipendente e autonoma. Non fa parte di cordate, e pensa con la sua testa. Qualità rare e importanti. Quanto all’avvocato Di Gregorio, «l’avvocato del Diavolo», cosa dire? Rosalba è una persona che ha una faccia sola. Ha sempre detto, ostinatamente, le stesse cose sul processo di via D’Amelio. Ha sempre detto le stesse cose sui collaboratori. A viso aperto, sopportando, secondo me, conseguenze che l’hanno fatta diventare «un avvocato di mafia», del Diavolo, appunto. Rosalba non è un avvocato di mafia. È un avvocato. E la parola «avvocato» non dovrebbe sopportare ulteriori specifiche. A meno che non si voglia indicare, con quel termine, che si occupa soprattutto di processi di mafia. Il che farebbe anche di principi del Foro antimafia «avvocati di mafia». E a Milano, chi difende i corruttori, come dovremmo chiamarli? «Avvocati della corruzione»? La verità è che la «colpa» di Rosalba è di difendere, e bene, i mafiosi. Ma è una colpa questa? E può essere all’origine di una «messa all’indice» professionale? La verità è che dovremmo limitarci ad ammettere i nostri errori. Dopo le sentenze già intervenute sulBorsellino quater, e senza discutere di prove, dobbiamo o no discutere di questa giustizia, di questa stampa, di questa società, che secondo me, negli anni Novanta, hanno, almeno in parte, fallito? Dobbiamo discutere di chi ha consegnato per 17 anni le chiavi della vita di sette persone innocenti per il reato di strage ad un falso pentito, Scarantino? Dobbiamo avere il coraggio di discutere di una regola, quella della «frazionabilità» delle dichiarazioni dei collaboranti, che forse andrebbe ripensata, perché consente a «collaboranti» scarsamente credibili in via generale di essere utilizzati «per ciò che serve», aprendo il fianco a possibili strumentalizzazioni probatorie? Dobbiamo discutere del fatto che, pur con tutte le considerazioni contenute nelle passate tre sentenze sulla poca credibilità di Scarantino – il processo basato sulle sue dichiarazioni è arrivato sino all’ultimo grado, ed è stato approvato anche in Cassazione? Cosa non ha funzionato? Abbiamo il dovere di chiedercelo. Perché io penso che in questa triste storia nessuno dei relè dello Stato democratico ha funzionato a dovere. Non ha funzionato la Polizia. Non ha funzionato la Magistratura. Non hanno funzionato i controlli, sia disciplinari sia penali. Non ha funzionato il Csm. Non ha funzionato la cosiddetta Dottrina. Ma, soprattutto, non ha funzionato la «libera stampa», che dovrebbe essere, e non lo è stata, il vero cane da guardia di una democrazia. Solo un «avvocato di mafia» ha gridato le sue urla nel vuoto. Sin quando, fortunatamente, grazie a nuove prove, la stessa Giustizia ha avuto il coraggio di autoriformarsi. Ma alti sono i prezzi pagati per questo, soprattutto all’interno delle forze dell’ordine. È accettabile tutto questo? Sono accettabili questi 17 anni? E, soprattutto, dobbiamo chiederci con trepidazione: potrebbe nuovamente accadere, magari sta già riaccadendo, quanto è avvenuto in quella occasione? E allora, per evitarlo, devono assisterci i principi generali delle democrazie cosiddette «occidentali». Il diritto di difesa non è un optional. È un principio cardine delle democrazie, per l’appunto, «di diritto». Il difensore di un mafioso non può divenire, per il solo fatto di difendere un mafioso, inattendibile e pericoloso. La verità la può dire un famoso procuratore antimafia, come anche un «avvocato di mafia». Come tutti e due possono andare dietro ad abbagli. Tutto questo, lo capisco, ci costringe a una fatica immane: non ragionare per schemi (buono-cattivo; mafioso-antimafioso) ma ragionare con la nostra testa. Criticando. Leggendo. Facendoci le nostre personali idee. Ma in questo deve aiutarci una stampa autenticamente indipendente. Una stampa che non si schieri né a favore «a priori», né contro «a priori». E necessitiamo di una magistratura aperta ad essere criticata (se le critiche non sono preconcette), e rispettosa dei diritti della difesa. Perché il processo, ricordiamocelo, è, come dicevano i romani, actus trium personarum, è un rito che richiede il necessario intervento di tre persone: il Giudice, il Pubblico Ministero, e la Difesa. Solo così, tenendo in debito conto tutti questi attori, si può arrivare ad accertare una «verità processuale» che assomigli il più possibile alla Verità. In ultimo, qualche breve considerazione, permettetemi, sul cosiddetto fronte antimafia: ilmovimento antimafia, che è di importanza basilare in uno Stato democratico, deve però essere anch’esso democratico, e rispettoso delle opinioni di tutti. «Non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere», diceva qualcuno più saggio di me. Isoliamo gli intolleranti per mestiere. Perché dobbiamo viverci tutti insieme, in questo nostro Stato. E dobbiamo edificarlo tutti insieme, su solide basi di verità, anche a costo di ammettere verità scomode. È un debito, questo della verità, che tutti dobbiamo pagare a chi, in quegli anni, perse la vita per una idea di Giustizia e di antimafia.
Rosalba Di Gregorio. Si laurea in Giurisprudenza all’Università di Palermo nel 1979. Nel periodo di praticantato fa esperienza politica nel Partito radicale. L’esperienza più impegnativa dell’inizio della professione sarà il primo maxiprocesso di Palermo, dove, assieme all’avv. Marasà, difenderà una decina di imputati, tra i quali Vittorio Mangano. Dall’esperienza del maxiprocesso e dall’«incontro» in aula con i primi pentiti nascerà il libro L’altra faccia dei pentiti (La Bottega di Hefesto, 1990).
Dina Lauricella. Palermitana «doc», vive a Roma da 14 anni. Ha scritto per diversi quotidiani e settimanali. Nel 2007 entra a far parte della squadra di inviati di Annozero. Per Michele Santoro firma diversi speciali, tra cui La Mafia che cambia, nella quale parla in tv per la prima volta Angelo Provenzano, il figlio del super boss. Stato criminale, la puntata di Servizio Pubblico con ospite Vincenzo Scarantino, trae spunto da questo libro.
Bombe, omicidi e stragi in Sicilia: ecco tutte le accuse a “faccia da mostro”. Pentiti lo additano, quattro procure lo indagano: Giovanni Aiello, ex poliziotto col volto sfregiato, sarebbe in realtà un sicario per delitti ordinati da pezzi deviati dello Stato, oltre che dai padrini. Dall'eversione nera degli anni '70 all'uccisione di Falcone e Borsellino: la storia scritta da Attilio Bolzoni e Salvo Palazzolo su “La Repubblica”. Ci sono almeno quattro uomini e una donna che l'accusano di avere ucciso poliziotti come Ninni Cassarà e magistrati come Falcone e Borsellino, di avere fornito telecomandi per le stragi, di avere messo in giro per l'Italia bombe "su treni e dentro caserme". Qualcuno dice che a Palermo ha assassinato pure un bambino. Su di lui ormai indagano tutti, l'Antimafia e l'Antiterrorismo. Sospettano che sia un sicario per delitti su commissione, ordinati da Cosa Nostra e anche dallo Stato. Lo chiamano "faccia da mostro" e ha addosso il fiato di un imponente apparato investigativo che vuole scoprire chi è e che cosa ha fatto, da chi ha preso ordini, se è stato trascinato in un colossale depistaggio o se è davvero un killer dei servizi segreti specializzato in "lavori sporchi". Al suo fianco appare di tanto in tanto anche una misteriosa donna "militarmente addestrata ". Nessuno l'ha mai identificata. Forse nessuno l'ha mai nemmeno cercata con convinzione. Vi raccontiamo per la prima volta tutta la storia di Giovanni Aiello, 67 anni, ufficialmente in servizio al ministero degli Interni fino al 1977 e oggi plurindagato dai magistrati di Caltanissetta e Palermo, Catania e Reggio Calabria. Vi riportiamo tutte le testimonianze che l'hanno imprigionato in una trama che parte dal tentativo di uccidere Giovanni Falcone all'Addaura fino all'esplosione di via Mariano D'Amelio, in mezzo ci sono segni che portano al delitto del commissario Cassarà e del suo amico Roberto Antiochia, all'esecuzione del poliziotto Nino Agostino e di sua moglie Ida, ai suoi rapporti con la mafia catanese e quella calabrese, con terroristi della destra eversiva come Pierluigi Concutelli. E con l' intelligence . Anche se, ufficialmente, "faccia da mostro" non è mai stato nei ranghi degli 007. Negli atti del nuovo processo contro gli assassini di Capaci — quello che coinvolge i fedelissimi dei Graviano — che sono stati appena depositati, c'è la ricostruzione della vita e della carriera di un ex poliziotto dal passato oscuro. La sua scheda biografica intanto: "Giovanni Pantaleone Aiello, nato a Montauro, provincia di Catanzaro, il 3 febbraio del 1946, arruolato in polizia il 28 dicembre 1964, congedato il 12 maggio 1977, residente presso la caserma Lungaro di Palermo fino al 28 settembre 1981, sposato e separato con l'ex giudice di pace.., la figlia insegna in un'università della California". Reddito dichiarato: 22 mila euro l'anno (ma in una recente perquisizione gli hanno sequestrato titoli per un miliardo e 195 milioni di vecchie lire), ufficialmente pescatore. Sparisce per lunghi periodi e nessuno sa dove va, racconta a tutti che la cicatrice sulla guancia destra è "un ricordo di uno scontro a fuoco in Sardegna durante un sequestro di persona", ma nel suo foglio matricolare è scritto che "è stata causata da un colpo partito accidentalmente dal suo fucile il 25 luglio 1967 a Nuoro". Il suo dossier al ministero dell'Interno, allora: qualche encomio semplice per avere salvato due bagnanti, un paio di punzioni, per molti anni una valutazione professionale "inferiore alla media", un certificato sanitario che lo giudicano "non idoneo al servizio per turbe nevrotiche post traumatiche ". Dopo il congedo è diventato un fantasma fino a quando, il 10 agosto del 2009, è stato iscritto nel registro degli indagati "in riferimento all'attentato dell'Addaura e alle stragi di Capaci e di via D'Amelio". Il 23 novembre del 2012 tutte le accuse contro di lui sono state archiviate. Ma dopo qualche mese "faccia da mostro" è scivolato un'altra volta nel gorgo. È sotto inchiesta per una mezza dozzina di delitti eccellenti in Sicilia e per alcuni massacri, compresi attentati ai treni e postazioni militari. Le investigazioni — cominciate dalla procura nazionale antimafia di Pietro Grasso — ogni tanto prendono un'accelerazione e ogni tanto incomprensibilmente rallentano. Forse troppe prudenze, paura di toccare fili ad alta tensione. Ma ecco chi sono tutti gli accusatori di Giovanni Aiello e che cosa hanno detto di lui. Il primo è Vito Lo Forte, picciotto palermitano del clan Galatolo. La sintesi del suo interrogatorio: "Ho saputo che ci ha fatto avere il telecomando per l'Addaura, ho saputo che era coinvolto nell'omicidio di Nino Agostino e che era un terrorista di destra amico di Pierluigi Concutelli, che ha fatto attentati su treni e caserme, che ha fornito anche il telecomando per via D'Amelio". Poi Lo Forte parla del clan Galatolo che progettava intercettazioni sui telefoni del consolato americano di Palermo, ricorda "un uomo con il bastone" amico di Aiello che è un pezzo grosso dei servizi, che ogni tanto a "faccia da mostro" regalavano un po' di cocaina. Dice alla fine: "Era un sanguinario, non aveva paura di uccidere". E racconta che Aiello, il 6 agosto 1985, partecipò anche all'omicidio di Ninni Cassarà e dell'agente Roberto Antiochia: "Me lo riferì Gaetano Vegna della famiglia dell'Arenella. Dopo, alcuni uomini d'onore erano andati a brindare al ristorante di piazza Tonnara. Insieme a loro c'era anche Aiello, che aveva pure sparato al momento dell'omicidio, da un piano basso dell'edificio". Il secondo accusatore si chiama Francesco Marullo, consulente finanziario che frequentava Lo Forte e il sottobosco mafioso dell'Acquasanta. Dichiara: "Ho incontrato un uomo con la cicatrice in volto nello studio di un avvocato palermitano legato a Concutelli... Un fanatico di estrema destra... dicevano che quello con la cicatrice fosse uomo di Contrada (il funzionario del Sisde condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ndr) ". Il terzo che punta il dito contro Giovanni Aiello è Consolato Villani, 'ndranghetista di rango della cosca di Antonino Lo Giudice, boss di Reggio Calabria: "Una volta lo vidi... Mi colpì per la particolare bruttezza, aveva una sorta di malformazione alla mandibola... Con lui c'era una donna, aveva capelli lunghi ed era vestita con una certa eleganza". E poi: "Lo Giudice mi ha parlato di un uomo e una donna che facevano parte dei servizi deviati, vicini al clan catanese dei Laudani, gente pericolosa. In particolare, mi diceva che la donna era militarmente addestrata, anche più pericolosa dell'uomo ". E ancora: "Lo Giudice aggiunse pure che questi soggetti facevano parte del gruppo di fuoco riservato dei Laudani, e che avevano commesso anche degli omicidi eclatanti, tra cui quello di un bambino e di un poliziotto e che erano implicati nella strage di Capaci". Il quarto accusatore, Giuseppe Di Giacomo, ex esponente del clan catanese dei Laudani, di "faccia da mostro" ne ha sentito parlare ma non l'ha mai visto: "Il mio capo Gaetano Laudani aveva amicizie particolari… In particolare con un tale che lui indicava con l'appellativo di “ vaddia” (guardia, in catanese, ndr). Laudani intendeva coltivare il rapporto con “ vaddia” in quanto appartenente alle istituzioni ". Per ultima è arrivata la figlia ribelle di un boss della Cupola, Angela Galatolo. Qualche settimana fa ha riconosciuto Aiello dietro uno specchio: "È lui l'uomo che veniva utilizzato come sicario per affari molto riservati, me lo hanno detto i miei zii Raffaele e Pino". Tutte farneticazioni di pentiti che vogliono inguaiare un ex agente di polizia? E perché mai un pugno di collaboratori di giustizia si sarebbero messi d'accordo per incastrarlo? Fra tanti segreti c'è anche quello di un bambino ucciso a Palermo. Ogni indizio porta a Claudio Domino, 10 anni, assassinato il 7 ottobre del 1986 con un solo colpo di pistola in mezzo agli occhi. Fece sapere il mafioso Luigi Ilardo al colonnello dei carabinieri Michele Riccio: "Quell'uomo dei servizi di sicurezza con il viso sfigurato era presente quando fecero fuori il piccolo Domino". Poi uccisero anche il mafioso: qualcuno aveva saputo che voleva pentirsi. La figlia ribelle di un boss della Cupola ha incastrato l'uomo misterioso che chiamano "faccia da mostro". L'ha indicato come "un sicario" al servizio delle cosche più potenti di Palermo. È un ex poliziotto, forse anche un agente dei servizi segreti. Ed è sospettato di avere fatto stragi e delitti eccellenti in Sicilia. "Ne sono sicura, è lui", ha confermato Giovanna Galatolo dietro un vetro blindato. Così le indagini sulla trattativa Stato-mafia, sulle uccisioni di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino - ma anche quelle sul fallito attentato all'Addaura e probabilmente sugli omicidi di tanti altri funzionari dello Stato avvenuti a Palermo - dopo più di vent'anni di depistaggi stanno decisamente virando verso un angolo oscuro degli apparati di sicurezza italiani e puntano su Giovanni Aiello. Ufficialmente è solo un ex graduato della sezione antirapine della squadra mobile palermitana, per i magistrati è un personaggio chiave "faccia da mostro" - il volto sfigurato da una fucilata, la pelle butterata - quello che ormai si ritrova al centro di tutti gli intrighi e di tutte le investigazioni sulle bombe del 1992. "È lui l'uomo che veniva utilizzato come sicario per affari che dovevano restare molto riservati, me lo hanno detto i miei zii Raffaele e Pino", ha confessato Giovanna Galatolo, l'ultima pentita di Cosa Nostra, figlia di Vincenzo, mafioso del cerchio magico di Totò Riina, uno dei padrini più influenti di Palermo fra gli anni 80 e 90, padrone del territorio da dove partirono gli squadroni della morte per uccidere il consigliere Rocco Chinnici e il segretario regionale del partito comunista Pio La Torre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il commissario Ninni Cassarà. "È lui", ha ripetuto la donna indicando l'ex poliziotto dentro una caserma della Dia. Un confronto "all'americana", segretissimo, appena qualche giorno fa. Da una parte lei, dall'altra Giovanni Aiello su una piattaforma di legno in mezzo a tre attori che si sono camuffati per somigliargli. "È lui, non ci sono dubbi. Si incontrava sempre in vicolo Pipitone (il quartiere generale dei Galatolo, ndr) con mio padre, con mio cugino Angelo e con Francesco e Nino Madonia", ha raccontato la donna davanti ai pubblici ministeri dell'inchiesta-bis sulla trattativa Stato-mafia Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia. Un riconoscimento e poi qualche altro ricordo: "Tutti i miei parenti lo chiamavano "lo sfregiato", sapevo che viaggiava sempre fra Palermo e Milano... ". La figlia del capomafia - che otto mesi fa ha deciso di collaborare con la giustizia rinnegando tutta la sua famiglia - aveva con certezza identificato Giovanni Aiello come amico di Cosa Nostra anche in una fotografia vista in una stanza della procura di Caltanissetta, quella che indaga sulle uccisioni di Falcone e Borsellino. Dopo tante voci, dopo tanti sospetti, adesso c'è qualcuno che inchioda lo 007 dal passato impenetrabile, scivolato in un gorgo di inchieste con le ammissioni di qualche altro pentito e di alcuni testimoni. Sembra finito in una morsa, da almeno un anno Giovanni Aiello è indagato dai magistrati di quattro procure italiane - quella di Palermo e quella di Caltanissetta, quella di Catania e quella di Reggio Calabria - che tentano di ricostruire chi c'è, oltre ai boss di Cosa Nostra, dietro i massacri dell'estate siciliana del 1992. E anche dietro molti altri delitti importanti degli anni Ottanta. Ora, con le nuove rivelazioni di Giovanna Galatolo, la posizione dell'ex poliziotto è diventata sempre più complicata. Questa donna è la depositaria di tutti i segreti del suo clan, per ordine del padre faceva la serva ai mafiosi, cucinava, stirava, spesso lavava anche gli abiti sporchi di sangue, sentiva tutto quello che dicevano, vedeva entrare e uscire dalla sua casa i boss. E anche Giovanni Aiello. Giovanna Galatolo parla pure del fallito attentato dell'Addaura, 56 candelotti di dinamite che il 21 giugno del 1989 dovevano far saltare in aria Giovanni Falcone sugli scogli davanti alla sua villa. Erano appostati lì gli uomini della sua famiglia, i Galatolo. C'era anche Giovanni Aiello? E "faccia da mostro" è coinvolto nell'uccisione di Nino Agostino, il poliziotto assassinato neanche due mesi dopo il fallito attentato dell'Addaura - il 5 agosto - insieme alla moglie Ida? Il padre di Nino Agostino ha sempre raccontato che "un uomo con la faccia da cavallo" aveva cercato suo figlio pochi giorni prima del delitto. Era ancora Giovanni Aiello? La sua presenza è stata segnalata sui luoghi di tanti altri omicidi palermitani. Tutti addebitati ai Galatolo e ai Madonia. Lui, l'ex agente della sezione antirapine (quando il capo della Mobile era quel Bruno Contrada condannato per i suoi legami con la Cupola) ha sempre respinto naturalmente ogni accusa, affermando anche di non avere più messo piede in Sicilia dal 1976, anno nel quale si è congedato dalla polizia. Una dichiarazione che si è trasformata in un passo falso. Qualche mese fa la sua casa di Montauro in provincia di Catanzaro - dove Giovanni Aiello è ufficialmente residente - è stata perquisita e gli hanno trovato biglietti recenti del traghetto che da Villa San Giovanni porta a Messina, appunti in codice, lettere, titoli per 600 milioni di vecchie lire, articoli di quotidiani che riportavano notizie su boss come Bernardo Provenzano e su indagini del pool antimafia palermitano, assegni. Dopo quella perquisizione, gli hanno notificato a casa un ordine di comparizione per il confronto con la Galatolo, ha accettato presentandosi con il suo avvocato. Il riconoscimento di Giovanni Aiello segue di molti anni le confidenze di un mafioso al colonnello dei carabinieri Michele Riccio. Il confidente si chiamava Luigi Ilardo e disse: "Noi sapevamo che c'era un agente a Palermo che faceva cose strane e si trovava sempre in posti strani. Aveva la faccia da mostro". Era il 1996. Poco dopo quelle rivelazioni Luigi Ilardo - tradito da qualcuno che era a conoscenza del suo rapporto con il colonnello dei carabinieri - fu ucciso. Anche lui parlava di Giovanni Aiello? Le confessioni della Galatolo stanno aprendo una ferita dentro la Cosa Nostra palermitana. Non solo misteri di Stato e connivenze ma anche un terremoto all'interno di quel che rimane delle famiglie storiche della mafia siciliana. "Come donna e come persona non posso essere costretta a stare con uomini indegni, voglio essere libera e non appartenere più a quel mondo, per questo ho deciso di dire tutto quello che so", così è cominciata la "liberazione" di Giovanna Galatolo che una mattina dell'autunno del 2013 si è presentata al piantone della questura di Palermo con una borsa in mano. Ha chiesto subito di incontrare un magistrato: "Ho 48 anni e la mia vita è solo mia, non me la possono organizzare loro". Del suo passato, la donna ha portato con sé solo la figlia. L'uomo del mistero che chiamano "faccia da mostro" l'abbiamo trovato in un paese della Calabria in riva al mare. È sospettato di avere fatto omicidi e stragi in Sicilia, come killer di Stato. È un ex poliziotto di Palermo, ha il volto sfregiato da una fucilata. Vive da eremita in un capanno, passa le giornate a pescare. Quando c'è mare buono prende il largo sulla sua barca, "Il Bucaniere". Ogni tanto scompare, dopo qualche mese torna. Nessuno sa mai dove va. Sul suo conto sono girate per anni le voci più infami e incontrollate, accusato da pentiti e testimoni "di essere sempre sul luogo di delitti eccellenti" come ufficiale di collegamento tra cosche e servizi segreti. È davvero lui il sicario a disposizione di mafia e apparati che avrebbe ucciso su alto mandato? È davvero lui il personaggio chiave di tanti segreti siciliani? L'uomo del mistero nega tutto e per la prima volta parla: "Sono qui, libero, mi addossano cose tanto enormi che non mi sono nemmeno preoccupato di nominare un avvocato per difendermi". Ha 67 anni, si chiama Giovanni Aiello e l'abbiamo incontrato ieri mattina. Abita a Montauro, in provincia di Catanzaro. Da questo piccolo comune ai piedi delle Serre - il punto più stretto d'Italia dove solo trentacinque chilometri dividono il Tirreno dallo Jonio - sono ripartite le investigazioni sulle stragi del 1992. L'ex poliziotto trascinato nel gorgo di Palermo l'abbiamo incontrato ieri mattina, davanti al suo casotto di legno e pietra sulla spiaggia di contrada Calalunga. Sotto il canneto la sua vecchia Land Rover, in un cortile le reti e le nasse. "La mia vita è tutta qui, anche mio padre e mio nonno facevano i pescatori", ricorda mentre comincia a raccontare chi è e come è scivolato nella trama. È alto, muscoloso, capelli lunghi e stopposi che una volta erano biondi, grandi mani, una voce roca. Dice subito: "Se avessi fatto tutto quello di cui mi accusano, lo so che ancora i miei movimenti e i miei telefoni sono sotto controllo, dovrei avere agganci con qualcuno al ministero degli Interni, ma io al ministero ci sono andato una sola volta quando dovevo chiedere la pensione d'invalidità per questa". E si tocca la lunga cicatrice sul lato destro della sua faccia, il segno di un colpo di fucile. Tira vento, si chiude il giubbotto rosso e spiega che quello sfregio è diventata la sua colpa. Inizia dal principio, dal 1963: "In quell'anno mi sono arruolato in polizia, nel 1966 i sequestratori della banda di Graziano Mesina mi hanno ridotto così durante un conflitto a fuoco in Sardegna, trasferito a Cosenza, poi a Palermo". Commissariato Duomo, all'anti-rapine della squadra mobile, sezione catturandi. Giovanni Aiello fa qualche nome: "All'investigativa c'era Vittorio Vasquez, anche Vincenzo Speranza, un altro funzionario. Comandava Bruno Contrada (l'ex capo della Mobile che poi è diventato il numero 3 dei servizi segreti ed è stato condannato per mafia, ndr) e poi c'era quello che è morto". Di quello "che è morto", Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio del 1979, l'ex poliziotto non pronuncia mai il nome. Giura di non avere più messo piede a Palermo dal 1976, quando ha lasciato la polizia di Stato. Dice ancora: "Tutti quegli omicidi e quelle stragi sono venuti dopo, mai più stato a Palermo neanche a trovare mio fratello". Poliziotto anche lui, congedato nel 1986 dopo che una bomba carta gli aveva fatto saltare una mano. Giovanni Aiello passeggia sul lungomare di Montauro e spiega quale è la sua esistenza. Mare, solitudine. Pochissimi amici, sempre gli stessi. Sarino e Vito. L'ex poliziotto torna alla Sicilia e ai suoi orrori: "So soltanto che mi hanno messo sott'indagine perché me l'hanno detto amici che sono stati ascoltati dai procuratori, anche mio cognato e la mia ex moglie. E poi tutti frastornati a chiedermi: ma che hai fatto, che c'entri tu con quelle storie? A me non è mai arrivata una carta giudiziaria, nessuno mi ha interrogato una sola volta". Ha mai conosciuto Luigi Ilardo, il mafioso confidente che accusa un "uomo dello Stato con il viso deturpato" di avere partecipato a delitti eccellenti? "Ilardo? Non so chi sia". Mai conosciuto Vito Lo Forte, il pentito dell'Acquasanta che parla della presenza di "faccia da mostro" all'attentato all'Addaura del giugno 1989 contro il giudice Falcone? "Mai visto". Mai conosciuto il poliziotto Nino Agostino, assassinato nell'agosto di quello stesso 1989? "No". E suo padre Vincenzo, che dice di avere visto "un poliziotto con i capelli biondi e il volto sfigurato" che cercava il figlio qualche giorno prima che l'uccidessero? "Non so di cosa state parlando". L'uomo del mistero si tira su la maglia e fa vedere un'altra cicatrice. Una coltellata al fianco destro. "Un altro regalo che mi hanno fatto a Palermo". E ancora: "Tutti parlano di me come faccia da mostro, ma non credo di essere così brutto". Continua a raccontare, del giorno che passò la visita per entrare in Polizia: "Pensavo di essere stato scartato, invece una mattina mi portarono in una caserma fuori Roma e mi accorsi che io, con il mio metro e 83 di altezza, ero il più basso". Estate 1964. "Molto tempo dopo ho saputo che tutti noi, 320 giovanissimi poliziotti ben piantati, eravamo stati selezionati come forza di supporto - non so dove - per il golpe del generale Giovanni De Lorenzo". La famosa estate del "rumore di sciabole" contro il primo governo di centrosinistra, il "Piano Solo". Il primo intrigo dove è finito Giovanni Aiello. Forse non l'ultimo. Forse. Di certo è che su di lui oggi indagano, su impulso della direzione nazionale antimafia, quattro procure italiane. Quelle di Palermo e Caltanissetta per le bombe e la trattativa, quelle di Reggio Calabria e Catania per i suoi presunti contatti con ambienti mafiosi. I dubbi su "faccia da mostro" sono ancora tanti. Non finiscono mai.
Quando di un’inchiesta si appropriano i mass media, vincono le illazioni, i sospetti, i teoremi su una colpevolezza che viene data per certa quando ancora nessun giudice si è pronunciato. Il libro diventa un circostanziato atto d’accusa contro il circuito infernale che da troppi anni lega parte della magistratura a pezzi dell’informazione. Il dr Antonio Giangrande, cittadino avetranese, autore di decine di saggi, tra cui i libri su Sara Scazzi, denuncia in tutta Italia: ora basta questa barbarie !!!
Maurizio Tortorella, vicedirettore di “Panorama”, discute con tempi.it del rapporto fra procure e redazioni: «Non è dignitoso che un giornalista faccia “copia e incolla” dei documenti che la procura gli passa sottobanco». Carcerazione preventiva e giustizia politicizzata. Due argomenti che nella serata di venerdì, all’incontro “Aspettando giustizia” organizzato da Tempi a Milano, hanno avuto profonda risonanza. Le testimonianze del generale Mori, di Renato Farina e di Ottaviano Del Turco sono rappresentative di una giustizia che si mischia con la stampa, diventando una raffigurazione inquietante della società italiana. Tempi.it ne parla con Maurizio Tortorella, vicedirettore di Panorama e autore di un bel libro, La gogna (Boroli editore).
Quando nascono i primi processi a mezzo stampa?
«Tutto comincia con Tangentopoli. Anzi, ancora prima, quando nel 1989 una nuova modifica alla procedura penale cambia il procedimento tradizionale. Mentre prima le indagini erano portate avanti congiuntamente da due magistrati, il pubblico ministero e il giudice istruttore, che avanzavano congiuntamente, da quel momento il pm diventava l’unico titolare dell’azione penale. La polizia giudiziaria inizia a dipendere da lui. Per un tempo illimitato il pm decide su intercettazioni, perquisizioni e arresti, ecc. Nella sua azione diventa completamente libero. Ogni atto, poi, passa al vaglio del giudice preliminare, ma solo successivamente all’azione del pm. Non appena l’atto va a finire tra le mani dell’avvocato difensore dell’imputato e del giudice, diventa automaticamente pubblicabile. Spesso i pm hanno “amici” che lavorano in testate giornalistiche di cui condividono la visione politica. Questa stampa non aspetta la fine del processo, né tantomeno intervista la controparte, per gettare fango su imputati di cui non è ancora stabilita la colpevolezza».
Perché si è modificata la procedura penale?
«Si intendeva migliorare le nostre procedure penali. Il nostro codice aveva caratteristiche arretrate, ben lontane da quelle europee, considerate più moderne. Ma la cura è stata peggiore della malattia che si voleva debellare. Questo meccanismo infernale funziona anche laddove l’avvocato dell’indagato rifiuti di ritirare l’interrogatorio. È il caso di Guido Bertolaso. Sono usciti sulla stampa dei virgolettati di un interrogatorio che non potevano che venire dall’accusa, perché la difesa ha rifiutato il ritiro dei documenti. A quanto pare, è necessario sentire soltanto l’accusa per redigere un articolo».
La “gogna” mediatica colpisce tutti indiscriminatamente o ha una certa predilezione verso un colore politico?
«Il garantismo non è un’idea molto praticata in Italia. Un tempo, fino agli anni Settanta, era la sinistra a essere garantista, a fronte di una destra forcaiola che chiedeva più galera, pene pesanti e l’uso della custodia cautelare. Adesso, le parti si sono invertite. È la sinistra forcaiola a chiedere misure pesantissime, mentre il centrodestra ha un orientamento garantista».
Pubblicare stralci di documenti prima della sentenza segue la deontologia professionale?
«Si dovrebbero ascoltare più voci e diversi punti di vista prima di toccare temi così delicati. Trovo mortificante che in troppi casi un pezzo si risolva aspettando che dalla procura arrivino delle carte. Non è dignitoso che un giornalista faccia “copia e incolla” dei documenti che la procura gli passa sottobanco. Se consideri che il pm di Palermo, dopo che Panorama ha pubblicato parte dell’intercettazione tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l’ex ministro Nicola Mancino, ha smentito di aver passato lui stesso le carte, giustificandosi che Panorama non è un giornale “amico”, ti spaventi. Perché significa che ci sono media “amici” e media “nemici”. E quelli amici, inevitabilmente, sono dello stesso colore politico del magistrato in questione».
La carcerazione preventiva e le lungaggini della giustizia italiana aiutano “la gogna”?
«Certo. Nello Rossi, procuratore aggiunta a Roma e appartenente a Magistratura democratica, ammette che oggi ha più impatto un arresto di una sentenza di primo grado. Perché? Sul piano emotivo, l’immediatezza di un arresto ha più effetto di una sentenza, che impiega anni prima di essere confermata o smentita. Nessuno più segue i processi – come quello di Ottaviano Del Turco – perché questi si svolgono sui giornali. Il vero processo è di carta.
Sbattere il mostro in prima pagina: quando l’orco è uno di noi, scrive in un suo editoriale Raffaella De Grazia. Massimo e Carlo, padri di famiglia realizzati e felici. Massimo e Carlo, lavoratori stacanovisti dalla vita senza ombre. Sono i vicini di casa ideali, i mariti fedeli, coloro ai quali affidereste volentieri i vostri figli, gli amici di mille bevute al bar, mentre si guarda l’ennesima partita di calcio. Se è vero ciò che sostiene Goya – e cioè che “Il sonno della ragione genera mostri” – allora Massimo e Carlo sono gli esempi più eclatanti di come, spesso, la ricerca dell’esecutore di crimini tanto efferati quanto immotivati che macchiano di sangue il nostro Bel Paese debba essere indirizzata poco lontano dalle sempre meno rassicuranti mura domestiche, più vicino a quella che l’uomo medio, erroneamente, denomina la “zona sicura”. Il “mostro”, identificato comunemente come lo sconosciuto, lo “straniero” che porta via la serenità ad una piccola comunità pare essere, invece, sempre più spesso un componente della stessa. E’ inserito perfettamente nel tessuto sociale del paese che gli ha dato i natali, contribuisce all’economia autoctona, conosce tutto di tutti. Nessuno dei suoi parenti o amici ha però idea del suo “lato oscuro”, delle sue perversioni inconfessabili, nemmeno nell’attimo stesso in cui il mostro le confessa, lasciando attoniti persino i più diffidenti tra i suoi conterranei. Il caso di Avetrana ha fatto tristemente “scuola” in tal senso. Come dimenticare lo sgomento di parenti, amici e vicini di casa nel conoscere la vera, presunta natura della famiglia Misseri, umili braccianti fuori le mura domestiche ma, al contempo, spietati killer di una 15enne, peraltro loro stretta parente? Eventi drammatici come il caso di Sarah Scazzi hanno catalizzato l’attenzione mediatica, generando un’ondata di morboso interesse attorno a simili crimini dettati dall’odio. Nello stesso periodo in cui le indagini sull’omicidio della piccola Sarah proseguivano – tra dichiarazioni ufficiali e smentite mezzo stampa – un’altra piccola, innocente creatura spariva, inghiottita dal nulla. Si trattava della 13enne Yara Gambirasio, grande sorriso e voglia di vivere appieno la sua adolescenza, oramai alle porte. Il mostro che ha privato la 13enne Yara del suo bene più prezioso – il diritto alla vita – è stato cercato ovunque. Sin dagli istanti successivi alla sua sparizione, però, il dito dell’intera comunità di Brembate di Sopra e non solo era stato puntato solo contro un operaio extracomunitario. Qual era la sua colpa? Ai compaesani di Yara era forse sembrato più facile “sbattere in prima pagina” un “corpo estraneo” alla propria comunità? Erano tanti i dubbi che circolavano attorno ad un caso così complesso, con pochi reperti a disposizione. Di certo c’è che mai nessun abitante di Brembate avrebbe immaginato di dover cercare il mostro proprio vicino a casa propria, di identificarlo nelle vesti dell’ uomo qualunque, sposato, incensurato e papà di tre figli piccoli. Ancora più cruenta è stata la svolta nel terribile, triplice omicidio di Motta Visconti. Cristina, Giulia e Gabriele hanno perso la vita per mano di una persona talmente vicina a loro da risultare assolutamente insospettabile. Ricordiamo, quasi sempre, più facilmente i nomi dei killer che delle proprie vittime, quando non dovrebbe essere così. Difficilmente, però, dimenticheremo quei volti, visibilmente felici nelle foto di rito, la cui esistenza è stata strappata via per motivi tanto futili quanto squallidi. Voleva un’altra donna il “papà-mostro” che, nella notte d’esordio “mondiale” della nostra Nazionale, ha ucciso senza pietà sua moglie ed i suoi due piccoli bimbi, di appena 5 anni e 20 mesi. Una storia raccapricciante che, man mano che il tempo passa, si arricchisce di orpelli sempre più orridi. Un altro mostro dalla faccia pulita, che sorride beffardo abbracciando sua moglie. Un altro mostro da sbattere in prima pagina, per non dimenticare l’orrore perpetrato dall’uomo comune.
Di che ci stupiamo?
Yara, fermato un uomo. E’ già il killer, scrive “Il Garantista”. Non è detto che sia la fine del giallo iniziato quattro anni fa ma di sicuro, dopo mesi di stasi apparente nelle indagini, si configura come una svolta cruciale l’arresto di uomo di quaranta anni accusato di essere l’assassino di Yara Gambirasio. A riferire della cattura del presunto colpevole è il ministro dell’Interno in persona: «Le forze dell’ordine, d’intesa con la magistratura, hanno individuato l’assassino di Yara Gambirasio. E’ una persona dello stesso paese dove viveva la vittima»- annuncia Alfano. Ad incastrare l’uomo, un muratore della provincia di Bergamo, sposato e padre di tre figli, sarebbe stata l’analisi del suo Dna che è stato ritenuto dagli esperti sovrapponibile con le tracce biologiche ritrovate sul corpo di Yara ( che era astato rinvenuto il 21 febbraio 2011 dopo quasi un anno di estenuanti ricerche). Per maggiori dettagli Alfano invita ad essere pazienti e aspettare le prossime ore. Pazienza di cui però il ministro e la maggior parte dei media non hanno dato prova additando un uomo che non è nemmeno ancora stato messo sotto processo come inequivocabilmente colpevole.
Caso Yara, così la stampa sbatte il mostro in prima pagina, scrive Angela Azzaro su “Il Garantista”. Un presunto colpevole – al solito – che diventa senza dubbio l’assassino. Un fermato che viene dato – al solito – in pasto alla rabbia del popolo. Le indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio sono diventate una brutta pagina di giornalismo e politica, e stavolta non è colpa della magistratura. Anzi, la procura di Bergamo, a poche ore dal fermo di Massimo Giuseppe Borsetti, è dovuta intervenire in polemica con il ministro dell’Interno. Perché Alfano aveva dato la notizia parlando di “assassino”. Sentenza già emessa. Il procuratore Francesco Dettori si è sentito obbligato a intervenire, per correggere: «Volevamo il massimo riserbo. Questo anche a tutela dell’indagato in relazione al quale, rispetto alla Costituzione, esiste la presunzione di innocenza». Il capo del Viminale – ex ministro della Giustizia – questi dettagli del diritto non li conosce bene. Perciò ha tuonato, mettendo da parte ogni dubbio: il popolo italiano «aveva il diritto di sapere e ha saputo per essere rassicurato». L’intervento di Alfano ha provocato un vero e proprio linciaggio. Rafforzati dall’intervento del ministro, quasi tutti i giornali, sia nella versione cartacea ma soprattutto in quella on line, hanno dato libero sfogo alla caccia al mostro. Il muratore fermato è diventato immediatamente il reietto, la sua foto sbattuta in prima pagina. Con facebook ci vogliono pochi secondi, si entra nei profili, si prende l’immagine e si fa girare con scritto: è lui il killer. Ma è facile anche prendere altre foto, come quelle con i tre figli, due bambine e un bambino, o quelle con la moglie, adesso chiusi in casa per paura di ripercussioni. La caccia al mostro: giornali all’assalto. Tra i titoli peggiori letti ieri, spicca quello di Repubblica. “E’ lui l’assassino di Yara”, dove le virgolette servono formalmente per riprendere la dichiarazione di Alfano, sostanzialmente sono un modo per condannare ma salvandosi la coscienza. Senza ipocrisie, Libero (“Preso l’assassino di Yara”) e il Giornale che mette insieme Yara e il caso di Motta Visconti (“Schifezze d’uomini”). Su molti quotidiani campeggiava la foto del “colpevole” e vicino, quasi citazione di un mondo che fu, la parola “presunto”. A non mettere in prima pagina la foto del mostro solo pochi giornali, tra cui il Corriere (che la pubblica all’interno, ma l’aveva pubblicata sull’home-page dell’on line) e l’Unità. Per il resto un lancio di pietre virtuali e l’indicazione della via dove abita la famiglia del fermato, fosse mai che qualcuno voglia provare a farla pagare a loro. Un caso esemplare di gogna mediatica. Certo, non è la prima volta che assistiamo a processi sommari di questo tipo. Sempre più spesso in Italia la presunzione di innocenza è un valore costituzionale di cui vergognarsi. Sono tanti i casi soprattutto di cronaca che diventano processi pubblici, senza né primo, né secondo, né terzo grado di giudizio. La sentenza è immediata, la condanna certa. E poco importa se poi nelle aule di tribunale mancano le prove certe. Questa volta però è accaduto qualcosa di più grave: un ministro dell’Interno che dovrebbe far rispettare le regole è stato il primo a “tradirle” in nome del clamore e della pubblicità personale che avrebbe potuto ricavare dalla vicenda. Del resto, bisogna dire che non è la prima volta che i giornali annunciano la cattura dell’assassino di Yara. Con la stessa certezza di oggi descrissero come mostro un ragazzetto egiziano, arrestato 24 ore dopo l’omicidio, e che – si seppe dopo un paio di settimane – con l’omicidio non c’entrava niente di niente ed era stato fermato per un clamoroso errore degli inquirenti. Proprio un caso come questo, così estremo, ci aiuta a capire ancora meglio come il rispetto delle regole sia fondamentale. Tutto fa pensare che Massimo Giuseppe Borsetti sia colpevole, ma proprio per questo dobbiamo essere cauti, per far sì che il processo si svolga nel migliore dei modi, senza interferenze e senza decidere al posto dei giudici. Solo così si può garantire una giustizia giusta e non processi sommari. Ma soprattutto solo in questo modo possiamo evitare di diventare meno umani, più incivili. Il sangue richiama sangue. La parola assassino solletica gli istinti peggiori. Dopo l’arresto del presunto assassino di Yara e dopo la confessione di Carlo Lissi di aver ucciso lui la moglie e due figli a Motta Visconti, sul web è partita una gara a chi la sparava più grande. Dall’ergastolo alle pene corporali. Fino alla richiesta di ripristinare la pena di morte, avanzata da Stefano Pedica, esponente della direzione del Pd, e dal suo compagno di partito, il senatore Stefano Esposito.
Yara: l'oscenità della giustizia-spettacolo, scrive Marco Ventura su “Panorama”. La cattura del presunto killer doveva avvenire senza clamori, proteggendo innocenti e minori. Invece, nel tritacarne, ci sono finiti tutti. Uno spettacolo immondo, inaccettabile, folle. Senza nulla di umano, di corretto, di giustificato. È la vicenda-spettacolo della cattura del presunto assassino di Yara Gambirasio. Una storia terribile, data in pasto senza le dovute cautele - complici autorità e giornalisti - a una pubblica opinione insieme respinta e attratta, attonita ma anche, forse, perversamente golosa dei particolari raccapriccianti, addirittura piccanti, di uno dei più clamorosi delitti di cronaca degli ultimi anni: Yara, la ragazzina di 13 anni uccisa il 26 novembre 2010 e ritrovata dopo tre mesi. Questa tragedia è diventata un thriller, un giallo, uno show, un noir, una gara a chi annuncia per primo la chiusura del caso (che non c’è). A chi ricama meglio. Sui giornali, in televisione, su Twitter. Senza ritegno, senza alcun rispetto per le famiglie coinvolte. Un intreccio sul quale ha improvvidamente alzato il sipario il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, quando secondo i magistrati non erano ancora concluse le operazioni di convalida del fermo del presunto assassino, Massimo Giuseppe Bossetti. Da dove cominciare per dire quanto dovremmo provare disagio per noi stessi, per questo paese, per chi ha gestito la vicenda? Potrei cominciare da un’ipotesi che oggi pare assurda ma che troppi errori giudiziari inducono a non considerare così improbabile: l’ipotesi che l’arrestato sia innocente. A dispetto delle notizie trapelate sul test del Dna confrontato con la macchia di sangue rinvenuta sugli slip della vittima. A dispetto delle convinzioni degli inquirenti (i primi però a invitare alla cautela, perché la prova del Dna non è certa al mille per mille, parliamo sempre di probabilità). L’altro elemento è la quantità di vite umane gettate nel tritacarne di una troppo affrettata divulgazione delle indagini. Adulti e minori, padri e patrigni, figli e figlie, gemelli, fratelli e fratellastri, madri, amanti, cugini, suoceri, amici... Ormai sappiamo tutto (dell’accusa). Il carpentiere sarebbe figlio illegittimo della relazione tra un autista morto (e riesumato) e una donna sposata. L’autista ha una vedova e tre figli (che non c’entrano nulla ma si ritrovano sulle prime pagine dei giornali: un imprenditore “di successo”, una madre “felice” e un idraulico “stimato”). I cronisti di “Repubblica” scrivono che tacciono, “introvabili dietro i loro citofoni nel centro di Clusone”. Già. L’assedio è cominciato, chissà quanto dovrà durare. C’è la madre del presunto assassino, che nega la relazione clandestina ma nessuno le crede e viene descritta come “la donna dei misteri”, barricata dietro le persiane della sua casa di Terno d’Isola. Addirittura i giornalisti abbozzano sentenze: lei assicura che Massimo “è figlio naturale di mio marito”, e così “tenta di salvarlo dalle accuse che lo hanno travolto”. Ecco i sospetti, nascosti dietro punti interrogativi. Lei cerca “di difendere anche di fronte all’evidenza quel segreto inconfessabile che solo gli esami del Dna hanno potuto svelare? E soprattutto: è stata lei negli ultimi mesi più consapevole del figlio che il cerchio delle indagini si stava stringendo attorno a Massimo?”. Già, perché tutti a chiedersi se Massimo sapesse, a sua volta, di essere figlio illegittimo di un altro padre. E con lui la sorella gemella. Poi c’è il terzo figlio, fratellastro di Massimo, di nome e di fatto del padre che non sa più se credere alla moglie e affronta il rovello di un possibile adulterio di oltre quarant’anni fa. Poi ci sono i figli del presunto omicida. Che sono piccoli, hanno 13, 10 e 8 anni. Da chi hanno saputo che il padre è accusato di un delitto così efferato? Come potranno proteggersi se l’altro giorno, durante il primo interrogatorio di Bossetti, tutti sapevano tutto e qualcuno pensava al linciaggio? C’è la moglie del presunto assassino, e madre dei tre bambini (la madre, suocera dell’arrestato, viene fotografata mentre si affaccia a una finestra col cane). Ovviamente diventa titolo sui giornali che lei non fornisca un alibi al marito. Dice di non ricordare. “È strano, molto strano”, osserva il “Corriere della Sera”. “Perché quel 26 novembre del 2010 quando Yara sparì all’improvviso, la notizia circolò velocemente. E già durante la notte cominciarono le ricerche diventate poi mobilitazione di centinaia di persone per giorni e giorni”. Fino al 26 febbraio 2011, quando fu ritrovata. “Possibile che una persona della zona, per di più mamma, non ricordi che cosa ha fatto quella sera?”. Io dico: è possibile eccome. “Che non abbia tenuto a mente ogni dettaglio e spostamento del marito, dei figli, degli altri familiari. Il dubbio è che lei sappia tutto, ma abbia così deciso di marcare la distanza dall’uomo diventato il mostro”. Ma se sono passati tre anni e mezzo! Ma come si fa a tranciare sospetti così. Non mi è piaciuto neppure l’incontro del Procuratore di Brescia, Pier Luigi Maria Dell’Osso, con i giornalisti, quelle risate sull’adulterio e sulla gemella di Bussetti come “complicazione” per le indagini. Tutto assurdo, tutto fuori luogo. E dire che invece il questore di Bergamo, Fortunato Finolli, ha correttamente e ripetutamente precisato che il caso non è per nulla chiuso, che bisogna ancora fare accertamenti e che poi dovrà tenersi il processo, “con le dovute risultanze e il dovuto contraddittorio”. Era tanto difficile mantenere questa linea? Infine, la parte più tragica, quella dei genitori di Yara, costretti a leggere dopo tanti anni che nelle tre pagine con cui il pubblico ministero dispone il fermo di Bossetti ci sono quelle righe che fanno titolo sui giornali: “con l’aggravante di avere adoperato sevizie e avere agito con crudeltà”. Sì, i genitori di Yara sono i più cauti e taciturni. Gli unici, quasi, all’altezza di questo mare di sofferenze. E sono quelli che hanno sofferto (e soffrono) di più. Non spetta a un ministro condannare un indagato, scrive Riccardo Arena su “Il Post”. l processo penale si celebra solo nelle aule di giustizia (e non sui giornali). La sentenza di condanna viene pronunciata solo da un giudice (e non da un Ministro dell’Interno). Ogni imputato è presunto non colpevole fino a condanna definitiva. Sono questi concetti ovvi per un Paese che si dice civile. Concetti che evidentemente non sembrano così ovvi per il Ministro dell’Interno Angelino Alfano. Ministro che si è affrettato ad emettere la sua condanna definitiva nei confronti di un indagato. “Le forze dell’ordine” ha sentenziato Alfano “hanno individuato l’assassino di Yara”. Una frase categorica capace di superare la necessità di celebrare un processo. Un’affermazione lapidaria che si è sostituita a tre gradi di giudizio: Corte d’Assise, Corte d’Appello e Corte di Cassazione. Eppure nessuna norma attribuisce al Ministro dell’Interno il compito di emettere sentenze né di diffondere notizie che riguardano esclusivamente le attività istituzionali dei magistrati. Attività dei magistrati che, soprattutto quando riguardano casi che sono nella fase delle indagini, necessitano del massimo riserbo. Riserbo che se violato potrebbe nuocere alle indagini stesse. Ma c’è dell’altro. La gogna politica di Alfano ha prodotto anche una gogna mediatica su tanti giornali. Una gogna mediatica fatta di titoli in prima pagina che hanno riportato tra le virgolette la sentenza emessa da Alfano: “Yara, preso l’assassino”. È la contaminazione dell’errore. È l’epidemia del decadimento. Resta infine un ultima perplessità: perché il ministro Alfano si è spinto tanto oltre? Al momento non è dato saperlo, anche se è preferibile non pensare al peggio. Ovvero che lo abbia fatto per ragioni di visibilità. Approfittare dell’omicidio di una tredicenne per andare sui giornali sarebbe una condotta davvero inqualificabile. Forse anche peggiore che fingersi giudice.
Caso Scazzi. La pubblica opinione è la "Cavia" di chi ha il potere di trasmettere formule retoriche elementari e ripetitive..., scrive Gilberto Migliorini. Alla fine il topolino partorisce la montagna. Forse l’opera strapperà il primato À la recherche du temps perdu in sette volumi di Marcel Proust. Non tanto per la lunghezza quanto per il tema della rievocazione come oeuvre cathédrale, con quella memoria spontanea e creativa. Come era del tutto logico prevedere, tutto un sistema di sillogismi (teoremi) può risultare una corposa esercitazione di verità apodittiche e dimostrazioni congetturali. Quando ci si avventura sulla strada delle inferenze induttive, quando si dimenticano i fatti e si introducono interpretazioni senza metterle al vaglio di altri fatti, quando non si tiene conto che i testimoni sono suggestionabili dal sistema mediatico e che più ci si allontana nel tempo da un evento tanto più subentrano fisiologicamente mille cose a inquinare e deformare la memoria… si finisce per dar credito alle fantasie, alle illazioni e alle deduzioni senza base empirica, scambiando per prove quelli che sono solo indizi lacunosi e inconsistenti, ricostruzioni di fantasia. Ne nasce un mastodontico zibaldone da leggere come una prolissa inventio di accadimenti, magari anche avvincente, ma priva di quella che si suole chiamare verosimiglianza. Il caso ricorda il feuilleton, quel romanzo d’appendice pubblicato a episodi e rivolto a un pubblico di massa, di bocca buona. I detrattori direbbero di un sottogenere letterario che anticipa certi moderni rotocalchi o le novelle di riviste prevalentemente femminili. Non a caso una delle opere più famose è i Misteri di Parigi (Les Mystères de Paris), di Eugène Sue, romanzo pubblicato a puntate, fra il 1842 e il 1843 su Le Journal des Débats. Non è da dimenticare che dai Misteri di Parigi trarrà ispirazione Victor Hugo con la prima versione de I miserabili (intitolata Les mystères) e Alexandre Dumas (padre), con il suo Edmond Dantès. Il romanzo d'appendice inaugura quella letteratura di massa che ai giorni nostri è andata annacquandosi nel genere dei rotocalchi e soprattutto nei format televisivi nazional-popolari. L’attuale romanzo d’appendice televisivo ha perso qualsiasi velleità letteraria per diventare soltanto un sistema di gossip salottiero con divagazioni psico-sociologiche da accatto, connotate da una sorta di narcisismo retorico da libro cuore (Les Mystères de Paris conservava invece ispirazione e perfino denuncia dei mali sociali, contro la società del suo tempo, contro un sistema giudiziario ed economico incapace di punire i veri colpevoli, anticipando le più complesse e approfondite analisi del naturalismo dei fratelli Goncourt, di Zola e del verismo italiano). Tutta la storia relativa al caso di Avetrana è ricca di misteri, cominciando dalle strane confessioni di Michele, ma nello stesso tempo risulta un caso senza capo né coda, un insieme di fotogrammi spaiati e senza logica. Nulla che abbia la parvenza di un mosaico dove le tessere si embricano con naturale verosimiglianza, sembra piuttosto un collage dove tutto ha l’apparenza di un quadro surreale, quasi un sogno con un incubo al risveglio. Evidentemente c’è un’altra verità che sfugge alla comprensione. Solo un’indagine che riparta da zero può riuscire a mettere insieme le tessere del puzzle senza pregiudizi e senza teoremi, con esiti che potrebbero risultare del tutto imprevedibili, forse perfino ribaltando ruoli e status dei personaggi. Di certo e assodato, c’è solo il corpo della povera ragazza in fondo al pozzo e quelle strane narrazioni di Michele, con un carattere vagamente onirico, e quei sogni che fanno da contraltare a una vicenda avvolta in una sorta di fantasia spettrale. Tanti operatori del settore criminologico (omicidi irrisolti) che affollano gli studi televisivi dimostrano notevoli capacità dialettiche quando discettano di cold case. Un florilegio di analisi e di affermazioni fondate su fantasticherie, dicerie, astruserie, pressapochezze… i classici ragionamenti per assurdo, sillogismi formulati senza il ben che minimo riscontro, tutto sulle spalle di poveri cristi messi alla berlina e senza che nessun settore del parlamento italiano abbia niente da ridire, rappresentanti politici solitamente così pronti ad attivarsi quando si invocano i diritti inalienabili della difesa per uno di loro fino al completamento di tutto l’iter giudiziario. Due imputate sono tenute in galera con motivazioni a dir poco sorprendenti in attesa dei successivi gradi di giudizio. Ovvio che due donne di estrazione contadina - che tutto un sistema massmediatico ha provveduto a rappresentare come diaboliche e perverse assassine - sono in grado con la loro rete di connivenze e di conoscenze non solo di inquinare le prove servendosi del loro mostruoso sistema di supporto e di protezione, ma, fidando su relazioni internazionali distribuite in vari paesi, possono proditoriamente sottrarsi con la fuga in qualche paradiso fiscale dove hanno accumulato cospicue risorse finanziarie grazie alla loro attività come bracciante agricola e estetista a tempo perso. Un sistema di linciaggio morale nei confronti di altri presunti colpevoli di omicidio (fino a sentenza definitiva), o semplicemente di persone entrate per caso in qualche cold case, va avanti ormai da anni (salvo qualche meritoria eccezione di opinionisti garantisti) in trasmissioni televisive che fanno illazioni e ricavano teoremi non già attraverso inchieste basate su dei fatti - mediante una meticolosa e obiettiva ricerca di riscontri, magari sul modello della controinchiesta tesa a sottolineare i dubbi e le incongruenze a favore del più debole o del meno ‘simpatico e fotogenico’ - ma su delle interpretazioni capziose con l’unico fine di creare audience indipendentemente da criteri di verità, obiettività e trasparenza. A questo si aggiungono sedicenti esperti che forniscono interpretazioni scientifiche senza indicare alcun criterio epistemologico, ma solo sulla base di considerazioni empiriche o semplicemente di impressioni soggettive. Semplificazioni che farebbero inorridire qualunque investigatore serio abituato a esercitare il dubbio e a relativizzare le conclusioni in ragione della complessità della realtà investigativa (con tutte le sue implicazioni giuridiche e metodologiche). Si tratta dei limiti di qualsiasi stereotipo di indagine applicato a situazioni che non sono mai quelle di laboratorio in cui si possono individuare con assoluta certezza le variabili (dipendenti e indipendenti) in una situazione controllata. Programmi con opinionisti che parlano spesso senza cognizione di causa, senza veri strumenti interpretativi, senza esperienza sul campo… ma influenzando e orientando un’opinione pubblica educata alla superficialità. Un processo di retroazione che finisce per determinare una sorta di profezia che si autoadempie attraverso l’individuazione di colpevoli sulla base esclusivamente di una influenza mediatica che nei casi più estremi diventa psicosi collettiva e ricerca di un capro espiatorio. Tutto questo avviene soprattutto in periodi di crisi, quando le difficoltà socio-economiche delle famiglie e la ricerca di compensazioni alle frustrazioni e all’angoscia del futuro determinano situazioni di stress e il bisogno di scaricare tensioni e difficoltà emozionali attraverso identificazioni proiettive e protagonismi per interposta persona. Da anni si effettua una sorta di teatro dell’assurdo con giudizi sommari attraverso format ammantati di approfondimento informativo con un circo di opinionisti dall’aria da Sherlock Holmes, armati vuoi di un armamentario da detective improvvisato e vuoi con teorie vagamente neo-lombrosiane, frenologiche, o vuoi semplicemente con il supporto dell’autorevolezza presenzialista di volti da sempre incorniciati nel rettangolo del televisore. La locuzione in dubbio pro reo assume un valore puramente teorico se non entra a far parte dei processi di inferenza logica già nella fase preliminare delle indagini, come forma mentis, in caso contrario, una volta presa una strada è come viaggiare sui binari della ferrovia andando in capo al mondo (un mondo per lo più inventato attraverso teoremi fantasiosi e prove(tte) abborracciate con molta fantasia e zero riscontri. Il dubbio investigativo dovrebbe costituire l’abito mentale di qualsiasi ricerca in qualsiasi ambito. Quel dubbio metodico che consente di tornare continuamente sui propri passi per verificare che qualche perverso particolare possa aver messo l’indagine su una strada sbagliata. Con l’avvento delle prove scientifiche, armi notoriamente a doppio taglio se usate come verifica, e non come falsificatori potenziali, si possono davvero fare danni notevoli. Alcuni sanno lavorare con metodo e consapevolezza, ma altri scambiano un indizio per un passepartout che in quattro e quattr’otto risolve un caso miracolosamente. Siamo tutti in pericolo di errore giudiziario, e senza voler fare di ogni erba un fascio, perché il lavoro dell’inquirente e del giudice è duro, difficile e oneroso (e in qualche caso molto pericoloso quando si ha a che fare con la delinquenza organizzata come la storia del nostro paese dimostra con veri eroi che hanno pagato con la vita l’abnegazione e il servizio alla collettività). Occorre però dire che spesso si ha l’impressione che la categoria si chiuda a riccio in una autodifesa, a prescindere, quando qualcuno dei suoi rappresentanti non si dimostra all’altezza...Il caso di Michele Misseri è poi emblematico. Si tratta di un contadino che in più di un’occasione ha dimostrato di trovarsi in un grave stato confusionale, che ha accumulato una serie di confessioni (narrazioni) diverse, contraddittorie e inattendibili, un teste che porta indizi senza prove, che dichiara cose senza riscontri (nessun elemento che attesti che nella casa di via Deledda sia avvenuto un delitto, nessun elemento che dimostri che la sua auto abbia trasportato un cadavere, nessun elemento che provi che lui abbia infilato il cadavere nel pozzo, nessuna prova che la povera Sarah abbia raggiunto la casa di via Deledda. L’uomo, in palese stato di sofferenza psichica, non viene sottoposto a perizia psichiatrica per capire qualcosa di più della sua personalità, se per caso non sia stato invece semplice testimone di qualcosa che lo ha sconvolto emotivamente. Tornando ai mass media e alla loro utilizzazione, occorre dire che l’influenza sull’opinione pubblica è tale da determinarne l’orientamento e da influenzarne l’interesse puntando sulla spettacolarizzazione e facendo leva sulla curiosità morbosa e sul giudizio di pancia, abituando il target a dare valutazioni basate sull’emotività e sul disimpegno. Tale atteggiamento è tanto più diseducativo quanto più trasforma l’audience in un modello di elettore sempre meno informato e che offre risposte pavloviane. Non a caso i cold case, in quanto casi irrisolti e problematici, rappresentano un test di influenza e un banco di prova su un target sprovvisto di autonomi e adeguati strumenti interpretativi, sempre più influenzabile attraverso l’uso di format che ne orientano le scelte e le modalità di reazione, con input emozionali programmati secondo il vecchio e inossidabile modello SR. Il caso in parola risulta emblematico, dal punto di vista mediatico, della facilità con la quale l’opinione pubblica può essere influenzata utilizzando una comunicazione basata su formule retoriche elementari e ripetitive e senza mai mettere in dubbio i contenuti espressi dall’autorevolezza del mezzo televisivo…
Quando la giustizia semina morti si chiama ingiustizia: Mimino Cosma è uno dei tanti uccisi dalla malagiustizia? Scrive Massimo Prati sul suo Blog, Volando Controvento. Per tanti di noi è difficile capire cosa significhi vivere nello stress e cosa lo stress porti in dote al fisico umano. Parlo in special modo dei giovani, di quelli fortunati che non hanno mai avuto a che fare con le disgrazie e vivono ancora nella leggerezza della loro età senza mai essere passati fra quelle brutte esperienze che cambiano il modo di vedere la vita. Inoltre, non tutte le persone soffrono in maniera cruenta lo stress: questo perché non siamo tutti uguali, non tutti reagiamo alla stessa maniera e non tutti siamo costretti a vivere quelle tragedie familiari che stroncano il pensiero e marciscono la speranza. Eppure i periodi stressanti esistono e prima o poi toccano a tutti noi. Chi non trova lavoro e non sa come andare avanti soffre di stress. Chi ha una famiglia e non sa come mantenerla soffre di stress. Una donna incinta che non si sente pronta a diventare madre soffre di stress. Suo marito, a cui un figlio cambierà radicalmente la vita, soffrirà di stress. Chi subisce la morte improvvisa di un padre o di una madre, perdendo un punto di riferimento importante, soffre di stress. Chi subisce la morte improvvisa di un figlio, perdendo quanto di più caro aveva al mondo, soffre di stress. Lo stress è sempre dietro l'angolo, pronto a colpire chiunque nei momenti meno attesi. Anche le persone a cui pare andare tutto bene. Per capire a cosa portino i periodi stressanti, possiamo far riferimento a diversi studi scientifici. Ad esempio il Brain and Mind Research Institute dell'Università di Sydney, ha pubblicato una ricerca sul Medical Journal of Australia in cui stabilisce che l'infarto è provocato dallo stress che eventi diversi possono scatenare nell'uomo. Ma non è lo stress da lavoro che uccide, non è quello che si prova in ufficio o in una catena di montaggio. No, a uccidere è quello provocato da fatti imprevisti, straordinari, e da tragedie familiari. Un altro studio, questa volta dei ricercatori della Ohio State University, pubblicato sul "Journal of Clinical Investigation" nell'agosto del 2013, ha cercato di stabilire come i tumori possano svilupparsi in caso di stress. Da tempo immemore la scienza ha ipotizzato una correlazione fra stress e cancro, senza però mai individuare un nesso concreto che portasse a una conferma della supposizione. Ma la ricerca non ha smesso di studiare e sperimentare, ed ora gli scienziati statunitensi hanno trovato nel gene ATF3 la possibile chiave per lo sviluppo e la diffusione delle metastasi, con la conseguente morte per cancro. In particolare si può dire che il gene era già conosciuto e già si sapeva che si attivava in condizione di stress. Ciò che gli esperimenti hanno dimostrato è che il gene non solo uccide le cellule sane, ma agendo in modo irregolare aiuta anche la proliferazione delle metastasi. "Se il corpo è in perfetto equilibrio - ha affermato lo scienziato Tsonwin Hai - non è un gran problema. Quando il corpo è sotto stress, però, cambia il sistema immunitario. E il sistema immunitario è una lama a doppio taglio". Detto questo c'è da star certi che l'essere indagati in un caso criminale dal grande profilo pregiudizievole, e dalla grande eco mediatica (essere indagati da una procura, ormai si è capito, significa anche essere additati dai compaesani a causa del pregiudizio iniettato nel popolo da giornalisti e opinionisti sapientoni), porta stress al fisico che più facilmente può subire un infarto o una malattia incurabile. Per averne conferma si potrebbe cadere nella tentazione di ricordare sin da subito il compianto Enzo Tortora, morto di tumore dopo anni di tortura mediatica e pregiudizi. Ma non serve scomodare il caso più eclatante della nostra stampa, perché tanti più gravi (ma meno pubblicizzati) stanno a dimostrare che chi viene indagato, se innocente, soffre in maniera esponenziale di stress, quello stress che può portare alla morte. Prendiamone alcuni e partiamo da Don Giorgio Govoni, che dal '97 al 2000 fu perseguitato dai magistrati che lo additavano a pedofilo-satanista. Nell'ultima udienza a cui assistette, il pubblico ministero lo dipinse come un rifiuto della società, come capo di una setta perversa, e chiese per lui 14 anni di carcere. Il giorno dopo Don Giorgio, agitatissimo, si presentò nello studio del suo legale: aveva bisogno di sfogarsi e di sentire una voce amica. Ma non riuscì a parlargli perché morì di infarto in sala d'attesa. Fu condannato da morto Don Giorgio. Per il giudice, dopo 57 udienze e 300 testimoni (un processo costosissimo), era lui a dire messa nei cimiteri della zona, era lui l'uomo vestito di nero che diceva "diavolo nostro", invece che Padre nostro, mentre i satanisti in maschera lanciavano bambini per aria o li sgozzavano gettandoli nel fiume. Ma c'erano davvero satanisti in quei cimiteri? No, non c'erano satanisti e non c'erano abusi. Tutto venne allestito da un Pm che si basò su quanto stabilito da una psicologa dei servizi sociali di Modena. Ma i procuratori si accanirono e quella brutta storia rovinò la vita anche ad altri. Parlo di una madre che quando le portarono via il figlio si gettò dalla finestra, parlo anche dei coniugi Covezzi che nel '98 se ne videro portar via 4 di figli dai magistrati. L'assoluzione definitiva per loro è giunta nel 2013, ma Delfino Covezzi non se l'è goduta perché subito dopo è morto senza poter rivedere i quattro figli strappatigli dalla giustizia e dati in adozione quindici anni prima del verdetto definitivo (solo in primo grado fu condannato). Storie allucinanti di sofferenza e stress incessante che portano anzitempo alla morte e crescono solo per il propagarsi del pregiudizio, lo stesso che ancora oggi fa dire a tanti italiani che Enzo Tortora qualcosa aveva fatto, altrimenti non sarebbe stato indagato. Storie allucinanti come quella di Giovanni Mandalà che assieme a Giuseppe Gullotta fu condannato per aver ucciso due carabinieri (strage di Alcamo Marina). Giovanni si è sempre proclamato innocente, come Giuseppe a cui la stampa l'anno passato ha dedicato tante parole perché ha chiesto allo Stato 69 milioni di euro per aver trascorso 22 anni in carcere da innocente. Ma il signor Mandalà non è riuscito ad arrivare alla sentenza di assoluzione. Lui è morto nel '98. Morto dopo aver subito il dolore assoluto, vittima di un tumore. Come in carcere è morto Michele Perruzza, un uomo incastrato in una storia che ha attinenze con quella di Avetrana. Forse non la ricorderete, perché contemporanea al delitto di via Poma (Simonetta Cesaroni) e perché in pochi giorni i magistrati dissero di aver scoperto la verità: e come sempre i giornalisti si defilarono senza approfondire né chiedersi se le accuse mosse dalla procura fossero reali. Michele Perruzza nel 1990 abitava in una piccola frazione di Balsorano, provincia de L'Aquila, dove viveva anche sua nipote, la piccola Cristina Capoccitti di soli sette anni. Il 23 agosto, dopo cena, Cristina uscì di casa per giocare all'esterno. Ma quando sua madre la chiamò perché si stava facendo buio, la bimba non rispose. Le ricerche si protrassero per tutta la notte, poi arrivò l'alba e il corpo di Cristina venne visto: la bimba era svestita e aveva la testa spaccata. Due giorni dopo un ragazzo di 13 anni, Mauro Perruzza (figlio di Michele e cugino di Cristina), confessò l'omicidio. Stavano facendo un gioco, disse, quasi erotico. Poi lei cadde sbattendo la testa su una pietra e lui, per paura, la strangolò. Ma gli inquirenti non gli credettero, non ce lo vedevano ad uccidere la cugina e così lo interrogarono per ore fino a fargli dire che era stato suo padre a uccidere e che lui lo aveva visto perché si trovava a 50 metri dal luogo del crimine. Ma questa fu solo la sua seconda versione, nel tempo ne fornì 17 e tutte diverse. Però non appena inserì suo padre, un'auto corse fino alla sua casa per arrestarlo: era l'alba del 26 agosto e nessuno verificò le parole del ragazzo. Quando in caserma gli passò davanti in manette, i giornalisti lo sentirono urlare: "Scusami papà, sono stato costretto!". In effetti il ragazzo, si scoprirà poi, era stato intimidito di brutto. In ogni caso suo padre non fece più ritorno a casa. Ma mai accusò il figlio per quel crimine. Così anche sua moglie che mai ha detto qualcosa contro suo figlio. Come sempre se non ci sono prove si ragiona di pregiudizio usando il solito ragionamento del: "Perché un figlio dovrebbe incolpare il padre se non è colpevole?". Che equivale al moderno: "Perché un padre dovrebbe incolpare la figlia se non è colpevole?". Così, basandosi su un pregiudizio, in un processo in cui l'avvocato del sempliciotto muratore Perruzza era lo stesso che difendeva suo figlio, inconcepibile, il 15 marzo del '91 ci fu una prima condanna all'ergastolo. In paese ormai tutti erano certi della colpevolezza del Perruzza e quella sera si festeggiò la condanna coi fuochi d'artificio. Il pregiudizio della gente era nato da un obbrobrio investigativo e giudiziario in cui non mancava neppure un'audiocassetta scomparsa (era quella di un interrogatorio in cui, si dice, si sentivano distintamente i colpi di un pestaggio). Alcuni giornalisti, solo un paio a dire il vero, muovendosi con sapienza cercarono di entrare nella verità. Ma non era facile e Gennaro De Stefano (uno dei pochi giornalisti veri, purtroppo morto anni fa) venne anche intimidito grazie a un poliziotto che mise della droga nella sua auto prima di una perquisizione (sei mesi dopo il fatto De Gennaro, per nulla intimidito, fu scagionato e risarcito con tante scuse). Tralasciando il resto di questa infame storia che procurò solo dolore, arrivo alla fine. Le Perizie stabilirono che il figlio, da dove aveva detto di trovarsi non poteva vedere il padre uccidere Cristina. Ma sia in appello che in cassazione le accuse della procura tennero e nel settembre del '92 la condanna divenne definitiva. Lo sconcerto subentrò poi, quando in un processo parallelo (celebrato a Sulmona e non a L'Aquila) si scoprì che sulle mutandine di Cristina c'era il dna del cugino Mauro, non dello zio. Per cui la giustizia si trovò agli estremi: la cassazione nel '92 aveva stabilito che Michele era colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, ma nel '98 un giudice, grazie a buone perizie, certificava nelle sue motivazioni l'innocenza di Michele Perruzza. Si poteva a quel punto rifare il processo, ma la procura del capoluogo abruzzese si oppose e alla fine vinsero i procuratori (fra l'altro, il giudice che aveva condannato all'ergastolo il Perruzza in quel periodo era diventato procuratore generale de L'Aquila). Comunque lo strazio e lo stress accesero in maniera esponenziale la sofferenza di Michele Perruzza quando questi capì che nessuno avrebbe fatto nulla per aiutarlo. Morì nel gennaio del 2003 a causa di un infarto e le sue ultime parole furono: "Dite a tutti che non ho ucciso io Cristina". Le disse in punto di morte ai medici dell'ambulanza che inutilmente cercarono di salvargli la vita. Storie di ordinaria follia? Casi rari che non fanno testo e non gettano ombre su una giustizia da decenni malata? Una giustizia spesso falsa e coadiuvata dai media che iniettano il pregiudizio delle procure nelle vene del popolo? In Italia ci sono sacerdoti con le palle. Uno si chiama Don Mario Neva e col suo gruppo (Impsex) da tempo cerca di salvare le ragazze costrette a battere sulle strade. Lui dieci anni fa disse: "Nel ’600 si credeva di combattere la peste uccidendo gli 'untori', innocenti accusati di spargere unguenti mortiferi. Un rito crudele quanto inutile che solo dopo 200 anni ebbe giustizia e cessò. Oggi sta succedendo lo stesso. In buona fede allora, in buona fede oggi: ma è una buona fede che mette radici profonde e diventa madre di ogni inquisizione". Ed è proprio così. Nulla è peggio del pregiudizio e nulla è peggio dello stress che uccide chi sa di essere vittima di una ingiustizia giudiziaria. La vergogna non vive in chi non ha cuore, ma si amplifica in chi il cuore lo ha più grande. Ed arrivo a Cosimo Cosma, morto a causa di un tumore che nessuno può dire lo avrebbe certamente colpito senza lo stress dovuto alle accuse della procura di Taranto. Mimino non era un santo, ma con lui la giustizia si è sbizzarrita e ha dimostrato di avere una doppia personalità (e una doppia morale), perché mentre veniva condannato a Taranto per aver occultato il corpo di una ragazzina di 15 anni (Sarah Scazzi), a Brindisi subiva la medesima sorte per qualcosa che risulta essere l'esatto contrario: per aver messo le mani addosso a chi aveva violentato una ragazza di 16 anni (questa è l'accusa a cui la difesa ha risposto chiedendo al giudice di riconoscere che il violentatore al momento del fatto non era in grado di intendere e volere). Un po' come dire che per la nostra giustizia un missionario può con una mano dare a un bimbo un pezzo di pane e con l'altra mollargli uno schiaffo. Non c'è logica in certe accuse, lo so, ma fin quando non si metteranno paletti e regole vere da rispettare, tutto e il contrario di tutto potrà essere dimostrato dal potere giuridico consolidato. Perché a tutt'oggi c'è chi può iniziare indagando A ed arrivare a condannare C senza alcun problema. Perché se non convince la versione di A si gira la frittata e si manda in galera B. E e se non è possibile incastrare solo B si gira la pentola in verticale e si condanna anche C. Basta volere e con sogni e veggenze alla fine si può anche dire che non era una frittata ma una paella, così da mettere in atto un gioco di prestigio buono per condannare chiunque. Il problema è che, tranne i soliti noti (e sono pochi), nessuno protesta: la maggioranza dei media sparge il pregiudizio e anche grazie a loro, con nulla in mano se non pochi indizi, c'è chi può indagare e condannare chiunque e credere, e far credere, di essere nel giusto. E se qualche avvocato in gamba dimostra che non è zuppa quanto portato dai procuratori in tribunale, per i pubblici ministeri c'è sempre la possibilità giuridica di cambiare la formula e le ricostruzioni e far credere zuppa il pan bagnato. Questo perché quando si entra nella categoria degli indagati, per i magistrati e la pubblica opinione non si è più persone e il dolore che si prova quando nessuno ti crede non figura essere dolore per chi accusa: in fondo, possono soffrire i numeri? L'essere umano per certe istituzioni non esiste e il dolore che una accusa fondata su congetture lascia in dote, come lo stress che si prova nel sentirsi già giudicati prima del processo finale, passa in secondo piano. Ma non solo gli indagati sono numeri. Forse non vi rendete conto che tutti noi siamo solo stupidi numeri scritti in sequenza su una qualche cartella o documento: sia per la sanità che per la giustizia che per i comuni e il governo. Numeri da allevare in provetta per gli scopi altrui, tifosi che vengono plagiati dalle istituzioni e vogliono solo vincere, nei campi di calcio come nella politica e nei tribunali, e a cui non importa di come si giochi la partita, se si fanno entrate oltre il limite, se agli avversari che giocano in inferiorità numerica saltano caviglia e perone, se l'arbitro non si dimostra imparziale, se qualcuno muore. Fin quando non toccherà a noi di subire tutto va bene, anche lo sport che non è più sport, la politica che non è più politica e la giustizia che non è più giustizia. Tanto la pubblica opinione alla fine darà ragione a chi comanda preferendo mettere in campo la volgarità dell'offesa. Tanto i media non daranno risalto alla notizia scomoda e nessuno si indignerà se i carcerati che si proclamano innocenti si suicidano dopo aver perso la speranza, se gli imputati che si proclamano innocenti muoiono di infarto o di tumore a causa di uno stress infinito, se chi ha mandato in carcere gli innocenti, morti e non, invece di venir cacciato dalla magistratura continua a incassare i suoi 100.000 euro all'anno e a far carriera...
Nicola Izzo: "Così i pm mi hanno rovinato". L’intervista di Giacomo Amadori su “Libero Quotidiano”. In questi giorni in Parlamento si sta discutendo di riforma della giustizia e responsabilità civile dei magistrati. Sono migliaia in Italia le persone rovinate dagli errori giudiziari delle toghe. E sicuramente uno dei casi più celebri è quello del prefetto Nicola Izzo. Da qualche mese è in pensione, ma sino al novembre 2012 era il vicecapo vicario della Polizia, quasi il comandante in pectore vista la battaglia contro la malattia che stava conducendo l’allora numero uno Antonio Manganelli. Un gruppo di agguerriti pm napoletani gli ha stroncato la carriera indagandolo per turbativa d’asta nell’ambito di un’inchiesta sull’appalto per il Centro elaborazione dati della Polizia. Lo scorso maggio il gip di Roma, dove il fascicolo era stato trasferito per competenza, ha prosciolto Izzo da ogni accusa. Lui ora resta alla finestra, in attesa che qualcuno lo risarcisca per un danno tanto grande.
Dottor Izzo, quanti milioni di euro dovrebbero darle per ripagarla di questo clamoroso errore giudiziario?
«Non saprei cosa risponderle. Si parla, ormai da troppi anni, dei malanni della giustizia senza trovare un rimedio. Io comunque ho sempre pensato che chi sbaglia deve rispondere: l’irresponsabilità crea i presupposti per aumentare gli errori e formare il convincimento in chi li commette di esercitare un potere incontrollato».
Il gip che ha archiviato il procedimento contro di lei e altri 14 indagati vi ha prosciolti senza ombre. Non fa male avere questo riconoscimento dopo aver lasciato la Polizia?
«Fa male perché in tutto il procedimento ci sono una serie di “travisamenti” che avrebbero, se valutati correttamente e con accertamenti approfonditi, consentito, anziché immaginifiche ricostruzioni giudiziarie, l’immediata archiviazione del tutto, senza creare danni irreparabili. L’inesistenza di qualsiasi ipotesi collusiva tra noi indagati era di un’evidenza solare».
I pm sembra che non abbiano brillato in precisione. Per esempio siete stati accusati di aver fatto vincere aziende senza Nos (nullaosta di sicurezza), mentre in realtà tutte ne erano in possesso. Come è possibile mettere nero su bianco un’accusa del genere senza averla verificata?
«Questa, al pari di alcune altre accuse, è una delle cose più strabilianti e gravi. Come si fa a riportare tra i capi di imputazione fatti neanche accertati, ma solo frutto della propria immaginazione? C’era da fare un semplice accertamento cartaceo, lo stesso che hanno fatto le difese. Bastava consultare gli archivi degli enti deputati al rilascio del Nos».
L’inchiesta è stata trasferita a Roma per competenza. Ma non era chiaro sin dall’inizio che quella presunta turbativa d’asta, se mai ci fosse stata, era stata consumata nella Capitale (dove si tenne la gara) e non a Napoli?
«Dico solo che dal 20 dicembre del 2012, data in cui la Procura Generale della Cassazione aveva individuato la competenza della Procura di Roma, abbiamo dovuto attendere il luglio 2013 per la trasmissione di tutti gli atti da Napoli, con la conseguenza che la procura di Roma ha dovuto emettere due distinti decreti di chiusura indagini per la “rateizzazione”, forse dovuta, mi passi il termine, a “dimenticanze” nella trasmissione dei documenti».
Certi pm sono innamorati dei loro fascicoli e se ne separano mal volentieri. Non vorrei infierire, ma per il giudice della Capitale «tutte le condizioni necessarie al regolare svolgimento della gara erano state seguite». Ma allora perché tenervi sotto processo per tanti anni?
«Non voglio infierire neanche io, credo solo che in questo clamoroso caso di malagiustizia ci siano, per chi ha la responsabilità di farlo, sufficienti elementi per accertare l’inconsistenza e la fantasia dei capi di imputazione e la leggerezza con cui è stata condotta l’indagine».
Pensa che qualcuno risponderà di questo svarione?
«Spero di scoprirlo presto».
In questa vicenda anche i media hanno contribuito al suo calvario. Per esempio hanno dato ampio risalto alla lettera anonima di un “corvo” che collegava il suicidio di un suo stretto collaboratore alle pressioni gerarchiche che avrebbe subito per alterare le procedure di gara. Ma la vicenda processuale ha raccontato un’altra verità.
«La morte del collega, anche per l’affetto che nutrivo per lui, è la vera tragedia nel contesto di questa vicenda. I verbali delle nostre riunioni di lavoro raccontano una verità molto diversa da quella immaginata dal “corvo”, verbali da cui emergono le richieste del mio collaboratore di maggiori risorse economiche per finanziare imprevisti progettuali e le mie pressanti pretese di giustificazioni per questi nuovi costi. Nell’ultima riunione il collega ammetteva di non conoscere il progetto a suo tempo elaborato, ma di essere convinto che avremmo dovuto ricorrere a inconsueti ampliamenti dei contratti, con l’ utilizzo di ulteriori risorse economiche».
Di fronte a tale affermazione come ha reagito?
«Nonostante fossi convinto della sua buona fede, lo richiamai molto fermamente a essere più attento e a documentarsi prima di reclamare altri fondi, anche perché qualsiasi superficialità poteva causare dei dispiaceri. È questo in sintesi il prologo della tragedia sulla quale ho sempre tenuto il più stretto riserbo per non ledere l’immagine di una persona onesta e perbene».
In questa storia c’è stata anche un’altra morte prematura. Per qualcuno pure in questo caso si sarebbe trattato di suicidio…
«Questa notizia non è un refuso di stampa, viene da un’affermazione del Gip di Napoli che a proposito di un dirigente di polizia ha scritto: «anch’egli recentemente deceduto in circostanze oggetto di accertamento, come emerso nel corso degli interrogatori». Di questi accertamenti e interrogatori non ho trovato traccia, se non nell’affermazione falsa, «si è suicidato», fatta dal pm nel corso dell’interrogatorio di un teste. Il figlio del compianto funzionario ha dovuto smentire la circostanza «assurda» con due comunicati in cui dichiarava che il padre era deceduto naturalmente, «stroncato da un infarto».
Perché secondo lei la lettera del “corvo” spunta sui giornali 3-4 mesi dopo la sua spedizione? Secondo lei c’era un piano dietro a quella strana fuga di notizie?
«Il ministro dell’Interno, all’epoca Anna Maria Cancellieri, non ha ritenuto di disporre alcuna inchiesta per scoprire questi motivi e quindi non posso avere certezze sul punto. Di certo, però, quell’azione va contestualizzata: nell’estate del 2012 ci trovavamo in un grave momento di crisi del vertice della Pubblica Sicurezza e vi erano grandi fermenti per la sua sostituzione. Gli artefici della lettera non erano dei passanti: hanno potuto manipolare i documenti sull’attività del Ministero di cui erano in possesso, falsandone i contenuti, e hanno diffuso la lettera utilizzando tecnologie così sofisticate da rendere non identificabili i mittenti neanche per i tecnici della Polizia delle comunicazioni».
Il “corvo” ha trovato anche spazio sui giornali…
«Quel documento anonimo è stato accolto con favore in importanti redazioni che hanno così dato risalto mediatico a una realtà travisata e falsa. Tanto falsa che oggi vi sono tre direttori di testate nazionali e vari giornalisti rinviati a giudizio per diffamazione, ma questo a differenza delle farneticazioni di un anonimo sembra che non sia una notizia degna di nota».
Potremmo definirla una “congiurina” contro la sua eventuale candidatura forte a Capo della Polizia?
«Certo i malpensanti possono opinare che vi sia dietro un vile, ma astuto manovratore, qualche puffo incapace di altro che possa aver ordito un qualche “disegno” per bruciare il mio nome per la successione di Manganelli, ma io non sono un malpensante e quindi mi ostino a credere che sia stato il “fato”».
Subito dopo le notizie di stampa che facevano riferimento al “corvo”, lei ha deciso di presentare le dimissioni. Qualcuno ha fatto pressioni per ottenere quel suo passo indietro?
«Assolutamente no, tutt’altro. Il ministro Cancellieri le respinse. Ma io non sono un personaggio da operetta, come ce ne sono molti in questo Paese, che presenta le dimissioni per incassarne il rigetto. In quel momento c’era un’ombra su di me ed era giusto fare un passo indietro. Per senso dello Stato».
Che cosa le ha fatto più male in questa vicenda, dal punto di vista umano? Di fronte a quelle ricostruzioni fantasiose, non ha avuto la sensazione di essere prigioniero di un castello kafkiano?
«Ho avuto modo in questo periodo di approfondire Kafka, e posso risponderle prendendo in prestito una frase “del traduttore”, Primo Levi: «Si può essere perseguiti e puniti per una colpa non commessa, ignota, che il “tribunale” non ci rivelerà mai; e tuttavia, di questa colpa si può portar vergogna, fino alla morte e forse anche oltre». Tutto questo lo sto provando sulla mia pelle. E nessuno vi potrà porre mai rimedio».
Lo scandalo del Viminale. Il corvo fa dimettere Izzo, ma la Cancellieri dice no. Il ministro dell'Interno ha respinto le dimissioni del vice di Manganelli dopo l'esposto anonimo su appalti pilotati, scrive “Libero Quotidiano”. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo preso molto seriamente la vicenda. Quello che vogliamo è che il Viminale resti una casa di vetro e un punto di riferimento per il Paese”. Aperta un'inchiesta. Si è dimesso il vice capo della Polizia, prefetto Nicola Izzo, chiamato in causa dal corvo nell’inchiesta sui presunti appalti truccati al Viminale. Izzo ha inviato questa mattina una email al Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli e al ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri che però ha ha respinto le dimissioni, perché "credo, ha detto il ministro, che una persona non possa essere giudicata sulla base di un esposto anonimo sul quale non abbiamo ancora riscontri". Intanto la Procura di Roma procede nell'inchiesta partita in seguito dell’esposto anonimo inviato nei giorni scorsi al ministro dell’Interno dove si faceva riferimento a presunte violazioni e illeciti nel conferimento di appalti per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche. L'inchiesta è stata avviata dal procuratore capo, Giuseppe Pignatone, che ha affidato il fascicolo all’aggiunto Francesco Caporale, che guida da poco il pool dei magistrati per i reati contro la pubblica amministrazione. L’esposto anonimo, composto da una ventina di pagine, indica episodi circostanziati e diversi illeciti che sarebbero stati compiuti dall’ufficio logistico del Viminale, incaricato delle gare d’appalto per l’acquisto degli impianti tecnologici. Da parte sua, nelle scorse ore, Izzo si era difeso da ogni accusa:"Diffamato per fatti che mi sono estranei: da vicecapo vicario non mi occupo della gestione di appalti". In una nota ha scritto: "Sono citato ignominiosamente in un esposto anonimo, che potrebbe essere redatto a carico di chiunque e con qualsiasi contenuto - scrive Izzo - per acquisti di cui ho conoscenza solo per la funzione strategica dei beni e non delle procedure per la loro materiale acquisizione. Chi ha costruito l’anonimo, si è nascosto abilmente, dimostrando la sua conoscenza delle tecnologie avanzate e del settore degli appalti, usando la mail di persone ignare; e tale modalità forse merita qualche riflessione sui nobili intenti dell’autore". Prosegue Izzo: "Nello scritto, l’anonimo segnala anomalie sulle procedure amministrative adottate, procedure per le quali, in alcuni casi e per quanto mi consta, le stazioni appaltanti, diverse tra loro e non solo interne al dipartimento della Ps, si sono consultate con gli organi istituzionali preposti e in tutti i casi, a conclusione degli appalti, sono state sottoposte al vaglio e registrate, senza alcun rilievo, dalla Corte dei Conti". Izzo conclude che "nonostante la natura anonima dell’esposto non dovrebbe dare luogo a seguiti e in presenza di un quadro di sostanziale regolarità, l’Amministrazione ha trasmesso gli atti alla Procura per gli eventuali approfondimenti. La morte del compianto Saporito per le sue tragiche modalità merita solo dolore e rispetto e non vili e strumentali insinuazioni. Per il Cen sono stato interrogato circa due anni e mezzo fa e attendo fiducioso il giudizio della magistratura". “Il corvo? Ci piacerebbe conoscerlo, vedere se sono uno, due o quanti sono”, sostiene il ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri ribadendo che oltre all’inchiesta della magistratura, “di cui attendiamo gli esiti” sono in corso accertamenti all’interno del Viminale: “Abbiamo preso molto seriamente la vicenda -conclude- perchè non sappiamo chi volesse colpire” il corvo, “forse aveva anche un interesse personale. Quello che vogliamo è che il Viminale resti una casa di vetro e un punto di riferimento per il Paese”.
Lo dice anche il capo della polizia. "I magistrati sono dei cialtroni". Manganelli al telefono col prefetto Izzo: "Vergognoso che le notizie sui processi vengano passate ai giornali per fare clamore", scrive “Libero Quotidiano”. "E' una cosa indegna". Veramente mi disgusta il fatto che io debba leggere sul giornale, momento per momento, 'stanno per chiamare la dottoressa Tizio, la stanno chiamando...l'hanno interrogato...la posizione si aggrava'". E ancora: "Perchè se no qua diamo per scontato che tutto viene raccontato dai giornali, che si fa il clamore mediatico, che si va a massacrare la gente prima ancora di trovare un elemento di colpevolezza". E poi ancora: "A me pare molto più grave il fatto che un cialtrone di magistrato dia indebitamente la notizia in violazione di legge...". Chi parla potrebbe essere Silvio Berlusconi, che tante volte si è lamentato di come le notizie escano dai tribunali prima sui giornali che ai diretti interessati. E invece, quelle che riporta il Corriere della Sera, sono parole pronunciate nel giugno 2010 nientemeno che del capo della polizia Antonio Manganelli, al telefono col prefetto Nicola Izzo, ex vicario della polizia. Si lamenta, Manganelli, della fuga di notizie a proposito del caso degli appalti per il centro elettronico e per gli altri interventi previsti dal patto per la sicurezza, indagine condotta dalla procura di Napoli e che portò a una serie di provvedimenti tra cui l'arresto del prefetto Nicola Fioriolii e l'interdizione dai pubblici uffici per i prefetti Nicola Izzo e Giovanna Iurato.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
Il pm Antimafia della Procura di Bari Isabella Ginefra ha chiesto 58 condanne, 35 assoluzioni e un non luogo a procedere per prescrizione nei confronti dei 103 imputati (gli altri 9 deceduti) nel processo chiamato «Il canto del cigno» su una presunta associazione mafiosa operante sulla Murgia barese tra Gravina e Altamura negli anni Novanta, finalizzata a traffico e spaccio di droga, detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni, 8 tentati omicidi, ferimenti e conflitti a fuoco tra clan rivali, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Il procedimento penale fu avviato nel 1997 dall'allora pm antimafia barese Leonardo Rinella quando, nel corso del processo alla mafia murgiana denominato «Gravina» nei confronti di oltre 160 persone, alcuni imputati decisero di collaborare con la giustizia rivelando nuovi particolari sulle attività illecite dei clan Mangione e Matera-Loglisci, all'epoca - secondo la Procura - in stretto contatto con i gruppi criminali baresi di Savino Parisi, Antonio Di Cosola, Giuseppe Mercante, Andrea Montani ed altri. Tra i capi di questa presunta associazione mafiosa c'erano, secondo l'accusa, Vincenzo Anemolo, ritenuto un «figlioccio» del boss Savinuccio, e suo fratello Raffaele, il defunto Francesco Biancoli (il camorrista che avrebbe battezzato Parisi), Bartolo D'Ambrosio (ucciso nel 2010) e il suo ex alleato, poi rivale, Giovanni Loiudice (processato e assolto per l'omicidio del boss), Emilio Mangione e suo nipote Vincenzo, Nunzio Falcicchio, soprannominato «Lo scheletro». L'indagine, ereditata negli anni successivi dai pm Antimafia Michele Emiliano ed Elisabetta Pugliese, portò nel marzo 2002 all'arresto di 131 persone. Per oltre 200 fu poi chiesto il rinvio a giudizio ma soltanto 94 sono ancora imputate per quei fatti. Gli altri sono stati giudicati con riti alternativi o prosciolti. A quasi vent'anni dai fatti contestati sulla base degli accertamenti dei Carabinieri di Bari e Altamura, la Procura chiede ora condanne comprese fra 10 e 4 anni di reclusione per 58 di loro. Tra i reati ritenuti ormai prescritti ci sono due tentati omicidi del 1994 e del 1997 e alcuni episodi di spaccio. Stando all'ipotesi accusatoria quella murgiana era una vera e propria «associazione armata di stampo mafioso-camorristico» promossa e organizzata da «padrini e figliocci». Agli atti del processo, durato oltre sette anni, ci sono prove dei «battesimi», le cerimonie di affiliazione, e l'esatta ricostruzione dei ruoli all'interno del clan sulla base di una precisa ripartizione territoriale per la gestione delle attività illecite. Le discussioni dei difensori sono fissate per le udienze del 16 luglio e del 29 settembre, data in cui è prevista la sentenza.
Niente sentenza per 17 anni. Imputati morti e prescritti. Il pm chiede le condanne per un'inchiesta antimafia del 1997. Ma alla sbarra di 200 ne restano solo 58, scrive Gianpaolo Iacobini su “Il Giornale”. A Bari, il processo alla cosca? Dopo 17 anni arrivano le richieste di condanna in primo grado. L'antimafia dei record è pugliese. Il primato, però, non è di quelli di cui andar fieri: per un procedimento penale nato da indagini avviate nel 1997, e relative a fatti verificatisi agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, soltanto adesso la Procura ha avanzato davanti ai giudici richiesta di pena nei confronti degli imputati. La storia ha un nome simbolico, uno di quelli che tanto solleticano le cronache ed i giornalisti quando scattano i blitz: «Il canto del cigno». È il 2 settembre del 2002: i magistrati della Dda barese Elisabetta Pugliese e Michele Emiliano (proprio lui: l'ex sindaco di Bari) chiudono con un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 131 persone il troncone investigativo fiorito 5 anni prima per gemmazione da un altro maxi-processo. Nel mirino della Direzione distrettuale finiscono gli appartenenti ad una presunta organizzazione criminale attiva sull'altopiano delle Murge, nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia, ed i loro collegamenti con i clan del capoluogo di regione. All'attivo estorsioni, detenzione d'armi, traffico di droga e ferimenti. Finalizzati, secondo gli inquirenti, all'affermazione di un'associazione armata di stampo mafioso-camorristico. «Quest'operazione dimostra come la criminalità barese, dalla fine degli anni '80 ad oggi, abbia creato dei cloni in tutta la provincia», commenta in quei giorni coi cronisti Emiliano, esprimendo soddisfazione per il lavoro portato a termine. Ma i processi sono un'altra cosa. Ed in Tribunale il cigno canterà solo a settembre 2014. Quando il collegio giudicante si determinerà in primo grado sulle richieste di pena avanzate l'altro ieri - a quasi vent'anni dall'apertura dell'inchiesta - dal pm antimafia Isabella Ginefra. Che la sua requisitoria l'ha conclusa sollecitando condanne oscillanti tra i 10 e i 4 anni di reclusione nei riguardi di 58 degli oltre 200 imputati: gli altri sono stati prosciolti o processati con riti alternativi. O sono morti. Alcuni per vecchiaia. Qualcuno per piombo, come Bartolo D'Ambrosio, crivellato a colpi di fucile e pistola nel 2010. Ed il passar del tempo, oltre agli uomini, ha spazzato via con la ramazza della prescrizione anche molti dei reati contestati, come un paio di tentati omicidi risalenti al 1994. Farà notizia? No, a giudicare dagli echi di cronaca che arrivano da Palermo, dove il presidente del tribunale del riesame, Giacomo Montalbano, con un'ordinanza ha disposto il rinvio d'ufficio a settembre di tutti i procedimenti che non riguardino detenuti in carcere o ai domiciliari: pochi i magistrati in organico, troppi i ricorsi che si prevede arriveranno dopo l'arresto, il 22 giugno, di 91 persone considerate affiliate ai mandamenti mafiosi di Resuttana e San Lorenzo. La chiamano giustizia. Pare una barzelletta.
LA CHIAMANO GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI TESTIMONI.
Dopo aver affermato qualche mese fa che se nel nostro Paese si fanno troppe cause la colpa è del numero eccessivo di avvocati, ora l’illustre magistrato Giorgio Santacroce, presidente della Corte di Cassazione, interviene per chiarire (agli avvocati, ovviamente) come vanno redatti i ricorsi da presentare alla Suprema Corte onde non incorrere in possibili declaratorie di inammissibilità. Lo ha fatto con una lettera inviata al Presidente del CNF Guido Alpa dopo il Convegno “Una rinnovata collaborazione tra magistratura e avvocatura nel quadro europeo” organizzato dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei del Consiglio d’Europa, dal CSM e dal CNF. Prendendo spunto dal dibattito scaturito in quella circostanza, il Dott. Santacroce ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera al Consiglio Nazionale Forense per confermare alcune direttive, ora finalmente rese “ufficiali” dall’organo deputato a riceverle. Richiamando quanto già espresso in precedenza sia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (la quale ha previsto tra le indicazioni pratiche relative alla forma e al contenuto del ricorso di cui all'art. 47 del Regolamento che «nel caso eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine il ricorrente dovrà presentare un breve riassunto dello stesso») e dal Consiglio di Stato (che ha suggerito di contenere nel limite di 20-25 pagine la lunghezza di memorie e ricorsi, e, nei casi eccedenti, di far precedere l’esposizione da una distinta sintesi del contenuto dell’atto estesa non più di 50 righe), il primo Presidente della Corte ha affermato che anche gli atti dei giudizi di cassazione dovranno trovare applicazione criteri similari. “Ben potrebbe ritenersi congruo – scrive il Presidente Santacroce nella lettera indirizzata al CNF - un tetto di 20 pagine, da raccomandare per la redazione di ricorsi, controricorsi e memorie. Nel caso ciò non fosse possibile, per l'eccezionale complessità della fattispecie, la raccomandazione potrà ritenersi ugualmente rispettata se l'atto fosse corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine del relativo contenuto. Sembra, altresì, raccomandabile che ad ogni atto, quale ne sia l'estensione, sia premesso un breve sommario che guidi la lettura dell'atto stesso. Allo stesso modo è raccomandabile che le memorie non riproducano il contenuto dei precedenti scritti difensivi, ma, limitandosi ad un breve richiamo degli stessi se necessario, sviluppino eventuali aspetti che si ritengano non posti adeguatamente in luce precedentemente, così anche da focalizzare su tali punti la presumibile discussione orale”. Attenendosi a tali criteri di massima si potrebbe superare, secondo il primo Presidente - in molti casi quello scoglio che è l’inammissibilità del ricorso “non già per la mancanza di concretezza dei motivi del ricorso, ma per la modalità con cui questo viene presentato, che non rispondono ai canoni accettati dalla Cassazione”, tra i quali appunto la sinteticità degli atti presentati a sostegno della presa in esame del dibattimento arrivato a sentenza in Appello”. Lo spirito dell’iniziativa del Dott. Santacroce è certamente propositivo e positivo, così come lo è il clima di collaborazione che il Magistrato ha auspicato in tal senso. Di certo però andrà conciliato con un altro principio - quello dell’autosufficienza dell’atto - che non poco ha turbato il sonno degli avvocati in questi ultimi mesi, ossia l’esigenza posta a carico del ricorrente di inserire nel ricorso o nella memoria la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori con eventuale trascrizione dei passi salienti. Un requisito (l’autosufficienza) che i giudici della Corte non hanno ritenuto affatto assolto mediante la allegazione di semplici fotocopie, e questo perché, si è detto, non è compito della Corte individuare tra gli atti e documenti quelli più significativi e in essi le parti più rilevanti, “comportando una siffatta operazione un'individuazione e valutazione dei fatti estranea alla funzione del giudizio di legittimità”. Da qui la redazione di atti complessi ed articolati, e dunque anche lunghi, nel timore di non vedere considerato dal parte del Giudice un qualche aspetto o un qualche documento essenziale ai fini del decidere. Ora, insomma, gli avvocati avranno un compito in più: conciliare il criterio della brevità dell’atto con quello dell’autosufficienza. Mica roba da poco….
La conseguenza è.........La Cassazione boccia un ricorso perché "troppo prolisso".Sotto accusa l'atto degli avvocati dell'Automobile club d'Ivrea contro una sentenza della Corte d'Appello di Torino:"Tante pagine inutili". Ma diventa un modello: massimo venti pagine, scrive Ottavia Giustetti su “la Repubblica”. La dura vita del giudice di Cassazione: presentate pure il ricorso, avvocati, ma fate in modo che sia sintetico. Altrimenti state pur certo che sarà respinto. Poche pagine per spiegare i fatti, niente che comporti uno sforzo inutile per chi legge. Insomma «non costringeteci» a esaminare pagine e pagine se volete avere qualche speranza di vincere. Nero su bianco, tra le righe del testo di una recente sentenza della terza sezione sul ricorso contro una decisione della Corte d’appello di Torino, i giudici supremi hanno vergato il vademecum della sintesi estrema. Altrimenti: bocciatura assicurata. Qualche tempo fa lo avevano fatto a proposito dei ricorsi di legittimità legati al fisco. «La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali - scrivono i magistrati al primo capoverso che illustra le motivazioni del rigetto del ricorso - è del tutto superfluo ed equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre che sia informata) la scelta di quanto rileva. La conseguenza è l’inammissibilità del ricorso per Cassazione». E, a quanto pare, è solo un esempio dei pronunciamenti di questo tenore che in questi mesi agitano le acque nell’ambiente degli avvocati. I forum sul diritto sono zeppi di commenti taglienti sulla «preziosa risorsa» del giudice che va «salvaguardata a tutti i costi». Tempi sterminati della giustizia, necessità di smaltire migliaia di procedimenti arretrati, prescrizione sempre in agguato: è nell’ambito della lotta a questi ormai cronici problemi del Paese il vademecum del giudice all’avvocato per evitare sbrodolamenti inutili. E non si può dire che sia nuova la tendenza a inibire il difensore che non si trasformi ogni volta in un Marcel Proust del diritto quando chiede giustizia. Ma respingere un ricorso perché un legale non è stato capace di sintesi da bignami appare come una novità giuridica importante, dicono gli avvocati. Nel caso della terza sezione civile sulla sentenza della Corte d’appello di Torino l’oggetto del contendere erano le spese di gestione dell’Automobile club di Ivrea. Una vicenda relativamente di poco conto. Ma analoghe prescrizioni si fanno strada e rischiano di diventare obbligo previsto per legge se sarà approvato uno specifico emendamento del decreto di riforma della giustizia in discussione in questi mesi in Parlamento. Il punto che è già stato approvato dalla commissione affari costituzionali della Camera finisce col prevedere la necessità per gli avvocati amministrativisti di scrivere i ricorsi e gli altri atti difensivi entro le esatte dimensioni che sono in via di definizione e sono stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Saranno venti pagine al massimo i ricorsi d’ora in poi, mentre quel che sconfina è destinato per sempre all’oblio. Brevità della trattazione, che va in direzione opposta all’abitudine di molti legali che, con il timore di rientrare nei canoni dell’inammissibilità, finiscono per presentare ricorsi-fiume.
Ed ancora: “Inammissibile, prolisso e ripetitivo”. Così i giudici del Consiglio di Stato di Lecce hanno giudicato il ricorso d’appello presentato dai tredici proprietari dei terreni interessati dai lavori di allargamento della tanto contestata s.s. 275. Oltre a riconfermare quanto rilevato dal Tribunale amministrativo leccese, il Consiglio di Stato ha deciso di condannare gli appellanti al rimborso delle spese di lite, con la sanzione prevista per la violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, introdotta dall’art. 3 del nuovo Codice del processo amministrativo. “Si deve tener conto – si legge in sentenza – dell’estrema prolissità e ripetitività dell’appello in esame (di 109 pagine)”. Il rispetto del dovere di sinteticità, ha sottolineato il Giudice, “costituisce uno dei modi – e forse tra i più importanti – per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace”. Gli appellanti dovranno rimborsare, dunque, le spese alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia, al Consorzio Asi, alla Prosal, al CIPE, all’Anas, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dei Rapporti con la Regione.
Eh, sì! Proprio così : lo affermano la Suprema Corte con sentenza n. 11199 del 04.07.2012 e, di recente, il Tribunale di Milano con sentenza del 01.10. 2013, scrive l’Avv. Luisa Camboni. "Viola il giusto processo l'avvocato che trascrive nel proprio atto processuale le precedenti difese, le sentenze dei precedenti gradi, le prove testimoniali, la consulenza tecnica e tutti gli allegati; il giusto processo richiede trattazioni sintetiche e sobrie, anche se le questioni sono particolarmente tecniche o economicamente rilevanti". I Giudici di Piazza Cavour dicono "NO" agli avvocati prolissi. Perché? Perché, a dire dei Giudici con la toga di ermellino, si violerebbe uno dei principi cardine, uno dei pilastri fondamentali su cui poggia il nostro sistema giuridico: il principio del giusto processo, ex art. 111 Cost. "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. [...]". Uno dei tanti significati insiti nel menzionato principio, difatti, è quello di garantire la celerità del processo, celerità che si realizza anche attraverso atti brevi, ma chiari e precisi nel loro contenuto ( c.d. principio di sinteticità). Il caso, su cui i Giudici si sono pronunciati, riguardava un ricorso di oltre 64 pagine e una memoria illustrativa di ben 36 pagine, il cui contenuto reiterava quello del ricorso. Il principio cui hanno fatto riferimento per dare un freno, uno STOP a Noi Avvocati, molto spesso prolissi, è il principio del giusto processo. Difatti, hanno precisato che un atto processuale eccessivamente lungo, pur non violando alcuna norma, non giova alla chiarezza e specificità dello stesso e, nel contempo, ostacola l'obiettivo di un processo celere. Il cosiddetto giusto processo, tanto osannato dalla nostra Carta Costituzionale, infatti, richiede da Noi Avvocati atti sintetici redatti in modo chiaro e sobrio: "nessuna questione, pur giuridicamente complessa", a dire della Suprema Corte, "richiede atti processuali prolissi". L'atto processuale, dunque, deve essere completo e riportare in modo chiaro la descrizione delle circostanze e degli elementi di fatto, oggetto della controversia. Ancora una volta la Suprema Corte ha richiamato l'attenzione di Noi Avvocati specificando quali sono i principi che ogni operatore di diritto, nella specie l'Avvocato, deve tener presente nel redigere gli atti: specificità, completezza, chiarezza e precisione. Nel caso, dunque, di violazione del principio di sinteticità, ovvero di redazione di atti sovrabbondanti, il giudice può tenerne conto, in sede di liquidazione delle spese processuali, condannando la parte colpevole ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Per Noi Avvocati, sulla base di quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour, non ha valore alcuno il motto latino "Ripetita iuvant", in quanto le cose ripetute non giovano alla nostra attività professionale che si estrinseca, nei giudizi civili, in attività di difesa negli atti, i quali devono essere chiari, sintetici e precisi. Un'attività di difesa non dipende dalla lungaggine dell'atto, ma dall'ingegno professionale, ingegno che consiste nell'individuare la giusta strategia difensiva per ottenere i migliori risultati sia per il cliente, sia per lo stesso professionista.
"Avvocati siete troppo prolissi, se volete ottenere giustizia per i vostri assistiti dovete imparare il dono della sintesi": la Cassazione ormai lo scrive nel testo delle sentenze. Ecco il parere di un principe del foro torinese, l'avvocato Andrea Galasso, protagonista nelle battaglie tra Margherita Agnelli e la sua famiglia e nel processo a Calciopoli.
Avvocato, i suoi colleghi sono contrari e allarmati, lei cosa ne pensa?
«Da un certo punto di vista i giudici mi trovano d'accordo perché so che spesso quando ci si dilunga e si sbrodola volentieri sui fatti è perché si teme di non poter argomentare bene in punto di diritto. Quindi la Cassazione ha ragione a ritenere che sia necessaria una buona dote di sintesi anche per non appesantire una attività che è diventata sempre più pressante».
Quindi, secondo lei, un bravo avvocato è capace di rimanere nei limiti che la Cassazione considera legittimi per presentare un ricorso?
«In linea di massima ritengo di sì. Poi, ovviamente, ci sono casi diversi. La sintesi deve essere una indicazione generale. poi ogni processo ha la sua storia».
Però sentenze recenti scrivono proprio nero su bianco che il ricorso può essere respinto perché è troppo prolisso e costringe la Corte a leggere elementi inutili. Lei crede che sia corretto?
«No, questo no. Siamo in un caso di cattiveria intellettuale. Di malcostume alla rovescia».
Tra l'altro queste indicazioni di brevità estrema condizioneranno sempre di più il lavoro degli avvocati. È in via di approvazione un emendamento che stabilisce un tetto di venti pagine per i ricorsi al Tar.
«Questo è un problema serio che riguarda il rapporto degli avvocati con i consigli dell'Ordine che evidentemente non sono in grado di far sentire la propria voce quanto dovrebbero».
Lei crede che la categoria dovrebbe essere più ascoltata, insomma?
«Beh sì. Quando si trasformano in legge regole che condizionano così profondamente il nostro lavoro sarebbe opportuno avere un Ordine degli avvocati capace di proporsi come interlocutore valido. E invece, evidentemente non è così».
Ma all'inaudito non c'è mai fine....
Il giudice: "Troppi testimoni inutili? Pena più alta". E gli avvocati milanesi scioperano. Gli avvocati si asterranno dalle udienze il 17 luglio 2014 perché ritengono che siano stati stravolti "alcuni principi cardine del processo accusatorio, ovvero quelli del contraddittorio nella formazione della prova", scrive “La Repubblica”. Non sono andate giù agli avvocati penalisti milanesi le parole pronunciate in aula da un giudice che, in sostanza, di fronte ai legali di un imputato ha detto che se si insiste per ascoltare testimoni inutili, i magistrati poi ne tengono conto quando si tratta di calcolare la pena. E così la Camera penale di Milano, prendendo una decisione clamorosa e dura, anche sulla base di quel grave "caso processuale" che lede il diritto di difesa, hanno deciso di proclamare una giornata di astensione nel capoluogo lombardo per il prossimo 17 luglio. Come si legge in una delibera del consiglio direttivo della Camera penale,"lo scorso 20 giugno, nell'ambito di un'udienza dibattimentale celebratasi avanti a una sezione del tribunale di Milano, il presidente del collegio ha affermato" a proposito dell'esame di testimoni: "Non mi stancherò mai di ripetere che secondo me quando in un processo si insiste a sentire testi che si rivelano inutili, ovviamente si può essere assolti, ma se si è condannati il tribunale ne tiene sicuramente conto ai fini del comportamento processuale" (che influisce sulla pena). E ha aggiunto: "E mi dispiace che sugli imputati a volte ricadano le scelte dei difensori". Il giudice che ha usato quelle parole in udienza sarebbe Filippo Grisolia, presidente dell'undicesima sezione penale. Il giudice, secondo la Camera penale, ha così violato "l'autonoma determinazione del difensore nelle scelte processuali, il quale deve essere libero di valutare l'opportunità o meno di svolgere il proprio controesame". In più il magistrato ha violato le norme che "riconducono la commisurazione della pena esclusivamente a fattori ricollegati alla persona dell'imputato", oltre a manifestare "non curanza per alcuni dei principi cardine del processo accusatorio, ovvero quelli del contraddittorio nella formazione della prova". I penalisti milanesi, dunque, preso atto che "le segnalazioni agli uffici giudiziari" fatte in passato "non hanno ottenuto" lo scopo di "neutralizzare" i comportamenti lesivi del diritto di difesa, e ritenuta "la gravità del fenomeno che il caso processuale riportato denuncia", hanno deciso di astenersi dalle udienze e da "ogni attività in ambito penale" per il 17 luglio prossimo. Con tanto di "assemblea generale" convocata per quel giorno per discutere "i temi" della protesta. "Questo fenomeno della violazione del diritto di difesa - ha spiegato il presidente della Camera penale milanese, Salvatore Scuto - è diffuso ed è emerso con virulenza in questo caso specifico, ma non va ridotto al singolo giudice che ha detto quello che ha detto. Questa è una protesta - ha aggiunto - che non va personalizzata, ma che pone l'indice su un problema diffuso e che riguarda le garanzie dell'imputato e il ruolo della difesa". La delibera è stata trasmessa anche al presidente della Repubblica, al presidente del consiglio dei ministri, al ministero della Giustizia e al Csm, il Consiglio superiore della magistratura.
LA VERA MAFIA: LO STATO ESTORTORE E CORROTTO.
Le vera mafia è lo Stato che ci vessa. È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e di avere il coraggio di dire la verità: la mafia è questo Stato, scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Per la prima volta un Papa ha scomunicato la mafia. Benissimo! È arrivato il momento di far luce su chi sia la mafia. Chi potrebbe non essere d'accordo con la condanna assoluta di chi usa la violenza nelle sue varie forme, psicologica, economica e fisica, per sottomettere le persone al proprio arbitrio, al punto da violare i diritti inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà? Ma chi è veramente il Male che sta devastando la nostra esistenza? È la criminalità organizzata che impone il pizzo ai commercianti e fa affari con il traffico di droga e dei clandestini? È la massoneria che gestisce in modo più o meno occulto il potere ovunque nel mondo? È il Gruppo Bilderberg che associa chi più conta nella finanza e nell'economia sulla Terra? Certamente queste realtà interferiscono con la nostra vita con conseguenze tutt'altro che trascurabili. Ma si tratta di realtà che o non riguardano tutti noi o non ne conosciamo bene i contenuti e i risvolti. Viceversa siamo tutti, ma proprio tutti, più che consapevoli delle vessazioni che tutti i giorni lo Stato ci impone attraverso leggi inique e pratiche del tutto arbitrarie. Chi è che ci ha imposto una nuova schiavitù sotto forma del più alto livello di tassazione al mondo, fino all'80% di tasse dirette e indirette? Chi è talmente spregiudicato da speculare sulla nostra pelle legittimando e tassando il gioco d'azzardo, gli alcolici e le sigarette? Chi è a tal punto disumano da tassare la casa, il bene rifugio dell'80% delle famiglie italiane? Chi è che condanna a morte le imprese applicando un centinaio di tasse e balzelli in aggiunta a un centinaio di controlli amministrativi? Chi è che sta accrescendo la disoccupazione e la precarietà in tutte le fasce d'età e lavorative? Chi ha permesso che 4 milioni e 100mila italiani non abbiano i soldi per comperare il pane? Chi protegge le grandi banche e le grandi imprese che continuano a privatizzare gli utili e a socializzare le perdite? Chi ha finora istigato al suicidio circa 4.500 italiani attraverso le cartelle esattoriali di Equitalia o coprendo le vessazioni delle banche quando non erogano credito o ingiungono di rientrare negli affidamenti entro 24 ore? Chi ha svenduto la nostra sovranità monetaria, legislativa e giudiziaria all'Europa dei banchieri e dei burocrati? Chi è responsabile della crescita inarrestabile del debito pubblico e privato dal momento che siamo costretti a indebitarci per ripianare il debito acquistando con gli interessi una moneta straniera? Chi sta devastando le famiglie obbligando entrambi i genitori a lavorare sodo per riuscire a sopravvivere? Chi ci ha portato all'ultimo posto di natalità in Europa e ci sta condannando al suicidio demografico? Chi sta incentivando l'emigrazione dei nostri giovani più qualificati perché in Italia non hanno prospettive? Chi sta danneggiando gli italiani promuovendo l'invasione di clandestini e umiliando i più poveri tra noi favorendo gli immigrati nell'assegnazione di case popolari, posti all'asilo nido e assegni sociali? Chi sta consentendo l'islamizzazione del nostro Paese riconoscendo il diritto a moschee, scuole coraniche, enti assistenziali e finanziari islamici a prescindere dal fatto che confliggono con i valori fondanti della nostra civiltà, indifferenti al fatto che sull'altra sponda del Mediterraneo i terroristi islamici stanno massacrando i cristiani e riesumando dei califfati in cui il diritto alla vita è garantito solo a chi si sottomette ad Allah e a Maometto? Ebbene è questo Stato che si è reso responsabile dell'insieme di questi comportamenti che ci stanno impoverendo e snaturando, trasformandoci da persone con un'anima in semplici strumenti di produzione e di consumo della materialità, assoggettati al dio euro e alla dittatura del relativismo. Ecco perché è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e di avere il coraggio di dire la verità: la mafia è questo Stato. Di ciò sono certi tutti gli italiani perché è una realtà che pagano sulla loro pelle giorno dopo giorno. Quindi caro Papa Francesco lei ha scomunicato le alte personalità che ha ricevuto in Vaticano, a cui ha stretto la mano e ha augurato successo. Per noi sono loro i veri mafiosi che stanno negando agli italiani il diritto a vivere con dignità e libertà.
“Si offre una narrazione delle vicende di mafia che è estremamente semplificata – ha detto a Rainews il Procuratore di Caltanissetta. – Da una parte ci sono Falcone, Borsellino e gli uomini di Stato uccisi per l’affermazione della legalità. Dall’altra parte ci sono i Riina, i Provenzano, ex villici, che vengono rappresentate come icone assolute della mafia. Ma dove li mettiamo i colletti bianchi che sono capi organici della mafia? Parlo di architetti, medici, ingegneri (magistrati, avvocati, notai ndr)…che sono collusi. Ma ci sono anche uomini dello Stato dei quali è stata accertata con sentenza definitiva la complicità con la mafia. Parlo di presidenti del consiglio, vertici dei servizi segreti, capi della polizia, assessori regionali. Io credo che senza questi colletti bianchi e senza gli uomini di Stato collusi, la mafia dei Riina e dei Provenzano sarebbe stata debellata da un pezzo. Non possiamo distorcere la verità e raccontare ai giovani che la mafia è solo estorsioni e spaccio, bisogna raccontare il fenomeno nella sua complessità – ha aggiunto Scarpinato. – Se noi non li aiutiamo a capire, rischiamo di fargli subire ancora la mafia, che si evolve sempre di più ed è componente del potere”.
Un esercito di politici, magistrati e colletti bianchi collusi o contigui. E' l'estrema sintesi delle ultime, incredibili rivelazioni di Carmine Schiavone, pentito e collaboratore di giustizia dal '93, cugino di Francesco Schiavone, alias Sandokan. Ha deciso di parlare ai media, Schiavone, di fare nomi e cognomi, di raccontare intrecci e connection, di alzare il sipario sugli affari più sporchi – e milionari – portati a segno dai Casalesi con forti complicità politico-imprenditoriali. A una settimana dalle dichiarazioni a SkyTG24 del pentito di camorra Carmine Schiavone, le istituzioni italiane, chiamate in causa, tacciono. L’ex collaboratore di giustizia ha chiaramente denunciato l’esistenza di uno “Stato mafioso”, di ministri corrotti, di intere caserme di Carabinieri, Polizia, e Guardia di Finanza conniventi. Il silenzio di chi dovrebbe parlare (e bonificare) è assordante!
Vero è che Carmine Schiavone ha dato una spallata consistente al lavoro dei pubblici ministeri antimafia. Ha collaborato alla prima costruzione di quel super processo che avrebbe spazzato in carcere tutti i vertici dei casalesi: Spartacus I e Spartacus II. Ma, superata anche la boa dei settant'anni, ora riserva l'ennesima confessione choc. "Se potessi tornare indietro non mi pentirei - dice - Io mi sono pentito davvero, se no tutte quelle carte non le avrei date. Ma qui non siamo in America. Io mi sono pentito veramente, quello è stato il guaio. Perché non c'è un politico che sappia guardare davvero un pentito, non siamo negli Stati Uniti. E non lo farei più : perché qui le istituzioni ci hanno abbandonato. Quando non sono riusciti ad ammazzarmi materialmente, hanno cercato di distruggermi economicamente, moralmente". Poi spara a zero su politici, divise e magistrati inquinati. "Noi mantenevamo una buona parte delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia. A me alla sera mi veniva portata la striscetta dalla polizia, con le operazioni che avrebbero fatto il giorno successivo". E in cambio, cosa offriva l'organizzazione criminale? "Gli davamo ogni tanto qualcuno, qualche piccolo spacciatore, per fargli fare carriera". E aggiunge: "Noi sì, è vero che abbiamo sparato. Però un ministro, un magistrato, un carabiniere e un poliziotto, che si sono venduti, sono più responsabili di noi". Irascibile, amante delle iperboli, ma sempre stratega. Carmine Schiavone è colui che rivelò, fin dalle sue prime dichiarazioni, il concepimento di un vero e proprio Stato Mafia da parte dell'organizzazione criminale del casertano. "Noi avevamo la nostra idea. Dovevamo formare, per la fine del millennio, i nostri giovani come degli infiltrati dentro lo Stato: quindi dovevano diventare magistrati, poliziotti, carabinieri e perché no, anche ministri e presidenti del Consiglio. Per avere i nostri referenti nelle istituzioni".
L’ultima volta che un padrino della camorra vuotò il sacco accusando avvocati e magistrati di essersi fatti corrompere per aggiustargli qualche processo, risale agli anni ’90. Non finì tanto bene, nel senso che le «clamorose» rivelazioni di «Lovigino», alias dell’ex boss di Forcella Luigi Giuliano, su un presidente di sezione del tribunale del Riesame e di un membro della Camera penale, finirono nel nulla: per un anno e mezzo non si riuscì a trovare adeguato riscontro al racconto di mazzette e sentenze taroccate, tutti assolti. Oggi, con un ex capo della malavita organizzata del calibro di Antonio Iovine, detto «’O ninno», passato come (quasi) tutti dall’altra parte della scrivania «perché il clan dei casalesi ormai non c’è più...», la scena si ripete, almeno nelle sue premesse: si tratta solo di vedere come andrà a finire, di tempo ce n’è, siamo agli inizi. The show must go on. «Per essere assolto in Corte d’assise dall’accusa di omicidio tirai fuori 250mila euro. In tribunale a Napoli c’era una struttura che si occupava di aggiustare processi».
LA VERA MAFIA E’ LO STATO. E PURE I GIORNALISTI? DA ALLAM ALLA FALLACI.
L'ultima rivelazione di Riina: "Telecomando nel citofono" Borsellino azionò la sua bomba. Il capomafia ha fatto nuove confidenze al compagno di socialità. I pm di Caltanissetta indagano sul misterioso tecnico che il pentito Spatuzza dice di aver visto il giorno prima dell'attentato. E dai vecchi atti dell'inchiesta salta fuori una relazione di servizio: una telefonata anonima al 113 aveva annunciato la strage, due ore prima, scrive Salvo Palazzolo su “La Repubblica”. Totò Riina, in carcere dal gennaio 1993 Sono una continua sorpresa i dialoghi di Totò Riina con il suo compagno di ora d'aria, il boss pugliese Alberto Lorusso: gli investigatori della Dia stanno finendo di trascrivere le intercettazioni proprio in questi giorni. A novembre, il capo di Cosa nostra è tornato a parlare delle stragi e al suo interlocutore ha raccontato un retroscena del tutto inedito sulla bomba che il 19 luglio 1992 scoppiò in via d'Amelio, a Palermo: Riina spiega che il telecomando della carica era stato sistemato nel citofono del palazzo dove abitava la madre del procuratore Borsellino. Il capomafia ha un tono compiaciuto quando descrive la scena a Lorusso. Paolo Borsellino, citofonando alla madre, avrebbe azionato la bomba piazzata dentro la Fiat 126, la bomba che non lasciò scampo al magistrato e ai cinque poliziotti della scorta. Quest'ultima sconvolgente verità è adesso all'esame del pool coordinato dal procuratore Sergio Lari, che in questi anni non ha mai smesso di cercare la verità sui misteri di via d'Amelio. I pm di Caltanissetta stanno ripercorrendo con attenzione le parole di Totò Riina, perché ancora oggi c'è un grande mistero attorno al telecomando che attivò l'ordigno della strage di luglio. Neanche gli ultimi due pentiti di Cosa nostra, Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina, hanno saputo dire chi avesse in mano il congegno elettronico. Forse, perché è proprio come dice Riina? Forse, per davvero, nessun mafioso azionò il telecomando? Tranchina ha spiegato che a metà luglio, il suo capomafia, Giuseppe Graviano, cercava un appartamento in via d'Amelio: "Poi, dopo alcuni sopralluoghi, mi disse che si sarebbe accomodato nel giardino. Dopo la strage, si limitò a commentare: "Na spurugghiammu". Ci siamo riusciti. Ma Tranchina non ha mai visto un telecomando in mano a Giuseppe Graviano, che invece, dal giardino dietro via d'Amelio, potrebbe avere attivato il congegno di cui adesso parla Riina, nel citofono del condominio a poca distanza. Misteri su misteri. Ma troppo tempo è trascorso, e oggi è impossibile verificare cosa ci fosse per davvero dentro quel citofono. Però, se Riina dice la verità doveva essere opera di una mano molto esperta, chissà forse la stessa che Spatuzza vide in azione il giorno prima della strage, quando la 126 fu imbottita di esplosivo in un garage di via Villasevaglios, a un paio di chilometri da via d'Amelio. Il pentito ha detto di non sapere chi fosse quell'uomo che si aggirava attorno all'autobomba. Però, adesso, si può ipotizzare che fosse un esperto elettronico. E non era un appartenente a Cosa nostra, precisa Spatuzza. Una cosa, invece, è certa. Alle 14,35 di quel 19 luglio 1992, una voce maschile annunciò al 113: "Tra mezz'ora esploderà una bomba sotto di voi". Lo dice una relazione di servizio che l'agente di turno stilò qualche ora dopo l'eccidio di via d'Amelio. Scrisse: "Tanto si riferisce per doverosa notizia. Della telefonata veniva informato il funzionario di turno alla squadra mobile, dottor Soluri". L'agente Giuseppina Candore firmò e inviò la relazione di servizio al "Signor dirigente la squadra mobile" e al "Signor dirigente l'ufficio prevenzione generale". Repubblica ha ritrovato quel documento, è l'allegato 66 del primo rapporto della squadra mobile di Palermo sulla strage. A margine, qualcuno fece un'annotazione: "Squadra mobile, sequestrare nastro". Ma di quel nastro oggi non c'è traccia. E senza la voce dell'anonimo sarà impossibile fare ulteriori accertamenti su quest'altro importante tassello della verità che ancora non c'è.
Via D’Amelio, Riina intercettato: “Il telecomando era nel citofono”. Dalle conversazioni del boss in carcere emergono nuovi dettagli sulla morte di Paolo Borsellino: «Fu il giudice stesso ad innescare la bomba che lo uccise», scrive “La Stampa”. Un nemico come lui lo Stato non l’avrà mai più. Totò Riina torna a vantarsi delle proprie gesta stragiste svelando, stavolta, un particolare inedito sull’attentato di via D’Amelio. «Avemmo un colpo di genio», dice ad Alberto Lorusso, criminale pugliese che col capomafia di Corleone ha condiviso per mesi l’ora d’aria nel carcere milanese di Opera. E racconta di come i mafiosi avrebbero piazzato nel citofono del palazzo della madre del giudice Paolo Borsellino il telecomando usato per azionare l’autobomba imbottita di tritolo, usata per far saltare in aria il magistrato e gli agenti della scorta. Una rivelazione che ha scioccato gli investigatori che da mesi continuano a riascoltare le conversazioni intercettate dei due detenuti. La registrazione del dialogo è stata trasmessa dalla Procura di Palermo ai colleghi di Caltanissetta che hanno riaperto le indagini sulla strage di via D’Amelio. Nel dialogo Riina, oltre a riaffermare il suo ruolo di capo assoluto dei clan, si attribuisce il «merito» dell’organizzazione tecnica di un attentato difficile, che però non poteva fallire. E a Lorusso, come sempre pronto ad ascoltarlo con attenzione, racconta di come riuscirono a superare gli ostacoli tecnici che si presentavano. I boss avrebbero piazzato nel citofono del palazzo di via D’Amelio una piccolissima trasmittente che doveva essere attivata da lontano e dare l’impulso a una ricevente piazzata vicino all’ordigno e in grado di fare scattare il detonatore. Così quando il commando fu sicuro che il bersaglio era sul posto, che Borsellino dunque, era arrivato sotto casa della madre e stava dirigendosi al portone per suonare, qualcuno - Riina non dice chi - avrebbe azionato il congegno. La conversazione e il racconto del capomafia non sono chiarissimi: gli inquirenti stanno cercando di capire con esattezza i passaggi tecnici spiegati dal boss. Sulla serietà della pista gli investigatori sembrano cauti. Per alcuni la rivelazione aprirebbe scenari nuovi sull’eccidio, confermando che dietro la strage c’era un personaggio esterno a Cosa nostra - di una figura misteriosa parla anche il pentito Gaspare Spatuzza - e dotato di notevoli competenze tecniche. Inoltre la versione del padrino di Corleone farebbe rileggere sotto un’altra luce l’attività di manutenzione a cui venne sottoposto il citofono dello stabile di via D’Amelio prima dell’attentato. Ma la storia di Riina non convincerebbe tutti: per alcuni investigatori si tratterebbe dell’ennesimo sproloquio di un boss ormai ultraottantenne in preda a manie di grandezza e pronto a raccontare al compagno di socialità anche cose lontane dal vero. Una interpretazione che sminuirebbe complessivamente la portata delle parole del capomafia e delle minacce da lui lanciate durante i colloqui con Lorusso. Il padrino si dice pronto a organizzare un nuovo attentato in grande stile ai danni dei magistrati. «Facciamolo grosso», dice Riina alludendo a un gesto eclatante che avrebbe dovuto colpire il pm palermitano Nino Di Matteo a cui si doveva far fare «la fine del tonno» come a Falcone. Sta agli inquirenti verificare la versione di Riina e la sua compatibilità con verità ormai accertate processualmente, come quella raccontata dal pentito Fabio Tranchina, il picciotto incaricato dal boss Giuseppe Graviano di comprare i telecomandi usati per la strage. Il collaboratore ha indicato nel boss di Brancaccio l’uomo che, nascosto in un giardino vicino al palazzo della madre di Borsellino, azionò i congegni che fecero saltare in aria la 126 col tritolo.
Sarebbe stato Paolo Borsellino stesso ad azionare il telecomando dell'ordigno che l'ha ucciso il 19 luglio del '92, scrive “Il Corriere della Sera”. È quanto avrebbe rivelato Totò Riina nell'ennesima confidenza rilasciata al suo compagno di cella Alberto Lorusso durante l'ora d'aria, in una delle conversazioni intercettate dalla Dia ed ora all'esame degli investigatori coordinati dal pool di pm di Caltanissetta che continua a indagare sui misteri legati alla strage di via D'Amelio. La vicenda è riportata stamane dall'edizione online di Repubblica Palermo. La confidenza di Riina risalirebbe a novembre scorso. Il padrino di Corleone avrebbe raccontato al suo interlocutore che il telecomando della carica era stato sistemato nel citofono del palazzo dove abitava la madre del procuratore Borsellino. Il giudice, citofonando alla madre, avrebbe dunque azionato la bomba piazzata dentro la Fiat 126, che lo uccise insieme ai cinque poliziotti della sua scorta. I pm di Caltanissetta stanno esaminando le parole di Riina perché ancora oggi c'è un grande mistero attorno al telecomando che attivò l'ordigno della strage di luglio. Neanche i pentiti di Cosa nostra ascoltati dai pm di Caltanissetta hanno saputo dire chi avesse in mano il congegno elettronico.
Quando ho sentito alla televisione che il generale Dalla Chiesa era stato promosso prefetto di Palermo per distruggere la mafia ho detto: “prepariamoci”, scrive “Il Corriere della Sera”. Mettiamo tutti i ferramenti a posto, tutte le cose pronte per dargli il benvenuto». Lo racconta il boss Totò Riina al capomafia pugliese Alberto Lorusso nella conversazione intercettata all’interno del carcere di Opera. «Lui - aggiunge - gli sembrava che veniva a trovare qua i terroristi. Gli ho detto: qua il culo glielo facciamo a cappello di prete». Parla anche di Falcone e della strage di Capaci e della scelta del magistrato di mettersi al posto di guida, mentre l’autista fu l’unico a salvarsi. «Meno male che lui si è voluto mettere là al posto dell’autista, se no si salvava, disgraziato. Una trovata migliore l’ha potuta trovare lui solo» afferma Riina. I dialoghi sono stati depositati agli atti del processo sulla trattativa Stato-mafia. Quindi gli apprezzamenti su Andreotti. «Quello è stato una persona seria, a livello mondiale. Figlio di put..., che persona seria, eh? Chiesa e casa, casa e chiesa. Questo qua era un burattinaio, che cavolo di burattinaio...». Quindi aggiunge: «Ce l’hanno con Andreotti perché era un cornuto Andreotti, era ‘ngagghiatu (ammanigliato ndr) bbuono era...- dice poi Riina a Lorusso - Lui non era ‘ngagghiatu con nessuno, neanche con sua moglie ngagghiò». E Lorusso: «Quello era proprio intelligente e conosceva l’esperienza regionale». E del famoso bacio tra Andreotti e lo stesso Riina, mai confermato da alcuna sentenza, ma raccontata da un pentito. Riina scherza: «si è andato a baciare con Andreotti, sono andato a baciarlo io». Racconta Salvatore Riina: "Balduccio Di Maggio dice che mi ha accompagnato lui e mi sono baciato con Andreotti. Pa... pa... pa". Il capo di Cosa scuote le mani mentre passeggia sorridente nel cortile del carcere milanese di Opera, come a far capire: tutte palle. Non ci fu alcun bacio, sostiene. Poi, cambia tono di voce e sussurra la sua verità: "Però con la scorta mi sono incontrato con lui". E Lorusso: «Perché questi poi enfatizzano nelle loro cose, inventano...». Riina: «Miii, questo Andreotti ha potuto dire... questo è il più malandrino che c’è in Sicilia, questo vedete che ci mette mano». E ride. «Minchia, ma si spirigghiò il processo da solo (si è risolto il processo da solo ndr)». Quindi sull’ex Procuratore di Palermo, Giancarlo Caselli che definisce: «quel disonorato». «L’ha organizzato a modo suo (il processo ndr) l’ha fatto su misura».
Parla del passato e parla del presente, Salvatore Riina, nel chiuso del cortile del carcere milanese di Opera, scrive “Il Corriere della Sera”. Ad agosto come a novembre, col caldo a 40 gradi o incappottato, con uno zuccotto in testa per proteggersi dal freddo. Dieci passi e dietrofront, dieci passi e dietrofront al fianco del detenuto pugliese Alberto Lorusso, che diventa il depositario (e a tratti persino l’istigatore) degli sfoghi e dei propositi di morte del boss corleonese col vizio delle stragi. Quelle che ha organizzato da uomo libero, negli anni Ottanta e inizio Novanta, e quelle che medita da ergastolano recluso al «41 bis». Con un obiettivo fisso: i magistrati. Ieri Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; oggi Nino Di Matteo e gli altri pm antimafia. E quasi si lamenta, Riina, che gli italiani non condividano i suoi propositi: «Mi viene una rabbia a me... ma perché questa popolazione non vuole ammazzare a nessun magistrato?». Ma c’è anche un passaggio sull’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, del quale il boss e il suo interlocutore parlano la mattina del 6 agosto, pochi giorni dopo la condanna definitiva in Cassazione. «Noi su Berlusconi abbiamo un diritto - dice Riina - sapete quando? Quando siamo fuori lo ammazziamo... Non l’ammazziamo, però. Perché noi stessi non abbiamo il coraggio di prenderci il diritto... Io lo dico con la rabbia del cuore... Io faccio il malavitoso e basta».
Salvatore Riina in carcere fa una battuta dietro l'altra sui "festini in Sardegna e in Puglia" di Silvio Berlusconi. "Mubarak Mubarak", ride durante la consueta passeggiata pomeridiana, riferendosi alla versione data dall'ex premier su Ruby, nipote del presidente dell'Egitto. "Che disgraziato, è un figlio di puttana che non ce n'è". E giù con altre risatine, scrive Salvo Palazzolo su “La Repubblica”. Ma il tono della voce si fa serio quando inizia il racconto degli anni Ottanta e Novanta su Berlusconi: "A noialtri ci dava 250 milioni ogni sei mesi", spiega il capo di Cosa nostra al compagno di ora d'aria, il pugliese Alberto Lorusso. E anche questa frase è finita nelle intercettazioni disposte dai pm di Palermo nel processo "trattativa". Per la prima volta, Riina rivela come si articolò quel "patto di protezione" che la Cassazione ha accertato definitivamente, mandando l'ex senatore Marcello Dell'Utri in carcere. Perché Dell'Utri sarebbe stato l'intermediario fra i vertici della mafia e Berlusconi, che prima temeva un sequestro, poi attentati ai suoi ripetitori in Sicilia. È la storia di una lunga stagione, che Riina racconta così, il 22 agosto dell'anno scorso: "È venuto, ha mandato là sotto ad uno, si è messo d'accordo, ha mandato i soldi a colpo, a colpo, ci siamo accordati con i soldi e a colpo li ho incassati". Diversamente, come è emerso dai processi, andò a Catania. Conferma Riina: "Gli hanno dato fuoco alla Standa ed i catanesi dicono: ma vedi di.... Non ha le Stande? gli ho detto: da noi qui ha pagato... così li ho messi sotto. Gli hanno dato fuoco alla Standa... minchia aveva tutte le Stande della Sicilia. Gli ho detto: bruciagli la Standa". Ed ecco il passaggio che per i pm vale più di tutti i racconti dei pentiti al processo Dell'Utri: "A noialtri ci dava 250 milioni ogni sei mesi", rivela il capo di Cosa nostra dopo 47 minuti di passeggiata nell'atrio del carcere milanese di Opera. E spiega come iniziò tutto: "Quello... è venuto il palermitano... mandò a lui, è sceso il palermitano ha parlato con uno... si è messo d'accordo... Dice vi mando i soldi con un altro palermitano. Ha preso un altro palermitano, c'era quello a Milano. Là c'era questo e gli dava i soldi ogni sei mesi a questo palermitano. Era amico di quello... il senatore". Ovvero, Dell'Utri, che Riina definisce "una persona seria". Il "palermitano" dovrebbe essere invece il boss Tanino Cinà, che negli anni Settanta suggerì a Dell'Utri di mandare Vittorio Mangano come stalliere ad Arcore quando Berlusconi cercava "protezione". Adesso, questo monologo di Riina è agli atti del processo Stato-mafia: per i pm Di Matteo, Del Bene, Tartaglia e Teresi è una conferma del ruolo di intermediario svolto da Dell'Utri nella seconda fase della trattativa. Oggi, però, Riina esprime giudizi pesanti sull'ex premier, anche se precisa di non averlo mai incontrato ("Non era così famoso ai miei tempi, altrimenti l'avrei cercato"): "Noi su Berlusconi abbiamo un diritto, sapete quando? Quando siamo fuori lo ammazziamo". Precisa: "Non lo ammazziamo però perché noi stessi non abbiamo il coraggio di prenderci il diritto". Alla fine, riprende a scherzare attorno al "buffone", al "disgraziato", così lo chiama. Scherza sui soldi che Berlusconi deve all'ex moglie. E sul calciatore brasiliano Pato, fidanzato con la figlia dell'ex premier: "Sta Barbarella è potentosa come suo padre, si è messa sotto quello lì, lui era un potente giocatore e non ha potuto giocare più". Prima di rientrare in cella, Riina dà del "disgraziato" al ministro Angelino Alfano. E Lorusso concorda: "Il più cattivo ministro di sempre, si sta impegnando per i sequestri di beni". Nelle registrazioni dei colloqui con il compagno di ora d’aria (ora trasferito in un altro carcere, che gli inquirenti palermitani sospettano possa ricevere e mandare informazioni all’esterno e addirittura conoscere notizie interne alla Procura mai uscite sui giornali) il «capo dei capi» di Cosa nostra esplicita i suoi progetti di strage, chissà quanto realizzabili. Dai ricordi del passato, invece, emerge un uomo che si vanta di aver colpito gli obiettivi più importanti e più protetti; come se - davanti al piccolo criminale pugliese - recitasse la parte del grande boss che, anche dopo vent’anni di carcere duro, si piega ma non si spezza. E rivendica quasi con orgoglio quegli attentati, senza risparmiare disprezzo per le vittime. La strage di Capaci in cui morirono Falcone, sua moglie Francesca e tre agenti di scorta, per Riina fu «una mangiata di pasta», una scorpacciata di cui racconta con soddisfazione: «Era imprevedibile, disgraziato... (...) Perciò quando ci siamo messi appresso alla macchina che parte, ci siamo andati appresso... lo seguivamo... (...) Il suo cervello ci ha portato il nostro alla pari... Fu una mangiata di pasta... Poi dice: come avete fatto? Come facevate? Niente, semplice!... (...) È andato a vedere la mattanza dei tonni. E meschino, è morto per andare a vedere la mattanza». Il boss ricorda i minuti di apprensione davanti alle prime notizie trasmesse dalla tv: «Sono feriti lui, la moglie. Minchia, feriti, porca madosca. Nel mentre il telegiornale: è morto Falcone, la moglie... (ride)». Con Borsellino, due mesi più tardi, vollero andare sul sicuro: «Domenica deve andare da sua madre... ah, gli ho detto, allora preparati, aspettiamolo lì... Devono essere tutte le cose pronte... logicamente si sono fatti trovare pronti. Gli ho detto: se serve mettetegli qualche cento chili in più». Sul consigliere istruttore Rocco Chinnici, saltato in aria con un’autobomba fatta esplodere mentre usciva di casa, la mattina del 29 luglio 1983, Riina fa ironia: «Ma che disgraziato sei, saluti e te ne sali nei palazzi. Minchia!... Per un paio d’anni mi sono divertito, sono stato grande... Minchia che gli ho combinato... Se io restavo sempre fuori, continuavo a fare un macello, al massimo livello...». In un’altra conversazione il boss ride ricordando che «quello scappava, volava subito in aria», e poi aggiunge: «Se ne è salito sul tetto. Ma che volete, allora ancora ne volete? Io vorrei incominciare di nuovo». E continua a ridere. A sentire lui, il capomafia ripartirebbe da Nino Di Matteo, il pubblico ministero che più di ogni altro s’è dedicato all’inchiesta sulla trattativa tra lo Stato e Cosa nostra, il processo che «fa uscire pazzo» Riina, come ammette lo stesso boss. Che torna a parlare della mattanza dei tonni: «Ti farei diventare il primo tonno, il tonno buono... Ancora ci insisti? Perché, me lo sono tolto il vizio? Inizierei domani mattina... Minchia ho una rabbia... Sono un uomo e so quello che devo fare, pure che ho cento anni». Il nome del pm viene fuori riferito alle polemiche seguite alla citazione come testimone del capo dello Stato («Questo Di Matteo, questo disonorato, questo prende pure il presidente della Repubblica»), a cui Riina immagina di fargli fare la fine del procuratore Scaglione, assassinato nel 1971: «A questo ci finisce lo stesso». Il problema pare quello di trovare qualcuno fuori dal carcere che si muova. Ma Matteo Messina Denaro, il «padrino» stragista ancora in libertà, sembra pensare ad altro; per esempio gli investimenti nell’energia alternative e nelle pale eoliche. «A me dispiace dirlo - commenta il Corleonese -, questo signor Messina che fa il latitante, che fa questi pali (...) Questo si sente di comandare, si sente di fare luce dovunque, per prendere soldi, ma non si interessa di... (...) E a noi ci tengono sempre in galera. Però quando siamo liberi li dobbiamo ammazzare... Io ho fatto il mio dovere, ma continuate, continuate. Qualcuno, non dico magari tutti, ma qualcuno, divertitevi...». Invece non succede niente. «Una papera non sono capaci a pigliare, neanche una...». Lui invece garantisce che potrebbe ammazzare magistrati e uomini di scorta: «L’ultimo se mi riesce sarà più grosso... Se mi ci metto (ride e gesticola, annotano gli investigatori della Dia) con una bella compagnia di anatroccoli “pa...pa...pa... patampiti” (gesticola con la mano e fa il gesto di un botto) così a chi peschiamo peschiamo.... Non devo avere pietà di questi, come loro non hanno pietà». In un altro colloquio, sempre passeggiando avanti e indietro, il boss insiste: «Questo Di Matteo non lo possiamo dimenticare più...». E dopo che sui giornali sono cominciate a uscire indiscrezioni sulle minacce di Riina al pm del processo sulla trattativa, il 16 novembre Lorusso dice al boss che si stratta di «strumentalizzazioni» di chi «vuole mantenere sempre viva la lotta alla mafia». Il boss reagisce così: «E allora organizziamola questa cosa! Facciamola grossa e non ne parliamo più (gli investigatori riferiscono che Riina tira fuori la mano sinistra dal cappotto e gesticolando mima il gesto di fare in fretta)... Perché questo Di Matteo non se ne va... gli hanno rinforzato la scorta, e allora se fosse possibile... ad ucciderlo... una esecuzione come eravamo a quel tempo a Palermo con i militari». Ma la condizione che brucia di più è quella del «carcere duro» sancito dal 41 bis: «Se io verrò fra altri mille anni, verrò a fargli guerra per questa legge».
La trattativa Stato-Mafia saltò perchè c'era un ostacolo, scrive “Il Corriere della Sera”. Quell'ostacolo era il giudice Borsellino. Questo, sinteticamente, il quadro tracciato dal superpentito Giovanni Brusca. «Riina mi disse che le richieste contenute nel papello erano troppo esose - ha detto il collaboratore di giustizia - e tornarono indietro perchè c'era un ostacolo». Brusca ha deposto oggi, giovedì, al processo sulla strage di via D'Amelio (il cosiddetto Borsellino quater) costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Al pm che gli chiede quale fosse l'«ostacolo», Brusca risponde di poter dedurre che l'ostacolo alla trattativa che vedeva al centro il papello era Borsellino, che per questo fu ucciso. Oggi al processo ha deposto anche Fabio Tranchina, che ha raccontato di quando comprò i due telecomandi che, secondo gli inquirenti, vennero poi usati per azionare l’autobomba della strage di Via D’Amelio.
Mafia e terrorismo. Magdi come la Fallaci processati per le loro idee. La scrittrice finì alla sbarra in Italia, Francia e Svizzera per i suoi scritti sul pericolo islamico. E anche lei diceva: «Non mi faccio intimidire», scrive “Il Giornale”. Li chiamava «i miei trofei». E di «trofei», alias processi per reato d'opinione a causa delle idee sull'islam espresse in libri e articoli, Oriana Fallaci ne ha subiti diversi nel corso della sua vita, in tutta Europa, dalla Francia alla Svizzera. E naturalmente pure in Italia, anche se l'ultimo, a Bergamo, è cominciato a giugno del 2006, due mesi prima che lei morisse, il 15 settembre. Oriana Fallaci come Magdi Cristiano Allam, anzi molto di più. A parte «l'amicizia complessa», così la definì Allam quando lei morì, che li legava sul fronte comune della denuncia dei pericoli del fondamentalismo islamico e del suo radicamento in Europa, c'è anche la persecuzione per via giudiziaria delle opinioni che li accomuna. Per Allam, oggi, si tratta di un procedimento avviato dal Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti che lo accusa di «islamofobia». Per la Fallaci, all'epoca, erano invece veri e propri processi penali, per vilipendio all'islam, razzismo, xenofobia. La sostanza, però, non cambia: vietato essere critici nei confronti dei musulmani, pena la gogna, anche giudiziaria. Si arrabbiava, la Fallaci, per quei quattro processi: due in Francia, a partire dal 2002 (quello per «razzismo», nel 2003, si chiuse con la sua assoluzione) e uno in Svizzera, tutti legati a La rabbia e l'orgoglio ; e un altro in Italia, nel 2006, finito con la sua morte. Li chiamava sì trofei ma li riteneva profondamente ingiusti. Ecco come lei stessa li raccontava a novembre del 2005 nel discorso di ringraziamento per il conferimento dell' Annie Taylor Award , il cui testo è stato pubblicato qualche giorno fa da Libero : «I trofei che chiamo processi. Si svolgono in ogni Paese nel quale un figlio di Allah o un traditore nostrano voglia zittirmi e imbavagliarmi nel modo descritto da Tocqueville, quei processi. A Parigi, cioè in Francia, ad esempio. La France Eternelle , la Patrie du Laïcisme , la Bonne Mère du Liberté-Egalité-Fraternité , dove per vilipendio all'islam soltanto la mia amica Brigitte Bardot ha sofferto più travagli di quanti ne abbia sofferti e ne soffra io. La France Libérale, Progressiste , dove tre anni fa gli ebrei francesi della Licra (associazione ebrea di Sinistra che ama manifestare alzando fotografie di Ariel Sharon con la svastica in fronte) si unì ai musulmani francesi del Mrap (associazione islamica di Sinistra che ama manifestare levando cartelli di Bush con la svastica sugli occhi). E dove insieme chiesero al Codice penale di chiudermi in galera, confiscare La Rage et l'Orgueil (La rabbia e l'orgoglio, ma la richiesta fu respinta, ndr ) o venderla con il seguente ammonimento sulla copertina: “Attenzione! Questo libro può costituire un pericolo per la vostra salute mentale”. Oppure a Berna, in Svizzera. Die wunderschöne Schweits , la meravigliosa Svizzera di Guglielmo Tell, dove il ministro della Giustizia osò chiedere al mio ministro della Giustizia di estradarmi in manette. O a Bergamo, Nord Italia, dove il prossimo processo avverrà il prossimo giugno grazie a un giudice che sembra ansioso di condannarmi a qualche anno di prigione: la pena che per vilipendio dell'islam viene impartita nel mio paese». Era furibonda, la Fallaci, per il processo di Bergamo, legato ad alcune affermazioni contenute in La forza della ragione . Un processo travagliato, partito dalla denuncia, nel 2004, di Adel Smith, il presidente all'epoca del'Unione dei Musulmani d'Italia che aveva definito il crocifisso un «cadaverino nudo inventato per spaventare i bambini musulmani». Il pm aveva chiesto l'archiviazione per la Fallaci, ma il gip l'aveva rigettata, imponendo l'imputazione coatta. Ecco cosa scriveva la stessa Fallaci a luglio del 2005, sul Corriere della Sera, nel celebre articolo dopo gli attentati di Londra «Il nemico che trattiamo da amico» : «Mi ascolti bene, signor giudice di Bergamo che ha voluto incriminarmi per vilipendio all'islam ma che non ha mai incriminato il mio persecutore per vilipendio al cristianesimo. Nonché per istigazione all'omicidio. (Il mio). Mi ascolti e mi condanni pure. Mi infligga pure quei tre anni di reclusione che i magistrati italiani non infliggono nemmeno ai terroristi islamici beccati con l'esplosivo in cantina. Il suo processo è inutile. Finché avrò un filo di fiato io ripeterò ciò che ho scritto nei miei libri e che riscrivo qui. Non mi sono mai fatta intimidire, non mi faccio mai intimidire dalle minacce di morte e dalle persecuzioni, dalle denigrazioni, dagli insulti contro i quali Lei si è guardato bene dal proteggermi, anche come semplice cittadino. Quindi si figuri se mi faccio intimidire da Lei che mi nega il costituzionale diritto di pensare ed esprimere la mia opinione. Però, prima del processo, una curiosità me la deve togliere. Nella cella mi ci terrà tutta sola o coi carabinieri che lo Stato italiano mi ha cortesemente imposto affinché non venga ammazzata come Biagi o come Theo Van Gogh? Glielo chiedo perché il ministro dell'Interno dice che nelle nostre carceri oltre il cinquanta per cento dei detenuti sono musulmani, e suppongo che di quei carabinieri avrei più bisogno in galera che a casa mia». Al processo, iniziato il 9 giugno del 2006, la Fallaci non si presentò per scelta. Per quel processo ricevette attestati di solidarietà da mezzo mondo, pure dall'ex presidente polacco Lech Walesa. E quel processo finì nel nulla. Alla fine lo beffò la morte della giornalista e scrittrice, il 15 settembre del 2006.
L’ordine dei giornalisti contro Allam così si calpesta la libertà di opinione, scrive Pierluigi Battista su “Il Corriere della Sera”. Trasformare in un crimine un’opinione, per quanto criticabile, non dovrebbe rientrare nei compiti di uno Stato che voglia conservare la sua anima liberale, figurarsi di un Ordine professionale come quello dei giornalisti. E invece mettere sotto accusa le opinioni di un commentatore come Magdi Cristiano Allam è diventato l’occupazione estiva dell’Ordine dei giornalisti. Una parodia dell’Inquisizione che fa di un’associazione di categoria, nata durante il fascismo e senza eguali in nessun’altra democrazia liberale con l’eccezione del post-salazariano Portogallo, un tribunale abusivo che si permette di interpretare a suo modo i princìpi della libertà di espressione e che si permette di emettere verdetti sulle opinioni espresse da un proprio associato. Già l’Italia è caricata da una pletora di reati d’opinione mai smaltiti in tutti gli anni della Repubblica post-fascista. Non c’è bisogno di processi aggiuntivi istruiti da chi si arroga il diritto di giudicare le opinioni altrui solo perché munito del tesserino di un Ordine professionale. Se un giornalista commette un reato, dovrà essere giudicato come tutti gli altri cittadini da un Tribunale della Repubblica. Piccoli tribunali del popolo che si impancano a misuratori dell’eventuale «islamofobia» di Allam sono invece pallide imitazioni di epoche autoritarie che non distinguevano tra reato e opinione. Mentre la libertà d’opinione, dovremmo averlo imparato, è indivisibile e non dovrebbe essere manipolata a seconda delle predilezioni ideologiche. Si vuole criticare Allam? In Italia c’è il pluralismo della critica e dell’informazione e il conflitto delle idee è il sale di una democrazia liberale. La giustizia fai da te, i tribunali delle corporazioni che si permettono di intromettersi non su un comportamento, o su una grave negligenza professionale, bensì sul contenuto di un articolo, sono invece il residuo di un’intolleranza antica, e che non sopporta la diversità delle opinioni, anche delle più estreme. Per cui i censori dell’Ordine potrebbero rimettere nel cassetto i loro processi, togliersi la toga dell’inquisitore e ammettere di aver commesso un errore. Non è mai troppo tardi per la scoperta della libertà.
Caso Allam, una decisione sconcertante. Su "Il Giornale", il presidente dell'Odg: "Magdi potrà difendersi". Ma la vicenda resta sconcertante risponde Alessandro Sallusti.
Caro direttore, leggo i servizi dedicati all'Odg in relazione a una vicenda che riguarda Magdi Cristiano Allam. Debbo dirti che alcuni toni e non poche espressioni mi sconcertano. L'idea che ci siano degli intoccabili non appartiene alla mia cultura né, a leggere il Giornale, alla tua. Potrei tacere, perché solo un ignorante (nel senso che non conosce le cose) può non sapere che il Consiglio nazionale di disciplina è organismo autonomo, voluto come tale da una legge dello Stato. Ma, come ben sai personalmente, non amo le fughe, tanto da essere stato - doverosamente, a mio avviso, ma ugualmente andando contro «corrente» - accanto a te quando a Milano eri sotto processo. Se non si trattasse di Allam mi verrebbe il sospetto che questa vicenda vien cavalcata per riaccendere l'attenzione su un impegno personale e politico. Ma le cose non stanno esattamente come si afferma, pur citando correttamente i passaggi di un capo di incolpazione. Non so, essendo estraneo all'organismo, come finirà. Ma so che ad Allam sono state accordate, doverosamente, tutte le opportunità di acquisire i documenti, contenuti nel fascicolo, che riterrà utili. Di più: ha eccepito che i termini di 30 giorni non gli erano sufficienti e gli uffici, mi assicurano, gli hanno formalizzato un prolungamento che, mi riferiscono, è stato di sua soddisfazione. Ma si tende a trasmettere una informazione distorta. Allam non è stato processato. Ci si è limitati a ritenere «non manifestamente infondato» un esposto presentato da una associazione (sconosciuta, perchè sul web non c'è traccia), «Media e diritto», che si duole per alcune affermazioni contenute suoi articoli. Personalmente non mi sarei sentito oltraggiato (ma non mi sento «intoccabile», come scritto in premessa), ma, anzi, avrei colto la notizia non tanto (né solo) come l'opportunità di rivendicare la possibilità di dire quel che penso, ma anche per argomentarne più approfonditamente le ragioni. Ancor di più, non mi sarei scandalizzato perché questa procedura conferma che non ci sono «intoccabili» e che le ragioni di tutti vengono valutate con attenzione. Una differenza non marginale, ad esempio e senza generalizzazioni, con chi vive di una giustizia, sommaria e tutta sua, sgozzando davanti alla telecamera un giornalista. Enzo Iacopino, Presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti.
Caro presidente, in effetti ho provato sulla mia pelle la tua solidarietà e te ne sono riconoscente e grato. Il che non ha impedito che nostri solerti colleghi mi ri-processassero, nonostante la «grazia» che mi ha concesso il presidente Napolitano, e condannassero a due mesi di sospensione (l'appello, come saprai è a giorni). Ma questa è un'altra storia. È vero, come dici, che non ci devono essere intoccabili, ma chissà perché chi la pensa in un certo modo è più toccato di altri. E quando ad allungare le mani sono colleghi od organi che sia pure autonomi riconducibili all'Ordine dei giornalisti, allora mi preoccupo. Mi piacerebbe che l'Ordine, e tutto ciò che ruota attorno ad esso, si battesse sempre e comunque per la libertà di pensiero ed espressione, di chiunque. Perché è questo, per stare in tema, che distingue la nostra società da quella islamica, il più delle volte fondata sulla sharia. A quei signori che hanno fatto l'esposto bastava spiegare questa semplice verità non trattabile: ci spiace, ma da noi si è liberi di pensare, dire e scrivere, ciò che si crede, per eventuali reati rivolgersi alla magistratura ordinaria. Alessandro Sallusti.
Vogliono toglierci la libertà di critica. Il cardine della democrazia è mettere in discussione (anche) le religioni, scrive Ida Magli su "Il Giornale". Islamofobia: strano concetto da usare in un procedimento disciplinare. «Fobia» è, infatti, termine medico che definisce un particolare disturbo psichico, presente in genere nelle nevrastenie, e che si presenta come paura, ripulsione non infrenabile nei confronti di un qualsiasi fenomeno della realtà. Freud ha aggiunto poi, con le teorie psicoanalitiche sull'inconscio, una spiegazione ulteriore del comportamento fobico affermando che il paziente è indotto a razionalizzare la propria fobia attribuendola agli aspetti negativi degli oggetti o delle persone di cui teme. Siamo sempre nel campo della psichiatria. Da qualche anno tuttavia, in Europa, e in Italia in particolar modo, le accuse di «fobia» si sprecano. Non si può aprire bocca su un qualsiasi argomento senza incorrere in questo rischio. Sarebbe bene, invece, cominciare a ricordarsi quanto cammino abbiamo fatto, quante lotte intellettuali e fisiche abbiamo dovuto sostenere, soprattutto noi, gli italiani, per giungere alla civiltà cui oggi apparteniamo. Abbiamo sofferto e pagato con il carcere e con il sangue non tanto la libertà concreta, quanto la certezza della ricerca scientifica e delle sue conoscenze, disgiunta dal pensiero filosofico, da quello politico e da qualsiasi fede religiosa. Finalmente siamo giunti anche noi, italiani, a poter godere di una democrazia totalmente laica in cui il rispetto per le convinzioni dei singoli cittadini non comporta l'impossibilità di discuterle. Questo è il punto fondamentale di una democrazia sicura di se stessa e della forza della propria libertà: ogni cittadino può e deve poter parlare con tutti gli altri di qualsiasi argomento perché vive in un gruppo ed è la vita di gruppo che forma una società e un popolo. È secondo questi principi di convivenza nella democrazia che si ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di discutere delle religioni. Oggi nessuno ritiene, in nessuna parte del mondo, che le religioni non facciano parte integrante delle culture e delle società. E ogni religione, proprio perché religione (religio è legame fra più individui) non è un fatto privato, né può essere trattato da nessuno, né singoli né governi né istituzioni, come un fatto privato. In Italia, poi, per la sua particolare storia, le discussioni e le critiche, anche fortissime, ad associazioni cattoliche, a vescovi, a parroci, a Papi, non sono mai mancate. Sarebbe sufficiente ricordarsi i dibattiti appassionati per la legislazione sul divorzio e sull'aborto. I cattolici hanno fatto allora tutto il possibile per sostenere le loro tesi che erano appunto fondate su norme dettate da un testo sacro, il Vangelo; altrettanto hanno fatto i partiti laici, e alla fine si sono svolti con assoluta libertà i relativi referendum. Cosa sarebbe stato dell'Italia, della democrazia in Italia, se qualcuno avesse pensato che i giornalisti non potevano discutere delle norme di un testo sacro, che bisognava porre loro il bavaglio, o intimorirli con provvedimenti disciplinari? Ho citato esplicitamente il Vangelo perché gli italiani possono supporre che il Corano, scritto diversi secoli dopo la venuta di Gesù, debba in qualche modo somigliargli, riprendere qualcuna delle sue tesi fondamentali. Siccome è vero il contrario perché il Corano è fondato sull'Antico Testamento, sulla legge del taglione, sulla vendetta contro i nemici, sull'obbligo di convertire gli infedeli, sui tabù dell'impurità, è quindi agli antipodi del Vangelo e agli antipodi della civiltà in cui viviamo. Visto che i musulmani sono già numerosissimi sul suolo italiano e aumentano ogni giorno, è dovere e diritto degli italiani sapere quali siano le norme di comportamento imposte da Maometto ai suoi fedeli, i quali, appunto in quanto fedeli, dovrebbero ritenerle giuste e averle fatte proprie. Ma chi dovrebbe informarli se non i giornalisti? L'ipocrisia non è nell'interesse di nessuno oggi in Italia. Intervengano i musulmani o i loro giornalisti (non gli imam) insieme a noi sui giornali e ci assicurino che, pur essendo fedeli a Maometto, ritengono sbagliate la giustizia del taglione, le norme sull'inferiorità e l'impurità delle donne, sulla fustigazione degli omosessuali, sulla lapidazione delle adultere, sull'uccisione degli infedeli... Noi gli crederemo.
Haisam Sakhanh, il jihadista che andava in tv all'Infedele di Gad Lerner, scrive “Libero Quotidiano”. L'orrore dei tagliagole, giorno dopo giorno, ora dopo ora, sconvolge l'Occidente. Solo poche ore fa, il video delle quattro sospette spie decapitate dai fanatici dell'Islam. Immagini strazianti, terrificanti, e che fanno ancor più paura perché è sempre più chiaro che i seguaci della jihad ce li abbiamo in casa. Sono molti, alcuni noti, altri no. C'è un Imam che giura: "Ci prenderemo il Vaticano". E c'è anche chi invece, in passato, andò in televisione. Due anni fa, per la precisione. Stiamo parlando di Haisam Sakhanh, nome di battaglia Abu Omar, che un tempo viveva nel milanese e che, una volta, si fece vedere negli studi de L'Infedele, la trasmissione di Gad Lerner su La7. Da mercoledì la procura di Milano ha fatto sapere di star indagando su di lui: la sua foto, ora, appare su tutti i giornali. Eppure era chiaro da tempo chi fosse, questo Abu Omar. Come ricorda Il Giornale, già nell'aprile del 2013 fu girato un video in cui il siriano-milanese si rese protagonista dell'orrore: assieme ad altri militanti prese parte all'esecuzione di 7 soldati filo-governativi, un colpo e testa e via, gli uomini in ginocchio vengono ammazzati. Nel 2012, inoltre, le autorità italiane non ritennero necessario svolgere qualche approfondimento su mister Haisam, ex elettricista a Cologno Monzese, e la sua rete: fu arrestato al termine di un assalto all'ambasciata di Roma. Haisam e i suoi vengono interrogati, indagati per danneggiamento, violazione di domicilio e violenza privata aggravata e rinviati a giudizio per direttissima. Ma non accadde nulla: tornò libero e riprese a fare proselitismi, nel nostro Paese, a Milano e hinterland. La replica di Lerner, via blog, arriva nel pomeriggio ed è velenosa. "Fra gli altri siriani che parteciparono alla trasmissione come pubblico, senza intervenire, scopriamo ora da una fotografia pubblicata su Facebook che si infiltrò un elettricista di Cologno Monzese, tale Haisam Sakhanh, che nel frattempo è entrato nella milizia Isis col nome di battaglia Abu Omar". "Naturalmente - spiega Lerner - io non ho invitato proprio nessun jihadista in trasmissione, né tre anni fa né mai. Tanto meno costui ha mai preso la parola all'Infedele. Ma per certe testate ogni occasione è buona per insultare".
Noi censurati, il jihadista invitato in tv da Lerner. L'elettricista di Cologno andato a combattere per l'Isis in Siria è indagato per terrorismo, ma due anni fa in Italia veniva trattato da eroe della rivolta, scrive Gian Micalessin su "Il Giornale. I tagliagole amici e complici dell'Isis li avevamo in casa. Vivevano e manifestavano a Milano, mentre a Roma godevano delle migliori coperture. E così quando polizia della Capitale li arrestava mentre assaltavano e devastavano le sedi diplomatiche, i magistrati li rimettevano in libertà. Del resto i ministri del governo Monti, gli stessi che rispedivano i nostri marò nella trappola indiana, ricevevano i loro capi politici alla Farnesina trattandoli alla stregua di eroi. Gad Lerner, nel frattempo, li invitava nel suo salotto televisivo. E Pier Luigi Bersani, allora segretario del Pd, non si faceva problemi ad appoggiarli concionando da un palco adornato con la bandiera dei ribelli. La stessa bandiera in cui s'avvolgevano le sprovvedute attiviste Vanessa Marzullo e Greta Ramelli inghiottite qualche settimana fa dall'inferno siriano. Ma siamo nel Belpaese. Un paese dove l'Ordine dei Giornalisti indaga chi critica l'Islam, ma si guarda bene dall'obbiettare se qualcuno da voce ad un terrorista. E dunque non succedeva nulla. E così anche quando Il Giornale , si permetteva di mostrare i volti e documentare le atrocità di questi signori tutti facevano vinta di non vedere, di non sapere, di non capire. Guardate questo signore. Il suo vero nome è Haisam Sakhanh, il suo nome di battaglia è Abu Omar. Da mercoledì, da quando l'assai sollecita procura di Milano ha fatto sapere di star indagando su di lui, tutti fanno a gara a parlarne. La sua foto campeggia dal Corriere della Sera a Repubblica e i telegiornali fanno a gara nel descriverlo come il reclutatore dei jihadisti di Milano e dintorni. Bella scoperta. Sul Giornale la sua foto era già comparsa l'11 gennaio accanto a un titolo che recitava «Cercate killer islamici? Eccone uno». Come lo sapevamo? Semplice. A differenza degli «ignari» magistrati, politici, diplomatici e di tanti colleghi, sempre pronti a chiuder gli occhi quando le notizie non sono politicamente corrette, non c'eravamo fatto scrupoli a identificare i protagonisti dell' agghiacciante video girato nell'aprile 2013 nella provincia siriana di Idlib e pubblicato lo scorso settembre sul sito web del New York Times . In quel video il siriano-milanese Sakhanh-Abu Omar è protagonista, assieme ad altri militanti guidati dal comandante Abdul Samad Hissa, della spietata esecuzione di 7 soldati governativi appena catturati. Nel filmato indossa un giubbotto marroncino, impugna il kalashnikov e ascolta il comandante che spiega a lui e altri nove militanti perché sia giusto e doveroso ammazzare i prigionieri. Subito dopo preme il grilletto e infila un proiettile nella nuca di un soldato denudato e fatto inginocchiare ai suoi piedi. A gennaio dopo la nostra denuncia nessuno muove un dito. Ma questa non è una novità. Ben più grave è che nessuno si curi di accertare i contatti e i collegamenti di Haisam alias Abu Omar nel febbraio 2012 quando il militante viene arrestato al termine di un vero e proprio assalto all'ambasciata siriana di Roma. Un assalto durante il quale guida alcuni complici all'interno degli uffici della sede diplomatica devastandoli e malmenando alcuni impiegati. Interrogati dal giudice Marina Finiti e indagati per danneggiamento, violazione di domicilio e violenza privata aggravata Haisam e i suoi vengono rinviati a giudizio per direttissima. Ma anche allora non succede nulla. Lui torna libero, continua a far proseliti e a guidare il suo gruppetto basato a Milano e dintorni. Tra questi si distingue l'amico Ammar Bacha che il 19 agosto 2012 non si fa problemi a pubblicare un video in cui i decapitatori dell'Isis (Stato Islamico dell'Iraq e del levante) illustrano la propria attività con il consueto corollario di atrocità e violenze. Anche stavolta tutti fanno finta di non vedere. Del resto solo pochi mesi prima, il 13 maggio 2012, il ministro Giulio Terzi ha incontrato alla Farnesina il Presidente del Consiglio Nazionale Siriano (Cns), Bourhan Ghalioun, capo politico di quei ribelli già allora finanziati dal Qatar e monopolizzati dall'estremismo di Al Qaida e dell'Isis. E così qualche mese dopo pm e polizia si guardano bene dal fermare il signor Sakhanh e il suo sodale. E loro fuggono in Turchia e poi in Siria. Dove possono finalmente dedicarsi alla loro attività più congeniale. Ovvero uccidere e massacrare.
Le decapitazioni di Isis e gli allarmi della Fallaci. Il video dell'uccisione di James Foley riporta alla mente le parole (inascoltate) della scrittrice, scrive Marco Ventura su Panorama. E quindi non è "un conflitto di civiltà" quello che è sotto gli occhi di tutti in Iraq, Siria, Africa? Il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, sempre così graziosamente politically correct, nega in Parlamento la matrice di "civiltà" nei sanguinosi eventi di queste ore e nella risposta di Stati Uniti e Europa, quasi dovessimo vergognarci di difendere i valori dell'Occidente contro una versione esasperata e integralista dell'Islam globale. Ma è così? Arancione e nero. Sapete a cosa penso guardando quell’immagine surreale, terribilmente cinematografica, del giornalista americano James Foley in tuta arancione come i prigionieri di Guantanamo inginocchiato davanti a un paesaggio desertico, il busto eretto e il mento dritto, la postura fiera incongruente con le parole che deve pronunciare, e poi guardando quella figura di morte nera accanto a lui, in piedi, quel tagliagole mascherato dell’Is, coltello in mano, che si rivolge direttamente in inglese a Barack Obama (“You, Obama”) prima di decapitare la sua vittima? Penso, ecco, a Oriana Fallaci. Ai profeti inascoltati che l’Italia ha avuto, e al fatto che per vedere meglio nel futuro si sono dovuti trasferire all’estero, negli Stati Uniti, e da lì vaticinare, puntare l’indice, declamare il j’accuse, le loro omelie laiche da italiani che amano l’Italia e disprezzano però una certa Italia (e Europa). La Fallaci come Prezzolini, isolato nel suo esilio americano (e svizzero). Penso a quanti hanno criticato la Fallaci degli ultimi anni considerando i suoi scritti, le sue invettive finali (o definitive) contro l’invasione islamica, il pericolo islamico, la brutalità islamica, una sorta di metastasi del pensiero, quasi un cancro dello spirito parallelo al male che le consumava il corpo. Ascoltate (sì, ascoltate) quello che Oriana scriveva “Ai lettori” all’indomani dell’11/9, in apertura de “La rabbia e l’orgoglio” (Rizzoli): “Dall’Afghanistan al Sudan, dall’Indonesia al Pakistan, dalla Malesia all’Iran, dall’Egitto all’Iraq, dall’Algeria al Senegal, dalla Siria al Kenya, dalla Libia al Ciad, dal Libano al Marocco, dalla Palestina allo Yemen, dall’Arabia Saudita alla Somalia, l’odio per l’Occidente cresce. Si gonfia come un fuoco alimentato dal vento, e i seguaci del fondamentalismo islamico si moltiplicano come i protozoi d’una cellula che si scinde per diventare due cellule poi quattro poi otto poi sedici poi trentadue. All’infinito”. Ognuno di quei paesi evoca oggi qualcosa di terribile che è avvenuto (che avviene). I talebani comandano ancora in Afghanistan (fino in Pakistan). In Egitto la primavera araba è morta con l’avvento dei Fratelli musulmani, finalmente stroncati dalla restaurazione del generale Al-Sisi. In Libia gli islamisti proclamano il Califfato di Bengasi, guerreggiano e spargono odio e caos anche se nelle elezioni hanno dimostrato di valere poco più del 10 per cento. Tra Somalia e Kenya i guerriglieri islamisti di Al Shabaab fanno incursioni omicide lungo le strade, stragi nei centri commerciali a Nairobi. In paesi come la Nigeria che la Fallaci non citava (la sua lista oggi sarebbe più lunga) i massacri islamisti e i rapimenti delle studentesse sono firmati dalle milizie di Boko Haram. Nello Yemen dei sequestri operano cellule di Al-Qaeda. In Palestina, Hamas usa i civili come scudi umani e lancia razzi su Israele con l’obiettivo di cancellare lo Stato ebraico dalle mappe. Con l’Iran rimane il contenzioso nucleare. Di Iraq e Siria sappiamo. In Libano spadroneggiano gli Hezbollah. L’Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo non sono ancora usciti dall’ambiguità, chi più e chi meno, di sostenere o chiudere un occhio sui finanziamenti alle formazioni integraliste. E così via. Dal 2001 sono passati 13 anni e le parole de “La rabbia e l’orgoglio” si avverano. “Non capite o non volete capire che se non ci si oppone, se non ci si difende, se non si combatte, la Jihad vincerà. E distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare, a rendere un po’ più intelligente cioè meno bigotto o addirittura non bigotto. Distruggerà la nostra cultura, la nostra arte, la nostra scienza, la nostra morale, i nostri valori, i nostri piaceri…”. Oriana tuonava contro “i nuovi Mori”. Dietro le figure in nero, che c’erano anche allora, vedeva i colletti bianchi, che ci sono ancora. Ascoltiamola. “I nuovi Mori con la cravatta trovano sempre più complici, fanno sempre più proseliti. Per questo diventano sempre di più, pretendono sempre di più. E se non stiamo attenti, se restiamo inerti, troveranno sempre più complici. Diventeranno sempre di più, otterranno sempre di più, spadroneggeranno sempre di più. Fino a soggiogarci completamente. Fino a spegnere la nostra civiltà. Ergo, trattare con loro è impossibile. Ragionarci, impensabile. Cullarci nell’indulgenza o nella tolleranza o nella speranza, un suicidio. E chi crede il contrario è un illuso”. Chissà che non dovremo darle ragione, nonostante il nostro perbenismo intellettuale, pure sui rischi dei flussi migratori. Proprio in conclusione del suo pamphlet la Fallaci scrive infatti dell’Italia che “nonostante tutto esiste. Zittita, ridicolizzata, sbeffeggiata, diffamata, insultata, ma esiste. Quindi guai a chi me la tocca. Guai a chi me la invade, guai a chi me la ruba. Perché (se non l’hai ancora capito te lo ripeto con maggiore chiarezza) che a invaderla siano i francesi di Napoleone o i tedeschi di Hitler o i compari di Osama Bin Laden, per me è lo stesso. Che per invaderla usino i cannoni o i gommoni, idem”. E per finire: “Stop. Quello che avevo da dire l’ho detto… Ora basta. Punto e basta”.
Oriana Fallaci, la sua lezione su Libero Quotidiano: Maestra di libertà. la profezia sull'Islam fanatico, gli insulti della sinistra, i processi. Il testo di cui oggi iniziamo la pubblicazione - per gentile concessione di Edoardo Perazzi, nipote e erede della Fallaci - è quello di un discorso pronunciato da Oriana Fallaci nel novembre del 2005. La grande toscana fu insignita del Annie Taylor Award, un premio conferito dal Centro Studi di cultura popolare di New York. Il suo discorso, in versione integrale inglese, fu pubblicato pochi giorni dopo da Il Foglio. Poi, il primo dicembre del 2005, Libero ne pubblicò la versione italiana, col permesso della stessa Fallaci, che volle rivederne personalmente la forma (modificandola tramite memorabili telefonate con l'allora responsabile delle pagine culturali Alessandro Gnocchi). Abbiamo deciso di ripubblicare questo testo perché pensiamo che oggi, a quasi dieci anni di distanza, sia più attuale che mai. Bé: un premio intitolato a una donna che saltò sopra le Cascate del Niagara, e sopravvisse, è mille volte più prezioso e prestigioso ed etico di un Oscar o di un Nobel: fino a ieri gloriose onorificenze rese a persone di valore ed oggi squallide parcelle concesse a devoti antiamericani e antioccidentali quindi filoislamici. Insomma a coloro che recitando la parte dei guru illuminati che definiscono Bush un assassino, Sharon un criminale-di-guerra, Castro un filantropo, e gli Stati Uniti «la-potenza-più-feroce, più-barbara, più-spaventosa-che-il-mondo-abbia-mai-conosciuto». Infatti se mi assegnassero simili parcelle (graziaddio un’eventualità più remota del più remoto Buco Nero dell’Universo), querelerei subito le giurie per calunnia e diffamazione. Al contrario, accetto questo «Annie Taylor» con gratitudine e orgoglio. E pazienza se sopravvaluta troppo le mie virtù. Sì: specialmente come corrispondente di guerra, di salti ne ho fatti parecchi. In Vietnam, ad esempio, sono saltata spesso nelle trincee per evitare mitragliate e mortai. Altrettanto spesso sono saltata dagli elicotteri americani per raggiungere le zone di combattimento. In Bangladesh, anche da un elicottero russo per infilarmi dentro la battaglia di Dacca. Durante le mie interviste coi mascalzoni della Terra (i Khomeini, gli Arafat, i Gheddafi eccetera) non meno spesso sono saltata in donchisciotteschi litigi rischiando seriamente la mia incolumità. E una volta, nell’America Latina, mi sono buttata giù da una finestra per sfuggire agli sbirri che volevano arrestarmi. Però mai, mai, sono saltata sopra le Cascate del Niagara. Né mai lo farei. Troppo rischioso, troppo pericoloso. Ancor più rischioso che palesare la propria indipendenza, essere un dissidente cioè un fuorilegge, in una società che al nemico vende la Patria. Con la patria, la sua cultura e la sua civiltà e la sua dignità. Quindi grazie David Horowitz, Daniel Pipes, Robert Spencer. E credetemi quando dico che questo premio appartiene a voi quanto a me. A tal punto che, quando ho letto che quest’anno avreste premiato la Fallaci, mi sono chiesta: «Non dovrei esser io a premiare loro?». E per contraccambiare il tributo volevo presentarmi con qualche medaglia o qualche trofeo da consegnarvi. Mi presento a mani vuote perché non sapevo, non saprei, dove comprare certa roba. Con le medaglie e i trofei ho un’esigua, davvero esigua, familiarità. E vi dico perché. Anzitutto perché crediamo di vivere in vere democrazie, democrazie sincere e vivaci nonché governate dalla libertà di pensiero e di opinione. Invece viviamo in democrazie deboli e pigre, quindi dominate dal dispotismo e dalla paura. Paura di pensare e, pensando, di raggiungere conclusioni che non corrispondono a quelle dei lacchè del potere. Paura di parlare e, parlando, di dare un giudizio diverso dal giudizio subdolamente imposto da loro. Paura di non essere sufficientemente allineati, obbedienti, servili, e venire scomunicati attraverso l’esilio morale con cui le democrazie deboli e pigre ricattano il cittadino. Paura di essere liberi, insomma. Di prendere rischi, di avere coraggio. «Il segreto della felicità è la libertà. E il segreto della libertà è il coraggio», diceva Pericle. Uno che di queste cose se ne intendeva. (Tolgo la massima dal secondo libro della mia trilogia: La Forza della ragione. E da questo prendo anche il chiarimento che oltre centocinquanta anni fa Alexis de Tocqueville fornì nel suo intramontabile trattato sulla democrazia in America). Nei regimi assolutisti o dittatoriali, scrive Tocqueville, il dispotismo colpisce il corpo. Lo colpisce mettendolo in catene o torturandolo o sopprimendolo in vari modi. Decapitazioni, impiccagioni, lapidazioni, fucilazioni, Inquisizioni eccetera. E così facendo risparmia l’anima che intatta si leva dalla carne straziata e trasforma la vittima in eroe. Nelle democrazie inanimate, invece, nei regimi inertamente democratici, il dispotismo risparmia il corpo e colpisce l’anima. Perché è l’anima che vuole mettere in catene. Torturare, sopprimere. Così alle sue vittime non dice mai ciò che dice nei regimi assolutisti o dittatoriali: «O la pensi come me o muori». Dice: «Scegli. Sei libero di non pensare o di pensare come la penso io. Se non la pensi come la penso io, non ti sopprimerò. Non toccherò il tuo corpo. Non confischerò le tue proprietà. Non violenterò i tuoi diritti politici. Ti permetterò addirittura di votare. Ma non sarai mai votato. Non sarai mai eletto. Non sarai mai seguito e rispettato. Perché ricorrendo alle mie leggi sulla libertà di pensiero e di opinione, io sosterrò che sei impuro. Che sei bugiardo, dissoluto, peccatore, miserabile, malato di mente. E farò di te un fuorilegge, un criminale. Ti condannerò alla Morte Civile, e la gente non ti ascolterà più. Peggio. Per non essere a sua volta puniti, quelli che la pensano come te ti diserteranno». Questo succede, spiega, in quanto nelle democrazie inanimate, nei regimi inertamente democratici, tutto si può dire fuorché la Verità. Perché la Verità ispira paura. Perché, a leggere o udire la verità, i più si arrendono alla paura. E per paura delineano intorno ad essa un cerchio che è proibito oltrepassare. Alzano intorno ad essa un’invisibile ma insormontabile barriera dentro la quale si può soltanto tacere o unirsi al coro. Se il dissidente oltrepassa quella linea, se salta sopra le Cascate del Niagara di quella barriera, la punizione si abbatte su di lui o su di lei con la velocità della luce. E a render possibile tale infamia sono proprio coloro che segretamente la pensano come lui o come lei, ma che per convenienza o viltà o stupidità non alzano la loro voce contro gli anatemi e le persecuzioni. Gli amici, spesso. O i cosiddetti amici. I partner. O i cosiddetti partner. I colleghi. O i cosiddetti colleghi. Per un poco, infatti, si nascondono dietro il cespuglio. Temporeggiano, tengono il piede in due staffe. Ma poi diventano silenziosi e, terrorizzati dai rischi che tale ambiguità comporta, se la svignano. Abbandonano il fuorilegge, il criminale, al di lui o al di lei destino e con il loro silenzio danno la loro approvazione alla Morte Civile. (Qualcosa che io ho esperimentato tutta la vita e specialmente negli ultimi anni. «Non ti posso difendere più» mi disse, due o tre Natali fa, un famoso giornalista italiano che in mia difesa aveva scritto due o tre editoriali. «Perché?» gli chiesi tutta mesta. «Perché la gente non mi parla più. Non mi invita più a cena»). L’altro motivo per cui ho un’esigua familiarità con le medaglie e i trofei sta nel fatto che soprattutto dopo l’11 Settembre l’Europa è diventata una Cascata del Niagara di Maccartismo sostanzialmente identico a quello che afflisse gli Stati Uniti mezzo secolo fa. Sola differenza, il suo colore politico. Mezzo secolo fa era infatti la Sinistra ad essere vittimizzata dal Maccartismo. Oggi è la Sinistra che vittimizza gli altri col suo Maccartismo. Non meno, e a parer mio molto di più, che negli Stati Uniti. Cari miei, nell’Europa d’oggi v’è una nuova Caccia alle Streghe. E sevizia chiunque vada contro corrente. V’è una nuova Inquisizione. E gli eretici li brucia tappandogli o tentando di tappargli la bocca. Eh, sì: anche noi abbiamo i nostri Torquemada. I nostri Ward Churchill, i nostri Noam Chomsky, i nostri Louis Farrakhan, i nostri Michael Moore eccetera. Anche noi siamo infettati dalla piaga contro la quale tutti gli antidoti sembrano inefficaci. La piaga di un risorto nazi-fascismo. Il nazismo islamico e il fascismo autoctono. Portatori di germi, gli educatori cioè i maestri e le maestre che diffondono l’infezione fin dalle scuole elementari e dagli asili dove esporre un Presepe o un Babbo Natale è considerato un «insulto-ai-bambini-Mussulmani». I professori (o le professoresse) che tale infezione la raddoppiano nelle scuole medie e la esasperano nelle università. Attraverso l’indottrinazione quotidiana, il quotidiano lavaggio del cervello, si sa. (La storia delle Crociate, ad esempio, riscritta e falsificata come nel 1984 di Orwell. L’ossequio verso il Corano visto come una religione di pace e misericordia. La reverenza per l’Islam visto come un Faro di Luce paragonato al quale la nostra civiltà è una favilla di sigaretta). E con l’indottrinazione, le manifestazioni politiche. Ovvio. Le marce settarie, i comizi faziosi, gli eccessi fascistoidi. Sapete che fecero, lo scorso ottobre, i giovinastri della Sinistra radicale a Torino? Assaltarono la chiesa rinascimentale del Carmine e ne insozzarono la facciata scrivendoci con lo spray l’insulto «Nazi-Ratzinger» nonché l’avvertimento: «Con le budella dei preti impiccheremo Pisanu». Il nostro Ministro degli Interni. Poi su quella facciata urinarono. (Amabilità che a Firenze, la mia città, non pochi islamici amano esercitare sui sagrati delle basiliche e sui vetusti marmi del Battistero). Infine irruppero dentro la chiesa e, spaventando a morte le vecchine che recitavano il Vespro, fecero scoppiare un petardo vicino all’altare. Tutto ciò alla presenza di poliziotti che non potevano intervenire perché nella città Politically Correct tali imprese sono considerate Libertà-di-espressione. (A meno che tale libertà non venga esercitata contro le moschee: s’intende). E inutile aggiungere che gli adulti non sono migliori di questi giovinastri. La scorsa settimana, a Marano, popolosa cittadina collocata nella provincia di Napoli, il Sindaco (ex seminarista, ex membro del Partito Comunista Italiano, poi del vivente Partito di Rifondazione Comunista, ed ora membro del Partito dei Comunisti Italiani) annullò tout-court l’ordinanza emessa dal commissario prefettizio per dedicare una strada ai martiri di Nassiriya. Cioè ai diciannove militari italiani che due anni fa i kamikaze uccisero in Iraq. Lo annullò affermando che i diciannove non erano martiri bensì mercenari, e alla strada dette il nome di Arafat. «Via Arafat». Lo fece piazzando una targa che disse: «Yasser Arafat, simbolo dell’Unità (sic) e della Resistenza Palestinese». Poi l’interno del municipio lo tappezzò con gigantesche foto del medesimo, e l’esterno con bandiere palestinesi. La piaga si propaga anche attraverso i giornali, la Tv, la radio. Attraverso i media che per convenienza o viltà o stupidità sono in gran maggioranza islamofili e antioccidentali e antiamericani quanto i maestri, i professori, gli accademici. Che senza alcun rischio di venir criticati o beffati passano sotto silenzio episodi come quelli di Torino o Marano. E in compenso non dimenticano mai di attaccare Israele, leccare i piedi all’Islam. Si propaga anche attraverso le canzoni e le chitarre e i concerti rock e i film, quella piaga. Attraverso uno show-business dove, come i vostri ottusi e presuntuosi e ultra-miliardari giullari di Hollywood, i nostri giullari sostengono il ruolo di buonisti sempre pronti a piangere per gli assassini. Mai per le loro vittime. Si propaga anche attraverso un sistema giudiziario che ha perduto ogni senso della Giustizia, ogni rispetto della giurisdizione. Voglio dire attraverso i tribunali dove, come i vostri magistrati, i nostri magistrati assolvono i terroristi con la stessa facilità con cui assolvono i pedofili. (O li condannano a pene irrisorie). E finalmente si propaga attraverso l’intimidazione della buona gente in buona fede. Voglio dire la gente che per ignoranza o paura subisce quel dispotismo e non comprende che col suo silenzio o la sua sottomissione aiuta il risorto nazi-fascismo a fiorire. Non a caso, quando denuncio queste cose, mi sento davvero come una Cassandra che parla al vento. O come uno dei dimenticati antifascisti che settanta e ottanta anni fa mettevano i ciechi e i sordi in guardia contro una coppia chiamata Mussolini e Hitler. Ma i ciechi restavano ciechi, i sordi restavano sordi, ed entrambi finirono col portar sulla fronte ciò che ne L’Apocalisse chiamo il Marchio della Vergogna. Di conseguenza le mie vere medaglie sono gli insulti, le denigrazioni, gli abusi che ricevo dall’odierno Maccartismo. Dall’odierna Caccia alle Streghe, dall’odierna Inquisizione. I miei trofei, i processi che in Europa subisco per reato di opinione. Un reato ormai travestito coi termini «vilipendio dell’Islam, razzismo o razzismo religioso, xenofobia, istigazione all’odio eccetera». Parentesi: può un Codice Penale processarmi per odio? Può l’odio essere proibito per Legge? L’odio è un sentimento. È una emozione, una reazione, uno stato d’animo. Non un crimine giuridico. Come l’amore, l’odio appartiene alla natura umana. Anzi, alla Vità. È l’opposto dell’amore e quindi, come l’amore, non può essere proibito da un articolo del Codice Penale. Può essere giudicato, sì. Può essere contestato, osteggiato, condannato, sì. Ma soltanto in senso morale. Ad esempio, nel giudizio delle religioni che come la religione cristiana predicano l’amore. Non nel giudizio d’un tribunale che mi garantisce il diritto di amare chi voglio. Perché, se ho il diritto di amare chi voglio, ho anche e devo avere anche il diritto di odiare chi voglio. Incominciando da coloro che odiano me. Sì, io odio i Bin Laden. Odio gli Zarkawi. Odio i kamikaze e le bestie che ci tagliano la testa e ci fanno saltare in aria e martirizzano le loro donne. Odio gli Ward Churchill, i Noam Chomsky, i Louis Farrakhan, i Michael Moore, i complici, i collaborazionisti, i traditori, che ci vendono al nemico. Li odio come odiavo Mussolini e Hitler e Stalin and Company. Li odio come ho sempre odiato ogni assalto alla Libertà, ogni martirio della Libertà. È un mio sacrosanto diritto. E se sbaglio, ditemi perché coloro che odiano me più di quanto io odi loro non sono processati col medesimo atto d’accusa. Voglio dire: ditemi perché questa faccenda dell’Istigazione all’Odio non tocca mai i professionisti dell’odio, i mussulmani che sul concetto dell’odio hanno costruito la loro ideologia. La loro filosofia. La loro teologia. Ditemi perché questa faccenda non tocca mai i loro complici occidentali. Parentesi chiusa, e torniamo ai trofei che chiamo processi. Si svolgono in ogni paese nel quale un figlio di Allah o un traditore nostrano voglia zittirmi e imbavagliarmi nel modo descritto da Tocqueville, quei processi. A Parigi, cioè in Francia, ad esempio. La France Eternelle, la Patrie du Laïcisme, la Bonne Mère du Liberté-Egalité-Fraternité, dove per vilipendio dell’Islam soltanto la mia amica Brigitte Bardot ha sofferto più travagli di quanti ne abbia sofferti e ne soffra io. La France Libérale, Progressiste, dove tre anni fa gli ebrei francesi della LICRA (associazione ebrea di Sinistra che ama manifestare alzando fotografie di Ariel Sharon con la svastica sulla fronte) si unì ai mussulmani francesi del MRAP (associazione islamica di Sinistra che ama manifestare levando cartelli di Bush con la svastica sugli occhi). E dove insieme chiesero al Codice Penale di chiudermi in galera, confiscare La Rage et l’Orgueil o venderla con il seguente ammonimento sulla copertina: «Attenzione! Questo librò può costituire un pericolo per la vostra salute mentale». (Insieme volevano anche intascare un grosso risarcimento danni, naturalmente). Oppure a Berna, in Svizzera. Die wunderschöne Schweitz, la meravigliosa Svizzera di Guglielmo Tell, dove il Ministro della Giustizia osò chiedere al mio Ministro della Giustizia di estradarmi in manette. O a Bergamo, Nord Italia, dove il prossimo processo avverrà il prossimo giugno grazie a un giudice che sembra ansioso di condannarmi a qualche anno di prigione: la pena che per vilipendio dell’Islam viene impartita nel mio paese. (Un paese dove senza alcuna conseguenza legale qualsiasi mussulmano può staccare il crocifisso dai muri di un’aula scolastica o di un ospedale, gettarlo nella spazzatura, dire che il crocifisso «ritrae-un-cadaverino-nudo-inventato-per-spaventare-i-bambini-mussulmani». E sapete chi ha promosso il processo di Bergamo? Uno dei mai processati quindi mai condannati specialisti nel buttare via i crocifissi. L’autore di un sudicio libretto che per molto tempo ha venduto nelle moschee, nei Centri Islamici, nelle librerie sinistrorse d’Italia. Quanto alle minacce contro la mia vita cioè all’irresistibile desiderio che i figli di Allah hanno di tagliarmi la gola o farmi saltare in aria o almeno liquidarmi con un colpo di pistola nella nuca, mi limiterò a dire che specialmente quando sono in Italia devo essere protetta ventiquattro ore su ventiquattro dai Carabinieri. La nostra polizia militare. E, sia pure a fin di bene, questa è una durissima limitazione alla mia libertà personale. Quanto agli insulti, agli anatemi, agli abusi con cui i media europei mi onorano per conto della trista alleanza Sinistra-Islam, ecco alcune delle qualifiche che da quattro anni mi vengono elargite: «Abominevole. Blasfema. Deleteria. Troglodita. Razzista. Retrograda. Ignobile. Degenere. Reazionaria. Abbietta». Come vedete, parole identiche o molto simili a quelle usate da Alexis de Tocqueville quando spiega il dispotismo che mira alla Morte Civile. Nel mio paese quel dispotismo si compiace anche di chiamarmi «Iena», nel distorcere il mio nome da Oriana in «Oriena» e nello sbeffeggiarmi attraverso sardoniche identificazioni con Giovanna d’Arco. «Le bestialità della neo Giovanna d’Arco». «Taci, Giovanna d’Arco». «Ora basta, Giovanna d’Arco».
Scontro di (in)civiltà. Oriana Fallaci: le galline della sinistra in ginocchio dagli islamici. Per gentile concessione dell’erede Edoardo Perazzi, continuiamo la pubblicazione del discorso che Oriana Fallaci pubblicò nel 2005, quando fu insignita del «Annie Taylor Award», prestigioso riconoscimento statunitense. I temi che la Fallaci affronta sono quelli delle sue celebri opere, tutte edite da Rizzoli. Lo scorso agosto venni ricevuta in udienza privata da Ratzinger, insomma da Papa Benedetto XVI. Un Papa che ama il mio lavoro da quando lesse Lettera a un bambino mai nato e che io rispetto profondamente da quando leggo i suoi intelligentissimi libri. Un Papa, inoltre, col quale mi trovo d’accordo in parecchi casi. Per esempio, quando scrive che l’Occidente ha maturato una sorta di odio contro sé stesso. Che non ama più sé stesso, che ha perso la sua spiritualità e rischia di perdere anche la sua identità. (Esattamente ciò che scrivo io quando scrivo che l’Occidente è malato di un cancro morale e intellettuale. Non a caso ripeto spesso: «Se un Papa e un’atea dicono la stessa cosa, in quella cosa dev’esserci qualcosa di tremendamente vero»). Nuova parentesi. Sono un’atea, sì. Un’atea-cristiana, come sempre chiarisco, ma un’atea. E Papa Ratzinger lo sa molto bene. Ne La Forza della Ragione uso un intero capitolo per spiegare l’apparente paradosso di tale autodefinizione. Ma sapete che cosa dice lui agli atei come me? Dice: «Ok. (L’ok è mio, ovvio). Allora Veluti si Deus daretur. Comportatevi come se Dio esistesse». Parole da cui desumo che nella comunità religiosa vi sono persone più aperte e più acute che in quella laica alla quale appartengo. Talmente aperte ed acute che non tentano nemmeno, non si sognano nemmeno, di salvarmi l’anima cioè di convertirmi. Uno dei motivi per cui sostengo che, vendendosi al teocratico Islam, il laicismo ha perso il treno. È mancato all’appuntamento più importante offertogli dalla Storia e così facendo ha aperto un vuoto, una voragine che soltanto la spiritualità può riempire. Uno dei motivi, inoltre, per cui nella Chiesa d’oggi vedo un inatteso partner, un imprevisto alleato. In Ratzinger, e in chiunque accetti la mia per loro inquietante indipendenza di pensiero e di comportamento, un compagnon-de-route. Ammenoché anche la Chiesa manchi al suo appuntamento con la Storia. Cosa che tuttavia non prevedo. Perché, forse per reazione alle ideologie materialistiche che hanno caratterizzato lo scorso secolo, il secolo dinanzi a noi mi sembra marcato da una inevitabile nostalgia anzi da un inevitabile bisogno di religiosità. E, come la religione, la religiosità finisce sempre col rivelarsi il veicolo più semplice (se non il più facile) per arrivare alla spiritualità. Chiusa la nuova parentesi. E così ci incontrammo, io e questo gentiluomo intelligente. Senza cerimonie, senza formalità, tutti soli nel suo studio di Castel Gandolfo conversammo e l’incontro non-professionale doveva restare segreto. Nella mia ossessione per la privacy, avevo chiesto che così fosse. Ma la voce si diffuse ugualmente. Come una bomba nucleare piombò sulla stampa italiana, e indovina ciò che un petulante idiota con requisiti accademici scrisse su un noto giornale romano di Sinistra. Scrisse che il Papa può vedere quanto vuole «i miserabili, gli empi, i peccatori, i mentalmente malati» come la Fallaci. Perché «il Papa non è una persona perbene». (A dispetto di ogni dizionario e della stessa Accademia della Crusca, il «perbene» scritto "per bene"). Del resto, e sempre pensando a Tocqueville, alla sua invisibile ma insuperabile barriera dentro-la-quale-si-può-soltanto-tacere-o-unirsi-al-coro, non dimentico mai quello che quattro anni fa accadde qui in America. Voglio dire quando l’articolo La Rabbia e l’Orgoglio (non ancora libro) apparve in Italia. E il New York Times scatenò la sua Super Political Correctness con una intera pagina nella quale la corrispondente da Roma mi presentava come «a provocateur» una «provocatrice». Una villana colpevole di calunniare l’Islam... Quando l’articolo divenne libro e apparve qui, ancora peggio. Perché il New York Post mi descrisse, sì, come «La Coscienza d’Europa, l’eccezione in un’epoca dove l’onestà e la chiarezza non sono più considerate preziose virtù». Nelle loro lettere i lettori mi definirono, sì, «il solo intelletto eloquente che l’Europa avesse prodotto dal giorno in cui Winston Churchill pronunciò lo Step by Step cioè il discorso con cui metteva in guardia l’Europa dall’avanzata di Hitler». Ma i giornali e le TV e le radio della Sinistra al Caviale rimasero mute, oppure si unirono alla tesi del New York Times. Tantomeno dimentico ciò che è avvenuto nel mio paese durante questi giorni di novembre 2005. Perché, pubblicato da una casa editrice che nella maggioranza delle quote azionarie appartiene ai miei editori italiani, e da questi vistosamente annunciato sul giornale che consideravo il mio giornale, in un certo senso la mia famiglia, un altro libro anti- Fallaci ora affligge le librerie. Un libro scritto, stavolta, dall’ex vice-direttore del quotidiano che un tempo apparteneva al defunto Partito Comunista. Bé, non l’ho letto. Né lo leggerò. (Esistono almeno sei libri su di me. Quasi tutti, biografie non-autorizzate e piene di bugie offensive nonché di grottesche invenzioni. E non ne ho mai letto uno. Non ho mai neppure gettato lo sguardo sulle loro copertine). Ma so che stavolta il titolo, naturalmente accompagnato dal mio nome che garantisce le vendite, contiene le parole «cattiva maestra». So che la cattiva-maestra è ritratta come una sordida reazionaria, una perniciosa guerrafondaia, una mortale portatrice di «Orianismo». E secondo l’ex vice-direttore dell’ex quotidiano ultracomunista, l’Orianismo è un virus. Una malattia, un contagio, nonché un’ossessione, che uccide tutte le vittime contaminate. (Graziaddio, molti milioni di vittime. Soltanto in Italia, la Trilogia ha venduto assai più di quattro milioni di copie in tre anni. E negli altri ventun paesi è un saldo bestseller). Ma questo non è tutto. Perché nei medesimi giorni il sindaco milanese di centro-destra mi incluse nella lista degli Ambrogini: le molto ambite medaglie d’oro che per la festa di Sant’Ambrogio la città di Milano consegna a persone note, o quasi, nel campo della cultura. E quando il mio nome venne inserito, i votanti della Sinistra sferrarono un pandemonio che durò fino alle cinque del mattino. Per tutta la notte, ho saputo, fu come guardare una rissa dentro un pollaio. Le penne volavano, le creste e i bargigli sanguinavano, i coccodè assordavano, e lode al cielo se nessuno finì al Pronto Soccorso. Poi, il giorno dopo, tornarono strillando che il mio Ambrogino avrebbe inquinato il pluriculturalismo e contaminato la festa di Sant’Ambrogio. Che avrebbe dato alla cerimonia del premio un significato anti-islamico, che avrebbe offeso i mussulmani e i premiati della Sinistra. Quest’ultimi minacciarono addirittura di respingere le ambite medaglie d’oro e promisero di inscenare una fiera dimostrazione contro la donna perversa. Infine il leader del Partito di Rifondazione Comunista dichiarò: «Dare l’Ambrogino alla Fallaci è come dare il Premio Nobel della Pace a George W. Bush». Detto questo, onde rendere a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, devo chiarire qualcosa che certo dispiacerà ad alcuni o alla maggioranza di voi. Ecco qua. Io non sono un Conservatore. Non simpatizzo con la Destra più di quanto non simpatizzi con la Sinistra. Sebbene rifiuti ogni classificazione politica, mi considero una rivoluzionaria. Perché la Rivoluzione non significa necessariamente la Presa della Bastiglia o del Palais d’Hiver. E certamente per me non significa i capestri, le ghigliottine, i plotoni di esecuzione, il sangue nelle strade. Per me la Rivoluzione significa dire «No». Significa lottare per quel «No». Attraverso quel «No», cambiare le cose. E di sicuro io dico molti «No». Li ho sempre detti. Di sicuro vi sono molte cose che vorrei cambiare. Cioè non mantenere, non conservare. Una è l’uso e l’abuso della libertà non vista come Libertà ma come licenza, capriccio, vizio. Egoismo, arroganza, irresponsabilità. Un’altra è l’uso e l’abuso della democrazia non vista come il matrimonio giuridico dell’Uguaglianza e della Libertà ma come rozzo e demagogico egualitarismo, insensato diniego del merito, tirannia della maggioranza. (Di nuovo, Alexis de Tocqueville...). Un’altra ancora, la mancanza di autodisciplina, della disciplina senza la quale qualsiasi matrimonio dell’uguaglianza con la libertà si sfascia. Un’altra ancora, il cinico sfruttamento delle parole Fratellanza-Giustizia-Progresso. Un’altra ancora, la nescienza di onore e il tripudio di pusillanimità in cui viviamo ed educhiamo i nostri figli. Tutte miserie che caratterizzano la Destra quanto la Sinistra. Cari miei: se coi suoi spocchiosi tradimenti e le sue smargiassate alla squadrista e i suoi snobismi alla Muscadin e le sue borie alla Nouvel Riche la Sinistra ha disonorato e disonora le grandi battaglie che combatté nel Passato, con le sue nullità e le sue ambiguità e le sue incapacità la Destra non onora certo il ruolo che si vanta di avere. Ergo, i termini Destra e Sinistra sono per me due viete e antiquate espressioni alle quali ricorro solo per abitudine o convenienza verbale. E, come dico ne La Forza della Ragione, in entrambe vedo solo due squadre di calcio che si distinguono per il colore delle magliette indossate dai loro giocatori ma che in sostanza giocano lo stesso gioco. Il gioco di arraffare la palla del Potere. E non il Potere di cui v’è bisogno per governare: il Potere che serve sé stesso. Che esaurisce sé stesso in sé stesso.
Maestra di libertà. Oriana Fallaci e l'Islam: "Diventeremo l'Eurabia. Il nemico è in casa nostra e non vuole dialogare". Per gentile concessione dell'erede Edoardo Perazzi, continuiamo la pubblicazione del discorso che Oriana Fallaci pubblicò nel 2005, quando fu insignita del Annie Taylor Award, prestigioso riconoscimento statunitense. I temi che la Fallaci affronta sono quelli delle sue celebri opere, tutte edite da Rizzoli. Questo può apparir demagogico, semplicistico, e perfino superficiale: lo so. Ma se analizzate i fatti vedrete che la mia è pura e semplice verità. La verità del bambino che nella fiaba dei Grimm, quando i cortigiani lodano le vesti del re, grida con innocenza: Il re è nudo. Pensateci ragionando sull'attuale tragedia che ci opprime. Perbacco, nessuno può negare che l'invasione islamica dell'Europa sia stata assecondata e sia assecondata dalla Sinistra. E nessuno può negare che tale invasione non avrebbe mai raggiunto il culmine che ha raggiunto se la Destra non avesse fornito alla Sinistra la sua complicità, se la Destra non le avesse dato il imprimatur. Diciamolo una volta per sempre: la Destra non ha mai mosso un dito per impedire o almeno trattenere la crescita dell’invasione islamica. Un solo esempio? Come in molti altri paesi europei, in Italia è il leader della Destra ufficiale che imita la Sinistra nella sua impazienza di concedere il voto agli immigrati senza cittadinanza. E questo in barba al fatto che la nostra Costituzione conceda il voto ai cittadini e basta. Non agli stranieri, agli usurpatori, ai turisti col biglietto di andata senza ritorno. Di conseguenza, non posso essere associata né con la Destra né con la Sinistra. Non posso essere arruolata né dalla Destra né dalla Sinistra. Non posso essere strumentalizzata né della Destra né della Sinistra. (E guai a chi ci prova). E sono profondamente irritata con entrambe. Qualunque sia la loro locazione e nazionalità. Attualmente, per esempio, sono irritata con la Destra americana che spinge i leader europei ad accettare la Turchia come membro dell’Unione Europea. Esattamente ciò che la Sinistra europea vuole da sempre. Ma le vittime dell’invasione islamica, i cittadini europei, non vogliono la Turchia a casa loro. La gente come me non vuole la Turchia a casa sua. E Condoleezza Rice farebbe bene a smetterla di esercitare la sua Realpolitik a nostre spese. Condoleezza è una donna intelligente: nessuno ne dubita. Certo, più intelligente della maggioranza dei suoi colleghi maschi e femmine, sia qui in America che al di là dell’Atlantico. Ma sul paese che per secoli fu l’Impero Ottomano, sulla non-europea Turchia, sulla islamica-Turchia, sa o finge di sapere assai poco. E sulla mostruosa calamità che rappresenterebbe l’entrata della Turchia nell’Unione Europea conosce o finge di conoscere ancora meno. Così dico: Ms. Rice, Mr. Bush, signori e signore della Destra americana, se credete tanto in un paese dove le donne hanno spontaneamente rimesso il velo e dove i Diritti Umani vengono quotidianamente ridicolizzati, prendetevelo voi. Chiedete al Congresso di annetterlo agli stati Uniti come Cinquantunesimo Stato e godetevelo voi. Poi concentratevi sull’Iran. Sulla sua lasciva nucleare, sul suo ottuso ex-sequestratore di ostaggi cioè sul suo presidente, e concentratevi sulla sua nazista promessa di cancellare Israele dalle carte geografiche. A rischio di sconfessare l’illimitato rispetto che gli americani vantano nei riguardi di tutte le religioni, devo anche chiarire ciò che segue. Come mai in un Paese dove l’85 per cento dei cittadini dicono di essere Cristiani, così pochi si ribellano all’assurda offensiva che sta avvenendo contro il Natale? Come mai così pochi si oppongono alla demagogia dei radicals che vorrebbero abolire le vacanze di Natale, gli alberi di Natale, le canzoni di Natale, e le stesse espressioni Merry Christmas e Happy Christmas, Buon Natale, eccetera?!? Come mai così pochi protestano quando quei radicals gioiscono come Talebani perché in nome dei laicismo un severo monumento a gloria dei Dieci Comandamenti viene rimosso da una piazza di Birmingham? E come mai anche qui pullulano le iniziative a favore della religione islamica? Come mai, per esempio, a Detroit (la Detroit ultra polacca e ultra cattolica le ordinanze municipali contro i rumori proibiscono il suono delle campane) la minoranza islamica ha ottenuto che i muezzin locali possano assordare il prossimo coi loro Allah-akbar dalle 6 del mattino alle 10 di sera? Come mai in un paese dove la Legge ordina di non esibire i simboli religioni nei luoghi pubblici, non consentirvi preghiere dell’una o dell’altra religione, aziende quali la Dell Computers e la Tyson Foods concedono ai propri dipendenti islamici i loro cortili nonché il tempo per recitare le cinque preghiere? E questo a dispetto del fatto che tali preghiere interrompono quindi inceppano le catene di montaggio? Come mai il nefando professor Ward Churchill non è stato licenziato dall’Università del Colorado per i suoi elogi a Bin Laden e all’11 Settembre, ma il conduttore della Washington radio Michael Graham è stato licenziato per aver detto che dietro il terrorismo islamico v’è la religione islamica? Ed ora lasciatemi concludere questa serata affrontando altri tre punti che considero cruciali. Punto numero uno. Sia a Destra che a Sinistra tutti si focalizzano sul terrorismo. Tutti. Perfino i radicali più radicali. (Cosa che non sorprende perché le condanne verbali del terrorismo sono il loro alibi. Il loro modo di pulire le loro coscienze non pulite). Ma nel terrorismo islamico non vedo l’arma principale della guerra che i figli di Allah ci hanno dichiarato. Nel terrorismo islamico vedo soltanto un aspetto, un volto di quella guerra. Il più visibile, sì. Il più sanguinoso e il più barbaro, ovvio. Eppure, paradossalmente, non il più pernicioso. Non il più catastrofico. Il più pernicioso e il più catastrofico è a parer mio quello religioso. Cioè quello dal quale tutti gli altri aspetti, tutti gli altri volti, derivano. Per incominciare, il volto dell’immigrazione. Cari amici: è l’immigrazione, non il terrorismo, il cavallo di Troia che ha penetrato l’Occidente e trasformato l’Europa in ciò che chiamo Eurabia. È l’immigrazione, non il terrorismo, l’arma su cui contano per conquistarci annientarci distruggerci. L’arma per cui da anni grido: «Troia brucia, Troia brucia». Un’immigrazione che in Europa-Eurabia supera di gran lunga l’allucinante sconfinamento dei messicani che col beneplacito della vostra Sinistra e l’imprimatur della vostra Destra invadono gli Stati Uniti. Soltanto nei venticinque paesi che formano l’Unione Europea, almeno venticinque milioni di musulmani. Cifra che non include i clandestini mai espulsi. A tutt’oggi, altri quindici milioni o più. E data l’irrefrenabile e irresistibile fertilità mussulmana, si calcola che quella cifra si raddoppierà nel 2016. Si triplicherà o quadruplicherà se la Turchia diventerà membro dell’Unione Europea. Non a caso Bernard Lewis profetizza che entro il 2100 tutta l’Europa sarà anche numericamente dominata dai musulmani. E Bassan Tibi, il rappresentante ufficiale del cosiddetto Islam Moderato in Germania, aggiunge: «Il problema non è stabilire se entro il 2100 la stragrande maggioranza o la totalità degli europei sarà mussulmana. In un modo o nell’altro, lo sarà. Il problema è stabilire se l’Islam destinato a dominare l’Europa sarà un Euro-Islam o l’Islam della Svaria». Il che spiega perché non credo nel Dialogo con l’Islam. Perché sostengo che tale dialogo è un monologo. Un soliloquio inventato per calcolo dalla Realpolitik e poi tenuto in vita dalla nostra ingenuità o dalla nostra inconfessata disperazione. Infatti su questo tema dissento profondamente dalla Chiesa Cattolica e da Papa Ratzinger. Più cerco di capire e meno capisco lo sgomentevole errore su cui la sua speranza si basa. Santo Padre: naturalmente anch’io vorrei un mondo dove tutti amano tutti e dove nessuno è nemico di nessuno. Ma il nemico c’è. Lo abbiamo qui, in casa nostra. E non ha nessuna intenzione di dialogare. Né con Lei né con noi. Di Oriana Fallaci.
Montanelli Fallaci, libro a 4 mani. Finì a “ti disprezzo” e “ti credevo migliore”, scrive Riccardo Galli su Blitz Quotidiano. Il titolo lo si sarebbe potuto trovare facilmente e avrebbe potuto, magari, suonare più o meno così: “L’impossibile libro a 4 mani”. E’, anzi era il progetto editoriale targato Rizzoli che poco meno di mezzo secolo fa avrebbe voluto dare i natali ad un libro scritto da due monumenti del giornalismo italiano: Indro Montanelli e Oriana Fallaci. Un progetto naufragato però ancor prima di reificarsi a causa delle personalità delle due “penne”. Personalità a dir poco ingombranti e, di certo, poco disponibili ad una posizione di non protagonista assoluto. Foss’anche nella stesura di un libro. Un progetto abortito e sconosciuto, almeno sino a che Paolo Di Paolo, raccogliendo materiale per un libro su Montanelli, non si è ritrovato tra le mani una lettera della Fallaci. Una lettera in cui la giornalista, da New York, scriveva alla moglie di Montanelli parlandole proprio del libro in questione: “Niente schemi rigidi, niente cattedre da una parte o dall’altra”. Da questo frammento è partita una ricerca che ha svelato la storia, o almeno parte di essa, del libro mai nato. Una storia che Di Paolo racconta sul Corriere della Sera. “Cinque anni prima – agosto 1971 – erano stati (Montanelli e la Fallaci ndr.) sul punto di scrivere un volume a quattro mani, ma il progetto naufragò. Questo libro mai nato rischiava di essere un capo lavoro: provate ad immaginare due penne simili – così sopra la media di chiunque scriva oggi, così brillanti, così feroci e libere – nello stesso spazio editoriale”. “’Niente schemi rigidi, niente cattedre da una parte o dall’altra’ precisa la Fallaci scrivendo alla moglie di Indro, Colette Rosselli, il 7 agosto del ’71,. Mentre lavoravo ad un libro su Montanelli – racconta Di Paolo sul Corriere – ho ritrovato questa curiosa lettera: l’Oriana racconta a Colette di aver tardato ad iniziare il lavoro per una serie di ragioni – una febbre tropicale presa durante un servizio in Asia, la malattia della madre e dello zio Bruno, ma anche una ‘comprensibile paura, una comprensibile timidezza che un po’ per volta mi aveva invaso’”. Da questa traccia si possono quasi immaginare i due, Montanelli e la Fallaci, uno al di qua e una al di là dell’Atlantico, da New York dove viveva, scambiarsi appassionate lettere. Internet, e con lui le e-mail, erano ancora lontani da venire e, per comunicare, i due dovevano per forza di cose ricorrere all’unico sistema allora efficiente: carta e penna. E allora lettere. Lettere in cui la Fallaci confida un pizzico di timore reverenziale alla moglie di quello che comunque, complici i 20 anni di differenza, considera in qualche modo un maestro. E lettere in cui il “maestro” manifesta comunque l’ammirazione per quella che ai suoi occhi è una “ragazzina”, seppur piena di talento. Lettere in cui dalla timidezza si passa alle idee e, rapidamente, allo scontro e alla fine ai veri e propri insulti. Una parabola in cui si possono riconoscere i caratteri dei due che, idee politiche a parte, hanno effettivamente contribuito a fare la storia del giornalismo italiano. La rabbia e l’orgoglio che, prima di divenire il titolo del libro probabilmente più celebre della Fallaci, erano parte integrante e caratterizzante della giornalista. E poi l’indisponibilità ad accettare lezioni da una “ragazzina” e le differenti visioni del mondo e, soprattutto, della Resistenza che Montanelli e che la Fallaci hanno e che saranno alla base della rottura tra i due. Dall’idea di un lavoro fatto insieme infatti a questo si arriva: ad una rottura praticamente definitiva tra i due. Anche se, entrambi, non smetteranno di riconoscere il valore dell’altro. “Ti disprezzo”, scriverà Montanelli. “Ti credevo migliore” le risponderà la Fallaci. Epitaffio di una collaborazione che avrebbe potuto essere magnifica ma che non poteva in realtà essere.
E poi c'è quello che nessuno ha mai detto. L'Oriana Fallaci che visse la storia di Gesù in diretta. "Stampo da mezzo secolo L'Evangelo di Maria Valtorta, 10 volumi. Contiene dettagli inediti che solo una testimone oculare può aver visto", scrive Stefano Lorenzetto su “Il Giornale”. Immaginate un'Oriana Fallaci al fianco di Gesù, pronta a osservare e a riferire tutto ciò che vede, con una dovizia di particolari da lasciare attoniti; una cronista dalla penna insuperabile, molto più attenta di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, i quattro evangelisti che narrarono la vita del Nazareno in modo succinto o riferendo episodi dei quali non furono testimoni diretti. Quella donna è esistita. Si chiamava Maria Valtorta. La cosa incredibile è che nacque a Caserta il 14 marzo 1897 e morì a Viareggio il 12 ottobre 1961. Ciononostante ha lasciato 122 quaderni di scuola - in tutto 13.193 pagine - compilati in uno stato di ascesi mistica fra il 1943 e il 1947, nei quali descrive per filo e per segno l'infanzia, la predicazione, i miracoli, la passione, la morte, la resurrezione e l'ascensione al cielo del Salvatore, citando luoghi, personaggi e dialoghi che nei Vangeli non compaiono. Ho potuto vedere alcuni di questi quaderni: la grafia, sgorgata da sette penne stilografiche tuttora conservate, è nitida, regolare, senza ombra di correzioni o tremori. Eppure la Valtorta era paraplegica, rimase inchiodata nel letto per 27 anni, fino al decesso, e come scrittoio doveva usare le proprie ginocchia arcuate, che infatti al momento di chiuderla nella bara erano ancora piegate in quella posa innaturale. Emilio Pisani, 79 anni, laureato in giurisprudenza, è da sempre il curatore e l'editore unico dell'opera monumentale ricavata da questi quaderni, L'Evangelo come mi è stato rivelato. Sono 10 volumi, per un totale di 5.000 pagine. Oltre 10 milioni di caratteri. Ciò significa che il racconto valtortiano è 25 volte più lungo dei quattro Vangeli canonici. «Quante copie sono in circolazione? Non lo so, c'è chi dice milioni», si sottrae pudico lo stampatore. Una cosa è certa: dal 1956 a oggi è stato tradotto persino in arabo, cinese, coreano, giapponese, russo, lituano, ucraino, croato, indonesiano, vietnamita, malayalam, tamil, rwandese e swahili. Oltre una trentina di lingue. Pisani, fondatore del Cev, il Centro editoriale valtortiano, va considerato un editore unico anche per il fatto che nessun altro suo collega al mondo ha in catalogo un solo autore. Né mi era mai capitato d'incontrare un editore che arde nel caminetto di casa i manoscritti inediti di questo suo autore. In gioventù Maria Valtorta perse il padre molto presto e così si risolse a scrivere un romanzo autobiografico, Il cuore di una donna, dal quale sperava di ricavare qualche soldo per la famiglia. In realtà non volle mai pubblicarlo e ordinò a Marta Diciotti, la governante-infermiera che la assistette dal 1935 sino alla fine, di distruggerlo. La donna non ebbe però il coraggio di farlo. «Nel 2001, prima di morire, la Diciotti consegnò il testo a me e a mia moglie», rievoca Pisani. «Lo aprimmo soltanto 10 anni più tardi. Erano pagine fittissime. Senza leggere neppure una riga , ci parve giusto bruciarle. Le ceneri le spargemmo qui fuori, nell'aiuola delle rose, che da allora fioriscono ancora più rigogliose». La villetta dei Pisani è nel giardino in cui ha sede la casa editrice, a Isola del Liri. Dal 2012 è più vuota: Claudia Vecchiarelli, insegnante di lettere e traduttrice che aveva aiutato il marito a diffondere il verbo della Valtorta, è morta di tumore. Il suo Emilio, un uomo mite dagli occhi limpidi come l'acqua delle cascate che si ammirano nel paesino della provincia di Frosinone, le ha dedicato un libro, Lettera a Claudia, in cui ripercorre la straordinaria avventura capitata a entrambi. Insieme hanno dato vita alla Fondazione Maria Valtorta Cev onlus, che amministra l'eredità materiale e spirituale della veggente e che ha acquistato dai Servi di Maria la sua casa di Viareggio, ora trasformata in museo. Per testamento sono finiti a loro tutti i documenti autografi della «evangelista», inclusi i famosi quaderni, oggi custoditi a Isola del Liri. Proprio in questi giorni gli italiani Marco Ruopoli e Matteo Ferretti e il mauritano Mor Amar, della cooperativa Sophia di Roma, hanno ultimato di digitalizzarli in alta definizione, per cui presto saranno consultabili in Pdf. Dopodiché gli originali finiranno in un caveau climatizzato, isolati dalla luce e dalla polvere.
Com'è diventato l'editore di Maria Valtorta?
«Cominciai come correttore di bozze con mio padre Michele, che negli anni Venti aveva aperto insieme al cognato Arturo Macioce una tipografia specializzata nella stampa di vite dei santi e trattati di teologia per il Vaticano e gli istituti religiosi. Una copia dell' Evangelo, dattilografata con la carta carbone dal direttore spirituale della Valtorta, il servita padre Romualdo Migliorini, fu data in lettura a Camillo Corsanego, notaio dei conclavi e decano degli avvocati concistoriali per le cause dei santi, il quale, benché sposato e padre di 6 figli, poteva fregiarsi del titolo di monsignore. Un'altra copia andò all'arcivescovo Alfonso Carinci, che era stato insegnante del futuro Pio XII all'Almo Collegio Capranica. Un'altra ancora al famoso endocrinologo Nicola Pende, che rimase impressionato dalla “perizia con cui la Valtorta descrive, nella scena dell'agonia di Gesù sulla croce, una fenomenologia che solo pochi medici consumati saprebbero esporre”. Quando i Servi di Maria chiesero al Sant'Uffizio il permesso di pubblicare il testo, la risposta fu negativa. Al che mio padre, che era stato convocato a Roma per stamparlo, si assunse l'onere di farlo come editore in proprio e nel 1952 firmò il primo contratto di edizione con la Valtorta».
Lei l'ha conosciuta?
«Certo. Andai a trovarla a Viareggio, dove il Venerdì santo del 1943 ebbe la prima rivelazione e il primo dettato».
Fu una visione? O udì una voce?
«Penso a un fenomeno interiore. Diceva di vedere Gesù e Maria accanto a sé e di essere stata fisicamente presente agli episodi narrati nei Vangeli. Leggendo la sua Autobiografia, mi ero convinto che fosse una grande donna. Giaceva nel letto e ripeteva spesso: “Che sole c'è qui!”, anche se fuori pioveva. Era in uno stato di isolamento psichico, come se avesse offerto il suo intelletto a Dio. Non le interessava comunicare con il resto dell'umanità. Quando nel 1956 ebbe fra le mani il primo volume del suo Evangelo che avevamo appena stampato, lo guardò distrattamente e lo appoggiò sulla coperta, come se non le appartenesse».
Che cosa sa della mistica?
«Era la figlia unica di Giuseppe Valtorta, mantovano, ufficiale di cavalleria, e di Iside Fioravanti, cremonese, docente di francese. A 4 anni, nell'asilo delle orsoline a Milano, le sue coetanee erano spaventate da un Cristo deposto dalla croce, raffigurato con crudo verismo nella cappella dell'istituto. Lei, invece, avrebbe voluto aprire l'urna in cui era deposto per mettergli nella mano trafitta dal chiodo il confetto che la nonna le dava ogni mattina accompagnandola a scuola. Studiò nel collegio Bianconi di Monza e nel 1917 entrò nel corpo delle infermiere volontarie che a Firenze curavano i feriti della Grande guerra. Si fidanzò due volte e per due volte sua madre, una donna fredda, dispotica, terribile, le mandò a monte il matrimonio. Nel 1920 fu aggredita per strada da un giovane facinoroso, che le diede una mazzata sui reni gridando: “Abbasso i signori e i militari!”. A causa dell'aggressione, nel 1934 rimase paralizzata dalla cintola in giù».
Ma che ha di speciale L'Evangelo ?
«Introduce personaggi e racconti che nei Vangeli sinottici non appaiono. Giovanni dice solo che Giuda era un ladro. Nell' Evangelo si spiega che rubò del denaro a Giovanna di Cusa, moglie di un intendente di Erode. Lo stesso Giuda si accorge che il Maestro piange dopo aver resuscitato il figlio della vedova di Nain, al quale la Valtorta dà per la prima volta un nome, Daniele. Interrogato dal discepolo traditore sul motivo di quelle lacrime, Gesù risponde: “Penso a mia madre”. L' Evangelo presenta figure sconosciute, come Giovanni di Endor, ex ergastolano, e Sintica, schiava greca assai colta, convertiti al cristianesimo. Per una delazione di Giuda al sinedrio, vengono esiliati ad Antiochia, da dove inviano lettere al Nazareno in cui descrivono la città della Siria con immagini e toponimi che hanno sbalordito lo studioso francese Jean-François Lavère e il mineralogista Vittorio Tredici. Quest'ultimo era di casa in Palestina e annotò come la Valtorta superasse “la normale cognizione geografica o panoramica” facendola diventare “addirittura topografica e più ancora geologica”».
L'autrice potrebbe aver attinto questi particolari in qualche biblioteca.
«E quale, considerato che non era in grado di muoversi? I libri che teneva in casa li ho io e nessuno di essi tratta della città di Seleucia Pieria, o dei monti Casio e Sulpio, o dei colonnati di Erode. Ma la cosa più strabiliante è che la Valtorta riporta in modo minuzioso la pianta e persino il colore rosso delle pareti di un palazzo che Lazzaro di Betania, resuscitato da Gesù a quattro giorni dalla morte, possedeva sulla collina di Sion. Soltanto nel 1983 un'équipe di archeologi diretta dal professor Nahman Avigad della Hebrew University di Gerusalemme ritrovò i resti della dimora, perfettamente corrispondenti alla descrizione fattane dalla mistica 40 anni prima».
Mi sfugge il senso di tanta meticolosaggine narrativa.
«Ma non sfugge a Gesù, che il 25 gennaio 1944 impartì alla Valtorta - è lei a riportarlo - questo comando: “Ricorda di essere scrupolosa al sommo nel ripetere quanto vedi. Anche una inezia ha un valore e non è tua, ma mia. Più sarai attenta ed esatta e più sarà numeroso il numero di coloro che vengono a Me”».
L'Osservatore Romano il 6 gennaio 1960 bollò L'Evangelo come «una vita di Gesù malamente romanzata».
«Inevitabile. Pochi giorni prima, il 16 dicembre 1959, era stato condannato dal Sant'Uffizio. Fu l'ultima opera messa nell' Indice dei libri proibiti, prima che Paolo VI lo abolisse: per non liberare il carcerato, demolirono il carcere. Il tutto a causa di qualche passaggio giudicato scabroso, come il racconto di Aglae, un'ex prostituta che confida a Maria di Nazaret il modo in cui un soldato romano la adescò dopo averla vista nuda».
Però nel 1985 l'allora cardinale Joseph Ratzinger ribadì la condanna.
«Con un distinguo: spiegò che la pubblicazione fu a suo tempo vietata “al fine di neutralizzare i danni che può arrecare ai fedeli più sprovveduti”. Quindi ai fedeli più avveduti non può arrecare danno, non essendovi in essa nulla contro la fede. Il cardinale Dionigi Tettamanzi, quand'era segretario della Cei, avrebbe preteso che inserissi nel colophon una postilla per avvertire i lettori che l'opera non è di origine soprannaturale. Ma chi sono io per arrogarmi questa autorità?».
È vero che Pio XII stimava la Valtorta?
«È vero che lesse l' Evangelo in dattiloscritto e che disse a padre Migliorini: “Pubblicatelo così com'è. Chi legge capirà”. Di sicuro lo capì San Pio da Pietrelcina. La bolognese Rosi Giordani nel 1989 mi scrisse che Elisa Lucchi di Forlì chiese al frate in confessione: “Padre, ho udito parlare dei libri di Maria Valtorta. Mi consigliate di leggerli?”. La risposta fu: “Non te lo consiglio, ma te lo ordino!”».
Ha notato che i veggenti, così numerosi nei secoli scorsi, sono spariti?
«Non sono mai stato né a Lourdes, né a Fatima, né a Medjugorje, pur rispettando chi ci va. Non aggiungerebbero nulla alla mia fede. La Valtorta non ambì mai a farsi conoscere. Il suo Evangelo doveva camminare nel mondo senza essere del mondo; pretese persino che la prima edizione uscisse in forma anonima. Una sola volta lo reclamizzai con un'inserzione a pagamento su Tuttolibri della Stampa: ebbene, nelle settimane seguenti ricevetti un unico ordine, evento mai capitato in precedenza. Come se l'opera rifiutasse la pubblicità».
Sorprendente.
«Le dico di più. Nel 1973 la salma della Valtorta fu esumata a Viareggio per essere traslata a Firenze, nella Basilica della Santissima Annunziata, dove vi è il celebre affresco della Madonna, a lei molto caro, che secondo Pietro Bargellini sarebbe stato completato da un angelo. Il servita Corrado Berti si aspettava un evento straordinario, per esempio il ritrovamento del corpo incorrotto. Invece affiorarono poche ossa, che fecero l'estremo viaggio con me alla guida dell'auto, mia moglie accanto e la governante Marta sul sedile posteriore».
Perché me lo racconta?
«Perché sul letto di morte la Valtorta aveva la mano sinistra già bluastra, mentre la destra, quella con cui aveva scritto L'Evangelo, era ancora rosea, come se fosse viva: nel 1961 fu considerato un segno del cielo. E la vuol sapere una cosa? Le uniche ossa che mancavano quando la disseppellimmo erano proprio quelle della mano destra. Dissolte. Come se la mistica volesse dirci per l'ultima volta: “Non pensate a me. Pensate a Lui”».
MAFIA E TERRORISMO DA QUALE PULPITO VIEN LA PREDICA. L’ITALIA CODARDA ED IL PATTO CON IL DIAVOLO. MEGLIO PAGARE IL PIZZO.
La trattativa tra Stato italiano e Cosa nostra (o trattativa stato-mafia), scrive Wikipedia, è una intrattenuta negoziazione tra lo Stato italiano e la mafia che si è sviluppata in seguito alla stagione delle bombe del '92 e '93 per giungere ad un accordo; oggetto ipotizzato dell'accordo sarebbe stato la fine della stagione stragista in cambio di un'attenuazione delle misure detentive previste dall'articolo 41 bis. L'ipotesi è oggetto di indagini giudiziarie e inchieste giornalistiche. La supposta trattativa è stata ritenuta riscontrata nella motivazione della sentenza del processo a Francesco Tagliavia per le bombe del '92 e '93. Secondo quella sentenza l'iniziativa per la trattativa "fu assunta da rappresentanti dello Stato e non dagli uomini di mafia". Ad oggi tale negoziazione non è stata definitivamente e chiaramente dimostrata, anzi risulta corrente oggetto di diverse inchieste, per le quali sono stati indagati diversi esponenti di Cosa nostra come Totò Riina e Bernardo Provenzano, alcuni politici tra i quali l'ex senatore del Pdl Marcello Dell'Utri, il suo ex socio in affari il finanziere Filippo Alberto Rapisarda, il deputato ed ex ministro democristiano Calogero Mannino nonché alcuni appartenenti alle forze dell'ordine come il generale dei carabinieri e capo del ROS Antonio Subranni l'allora colonnello Mario Mori e il suo braccio destro al ROS, il capitano Giuseppe De Donno che disse: "Decidemmo di contattare in qualche modo la mafia attraverso Vito Ciancimino per fermare le stragi, ma non ci fu nessuna trattativa". Molti sostenitori dell'ipotesi indicano che la trattativa sia avvenuta nel periodo tra la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e che quest'ultimo possa essere stato assassinato anche perché veniva considerato un ostacolo alla trattativa tra Stato e mafia, secondo le rivelazioni ancora da accertare di Gaspare Spatuzza e di Giovanni Brusca.
«Trattativa Stato-mafia era lecita». Uno storico e un giurista «contro» i pm. Il libro di Salvatore Lupo e Giovanni Fiandaca: «Far cessare le stragi era uno stato di necessità», scrive Giovanni Bianconi su “Il Corriere della Sera”. Lo storico la mette così: nella primavera del 1992, dopo l’omicidio Lima e la strage di Capaci, lo Stato era sotto scacco e la mafia procedeva dritta sulla strada del terrorismo. In quel drammatico momento, all’interno delle istituzioni «qualcuno può avere avviato, più o meno autonomamente, trattative con la leadership dell’organizzazione mafiosa, o con qualche sua fazione, o qualche suo satellite... Il reato di trattativa non esiste, e per fortuna». Niente di strano, insomma. Il giurista ritiene che di fronte a una simile emergenza si possa invocare addirittura lo «stato di necessità», che giustificherebbe «eventuali interventi o decisioni extralegem del potere esecutivo»; fermo restando il bilanciamento costi-benefici, «la scelta politico-governativa di fare concessioni ai mafiosi in cambio della cessazione delle stragi risulterebbe legittima perché legittimata, appunto, dalla presenza di una situazione necessitante che impone agli organi pubblici di proteggere la vita dei cittadini». Farà discutere il doppio saggio che Salvatore Lupo (lo storico) e Giovanni Fiandaca (il giurista) hanno scritto per gli Editori Laterza, significativamente intitolato La mafia non ha vinto - Il labirinto della trattativa , (pagg. 154, euro 12,00). Perché al netto delle digressioni accademiche, dei tanti distinguo e dei dubbi tra cui gli stessi autori si muovono per arrivare alle proprie conclusioni, la tesi del libro è che il processo in corso a Palermo sul presunto «patto occulto» tra lo Stato e Cosa nostra non sta in piedi. È sbagliato sul piano giuridico e per la visione storico-politica da cui prende le mosse. Una tesi netta, argomentata con analisi approfondite naturalmente suscettibili di obiezioni (qualcuna non infondata), destinata a provocare ulteriori polemiche intorno al dibattimento che vede alla sbarra — uno di fianco all’altro, accusati di essere autori e complici del ricatto mafioso — boss del calibro Riina, Brusca e Bagarella, ex carabinieri come i generali Mori e Subranni ed ex esponenti politici come Mannino e Dell’Utri, (più l’ex ministro Mancino imputato di falsa testimonianza). Frutto di un’inchiesta che ha provocato divisioni e conflitti, anche istituzionali, senza precedenti. Ci sarà chi accuserà gli autori di delegittimare la magistratura, e chi li utilizzerà per delegittimarla (com’è successo per un altro saggio del professor Fiandaca sul medesimo argomento), mentre sarebbe bene leggere il libro «laicamente», e dibatterne senza pregiudizi né strumentalizzazioni, da una parte o dall’altra. Non sarà facile, anche perché è Fiandaca ad accusare gli inquirenti palermitani di un «pregiudiziale atteggiamento criminalizzatore» ispirato da «una sorta di avversione morale» verso «ipotesi trattattivistiche» che sono prerogativa del potere esecutivo, senza necessità di un previo assenso dell’autorità giudiziaria. Vero è che «interessi tutt’altro che nobili e aspetti di forte ambiguità hanno contribuito a rendere poco chiaro e poco trasparente lo scenario di allora», ma resta la domanda di fondo: «Ciò è sufficiente per escludere la possibile liceità di concessioni a Cosa nostra, trasformando negoziatori istituzionali operanti a fin di bene in una banda di delinquenti in combutta con la mafia?». La risposta del giurista è no. Anche perché — sostiene — ammesso che la mancata proroga di oltre 300 decreti di «carcere duro» per altrettanti detenuti «non di primaria grandezza» fosse una concessione a Cosa nostra per evitare nuove stragi (l’unica concreta, nei fatti), fu comunque un atto «di discrezionalità politica» dell’allora Guardasigilli Conso, «insindacabile penalmente». Sia che il ministro l’abbia assunta «in piena solitudine», come afferma, sia che abbia aderito a mirati suggerimenti, come ipotizza l’accusa: «La decisione rimane giuridicamente legittima in entrambi i casi. Altra cosa sono le valutazioni politiche o di opportunità». Alle quali si dedica il professor Lupo: il ministro della Giustizia aveva pieno diritto di concedere quelle «aperture» senza venire meno ai propri doveri, e «agì comunque nell’ambito delle sue competenze, scegliendo tra due alternative per cui militavano buoni argomenti». Lo storico concede che da alcuni messaggi fatti filtrare dai capimafia ai loro gregari si arguisce che «la trattativa c’è stata, solo che purtroppo (per i boss, ndr ) qualcuno si è rimangiato la parola». Verità o millanteria che fosse, argomenta Lupo, non c’è scandalo: il piano storico-politico non va confuso con quello etico né tantomeno con quello giudiziario; non a caso, quando ai tempi del caso Moro ci fu chi tentò trattative coi brigatisti, nessuno s’immaginò di imbastire processi. Al cattedratico non interessa contestare i magistrati, quanto mettere in guardia da una visione complottistica che instilli nell’opinione pubblica l’idea che fu commesso qualcosa di losco, e oggi il complotto si rinnova perché non venga fuori. Il giurista, invece, si concentra sul reato inserito nel capo d’imputazione (violenza o minaccia a un corpo politico), definito un «espediente giuridico» teso a «colorare indirettamente di criminosità la stessa trattativa». Tanto più, insiste Fiandaca, che la sede competente non sarebbe Palermo, nonostante su questo punto si siano già pronunciati, dopo i pubblici ministeri, il giudice dell’udienza preliminare e la Corte chiamata a celebrare il processo. Che non si sarebbe dovuto nemmeno aprire perché, fanno capire gli autori anche dal titolo del libro, lo Stato ha vinto e la mafia ha perso. Senza più tornare ai fasti sanguinosi del tempo delle stragi. Anche questo proverebbe che certi comportamenti di vent’anni fa avevano buone ragioni; non «di Stato», bensì di salvaguardia delle «persone in carne ed ossa». Scelte che non si possono giudicare in un’aula di giustizia, sostengono Lupo e Fiandaca. Pena lo scadimento nell’«uso politicamente antagonista della giustizia penale» e nel «populismo giudiziario» da cui discende la demonizzazione di ogni critica, anche giuridicamente motivata, bollata come «attacco sferrato dai nemici della verità». Ce n’è abbastanza per alimentare il dibattito intorno a quel che accadrà, di qui in avanti, nell’aula della Corte d’assise di Palermo.
«La Trattativa Stato-mafia era necessaria», scrive Alberto Sofia su “Giornalettismo”. I due intellettuali Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo, arrivano a invocare uno «stato di necessità» in un saggio controverso «La Trattativa Stato-mafia era necessaria». C’è chi, come la procura di Palermo, tenta di ricostruire la verità su quel patto segreto tra Cosa Nostra e pezzi deviati delle istituzioni, a cavallo tra la stagione stragista del ’92-’93. Nelle vesti dell’accusa nel processo sulla trattativa Stato-mafia, dopo essere riuscita a portare nella stessa aula boss, politici e vertici delle forze dell’ordine, nonostante vent’anni di silenzio e depistaggi. Ci sono poi le «Scorte civiche», quei cittadini riuniti in presidio simbolico che continuano a manifestare la propria solidarietà nei confronti dei magistrati minacciati e al pm Nino Di Matteo, vittima dell’ordine di morte partito dal “Capo dei Capi”, Totò Riina, dal carcere di Opera. Ma c’è anche chi, al contrario, preferisce portare avanti il «processo al processo», insistendo nel delegittimare l’impianto accusatorio del pool palermitano. È il caso degli autori del saggio «La mafia non ha vinto», il giurista Giovanni Fiandaca e lo storico Salvatore Lupo: un testo che tenta di smontare il processo in corso, sostenendo come i comportamenti sotto accusa non costituiscano reato, che Cosa Nostra non sia stata salvata e che le tesi dei pm della procura palermitana non reggano. Ma non solo. Nel saggio pubblicato dalla casa editrice Laterza si arriva fino a giustificare la trattativa stessa. Invocando un presunto «stato di necessità», in un periodo in cui l’Italia era sotto choc per lo stragismo, che renderebbe leciti «eventuali interventi o decisioni extralegem del potere esecutivo». Per Salvatore Lupo, fermo restando il bilanciamento costi-benefici, «la scelta politico-governativa di fare concessioni ai mafiosi in cambio della cessazione delle stragi risulterebbe legittima, perché legittimata, appunto, dalla presenza di una situazione necessitante che impone agli organi pubblici di proteggere la vita dei cittadini». In pratica, una trattativa “a fin di bene”, per “tutelare” gli italiani. E non quei politici democristiani (e non solo) finiti, insieme a Salvo Lima, nella blacklist mafiosa, che Cosa Nostra accusava di aver tradito promesse e attese in seguito alla conferma delle pesanti condanne del maxiprocesso: da Calogero Mannino a Claudio Martelli, fino ai figli di Andreotti, secondo il racconto del pentito Gioacchino La Barbera (lo stesso che ha svelato anche come il tritolo fosse pronto anche per l’attuale presidente del Senato Pietro Grasso, allora procuratore, ndr). Non si capisce però in che modo la trattativa avrebbe dovuto tutelare i cittadini, dato che oltre alle stragi di Capaci e Via d’Amelio che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, seguirono nel ’93 altre bombe, tra gli attentati di via Fauro a Roma, via dei Georgofili a Firenze, via Palestro a Milano e le auto-bombe di fronte alle basiliche di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano nella Capitale. In totale, 15 morti e decine di feriti. Ma non è l’unica tesi controversa del saggio – definita dalla Laterza «sorprendente, uno sguardo nuovo su un processo ricco di ambiguità, coni d’ombra e nodi tecnici da sciogliere» – capace di scatenare reazioni indignate soprattutto tra i parenti delle vittime, che l’hanno interpretata come un nuovo attacco al pool di Palermo. Una teoria poi bollata e attaccata con l’epiteto di «grande monnezza» dal vicedirettore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, già in passato scontratosi con il giurista Fiandaca (che sul Foglio aveva etichettato come una “boiata pazzesca” il processo sulla trattativa). Nonostante le polemiche partite dopo le anticipazioni del saggio pubblicate dal Corriere della Sera, la Commissione antimafia presieduta da Rosy Bindi ha pensato di invitare il co-autore Fiandaca a presentare le sue teorie di fronte ai parlamentari, scatenando le proteste in rete di diverse associazioni antimafia, che hanno spiegato di ritenere «inopportuno il suo intervento, mentre è in corso il processo che proprio quella trattativa ha per oggetto» nell’aula bunker dell’Uccciardone a Palermo. Non è la prima volta che Fiandaca accusa il pool palermitano e critica il processo sulla trattativa. Eppure, se prima questa veniva spacciata per “presunta”, nonostante sentenze giudiziarie (come quella che ha condannato all’ergastolo il boss di Brancaccio Francesco Tagliavia per la strage di via dei Georgofili a Firenze, dove si spiega che «indubbiamente ci fu e venne quantomeno inizialmente impostata su un do ut des», oltre che «assunta da rappresentanti dello Stato e non dagli uomini di mafia», ndr), le dichiarazioni a verbale di Mori e De Donno, testimonianze di pentiti che la confermano, nel saggio c’è un cambio di prospettiva, seppur tra perifrasi e perplessità. La trattativa viene ammessa nel volume («Qualcuno può avere avviato, più o meno autonomamente, trattative con la leadership dell’organizzazione mafiosa, o con qualche sua fazione, o qualche suo satellite…»), ma si azzarda la teoria secondo cui la decisione di venire a patti con i mafiosi in cambio della cessazione delle stragi risulterebbe legittima, perché legittimata «dalla presenza di una situazione necessitante che impone agli organi pubblici di proteggere la vita dei cittadini». Fiandaca invoca uno «stato di necessità» , allontanando i paragoni con la «categoria obsoleta della ragion di Stato» (dato che, secondo lui, «eventuali deroghe alla legalità formale, decise e a livello governativo, avrebbero come motivazione […] il perseguimento di un fine salvifico, il contrasto al pericolo incombente di danni gravi alle persone in carne e ossa») e spiegando come, con lo Stato sotto scacco, «l’iniziativa di Mori e De Donno di contattare Ciancimino poteva essere anche a posteriori considerata come «meritoria e coraggiosa». Oltre che «nemmeno biasimevole o illecita, neppure se – come sostiene l’accusa – fosse stata sollecitata da Mannino». Anche perché, a suo dire, risulta «non incompatibile con il complessivo quadro giuridico» e giustificabile, «in particolare per un organismo come il Ros, qualche forma di attività investigativa borderline o non completamente in linea con regole procedurali formalisticamente interpretate». In pratica, tutto viene minimizzato e legittimato. Con buona pace delle vittime della stagione stragista, continuata anche nel 1993, come già ricordato. «Mi pare che accettare l’idea dell’opportunità di un tentativo di dialogo con l’organizzazione mafiosa possa aprire a scenari incerti e indefiniti, in cui si rischia di accettare che la mafia diventi una controparte, o addirittura un interlocutore», ha replicato il pm Di Matteo. Mentre, di fronte alle giustificazioni di Lupo e Fiandaca, è stata Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell’”Associazione familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili” a spiegare: «Dire questo è un fatto gravissimo, dovrebbe generare la rabbia di tutti i familiari che hanno perso qualcuno in quelle stragi. C’è la volontà di dare un’immagine pulita di quella parte di storia che noi non possiamo accettare, di far passare la trattativa e le stragi che ne sono conseguite come un bene. Non senza aggiungere come «non solo di trattativa, ma anche di concorso in strage si è macchiato lo Stato». Nel saggio i due docenti dell’Ateneo palermitano bocciano in generale il processo sulla trattativa – che vede coinvolti capimafia come Riina e Bagarella, pentiti come Brusca, ex carabinieri come i generali Mori e Subranni ed il colonnello De Donno, ex esponenti politici come Mannino e Dell’Utri, oltre al figlio di Don Vito, Massimo Ciancimino (c’è anche l’ex ministro Mancino, imputato di falsa testimonianza ai pm) –, considerandola come un errore giuridico. Un processo che non andava realizzato. Fiandaca accusa gli inquirenti palermitani di un «pregiudiziale atteggiamento criminalizzatore», motivato da «una sorta di avversione morale nei confronti di ogni ipotesi di calcolo costi/benefici» e verso «ipotesi trattattivistiche». E attacca un impianto accusatorio che, a suo dire, trasformerebbe «negoziatori istituzionali operanti a fin di bene in una banda di delinquenti in combutta con la mafia». Ma non solo. Fiandaca cerca anche di smontare l’impianto giudiziario sul quale si basa il processo, ribandendo come il reato di trattativa non esista. Una cosa chiara in realtà anche ai pm di Palermo, dato che l’accusa che pesa sulla maggior parte degli imputati è di «minaccia a corpo politico dello Stato (art. 338 Codice penale)», punito con la reclusione da uno a sette anni. Ma per Fiandaca il capo d’imputazione scelto – sbagliato secondo il giurista perché, essendo il governo un organo costituzionale, i pm di Palermo avrebbero dovuto scegliere l’art.289 – sarebbe soltanto un «espediente giuridico», con l’obiettivo di «colorare indirettamente di criminosità la stessa trattativa». Ma se un giudice terzo come il gup Piergiorgio Morosini ha deciso, su richiesta dei pm, di rinviare a giudizio gli indagati, significa che ha ritenuto gli elementi a carico degli imputati idonei a sostenere un’accusa in giudizio. Dovrà poi essere il processo stesso a cercare di dimostrare se la trattativa, certa e non presunta, implichi il reato di “violenza o minaccia a corpo dello Stato”, come ipotizzato dal pool di Palermo. Fiandaca e Lupo sostengono poi che la mancata proroga dei 334 decreti di «carcere duro», tra il ’93 e il ‘94 – che secondo i due docenti ha coinvolto soltanto detenuti «non di primaria grandezza» – , anche qualora fosse stata una concessione a Cosa nostra per evitare nuove stragi, andrebbe interpretata come un atto «di discrezionalità politica» dell’allora Guardasigilli Conso. «Insindacabile» dal punto di vista penale, in ogni caso: sia se la scelta fosse stata fatta in autonomia, come si è sempre difeso l’ex ministro della Giustizia, sia se seguito a determinati suggerimenti, come sostiene l’accusa. Secondo il professor Lupo, Conso aveva il diritto di poter concedere quelle «aperture», senza venire meno ai propri doveri: «Agì comunque nell’ambito delle sue competenze». Ma Conso è indagato per falsa testimonianza dai pm (il codice penale prevede che per questo tipo di reato la posizione resti sospesa, in attesa della definizione del procedimento principale, ndr), non certo per l’inesistente reato di trattativa o per le sue scelte politiche. Allo stesso modo è stato l’ex procuratore aggiunto e titolare dell’inchiesta, Antonio Ingroia, sul reato contestato, a precisare, intervistato da Antimafia 2000, come il processo preveda tra gli imputati sia i mafiosi che hanno minacciato lo Stato per ottenere dei benefici che i pezzi dello Stato che hanno favorito Cosa Nostra nel portare a destinazione la minaccia e a beneficiarne dei risultati. Con tanto di paragone: «Nessuno è imputato in questo processo per il solo fatto di avere trattato con la mafia. [..] C’è una giurisprudenza di Cassazione, ormai consolidata, che sancisce che alla pari dell’estortore nei confronti del commerciante risponde dello stesso reato il concorrente in estorsione e cioè colui che svolge il ruolo di intermediario tra l’estortore e l’estorto. Nella misura in cui l’intermediario aiuta l’estortore a portare a compimento l’estorsione nei confronti del commerciante. Il commerciante – che è la vittima dell’estorsione – ha l’obbligo di dire la verità, e se non dice la verità viene incriminato per falsa testimonianza. E’ esattamente quello che abbiamo applicato nel processo in questione. Anche in questo caso – con le dovute specifiche – abbiamo il mafioso “estortore” che ha messo in atto un’estorsione di tipo politico-criminale; l’imprenditore viene rappresentato dallo Stato e dal Governo, mentre gli intermediari sono quegli uomini politici e quelli degli apparati che hanno svolto un ruolo di intermediazione. Quindi gli intermediari, così come rispondono di concorso in estorsione, per principio di uguaglianza devono rispondere di concorso nel reato specifico di minaccia nei confronti dello Stato. Il destinatario finale della minaccia, rappresentante del Governo, ha l’obbligo di dire la verità, se non la dice viene imputato di falsa testimonianza come è il caso di Nicola Mancino e di Giovanni Conso. [..] Chi aiuta il minacciante risponde di concorso alle minacce. Di fatto, queste sono le imputazioni che riguardano i mafiosi del calibro di Riina, così come gli stessi Mori, De Donno, Subranni, Dell’Utri e Mannino». Ma non solo Lupo e Fiandaca considerano la trattativa come legittima. Secondo loro Cosa Nostra non avrebbe vinto e contestano i benefici che lo Stato «avrebbe effettivamente concesso a Cosa Nostra come risultato della presunta trattativa». Oltre alla questione della già citata mancata proroga sul 41bis da parte di Conso, per il giurista «non risultano altre forme di concessioni riconducibili a singoli ministri o al governo nel suo insieme». Tanto da azzardare: «La montagna avrebbe partorito un topolino?». Peccato che le “concessioni” negli anni invece ci siano state. Lo stesso regime carcerario 41 bis è stato di fatto svuotato negli anni. Ma non solo. Il papello di Riina è stato esaudito anche in altri punti. Come sulla chiusura delle super-carceri di Pianosa e Asinara. E sulla riforma della legge sui pentiti, quella del 2001 Fassino-Napolitano, che di fatto ha reso sconveniente per un mafioso collaborare con la giustizia (ai tempi dell’approvazione non mancarono le critiche. Lo stesso Pietro Grasso spiegò come la nuova normativa fosse disincentivante: «Con questa legge, se fossi un mafioso, non mi pentirei più», spiegò). Senza dimenticare i capitali mafiosi rientrati in modo “pulito” dall’estero grazie ai diversi scudi fiscali. Altro che «topolino». Se per Lupo, «la trattativa c’è stata, solo che purtroppo (per i boss, ndr) qualcuno si è rimangiato la parola», in realtà i fatti dimostrano ben altro. Senza dimenticare quegli altri tentativi non andati in porto, come per la revisione delle sentenze passate in giudicato, che avrebbe permesso di rimettere in discussione le sentenze del maxi-processo. Non certo comunque indizi di una vittoria dello Stato. Ne è convinto anche Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo fatto saltare in aria il 19 luglio 1992 nella strage di Via D’Amelio, insieme agli uomini della scorta (Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi). Secondo la ricostruzione della procura di Palermo, proprio perché aveva scoperto e si era opposto a quell’accordo maledetto tra i vertici mafiosi e quello Stato che aveva abdicato al suo ruolo, venendo a patti. Una versione però smontata dai giudici palermitani che hanno assolto in primo grado i militari dell’Arma Mario Mori e Mauro Obinu dall’accusa di favoreggiamento aggravato alla mafia, «perché il fatto non costituisce reato», sulla mancata cattura di Bernardo Provenzano nell’ottobre 1995 a Palermo. Per il Tribunale di Palermo «resta senza riscontro l’eventualità che Paolo Borsellino abbia in qualche modo manifestato la sua opposizione ad una trattativa in corso fra esponenti delle Istituzioni statali e associati a Cosa Nostra”. Mancano le prove, secondo i giudici. Una sentenza che rischia di mettere un’ipoteca pesante anche sullo stesso processo in corso sulla trattativa, considerato come Mori, secondo i pm, non avrebbe arrestato il boss per onorare il patto siglato nel ’92 tra pezzi dello Stato e la mafia. Nelle motivazioni i giudici di Palermo ammisero gravi errori investigativi, attendismo e aspetti opachi, ma non configurano patti. “Si deve rilevare che, benché non manchino aspetti che sono rimasti opachi, la compiuta disamina delle risultanze processuali non ha consentito di ritenere adeguatamente provato – aldilà di ogni ragionevole dubbio – che le scelte operative in questione, giuste o errate, siano state dettate dalla deliberata volontà degli imputati di salvaguardare la latitanza di Bernardo Provenzano o di ostacolarne la cattura. Ne consegue che i medesimi devono essere mandati assolti con la formula perché il fatto non costituisce reato, che sembra al Tribunale quella che più si adatti alla concreta fattispecie”, scrissero i giudici. Di Matteo, invece, annunciò di voler fare ricorso: «Sono un magistrato e quindi rispetto la sentenza anche se non la condivido in nessuno dei suoi punti», spiegò. Di recente c’è stato anche uno scontro tra i pm di Palermo e la Direzione nazionale antimafia: il pool siciliano ha interpretato come un “intervento a gamba tesa” le perplessità segnalate dal consigliere Maurizio De Lucia nell’ultima relazione annuale sull’impostazione del processo. Soltanto l’intervento del capo Franco Roberti («Nessun intento critico. La Dna, senza volersi ingerire nelle scelte processuali, ha inteso soltanto evidenziare la complessità del processo») ha evitato che le polemiche degenerassino. Secondo Salvatore Borsellino, contattato da Giornalettismo, diversi sono i tentativi per «fermare il processo» sulla trattativa in corso a Palermo e per delegittimarlo. Non solo gli interventi di alcuni intellettuali, compresi Salvatore Lupo e Giuseppe Fiandaca. Come dimenticare anche le critiche di Pino Arlacchi, sociologo ed europarlamentare (ex Idv, poi Pd) che ha bollato in un’intervista con Panorama come un’«allucinazione» senza «una sola prova seria» la trattativa Stato-mafia, prevedendo che il processo «si concluderà con il totale flop dell’inchiesta di Antonio Ingroia e soci». Lo stesso Arlacchi che poco tempo prima, come testimone nel 2009 di fronte ai pm di Caltanissetta, sposava le tesi della Procura di Palermo. Contro il saggio che giustifica la trattativa Salvatore Borsellino usa toni forti: «Certe tesi non ho nemmeno voglia di leggerle. In questo momento in Italia si vuole impedire in ogni modo che il processo vada avanti. C’è un’azione concentrica contro il pool di Palermo», ha spiegato, contestando le tesi portate avanti nel saggio. «La mafia non ha vinto? Questa tesi non ha alcun senso. Nel nostro paese continuiamo a pagare le cambiali di una trattativa che non è costata soltanto la vita a mio fratello, bensì anche ad altre vittime innocenti, come quelle morte in via Palestro e in via dei Georgofili. Stragi fatte per alzare il prezzo di quell’accordo e per concludere la trattativa (secondo i pm la trattativa nel ’94 fu conclusa «con le garanzie assicurate dal duo Dell’Utri-Berlusconi, come emerge dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Spatuzza, Brusca e Giuffrè», ndr)», ha spiegato Borsellino. Nonostante la denuncia per vilipendio nei confronti del capo dello Stato Giorgio Napolitano, fatta alcuni mesi fa nei suoi confronti da Vittorio Sgarbi, Borsellino ha rilanciato le critiche contro il presidente della Repubblica: «Il suo settennato è stato rinnovato proprio perché è il garante di quel silenzio sulla trattativa. Una congiura che dura da vent’anni. Oggi che c’è il rischio che certe cose vengano alla luce, si sta cercando di giustificare quel patto scellerato come se fosse stato necessario per una ragion di Stato», ha attaccato. Oppure, come hanno spiegato Fiandaca e Lupo nel loro saggio, secondo un presunto «stato di necessità», a “fin di bene”: «Ma affermare questa tesi è come uccidere di nuovo le vittime che la trattativa stessa ha prodotto. Un’offesa alla loro memoria», ha spiegato. Per Borsellino i «prodromi della giustificazione della trattativa» e della delegittimazione del processo si sono potuti già intravedere. Anche con la contestata sentenza sul processo Mori. « È stato deciso in primo grado che il fatto, la mancata cattura di un latitante, c’è stato, ma non costituisce reato. Una sentenza preparatoria. Sono sicuro che anche in futuro si dirà lo stesso per il processo sulla trattativa: c’è stata, ma non costituisce reato il fatto che pezzi dello Stato siano venuti a patti con Cosa Nostra, elevandola al rango di interlocutore, come fosse uno Stato parallelo». Secondo Borsellino i tentativi di attaccare il processo sono continui: «Ci stanno tentando delegittimando i testimoni, così come cercando di mettere sotto stress il principale attore di quel processo, Nino Di Matteo. A lui si concedono quei mezzi di protezione appariscenti, ma insufficienti per fermare gli attentati. Tant’è vero che con una scorta potenziata sono stati uccisi sia mio fratello che Giovanni Falcone. Al contrario, si continua a contestare il suo operato». Polemiche aveva suscitato anche l’istanza di rimessione presentate dai legali di Mori, Subranni e De Donno per chiedere il trasferimento del processo, insieme alla richiesta di sospendere il processo. Fondata, secondo la difesa dei tre imputati su una serie di elementi (dalle minacce di Totò Riina, agli anonimi giunti alle Procure di Palermo e Caltanissetta, all’incursione in casa del pm Roberto Tartaglia, tra i magistrati del pool palermitano, ma anche la creazione delle “Scorte civiche” in difesa simbolica dei magistrati) che a loro dire dimostrerebbe che lo svolgimento del dibattimento nel capoluogo siciliano creerebbe pericolo per l’incolumità pubblica, con il rischio di influenze anche sull’intero ambiente giudiziario di Palermo e sulla serenità dei giudici popolari. «Hanno cercato di strumentalizzare anche l’appoggio dell’opinione pubblica con le Scorte civiche ai pm per chiedere lo spostamento del dibattimento. Ma non si capisce che senso avrebbe questa istanza, dato che lo Stato non riesce ad assicurare la sicurezza di questi magistrati nemmeno fuori da Palermo. Tanto che a Di Matteo è stato impedito di andare a Torino, dove era stato invitato a una manifestazione, per ragioni di sicurezza, così come gli è stato sconsigliato di andare a Milano per seguire l’udienza, sempre per lo stesso motivo» (fu il procuratore Francesco Messineo a spiegare l’assenza, motivandola con la «necessità che i magistrati sottoposti a tutela non siano troppo abitudinari»: «Variare orari, itinerari ed evitare di ripetere comportamenti e appuntamenti fissati da tempo sono ragionevoli forme di protezione», disse. ndr). Borsellino ha continuato: «Allora dove si dovrebbe svolgere questo processo? Bisogna andare in Svizzera o in Finlandia per garantire la sicurezza?». Per il fratello del giudice Borsellino, si tratta di una serie di tasselli che conducono a un unico obiettivo, quello di voler «bloccare un processo scomodo». Altro che «stato di necessità» e tutela dei cittadini. Con la trattativa secondo Borsellino si voleva soltanto «difendere una casta in disfacimento, ma ancora abbastanza potente da pretendere da pezzi dello Stato che venisse intavolata e conclusa la trattativa. E di fronte a questo la mafia non avrebbe vinto? Di sicuro lo Stato ha perso, non c’è dubbio», ha continuato. «Una volta finita la prima trattativa, sono cambiati i referenti e c’è stato il secondo accordo, quello concluso nel ‘94. Stipulato attraverso nuovi garanti e intermediari, come Dell’Utri da una parte e dall’altra l’ala moderata della mafia, quella di Provenzano, più adatto a stabilire un nuovo patto con lo Stato». Nell’ultima udienza, dal carcere di Rebibbia a Roma, è stato il pentito Gaspare Spatuzza a deporre come teste, spiegando di aver già avvertito nel 1997, durante un colloquio investigativo con l’allora procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna e con Piero Grasso, di «fare attenzione a Milano 2». Da allora sono trascorsi 12 anni prima che l’ex killer di Cosa nostra e braccio destro del boss Giuseppe Graviano si decidesse a collaborare e parlare esplicitamente di Silvio Berlusconi. Ma l’argomento, secondo la sua versione, era ritenuto talmente pericoloso da averlo affrontato soltanto nel 2009, a un anno dalla formalizzazione del pentimento. Ben oltre i sei mesi che la legge – dopo la riforma Fassino-Napolitano – impone ai collaboratori come limite per raccontare tutto. Un punto, quello dei ricordi tardivi, sul quale ha puntato la difesa di Dell’Utri: «Dopo alcune settimane dalla mia decisione di collaborare con la giustizia, nel 2008, cadde il governo Prodi e subentrò in me un grosso timore. Mi trovai il Cavaliere presidente del Consiglio e Alfano come ministro della Giustizia e le mie preoccupazioni aumentarono ulteriormente», ha replicato Spatuzza. Non senza ricordare le confidenze ricevute da Graviano nel ’94, l’accenno a una trattativa in corso – «Abbiamo una cosa in piedi», gli avrebbe rivelato il boss – e la felicità del capomafia che gli svelò di tenere il Paese sotto scacco grazie al duo Berlusconi-Dell’Utri. Lo stesso Spatuzza ha ribadito come dietro la stagione stragista del ’92-’93 non ci fosse stata solo Cosa Nostra. Lui, che faceva parte del gruppo di Brancaccio, reperì il tritolo dagli ordigni bellici nei fondali marini. Ma ha spiegato come venisse utilizzato pure «un altro tipo di esplosivo, una specie di gelatina», del quale non conosceva l’origine. Resta il mistero su quelle entità esterne che avrebbero affiancato Cosa Nostra nelle stragi, quelle «menti raffinatissime» di cui parlava Falcone dopo il fallito attentato all’Addaura, rimaste a oltre vent’anni di distanza ancora nell’ombra. Un personaggio oggi defunto, il pentito ed ex membro di Cosa nostra Salvatore Cancemi, disse che Riina era stato “accompagnato per la manina” nell’organizzazione di quelle stragi. E nella sua deposizione Spatuzza ha anche parlato di quell’uomo esterno a Cosa Nostra, nel garage di via Villasevaglios, mentre la Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti veniva trasformata in autobomba: «Non era un ragazzo, né un vecchio. Non l’avevo mai visto prima, né lo vidi dopo quella volta. Non mi allarmò la sua presenza perché se era lì era perché Giuseppe Graviano lo voleva». Spatuzza ha spiegato di aver cercato negli anni di dare indicazioni su di lui, ma di avere ricordi sfocati. Quel coinvolgimento di altri settori – tra sospetti su servizi segreti deviati, massoneria e destra estrema – nella stagione stragista del ’92-’93 era stato oggetto dell’indagine sui “Sistemi criminali”, archiviata per la mancanza di sufficiente materiale probatorio da poter arrivare a processo. Eppure dalle indagini i pm erano portati a concludere come la mafia fosse un asse portante « di un autentico “sistema criminale” in cui venivano a convergere le altre più pericolose consorterie di stampo mafioso e non». Anche Borsellino ha aggiunto: «Io lo dico da anni che quella di via d’Amelio è stata una strage non solo di mafia, ma di Stato. Mi limito a parlare di mafia e Stato, ma sono convinto che ci sia molto di più. Sono convinto dell’esistenza di questi sistemi criminali, che magari sono indipendenti tra di loro, ma nei momenti cruciali collaborano per arrivare a obiettivi comuni», ha aggiunto. Dopo il messaggio di morte inviato da Riina dal carcere di Opera nei confronti di Nino Di Matteo, Borsellino ha aggiunto di avvertire «un attacco concentrico nei confronti della procura di Palermo» da chi tenta di difendere quel silenzio che dura da 20 anni. Eppure allo stesso tempo ha rivendicato un «largo appoggio della parte sana dell’opinione pubblica». Sulle intercettazioni di Riina, a colloquio con il boss della Sacra corona unita Alberto Lorusso, ha aggiunto: «Ho letto le interpretazioni di chi ritiene che siano minacce che arrivano da chi non ha ormai nessuna possibilità di metterle in pratica. Ma per me ha ancora un grosso potere sulla mafia. E le sue parole servono a lanciare un messaggio: “La mafia è ancora disponibile a fare un lavoro sporco, siamo ancora disponibili”. Può anche essere letta come una fatwa, lanciata da quello che è ancora una sorta di capo spirituale. Chi la raccoglie, potrebbe scalare le gerarchie mafiose e legittimarsi», ha continuato Borsellino. «Restano complicate» da interpretare, invece, secondo il fratello del giudice, le parole di Riina sulle modalità d’esecuzione sulla strage di via D’Amelio. Il “Capo dei Capi” è stato intercettato mentre spiegava che Borsellino “si futtiu sulu” (tradotto, “si è fregato da solo”), lasciando intendere che avrebbe direttamente innescato l’autobomba suonado il campanello di casa di sua madre. Restano dubbi sulla vicenda, considerato come finora era stato Giuseppe Graviano quello indicato di aver azionato il telecomando collegato all’autobomba, nascosto a poca distanza, in un giardino dietro ad un muretto che divide in due via D’Amelio (ricostruzione fatta anche dal pentito Fabio Tranchina, ndr). «Sembra un’opzione incredibile e improbabile, dato che quel palazzo era molto frequentato e in quel citofono c’erano almeno 50 pulsanti diversi. Anche se fosse stato collegato soltanto a quello della casa di mia madre e mia sorella, una qualunque persona avrebbe potuto far fallire l’obiettivo dell’attentato, per errore». Borsellino ha però spiegato di aver fatto delle ipotesi di natura tecnica: «Sarebbero serviti due dispositivi. Uno attivabile dall’esterno, posto nella macchina, che servisse a sua volta ad abilitare il primo dispositivo collegato al campanello. Un meccanismo che avrebbe permesso di assicurare che mio fratello si trovasse al punto giusto quando veniva azionato il timer. Ma di fatto un sistema complicato, che richiedeva competenze che la mafia difficilmente aveva. Potrebbe spiegare, però, la presenza di quel soggetto che Spatuzza non conosceva mentre la 126 veniva preparata complicato. Magari una persona dei servizi segreti». Resta da capire anche «il motivo sul perché Riina esca fuori soltanto adesso con queste dichiarazioni», ha concluso. Per Borsellino, infine, c’è ancora il rischio della «tentazione del botto»: «In quel sistema che ha attuato la strage di Via D’Amelio c’è chi può riprendere i metodi stragisti. Siamo in un momento molto pericoloso, simile a quello del ’92 e di altre epoche in cui per passare da un sistema di potere a un altro sono state realizzate stragi di Stato. Ma c’è anche un altro elemento: la necessità di fermare questo processo. L’extrema ratio potrebbe essere quello di realizzare un’altra strage». E il nuovo governo Renzi, sul piano della lotta alla mafia? Secondo Borsellino c’era stato «un segnale inaspettato» con la proposta di Nicola Gratteri alla Giustizia, poi bocciata: «Potrebbe essere stata soltanto una mossa ad effetto, considerato come era chiaro che la sua nomina non sarebbe stata accettata da Napolitano. Per ora ci sono segnali contrastanti, ma si resta soltanto sul campo delle parole. Ma non si può ancora dare un giudizio». E con uno sguardo al recente passato, ha bocciato il modo in cui si è sviluppata la candidatura di Antonio Ingroia, che gli elettori non hanno premiato: «Il progetto di entrare nelle stanze della politica era corretto. La magistratura aveva fatto il massimo che poteva ottenere e per cercare la verità era necessario un salto di livello. Purtroppo il modo in cui il progetto è stato condotto non è stato consono alla bontà originaria. La sua figura di magistrato non può essere di certo annebbiata, ma sul piano politico il giudizio non può essere altrettanto positivo».
Lo Stato italiano non solo con la mafia si caga sotto. Lo fa anche con il terrorismo internazionale.
"Che illusi Usa e Europa. Questo è il vero Islam". Il politologo americano Luttwak: "Si sforzano di credere a predicatori in giacca e cravatta. Ma in quel mondo comanda chi uccide. Intervista resa a Gian Micalessin su “Il Giornale”. «Foley? Se penso che abbiamo rischiato la vita dei nostri soldati per tentare di salvarlo mi arrabbio. Quello prima è andato a giocare al corrispondente di guerra in Libia e si è fatto catturare. Poi è andato a cercar guai in Siria». Non appena nomini il reporter decapitato dai tagliagole dell'Isis il professor Edward Luttwak reagisce con una sparata al vetriolo. «È come la vostra Sgrena - sbotta Luttwak in questa intervista al Giornale - si autodefiniscono reporter di guerra e poi si cacciano nei guai. Risultato? Voi europei pagate enormi riscatti per liberarli e noi americani rischiamo la vita dei soldati per riportarli a casa».
Dicevate che «nessuno va lasciato indietro»...
«Nessuno che vesta la divisa e vada in missione per il governo».
Insomma per lei se l'è cercata?
«Totalmente..... Il suo, come quello della vostra Sgrena, non è giornalismo, ma protagonismo. Lui, la Sgrena e tanti altri non raccontano quel che succede, aiutano una parte in gioco. Nel suo caso il cosiddetto popolo siriano. Nel caso della Sgrena quelli che combattevano contro l'Italia. Che poi ha pagato per riaverla viva. Questo oltre ad esser pericoloso per chi lo pratica, genera disinformazione. Identificandosi con chi, a detta loro, soffre producono racconti emotivi destinati non ad informare, ma a coinvolgere il pubblico.
Dopo la decapitazione di Foley, Obama e i governi europei hanno compreso la pericolosità dello Stato Islamico...
«Non è proprio così. Quel video è un pretesto. Arriva e fingono di reagire al video, non ad una realtà che conoscono bene, ma su cui preferiscono tacere. Gli islamici combattono dalle Filippine alla Thailandia, dall'India al Pakistan, dall'Afghanistan a Gaza, dall'Iraq alla Nigeria e al Mali Eppure Obama e i capi di governo europei ripetono che l'Islam è una religione di pace».
Cosa devono fare, bandire l'Islam?
«Obama, Cameron e gli altri si sforzano di credere ad un paio di predicatori in giacca e cravatta, sempre pronti a sostenere il dialogo interreligioso e a stringere le mani di preti e rabbini. Ma nel mondo islamico dettano legge i combattenti. Sennò perché i giovani abbandonerebbero l'Europa per combattere con lo stato islamico? L'Islam dei predicatori gentili e carini è una montatura. I vostri governi sono come Alice nel paese delle meraviglie. S'illudono che ripetendo una bugia tre volte al giorno diventi realtà».
Ma il video li ha riportati alla realtà...
«L'Isis ha dissacrato centinaia di chiese e massacrato gli yazidi, ma nessuno ha mosso un dito. Poi è arrivato il video e tutti a stupirsi».
Dunque bisogna tornare in Iraq?
«Fare la guerra serve solo se la puoi vincere. In Germania nel 1945 valeva la pena. Lì se uno inneggiava al nazismo gli sparavi in testa. In Iraq non puoi farlo perché da Birmingham all'Indonesia devi fare i conti con migliaia di imam pronti a proclamare la guerra santa appena tocchi un musulmano. In Italia avete perfino dei professori pronti a difendere i terroristi di Hamas. A Napoli avete un sindaco totalmente incapace di risolvere i problemi della città, ma pronto a mobilitarsi per Gaza. Dove sono quando uccidono i cristiani di Mosul o stuprano le loro donne?».
Senta...
«Non cambi discorso! Risponda lei per una volta. Quante dimostrazioni avete avuto in Italia per i cristiani di Mosul?
Direi nessuna...
«Esattamente. Questa è la dimostrazione. La grande bugia dell'Islam religione di pace domina la scena. Per questo devi attendere un video per poter condannare il nuovo califfato. Eppure tutto quel che fa il Califfato è dal punto di vista islamico perfettamente legale. Uccidere gli infedeli è assolutamente legittimo. E il profeta Maometto è stato il primo a farlo».
Il Papa ha detto...
«Il Papa fatto due dichiarazioni di 18 parole in tutto... Per reagire all'Islam reale, non a quello dei salotti europei, bisogna guardare in faccia la realtà altrimenti è inutile».
Intanto però finanziatori dell'Isis stanno in Arabia Saudita, Qatar e Kuwait .... Sono vostri alleati.
«I sauditi hanno smesso di sostenere gli assassini islamici. I soldi arrivano da privati ed escono in nero. Sul Qatar ha ragione. Va eliminato dalla scena è un regno perverso».
L'Isis aveva le sue retrovie in Turchia un paese Nato...
«La Turchia di oggi è quella di un Erdogan beccato a rubare, ma eletto presidente grazie a degli sproloqui islamisti. L'Islam si è ripreso il paese e lo ha riportato alla sua veste originale».
Renzi promette armi ai curdi. Servirà?
«Grazie ai curdi frazioneremo la Turchia».
L'Italia si è accollata centomila profughi africani e islamici. Come la vede?
«Da noi chi entra dal Messico si chiama Jose Martinez è cristiano e sogna di diventare Joe Martin, americano. Da voi arriva Ahmed che vuole tenere la moglie coperta e i bimbi ignoranti. Il lassismo sentimentale di voi italiani è incredibile. Mi meraviglio che non vi buttino fuori da Schengen per mancata protezione delle vostre frontiere».
Pagine di storia/Cinquant’anni fa nasceva l’Olp: una storia di sangue che (forse) volge al termine, scrive Antonio Pannullo su “Il Secolo d’Italia”. Questione palestinese. Quante volte abbiamo ascoltato o letto questa espressione, e l’impressione è che ne sentiremo parlare ancora per parecchio. Gli archivi dei giornali sono pieni di foto di esponenti palestinesi (quasi sempre il leader storico Yasser Arafat) con i vari presidenti americani che si sono succeduti, e che sempre volenterosamente hanno mediato tra le parti, arabi e israeliani, affinché si ponesse fine una volta per tutte a quello che è il più lungo conflitto del dopoguerra. E che iniziò proprio nel dopoguerra, con l’arrivo degli ebrei fuggiti dall’Europa in Medio Oriente, ossia nella “terra promessa”. Nel 1948, su mandato britannico, dettero vita allo Stato di Israele, come è raccontato nel miglior film sulla vicenda, Exodus, di Otto Preminger, del 1960. I palestinesi furono per così dire confinati nella costa occidentale e nella striscia di Gaza. In pratica, si sentirono defraudati di un territorio che consideravano loro. Inoltre molti ebrei arrivarono in Israele stanziandovisi per sempre e spesso occupando anche zone esorbitanti lo Stato di Israele stesso. Perché ricordare queste cose arcinote? Perché esattamente mezzo secolo fa, il 28 maggio del 1964, nasceva l’Olp, acronimo di Organizzazione per la Liberazione della Palestina, su iniziativa della Lega Araba. Nacque proprio a Gerusalemme dopo una riunione di 422 personalità palestinesi con l’obiettivo di liberare la Palestrina con la lotta armata, ovviamente contro Israele, come recita ancora oggi lo statuto dell’Olp. E purtroppo quanto annunciato è accaduto alla lettera: sono moltissimi gli attentati dei terroristi palestinesi, non necessariamente affiliati all’Olp, che hanno causato moltissime vittime: il più celebre di tutti è senza dubbio quello alle Olimpiadi di Monaco, nel 1972, da parte dei palestinesi di Settembre Nero, rievocato in articoli, libri, film. Altrettanto sangue è scorso nelle reazioni di Israele, non disposto a subire attentati terroristici contro i suoi abitanti. A lungo il mondo ha considerato l’Olp un’organizzazione terrorista, poiché la geografia dei gruppi e gruppuscoli dissidenti o scissionisti non è mai stata chiara, anche perché è estremamente complessa e in continua evoluzione. La questione palestinese però ha attirato l’attenzione dell’intero pianeta per anni, e i masse media internazionali se ne sono occupati – e se ne occupano – continuativamente. Senza prendere parte per uno dei due contendenti, però si può affermare che l’Olp in questo ha assolto la sua funzione: ossia quella di porre all’attenzione degli Stati, più spesso in maniera violenta, il problema enorme che da anno affligge tutto il Medio Oriente. Nel 1974 Yasser Arafat, arrivato al vertice cinque anni prima, ha chiesto ufficialmente uno Stato della Palestina indipendente, nel 1988 ha adottato la soluzione “due Stati”, Palestina e Israele, con Gerusalemme est capitale, e finalmente nel 1993 il presidente dell’OLP Arafat ha riconosciuto lo Stato di Israele in una lettera all’allora premier Rabin. Ma non ha eliminato – tuttora – dal suo statuto fondativo l’articolo che ne auspica l’eliminazione. Subito dopo Israele riconobbe l’Olp, più che altro per aver un interlocutore. In seguito ai cosiddetti accordi di Oslo, l’Olp non fu più definita un’organizzazione terrorista. Arafat morì nel 2004 e al suo posto venne eletto Abu Mazen, considerato un moderato, che ancora guida la causa palestinese. Dopo la Guerra dei Sei Giorni, nel 1967, i palestinesi ritennero che la guerriglia contro Israele fosse l’unica strada percorribile e l’Olp fu da allora controllato dagli ormai famosissimi feddayyin (i devoti). Da allora la vicenda dell’Olp è storia, tra Libano, Egitto, Giordania, Tunisia, Intifade, storia piena di attentati, omicidi politici, scontri intestini sanguinosi, guerriglia continua con Israele. Nel 1993 la direzione dell’Olp si trasferì da Tunisi a Ramallah, dove ancora si trova. I gruppi e sottogruppi palestinesi hanno compiuto attentati soprattutto fuori dal Medio Oriente, e sempre contro obiettivi ebraici: in Italia a Fiumicino, nel 1973 e nel 1985, alla Sinagoga di Roma nel 1982 e alla nave Achille Lauro ancora nel 1985. Molti inoltre hanno sostenuto che gruppi dissidenti palestinesi sarebbero anche coinvolti con la strage di Bologna del 1980, ma nessuna indagine fu mai seriamente indirizzata in questo senso. Oggi le cose sono molto cambiate per i palestinesi, lo Stato è riconosciuto da moltissimi Paesi, la Palestina ha rappresentanze diplomatiche all’estero, Italia compresa, l’Olp è osservatore all’Onu da anni. Ma i gruppi islamisti continuano ad agire contro Israele e all’estero contro ad esempio il governo siriano o anche in Iraq e Afghanistan. Questa è la sfida che i governi occidentali devono raccogliere e vincere. Altrimenti la questione palestinese terrà ancora banco per i prossimi decenni….
“Dovevamo liberare l’Achille Lauro, ma così ci fermarono”. Il ricordo degli incursori del “team Torre”, il gruppo operativo specializzato nell’antiterrorismo dei «baschi verdi» del Comsubin, scrive Fabio Pozzo su “La Stampa”. Quella «sporca dozzina». Anzi, qualcuno di più. Erano alcune decine gli incursori italiani che nell’ottobre 1985 avrebbero dovuto liberare l’Achille Lauro dai terroristi di Abu Abbas. E tra questi, i migliori del «team Torre», il gruppo operativo specializzato nell’antiterrorismo dei «baschi verdi» del Comsubin. I dettagli dell’operazione non sono mai stati divulgati. Anche perché gli incursori furono bloccati in extremis da un ordine del governo Craxi, mentre erano in volo, pochi istanti prima dell’azione. Prevalse la soluzione politica a quella militare. Quella che poi portò al caso Sigonella e alla fuga di Abu Abbas, il leader del Fronte per la liberazione della Palestina. Il comandante Danilo Gattoni, oggi in congedo, faceva parte di quella «sporca dozzina». Lo avevo incontrato a Le Grazie, davanti al Varignano, la base degli incursori che domina il golfo della Spezia. «La sera del 7 ottobre ero a casa. Avevo tenuto spento il televisore e non sapevo del dirottamento. L’indomani, appena varcato il cancello del Varignano, il capoguardia mi dice soltanto: “Il team è già partito”. Dopo due ore mi convoca il comandante della base. “Entro le 11,30 devi essere pronto con le attrezzature specialistiche”. Sapevo che cosa significava: si riferiva ai ferri del mestiere, alle dotazioni per il combattimento. A mezzogiorno parto per Pisa, con altri quattro colleghi, due specialisti in lanci col paracadute come me e altrettanti esperti in cariche esplosive». Il 7 ottobre era stata una giornata campale nelle acque egiziane, tra Alessandria e Porto Said. Alle 13.15 quattro terroristi palestinesi avevano dato inizio al dirottamento della nave passeggeri (a notizia era stata comunicata via radio alle 14). Alle 22 il ministro degli Esteri Giulio Andreotti aveva contattato l’Olp e il governo del Cairo. Alle 23, il premier Bettino Craxi aveva convocato quest’ultimo e il ministro della Difesa Spadolini a Palazzo Chigi. E da qui era partita l’allerta per i reparti speciali. «A Pisa ci imbarcano insieme ad un gruppo di parà del “Col Moschin” sull’aereo presidenziale. Io prendo posto dove sedeva Pertini durante la famosa partita a scopone con Bearzot, al ritorno dei Mundial. Facciamo rotta su Gioia del Colle. Atterriamo e ripartiamo per Akrotiri, Cipro». Nel frattempo, l’Achille Lauro era stata rifiutata dalla Siria e i terroristi avevano ucciso il passeggero americano Leon Klinghoffer. «Arriviamo a Cipro poco prima dell’alba del 9 ottobre - continua Gattoni -. Lì, c’erano già i Delta Force. Gli americani erano agitati, impegnati in una attività febbrile: scaricavano materiali, approntavano piccolo elicotteri. Si capiva che volevano intervenire». Era stato l’ambasciatore degli Usa a Roma, Maxwell Rabb, a informare Craxi che il Pentagono aveva approntato un piano d’intervento per la notte tra il 9 e il 10 ottobre. Si preparano anche i nostri incursori. Arrivano le informazioni sulla nave, gli schemi dei ponti, dei locali interni. E l’ordine di congiungersi con un altro gruppo di «baschi verdi», in navigazione nelle acque egiziane a bordo dell’incrociatore «Vittorio Veneto». «Ci vengono a prendere con un elicottero. Dobbiamo raggiungere l’incrociatore e da qui entrare in azione. Spettava a noi farlo, e non agli americani, perché l’Achille Lauro era territorio italiano». Gattoni e gli altri specialisti si sarebbero dovuti lanciare durante la notte dall’elicottero, in alta quota, 5-10 mila piedi, e atterrare su uno dei ponti superiori dell’Achille Lauro. «Noi avremmo dovuto proteggere l’arrivo dal mare degli altri colleghi, che avrebbero raggiunto la nave dal mare con gommoni veloci e mezzi subacquei. Insieme, poi, ci saremmo dovuti occupare della “bonifica”». Gli incursori sapevano di dover mettere in conto anche delle vittime. «Se i terroristi avessero sparato, avremmo risposto». Ma il rischio non si porrà. «Mentre stiamo atterrando sull’incrociatore il pilota ci informa che la missione è annullata. “I terroristi si sono arresi, cessata crisi“, ci dice». I dirottatori lasciano l’Achille Lauro, s’imbarcano sul Boeing 737 dell’Egypt Air che sarà poi intercettato dai quattro caccia americani decollati dalla portaerei «Saratoga». Reagan ottiene da Craxi il permesso di farli atterrare a Sigonella. Comincia il braccio di ferro tra Italia e Usa, che proseguirà poi tra Ciampino e Fiumicino. «Mentre stiamo tornando in elicottero verso l’Italia, arriva l’ordine di fare rotta su Sigonella. E poi, ancora, ci bloccano sopra Ciampino». Ma Craxi la spunta con Reagan. E per Gattoni e gli altri incursori la crisi cessa davvero.
Lodo Moro. Quei patti inconfessabili tra Sismi e terrorismo palestinese, scrive Gea Ceccarelli su “Articolo 3”. Con l'imperversare della crisi di Gaza, tutti hanno imparato a conoscere Hamas. Chiunque, adesso, sa che si tratta di un'organizzazione paramilitare e terrorista, contro cui si è scatenata la furia di Israele con quello che ne è conseguito: un vero e proprio genocidio di innocenti, arabi colpevoli semplicemente di essere non ebrei. Quello che in pochi sanno è come, Hamas, abbia una storia lunga e travagliata: come la stessa sia stata probabilmente vista di buon occhio per lungo tempo, dagli israeliani, a causa della sua rivalità con un'altra organizzazione palestinese, l'Olp, fondato, tra gli altri, da Yasser Arafat. Nell'aprile scorso, Hamas e l'Olp hanno firmato un accordo, un'alleanza. Un patto che ha istantaneamente fatto allertare Israele, la quale, da parte sua, ha tuonato chiaramente come esso avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile per la pace tra i due paesi. Pochi mesi dopo, il rapimento di tre ragazzi ebrei s'è configurato come la scintilla in grado di scatenare l'inferno, con Netanyahu che giurava vendetta, pur sapendo, come è stato confermato da alcuni funzionari di polizia, che la responsabilità non era stata di Hamas. Ogni scusa, però, era valida per intervenire. Così, riconoscendo in Hamas il nemico supremo, si dimentica l'Olp. La cui storia sta per tornare a galla, fra pochi giorni, in Italia. Il motivo è semplice: fu proprio questa organizzazione a scendere a patti con il Sismi italiano, nell'ambito del cosiddetto "lodo Moro", i cui dossier relativi stanno per diventare pubblici. Erano gli anni '70-'80. Anni di stragi, nel nostro Paese. Anni di ombre incombenti e alleanze inconfessabili. Una di queste sarebbe proprio quella intercorsa tra la nostra intelligence e i terroristi palestinesi: un patto, firmato dall'allora Presidente del Consiglio Aldo Moro, che garantiva agli islamici la possibilità di far passare fiumi d'armi nel nostro paese, destinati a cellule terroriste sparse in tutto il continente, e la liberazione dei prigionieri palestinesi. In cambio, i militanti non avrebbero colpito gli italiani, avrebbero lasciato il nostro Paese tranquillo, pur non inserendo negli accordi l'incolumità per gli ebrei residenti nel Belpaese. Tanto più che, nell'82, venne attaccata la Sinagoga di Roma. Fu quella, forse, a squarciare il velo di misteri che avvolgeva gli accordi. Il 3 ottobre del 2008, in occasione del 30esimo anniversario dell'attentato, l'ambiguo ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, rivelò chiaramente l'esistenza del lodo in un'intervista rilasciata al quotidiano israeliano Yediot Aharonot. “Vi abbiamo venduti”, dichiarava in essa Cossiga. “Lo chiamavano ‘Accordo Moro’ e la formula era semplice: l’Italia non si intromette negli affari dei palestinesi, che in cambio non toccano obiettivi italiani”. “Per evitare problemi, l’Italia assumeva una linea di condotta tale da non essere disturbata o infastidita”, continuava l'uomo nell’intervista “Poiché gli arabi erano in grado di disturbare l’Italia più degli americani, l’Italia si arrese ai primi." Ma non solo: Cossiga rivelava anche l'esistenza di simili accordi con l'Hezbollah libanese, "per cui le forze UNIFIL chiudono un occhio sul processo di riarmo, purché non siano compiuti attentati contro gli uomini del suo contingente”. Nonostante secondo Giovanni Pellegrino, ex presidente della Commissione Stragi il patto risalga all'autunno del 1973, Cossiga dichiarava di esserne a conoscenza soltanto dal 1976, da quando, cioè, divenne ministro dell'Interno. "Mi fecero sapere che gli uomini dell’OLP tenevano armi nei propri appartamenti ed erano protetti da immunità diplomatica", raccontava nell'intervista. "Mi dissero di non preoccuparmi, ma io riuscii a convincerli a rinunciare all’artiglieria pesante ed accontentarsi di armi leggere”. Anni dopo, quando divenne Presidente del Consiglio, ebbe la certezza dell'esistenza di tali accordi: “Durante il mio mandato, una pattuglia della polizia aveva fermato un camion nei pressi di Orte per un consueto controllo”, raccontava. “I poliziotti rimasero sbigottiti nel trovare un missile terra-aria, che aveva raggiunto il territorio italiano via mare”. In pochi giorni, una sua fonte del Sismi gli fece sapere dell'esistenza di un telegramma, arrivato da Beirut, nel quale era "scritto che secondo l’accordo, il missile non era destinato ad un attentato in Italia, e a me fu chiesto di restituirlo e liberare gli arrestati”. “Col tempo", aggiungeva ancora Cossiga nell'intervista, "cominciai a chiedermi che cosa potesse essere questo accordo di cui si parlava nel telegramma. Tutti i miei tentativi di indagare presso i Servizi e presso diplomatici si sono sempre imbattuti in un silenzio tuonante. Fatto sta che Aldo Moro era un mito nell’ambito dei Servizi Segreti”. Secondo Pellegrino, il patto fu stilato dal Sismi, e solo firmato da Moro, che pure ne faceva riferimento in alcune missive inviate durante la seconda metà degli anni Settanta. Numerose le testimonianze che confermano tale versione. Come quella, rilasciata al Corriere della Sera, di Bassam Abu Sharif, portavoce del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, "costola" dell'Olp, da cui successivamente si separò. "Ho seguito personalmente le trattative per l'accordo", ricorda Abu Sharif. "Aldo Moro era un grande uomo, un vero patriota. Voleva risparmiare all'Italia qualche mal di testa", ma "non l'ho mai incontrato. Abbiamo discusso i dettagli con un ammiraglio, gente dei servizi segreti, e con Stefano Giovannone (capocentro del Sid e poi del Sismi a Beirut, ndr). Incontri a Roma e in Libano. L'intesa venne definita e da allora l'abbiamo sempre rispettata". Grazie a questa, prosegue, "ci veniva concesso di organizzare piccoli transiti, passaggi, operazioni puramente palestinesi, senza coinvolgere italiani. Dovevamo informare le persone opportune: stiamo trasportando A, B, C… Dopo il patto, ogni volta che venivo a Roma, due auto di scorta mi aspettavano per proteggermi. Da parte nostra, garantivamo anche di evitare imbarazzi al vostro Paese, attacchi che partissero direttamente dal suolo italiano". C'è però altro: quando, il 2 agosto del 1982, Bologna fu sconvolta dalla strage alla stazione, Cossiga puntò dapprima il dito contro i neofascisti e, successivamente, contro i palestinesi. Secondo lui,a compiere l'incredibile attentato erano stati proprio i terroristi arabi, dopo che il "patto" era stato tradito. Un'ipotesi venuta a crollare nelle settimane scorse, quando quando i pm di Bologna hanno depositato la richiesta di archiviazione per le posizioni di Thomas Kram e Margot Christa Frohlich, due terroristi tedeschi indagati e legati ai palestinesi. Secondo i magistrati, la presenza dell'esperto di esplosivi Kram a Bologna la notte prima dell'attentato è accertata, ma “quel solo e sorprendente fatto non è tuttavia sufficiente per ipotizzare in assenza di altri elementi” sul suo conto “una partecipazione alla strage della stazione”. Per i pm, poi, è tutta la teoria a non reggere, in quanto, secondo tale ipotesi, il legame tra terrorismo palestinese e Kram avrebbe dovuto essere il terrorista venezuelano "Carlos". Rapporto non solo indimostrabile, ma pure confutato dal diretto interessato. Fu lui, Carlos, a sottolineare infatti come, non solo ai tempi della strage avesse già rotto da anni i ponti con il Fplp, ma che inoltre non vi sarebbero stati motivi, per gli arabi, di colpire degli innocenti italiani: avrebbero solo rischiato di danneggiare i rapporti tradizionalmente buoni tra la Palestina e il nostro paese. Secondo lui, dunque, a Bologna a colpire furono piuttosto piuttosto la Cia e il Mossad, così da punire l'Italia e distoglierla dai propri interessi “antiatlantici” e “filoarabi”. Ipotesi, questa, supportata da Abu Sharif: "Non c'entriamo niente", ha infatti spiegato. "Nessuno ordine è venuto da me. Il massacro non ha niente a che vedere con organizzazioni palestinesi. Neppure un incidente. Non c'era nessuna ragione per farlo, soprattutto a Bologna". L'unica possibilità è che "la Cia o il Mossad abbiano usato un palestinese, un loro agente. E' stato fatto esplodere, senza che lo sapesse, per accusare noi." D'altronde, sottolinea, "Gli americani non erano affatto felici della nostra cooperazione con l'Italia. Soprattutto perché passavamo agli italiani informazioni top secret su quello che gli americani stavano facendo nel vostro Paese". Ma l'Olp e il Flpl avevano contatti anche con le Br: "Solo cooperazione", chiarisce l'ex portavoce. "Qualcuno di loro faceva parte dell'" Alleanza" che venne stabilita nel 1972, assieme a organizzazioni di tutto il mondo." "Erano", spiega, "le "operazioni speciali" guidate da Wadie Haddad. Questi gruppi stranieri non sono mai stati ai nostri ordini, c'era solo coordinamento". Per questo, quando, nel '78 venne rapito il segretario della Dc, i palestinesi avrebbero potuto intervenire. Ma, prosegue Abu Sharif, "ho chiamato un numero, ho lasciato un messaggio dopo l'altro. Nessuna risposta. Davvero strano: una linea speciale e nessuno risponde". Certo è che, del lodo Moro, l'opinione pubblica seppe in seguito, e sempre a spezzoni. Dopo la sparizione dei due giornalisti De Palo e Toni, che indagavano sul traffico d'armi, si alzò subito un impenetrabile muro di silenzi e depistaggi atto a oscurare l'esistenza stessa degli accordi che, nell'ambito delle indagini sulla loro scomparsa, sarebbero inevitabilmente emersi. Nell'84, poi, l'ufficiale del Sismi Giovannone invocò il segreto di Stato su tali patti, ottenendolo grazie a Bettino Craxi. Un sigillo poi ribadito da Silvio Berlusconi per due volte tra il 2009 e il 2010. Il 28 agosto prossimo, però, scadono i trent’anni previsti dalla recente riforma sui servizi come limite massimo per il segreto di Stato. Non c'è più niente che possa esser nascosto ancora. Circa un'ottantina di faldoni verranno alla luce e riconsegnati agli inquirenti. In essi, si potrà trovare la verità su numerosi misteri italiani e non solo: stragi e rapimenti, accordi inconfessabili. Potrebbe, altresì, esser compresa una volta per tutte l'attuale situazione di equilibri tra le potenze in gioco a Gaza, dove "buoni" e "cattivi" non esistono, e dove l'Italia ha una sua, enorme, colpa.
Si apre una breccia nel muro di gomma. I rapporti inconfessabili tra palestinesi e Sismi. Occhi chiusi sul fiume di armi destinate alle cellule dell'Olp. In cambio niente attentati. E' il patto tra servizi segreti, Dc e Yasser Arafat. Un quadro già emerso in un processo menomato dai veti politici. Fino a ora: i documenti decisivi stanno per essere desecretati, scrive Andrea Palladino su “L’Espresso”. Una doppia politica. Un lodo - firmato da Aldo Moro - che garantiva tutti. Niente attentati, ma occhi chiusi sul fiume di armi da far passare nel nostro paese, destinate alle cellule internazionali palestinesi sparse in tutta Europa. Accordi per tre decenni coperti dal segreto di Stato, l’omissis tutto politico. Un sigillo che neanche la magistratura può violare. Ancora per poco. Perché i dossier sui rapporti tra la nostra intelligence e l’Olp di Yasser Arafat che hanno marcato la politica estera italiana tra gli anni ’70 e ’80 stanno per diventare pubblici. Ed è la prima volta nella storia repubblicana. Scade il 28 agosto il termine ultimo del segreto invocato nel 1984 dall’ufficiale del Sismi Stefano Giovannone - confermato da Bettino Craxi il 5 settembre dello stesso anno e ribadito da Silvio Berlusconi per due volte tra il 2009 e il 2010 - di fronte alla domanda del pm romano Giancarlo Armati, che indagava sulla scomparsa in Libano dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni. Che rapporti avevate con i palestinesi? Era questa la questione chiave per capire non solo che fine avessero fatto i due reporter arrivati a Beirut nell’agosto del 1980, ma soprattutto i motivi del sistematico depistaggio attuato dall’intelligence italiana per coprire gli autori del rapimento e della successiva esecuzione. Ovvero la fazione più dura dei palestinesi, quella di George Habbash, detto al-akīm, il dottore. Per le famiglie dei due giornalisti, che hanno lanciato una petizione per togliere il segreto di Stato e pubblicare on line tutti i documenti disponibili , i prossimi giorni saranno cruciali. Potrebbero essere il punto finale di una battaglia che dura da 34 anni. La verità sostanziale è nota e certificata dalla carte processuali, che hanno portato alla condanna di un brigadiere dei carabinieri addetto all’ufficio cifra dell’ambasciata italiana a Beirut (gli altri indagati, Giovannone e Santovito, alti ufficiali dei servizi, nel frattempo sono deceduti). Graziella De Palo, giovane freelance - collaboratrice di Paese Sera e dell’Astrolabio - e Italo De Toni, giornalista di esperienza di Diari con la passione sfrenata per il jazz, erano partiti per Beirut con idee precise. La capitale libanese godeva in quegli anni della fama di città più pericolosa del Medio Oriente, forse del mondo. Crocevia di spie, terroristi di ogni matrice, trafficanti di armi e di droga, faccendieri arrivati da ogni dove, gente pronta a sfruttare le opportunità di una guerra civile infinita, in una città divisa in due, tra i cristiani maroniti del partito falangista di Bashir Gemayel e le fazioni filo palestinesi. Toni e De Palo avevano contatti buoni, presi in Italia prima della partenza, direttamente con l’Olp di Arafat. Cosa cercavano? Tante le ipotesi. Di certo non si accontentavano del semplice racconto di una città in guerra. Graziella De Palo seguiva ormai da mesi il filo del traffico di armi. La sua agenda e i suoi quaderni erano pieni di annotazioni precise, nomi di società legate alla nostra difesa. Partono tre settimane esatte dopo l’attentato alla stazione di Bologna, quando in Italia si viveva la stagione delle bombe e dei misteri di Stato. Un anno prima a Ortona i carabinieri avevano fermato un gruppo di terroristi, una cellula composta dall’esponente dell’Autonomia Daniele Pifano, dal militante del Fplp di George Habbash (Fronte popolare per la liberazione della Palestina) Saleh Abu Anzeh, da Giuseppe Nieri e Giorgio Baumgartner, con un lanciamissili. Solo più tardi si scoprirà che quell’arma micidiale apparteneva all’Olp, e che l’Italia era solo un punto di transito, come spiegarono gli stessi palestinesi del Fplp in una lettera inviata al Tribunale di Chieti, competente per il caso. La prova dei rapporti inconfessabili tra l’intelligence militare italiana e l’organizzazione palestinese è arrivata - per il pm Armati che indagò sul caso - dal muro di silenzi e depistaggi alzato immediatamente dopo la scomparsa di De Palo e Toni. Scrive il magistrato nella sua richiesta di rinvio a giudizio per George Habbash, Stefano Giovannone (ufficiale del Sismi a capo degli uffici di Beirut) e Damiano Balestra (brigadiere dei carabinieri addetto all’ufficio cifra dell’ambasciata italiana in Libano): “L’istruttoria finora compiuta avrebbe certamente consentito di fare piena luce sulla complessa vicenda della scomparsa all’estero dei due giornalisti”. Ma troppi sono stati gli ostacoli che hanno bloccato la procura di Roma: “In primo luogo l’atteggiamento completamente negativo delle autorità libanesi; in secondo luogo le difficoltà frapposte dalle autorità elvetiche (coinvolte per il caso del depistaggio sulla strage di Bologna attuata da Elio Ciolini, ndr); in terzo luogo la conferma da parte dell’autorità di governo del segreto di Stato opposto dal Giovannone, (…) che ha avuto l’effetto non voluto di coprire anche le ragioni della condotta dell’ufficiale del Sismi nei confronti dell’Olp”. Per il pm Armati la condotta dei nostri servizi nella vicenda “presenta aspetti oscuri certamente estranei ai suoi fini istituzionali”. Con un coinvolgimento - ipotizzato dalla procura - dello stesso direttore del servizio, il generale Giuseppe Santovito. Il primo novembre del 1980 - due mesi dopo la scomparsa dei giornalisti - il capo del Sismi incontrò Arafat. Il leader dell'Olp chiese alla nostra intelligence di “stendere un velo pietoso sulla vicenda”. Circostanza che lo stesso Santovito ammise davanti al pm Armati. Da quel momento - si legge nelle carte del processo - l’ambasciatore italiano D’Andrea, intenzionato a chiarire quello che era accaduto, si trovò davanti il classico muro di gomma, metafora che il nostro paese stava imparando a conoscere molto bene. Gli ufficiali del Sismi iniziarono a monitorare le indagini condotte dall’ambasciata, convincendo il brigadiere Balestra - poi condannato in via definitiva - a passare all’intelligence i messaggi scambiati con la Farnesina. Stefano Giovannone, a quel punto, intervenne direttamente con la famiglia, chiedendo il silenzio stampa, accusando i Falangisti di Beirut, giocando sulla speranza dei parenti dei giornalisti di poter risolvere il rapimento. Nonostante i depistaggi, la Procura di Roma riuscì a ricostruire almeno il contesto della scomparsa, attribuendone la responsabilità ai palestinesi: “I due erano stati uccisi dal gruppo di Habbash, subito o quasi”, spiega il magistrato romano citando una nota dell’ambasciata italiana a Beirut. Il mistero nasce sui motivi del rapimento e dell’omicidio, con un’ipotesi inquietante: “Forse i palestinesi avevano ricevuto qualche indicazione errata”, era l’indicazione arrivata dalle forze di sicurezza libanesi. Una trappola, un mandante esterno. Italiano? Chissà. Il 28 agosto scadono i trent’anni previsti dalla recente riforma sui servizi come limite massimo per il segreto di Stato. Già il 10 marzo del 2010 - attraverso l’intervento del Copasir presieduto da Francesco Rutelli - le famiglie dei due giornalisti avevano ottenuto un primo accesso a 1.161 documenti classificati. Mancavano all’appello un’ottantina di fascicoli, per i quali fu confermato il segreto di Stato da Silvio Berlusconi. Fabio De Palo, fratello minore di Graziella, oggi giudice civile a Roma, ha catalogato con cura le migliaia di pagine consultate (che ha potuto copiare solo dopo un ricorso al Tar). All’Espresso spiega che dal 29 agosto è pronto a chiedere l’accesso alle carte mancati al premier Matteo Renzi, che - secondo le norme attuali - non potrà più autorizzare gli omissis. “Gli interessi economici prevedevano lucrosi affari nella vendita delle armi - spiegano in un appello i familiari di Graziella De Palo e Italo Toni - a quei paesi nei confronti dei quali vigevano embarghi economico militari”. Una politica che Paolo Emilio Taviani sintetizzò nella formula “della moglie americana e dell’amante libica”. Sintesi di quel lodo “Moro” che l’ufficiale del Sismi Stefano Giovannone (uomo di stretta fiducia del leader Dc) attuò con meticolosità, e che Vincenzo Parisi citò in parlamento “per spiegare il movente di tante stragi ancora oggi inspiegabili e coperte da inquietanti aloni di mistero”, come ricordano i familiari dei due giornalisti uccisi nel 1980. “Ci aspettiamo di riavere i resti degli scomparsi e la riapertura di un processo” che era stato interrotto, bloccato dal segreto di Stato confermato da Bettino Craxi, trent’anni fa. Verità e giustizia, al posto dell’eterno muro di gomma italiano.
L'accordo con l'Olp degli anni 70'. In questi giorni di fervore patriottico per il caso Battisti proviamo a riesaminare alcuni degli episodi altrettanto irrisolti della storia del nostro Paese. Vi propongo un articolo che fà riflettere, fatti irrisolti di cui si preferisce ancora tacere. Decidete voi se significa qualcosa o significa nulla.
Tratto da L’accordo Moro e la strage di Bologna del 2 agosto 1980 di Matteo Masetti su “Vietato Parlare”. Negli anni Settanta il governo italiano siglò un accordo segreto con l’Olp per evitare atti di terrorismo nel nostro Paese. In cambio l’organizzazione di Arafat ottenne la libera circolazione dei fedayn palestinesi nella penisola. L’intesa sarebbe stata pensata da Aldo Moro. Ma tra la fine del 1979 e i l’agosto del 1980 qualcosa andò storto. L’attentato alla stazione di Bologna potrebbe essere maturato in quel clima. Una delle pagine più oscure e tragiche nella storia della nostra Repubblica è quella dell’attentato alla stazione ferroviaria di Bologna il 2 agosto 1980. Questa strage fu un fatto di una violenza terroristica mai apparsa fino ad allora nel nostro paese e avvenne poco tempo dopo il misterioso incidente al DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo il 27 giugno di quell’anno, inabissatosi con 81 passeggeri nel mar Tirreno nei pressi dell’isola di Ustica. Ecco dunque la breve cronaca di quel tragico 2 agosto: alle ore 10,25 nella sala d’aspetto della stazione di Bologna Centrale circa 23 kg di esplosivo di fabbricazione militare vennero fatti saltare con un comando a tempo. Assieme alle vittime – 85 morti e 200 feriti – andarono distrutti gran parte della stazione, il parcheggio antistante e il treno Ancona-Chiasso in sosta. Tre giorni dopo l’attentato, a seguito di una riunione del comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, il presidente del Consiglio Francesco Cossiga dichiarò: “La strage è di chiara marca fascista”. Le indagini porteranno all’arresto tra il 1981 e il 1982 di due estremisti di destra dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari), Giuseppe Valerio Fioravanti e la sua fidanzata Francesca Mambro, i quali dopo un processo che era stato annullato, verranno condannati in modo definitivo all’ergastolo con sentenza del 23 novembre 1995. A questo riguardo l’ex presidente della Commissione Stragi, Giovanni Pellegrino, ha sostenuto che il movente attribuito ai condannati per quell’eccidio, “non ha alcun senso”. Mambro e Fioravanti hanno ammesso altri delitti assai gravi per i quali hanno ricevuto condanne pesantissime; ma si sono sempre professati innocenti per quella bomba alla stazione di Bologna. Da notare che Cossiga, in una lettera inviata all’on. Enzo Fragalà – membro della Commissione d’inchiesta sul dossier Mitrokhin – e letta nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio il 20 luglio 2005 aveva scritto: “Premetto che non ho mai ritenuto la Francesca Mambro e Giusva Fioravanti responsabili dell’eccidio di Bologna. L’ultima, assai debole sentenza di condanna è da ascriversi alle condizioni ambientali, politiche ed emotive della città in cui è stata pronunziata, nonché alle teorie allora largamente imperanti nella sinistra e nella cosiddetta magistratura militante “. Il 30 maggio 2005, cioè due mesi prima di questa importantissima dichiarazione – che quindi smentiva quanto il presidente emerito della Repubblica aveva affermato quando la strage era stata appena compiuta – l’ANSA dava una notizia riferita al 1980, secondo la quale il giorno 11 luglio di quell’anno, il prefetto Gaspare De Francisci, direttore dell’UCIGOS (Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali), scriveva al direttore del SISDE generale Grassini che il FPLP (Fronte Popolare Liberazione Palestina) minacciava ritorsioni contro il nostro paese a causa della vicenda di un giordano arrestato e condannato il 25 gennaio 1980 dal Tribunale di Chieti. De Francisci avrebbe poi coordinato le indagini sul sequestro Dozier, l’alto ufficiale statunitense rapito da un commando delle Brigate Rosse il 17 dicembre 1981 e liberato da una brillante operazione dei Nocs il 28 gennaio 1982. Il direttore dell’UCIGOS di quegli anni era quindi un grande professionista. Ma perché De Francisci aveva parlato del terrorismo palestinese che minacciava da vicino l’Italia? L’intricata vicenda è stata ben ricostruita da un dossier apparso sul numero di luglio/agosto 2005 del mensile “Area” e firmato da un brillante giornalista investigativo, Gian Paolo Pellizzaro. Consulente della commissione di inchiesta parlamentare sulle stragi e sul terrorismo, oltre ad avere svolto lo stesso incarico per la commissione Mitrokhin, presieduta tra il 2001 e il 2006 dal senatore Paolo Guzzanti, Pellizzaro si è occupato delle ricerche inerenti la strage di Bologna, citata infatti nel capitolo conclusivo del documento della commissione Mitrokhin. Secondo questa ricostruzione ampiamente documentata le origini dell’attentato sono da far risalire all’episodio dei “missili di Ortona”, ovvero all’arresto avvenuto il 7 novembre 1979 nei pressi di Ortona (Chieti) di tre rappresentanti dell’Autonomia Operaia di Roma. Baumgartner, Pifano e Nieri – questi i nomi degli arrestati – stavano infatti trasportando due lanciamissili di fabbricazione sovietica del modello SAM-7 Strela con relativo munizionamento avuti da un contrabbandiere di armi, il quale le aveva sbarcate quel giorno da una motonave presso il porto di Ortona al Mare. Ecco come vengono descritti i missili Sam-7 Strela nel capitolo conclusivo della relazione di maggioranza sul dossier Mitrokhin (pag. 285): “I missili [.] possono essere impiegati per un solo colpo e il missile è dotato di una testa auto cercante che consente di manovrare in modo automatico per colpire l’obiettivo, con una gittata massima di 6-7 chilometri. Il sistema è destinato contro aerei a bassa quota ed è idoneo a lanci contro aerei in allontanamento, in fase di decollo e di atterraggio”. Nello svolgimento della vicenda è fondamentale il successivo arresto operato a Bologna il 13 novembre 1979 del giordano Abu Anzeh Saleh, ovvero del responsabile del FPLP in Italia. E’ quindi importante ricordare che il capoluogo romagnolo era il luogo di residenza del giordano e che in questa ricostruzione la scelta del luogo dell’attentato – al di là delle motivazioni che vedremo – sia da ricondurre a questo fatto. Saleh avrebbe infatti dovuto essere presente alla consegna delle armi ma quel giorno aveva avuto un impedimento e quindi aveva delegato i tre autonomi romani per assolvere questo compito. Oltre ad essere una figura di spicco in Italia del FPLP, comandato dal noto terrorista palestinese George Habbash, A. A. Saleh era anche un uomo legato all’organizzazione del venezuelano Ilich Ramirez Sanchez, noto anche come “Carlos”, ora condannato all’ergastolo e detenuto in Francia. Comunque la vicenda dei missili, lungi dal risolversi con l’arresto delle persone coinvolte, cominciò invece a diventare una questione molto spinosa per la magistratura e la politica italiana. Infatti il 2 gennaio 1980 il Comitato Centrale del Fronte popolare per la liberazione della Palestina inviava una nota ufficiale al presidente del Tribunale di Chieti, presso il quale si stava svolgendo il processo. Ecco alcuni passaggi di quella nota: “I missili trovati ad Ortona sono dell’FPLP [.] Non c’è mai stata intenzione da parte del Fronte di usarli in Italia [.] E quindi il passaggio-chiave: “Noi richiedemmo che queste informazioni fossero trasmesse al governo italiano. Alcuni giorni dopo, l’ambasciata italiana ci confermò che il governo italiano era stato informato in modo esatto e completo”. Tutto il documento venne letto in aula durante il dibattimento ma a questo punto è opportuna una precisazione importante, perché la missiva era stata affidata a Damasco al colonnello Stefano Giovannone, il quale era subito partito per l’Italia senza informare l’ambasciatore a Beirut del motivo del viaggio. Questo alto ufficiale era stato designato nel 1972 come capo centro del SISMI a Beirut e lì rimase fino al 1981. Ecco cosa scrisse di lui l’ammiraglio Fulvio Martini – ex direttore del SISMI – nel suo libro “Nome in codice: Ulisse”: “Penso che l’Italia debba qualcosa a questo ufficiale dei carabinieri; in centrale [.] avevano scelto per lui il nome in codice Maestro e questo è già di per sé indicativo. Pochi riuscivano a capire con quali difficoltà il colonnello Giovannone avesse a che fare nello svolgimento della sua missione di capo centro a Beirut. Il compito principale di Giovannone era quello di mantenere il SID informato con continuità sull’evoluzione degli avvenimenti. Il Servizio, come era suo dovere istituzionale, aveva necessità di conoscere esattamente la situazione, non solo per poterla analizzare e fare delle previsioni utili alla politica estera del nostro governo, ma anche al fine di provvedere alla difesa dell’Italia da eventuali operazioni di terrorismo che avrebbero potuto coinvolgerla.[.] Era un maestro della cosiddetta diplomazia parallela – quella che ti scarica se non riesci e che ha come solo scopo l’interesse superiore del tuo Paese. Il suo successo fu completo. L’Italia fu molto ingrata con lui. Rientrò da Beirut nel 1980 e morì nel 1985, di tumore, dopo un calvario giudiziario che durò a lungo e durante il quale non fu difeso da quei politici che l’avevano utilizzato”. Poco prima di morire rilasciò un’intervista nella quale dichiarò: “Il mio dialogo con i palestinesi ha dato sette anni di pace all’Italia”. Possiamo a questo punto evidenziare nella lunga citazione tratta dal libro dell’ammiraglio Martini il termine di “diplomazia parallela”, quindi credo sia lecito domandarsi che tipo di agreement esistesse tra il nostro paese e i palestinesi per lasciare in pace l’Italia in quegli anni. Esistono infatti tutti gli indizi per ricostruire l’esistenza di un patto per assicurare al nostro paese un livello di tranquillità in cambio di una specie di salvacondotto per gli estremisti arabi. Nel saggio “Fratelli d’Italia” uscito nel 2007, l’autore Ferruccio Pinotti scrive: “Come è emerso successivamente, il governo italiano aveva siglato negli anni Settanta un accordo segreto con l’Olp mirato a evitare atti di terrorismo: in cambio della possibilità degli attivisti palestinesi di circolare sul territorio italiano, l’organizzazione di Arafat si sarebbe impegnata affinché non avvenissero attentati sul suolo nazionale. L’intesa sarebbe stata pensata già da Aldo Moro”. A questo proposito Rosario Priore, il magistrato che ha indagato nel corso della sua carriera su casi come la strage di Piazza Fontana, “l’incidente” di Ustica e l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, ha affermato nel corso della trasmissione “Omnibus” su LA7 del 14 maggio 2007: “Io vorrei solo fare un piccolo riferimento a questo patto, questo è un patto di cui parla Moro in quattro importantissime lettere [.] Questo è un patto, diciamo la verità, che ha determinato la nostra storia per oltre trent’anni.” Le lettere di cui parla Priore sono evidentemente quelle che lo statista democristiano scrisse durante la sua prigionia nelle mani delle Brigate Rosse e i riferimenti a questo patto dovevano servire a giustificare uno scambio per la sua liberazione. Ecco il passaggio della lettera inviata alla Democrazia Cristiana: “in moltissimi casi scambi sono stati fatti in passato, ovunque, per salvaguardare ostaggi, per salvare vittime innocenti. Ma è tempo di aggiungere che, senza che almeno la DC lo ignorasse, anche la libertà (con l’espatrio) in un numero discreto di casi è stata concessa a palestinesi, per parare la grave minaccia di ritorsioni e rappresaglie capaci di arrecare danno rilevante alla comunità”. In un’altra lettera indirizzata a Flaminio Piccoli Moro farà preciso riferimento al colonnello Giovannone affinchè venga in Italia ed influisca per la sua liberazione. Ma allora a quando risale la data di questo patto? Probabilmente una data precisa di stipula non esiste, ma le condizioni perché esso si realizzasse avvennero attraverso una serie di incontri e successivamente ad azioni terroristiche di “stimolo”. Ad esempio a seguito della strage all’aeroporto di Fiumicino operato da un commando palestinese di Settembre Nero, che il 17 dicembre 1973 provocò 32 morti e decine di feriti: fu così che il governo italiano nella persona dell’allora ministro degli Esteri Aldo Moro si decise a condurre le trattative per una “tregua” mantenendo il colonnello Giovannone dislocato a Beirut in qualità di garante affinchè potesse controllare e monitorare costantemente la situazione. Di fatto un accordo tutto sulla parola ma senza nulla di scritto. In pratica, a fronte della “distrazione” delle autorità italiane per il transito di materiale esplosivo e armi attraverso il nostro paese, l’Italia sarebbe stata risparmiata dalle cruente azioni del terrorismo palestinese e dai pericoli di ritorsione israeliana: e ciò in effetti accadde. Il nostro paese infatti, per la sua posizione geografica in mezzo al Mediterraneo era considerato un punto strategico ed inoltre proprio in quel periodo si verificò lo scontro arabo-israeliano del Kippur (6-22 ottobre 1973), con le dovute ripercussioni nell’area. Trattandosi comunque di un patto non scritto e a causa della cronica instabilità della situazione politica italiana, le condizioni andavano di volta in volta riviste a seconda dei vari accadimenti del nostro scenario politico. E sicuramente la morte di Moro (9 maggio 1978) dovette creare non poche complicazioni. Questa lunga digressione per spiegare cosa aveva innescato il sequestro dei missili – che durante il processo si scoprì essere solo in transito nel nostro paese – e l’arresto del responsabile del FPLP in Italia alla fine del 1979. Sempre Cossiga nella lettera inviata alla commissione Mitrokhin nel 2005 scriveva: “La richiesta avanzata dall’FPLP di restituzione dei missili faceva forse parte dell’accordo mai dimostrato ‘per tabulas’, ma notorio, stipulato sulla parola tra la resistenza ed il terrorismo palestinese da una parte, e dal governo italiano dall’altra, quando era per la prima volta Presidente del Consiglio dei Ministri l’on. Aldo Moro. La totale fedeltà e conseguente riservatezza che i collaboratori sia del Ministero degli esteri sia del Sifar e poi Sismi nutrivano per lui, impedì sempre a me, benché autoritariamente curioso, di sapere alcunché di più preciso sia da ministro dell’Interno, che da Presidente del Consiglio dei Ministri e da Presidente della Repubblica”. Inoltre nel corso della trasmissione “La storia siamo noi” su Rai Due del 24 maggio 2007 l’ex presidente della Repubblica ha affermato: “Arrivò attraverso Giovannone, un messaggio del capo di un’organizzazione terroristica, a me diretto, molto cortese che diceva: Ma qui stiamo violando i patti, il missile è mio, voi me lo dovete restituire “. Vi fu in quell’occasione un vero e proprio braccio di ferro tra la posizione dell’allora premier Cossiga e il nostro servizio segreto militare – i cui vertici risulteranno iscritti alla loggia massonica P2 – che riteneva ancora in vigore quell’accordo nonostante Moro non fosse più in vita. Tra l’altro, proprio in quel periodo il nostro paese era impegnato in una fase di importante riavvicinamento agli interessi degli Stati Uniti, di Israele e della NATO. Ma la posizione palestinese verso il governo italiano andò peggiorando nei mesi successivi, anche perché, come abbiamo accennato, il giordano Saleh, del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, era anche un uomo che faceva parte dell’organizzazione terroristica di Carlos, con il quale si era incontrato in più di un’occasione a Bologna e di certo non per dei briefing di tipo culinario. Il gruppo Carlos denominato Separat dalla Stasi dell’ex DDR ed attivo tra il 1976 e il 1989 ha avuto al suo attivo una serie di azioni terroristiche soprattutto sul territorio francese. Quindi la vicenda del sequestro dei missili Strela si stava intrecciando pericolosamente anche a questo gruppo che tra l’altro non era solo una variabile rischiosa ma altamente imprevedibile per gli sviluppi che poteva provocare. L’organizzazione terroristica di Carlos, detto anche lo Sciacallo, godeva inoltre della protezione dei governi dell’Est Europa e del Medio Oriente ed era in contatto con altri gruppi eversivi in Italia, Francia, Germania, Spagna, ecc. Da una ricerca della Digos di Bologna del marzo 2001 su segnalazione dell’allora capo della Polizia Gianni De Gennaro è emerso che Thomas Kram, membro di spicco delle Cellule Rivoluzionarie (RZ) e facente parte a tutti gli effetti del gruppo Carlos, alloggiò a Bologna la notte del 1° agosto 1980, cioè proprio il giorno prima dell’attentato. Kram, cittadino tedesco qualificato negli atti giudiziari come un grande esperto di esplosivi, si rese poi irreperibile la mattina del 2 agosto rimanendo latitante fino al 2006 quando si costituì in Germania. Va quindi annotato che, come indicato nell’ultimo capitolo dalla Commissione Mitrokhin, la Procura di Bologna ha aperto un procedimento a carico di ignoti per l’ipotesi di strage e successivamente ha chiesto, con rogatoria internazionale, di interrogare Kram come persona informata dei fatti. Tra l’altro lo stesso Carlos, nel corso di un’intervista in carcere rilasciata al “Corriere della Sera” il 23 novembre 2005 ha affermato che “un compagno tedesco era uscito dalla stazione pochi istanti prima dell’esplosione. Ho ricordato il suo nome leggendo il Corriere: Thomas Kram”. Se ciò non fosse ancora sufficiente a seguire questa pista, vorremmo anche ricordare che lo stesso tipo di esplosivo utilizzato nell’attentato di Bologna è stato rintracciato al momento dell’arresto nella valigia della terrorista tedesca Christa Margot Froehlich, anch’essa legata al gruppo Carlos, avvenuto il 18 giugno 1982 all’aeroporto di Fiumicino: purtroppo però gli esperti non lo hanno mai accertato con sicurezza assoluta e questo rimane un interrogativo ancora aperto di quella vicenda.L’attentato di Bologna venne poi a legarsi anche alla improvvisa sparizione, avvenuta a Beirut il 2 settembre 1980, di due giornalisti italiani, Italo Toni e Graziella De Palo. Ecco cosa scrive ancora Ferruccio Pinotti nel suo libro “Fratelli d’Italia”: “Lo stato, il governo, i servizi segreti avrebbero coperto i veri responsabili della strage di Bologna per rispettare l’accordo coi palestinesi. Si tratterebbe di una verità sconvolgente. E se Italo Toni e Graziella De Palo, attraverso le loro fonti palestinesi in Libano, avessero messo le mani su una simile “lettura” della strage di Bologna, si giustificherebbe la loro sparizione e si spiegherebbero le coltri di fumo e i depistagli posti in essere da Giovannone e dal generale Santovito sulla loro morte, tanto da essere rinviati a giudizio. Soprattutto si capirebbe il motivo dell’imposizione, sull’intera vicenda, del ‘segreto di Stato’, che permane tutt’oggi.” Se quindi l’ipotesi dell’attentato di matrice medio-orientale, finora senza esiti processuali, può comunque essere considerata una traccia molto credibile, considerando l’intreccio di motivazioni, connivenze e interessi – oltre alla sentenza molto dubbia nei confronti degli imputati Mambro e Fioravanti -, aggiungiamo un altro elemento che ha contribuito in questi anni all’offuscamento della verità processuale. Infatti il 13 gennaio 1981 sul treno Taranto-Milano in sosta alla stazione di Bologna veniva rinvenuta una valigia contenente esplosivo simile a quello utilizzato per la strage oltre ad armi ed altro materiale compromettente. Le indagini fecero scoprire che questo ritrovamento costituiva una vera e propria sceneggiata operata dal SISMI che, sempre fedele al “patto”, tentò il depistaggio verso elementi neo-nazisti e ciò spiega perché ufficiali del SISMI vennero condannati per questo episodio. Tornando invece alla condanna degli imputati al processo di Chieti per l’episodio dei missili, il giordano Saleh venne rimesso in libertà il 17 giugno 1981 per decorrenza dei termini di custodia, mentre gli altri complici italiani continuarono a rimanere in carcere. E’ quindi evidente la disparità del trattamento degli imputati. E ciò non può non essere stata una coincidenza casuale in seguito all’attentato avvenuto meno di un anno prima. Un’ultima nota crediamo sia doverosa per le vittime di quel tragico 2 agosto: persone ignare del proprio destino che vide 85 vittime o che avrebbero visto la propria vita completamente cambiata per un grave ferimento così come per la perdita di un familiare o di un caro amico. La perdita di fiducia nella giustizia e nelle istituzioni di cui oggi dobbiamo constatare la drammatica attualità è dovuta anche – ovviamente non solo – a situazioni irrisolte come quella di Bologna che, a distanza di quasi 30 anni, chiede una chiave di lettura diversa rispetto a quella finora rivelata. Mi sembra infatti che gli elementi oggi a nostra disposizione richiedano quindi un nuovo impegno da parte degli organi inquirenti e giudiziari per arrivare ad una memoria processuale condivisa che possa cominciare a ridare credibilità al nostro panorama istituzionale. Allo stesso tempo è certo che continuerà l’azione di sbarramento dei “guardiani della verità”, cioè di coloro che non vogliono che queste rivelazioni diventino di ampia diffusione, poiché si ha quasi l’impressione che la nostra opinione pubblica non sia ancora preparata alla lettura di fatti che accaduti da troppo poco tempo per essere completamente metabolizzati. Oltre alle inevitabili ripercussioni che simili verità possano divenire fonte di attrito con i vicini medio-orientali e i nostri interessi nell’area.
Rapporti Italia-OLP, segreti svelati!, scrive “Liberali per Israele”.
FRANCESCO COSSIGA: « Vi sono sempre delle cose, delle verità che è meglio che in certi momenti non si sappiano. Le faccio un esempio: quando io da Ministro dell'Interno o presidente del Consiglio mi vedevo con gli esponenti dell' Olp, non era bene che si sapesse, o quando abbiamo trattato con l'Urss per coprire un caso di spionaggio che aveva portato all'arresto di alcuni italiani e un brillante ufficiale del sevizio militare sovietico; all'arrivo di Gorbaciov facemmo in modo che questo funzionario fosse scarcerato.
Cari giudici girotondini, vi svelo una cosa. Io e Moro i terroristi li abbiamo sequestrati, cacciati, incastrati con la droga. E abbiamo vinto. Voi invece...
Caro dottor Spataro, io ho per Lei una grande simpatia, anche se l'ho denunziata e spero che di quella denunzia Lei debba rispondere, a onore degli uomini dei servizi segreti italiani e delle potenze alleate e amiche che ci difendono dal terrorismo (pardon, dalla "resistenza"). Stia certo che io andrei a trovare in carcere chiunque, anche se fosse un giudice, e porterei le arance siciliane e le ciliegie di Vignola prodotte da un mio amico, che non è né della Cia né del Sismi. Dicevo: io ho per Lei una grande simpatia perché siamo entrambi dei politici. Io lo sono in panni normali e combatto con la parola e lo scritto; Lei lo è nei panni del magistrato che lotta con l'esercizio dell'azione penale e con gli ordini di custodia cautelare. Da ragazzino io per la Repubblica e la Democrazia Cristiana facevo a botte; Lei non ho ben capito per che cosa, ma forse già allora faceva i girotondi. ::: Voglio raccontarLe alcune istruttive cose. Aldo Moro molto si preoccupava di tenere al riparo i cittadini italiani dagli attacchi del terrorismo arabo-medio orientale e palestinese: l'Olp di Arafat non aveva ancora rinunciato a compiere "azioni di convinzione" all'estero contro obiettivi ebraici e occidentali. Si operava nell'ambito del più generale accordo segreto chiamato il "patto Giovannone", dal nome del residente del Sismi a Beirut. Quando terroristi palestinesi tentarono - con missili terra-aria piazzati nei dintorni all'Aeroporto di Fiumicino - di abbattere un aeromobile civile israeliano dell'El-Al e furono arrestati, Moro intervenne personalmente sul presidente del tribunale, con la cortesia e la fermezza che gli erano proprie, e fece concedere ai terroristi la libertà provvisoria. All'uscita dal carcere vi erano agenti dell'allora Sid che prelevarono i terroristi appena scarcerati, li portarono in un aeroporto militare, li imbarcarono su un aeromobile DC 3 dello stormo dello Stato Maggiore, sigla "Argo", quello di cui normalmente si serve la V Divisione e cioè "Gladio" (mamma mia, "Gladio!") e li spedì a Malta, da dove raggiunsero la Palestina. Arafat ringraziò. Fortunatamente Lei, dottor Spataro, era impegnato in un girotondo! Gli israeliani anni dopo ci risposero e fecero saltare in aria l'Argo: pari e patta. Nella "guerra sporca" dei servizi si fa così! Altra storia. Un magistrato arrestò un giorno il capo del Sid, uomo fedele ad Aldo Moro che era allora presidente del Consiglio dei ministri, e arrivò vicino a scoprire la struttura di Gladio. Moro convocò un giovane ministro che ero io, e gli diede istruzioni di prendere contatto con la famiglia, e di esprimere ad essa e tramite essa la solidarietà del governo al generale. Moro mi diede le indicazioni per impartire all'arrestato le istruzioni su ciò che doveva e su ciò che non doveva dire al magistrato. Il generale fu messo in libertà e delicati segreti di Stato non furono rivelati al magistrato, con e senza password! E Lei, il dottor Spataro non c'era, perché si allietava a fare già i girotondi contro i futuri Ds, quando il Pci si fosse trasformato in essi! Quando diventai ministro dell'Interno, il capo dell'Ispettorato Antiterrorismo mi disse che potevamo fare un "colpo" catturando un terrorista (pardon, un "resistente rosso"!), rapendolo con la forza da un Paese confinante. Diedi l'autorizzazione, i nostri ragazzi penetrarono in "territorio amico", localizzarono il "rapendo", ebbero con lui un conflitto a fuoco e lo trasportarono di forza in territorio nazionale. Al processo il terrorista tacque perché su nostra richiesta il magistrato gli aveva promesso un trattamento di favore. Lei, dottor Spataro fortunatamente non c'era, perché si riposava dai girotondi. Sempre io giovane e spregiudicato ministro dell'Interno, mi feci consegnare da un mio più giovane collega straniero in un aeroporto militare di quel Paese un gruppetto di terroristi di destra (questi "delinquenti", e non "resistenti"), e li feci riportare in Italia senza le complicazioni di domande di estradizione e simili. Sempre ministro dell'Interno, escogitai un sistema per far fermare e interrogare sospetti terroristi o loro fiancheggiatori, per i quali i magistrati proprio non ci potevano concedere mandati di arresto e cattura o confermare fermi di polizia giudiziaria (solo dopo un paio d'anni riuscii infatti a far reintrodurre il fermo di polizia, con l'aiuto dei comunisti). E Le racconto un'altra cosa ancora, dottor Spataro. Nella calca delle grandi città, nostri ragazzi dell'Arma o della Polizia facevano scivolare buste di cocaina o di altra droga (in modica quantità!) nelle tasche del ben-capitato di turno. Qualche metro dopo una squadra della Guardia di finanza in divisa, che si trovava per caso di passaggio per servizio antidroga, fermava il sopraddetto, lo perquisiva, gli trovava la droga e lo portava in caserma dove, dopo un sommario interrogatorio sul possesso di droga, insieme a carabinieri o agenti di polizia dell'antiterrorismo in borghese il bencapitato veniva interrogato su fatti di terrorismo... con minor dolcezza! Gli Spataro non c'erano: erano i tempi degli Occorsio, dei Sica e dei Di Matteo..., quelli che con seri politici, soprattutto democratico-cristiani e comunisti, sconfissero il terrorismo (perdono! La "resistenza"!). Chissà quanti ostacoli alla lotta contro il terrorismo rosso ci avrebbe messo il girotondino Spataro, allora con baffi meno bianchi! Andiamo avanti con i ricordi. Dopo un devastante attacco terrorista contro obiettivi israeliani a Fiumicino (il "patto Giovannone" non venne violato!), dopo che gli "steward" e le "hostess" della El-Al fecero fuori tre o quattro terroristi la polizia italiana riuscì a catturarne uno, ferito. Il sostituto procuratore e il capo di una sezione antiterrorismo che mi incontrarono nell'obitorio dove ero andato a rendere omaggio alle salme dei cittadini israeliani (mi scusi, qualche girotondino direbbe "sporchi sionisti"!) uccisi, mi chiesero se ritenessi opportuno che, con l'aiuto degli anestesisti, gli agenti dessero una "strizzatina" al ferito per farlo parlare, in presenza del magistrato della procura di Roma, che naturalmente non era girotondino ma della sinistra vera. Il consiglio di dare strizzatine ai terroristi detenuti mi era stato dato anche da un grande capo partigiano, "icona" del Pci e leninista di ferro. Risposi che mi sembrava un'ottima idea. Così fu fatto: e la magistratura "mise dentro" un bel po' di complici dei terroristi (pardon, di resistenti contro il sionismo). Il "resistente" fu condannato all'ergastolo e fu poi oggetto di uno scambio. Lei, dottor Spataro non c'era, perché aveva ripreso gli allenamenti di girotondo! Avendo avuto forti insegnanti di diritto costituzionale e di diritto penale (sì, mi sono laureato in diritto penale ottenendo il voto di 110 su 110 e lode, con dignità di stampa!) conosco che cosa sia la legalità ordinaria e la legittimità istituzionale dei tempi di guerra. Non si affanni a fare indagini, dottor Spataro, perché è tutto prescritto... In conclusione: io, democratico, antifascista e antiterrorista, ringrazio gli agenti del Sismi, quelli della Cia (sì, anche quelli della Cia con le "extraordinary rendition") del Security Service, quelli della BND, quelli dell'SFB che hanno fatto (complimenti!) il bel colpo contro il capo terrorista ceceno. Li ringrazio per il contributo che danno, anche con metodi spicci, alla lotta contro il terrorismo islamico (pardon, la resistenza islamica!) Spero che Clemente Mastella riesca a salvarsi dalla stretta della lobby politicosindacale dell'Associazione Nazionale Magistrati e a rifiutarsi di inoltrare la domanda di estradizione degli agenti Cia che Lei - insieme al non girotondino conoscitore delle "carte di Montenevoso" - inoltrerete agli Stati Uniti. Spero che Mastella riesca ad evitare che dall'altra parte dell'Atlantico ci arrivi una pernacchia imperiale! Sa che cosa mi duole di tutta questa vicenda, dottor Spataro? Che né il governo né il Sismi abbiano dato una mano alla Cia, come quasi tutti gli altri Stati e servizi di intelligence europei hanno fatto! Con sincera cordialità.»
FRANCESCO COSSIGA: «Adesso le dico un segreto, quando venne in Italia Arafat per i funerali di Berlinguer, nei suoi confronti c'era un ordine di cattura emesso dal giudice Mastelloni. Avevamo paura che ci arrestassero Arafat, e io allora ero presidente del Senato lo nascosi insieme ai suoi all'interno dell'allora mio appartamento al Senato, e depistammo i carabinieri che avevano avuto l'ordine dal giudice Mastelloni di eseguire il mandato di cattura. Adesso lo si può dire».
Lo sa che Cossiga per far partecipare Arafat ai funerali di Berlinguer lo nascose al Senato?
CARLO MASTELLONI - Procura di Venezia: «Non mi meraviglio perché si mosse tutta una macchina, in maniera abbastanza violenta, virulenta. Io ricevetti perquisizioni per scoprire quali fossero le mie idee politiche, fu un episodio molto doloroso. Da una parte si può anche capire le motivazioni politiche che spingono un parte politica ad intervenire, dall'altra bisogna andare sempre dritti per fare il proprio dovere.»
BERNARDO IOVENE: «Tra l'organizzazione per la liberazione della Palestina e l'Italia c'era un accordo segreto che aveva fatto Aldo Moro. Un accordo ancora oggi sconosciuto».
FRANCESCO COSSIGA: «Non si è mai saputo, io non ho mai conosciuto i termini reali dell'accordo che fece Moro con l'OLP, ma tale accordo prevedeva che quando furono arrestati dei guerriglieri arabi con dei lanciamissili terra-aria destinati ad abbattere un aereo di linea israeliano a Fiumicino, questi su richiesta dell'OLP furono portati a Malta e liberati».
BERNARDO IOVENE: «In pratica furono beccati dei terroristi palestinesi con dei missili terra aria per abbattere un aereo israeliano e in barba alle leggi italiane furono riaccompagnati a casa».
E ritorniamo al segreto di Stato, quanto dura?
GIUSEPPE DE LUTIIS - Consulente Commissione Stragi: «Attualmente i segreti dei servizi sono eterni a meno che un presidente del Consiglio non decida di farne decadere qualcuno in specifico».
Da spararsi un colpo in testa, ragazzi!